|
Nel 2022, in occasione dei 400 anni dalla nascita, la città natale e il Land Brandeburgo hanno dedicato un convegno internazionale e una serie di pubblicazioni a Christian Mentzel, medico personale del Grande Elettore Federico Guglielmo. Personaggio poliedrico, come medico ebbe un ruolo centrale nella creazione delle strutture sanitarie dello stato prussiano, come botanico fu autore di una flora locale di Danzica e di uno dei primi dizionari universali dei nomi delle piante, come chimico si occupò della pietra fosforica bolognese, come bibliotecario curò la redazione di alcune magnifiche opere illustrate; negli ultimi anni della sua vita fu in relazione con vari studiosi che vivevano o avevano vissuto in Asia e divenne uno dei padri fondatori dello studio della lingua e della civiltà cinesi. Plumier gli dedicò il genere Mentzelia, poi ufficializzato da Linneo. 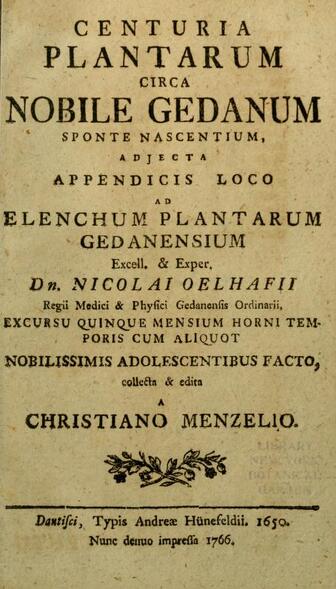 Una flora locale e un grande viaggio d'istruzione Il quattrocentesimo compleanno del medico, botanico e sinologo Christian Mentzel (1622-1701) è stato celebrato a Fürstenwalde, la sua città natale, con un simposio internazionale - culmine di una serie di iniziative in ricordo del poliedrico personaggio. La città sorge sul fiume Sprea, quasi a metà strada tra Berlino e Francoforte sull'Oder, e nel Seicento, grazie alla sua posizione sul fiume, era un importante nodo commerciale, rinomato anche come centro scolastico. Mentzel, che era figlio del sindaco, ricevette la prima eduicazione in casa poi nel 1630 fu ammesso al Ginnasio di Joachimsthal, una scuola d'élite da poco fondata e finanziata dall'elettore di Brandeburgo. Nel frattempo però era scoppiata la guerra dei Trent'anni; nel 1636 studenti e professori furono costretti a mettersi in salvo da un'incursione svedese durante la quale la scuola andò distrutta. Christian dovette interrompere gli studi e nel 1639 perse anche il padre, morto di peste. Si trasferì allora a Berlino per studiare al Köllnisches Gymnasium; studiò quindi medicina prima a Francoforte sull'Oder poi a Königsberg. Nel 1647 accompagnò l'ambasciatore del Brandeburgo a Varsavia e a Cracovia e nel 1648 fu assunto come lettore di anatomia e botanica presso il ginnasio accademico di Danzica. Si trovò così a collaborare ai progetti di riforma scolastica di Johann Raue (Ravius), ammiratore e seguace di Comenio, che davano maggiore spazio a uno studio non libresco della natura. Così le sue lezioni di botanica non si svolgevano solo in aula, ma anche nei prati, nei campi e nei boschi. Proprio come supporto didattico per i suoi studenti Mentzel scrisse il suo primo libro, Centuria plantarum circa nobile Gedanum ad elenchum plantarum gedanensis dom. Nicolai Oelhafii. L'esilissimo libretto (poco più di 20 pagine) elenca in ordine alfabetico 100 piante reperibili nell'area di Danzica; secondo quanto scrive l'autore, è il frutto di cinque mesi di escursioni: "Condussi per campi e foreste la più nobile adolescenza e quanto da ogni lato si offriva fiorente, lo sottoponevo ai loro occhi fedeli". Uno di quei nobili adolescenti era Jakob Breyne che proprio grazie a Mentzel si appassionò alle scienze naturali, Mentzel per lo più si rifà al precedente della prima flora di Danzica, anzi dell'intera area compresa tra Prussia e Polonia, Elenchus plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum sua sponte nascentium (1643), del medico (e suo predecessore come insegnante di anatomia e botanica al ginnasio accademico) Nikolaus Oelhafen, estraendone solo le piante che ha effettivamente incontrato e presentandole in modo più sintetico, adatto a un "quaderno di campo" per adolescenti; elimina tra l'altro le indicazioni sugli usi medici. Ogni voce, brevissima, inizia con il nome latino per lo più ripreso dal Pinax di Caspar Bauhin, seguito dal nome tedesco e dai sinonimi in altri autori, dall'epoca di fioritura e dalla localizzazione (generica in latino, specifica in tedesco, ad esempio in littoris maris bei Zoppot). Nel 1650, forse poco dopo aver pubblicato il libro, Mentzel lasciò Danzica per un lungo viaggio di istruzione; imbarcatosi ad Amburgo, visitò l'Olanda, dove fu ad Amsterdam e Leida e forse strinse alcuni dei legami che gli sarebbero stati utili nella sua futura carriera; quindi continuò il suo viaggiò in nave, toccando le coste della Francia, del Portogallo e della Spagna. Proseguì nel Mediterraneo, toccando successivamente Maiorca, la Corsica, la Sardegna, le Isole Eolie, la Sicilia, Malta, Creta e Corfù, dalla quale raggiunse Venezia. Visitò Pisa, Firenze, Roma, Napoli, dove scalò il Vesuvio, quindi riprese gli studi di medicina a Bologna e a Padova, dove nel 1654 ottenne il dottorato in filosofia e medicina. Sulla via del ritorno, visitò ancora Verona, Vicenza, Trento, Innsbruck, Vienna, Augusta e Norimberga, dove incontrò il futuro presidente dell'Academia Naturae Curiosorum, Johann Georg Volkamer. Quindi si stabilì come medico prima a Fürstenwalde, poi a Berlino. Qui attirò l'attenzione del grande elettore Federico Guglielmo che lo nominò aiutante medico di corte e medico di campo. In questa veste partecipò alla campagna contro gli svedesi in Holstein; quindi accompagnò a Cleves e Königsberg l'elettore che nel 1660 lo promosse a proprio medico personale e membro del consiglio di corte. 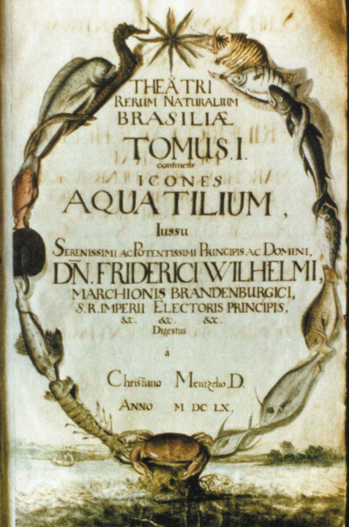 Bibliotecario e... editor Era un compito faticoso che spesso imponeva a Mentzel lunghi viaggi lontano da Berlino per accompagnare l'elettore nelle campagne militari e nelle visite diplomatiche o per assistere lui o i suoi famigliari in caso di malattia, come nel 1667, quando andò nei Paesi Bassi per recuperare la principessa Luise ammalata di tisi e riportarla in patria o nel 1674 quando non poté salvare dalla morte il giovanissimo principe Carl Emil, ammalatosi di febbri perniciose durante una campagna in Alsazia. Dal 1661 fu anche impegnato, con altri medici di corte tra cui Elsholtz, nella riforma del settore sanitario che sarebbe sfociata nell'editto medico del 1685. Per molti anni a causa di questi impegni pressanti e dei continui spostamenti non poté scrivere né soddisfare la sua passione per la botanica, anche se sappiamo che continuò ad osservare la flora e a probabilmente tenne un diario di campo dei propri ritrovamenti. L'elettore gli aveva affidato anche la sua biblioteca e intorno al 1660 gli chiese di occuparsi di una collezione di immagini di animali, piante e persone del Brasile olandese che gli era stata donata da Johan Maurits di Nassau Siegen in cambio della nomina a governatore di Mark e Cleves. Si trattava di due libri rilegati con immagini ad acquarello, noti come Libri principis, e di alcune centinaia di fogli sciolti, dipinti sia ad acquarello sia ad olio, questi ultimi presumibilmente opera di Albert Eckhout, oltre a diversi disegni e schizzi. Su richiesta dell'elettore, Mentzel riorganizzò gli oli in quattro volumi in folio con animali e piante; ciascuno è aperto da un frontespizio, con il titolo manoscritto Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae e un sottotitolo specifico, racchiusi in una cornice miniata formata da animali; Mentzel figura come autore. Come dimostrano i numerosi fogli bianchi intercalati ai dipinti, egli progettò una rassegna completa della fauna e della flora del Brasile olandese (o Nuova Olanda); infatti anche i fogli bianchi sono numerati, hanno un titolo vernacolare brasiliano e spesso un rimando alle due principali opere scaturite dalla breve occupazione olandese del Nord est brasiliano: Historia Naturalis Brasiliae di Willem Piso e Georg Marcgraf e De Indiae utriusque re naturali et medica di Piso. Chiaramente, Mentzel aveva intenzioni di completare l'opera con ulteriori immagini, in gran parte copiate da queste opere. ma ciò non si realizzò mai, vuoi per i troppi impegni, vuoi per il costo insostenibile, vuoi per insormontabili problemi tecnici. Le immagini sono organizzate secondo un ordine che si vuole "naturale". Nel primo volume troviamo i pesci perché furono i primi ad apparire; nel secondo gli uccelli perché "proprio come i pesci tagliano l'acqua con le pinne, gli uccelli tagliano l'aria con le ali [...] e le somiglianze e le relazioni tra loro indicano chiaramente che Dio onnipotente li ha creati lo stesso giorno"; nel terzo gli indiani e altri abitanti del Brasile olandese perché "l'uomo è il padrone di tutta la creazione e deve essere il primo", seguiti da scimmie, gatti, conigli, volpi, per concludere con insetti e anfibi, la cui natura è considerata intermedia tra animali e piante. Queste ultime occupano il quarto volume, ma Mentzel non diede loro un particolare ordine, anzi sottolineò che ordinarle e classificarle era impossibile. I fogli di piante sono 106, intercalati con 206 fogli bianchi, ma titolati con nomi vernacolari brasiliani e con rimandi alle opere di Piso e Marcgraf; gli studiosi hanno identificato 162 piante vascolari e il fungo Copelandia cyanescens, cui se ne aggiungono altre 196 per i fogli intercalati. Nella maggior parte dei casi, si tratta di piante native del Brasile, ma ci sono anche una trentina di specie introdotte. Le date dei frontespizi dei quattro volumi ci dicono che Mentzel lavorò al Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae tra il 1660 e il 1664, poi abbandonò il progetto e i volumi vennero riposti così come si trovavano nella biblioteca dell'elettore. Del resto era iniziato un nuovo ciclo di guerre, conclusosi solo nel 1679 con la pace di Saint Germain. Ora Mentezel non doveva più trascorrere lunghi periodi lontano da Berlino e poteva tornare a studiare e a scrivere. Nel 1675, mentre la seconda moglie dell,'elettore era in travaglio, approfittò dell'attesa per scrivere un saggio sulla cosiddetta pietra di Bologna, ovvero una pietra fosforescente di barite che nel Seicento attirò l'attenzione di molti studiosi, tra cui Fortunio Liceti, che era stato suo professore a Padova. Con questo saggio Mentzel iniziò una regolare collaborazione con l'accademia Leopoldina, cui fu ammesso quello stesso anno. 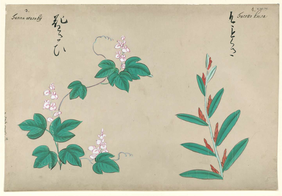 Un lessico botanico e molte opere "cinesi" Tornò anche a occuparsi di piante, con un'opera singolare che fonde l'interesse per la botanica con quella per le lingue: un dizionario universale dei nomi delle piante. Proprio come la piccola flora di Danzica che aveva scritto da giovane, anche quest'opera della vecchiaia nacque da un intento didattico. Mentzel aveva tre figli maschi, ma, come scrisse - metà rassegnato metà sconsolato - all'amico Volkamer, nessuno dei tre aveva voglia di studiare. Infine però Johann Christian si convinse a seguire le orme paterne e a studiare medicina. Per avviarlo alla botanica, che continuava a considerare una competenza di base indispensabile per ogni medico, il padre gli assegnò il compito di leggere tutti i testi di botanica che gli capitassero sotto mano e compilare una lista alfabetica di tutti in nomi delle piante via via citate, in tutte le lingue. Da esercizio scolastico, l'idea si trasformò in un progetto editoriale cui padre e figlio lavorarono insieme a quattro mani; nel 1682 fu pubblicato sotto il titolo Pinax Botanōnymos Polyglōttos Katholikos o Index Nominum Plantarum Universalis. Come ci informa il chilometrico frontespizio, contiene i nomi delle piante in dozzine di lingue e dialetti, a iniziare dal latino e dal greco, per proseguire con le principali lingue europee, ma anche con idiomi più esotici dei quattri continenti: ebraico, caldeo, arabo, siriano, turco, tataro, malabarico, bramino e cinese per l'Asia, egizio, etiopico, mauritano, malgascio ecc. per l'Africa, brasiliano, virginico e messicano per le Americhe. In appendice, Mentzel volle aggiungere una breve selezione di piante rare (Pugillus rariorum plantarum), tanto appartenenti alle collezioni dall'ex allievo Jacob Breyne quanto incontrate nei suoi viaggi, illustrate da tavole calcografiche di buona qualità; aggiunse infine un indice delle piante del manoscritto brasiliano. L'opera era la prima nel suo genere e conobbe un certo successo, venendo ristampata nel 1696. Dal 1685 con la promulgazione dell'editto medico, come medico personale dell'elettore Mentzel entrò a fare parte di diritto del Collegium medicum. Più o meno nello stesso periodo l'elettore gli affidò la cura della sua biblioteca di libri cinesi. In quegli anni, in Europa l'interesse per la Cina, che incominciava ad essere conosciuta soprattutto grazie ai missionari gesuiti, era vivissimo. Molto vi aveva contribuito la recente pubblicazione di China illustrata di padre Athanasius Kircher (1667) che, con l'incoraggiamento dell'elettore, aveva spinto l'orientalista prussiano Andreas Müller a intraprendere lo studio del cinese e la stesura di una serie di opere, tra cui una Clavis sinica che avrebbe dovuto facilitare l'apprendimento degli ideogrammi e della lingua cinese. Federico Guglielmo incaricò Müller di catalogare i manoscritti orientali della biblioteca elettorale ma fu deluso dalla mancata consegna della Clavis sinica che aveva finanzaito e l'orientalista prometteva da diversi anni; nel 1685, quando Müller lasciò Berlino, l'elettore passò l'incarico a Mentzel. Quest'ultimo all'epoca era già sulla sessantina e non aveva alcuna conoscenza del cinese, ma ne affrontò lo studio con energia e entusiasmo. Inoltre, attraverso l'Accademia curiosorum leopoldina, era già in contatto con alcuni membri della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC) da cui poté per ottenere informazioni di prima mano, manoscritti e altri materiali, che andarono ad arricchure la biblioteca elettorale. I suoi corrispondenti più importanti furono Georg Eberhardt Rumpf (Rumphius) e Andreas Cleyer. Con il primo, naturalista al servizio della VOC nella remota Ambon nelle Molucche e come lui membro della Leopoldina, cominciò a corrispondere nel 1682 e scambiò numerose lettere, che poi pubblicò in forma di brevi articoli o notizie tra il 1682 e il 1698 nella Miscellanea curiosa sive Ephemerides dell'Accademia. Ancora più fruttuosa la corrispondenza con l'intraprendente Cleyer. Anche lui era membro dell'Accademia curiosorum ed era in contatto con l'orto botanico di Amsterdam. Durante in suoi due mandati come mercante-capo della factory di Dejima (1683-84 e 1685-86) riuscì ad acquistare uno splendido manoscritto con disegni di uccelli e piante e altri li fece eseguire da un pittore europeo; inviò i materiali a Mentzel che riunì le circa 1300 illustrazioni, precedute da un dedica all'elettore Federico III (era succeduto al padre nel 1688) e da una breve introduzione, in una Flora japonica in due tomi rilegati. Mai pubblicati, entrarono a far parte della collezione di illustrazioni naturalistiche della Biblioteca di stato di Berlino nota come Libri picturati con la sigla A41. L'edizione digitale della magnifica opera è consultabile qui. Egli stesso interessato alla farmacopea e alla medicina cinesi, oltre a contribuire di persona alla rivista dell'Accademia curiosorum con numerose osservazioni su questi argomenti, Cleyer fece pervenire a Mentzel testi medici cinesi per la biblioteca elettorale e altri materiali, che furono da lui uniti agli acquarelli e agli schizzi del dono brasiliano del principe di Nassau Siegen nel volume manoscritto noto come Miscellanea Cleyeri (Liber picturatus A38) e probabilmente custoditi nella sua casa. Confluito nella Biblioteca elettorale di Berlino, insieme ai Libri principis e al Theatrum rerum naturalium Braziliae, fa parte dei Libri picturati scomparsi durante la Seconda Guerra mondiale e ritrovati presso la Biblioteca Jagellonska di Cracovia. Ho già racconta questa storia in questo post. Già nel 1685 Mentzel fu in grado di pubblicare un piccolo lessico latino-cinese (Sylloge minutiarum lexici Latino-Sinico-Characteristici), in cui gli ideogrammi cinesi sono accompagnati dalla traslitterazione fonetica in caratteri latini. Entrato poi in contatto con il missionario gesuita belga Philippe Couplet, l'anno successivo pubblicò una cronologia della storia cinese (Kurtze chinesische Chronologia oder Zeit-Register), basata sulla Tabula chronologica dello stesso Couplet e su Sinicæ historiæ decas prima del gesuita italiano Martino Martini. Su consiglio di Couplet, riprese poi il progetto di Müller di una chiave per l'apprendimento del cinese (Müller da parte sua vi aveva rinunciato e prima di morire fece bruciare i propri manoscritti), basandosi per la grammatica su un manoscritto di Martini, per la pronuncia sul Vocabulario de letra China del domenicano spagnolo Francisco Díaz e per l'impostazione generale sul lessico cinese Zihui che organizzava gli ideogrammi in 214 radici. Tuttavia, non andò oltre prefazione (Clavis Sinica, ad Chinensium scripturam et pronunciotionem Mandarinicam) pubblicata nel 1698. Infatti Mentzel si era già imbarcato in un progetto ancora ambizioso: un dizionario cinese-latino (Chinensium Lexici characteristici inscripti 字彙 Cú-guéi) di cui redasse nove volumi, rimasti però inediti. Per l'intensità e la ricchezza di risultati, l'attività di Metzel come sinologo è tanto più stupefacente se pensiamo che negli ultimi anni della sua vita egli era gravemente malato. Nel 1686 fu colpito da un'emiparesi che gli lasciò un tremore costante degli arti; non poteva più scrivere e poté continuare a studiare e lavorare solo grazie al figlio, che poi gli succedette come medico di corte. Morì a Berlino nel 1701.  Mentzelia, fiori notturni dalle Americhe Come botanico, ad assicurare una certa fama postuma a Mentzel fu soprattutto il suo Index Nominum Plantarum Universalis; in Nova plantarum americanarum genera Plumier lo onorò con la dedica del genere Mentzelia proprio ricordando quest'opera; quanto a Linneo, che riprese il genere fin da Hortus cliffortianus, in Bibliotheca botanica elenca il medico dell'elettore sia tra gli autori di flore locali (riferendosi ovviamente alla sua centuria sulla flora di Danzica) sia tra i lessicografi, e utilizzò ampiamente il dizionario di Mentzel come opera di riferimento. Menzelia L. (famiglia Loasaceae) è un genere di un cdntinaio di specie originarie delle Americhe, con centro di diffusione nell'America nord-occidentale; sono soprattutto erbacee annuali, biennali e perenni di breve vita, con qualche arbusto. La grande maggioranza vive in ambienti aridi o subdesertici, spesso disturbati o poveri. La caratteristica più costante sono le foglie munite di peli uncinati che per la loro capacità di attaccarsi a ogni cosa sono stati paragonati al velcro; presumibilmente hanno funzione difensiva, ma è stato anche ipotizzato che i numerosi insetti che vi vengono intrappolati, cadendo poi ai piedi della pianta, contribuiscano ad arricchire il suolo povero di nutrienti. Per la grande variabilità di forme tanto del genere quanto delle specie e per le affinitàmtra queste ultime, è considerato un genere tassonomicamente difficile. Tanto la forma delle foglie, in genere caratterizzate da margini ondulati, dentati o serrati, quanto la struttura dei fiori sono alquanto varie. I fiori, singoli o riuniti in infiorescenze termiali, possono avere da 5 a 10 petali, talvolta intervallati da brattee, stretti in alcune specie, ampi in altre, mucronati in altre ancora; le corolle sono biache, bianco crema, gialle, a volte rosse alla gola. Molto decorativi gli stami, molto numerosi. I fiori si aprono nel tardo pomeriggio o di sera per essere impollinati da falene e altri insetti notturni. Tra i caratteri distintivi più importanti, anche la superficie dei semi. Ad esempio, quelli di M. affinis, un'annuale distribuita tra California meridionale, Arizona, Nevada e a Baja California, hanno forma prismatica, quello di M. congesta sono angolati con lati concavi ricoperti di minute protuberanze, quelli di M. involucrata sono minuscoli, ruvidi e bianco-cenere. Il genere è particolarmente rappresentato negli Stati Uniti; porta il suo nome la rivista "Mentzelia", organo della Northern Nevada Native Plant Society. Alcune specie, in particolare la californiana M. lindley, sono talvolta coltivate come annuali da giardino. Una scelta di specie nella scheda.
0 Comments
In questa storia si incontrano due misteri a prima vista senza connessioni. Il primo: chi era lo sfuggente "signore di Reynoutre" cui il botanico olandese Maarten Houttuyn dedicò il genere Reynoutria? Il secondo: chi ha creato o commissionato i bellissimi Libri picturati A16-30, uno dei massimi capolavori dell'illustrazione botanica del Rinascimento? E ancora: c'entra qualcosa Carolus Clusius? E come sono finiti alla Staatsbibliothek di Berlino? Le risposte convergono verso un luogo, un'epoca e una persona: le Fiandre meridionali della seconda metà del Cinquecento e il nobile Charles de Saint Omer, il primo mecenate di Clusius.  Sulle tracce dei Libri picturati: Berlino, anni 30 Prima storia e primo mistero. Nel 1777 ad Amsterdam il botanico olandese Maarten Houttuyn pubblica il settimo tomo del secondo volume della sua Natuurlyke historie. Nel capitolo dedicato all'annuale acquatica Callitriche verna (oggi si chiama Callitriche palustris subsp. palustris) riassume quanto ne hanno scritto i botanici preceedenti e, a proposito di Mathias de Lobel, scrive: "E' stata descritta e raffigurata sotto il nome Stellaria da Lobel, il quale dice che il signore di Reynoutre, un grande amante delle piante a lui noto, non badò a spese per fare raffigurare dopo la vita piante tanto straniere quanto autoctone, tra cui questa specie". Nell'ottavo tomo, pubblicato lo stesso anno, si ricordò del signore di Reynoutre per dedicargli il nuovo genere Reynoutria con queste parole: "Per un certo signore di Reynoutre, che, secondo la testimonianza di Lobel, ha dato grandi servizi alla scienza delle erbe, come ho già segnalato". Houttuyn non ne sa di più; e continuano a non sapere altro molti siti, in cui si legge "in onore del Barone van Reynoutre (sec. XVI), grande amante delle piante" oppure "in onore del Barone van Reynoutre (sec. XVI) che, secondo Lobelius, era un appassionato estimatore delle piante". Genaust ne sa anche meno: "Nome di Houttuyn per una Polygonacea dell'Asia orientale; etimo non chiaro". Seconda storia anche più misteriosa, nonché intricata. Nel 1941, in seguito a pesanti bombardamenti, viene deciso di evacuare i più preziosi manoscritti della Biblioteca nazionale di Berlino, tra cui l'inestimabile raccolta nota come Libri picturati: ben 144 volumi di migliaia di illustrazioni di piante, animali, persone, provenienti dalle collezioni personali del re di Prussia. La raccolta viene smembrata in lotti che vengono trasportati in diversi luoghi ritenuti sicuri. Uno viene inizialmente ricoverato nel castello di Fürstenstein in Slesia, quindi nel 1943 nuovamente trasferito nel monastero benedettino di Grüssau (oggi Krzeszów). Poi per anni e anni non se ne sa più nulla. Solo nel 1977 lo zoologo Peter Whitehead ritrova i manoscritti nella Biblioteka Jagiellońska di Cracovia, dove erano stati portati nel 1947 senza che la notizia fosse trapelata in Occidente, e dove si trovano tuttora. I Libri picturati della Jagellonska possono essere divisi in due nuclei principali, di data e provenienza diversa; i volumi A32-A38 contengono materiali iconografici relativi all'esplorazione del Brasile olandese promossa da Giovanni Maurizio di Nassau Siegen, che ne fu governatore dal 1636 al 1644; quando tornò in Europa, il principe, in cambio di titoli e proprietà, ne fece dono all'elettore Federico Guglielmo di Prussia che incaricò di selezionarli e riunirli in volume il suo medico personale Christian Mentzel; questi, nel volume A 38, noto come Miscellanea Cleyeri, incluse anche rappresentazioni etnografiche e acquarelli di piante asiatiche che gli erano state inviate dal suo corrispondente Andreas Cleyer. Il mistero riguarda le origini e la vicenda degli altri volumi del lotto, i Libri picturati A16-31. Al contrario di quelli "brasiliani", non hanno né titolo né frontespizio, né ci sono ex-libris o altre note di possesso. I 15 volumi in folio contengono oltre 1400 acquarelli di piante e animali; lo stile dei disegni e dettagli delle annotazioni rimandano alle Fiandre della seconda metà del Cinquecento; la rilegatura però risale a circa il 1660 o anche dopo, ed alcune immagini furono presumibilmente inserite in un secondo tempo. Chi abbia dipinto gli acquarelli, chi abbia ordinato o messo insieme la raccolta, quale mano abbia scritto le note che accompagnano molte immagini, per quali vie il manoscritto sia giunto a Berlino, è ancora oggetto di dibattito, anche se, come vedremo, orami sono noti glie elementi essenziali. La qualità delle immagini è eccezionale e si tratta senza dubbio di una delle più importanti collezioni di acquarelli naturalistici del Rinascimento; eppure hanno attirato l'attenzione degli studiosi solo dopo il loro "miracoloso ritrovamento" (la definizione è di Whitehead). Unica eccezione il bibliotecario tedesco Hans Wegener che negli anni '30 lavorava nel dipartimento dei manoscritti della Biblioteca statale di Berlino; studiando attentamente le immagini, notò che diverse avevano una stretta affinità con le xilografie di opere di Carolus Clusius stampate da Plantin tra il 1574 e il 1576; trovò corrispondenze anche con xilografie della prima edizione del Kruydtboeck di Lobel (1581) e con la prima parte di Rariorum plantarum historia di Clusius (1601). Osservò poi che nelle annotazioni erano citate regioni come la Provenza e città come Salamanca, Montpellier e Marsiglia, tutte località visitate da Clusius; c'erano parecchi riferimenti a località fiamminghe, e in particolare a Moerkerke, dove Clusius trascorse un lungo periodo nel castello di Charles de Saint Omer. Comparivano anche i nomi dei fratelli Laurin, di Jacobus van den Eede di Bruges e del farmacista di Anversa Peeter van Coudenberghe, tutti noti amici di Clusius. Sulla base di tutti questi elementi, Wegener giunse a una conclusione che gli sembrava tanto chiara quanto inappuntabile: a predisporre quella raccolta non poteva essere stato che il grande botanico fiammingo, e in un suo articolo del 1936 fin dal titolo non esitò a definire il manoscritto Das grosse Bilderwerk des Carolus Clusius, ovvero "La grande opera pittorica di Carolus Clusius". Inoltre, nel catalogo della biblioteca dell'elettore compilato nel 1668, individuò la menzione di "XVI tomi tam Animalium quam Plantarum ex Bibliotheca Cancellarii Weinmanni" (16 tomi sia di animali sia di piante, provenienti dalla biblioteca del cancelliere Weinmann). Si trattava senza dubbio dei Libri picturati A16-31, giunti a Berlino o come dono del cancelliere di Kleve Daniel Weinmann o come acquisto di Federico Guglielmo. Molto rimaneva da scoprire, ma ostacoli burocratici prima, lo scoppio della Seconda guerra mondiale poi gli impedirono di continuare le ricerche. 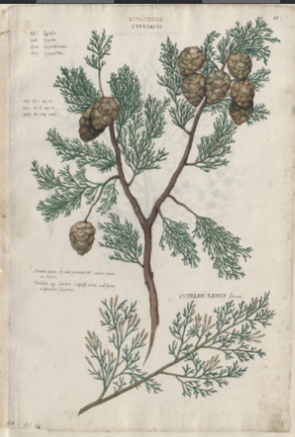 Clutius versus Clusius? No, Saint Omer! Il ritrovamento dei manoscritti riaccese l'interesse degli studiosi. Nel 1989, Whitehead, van Vliet e Stearn pubblicarono un'accurata descrizione dell'intero lotto, in cui distinsero segmenti risalenti a periodi compresi tra il XVI e addirittura il XIX secolo. Per quanto riguarda i Libri picturati A16-30 (A31 non fa parte della serie, perché fu prodotto nel XVII secolo ed è per lo più costituito da copie di disegni di piante dei volumi A18-A30), suggerirono che i contenuti dei volumi fossero stati riordinati e fatti rilegare da un altro medico di Federico Guglielmo, Johann Elsholz. Il volume A16 contiene immagini di pesci e mammiferi, A 17 di uccelli, A18-30 circa 1500 acquarelli di piante, relativi a 1860 taxa (alcuni fogli raffigurano infatti più di una specie). In genere accettavano la conclusione di Wegener che Clusius avesse avuto un ruolo chiave nella creazione della raccolta, ma pensavano anche che non tutti i disegni fossero stati commissionati o ispirati da lui. A puntare in tutt'altra direzione pensò la storica statunitense Claudia Swan che in un saggio del 1995 sostenne che la raccolta non andava attribuita a Clusius, ma a Clutius, ovvero non a Charles de l'Ecluse, ma al suo amico Dirck Outgaertsz. Cluyt, primo hortulanus dell'orto botanico di Leida. L'ipotesi di Swan non ha trovato seguito, ma ebbe il merito di riaccendere il dibattito. In un saggio pubblicato l'anno successivo, la storica dell'arte belga Helena Wille respinse in poche righe la tesi di Swan, per suggerire una propria ipotesi diversa da quella del "libro di Clusius". Le evidenze raccolte da Wegener dimostravano senza dubbio che c'era un legame tra Clusius e la raccolta, "ma ciò che non significava che egli fosse colui che l'aveva commissionata". Sappiamo che Clusius possedeva una biblioteca, una piccola raccolta di curiosità, un erbario, ma non una collezione di acquarelli; inoltre, sempre squattrinato com'era, non avrebbe certo potuto permettersela. Non avendo né un giardino proprio, né adeguate risorse finanziare, la soluzione ideale per studiare piante esotiche e averne le illustrazioni per i suoi libri era ricorrere a un mecenate appassionato di piante. Quando viveva in Austria, l'aveva trovato nel nobile Boldiszar de Batthyani, che l'aveva più volte invitato nel suo castello ungherese e aveva fatto dipingere piante per lui. Un mecenate c'era anche nelle Fiandre, e lo abbiamo già incontrato: Charles de Saint Omer, membro di una delle più illustri casate del paese, appassionato di piante, amico di Clusius, che aveva ospitato sia a Bruges sia nel suo castello di Moerkerke. Anzi, lo abbiamo già incontrato due volte, sotto nomi diversi. I Saint Omer erano originari dell'Artois, ma alcuni rami avevano signorie nelle Fiandre, e il nostro poteva indifferentemente chiamarsi in francese Charles de Saint Omer, in fiammingo Karel van Sint Omaars, ma anche, usando i titoli nobiliari com'era d'uso per un gentiluomo, Charles de Saint Omer, detto di Moerbeke, signore de Moerkercke, Dranoutre (ovvero Ranoutre o Reynoutre), o ancora Mijnheer de Reynoutre. Ovvero il personaggio citato da Lobel, che ci ha già informato che il nobiluomo non aveva lesinato spese per fare ritrarre le sue amate piante. Anzi è proprio sulla base di puntuali corrispondenze tra alcuni acquarelli dei Libri picturati e le corrispondenti immagini del Kruydtboeck di Lobel (1581), nel cui testo viene esplicitamente citato Mijnheer de Reynoutre, che Wille dimostra il ruolo di Charles de Saint Omer come committente della collezione. Inoltre, individua il probabile autore degli acquarelli, o almeno di buona parte di essi, nel valente pittore Jacques (o Jacob) Corenhuyse, membro della Gilda di San Luca di Bruges. Una lettera, inviata nel 1595 a Clusius da Carlo di Arenberg, un altro gentiluomo appassionato di piante, le permette infine di trovare un anello di collegamento tra Charles de Saint Omer, morto nel 1569, e il cancelliere Weinmann che quasi un secolo dopo fece giungere i volumi a Berlino. Arenberg informa il botanico di aver acquistato "le livre de feu Monsieur Ranoutre", (il libro del fu signor Ranoutre), che come abbiamo visto è uno dei tanti modi per designare il defunto Charles de Saint Omer. La lettera era stata già pubblicata qualche anno prima da un archivista, che però non aveva identificato il personaggio. Wille osserva che è comprensibile: il fatto stesso che fosse designato in modo diversi dimostra che "questo eminente amante delle piante era stato davvero dimenticato". Dalla lettera di Arenberg, la studiosa belga ricava un ultimo dettaglio importante: Clusius è stato direttamente coinvolto nella confezione dei Libri picturati, non come committente, ma come esperto: è sua la mano che ha scritto le annotazioni che accompagnano molti acquarelli. Queste dunque le sue conclusioni: "Abbiamo in realtà a che fare con il catalogo dipinto della collezione di oggetti naturali riuniti nello studio e nel giardino di Karel van Sint Omaars, successivamente riordinato e integrato da Karel van Arenberg, anch'egli grande amante delle piante, dipinto per la maggior parte da Jacques van Corenhuyse e annotato da Clusius". 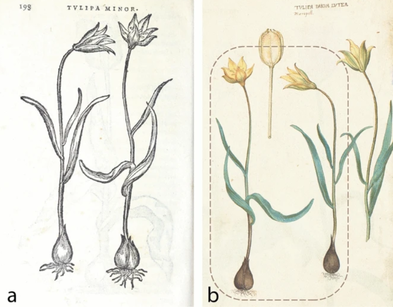 Mijnherr de Reynoutre svelato L'articolo di Wille ha costituito la base per gli studi successivi, che, seppur discostandosi dalle sue conclusioni in alcuni particolari, ne hanno sostanzialmente confermato l'impianto. Di particolare importanza i contributi di Luis Ramón-Laca, che nel 2011 sulla base dei marchi della carte ha dimostrato che la maggior parte degli acquerelli formavano già una raccolta nel XVI secolo; su 1400 fogli, più di 1100 utilizzano una carta prodotta a Fabriano a partire dal 1554. In 625 di questi fogli gli acquerelli sono accompagnati da annotazioni "di una mano professionale", mentre i restanti in genere non sono terminati e spesso corrispondono a xilografie delle opere di Clusius. Le due serie differiscono anche per lo stile: da una parte ci sono acquarelli molto realistici, dipinti dal vivo, quasi sempre annotati, dall'altra disegni molto più schematici, per lo più non terminati e tratti da esemplari d'erbario. Nel 2008 Florike Egmond, una specialista di Clusius di cui ha curato la pubblicazione dell'epistolario, ha fatto il punto sullo stato delle ricerche in un ampio articolo in cui, dopo aver demolito la tesi di Swan con un'ampia argomentazione, analizza in modo puntuale i luoghi e le persone citati nelle annotazioni, la corrispondenza tra le immagini e opere a stampa coeve, le informazioni in nostro possesso su Charles de Saint Omer, le sue collezioni e la sua relazione con Clusius e con i possibili artisti coinvolti, per concludere con un approfondimento sul contesto culturale in cui è nata l'opera, il circolo umanistico di Bruges. E così conclude: "La conclusione appare inevitabile: il nucleo centrale dei Libri picturati A16-30 [...] fu messo insieme e posseduto da Charles de Saint Omer con l'assistenza e la consulenza di Clusius negli anni '60 (probabilmente tra il 1562-63 e il 1568). Clusius stimolò o forse innescò l'interesse di Saint Omer per gli oggetti naturali ed è probabile che lo abbia incoraggiato a far pubblicare i suoi acquarelli botanici [...]. Un considerevole numero di acquarelli appartenenti a questo nucleo sono stati probabilmente dipinti da Corenhuyse e possibilmente da Van der Bosch. Le annotazioni della 'mano professionale' su un gruppo di 625 acquarelli botanici in tutta probabilità sono state fatte da Clusius. Nel corso del XVI secolo alla collezione sono state fatte aggiunte, certamente da Aremberg, possibilmente da Clusius stesso, e probabilmente da altri". Contrariamente a Wille, non ritiene però che i Libri picturati 16-30 siano un catalogo del giardino e della Wunderkammer del castello di Moerkerke, ma piuttosto "una specie di enciclopedia di casa, in cui potevano essere inclusi dipinti, copie di opuscoli su animali curiosi e piante esotiche inviate a Saint Omer, a Clusius o a uno dei loro amici". Nel 2008 l'editore Brill ha pubblicato lo spettacolare volume Drawn after Nature: The Complete Botanical Watercolours of the 16th-Century Libri Picturati, che contiene tutte le immagini botaniche dei Libri picturati 18-30, introdotte da un team internazionale cui si devono anche numerosi saggi che indagano la storia, il contesto e il valore artistico e scientifico di quello che ormai potremmo chiamare "il libro di botanica di Charles de Saint Omer". E' dunque ora di conoscere meglio questo appassionato di piante che ha rischiato di essere totalmente dimenticato. Charles de Saint Omer (1533-1569) alias Karel van Sint Omaars alias Mijnherr de Reynoutre, era il secondogenito di Josse (Joos) de Saint Omer, signore di Oudeneem, Merris e Dranouter, e di Anna van Praet, dama di Moerkerke. Tra i suoi antenati troviamo uomini d'arme e di potere, come il bisnonno Josse, consigliere e ciambellano ordinario prima di Carlo il Temerario poi dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo. Dopo aver forse frequentato l'università a Lovanio, intraprese il mestiere delle armi che però presto dovette abbandonare a causa della salute malferma. Molto ricco e colto, si ritirò a vivere nella tenuta e nel castello di Moerkerke non lontano da Bruges, che aveva ereditato dalla madre (morta nel 1559), dove si dedicò agli studi umanistici, forse alla poesia, e soprattutto alle scienze naturali. Possedeva anche una casa a Bruges, dove in genere trascorreva i mesi invernali, ma Moerkerke era la residenza principale della famiglia. Conosceva diverse lingue: il francese, la sua lingua madre, il fiammingo, il latino, e probabilmente aveva qualche nozione di greco, tedesco e italiano. Come ha sottolineato Florike Egmond, faceva parte del circolo umanistico di Bruges ed era strettamente legato ai fratelli Mathias e Guido Laurin (o Laurinus), che condividevano i suoi interessi naturalistici. Si sposò due volte, prima con Françoise de Blois, detta Trèslong, poi con Anne d'Oingnies, ma non ebbe figli. Della sua vita personale in realtà conosciamo pochissimo. Sappiamo invece qualcosa di più sulle sue collezioni e soprattutto sul suo giardino. Nel castello di Moerkerke c'erano una biblioteca, con opere in greco, latino, francese e italiano, e due gabinetti di curiosità, uno attiguo alla camera del signore, l'altro alla camera della moglie; il primo conteneva oggetti considerati più maschili, come una collezione di armi, il secondo le vere e proprie rarità, compresi "un cofanetto con dentro quattro libri di erbe dipinte", "l'inizio di un libro degli uccelli", "l'inizio di un libro sui pesci e altri animali", "una scatola di minerali". come leggiamo nell'inventario che fu redatto dopo la sua morte. In base al contratto matrimoniale, gli oggetti contenuti nel gabinetto di Anne rimasero di sua proprietà anche dopo la morte del marito. I futuri Libri picturati probabilmente furono venduti dopo la sua morte nel 1577, fino a finire nelle mani di Arenberg, ma non conosciamo i passaggi intermedi. Quanto al giardino, era considerato uno dei più raffinati della regione. E' ricordato anche da Lodovico Guicciardini che ebbe modo di visitarlo e nella sua Descrizione dei Paesi Bassi scrive: "Anche il signor Carlo di Sant'Omero nella signoria di Moerkerke, a un miglio e mezzo da Bruges, ha un giardino con innumerevoli varietà eccellenti e mille altre cose belle che faranno sì che questo luogo, ma anche il Signore, sia famoso e lodato per sempre". Forse esisteva già in precedenza, ma Charles lo rimodellò secondo il gusto del tempo, avvalendosi dei consigli (e delle piante) di Clusius. Si trovava all'esterno della corte superiore del castello, sui lati sud ed est, ed era diviso in due parti: il giardino di piacere e il giardino delle erbe; inoltre c'era un grande frutteto. Nel giardino delle erbe si coltivavano piante sia autoctone sia esotiche, alcune delle quali procurate da Clusius: "sedotto dall'amore per le piante dell'illustre signore di Dranoutere" dalla Spagna gli inviò semi attraverso il comune amico Guido Laurinus; nel 1566 gli donò semi di pepe brasiliano (Schinus terebinthifolia) di cui Saint Omer riuscì a coltivarne un esemplare che fiorì nell'autunno dello stesso anno; gli donò anche uno dei due germogli di Aloe americana che aveva prelevano in un giardino di Valencia e aveva portato con sé nelle Fiandre. E' probabile dunque che ci fosse qualche struttura per proteggere le esotiche dai rigori invernali. Dall'inventario dei beni risulta che nei gabinetti di Charles e Anne c'erano anche "un couffre pour y mectre les semences" (un cofanetto per riporre i semi) e 'ung grand ormaire pour garder sementes', un grande armadio per conservare i semi. Questi ultimi venivano raccolti e conservati per riseminarli nel giardino, ma anche per scambiarli con altri collezionisti, come sappiamo dalla corrispondenza di Clusius. Vengono menzionati anche i nomi dei due giardinieri che si occupavano l'uno del giardino, l'altro del frutteto, rispettivamente Paul de Witte e Zegher de Wever. Inoltre, a Moerkerke c'era anche un piccolo zoo, con animali da fattoria ma anche qualche rarità esotica o curiosa. Secondo la testimonianza di Lobel, Charles de Saint Omer coltivava piante esotiche anche nel giardino della sua casa di Bruges: nel suo Kruydtboeck infatti egli scrive che intorno al 1567 vi cresceva il grano dei turchi, cioè il mais, quasi introvabile nei Paesi Bassi. Per concludere, due parole su Charles de Saint Omer come mecenate di Clusius. Il botanico dovette incontrarlo prima di partire per la Spagna, come si evince dal già citato invio di semi. Al suo ritorno in patria, venne ospitato da Saint Omer dal settembre 1565 al novembre 1567. Egli poté così dedicarsi alla stesura della sua prima opera, la traduzione dei Coloquios dos simples di Garcia da Orta (Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia, 1567). Ma per il suo lavoro di "consulente botanico" riceveva, oltre a vitto e alloggio, anche un salario di 200 lire. Principale frutto dei due anni di coabitazione e collaborazione con Saint Omer, come già sappiamo furono i Libri picturati, che però non vennero né completati né stampati, sia per la morte precoce del nobiluomo, a soli 36 anni, sia per la situazione politica delle Fiandre spagnole, in rivolta dal 1566. Secondo Jacques de Groote, che nel suo sito ha raccolto una grande massa di informazioni su Charles de Saint Omer, egli si ricordò del suo protetto lasciandogli in eredità i suoi libri greci e latini, anche se probabilmente Clusius non riuscì mai a recuperarli (secondo altri, si trattava di libri suoi che aveva lasciato a Moerkerke). Quanto al botanico, nella sua prima opera così ricorda il suo primo protettore: "Un uomo non solo espertissimo in materia di piante e che fece dipingere le piante stesse, gli uccelli e i quadrupedi con eccezionale abilità in colori vivaci, ma anche molto interessato alla natura di ogni sorta di cose meravigliose".  Reynoutria, un pericolo venuto da Oriente Ed eccoci ritornati a Reynoutria, il genere dedicato da Houttuyn al signore di Reynoutre, ovvero a Charles de Saint Omer, separandolo da Polygonum. Una scelta presto messa in discussione: nel 1848 la sua Reynoutria japonica fu riclassificata come Polygonum sieboldii, per poi essere inserita nel genere Fallopia. Le ricerche filogenetiche basate sul DNA ne hanno invece confermato l'indipedenza, anche se vari autori continuano a considerarlo una sezione del genere Fallopia. Ne è derivata una certa confusione terminologica, con la stessa pianta denominata da autori diversi Polygonum, Fallopia o Reynotria. Inteso come genere indipendente, Reynoutria comprende cinque specie accettate, tutte originarie dell'Asia orientale, più un ibrido naturale, R. x bohemica, originato dall'incrocio tra R. japonica e R. sachalinensis. La specie più nota (o famigerata) è R. japonica, originaria di Giappone, Cina e Corea; portata in Europa dal Giappone da von Siebold, incominciò ad essere commercializzata negli anni '40 dell'Ottocento. Entro il 1850, Siebold ne donò un esemplare ai Kew Gardens; il dono fu molto apprezzato e determinò il successo della pianta, che piaceva ai giardinieri perché i suoi fusti assomigliavano ai bambù e "facevano oriente", senza contare che era facile da coltivare e cresceva dappertutto. Verso la fine del secolo si era naturalizzato in varie parti d'Europa, ma dato che nel nostro continente (e in America) non si riproduce per seme, non causava problemi. Le cose sono cambiate nel Novecento, quando la creazione di infrastrutture, i movimenti di terra e le inondazioni ne hanno scatenato le potenzialità invasive. Basta infatti un frammento di rizoma perché attecchisca e incominci a formare una colonia, che diventerà così fitta da escludere ogni altra pianta, inclusa l'erba. Oggi è inserita nella lista delle piante aliene invasive più aggressive e difficili da controllare. E' tuttavia molto bella; chi l'apprezza, può ripiegare sulla cultivar 'Variegata', con foglie cuoriformi spruzzate di giallo, di crescita rapida, ma non considerata invasiva. Lo sono invece anche le altre due specie ampiamente introdotte in Europa. R. sachalinensis, una specie simile alla precedente ma di dimensioni molto maggiori, fu originariamente introdotta (1864) dall'orto botanico di San Pietroburgo per poi diffondersi soprattutto verso la fine dell'Ottocento, quando una prolungata siccità ne favorì l'impiego come foraggio. Introdotta in Italia nel 1897 come ornamentale a Roma, oggi è presente in quasi tutte le regioni settentrionali, in Toscana e in Lazio. Presenta gli stessi problemi di R. japonica e si espande soprattutto lungo i corsi d'acqua, per il trasporto da parte della corrente dei rizomi delle piante che crescono lungo gli argini. L'ibrido tra le due specie R. x bohemica era già coltivata nei giardini inglesi nel 1872, ma è stata individuata e descritta per la prima volta solo nel 1983, per la Repubblica ceca (da cui l'eponimo); è infatti difficile da distinguere dai genitori, con cui è stata a lungo confusa. E' dunque problematico determinare con precisione la data della sua introduzione. Oggi in Italia anch'essa è classificata come aliena invasiva in quasi tutte le regioni dell'Italia settentrionale e in Toscana. Ha probabilmente potenzialità invasive anche R. multiflora (nota anche con il sinonimo Pleuropterus multiflorus), che, a differenza delle altre specie, tutte erbacee perenni decidue, è una rampicante; diffusa dalla Cina all'Indocina, è una specie officinale, uno dei tonici più importanti della medicina traduzionale cinese. Da queste specie aggressive sembra distinguersi R. compacta, una specie di piccole dimensioni con fiori femminili rossastri e fiori maschili biancastri, talvolta coltivata come ornamentale. L'ultima specie, R. cilinervis, originaria della Cina e della Corea, sembra non sia mai stata introdotta nei giardini occidentali. E, viste le sue parentele, verrebbe da aggiungere: per fortuna! Tra il 1683 e il 1685, il farmacista e pittore di origine tedesca Heinrich Claudius prese parte a due spedizioni nel Namaqualand (Sudafrica); durante la seconda, comandata dal governatore van der Steel in persona, fu incaricato di illustrare il diario della spedizione. Le sue illustrazioni della flora sudafricana, tra le primissime a raggiungere l'Europa, attirarono l'attenzione dei collezionisti. Tra di essi anche il sindaco di Amsterdam Nicolaes Witsen, che, non sappiamo se in Europa o a Città del Capo, fece copiare diverse tavole botaniche di Claudius per includerle nella sua collezione di illustrazioni botaniche, il cosiddetto Codex Witsenii. Secondo Boerhaave aveva dimensioni favolose, ma solo pochissimi dei disegni originali che ne facevano parte sono giunti fino a noi, seguendo vie alquanto tortuose. La botanica (per qualche tempo fu anche commissario dell'orto botanico di Amsterdam) non fu per altro che uno dei tanti interessi del multiforme Witsen, non solo uno dei più grandi collezionisti del suo tempo, ma anche uomo politico, diplomatico, cartografo, esperto di costruzioni navali, nonché amico e corrispondente dello zar Pietro il grande. A ricordarlo il singolare genere sudafricano Witsenia, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae. 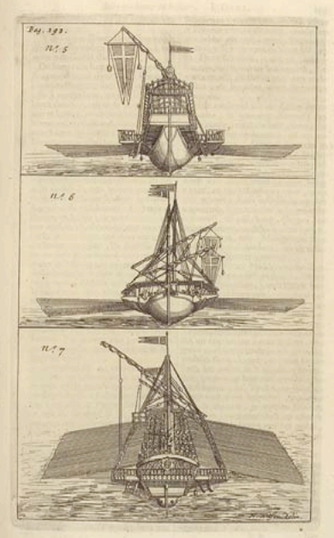 Uno zar eccentrico e un sindaco dai molteplici interessi Nel marzo 1697, il giovane zar Pietro, all'epoca venticinquenne, si imbarcò per quella che è passato alla storia come "Grande ambasciata". La missione aveva un obiettivo diplomatico che non si realizzò (costruire una grande alleanza antiturca), ma anche obiettivi non certo minori agli occhi di Pietro, che furono conseguiti con successo. Egli infatti desiderava anche acquistare armi e attrezzature militari e ingaggiare specialisti che lo aiutassero a modernizzare il suo paese; a cuore gli stava soprattutto la creazione di una flotta all'altezza dei migliori standard europei. Una delle tappe principali del suo viaggio fu dunque la Repubblica delle Province unite, dove giunse ad agosto, dopo aver incontrato il duca di Curlandia e aver stretto un'alleanza con il re di Prussia. Desideroso di apprendere di persona le tecniche di costruzione navale, accompagnato da dodici volontari e vestito con abiti comuni, prima ancora di raggiungere la frontiera olandese Pietro si separò dalla delegazione ufficiale, che proseguiva più lentamente alla volta di Amsterdam, e si imbarcò per Zaandam, dove si trovavano importanti cantieri navali. La mattina stessa del suo arrivo, fu riconosciuto dal fabbro Gerrit Kist che aveva lavorato a Mosca, e lo convinse ad affittargli una stanza nella sua casetta di legno, tuttora conservata. Quindi, per otto giorni, sotto il nome di Pëtr Michailov, lavorò come carpentiere in uno dei cantieri. Tuttavia, la sua presenza non passò certo inosservata, tanto più che Pietro era un gigante di oltre 2 metri. Stufo delle crescenti attenzioni, egli scrisse al sindaco di Amsterdam e direttore della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Nicolaes Witsen (1641-1717) che gli consigliò di spostarsi a Amsterdam dove avrebbe potuto lavorare lontano da occhi indiscreti in uno dei moli della compagna. Così lo zar lasciò Zaandam e il 27 agosto assistette in incognito all'arrivo della delegazione russa, con la quale visitò il municipio e l'orfanatrofio e il giorno seguente i cantieri della VOC. Intanto Witsen si era dato da fare e aveva convinto i vertici della Compagnia ad autorizzare Pietro a lavorare nel cantiere di Oostenburg, dove appositamente per lui sarebbe iniziata la costruzione di una nuova fregata. Così, dal 30 agosto, per 4 mesi, il "mastro Pietro", come amava farsi chiamare, lavorò come apprendista carpentiere nel cantiere della VOC; contemporaneamente, c'erano anche gli incontri ufficiali (il 10 settembre andò ad Utrecht per incontrare lo statolder Guglielmo, che dal 1689 era anche re d'Inghilterra), le visite culturali, gli stages presso esperti, la campagna acquisti di studiosi e artigiani da attirare in Russia. A organizzare molte di queste attività fu Witsen, con il quale lo zar corrispondeva da tempo, tanto da considerarlo un amico personale. Del resto, il borgomastro era noto come il massimo esperto di affari russi dell'Europa occidentale. Nel 1664 aveva vistato la Russia come membro di un'ambasceria e si era trattenuto nel paese per tre anni, spingendosi fino al mar Caspio. Durante i suoi viaggi, incontrò persone di ogni ceto, strinse utili relazioni e raccolse molti materiali etnografici; nel 1667, prima di rientrare in Olanda, fu ricevuto dal padre di Pietro, lo zar Aleksej Michajlovič. Nei vent'anni successivi, continuò a coltivare un grande interesse per la Russia che culminò tra il 1690 e il 1692 con la pubblicazione della prima carta della Siberia e di Noord en Oost Tartarye ("La Tartaria settentrionale e orientale"), un'ampia trattazione di geografia, etnografia, linguistica, flora e fauna di ciò che all'epoca si chiamava Tartaria, ovvero il vastissimo territorio situato tra il Mar Caspio e l'Oceano Pacifico; non la sola Siberia, dunque, ma il Caucaso, l'Asia centrale, l'Asia Interna, e oltre, fino alla Manciuria, la Mongolia, la Corea e lo stesso Giappone. Insieme a un resoconto del suo viaggio in Russia, ne inviò una copia allo zar Pietro, che però era molto più interessato al secondo campo di studio di Witsen: le costruzioni navali. Nel 1671 egli aveva infatti pubblicato la prima edizione di Aeloude and hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier ("Cantieristica e gestione navale antica e contemporanea"), che presto divenne un'opera di riferimento. Lo zar iniziò a corrispondere con Witsen, che divenne di fatto il suo agente ufficioso in Olanda; ne seguì un ordine di navi da guerra ai cantieri navali di Amsterdam e un ukase sul commercio russo-olandese che garantiva alla Repubblica l'importazione di grano, legno, talco, catrame e pellami. Allo studio della cartografia e delle costruzioni navali il multiforme Witsen dedicava il tempo libero. Per tradizione familiare, era infatti una delle personalità più in vista dell'economia e della politica dei Paesi Bassi. Già il padre Cornelis Jan Witsen era stato sindaco di Amsterdam, membro del consiglio dell'Ammiragliato e direttore della Compagnia delle Indie Occidentali. A sua volta, Nicolaes fu borgomastro di Amsterdam per 13 volte (l'ultima nel 1705) e dal 1693 direttore della VOC; nel 1690 fu inviato come ambasciatore straordinario in Inghilterra, dove Guglielmo III si era appena insediato; nel 1702 fu coinvolto nelle trattative tra gli Stati generali olandesi e il re di Prussia. All'epoca, Amsterdam era il porto più trafficato d'Europa ed era il paradiso dei collezionisti; in città si contavano almeno una cinquantina di Wunderkammer, e ovviamente una delle più prestigiose era quella di Witsen, che aveva iniziato a raccogliere curiosità in gioventù durante il viaggio in Russia e continuò ad arricchire gli scaffali e i cassetti del suo gabinetto, avvantaggiandosi della sua posizione di direttore della VOC. Profondamente convinto che le conoscenze scientifiche giovassero agli affari, incoraggiò le ricerche degli agenti della compagnia; protesse Rumphius, il primo studioso della flora delle Molucche; incoraggiò i viaggi di Cornelis de Bruijn, che visitò e dipinse le rovine di Persepoli; promosse la spedizione di Willem de Vlamingh nell'Australia occidentale (1696-97). Dai suoi corrispondenti riceveva informazioni di prima mano, ma anche rarità di varia natura per il suo gabinetto di curiosità. De Brujn gli inviò i suoi disegni di Persepoli e Vlamingh una cassa di conchiglie, frutti e piante australiani, insieme a undici disegni del disegnatore e cartografo della spedizione Victor Victorsz. Negli anni '90, su suo incoraggiamento Herbert de Jager realizzò disegni della flora di Giava (che però nel 1695 vennero sequestrati dalla VOC, che temeva che la loro conoscenza potesse avvantaggiare mercanti rivali). Quella di Witsen, come apprendiamo dal catalogo dell'asta che fece seguito alla sua morte, era una collezione universale: c'erano monete antiche e reperti archeologici, pietre preziose, armi, curiosità etnografiche, oggetti laccati, porcellane e dipinti provenienti dall'Asia. Anche se il suo interesse principale andava alla geografia, all'etnografia e alla linguistica, non disdegnava le scienze naturali: nel suo gabinetto di curiosità c'erano pietre, minerali, fossili, conchiglie, coralli, preparazioni animali (tra cui un rospo del Suriname Pipa pipa sotto spirito), insetti, zanne di mammut, corna di ogni tipo (tra cui una zanna di narvalo, che secondo Witsen era all'origine del mito degli unicorni). Non risulta avesse un erbario, ma certamente possedeva una ricca collezione di illustrazioni botaniche che, secondo la testimonianza di Hermann Boerhaave, giunse a comprendere oltre 1500 tavole. Tuttavia esse non risultano nel catalogo d'asta. Ne conosciamo solo una selezione, però in modo indiretto ed enigmatico. Intorno al 1692, Witsen fece eseguire o piuttosto copiare, non sappiamo se a Città del Capo o in Europa, numerosi acquarelli di piante sudafricane, dipinte dal pittore tedesco Heinrich Claudius, che nel 1685 aveva partecipato come disegnatore ufficiale alla spedizione nel Namqualand diretta dal governatore de Steel. Ne risultò un manoscritto di tre volumi, noto come Codex Witsenii o Codex witsenianus; Witsen, che all'epoca era anche uno dei commissari dell'orto botanico di Amsterdam, lo affidò a Caspar Commelin perché identificasse le piante e ne redigesse il catalogo. Alla sua morte nel 1717, il codice rimase nelle mani di Commelin, che a sua volta morì nel 1731; il catalogo è andato perduto, mentre il Codice fu ceduto a Johannes Burman dalla vedova del figlio di Commelin. Burman ne trasse 92 delle illustrazioni del suo Rariorum africanarum plantarum Decades; altre furono tratte da altri codici, almeno uno dei quali, Herbarium witsenianum, appartenuto allo stesso Witsen. Quindi il codice passò al figlio Nicolaas Laurens; qualche anno dopo la morte di quest'ultimo, nel 1800, la biblioteca dei Burman venne messa all'asta e il codice fu acquistato da un acquirente ignoto e scomparve. Nel 1829 Johannes Andreas Truter, presidente della corte di Giustizia del Capo e membro della Società letteraria del Sudafrica, donò alla stessa un manoscritto, di cui si ignora come fosse venuto in possesso, oggi conservato presso l'Iziko South African Museum di Cape Town. Certamente era uno dei codici utilizzati da Burman, che ne annotò di sua mano diverse parti, e si ritiene generalmente facesse parte del Codex Witsenii. In tal caso, poiché include appena 59 illustrazioni botaniche, ne costituirebbe solo una parte. Altri disegni di Claudius, non sappiamo se passati per le mani di Witsen, sono conservati in diverse biblioteche sia in Europa sia in Sudafrica. Il manoscritto più consistente si trova all'Africana Museum di Johannesburg: consiste di 433 fogli di disegni, 343 dei quali di piante; 78 sono molto simili alle immagini dell'opera di Burman, di cui potrebbero costituire gli originali. Anche questo volume potrebbe dunque aver fatto parte del Codex Witsenii, ma ne ignoriamo del tutto le vicende.  Un fiore singolare e dolcissimo Insomma, il codice Witsen rimane un enigma. Siamo più informati su un altro lascito botanico del borgomastro; nel 1705, quando era ancora in auge (proprio a quell'anno risale il suo ultimo mandato come sindaco; poi la sua stella politica si eclissò e si ritirò a vita privata, lasciando anche la direzione della VOC), fece recapitare all'Orto botanico di Amsterdam due pianticelle di caffè, provenienti da Batavia. Sistemate in serra e curate amorosamente, prosperarono, produssero frutti e semi. La coltivazione di pianticelle di caffè divenne così una specialità del giardino, che le vendeva a un prezzo variabile tra 17 e 26 guilder. Ad acquistarle erano i ricchi collezionisti, ma soprattutto erano destinate alle piantagioni americane. Qualche anno dopo pianticelle e semi da Amsterdam raggiunsero il Suriname; più tardi dal Suriname qualcuno le portò in Brasile. Nel 1715 il sindaco di Amsterdam (che non era più Witsen) ne inviò in dono diplomatico due pianticelle al re Sole; una fu trapiantata nel parco del castello reale di Marly, l'altra al Jardin des plantes di Parigi. Anch'esse prosperarono. Nel 1720, due pianticelle furono affidate al capitano de Clieu perché le portasse in Martinica; dopo un viaggio rocambolesco, riuscì a farne arrivare a destinazione solo una. La sopravvissuta si ambientò così bene che nell'arco di pochi anni la coltivazione del caffè si era estesa a tutte le Antille francesi e alla Guyana. Nel 1728, il governatore Nicholas Lawes introdusse alcune piante della Martinica in Giamaica. Sono le antenate del pregiato caffè Blue Mountain. Ecco perché all'orto botanico di Amsterdam affermano con orgoglio che tutto il caffè del Nuovo mondo discende dalle due pianticelle donate alle sue serre nel lontano 1705 da Nicolaas Witsen. Anche se probabilmente, da buon olandese d'adozione, anche lui amava il caffè, non fu per questo merito, ma come mecenate della scienza che Carl Peter Thunberg volle celebrarlo; nel dedicargli il genere Witsenia, infatti così scrive: "Gli ho dato questo nome in memoria del signor Witsen, borgomastro di Amsterdam, e sommo patrono e protettore delle scienze in generale". La pianta scelta da Thunberg sarebbe sicuramente piaciuta a Witsen, che amava gli aspetti più curiosi e bizzarri della natura. Questo genere monotipico, il cui unico rappresentante è W. maura: insieme a Nivenia e Klattia è infatti uno dei soli tre arbustivi della famiglia Iridaceae. Fu anche il primo del gruppo ad essere descritto: W. maura fu infatti inizialmente pubblicata da Linneo nel 1771 come Antholyza maura. E' una specie piuttosto rara che vive nelle aree costiere, basse e paludose, della Provincia del Capo occidentale, dalla penisola del Capo meridionale a Caledon. Il suo habitat tipico è il fynbos paludoso; purtroppo è seriamente minacciata dall'urbanizzazione e dalle specie aliene invasive. Inoltre, essendo di difficile coltivazione, è raramente coltivata anche nello stesso Sudafrica. E' un vero e proprio arbusto di ragguardevoli dimensioni; di portamento eretto o disordinatamente ricadente, può raggiungere un'altezza di 3 metri; le lunghe foglie lanceolate, verde-glauco e simili anche nella forma a quelle delle iris, sono raccolte a ventaglio e possono superare 1 metro di lunghezza. I fiori, che si aprono nei mesi invernali, sono molto vistosi: raggruppati in cime di 6-8 e lunghi fino a 85 cm, sono disposti in coppie tenute insieme da tre-cinque brattee e hanno tepali, pubescenti all'esterno, nerastri nella metà inferiore e giallo brillante in quella superiore. Non passano certo inosservati! Un richiamo irresistibile per gli uccelli nettarinidi e per lo zuccheriere del Capo Promerops cafer, che impollinandoli si vedranno premiati dal dolcissimo nettare di questa singolare specie, il cui contenuto di zuccheri varia dall'11 al 13%. Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola. Nell'arco di quasi cinquant'anni, dal 1878 ai primi anni '20 del Novecento, l'illustratrice botanica Matilda Smith firmò 2300 tavole per il Curtis' s Botanical Magazine, 1500 per Icones Plantarum di Kew, senza contare innumerevoli disegni per il Bollettino di Kew e altre pubblicazioni. Questa imponente produzione, altamente professionale per precisione, affidabilità e standard medio, era iniziata in modo un po' casuale, per venire in soccorso a suo cugino Joseph Dalton Hooker, e fu sancita nel 1898 dalla nomina a prima artista ufficiale dei Kew Gardens. Già qualche anno primo i meriti di questa valente pittrice erano stati riconosciuti dal botanico tedesco Kuntze con la dedica del bellissimo e scenografico genere Smithiantha (ovvero "fiore di Smith"). 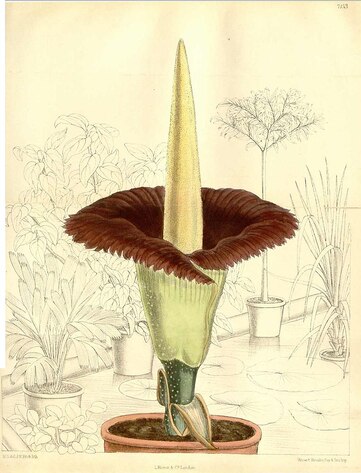 Una pittrice di alta professionalità Nel giugno 1889, c'era grande attesa ai Kew Gardens. Uno dei cormi di Amorphophallus titanum portati da Sumatra nel 1878 dallo scopritore Odoardo Beccari e donati al giardino inglese dal marchese Salviati si accingeva finalmente a fiorire per la prima volta. Con qualche conseguenza non del tutto piacevole, come riferisce Joseph Dalton Hooker sul Curtis' s Botanical Magazine: "Sfortunatamente la fase di fioritura fu così breve che ebbe ben pochi testimoni, che dovettero fare le spese dell'odore atroce, simile a quello di Bulbophyllum beccarii, che nel 1881 durante la sua fioritura aveva reso impraticabile la serra delle orchidee. Sarei ingrato se non esprimessi qui il mio profondo obbligo verso l'artista di talento che con la sua matita ha cercato di rendere giustizia a queste piante, che in questa e in quella occasione ha sofferto un martirio che nel primo caso l'ha fatta ammalare". L'"artista di talento" che nel 1881 e nel 1889 sfidò quell'olezzo per ritrarre dal vivo la fioritura di quelle rarità era Matilda Smith (1854-1926), dal 1879 una degli illustratori botanici che preparavano le tavole per la prestigiosa rivista, di cui Hooker figlio era il curatore fino dal 1865, quando era succeduto al padre nel doppio ruolo di curatore del Curtis e direttore di Kew Gardens, Matilda Smith era sua cugina di secondo grado, e fu lui ad incoraggiarla a coltivare l'arte dell'illustrazione botanica quando venne a trovarsi in una situazione difficile. Per quarant'anni, il principale illustratore della rivista era stato Walter Hood Fitch, che aveva anche creato molte tavole, tanto accurate quanto splendide, per le opere di entrambi gli Hooker e altri eminenti botanici. Tuttavia, nel 1877, una disputa sulla paga divise le sorti di Fitch e Hooker junior, che fu costretto ad affidare gran parte del lavoro a sua figlia Harriett Ann (nota con il nome da sposata Thilseton-Dyer). Fu in queste circostanze che, nonostante la scarsa esperienza e le quasi nulle conoscenze di botanica di Matilda, Hooker le impartì i primi rudimenti e la mise a bottega al fianco di Harriet Ann; per qualche tempo, le due giovani donne lavorarono insieme, e Matilda imparò il mestiere; a partire dal 1879, ogni numero della rivista comprese 20 sue tavole; dal 1887, divenne di fatto la principale, se non la sola, illustratrice del Curtis; nei quarant'anni in cui avrebbe lavorato per la rivista (1878-1923), avrebbe prodotto 2300 tavole, notevoli per la chiarezza del tratto e la precisione. Collaborò intensamente anche a Icones Plantarum, la grande serie di illustrazioni botaniche tratte dall'erbario di Kew, iniziata da William Jackson Hooker e proseguita dal figlio; dalla tavola 1354, fu l'unica artista di questa pubblicazione, per la quale creò 1500 tavole. Solitamente è lodata per la capacità di far rivivere e rendere credibili esemplari appiattiti e disseccati. Per i Kew Gardens realizzò anche le tavole mancanti di molti volumi della biblioteca. Solo nel 1898, la sua dedizione fu infine premiata con la designazione a prima artista ufficiale del giardino: come tale, si dedicò soprattutto all'illustrazione delle nuove introduzioni, collaborando a innumerevoli pubblicazioni. Nel 1916 fu la prima donna a diventare presidente della Gilda di Kew, un'associazione che riunisce coloro che hanno o hanno avuto una posizione di responsabilità nell'orto botanico; nel 1921 fu la seconda donna ad essere ammessa alla Linnean Society. Lo stesso anno andò in pensione; nel 1926, anno della sua morte, fu premiata dalla Royal Horticultural Society con la medaglia d'argento Veitch. In suo memoria, negli anni '60 del Novecento la Gilda di Kew istituì il Matilda Smith Memorial Prize, destinato al migliore "studente pratico", come in effetti fu anche lei.  Un genere decisamente pittorico Tra i tanti botanici che si avvalsero della collaborazione di Matilda Smith, troviamo anche Stephan Troyte Dunn, che lavorò a più riprese all'erbario di Kew; nel 1920 le dedicò Smithiella myriantha (oggi Pilea myriantha), con un'eloquente motivazione: "Questo genere è rispettosamente dedicato a Miss Matilda Smith, e il nome specifico della prima specie si riferisce non immeritatamente tanto ai suoi innumerevoli fiori quanto al grandissimo numero di bei disegni e dipinti con i quali per così tanti anni essa ha illustrato il Botanical Magazine, le Icones Plantarum e il Bollettino di Kew". Anche se il genere creato da Dunn è ridotto a sinonimo, vale la pena di citarlo perché le sue parole inquadrano bene il senso dell'opera di Matilda Smith. Che, del resto, non era sfuggito a Kuntze che già nel 1891 le aveva dedicata Smithiantha: "Dedico questo genere alla botanica e disegnatrice Miss Smith, che, amabile signorina dell'erbario di Kew, ha fornito costantemente i disegni per le Icones Plantarum di Hooker, elaborando un proprio metodo di analisi. Tutte le illustrazioni firmate con il modesto "M. S. del." [Matilda Smith delineavit] sono sue. Merita di unirsi ai ranghi delle celebri pittrici che l'hanno preceduta, ad esempio Blackwellia per Elisabeth Blackwell, Meriana Trew (Vell.) per Maria Sybilla Merian, Northia Hk.f. per Miss Marianne North, la donatrice e unica pittrice della famosa North' Gallery nei Royal Kew botanic Garden, allo stesso modo che prendono il nome da disegnatori botanici e pittori maschi vari generi di piante, ad esempio Bauera, Andrewsia, Redoutea, Fitchia, Hookera [per l'artista William Hooker, non per gli Hooker di Kew], Bikkia, Govindooia, Ehretia, Isidrogalvia, Matisia, Spaendoncea". L'interesse di questa dedica sta soprattutto nel fatto che Kuntze inserisce Matilda Smith, al di là dei suoi meriti particolari, in una tradizione, in cui le pittrici non sono più eccezioni, ma incominciano a trovarsi alla pari, come professioniste, ai colleghi maschi, famosi o meno, di cui ci fornisce una lunga lista. In effetti, gli studiosi hanno sottolineato che proprio con Harriet Ann Hooker Thilseton-Dyer e Matilda Smith per le donne l'illustrazione botanica si trasforma, da pratica occasionale o attività ricreativa, in una vera e propria professione, in cui sono richiesti, più ancora dell'estro artistico, la precisione, l'affidabilità e la continuità, nonché la capacità di conciliare una produzione massiccia con un accettabile standard di qualità. Il genere scelto da Kuntze per onorare Matilda Smith appare eminentemente adatto a una pittrice perché raggruppa piante di bellezza scenografica; nelle riviste dell'Ottocento, soprattutto in Flore des Jardins et des serres di van Houtte, le troviamo spesso raffigurate sotto il vecchio nome Naegelia. Era uno dei generi di Gesneriaceae creati da Regel nel 1848; Kuntze lo sostituì in quanto illegittimo (essendo in conflitto con Naegelia Zoll. & Moritzi, creato nel 1846). Oggi le sono assegnate sei specie, distribuite nelle foreste montane di Messico e Guatemala; sono erbacee perenni abbastanza grandi, con tuberi scagliosi, fusti eretti, foglie spesso esse stesse decorative e fiori a campana molto numerosi riuniti in grandi racemi; le corolle hanno colori pastello, che vanno dal bianco al rosa al giallo, oppure più vivaci, dall'arancio al rosso, spesso con marcature più scure. Come spesso in questa famiglia, tendono ad essere piuttosto variabili, nonché ad ibridarsi; divennero così uno dei cavalli da battaglia dei vivaisti belgi, in particolare di van Houtte, che ne selezionò diverse varietà e tentò ibridi intergenerici con Achimenes (x Achimenantha) e Eucodonia (x Smithcodonia). Questi ibridi sono perduti, ma c'è stata una riscoperta alla fine del Novecento, con la produzione di un certo numero di nuovi ibridi; tra i papà di questa nuova generazione di ibridi si segnala il texano Dale Martins, con all'attivo numerose varietà di grande bellezza. Con due libri dal ricercato titolo greco, Fabio Colonna segna una tappa decisiva per l'avvento della botanica come scienza, negli anni a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Membro dell'Accademia dei Lincei, ha ancora la formazione erudita di stampo classico e la vastità di interessi dell'uomo universale del Rinascimento, ma è già a tutti gli effetti un uomo della nuova scienza, corrispondente di Galileo e scienziato sperimentale, che più che all'auctoritas degli antichi si affida al libro della natura. I suoi contributi alla nascita di un metodo scientifico per studiare le piante e determinarne i generi gli guadagnarono il plauso di Tournefort e Linneo, per non parlare di Plumier che gli dedicò il sontuoso genere Columnea. 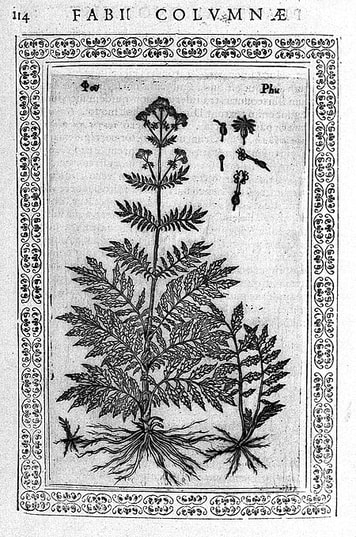 La botanica come cura Forse, se avesse goduto di buona salute, il napoletano Fabio Colonna (1567-1640) non sarebbe mai diventato un naturalista. Esponente di un ramo cadetto della celebre famiglia romana, nel 1589 si laureò utroque iure all'Università di Napoli, ma la salute precaria gli impedì di esercitare la professione. Spirito indagatore, per trovare rimedio ai suoi mali, e in particolare ai ricorrenti attacchi di epilessia, si rivolse ai testi degli antichi, a cominciare da Dioscoride, dove lesse delle proprietà antiepilettiche di una pianta chiamata Phu. Incominciò così a battere le campagne alla sua ricerca; il risultato fu che si innamorò della botanica e fece scoperte ben più interessanti dell'identificazione delle piante di Dioscoride, croce e delizia dei botanici del Rinascimento. Ma qui lascio volentieri la parola a Michele Tenore: "L'impegno di riconoscere nelle campagne la pianta che l'Anazarbeo chiamava Fu [...] lo condusse a scorrere le nostre selve, i nostri boschi e i monti; ove siccome doveva necessariamente avvenire, con giornaliero paragone delle descrizioni di Dioscoride con le piante che incontrava, invece del Fu di questo Autore, che scambiò con la Valeriana officinalis [...], riconobbe non solo la maggior parte delle piante mentovate dagli antichi scrittori; ma anche moltissime altre proprie del nostro suolo che egli scopriva per la prima volta". Nelle sue scorribande botaniche, che, a detta di Tenore, dovettero giovargli ben più del supposto rimedio dioscorideo, per memoria delle piante che incontrava, e per meglio confrontarle con le descrizioni degli antichi, Colonna dovette iniziare ad allestire un originale erbario ad impressione, testimoniato dal magnifico manoscritto in due volumi conservato a Blickling Hall nel Norfolk e intitolato Icones ipsis plantis ad vivum expressae quoad fieri potuit nova quadem arte excogitata ab ipso auctore Fabio Columna pro ipsius oblectatione, studio e memoria. Perfezionando una tecnica attestata fin dal secolo precedente, Colonna cospargeva di pigmenti l'esemplare, fresco o essiccato, ma sempre raccolto in natura (la coltivazione, aveva osservato, altera l'aspetto delle piante), quindi lo pressava su un foglio; ma, a differenza di Boccone o altri, a questo punto disegnava i particolari che l'impressione non conservava, talvolta aggiungendo anche i colori originali ad acquerello. Il poderoso erbario (oltre 500 fogli) fu certo il frutto di ricerche di molti anni, ma è probabile che egli lo abbia iniziato prima del 1592, data di pubblicazione dell'opera frutto di quelle prime escursioni e ricerche. Per identificare le piante di Dioscoride, Colonna, figlio di un agguerrito filologo ed egli stesso perfetto conoscitore delle lingue antiche, non rifuggiva dalla critica testuale, ma cercava la risposta soprattutto nel confronto tra le succinte e spesso criptiche descrizioni del testo greco con le piante raccolte in natura, minuziosamente osservate o "interrogate". E' questo il senso del curioso titolo della sua prima opera, Phytobasanos, sive plantarum aliquot historia. Come spiega Eva Cantarella, in greco il termine basanos originariamente indicava la pietra di paragone, utilizzata per saggiare l'oro, "da questo passò a indicare qualunque strumento o procedimento utile a 'mettere alla prova' una persona: e dunque, successivamente, anche la pratica che noi chiamiamo tortura". Ecco perché Phytobanos è stato variamente tradotto "Interrogazione delle piante", "Pietra di paragone della piante", "Tortura delle piante". La breve opera, stampata a Napoli a spese dell'autore nel 1592 (all'epoca Colonna aveva 25 anni) e dedicata al cardinale Marcantonio Colonna, è divisa in due parti; la prima analizza 26 piante di Dioscoride, ricavandone l'identificazione, più che dall'analisi filologica e dai pareri di altri studiosi (anche se non mancano né l'una né gli altri), dalla accurata e minuziosa descrizione della pianta stessa; la seconda parte, che si aggiunse in corso d'opera, durante la stampa della prima, tratta quattro animali marini e altre otto piante, che dovrebbero essere "nuove", cioè non descritte in precedenza. Lo era davvero la splendida Primula palinuri, che Colonna, il suo scopritore, identifica invece con la dioscoridea Alisma. Parte integrante dell'opera sono le 37 incisioni calcografiche a piena pagina, sicuramente almeno in parte ricavate da impressioni e disegni dello stesso Colonna. E' la prima volta che l'incisione su rame, con i suoi tratti molti più fini di quella su legno, viene applicata alla botanica; ed è anche la prima volta che, accanto alla pianta stessa, completa di radici, vengono raffigurati a parte, ingranditi, particolari essenziali per l'identificazione, come gli organi della fruttificazione. Stando a quanto scrive Colonna nella prefazione Ad lectorem, l'opera fu per lui, autodidatta ("nullo mostrante, aut docente"), un laborioso apprendistato; ma certo si avvalse dei consigli del farmacista Ferrante Imperato, che poi divenne il suo maestro e lo indirizzò anche allo studio dei fossili. Nel 1599, quando Imperato diede alle stampe Dell'historia naturale, Colonna contribuì con alcune tavole di serpenti disegnati dal vero. Grande influenza su di lui esercitò anche Giambattista della Porta, che più tardi l'avrebbe introdotto all'Accademia dei Lincei. 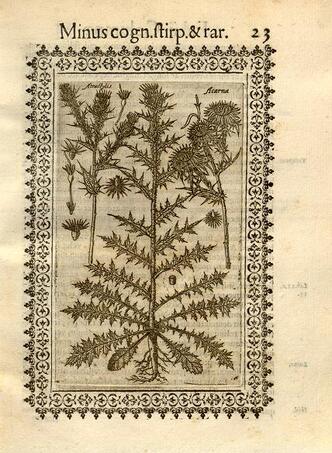 Un metodo per determinare i generi Dopo il 1593, anche se la stampa di Phytobasanos aveva alquanto intaccato il suo scarso patrimonio, ora che la migliorata salute gli permetteva di viaggiare, Colonna estese le sue ricerche oltre i confini del Napoletano, approfittando dei legami familiari. Per qualche tempo soggiornò presso un fratello a Campochiaro, dove studiò la flora del Matese, poi fu a Cerignola presso uno zio, quindi passò al servizio del duca di Zagarolo Marzio Colonna, mettendo finalmente a frutto le sue competenze giuridiche nella risoluzione di complesse controversie di confini. Era anche di frequente a Roma, dove poteva ammirare gran copia di piante esotiche nei giardini dei porporati come i famosi orti farnesiani. Ma a interessarlo erano soprattutto le specie "che nascono sotto il nostro cielo". Anche se non manca qualche esotica, sono soprattutto loro le protagoniste della seconda, più ampia opera di Colonna, Minus cognitarum stirpium aliquot ac etiam rariorum nostro coelo orientium Ekphrasis, la cui prima parte uscì a Roma presso Facciotto nel 1606. Il termine Ekphrasis è preso in prestito dal lessico artistico, dove indica la descrizione verbale, il più possibile dettagliata, di un'opera d'arte. Vi ritroviamo infatti le accuratissime descrizioni che già caratterizzavano Phytobasanos, nonché le splendide tavole calcografiche basate su disegni dello stesso Colonna; ad essere nuova è invece la consapevolezza metodologica. Ormai il botanico napoletano ha elaborato un solido metodo per lo studio scientifico delle piante, a partire dalla riconoscimento dell'importanza per la classificazione dei fiori e dei semi, ed ha maturato un metodo che farà l'ammirazione di Tournefort, che riconobbe in lui lo scopritore della "constituendorum generum ratio", ovvero del metodo per la determinazione dei generi. Né minore fu la considerazione di Linneo, che lo proclamò "primo di tutti i botanici". Importanti anche i suoi contributi alla terminologia, tra l'altro con la creazione del termine "petalo". Già pronta intorno al 1603, ma ritardata dai soliti problemi finanziari, l'opera fu dedicata da Colonna al duca di Zagarolo: tuttavia, nonostante l'alto valore scientifico e le splendide illustrazioni (in questa prima edizione sono 114, 102 delle quali dedicate a piante, le altre ad animali marini e terrestri, incluso un ippopotamo) non ebbe molta fortuna. Per qualche tempo Colonna fece la spola tra Roma e Napoli, dove tornò definitivamente intorno al 1610. In questa fase, il suo interesse principale si spostò sui fossili, con la determinazione dell'origine animale delle cosiddette glossopietre: non lingue di serpente, come si credeva, ma denti di squalo pietrificati. Nel 1612, grazie alla raccomandazione di Della Porta, entrò a far parte della colonia napoletana dell'Accademia dei Lincei di cui fu l'undicesimo membro nonché uno degli esponenti più attivi, divenendo uno stretto collaboratore di Cesi, anche come consulente e procuratore; corrispose con Galilei e fu tra i primi a capire le potenzialità dei suoi nuovi strumenti ottici. Ispirato dalle esperienze dello scienziato pisano, costruì da solo un cannocchiale con il quale replicò le osservazioni galileane del Sole e della Luna. Ancora maggiore fu il suo entusiasmo per il microscopio, che Galileo chiamava occhialino ed egli propose di battezzare enghiscopio "che vol dir occhiale da vicino, a differenza dell'altro che vede di lontano". Insoddisfatto dello strumento che Galileo aveva donato a Cesi, ne costruì uno con una lente da lui stesso molata di ampio diametro, che utilizzò per osservare l'anatomia delle api. Queste osservazioni era finalizzate a un'opera celebrativa offerta dai Lincei al cardinale Matteo Barberini, appena eletto pontefice con il nome Urbano VIII: le api, accampate sul loro stemma gentilizio, erano infatti il simbolo della famiglia Barberini. Nel 1615, alla morte di Della Porta, Colonna divenne viceprincipe, ovvero capo della colonia napoletana. Ed è orgogliosamente come Linceo che figura nel frontespizio della seconda, più ampia edizione di Ekphrasis, stampata a Roma nel 1616 da Mascardo, il tipografo di fiducia dell'Accademia; si è aggiunta qualche pianta, ma soprattutto due appendici, una dedicata alle glossopietre, l'altra alla porpora, ma soprattutto ai molluschi da cui è ricavata. Fu proprio De purpura ad assicurargli una certa fama europea; Colonna vi fonde le competenze antiquarie, con citazioni di Plinio, Aristotele, Dioscoride, la conoscenza della letteratura più recente (tra i nomi citati, Guillaume Rondelet), con l'indagine zoologica diretta delle diverse specie di molluschi del Tirreno meridionale, di cui esamina una ventina di specie, elencando anche i luoghi di crescita, da lui visitati personalmente. Intorno al 1624, Colonna fu coinvolto nel più ambizioso progetto collettivo dei Lincei, Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, più noto come Tesoro messicano, ovvero la pubblicazione commentata dell'epitome che Nardo Antonio Recchi aveva tratto dall'opera di Hernandez sulla natura messicana (le cui complesse vicende editoriali sono riassunte in questo post). Inizialmente, Cesi aveva affidato la parte botanica a Giovanni Faber e Giovanni Terrenzio, ma dopo la partenza di quest'ultimo per la Cina, insoddisfatto delle succinte note da lui redatte, si rivolse a Colonna, che, nuovamente afflitto da problemi di salute, accettò con riluttanza, soprattutto per non scontentare il principe. Temeva infatti di non essere sufficientemente aggiornato sugli sviluppi della botanica, che proprio in quegli anni stava facendo rapidi progressi (basti pensare che nel 1623 era uscito il Pinax di Caspar Bauhin). Ma, una volta entrato nel progetto, vi lavorò con il consueto impegno e serietà, redigendo le Annotationes et Additiones, che consegnò nel luglio 1628, in tempo per essere incluse nel primo volume, di cui avrebbero costituito la terza parte (pp. 847-899); sono prevalentemente dedicate alle botanica, tranne le ultime quattro, dedicate ai mineralia. Colonna, nell'esaminare le piante messicane e nel confrontarle con analoghe specie già note, ha modo di approfondire il metodo di determinazione dei generi; aggiunge inoltre la trattazione di alcune piante esotiche, non necessariamente messicane, e talvolta neppure americane. Ad esempio, in Narcissus indicus serpentarius riconosciamo il sudafricano Haemanthus coccineus, che negli stessi anni è descritto anche da Ferrari. E' invece nordamericano il Flos cardinalis Barberini, che Colonna dedicò a Francesco Barberini, protettore delle arti e della scienza, prendendo spunto dal colore rosso dei fiori, lo stesso della veste cardinalizia. Oggi si chiama Lobelia cardinalis, conservando l'eponimo voluto da Fabio Colonna. Dopo la morte di Cesi (1630), che ritardò per un ventennio l'effettiva diffusione del Tesoro messicano, Colonna fu indicato come suo possibile successore, ma la proposta non ebbe seguito. Poco sappiamo dei suoi ultimi anni, certo funestati da difficoltà finanziarie e crescenti problemi di salute. Morì nel 1640. Vale la pena di ricordare, tra i suoi poliedrici interessi, anche la musica; gli si deve anche la creazione di uno strumento musicale, il pentecontachordon o sambuca lincea, una specie di cembalo con 50 corde.  Magnificenze tropicali Come esploratore della flora dell'Italia centro-meridionale, si deve a Colonna la scoperta di almeno una ventina di specie. Diverse portano l'epiteto columnae (dalla forma latina del suo nome, Fabius Columna); tra di esse Doronicum columnae, Aubrieta columnae, Romulea columnae. Ci porta invece nell'America tropicale il genere Columnea, che gli fu dedicato da Plumier con un vero e proprio peana: "Fabio Colonna, nobile romano, nato in quella antica ed illustrissima famiglia, che occupa il primo rango tra le più nobili famiglie italiane, da lodare sopra tutti per la squisita conoscenza della storia naturale. In effetti, in questo campo nulla è paragonabile alle opere di un uomo così grande, che si guardino le immagini disegnate di sua mano o le descrizioni e le dissertazioni critiche". Già sappiamo quanto lo ammirasse anche Linneo, che fece proprio il genere. Con oltre 200 specie riconosciute, Columnea L. è il più vasto dei generi delle Gesneriaceae neotropicali. Ovviamente, è anche uno dei più vari. Diffuso dal Messico alla Bolivia e verso Est fino allo stato di Amapá in Brasile, trova il suo habitat ideale nelle foreste pluviali, dove può disporre di umidità tutto l'anno; è a sua agio soprattutto in quelle fresche ad altitudine media. Anche se il genere comprende anche arbusti ed erbacee, è fondamentalmente rappresentato da epifite che vivono sui tronchi e tra i rami degli alberi della foresta pluviale, a volte anche a considerevole altezza. Possono essere erette, ricadenti o rampicanti, e hanno per lo più foglie in coppie opposte, carnose, lucide, da ovate a lineari. Le specie più frequentemente coltivate e più utilizzate per la creazione di ibridi, come C. hirta, C. linearis o C. magnifica, appartengono alla sezione Columnea, caratterizzata da fiori tubolari fortemente bilabiati, con i due lobi superiori fusi a formare una specie di cappuccio, o galea; in genere la corolla è rossa, ma talvolta aranciata o rosa. Per la loro forma, che ricorderebbe un pesce rosso, in inglese vengono chiamata flying fish plants. La sezione Ortholoma è invece caratterizzata o da corolle piccole così fittamente ricoperte di peli da nascondere la corolla stessa (è il caso di C. purpurata) o da appendici poste alla base dal calice, che sembra emergere da una soffice palla di peli (è il caso di C. minor). I fiori delle sezioni Collandra, a sua volta assai varia, sono in genere molto meno colorati; in alcune specie a dare spettacolo e a fungere da richiamo sono le foglie: quelle di C. consanguinea sono segnate da una vistosa macchia rossa traslucida a forma di cuore. La sezione Pentadenia raggruppa specie per lo più terrestri, erbacee o arbustive, alte ed erette, con fiori tubolari o imbutiformi. Anche le specie della sezione Stygnanthe sono per lo più terresti, con corolle tubolari prive di lobi. Infine, la sezione Angustiflorae riunisce specie erbacee epifite, con rami sottili e corolla tubolare stretta ed allungata, non bilabiata. Alle già numerose specie si sono aggiunte dozzine di ibridi, in genere considerati più adattabili e quindi più facili da coltivare rispetto alle specie; inoltre spesso sono in grado di fiorire tutto l'anno. Tra i più notevoli, 'Bonfire', con corolla fortemente bilabiata, tubo giallo-aranciato e apici dei lobi rossi; 'Orange Fire', con calice verde piumoso, lungo tubo giallo e piccoli lobi arancio; 'Early Bird' (una delle varietà più popolari), con corolla bilabiata, tubo giallo vivo e galea arancio; 'Broget Stavanger' ha invece lunghi rami ricadenti e foglie variegate. Per una selezione di specie si rimanda alla scheda. Anche se siamo da tempo entrati nell'era dei cataloghi on-line, sono ancora molti i vivai e i negozi di sementi che mettono a disposizione dei clienti cataloghi cartacei. Quasi sempre, si punta sulle immagini, con didascalie e indicazioni ridotte al minimo. In fondo, è ancora il formato inaugurato dal primo catalogo commerciale di piante a noi pervenuto: il Florilegium aplissimum et selectissimun, predisposto dal mercante olandese Emanuel Sweert per la fiera di Francoforte del 1612. Le sue immagini a grandezza naturale sono così belle da aver indotto Linneo a dedicargli l'interessante genere Swertia (Gentianaceae). 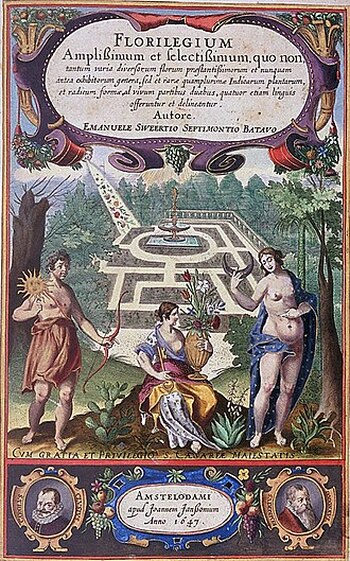 Florilegio o catalogo? Come sempre, anche nell'anno di grazia 1612 la fiera d'autunno di Francoforte aveva attirato visitatori da tutto l'impero e oltre; tra gli stand di maggiore richiamo, quello del mercante olandese Emanuel Sweert; non era la prima volta che partecipava alla fiera, ma quell'anno offriva una selezione particolarmente ricca di bulbi e piante esotiche, portate dalle Indie orientali e occidentali dalle navi della Repubblica delle Province Unite. Diverse vareità si vedevano per la prima volta; e c'era un'altra novità: per permettere agli acquirenti di farsi un'idea di che cosa stavano per acquistare, Sweert aveva fatto stampare un catalogo con più 500 piante magnificamente illustrate. Quell'opera dovette fare sensazione. Era lo spettacolare Florilegium aplissimum et selectissimum, stampato per conto di Sweert da due tipografi della città tedesca, Antonius Kempner e Erasmus Kempffer. Per il grande formato (34 x 21 cm), il numero di tavole (ben 110), la tecnica utilizzata (l'ancora recente calcografia), la bellezza e la cura dei disegni a grandezza quasi naturale, rientrava in un genere editoriale che stava diventando di moda, molto praticato anche da artisti e incisori di Francoforte: il florilegio, ovvero la raccolta di illustrazioni di fiori. Ma era anche altro: appunto uno catalogo commercialedi piante, il primo giunto sino a noi. Quasi tutto ciò che sappiamo sull'uomo che l'aveva commissionato proviene dal catalogo stesso. Emanuel Sweert (o Sweerts, o ancora alla latina Swertius, 1552-1612), come è dichiarato nel cartiglio del frontespizio, era nato a Zevenberger nel Brabante settentrionale, ma si era trasferito ad Amsterdam prima del 1584. Al momento della stampa del Florilegium era sessantenne, come recita la scritta che contorna il suo ritratto anteposto al testo. Nella prefazione Ad candidum lectorem rivela che fin da giovane egli aveva amato viaggiare e collezionare "le mirabili creature di Dio onnipotente" e le curiosità che i marinai olandesi portavano dalle Indie orientali ed occidentali, nonché dalle plaghe australi e settentrionali; ma su ogni cosa ad ispirare la sua massima ammirazione era la straordinaria varietà di piante, alberi, erbe e soprattutto fiori. Che le piante non si limitasse a collezionarle, ma le vendesse la dice esplicitamente l'annuncio pubblicitario stampato sul retro del frontespizio: "Signori, se qualcuno desidera acquistare questo libro e le piante e fiori che vi sono descritti, li troverà nel corso della fiera di Francoforte nella Roemerplatz o nella bottega dell'autore davanti al municipio; oppure, successivamente, alla fiera di Amsterdam e presso il tipografo Paulus Arnoldus van Ravenstein". Che, per inciso, era il marito di una delle sue figlie. Proseguendo nella lettura, risulta chiaro che Swertius era attivo sul mercato internazionale come mercante sia di piante sia di curiosità venute da tutto il mondo (conchiglie, minerali, fossili, insetti e così via) e che il suo migliore cliente era l'imperatore Rodolfo II, che cercò inutilmente di convincerlo a dirigere i suoi giardini a Praga e lo incoraggiò a pubblicare il florilegio-catalogo. Che fosse ben inserito nell'ambiente colto olandese ce lo dicono anche le due liriche che seguono la prefazione; al di là degli elogi sperticati tipici del genere encomiastico, si devono a due personaggi di un certo spessore. Il primo è il poeta neolatino Damas van Blyenburg, autore tra l'altro di una grande antologia di poesia erotica intitolata Veneres Blyenburgicae sive amorum hortus (ovvero giardino degli amori), che raccoglie 1137 poesie di 148 autori, distribuite in cinque "aiuole". Il secondo è Outgers Cluyt (Augerius Clutius), figlio del capo giardiniere dell'orto botanico di Leida all'epoca di Clusius, a sua volta botanico, viaggiatore, raccoglitore di piante e medico ad Amsterdam. Clusius era indubbiamente uno dei numi tutelari di Swertius, che volle fosse ritratto ai piedi del frontespizio, insieme a Dodoens; infatti (lasciando sottotraccia lo scopo commerciale), sempre nella prefazione egli dichiara che il primo scopo del suo libro è ridare vita alle innumerevoli forme delle piante dottamente descritte dai sapienti fiamminghi Dodoens, L'Obel e soprattutto Clusius; ma i loro testi erano corredati di piccole immagini, ben lungi dall'accontentare gli amatori; quindi prosegue "in questo grande formato ho messo ogni diligenza non solo nel rappresentare la vita, ma anche pressoché la grandezza dei fiori e dei loro bulbi o radici, così come crescono d'ordinario". Se ne è dedotto che Swertius fosse anche un'artista botanico (pittore e/o incisore) e fosse l'autore di almeno alcune di quelle splendide immagini. Su questo punto però gli studiosi sono divisi. Per alcuni, egli si limitò a far disegnare e a far incidere a artisti (o meglio ancora artigiani sconosciuti) immagini attinte da opere di Mattioli, Dodoens, L'Obel e Clusius, e per le bulbose da un florilegio pubblicato l'anno prima sempre a Francoforte, il Florilegium novum di Johann Theodor de Bry (il nonno di Maria Sybilla Merian), che a sua volta le aveva in gran parte riprese, a volte ruotandole di 180 gradi, dal florilegio di Vallet e Robin Le Jardin du roy très chrestien Henry IV. Carla Oldenburger-Ebbers pensa il contrario: poiché Sweert ottenne il privilegio di stampa del suo catalogo già nel 1609, le tavole del volume sulle bulbose (tra l'altro, molto migliori tanto nel disegno quanto nell'incisione di quelle del secondo volume, tutte attinte da erbari precedenti) potrebbero essere state preparate prima del 1612, e potrebbe essere stato de Bry a copiare da Sweert e non viceversa. La questione però è tutt'altro che risolta, quindi è impossibile definire lo status professionale dell'olandese: solo vivaista e mercante, o anche pittore e incisore? Da parte mia, propendo per la prima ipotesi: mente de Bry era un brillantissimo incisore, di cui conosciamo molti altri lavori, non ci è nota nessun altra opera di Sweert; difficile pensare che abbia potuto produrre disegni così precisi e raffinati e padroneggiare a tal punto la tecnica dell'incisione a bulino se non fosse stato un professionista. Il suo status di mercante è invece confermato dall'atto di battesimo del più giovane dei suoi figli, Hieronymus, nato nel 1603 (che invece è un pittore noto, padre di un anche più noto omonimo, tipografo, editore, incisore e poeta). Ma è ora di sfogliare questo splendido catalogo. Scritto in quattro lingue (latino, olandese, tedesco e francese) per raggiungere una clientela internazionale, dopo una paginetta con succinte istruzioni di coltivazione, elenca le specie e varietà poste in vendita, con descrizioni essenziali (spesso limitate al colore), seguite dalle tavole calcografiche. E' diviso in due parti o libri. Il primo, più cospicuo, è dedicato alle piante all'epoca più amate e ricercate, ovvero le bulbose, per un totale di 330 specie o varietà e 67 tavole e si conclude con un elenco di "piante esotiche delle Indie orientali e occidentali e altre, che vedono ora la luce con l'opera di Emanuel Sweert, ovvero inedite", in tutto 27, tutte bulbose o rizomatose. Il secondo libro elenca 243 specie tra perenno da fiore e le tipiche piante da aranciera, come limoni, oleandri e melograni, illustrate in 43 tavole. Non mancano però anche altre curiosità, come la melanzana (mala insana), il pomodoro (poma amoris) e la patata (papas americanorum) o i cinque "fiori africani" della tavola 26 che sono riconoscibilissimi Tagetes (per inciso, originari del Messico). Tra le bulbose, tralasciando i generi minori, di cui sono poste in vendita una o due varietà, troviamo in ordine alfabetico 38 varietà di anemoni, 8 di crochi primaverili e 6 di crochi autunnali, 10 di colchici, 4 di ciclamini, 2 di corona imperiale e 7 di fritillaria, 5 di gladioli (compreso il misterioso Gladiolus maximus capitis aut promontorii bonae spei magnitudine alias species superans), 44 di giacinti, 30 di iris, 16 di gigli, 9 di "Moly" ovvero di Allium e affini, 5 di Narcisso-lyrion, ovvero di bucaneve e Leucojum, 55 di narcisi (ma all'epoca sotto quest'etichetta poteva capitare di tutto), 7 di Ornithogalum, 12 di ranuncoli, 10 di Satyrion, ovvero vari tipi di orchidee, 32 tulipani, tra cui diversi di quelli fiammati che di lì a qualche anno avrebbero scatenato la tulipomania. Tra le iris, va segnalata Iris latifolia alba [f]loris caeruleis che Lamarque, attestando che era coltivata da molto tempo al Jardin de Roy, volle battezzare Iris swertii; oggi è considerata sinonimo di Iris pallida subsp. pallida. Tra i Narcissus, all'epoca un'etichetta generica che si assegnava spesso e volentieri a bulbose esotiche ignote, ne troviamo due, uno proveniente dalle Indie orientali, l'altro dalle Indie occidentali, "dette Swertius", che non avevano ancora fiorito, a conferma che il nostro era un importatore, in contatto con capitani e marinai delle Compagnie delle Indie olandesi, ma anche che il mercato era desideroso di accaparrarsi novità anche "a scatola chiusa". L'opera era stampata in bianco e nero, ma ne esistono anche esemplari colorati a mano con maggiore o minore cura, presumibilmente venduti a prezzi diversi. Ebbe un notevole successo, trascendendo lo scopo iniziale (del resto, sia Sweert sia Rodolfo, che secondo la prefazione avrebbe incoraggiato l'opera, morirono in quello stesso 1612), tanto che se ne conoscono diverse edizioni: una uscita ancora a Francoforte nel 1614 presso Kaempfer, e due a Amsterdam, presso Johannes Janson, rispettivamente nel 1646 e nel 1654. Non più un catalogo, ormai, ma un bel libro da sfogliare per godere le figure.  Petali come una tavolozza di pittore Nella didascalia che accompagna il ritratto Sweert è definito "principe dei rizotomi batavi", nel frontespizio della seconda parte "studioso di botanica". Ma fu come pittore (o presunto tale) che Linneo decise di immortalarlo dedicandogli il genere Swertia. In Hortus cliffortianus, separando da Gentiana Swertia perennis, una specie con fiori a stella azzurro-violacei spruzzati di macchie più scure, egli infatti scrive "Ho chiamata Swertia questa pianta, i cui fiori si fregiano di molte screziature, come poste sulla tavolozza di un pittore, da Emanuel Swertius, al quale dobbiamo tante piante egregiamente dipinte". Il genere Swertia (Gentianaceae) comprende oggi più di 150 specie di erbacee perenni, biennali o annuali native degli ambienti subartici, subalpini e montani dell'emisfero boreale e delle montagne dell'Africa tropicale. Sono simili alle genziane, ma hanno fiori a stella raccolti in pannocchie. Anche la nostra flora ne annovera una specie, S. perennis (la specie tipo di Linneo), nota con il nome comune genzianella stellata; piuttosto rara, è presente sparsamente in tutto l'arco alpino, dalle Alpi marittime al Cadore, nonché in poche stazioni dell'Appennino tosco-emiliane. Anche al di fuori della penisola, questa specie, legata all'ambiente delle torbiere umide, ha una distribuzione fortemente discontinua; in Europa vive nelle montagne di orogenesi alpina (oltre alle Alpi, i Pirenei, le Alpi dinariche, i Carpazi, i Sudeti, la Foresta Boema, il Caucaso) ma anche nelle paludi torbose dell'Europa centrale e della Russia; una seconda area va dalla Manciuria al Giappone, e, quindi, attraverso le Curili e le Aleutine, raggiunge l'Alaska e da qui tutta la costa dell'America settentrionale, fino alla California. Si ritiene che il centro di dispersione del genere sia l'Asia; in Cina sono presenti 75 specie e in India 40, anche in questi caso sparsamente disperse nell'Himalaya occidentale e orientale e nei Ghati occidentali. Diverse specie hanno una lunga tradizione di piante officinali. La più nota di questo gruppo è probabilmente S. chirayita, una biennale originaria dell'Himalaya temperato, usata nella medicina tradizionale indiana, pakistana e tibetana per curare una larga gamma di malattie, dai disordini epatici alla malaria al diabete. S. japonica è invece una delle erbe medicinali più popolari in Giappone, apprezzata per le sue virtù stomatiche e antidiarroiche. Sul mercato asiatico, le specie officinali sono molto richieste, tanto che l'eccessiva raccolta in natura ne mette a rischio la sopravvivenza. Al momento, la coltivazione è ancora occasionale o presente in piccole aree. Nonostante l'indubbio valore estetico, rara è anche la coltivazione nei giardini. Tra le poche eccezioni, S. bimaculata, una biennale o perenne di breve vita originaria dell'Asia orientale, con fiori a coppa bianchi puntinati di viola e due vistosi nettari per ogni lobo, talvolta offerta da vivai specializzati. Richiede terreno fresco, acido, umido, e posizioni semi ombreggiate. I fratelli Franz e Ferdinand Bauer furono forse i più grandi pittori botanici della prima metà dell'Ottocento. Il loro destino fu allo stesso tempo parallelo e divergente. Divisi da appena due anni d'età, furono educati alla pittura e alla botanica dallo stesso maestro e per qualche anno lavorarono fianco a fianco alla stessa opera, poi, dopo un passaggio a Vienna, entrambi si trasferirono in Inghilterra. Ma a questo punto i loro destini avevano già preso una piega diversa. Franz, il sedentario, divenne il primo pittore ufficiale dei Kew Gardens, dove andò anche ad abitare; mutò il suo nome in Francis e non si mosse più dall'Inghilterra; si specializzò nel dipingere i più minuti particolari delle piante osservati al microscopio, fornendo un inestimabile aiuto ai botanici di Kew. Socievole e ben inserito nella società scientifica, ottenne riconoscimenti come l'ammissione alla Royal Society. Ferdinand, il viaggiatore, accompagnò Sibthorp in Grecia e in Asia minore, quindi si unì alla spedizione Flinders; non solo pittore, ma anche appassionato raccoglitore di piante, dopo lo scioglimento della spedizione rimase in Australia, continuando le raccolte sia con Robert Brown, sia da solo. Disegnò moltissimo e perfezionò un codice numerico dei colori per cogliere le mille sfumature della natura australiana. Di ritorno in Inghilterra, quei numeri permettevano di trasformare gli schizzi in acquarelli di stupefacente precisione e verità. Era un lavoro quasi maniacale che lo assorbiva totalmente, ma nel suo perfezionismo destinato al fallimento commerciale. Negli ultimi anni della sua vita, preferì tornare in Austria dove divise il suo tempo tra la pittura e le escursioni alla ricerca di piante alpine. Nonostante con lui l'arte dell'illustrazione botanica abbia raggiunto il vertice, dopo la sua morte fu presto dimenticato. A ricordare i due fratelli, così simili e così diversi, provvede il bel genere australiano Bauera, voluto da Banks che li stimava in egual modo e in un certo senso fu lo sponsor di entrambi. 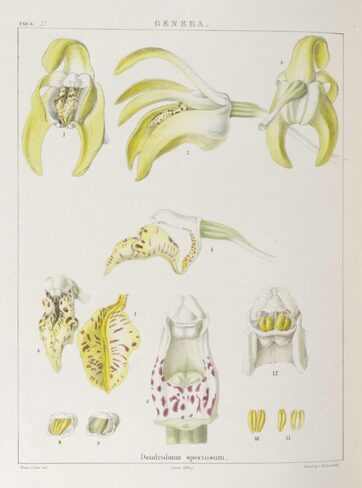 Diagnosi al microscopio Abbiamo già incontrato il pittore Ferdinand Bauer (1760-1826) come validissimo membro dell'équipe scientifica dell'Investigator. Per conoscerlo meglio dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e spostarci nella Bassa Austria, nella cittadina di Feldsberg (oggi Valtice, nella Repubblica ceca), uno dei feudi del principe di Liechtenstein. Ferdinand era il più giovane dei figli del pittore di corte Lucas che morì quando egli non aveva ancora due anni. C'erano altri due fratelli: Joseph Anton, di sei anni, e Franz Andreas (1758-1840), di quattro. La madre Theresia li fece educare alla pittura, quindi li affidò a padre Boccius, il priore del convento dei Fratelli della misericordia, che era anche un medico e un reputato botanico. Mentre il fratello maggiore, raggiunta l'età adulta, divenne a sua volta pittore di corte dei Lichtenstein, i due minori ancora adolescenti sotto la guida di Boccius iniziarono a lavorare al grandioso Codice Liechtenstein; in quattordici volumi, richiese vent'anni di lavoro e comprende oltre 3100 acquarelli botanici, metà dei quali furono dipinti da Franz e Ferdinand Bauer. Padre Boccius insegnò ai due ragazzi che il segreto dell'arte botanica sta nell'osservare i soggetti nei minimi dettagli, per poi ritrarli con precisione, verità e grazia. Grazie a questo apprendistato i due giovani appresero alla perfezione le tecniche del disegno e del colore, tanto da attirare l'attenzione di Nikolaus von Jacquin, il direttore dell'orto botanico dell'Università di Vienna, egli stesso un ottimo disegnatore, che impiegò prima Ferdinand poi anche Franz per i disegni di Icones plantarum rariorum (1781-1793). Da lui i due fratelli appresero la classificazione linneana e l'uso del microscopio. Ferdinand prese anche lezioni dal celebre pittore paesaggista Johann Christian Brand. Ben presto però von Jacquin perse i due migliori illustratori della sua scuderia. Il primo a partire fu Ferdinand nel 1786 (ma su di lui torneremo più avanti). Nel 1788 partì anche Franz, come accompagnatore del neo laureato Joseph Franz von Jacquin nel suo grand tour attraverso l'Europa. A Londra il giovane von Jacquin presentò Bauer a Joseph Banks, che, ammirato dalla sua maestria, riuscì a farlo assumere come primo pittore ufficiale dei Kew Gardens con un salario annuo di 300 sterline. Il pittore austriaco inglesizzò il suo nome in Francis, si stabilì a Kew, mantenendo quell'incarico fino alla morte, per oltre quarant'anni. Assai apprezzato da Giorgio III, fu insignito del titolo di "pittore botanico di sua maestà" e incaricato di impartire lezioni di pittura alla regina Carlotta e alle sue figlie, la più talentuosa delle quali era la principessa Elizabeth. Nel corso della sua lunga attività ai Kew Gardens, il maggiore dei Bauer ebbe modo di disegnare e dipingere centinaia di piante giunte da tutto il mondo; anche se amava dipingerle anche a figura intera, raggiunse una perfezione senza rivali nel ritrarre i particolari più minuti osservati al microscopio, uno strumento diagnostico senza pari per i molti botanici con i quali collaborò. Tra le opere che illustrò, in ordine cronologico, possiamo citare il catalogo del giardino Hortus Kewensis (con testi di Dryander e Aiton, 1789); il florilegio Delineations of Exotick Plants cultivated in the Royal Garden at Kew (1791-1801), con molte delle piante portate dal Sudafrica da Masson; Strelitzia depicta, ordinatogli da Banks (1818); The genus and species of orchidaceous plants di Lindley (1830-1838), forse il suo capolavoro assoluto (le orchidee erano senza dubbio il gruppo di piante preferite sia del botanico sia del pittore); Genera filicum di William Jackson Hooker (1842), al quale impartì anche lezioni di disegno. Socievole e ben inserito nell'ambiente scientifico, Franz Bauer divenne membro della Royal Society e alla sua morte fu sepolto nella cappella di St. Anne a Kew. Di lui possediamo anche un ritratto, che ci restituisce il volto di un uomo aperto e simpatico.  Dipingere con i numeri Neanche uno schizzo ci ha invece tramandato i tratti di Ferdinand, il fratello viaggiatore. Nel 1786 (all'epoca egli aveva ventisei anni ed era un pittore botanico professionista da almeno dieci) incontrò il suo coetaneo John Sibthorp, professore di botanica di Oxford, venuto a Vienna per esaminare uno dei più preziosi manoscritti della biblioteca imperiale, ovvero il celebre codice di De materia medica noto come "Dioscoride di Vienna". Sibthorp ne fu così affascinato da decidere immediatamente di mettersi in viaggio alla volta della Grecia e dell'Asia Minore per cercare di identificare in loco le piante descritte dal medico greco. Su suggerimento di Boccius e von Jacquin propose a Bauer di accompagnarlo come "suo disegnatore". Il pittore accettò e a marzo i due partirono per Napoli, dove si imbarcarono per Creta, con uno scalo a Milo. Dopo aver toccato diverse isole egee, visitarono Atene, quindi passarono a Smirne; trascorsero l'inverno a Costantinopoli, dove furono raggiunti dal cognato di Sibthorp, John Hawkins, con il quale nella primavera esplorarono Cipro e altre isole dell'Egeo. La minaccia di una guerra con la Russia e lo scoppio di un'epidemia li dissuase dall'esplorare la Grecia continentale; poterono però visitare una seconda volta Atene, poi l'Eubea, Delfi (con una scalata che mise a dura prova la loro resistenza), il Monte Athos, Tessalonica, Corinto, Patrasso; qui a settembre si imbarcarono per l'Inghilterra, dove giunsero a dicembre. Sia Sibthorp sia Bauer erano lavoratori ossessivi, e impressero alle loro ricerche un ritmo forsennato. Di solito il mattino era dedicato alle raccolte, con il professore che interrogava le persone del posto per cercare di identificare le piante di Dioscoride, il pomeriggio riservato al lavoro sugli esemplari. Dovendo fissare sulla carta una grande quantità di piante (ma anche animali e paesaggi), Bauer perfezionò un sistema che aveva già sperimentato con suo fratello a Feldsberg, quando disegnavano dal vero le piante locali: le forme del soggetto venivano fissate in un rapido schizzo a matita, mentre i colori delle varie pari venivano tradotti in un apposito codice numerico. Il codice che i due fratelli usavano da ragazzi comprendeva circa 140 sfumature; mentre Franz, che poteva lavorare con comodo ai Kew Gardens, lo abbandonò, Ferdinand, che doveva spostarsi in fretta da un luogo all'altro, spesso in condizioni difficili, senza avere a disposizione materiale da pittura adeguato, lo perfezionò, portando i colori usati in Grecia a 273. Va anche aggiunto che doveva occuparsi della preparazione degli esemplari (purtroppo, il professore tendeva a considerarlo più un servitore che un suo pari) e partecipava in prima persona alla raccolta; ad esempio, gli è attribuita la scoperta di Veronica glauca e Salvia candidissima subsp. candidissima. Nel corso dei diciotto mesi del viaggio, il pittore creò oltre mille schizzi di piante, e diverse centinaia di animali e paesaggi. Giunto in Inghilterra, ebbe il piacere di trovarvi il fratello; decise così di rimanere e seguì Sibthorp a Oxford, dove (in parte basandosi sugli esemplari d'erbario, in parte sfruttando la sua incredibile memoria visiva e la sua raffinatissima sensibilità al colore) iniziò a trasformare gli schizzi in spettacolari acquarelli da cui ricavare le incisioni per il grande libro sulla flora greca progettato di Sibthorp, che vi investì tutta la sua fortuna: ognuno gli costava più di un giorno di lavoro, e ne produsse 966. Per completare l'opera con le piante delle zone che non avevano potuto visitare, nel 1794 Sibthorp partì per un secondo viaggio in Grecia. Bauer si rifiutò di accompagnarlo; non si sarebbero più incontrarti: infatti il professore si ammalò di tisi e morì sulla via del ritorno nel 1796, lasciando le sue proprietà all'università di Oxford con il vincolo di pubblicare Flora Graeca. Gli esecutori testamentari e James Edward Smith, cui era stata affidata la redazione dei testi, si trovarono di fronte a materiali così caotici che l'opera richiese decenni per essere completata: il primo volume uscì nel 1806, il decimo e ultimo nel 1840. Ma intanto per Bauer era ormai iniziata un'altra avventura. Dopo la morte di Sibthorp, aveva collaborato con altri botanici, in particolare con Lambert, che gli commissionò il grosso delle illustrazioni di A description of the genus Pinus (il primo volume sarebbe uscito nel 1803, quando Bauer si trovava già in Australia); Ferdinand ne preparò 61, mentre suo fratello Francis 5. Come abbiamo già visto nei precedenti post, nel 1801 su suggerimento di Banks divenne il pittore naturalista della spedizione Flinders, affiancando Brown anche nella raccolta degli esemplari. Con i suoi 41 anni, era il decano della spedizione (sia Flinders sia Brown ne avevano ventisette, l'altro pittore Westall appena diciannove); nutrita dalla medesima passione e competenza, nonché dalla stima reciproca, la collaborazione tra botanico e pittore fu perfetta, e continuò quando nell'agosto 1803 i due decisero di comune accordo di rimanere in Australia per continuare le ricerche. A quella data Bauer aveva già realizzato 1000 disegni di piante e 200 di animali, e ulteriormente perfezionato il suo codice dei colori, che adesso aveva quattro cifre, ovvero comprendeva circa 1000 diverse sfumature. Per qualche mese, i due raccolsero insieme nei dintorni di Port Jackson, finché nel novembre 1803 Brown partì per la Tasmania; qualche tempo dopo, Bauer ebbe l'opportunità di visitare le isole Norfolk, dove rimase otto mesi, creando un erbario di non meno di 152 specie; raccolse anche animali, soprattutto uccelli, e ritrasse 70 specie di piante e 40 di animali. Di questi materiali si servì Endlicher per il suo Prodromus florae norfolkicae, 1831. All'inizio del 1805 gli amici si ricongiunsero a Port Jackson, in tempo per imbarcarsi sul restaurato Investigator, che a maggio salpò alla volta dell'Inghilterra con il prezioso carico delle loro raccolte e disegni. Questi ultimi ormai superavano i 2000. Il viaggio fu tempestoso, ma senza gravi incidenti e li riportò sani e salvi a Liverpool. Forse i due si aspettavano una calorosa accoglienza, ma il loro arrivo coincise con i festeggiamenti per la vittoria di Trafalgar (21 ottobre 1805) e passò quasi inosservato. Da quel momento avrebbero lavorato fianco a fianco per quasi dieci anni, uno a descrivere piante e animali, l'altro a dipingerli. Era diventato ancora più minuzioso e perfezionista: ora, per completare una tavola, poteva servirgli anche una settimana. Tanto più che Brown l'aveva iniziato all'arte della dissezione degli esemplari, e quindi c'erano da dipingere anche i particolari più minuti. Purtroppo il loro principale sponsor, ovvero Joseph Banks, per quanto ricco, non lo era abbastanza da sobbarcarsi l'impresa di pubblicare la loro costosissima opera. Brown si rassegnò a pubblicare il suo Prodromus floræ Novæ Hollandiæ et Insulæ Van-Diemen senza figure, ma l'opera fu un tale fiasco che ne vendette solo venticinque copie. Ancora peggio andò a Bauer: era così perfezionista che, dopo aver cercato inutilmente di trovare un incisore e un pittore per dipingere a mano le tavole stampate, non ne trovò nessuno secondo lui all'altezza, e si rassegnò a fare da sé. Riuscì a produrre solo tre fascicoli di Illustrationes Florae Novae Hollandiae (1806-1813), che vendettero anche meno. Fu una delusione tale per Bauer che decise di lasciare l'Inghilterra e di tornare in Austria. Grazie ai buoni emolumenti ottenuti dall'ammiragliato, poté acquistare una piccola casa nel sobborgo viennese di Hitzing e qui visse fino alla morte, a parte un breve viaggio a Londra nel 1819 per salutare il fratello. I suoi "clienti" però rimasero soprattutto inglesi: mentre i volumi dell'immensa Flora Graeca continuavano ad uscire, con le illustrazioni che aveva dipinto negli anni di Oxford, illustrò il secondo volume di A Description of the Genus Pinus (1824) di Lambert, Digitalium Monographia di Lindley (1821) e collaborò anche con Endlicher per Iconographia Generum Plantarum (Vienna, 1833). La maggior parte dei suoi disegni e dei suoi acquarelli rimase però inedita, e oggi è conservata in parte al British Museum of Natural History di Londra, in parte al Naturhistorische Hofmuseum di Vienna, in parte all'università di Göttingen. Negli ultimi anni della sua vita (morì sessantaseienne nel 1826) non dimenticò la passione per la botanica, alternando alla pittura le escursioni sulle Alpi. Purtroppo i suoi disegni sulla flora alpina sono tra quelli rimasti inediti.  Il genere Bauera Su suggerimento di Joseph Banks, nel 1801 Andrews creò il genere Bauera per omaggiare i fratelli Bauer, Franz già celebre e noto al pubblico inglese per le sue immagini di piante sudafricane, Ferdinand quasi sconosciuto visto che nessuna della sue opere era già stata pubblicata. Si tratta di un piccolo genere endemico dell'Australia (famiglia Cunoniaceae) che comprende tre specie di arbusti da prostrati a eretti, con foglie trifogliate disposte in coppie opposte e fiori da bianchi a rosa a coppa che ricordano quelli delle rose canine, da cui il nome comune Dog Rose. La più nota è B. rubioides, endemica dell'Australia orientale, diffusa nelle aree costiere dal Queensland sudorientale alla Tasmania, per lo più in zone umide e ombrose. Forma fitti cespugli tappezzanti ed è molto apprezzata come pianta da giardino. B. capitata è invece diffusa nelle zone costiere dal Queensland sud-orientale a Port Hacking nel Nuovo Galles del Sud, mentre B. sessiliflora è endemica della regione dei Grampiani del Victoria. Non è opportuno assumere una donna per questo scopo: Mary Agnes Chase ovvero una storia di genere31/3/2022 Ancora all'inizio del Novecento e anche negli Stati Uniti, sebbene le ragazze che si iscrivevano alle facoltà scientifiche fossero sempre più numerose, non era facile per loro fare ricerca; se riuscivano ad entrare in questa o quella istituzione, accedere ai finanziamenti era molto più difficile che per i colleghi maschi. Se poi non avevano neppure una laurea, le cose si complicavano ulteriormente. Per la botanica, la porta d'accesso più praticabile continuava a rimanere l'illustrazione, un settore in cui la presenza femminile era ormai sdoganata da tempo. Fu questa la strada percorsa dall'autodidatta Mary Agnes Chase che, grazie ad alcuni incontri fortunati, ma soprattutto a una tempra eccezionale riuscì a superare tutti gli ostacoli di genere e ad affermarsi come uno dei botanici più importanti del suo campo, l'agrostologia, ovvero lo studio delle graminacee. Animata da una forte coscienza sociale, non concepì la sua battaglia come una questione individuale, ma politica: ecco perché fu in prima fila nel movimento suffragista e non fece mancare il suo sostegno alle ragazze che intendevano seguire le sue orme. Esperta di graminacee di valore mondiale, è ricordata da ben tre piccoli generi di Poaceae: Agnesia, Chasechloa e Sinochasea.  Come un'illustratrice divenne botanica Tra i 27 milioni di visitatori della Fiera Colombiana di Chicago del 1893, organizzata per celebrare i 400 anni dalla scoperta dell'America, c'erano anche una giovane donna e un ragazzo: Mary Agnes Chase (1869-1963) e Virginius Heber Chase (1876-1966), rispettivamente zia e nipote. A stupirli ed emozionarli furono soprattutto le collezioni botaniche, tanto che decisero di iniziare ad esplorare la flora dei dintorni della città. Mary Agnes aveva solo ventiquattro anni, ma aveva già alle spalle una vita difficile. All'età di due anni perse il padre, Martin Meara, un fabbro di origini irlandesi che lavorava per le ferrovie, e andò ad abitare a Chicago dalla nonna materna con la madre e i quattro fratelli. La famiglia era molto povera, e finita la scuola di base, dovette lavorare per contribuire al bilancio familiare. Trovò lavoro come tipografa e correttrice di bozze allo School Herald , una modesta rivista destinata agli insegnanti rurali, diretta da Willam Ingraham Chase; nonostante la notevole differenza d'età (lei aveva diciotto anni, lui trentaquattro) i due si innamorarono e presto si sposarono. Ma William era ammalato di tubercolosi e entro un anno morì, lasciando Mary Agnes vedova e oberata di debiti. Per tirare avanti, di notte lavorava come correttrice di bozze per il Chicago Inter Ocean e di giorno dava una mano nell'emporio del cognato, dove strinse una grande amicizia con il nipote Virginius. Sempre più affascinato dalla botanica, il ragazzino leggeva tutto quello che poteva sull'argomento e cominciò a trascinare la zia nelle sue scorribande. Raccoglievano piante, prendevano note, essiccavano i soggetti e imparavano a classificarli. Per saperne di più, Mary Agnes decise di seguire corsi aperti di botanica all'Università e al Lewis Institute, dove imparò a disegnare le piante. La botanica per ora era solo un hobby, qualche ora di pausa in una difficile vita di lavoro e di fatica. Durante un'escursione, un primo incontro fortunato cominciò a cambiare la sua vita: quello con un altro appassionato, il pastore presbiteriano Ellsworth Jerome Hill, che, ormai in pensione, poteva dedicare parecchio tempo alla raccolta e allo studio delle sue piante preferite, i muschi e le epatiche. Hill incoraggiò Chase a perseverare, le insegnò le basi della tassonomia e l'uso del microscopio e le chiese di illustrare (gratis) i suoi numerosi articoli. Queste illustrazioni, molto classiche per impostazione e notevoli per la precisione dei dettagli, attirarono l'attenzione di Charles Frederick Millspaugh, curatore di botanica del Field Museum of Natural History, che le chiese di illustrare (sempre a titolo gratuito) due pubblicazioni dell'istituto: Plantae Utowanae (1900) e Plantae Yucatanae (1904). Nel frattempo, la pratica del microscopio aveva permesso a Chase di trovare un lavoro meglio pagato nei laboratori di controllo dell'industria conserviera. Ma per lei era ora che la botanica da hobby si trasformasse in professione; sempre su suggerimento di Hill, nel 1903 presentò la sua candidatura come illustratrice botanica al Dipartimento di agricoltura (USDA). Vinto il concorso, si trasferì a Washington e per due anni lavorò alla Divisione delle piante da foraggio. Nel 1905 un secondo incontro fortunato impresse la svolta definitiva alla sua vita: il suo capo divenne Albert Spear Hitchcock, un botanico specializzato in agrostologia (ovvero lo studio delle graminacee). Egli apprezzò il suo talento e decise di farne la propria allieva e la propria assistente (lo divenne ufficialmente nel 1907). Chase cominciò così ad abbandonare gradualmente l'illustrazione a favore dello studio scientifico delle piante, accompagnando Hill anche nelle sue spedizioni sul campo in varie parti degli Stati Uniti. Il primo frutto di questa collaborazione, che sarebbe durata trent'anni, furono due lavori a quattro mani sulle specie statunitensi del genere Panicum (1910 e 1915). Nel 1911 Hill partecipò alla ricognizione botanica di Panama finanziata dallo Smithsonian; al suo ritorno, chiese che i 54 $ che aveva risparmiato fossero assegnati a Mary Agnes Chase per continuare le ricerche. La risposta dello Smithsonian fu un netto rifiuto: "Spiace dire che non posso raccomandare di inviare la signora Chase nella Zona del Canale, sia perché dubito che la somma menzionata sia sufficiente sia perché dubito dell'opportunità di assumere una donna per questo scopo". Allo stesso modo, la stazione di Barro Colorado (che pure Chase aveva contribuito a installare) rifiutò l'accesso alle donne. Per Mary Agnes fu chiaro che non si trattava di una questione personale, ma politica. Fu così che, senza lasciarsi intimorire dalle conseguenze di questa scelta per la sua carriera, si impegnò attivamente nel movimento suffragista. Nel 1915 fu arrestata una prima volta mentre, insieme ad altre donne, manteneva acceso un falò dei discorsi di Wilson che contenevano le parole freedom e liberty (somma ipocrisia finché non c'era libertà per le donne). Nel 1918 fu tra le attiviste (le Silent Sentinels) che picchettarono la Casa bianca per ricordare al neoeletto Wilson la promessa di sostenere il suffragio femminile; arrestata e incarcerata, partecipò allo sciopero della fame che guadagnò al movimento il sostegno di parte dell'opinione pubblica e costrinse l'amministrazione a rilasciare le donne arrestate. Per le sue posizioni "incompatibili per un dipendente dello stato" rischiò anche il licenziamento; a salvarle il posto fu Hitchcock che dichiarò che gli era impossibile continuare le sue ricerche senza di lei.  Viaggi e pubblicazioni della "signora delle graminacee" Non era un'esagerazione. Il programma di ricerca dei due botanici era niente meno che la mappatura di tutte le graminacee delle Americhe e dopo gli Stati Uniti intendevano estendere le loro ricerche all'America latina. Non potendo attingere a finanziamenti pubblici, Chase (abituata fin da bambina a vivere frugalmente) finanziò autonomamente i suoi primi viaggi e anche più tardi si appoggiò su organizzazioni e missioni femminili, a proposito delle quali scrisse: "I missionari viaggiano ovunque e come i botanici lo fanno spendendo il meno possibile". A partire dal 1906, dedicò molto del suo tempo libero a viaggi negli Stati Uniti (ne visitò ben 19) e nel Messico. Tutti autofinanziati, benché il suo stipendio fosse nettamente inferiore a quello dei colleghi maschi. Nel 1913 poté trascorrere diversi mesi in Porto Rico dove tra l'altro scoprì una nuova specie di felce; le sue raccolte di graminacee confluirono nel 1917 in Grasses of the West Indies, scritto in collaborazione con Hitchcock. Nel 1922 pubblicò il suo primo libro, illustrato da lei stessa, First Book of Grasses: The Structure of Grasses Explained for Beginners. Come è evidente dal sottotitolo, si rivolge non a botanici professionisti bensì "a studiosi seri ma dilettanti". Lo stesso anno partì per il suo primo viaggio in Europa, nel corso del quale visitò diversi erbari, tra cui quelli di Pisa e Firenze e l'Hackel Herbarium del Museo nazionale di Vienna, dove poté collaborare con Hackel alla raccolta di graminacee alpine. Anche grazie al successo del suo libro, nel 1923 fu promossa botanica assistente e nel 1925 botanica associata. Nel 1924, con il finanziamento di diverse organizzazioni, tra cui l'USDA e il Field Museum di Chicago e l'appoggio logistico delle missioni femminili, Chase partì per il Brasile. Incontrò i colleghi dell'orto botanico di Rio de Janeiro Paulo de Campos Porto e María de Carmo Bandeira, quindi per sei mesi percorse il Brasile orientale in treno, in autobus, in automobile, a dorso d'asino, a piedi, raccogliendo più di 500 nuove specie di graminacee e 19.000 altri esemplari. Insieme a Maria Bandeira, scalò persino il monte Itatiaia (erano le prime donne a farlo), da cui discesero "con le gonne piene di esemplari". Nel 1929, tornò in Brasile per una seconda spedizione di un anno. Nel 1935 uscì il magnum opus di Hitchcock, Manual of the Grasses of the United States, a cui le ricerche di Chase avevano dato un contributo decisivo. Ma nel dicembre di quell'anno il botanico morì all'improvviso sulla nave che lo riportava negli Stati Uniti da un lungo viaggio attraverso gli orti botanici e gli erbari europei. Nel 1936 Chase (che ora aveva 67 anni) le succedette come botanico senior, responsabile del dipartimento di agrostologia sistematica dell'USDA. Nel 1937, fu nominata anche curatrice del settore delle graminacee dell'Erbario nazionale. Nel 1939, andò in pensione, ma mantenne l'incarico all'erbario e continuò a lavorare allo Smithsonian come volontaria. Era ormai riconosciuta come la più importante specialista di graminacee del mondo. Nel 1940 fu invitata in Venezuela dal governo come consulente per un programma di sviluppo; anche se ormai aveva superato la settantina, ne approfittò per continuare le ricerche, raccogliendo 400 taxa di graminacee in ambienti diversi: le Ande, la savana e la foresta pluviale. Come già in Brasile, in Venezuela incontrò molti studenti e studentesse di botanica; per molti di loro, divenne una consigliera, un'amica e non fece mancare loro il suo sostegno concreto, aiutando decine di giovani promettenti ma privi di mezzi a continuare gli studi negli Stati Uniti. Per le ragazze, l'ostacolo era duplice: incoraggiare le giovani donne ad abbracciare la carriera scientifica divenne uno dei principali scopi dei viaggi che nel dopoguerra la videro ancora in America latina, in Canada e nelle Filippine. La sua casa, che soprannominò affettuosamente in spagnolo "Casa contenta", era sempre aperta alle studentesse e alle botaniche che passavano da Washington. Tra di loro la venezuelana Zoraida Luces de Febres (1922–2015), che grazie a lei poté entrare allo Smithsonian; tradusse in spagnolo First Book of Grasses, fu la prima donna venezuelana a laurearsi in scienze naturali e divenne a sua volta un'importante agrostologa. E' solo un esempio dell'impegno personale e politico di Chase per le cause in cui credeva. Oltre ad essere impegnata nel movimento femminista, come membro del Women's Party e della Women's Christian Temperance Union, aderì al Socialist Party, si batté contro la discriminazione razziale aderendo alla National Association for the Advancement of Colored People. Attiva e lucida fino in tarda età, nel 1951 pubblicò la seconda edizione di Manual of the grasses of the United States di Hitchcock. E finalmente anche l'establishment botanico le tributò gli onori che meritava: nel 1956 la Botanical Society of America la premiò con un certificato di merito definendola "uno dei più importanti agrostologi del mondo e preminente tra gli studiosi americani in questo campo"; nel 1958 (aveva appena compiuto 89 anni) ricevette la laurea honoris causa dall'università dell'Illinois e fu nominata membro onorario dello Smithsonian; nel 1961 divenne membro della Linnean Society. Nel 1962, ultranovantenne, in collaborazione con un'altra botanica, Cornelia D. Niles, riuscì ancora a completare il monumentale Index to grass species, in tre volumi. Morì l'anno dopo all'età di 94 anni, poco dopo essersi ritirata in una casa di riposo. Le sue raccolte sono custodite in diversi erbari. L'Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburg ospita la Hitchcock-Chase Collection of Grass Drawings, una straordinaria collezione che comprende 2713 disegni - per lo più a china - di graminacee raccolti e in parte disegnati da Albert Spear Hitchcock e Mary Agnes Chase.  Un giro del mondo in tre graminacee Alla "signora delle graminacee" non potevano mancare gli omaggi botanici. Le sono stati dedicati ben quattro generi, tre dei quali tuttora validi; non stupisce che tutti appartengano alla famiglia Poaceae. In ordine di tempo (1911), la prima dedica giunse dal sacerdote, chimico e botanico Julius Nieuwland che, nell'ambito di una revisione del genere Panicum, creò Chasea, prendendo le mosse dallo studio su questo genere pubblicato l'anno precedente da Hitchcock e Chase; non valido, è considerato un doppione di Panicum. Con i tre generi validi facciamo un piccolo giro del mondo, segno della reputazione internazionale di Agnes Mary Chase. Iniziamo dal Madagascar, con il genere endemico Chasechloa (1949), omaggio di una delle tante colleghe con cui Chase era in corrispondenza, la francese Aimée Antoinette Camus (che a sua volta, prima di diventare specialista di orchidee, si era occupata di graminacee). Comprende due sole specie, C. egregia e C. madagscarensis, in precedenza assegnate anch'esse al genere Panicum, a cui sono molto affini; tuttavia, le analisi filogenetiche ne hanno confermato l'indipendenza. Sono grandi erbe piuttosto rare limitate alle regioni nord-occidentali dell'isola. La seconda tappa è la Cina, con il genere monotipico Sinochasea (1958), dedica di Yi-Li Keng, uno dei tanti studenti stranieri che poterono giovarsi dell'aiuto della generosa botanica statunitense. Keng, infatti, dopo essersi laureato a Nanchino, si spostò all'università di Washington per la laurea di secondo livello, per la quale scrisse una tesi sulle graminacee cinesi. Come ricorda nella dedica "il nome è una combinazione di Sino, Cina, e Chasea, in onore della sig.a Agnes Chase, la nota agrostologa degli Stati Uniti, che mi aiutò molto nello studio delle graminacee cinesi". L'unica specie, S. trygina, è un'erba dei pascoli alpini della Cina, del Tibet e dei piccoli stati himalayani adiacenti. Concludiamo il viaggio in Amazzonia con un altro genere monotipico, Agnesia (1993). I due autori, l'argentino Fernando Omar Zuloaga e lo statunitense Emmet Joseph Judziewicz, con questa dedica vollero sottolineare quanto utile e ancora attuale fosse (e sia ancora) il lavoro di questa grande botanica: "Il genere è dedicato all'eccezionale agrostologa statunitense Agnes Chase, autrice del monumentalmente completo e utilissimo indice delle specie pubblicate di graminacee. Ancora oggi le sue note manoscritte sugli esemplari e sulle cartelle dell'erbario nazionale statunitense spesso forniscono suggerimenti benvenuti e permettono di risparmiare molto tempo nell'identificazione e nelle relazioni reciproche di molte graminacee". L'unica specie di questo genere, A. lancifolia, è un raro bambù delle foreste umide dell'area amazzonica. Nell'Inghilterra vittoriana c'è una vera e propria esplosione dell'interesse per la botanica e il giardinaggio, alimentato tra l'altro da libri e riviste magnificamente illustrati, dai prezzi relativamente contenuti e accessibili a un vasto pubblico. E' un mercato in crescita, che dà lavoro a molti illustratori che non di rado sono illustratrici. Poche di loro sono ricordate e quasi nessuna ha avuto la ventura di essere celebrata da un genere botanico. Tra le poche eccezioni, la misteriosa miss Drake, che per sedici anni fu la principale collaboratrice dell'indaffaratissimo botanico John Lindley, il "padre dell'orchidologia". Per lui dipinse più di mille tavole, dando il meglio di sé proprio nel ritrarre le orchidee; Lindely dunque non poteva che dedicarle un genere di questa affascinante famiglia, la curiosissima Drakaea. 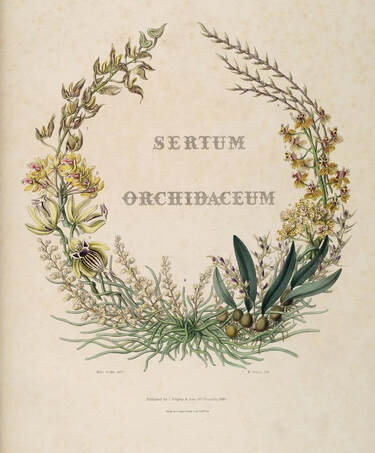 Un'illustratrice enigmatica Per molte donne britanniche dell'Ottocento occuparsi di botanica è stato un affare di famiglia. Non avevano accesso né all'università né alle istituzioni scientifiche, ma come figlie e mogli di scienziati non solo si trovarono immerse in un ambiente ricco di stimoli, ma spesso vennero coinvolte in prima persona nelle attività scientifiche dei congiunti, raccogliendo esemplari, tenendo in ordine appunti ed erbari e soprattutto disegnando. Il caso più eclatante è quello di quattro generazioni di mogli, figlie, nuore legate alla più illustre famiglia botanica inglese, gli Hooker. La capostipite di questa linea di "botaniche di famiglia" è Mary Dawson Turner (1774-1850), nata Palgrave, un'eccellente ritrattista, che illustrò le opere naturalistiche e antiquarie del marito Dawson Turner, in particolare Synopsis of British Fuci (1802) e Natural History of Fuci (1808-1891), e trasmise il suo talento alle figlie Elizabeth e Maria Sarah (1797-1872). Quest'ultima sposò William Dalton Hooker, raccolse per lui diverse specie di muschi e li disegnò insieme alla sorella. Anche il figlio Joseph Dalton Hooker sposò la figlia di un botanico, Frances Harriet Henslow (1825-1874), figlia del titolare della cattedra di botanica di Cambridge John Stevens Henslow; le conoscenze botaniche della signora Hooker erano ben più di un'infarinatura e le permisero di tradurre dal francese un'opera di alto impegno teorico, il Traité général de botanique di Le Maout e Decaisne, poi pubblicato a cura del marito (A General System of Botany, 1872). A sua volta la loro figlia maggiore Harriet Anne (1854–1945) sposò il botanico William Turner Thiselton-Dyer e divenne un'illustratrice professionista, producendo non meno di cento tavole per il Curtis' s Botanical Magazine diretto dal padre. Il caso non è affatto isolato: si potrebbe continuare citando Jane Wells Webb Loudon, moglie del botanico e architetto del paesaggio John Claudius Loudon, che, iniziata dal marito alla botanica e al giardinaggio, imparò l'arte dell'illustrazione botanica e divenne una prolifica autrice di libri di giardinaggio rivolti specificamente a un pubblico femminile, come il popolarissimo Gardening for Ladies, da lei stessa illustrato; oppure le figlie del botanico Benjamin Maund che dipinsero molte tavole per The Botanic Garden edito dal padre, firmandosi semplicemente miss Maund (ecco perché non ne conosciamo neppure il nome); o ancora Margaret Roscoe nata Lace che illustrò Monandrian Plants of the Order Scitamineae (1828) del marito William Roscoe. A lungo si è pensato che rientrasse in questa categoria familiare anche la misteriosa miss Drake o miss S.A. Drake che per sedici anni fu la principale illustratrice delle opere del botanico ed orchidologo John Lindley; dato che viveva con la famiglia, si è dedotto che fosse la classica parente povera. In realtà anche se pure Anne Sarah Drake (1803-1857) dovette il suo ingresso nel mondo dell'illustrazione botanica a un legame personale con un'eminente figura maschile, non aveva legami familiari con Lindley. Era piuttosto un'amica di famiglia, o almeno una conoscente: era nata in un villaggio del Norfolk non lontano dal paese di origine di Lindley, aveva frequentato la stessa scuola di sua sorella Ann di cui era amica, non sappiamo quanto intima. Per altro non sappiamo nulla né della sua condizione sociale né della sua formazione; alcune fonti riferiscono di un soggiorno a Parigi durante il quale potrebbe avere studiato pittura. Ugualmente ignoriamo in seguito a quali circostanze e con quali mansioni nel 1830 si sia trasferita nella casa dei Lindley a Turnam Green; l'ipotesi più gettonata è che sia stata assunta come bambinaia-istitutrice dei tre piccoli figli di John e Sarah Lindley: Sarah di quattro anni, Nathaniel di due e Barbara di pochi mesi. E' però possibile che Lindley l'abbia ingaggiata proprio per il suo talento artistico. Nel 1829 l'indaffaratissimo botanico, che già da tempo era segretario dell'Horticultural Society, era stato nominato primo professore di botanica all'Università di Londra e aveva assunto la direzione dell'Edwards's Botanical Register. Egli stesso un eccellente disegnatore che fino ad allora aveva illustrato di persona le proprie opere, aveva troppi impegni professionali per occuparsi anche delle tavole illustrate della rivista. Dunque è possibile che fin da subito miss Drake sia stata una sorta di ibrido tra amica di famiglia, bambinaia, governante tutto fare e collaboratrice di Lindley, che sicuramente le insegnò i segreti dell'illustrazione botanica, trovando in lei un'allieva pronta e dotatissima. Certo è che già nel 1831 i disegni firmati miss Drake cominciano ad affiancare quelli dello stesso Lindley nell'Edwards's botanical register. Presto ne diverrà l'artista principale, disegnando nell'arco di sedici anni (la rivista cesserà le pubblicazioni nel 1847) oltre mille tavole. Era l'impegno maggiore ma non il solo della prolifica illustratrice. Sempre per Lindley, disegnò le illustrazioni di Ladies' Botany, un'opera divulgativa in due volumi rivolto a "quelle che desiderano accostarsi alla botanica come divertimento e svago", in cui, opponendosi al sistema artificiale di Linneo, il botanico inglese adottò il sistema naturale di Antoine Laurent de Jussieu. Tra il 1837 e il 1841 uscì quello che possiamo considerare il capolavoro congiunto di botanico e illustratrice, Sertum Orchidaceum: a Wreath of the Most Beautiful Orchidaceous Flowers, in cui Lindley descrisse e Drake illustrò 46 orchidee scelte tra le più belle e spettacolari. Occasionalmente, Lindley prestò la sua illustratrice a qualche amico. Alcune tavole firmate miss Drake compaiono in Plantae Asiaticae Rariores (1830-1832) di Nathaniel Wallich, Illustrations of the botany and other branches of the natural history of the Himalayan Mountains (1839) di John Forbes Royle e in The Botany of HMS Sulphur (1844–1846), con testi di George Bentham. Contribuì inoltre con sedici tavole alla monumentale Orchidaceae of Mexico and Guatemala di James Bateman, celebre per essere l'opera botanica più "pesante" di tutti i tempi (in senso letterale: oltre 17 chili). Le orchidee (di cui Lindely era il massimo specialista dei suoi tempi - i tempi dell'orchidelirium) erano indubbiamente il soggetto preferito di Drake e quello in cui toccò il vertice della sua arte. Nel corso della sua carriera ne ritrasse ben 325 (ovvero circa un quarto della sua produzione). Le dipingeva dal vivo, ma senza allontanarsi più di tanto da casa Lindley: per qualcuna le toccò andare ai Kew Gardens, molte le ritrasse nei vivai Loddiges di Hackney, che - si dice - avevano allestito una mostra di orchidee appositamente per lei. Nel 1847, a causa di problemi finanziari, il Botanical Register cessò le pubblicazioni, segnando anche la fine della carriera artistica di miss Drake. Quasi da un giorno all'altro, la pittrice sparì di scena. Non era morta, come ha pensato qualche studioso, ma era tornata nel Norfolk, dove visse ancora qualche anno, prima con un vecchio zio, poi con il marito, un ricco fattore sposato nel 1852. Non risulta che abbia più dipinto. Il fallimento della rivista non basta a spiegare questa improvvisa eclissi. Forse erano intervenuti problemi di salute: l'abbassamento della vista o il manifestarsi dei primi sintomi del progressivo avvelenamento che potrebbe averla portata alla morte a cinquantaquattro anni nel 1857 (anche se ufficialmente morì di diabete). In effetti, molti dei pigmenti utilizzati dai pittori dell'epoca erano tossici. Anche da lontano, i suoi rapporti con la famiglia Lindley dovettero rimanere improntati al reciproco affetto, come si evince da una lettera di Sarah Lindley in cui annuncia il matrimonio della "vecchia amica Ducky", come la chiamavano familiarmente. Il legame doveva essere particolarmente stretto proprio con la figlia maggiore dei Lindley: introdotta da Ducky ai segreti dell'illustrazione botanica, fin dal 1842 aveva incominciato a collaborare alle opere del padre, disegnandone le illustrazioni in bianco e nero. Insomma, un'altra "botanica di famiglia".  Orchidee ingannatrici e a rischio Tra le numerose illustratrici botaniche della prima metà dell'Ottocento, Sarah Anne Drake è una delle pochissime dedicatarie di un genere, e l'unica a cui spetta un genere valido; segno della scarsa considerazione in cui erano tenute rispetto ai loro colleghi maschi, che ricevevano regolarmente quell'onore dai loro committenti. Non c'è bisogno di dire che l'omaggio arrivò da John Lindley, che ovviamente scelse un'orchidea. Non però una delle sontuose orchidee epifite che facevano impazzire i collezionisti e che la stessa miss Drakea amava dipingere, ma una modesta e curiosa orchidea terrestre australiana, Drakaea elastica. Oggi al genere Drakaea sono attribuite dieci specie, tutte endemiche dell'Australia sud-occidentale. Sono note con il nome comune "orchidee martello" per la forma del labello e il suo movimento all'indietro quando viene impollinato. Il fiore di queste piccole orchidee è infatti caratterizzato da un labello retto da un gambo sottile che ricorda per forma, colore e odore una femmina di vespa thynnide. In questo gruppo di vespe, le femmine sono incapaci di volare. Quando emergono dal terreno, si arrampicano su uno stelo d'erba e emettono un feromone che attira i maschi. Questi ultimi volano a zig-zag in cerca delle femmine; quando un maschio rileva il feromone, si posa sulla femmina, la afferra e vola via con lei verso una fonte di cibo. Le orchidee Drakaea producono una sostanza chimica che imita il feromone di queste vespe. Il maschio, attratto da questo odore, scambia il labello dell'orchidea per una femmina, vi si posa e cerca di staccarlo, facendo muovere all'indietro il gambo che lo trattiene; in tal modo il torace dell'insetto viene a trovarsi a contatto con un pacchetto di polline appiccicoso. Dopo un po' la vespa si stufa e vola via, alla ricerca di una femmina più disponibile. Se si fa ingannare un'altra volta e visita una seconda orchidea, questa viene impollinata dal polline rimasto sul suo torace. Un metodo un po' rischioso se pensiamo che ciascuna delle dieci specie di Drakaea è tendenzialmente impollinata da un insetto specifico. Nessuna di esse è abbondante, una è presumibilmente già estinta e sei sono vulnerabili o a rischio, per un complesso di ragioni che includono anche la rarità degli insetti impollinatori. Non sempre conviene specializzarsi troppo! Qualche informazione in più e una lista delle specie con la distribuzione e lo stato di conservazione nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|




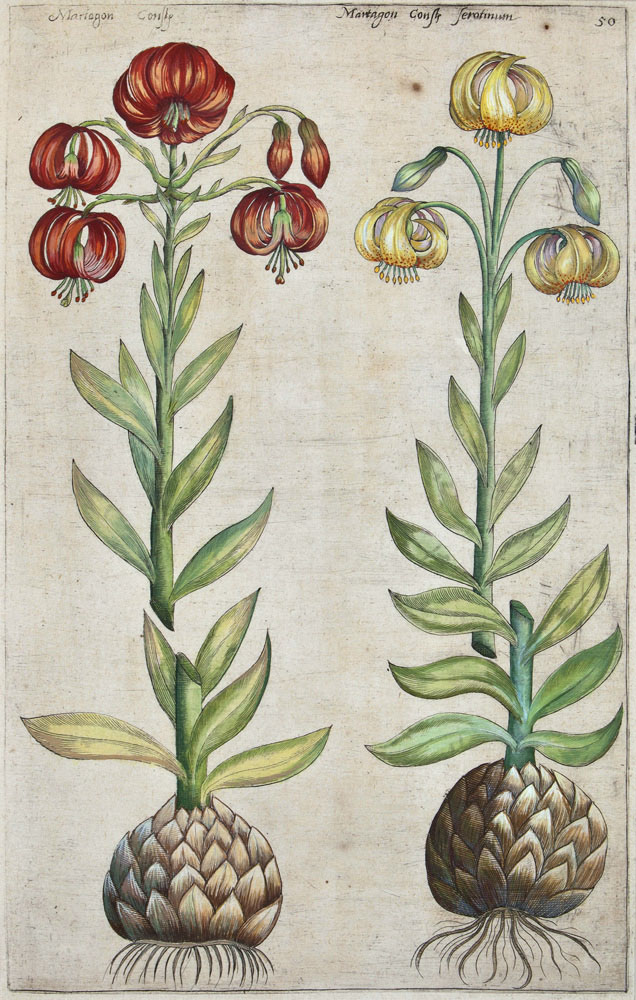


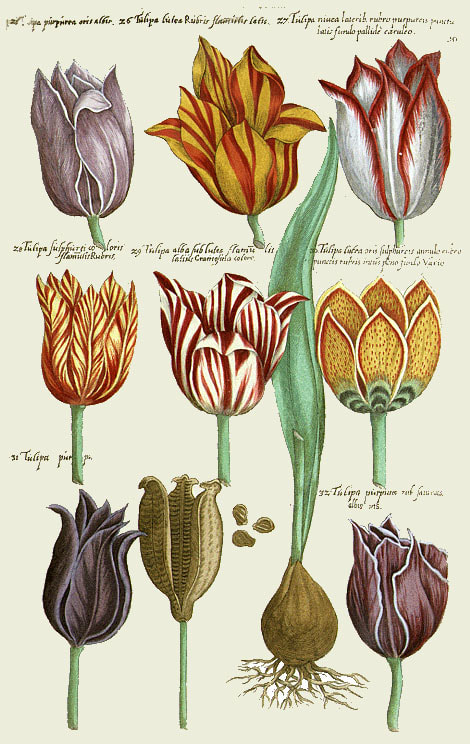

 RSS Feed
RSS Feed