|
Nel quindicennio tra il 1798 e il 1812, lo scozzese James Niven fu un prolifico ed efficiente cacciatore di piante in Sudafrica. Prima al servizio di George Hibbert, poi di un consorzio che includeva il vivaio Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina, raccolse migliaia di semi e esemplari di erbario, introducendo nei giardini europei molte nuove specie, in particolare Ericaceae e Proteaceae. Nella realtà fu un giardiniere, poi un raccoglitore, infine forse un commerciante morto troppo presto; nel mito, chissà perché, la sua scarna biografia si colora di particolari da fantasiosi a melodrammatici. A ricordarlo il reale e bellissimo genere Nivenia, endemico della provincia del Capo occidentale, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae. 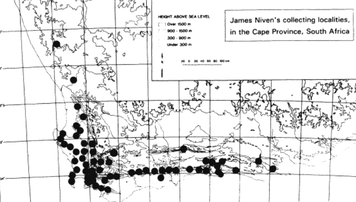 Un raccoglitore prolifico e coscienzioso Nel fascicolo del 1827 della rivista di orticultura edita da Longman e curata da Loudon The Gardener's Magazine i lettori poterono leggere il necrologio di Mr. James Niven, morto il 9 gennaio di quell'anno, corredato da una breve biografia. Ancora oggi è il resoconto più ampio della vita di questo giardiniere e cacciatore di piante; a firmarlo è J. M., ovvero James Main, che doveva aver conosciuto Niven di persona, visto che entrambi per qualche tempo avevano lavorato per il ricco collezionista di piante George Hibbert. Eppure, come vedremo meglio più avanti, le notizie fornite da Main sono da prendere con beneficio d'inventario. Figlio di un tessitore di Penicuik, non lontano da Edimburgo, James Niven (1776-1827) dovette ricevere la relativamente accurata educazione garantita dalle scuole pubbliche scozzesi; poi probabilmente lavorò come ragazzo giardiniere presso vari giardini, finché diciannovenne completò il suo apprendistato presso l'orto botanico di Edimburgo, dove rimase per circa un anno. Nel 1796 si trasferì a Londra dove fu assunto come giardiniere a Syon House, la splendida proprietà del duca di Northumberland, sotto il capo giardiniere Thomas Hoy. In qualche modo dovette attirare l'attenzione di George Hibbert che decise di inviarlo in Sudafrica a caccia di piante. Secondo Nelson e Rourle che, in assenza di un diario di campo, hanno cercato di ricostruire i suoi movimenti sulla base delle sue note d'erbario, Niven dovette arrivare al Capo alla fine del 1798 o all'inizio del 1799, dato che il suo primo esemplare datato risale all'agosto 1799. Secondo Main, presto si impadronì tanto dell'olandese quanto del khoi, tanto da poter servire come interprete e guida alle truppe del generale Craig. E' il primo mito che troviamo in questa storia: almeno un anno prima che Niven vi arrivasse, Craig, dopo aver brillantemente diretto l'occupazione inglese della Colonia del Capo, sottratta alla Repubblica batava, ed esserne stato per due anni governatore, era stato destinato al Bengala e aveva lasciato il Sudafrica per Madras. E' molto probabile (anzi certo secondo Nelson e Rourle) che al Capo Niven abbia invece incontrato un altro botanico scozzese, William Roxburgh, che vi era arrivato da Calcutta nel 1798 insieme a suo figlio John; mentre il padre lasciò il paese alla fine del 1799, il figlio vi rimase fino al 1804 a raccogliere esemplari per l'orto botanico di Calcutta. Nelson e Rourle ipotizzano che, essendo conterranei e avendo interessi comuni, Niven e i Roxburgh abbiano botanizzato insieme, anche se è difficile da dimostrare, perché, al contrario di quelli di Niven, per gli esemplari dei due Roxburgh la località di raccolta è spesso indicata in modo molto generico; una prova indiretta è il fatto è che nel suo erbario Niven usò alcuni binomiali inediti di Roxburgh, Nel 1803, in seguito al trattato di Amiens, la colonia del Capo fu restituita alla Repubblica batava; Niven, che ora non poteva più muoversi liberamente nel paese, rientrò in Inghilterra, ma, sempre stando a Main, dopo solo tre mesi tornò in Sudafrica, al servizio di un consorzio che comprendeva il vivaio Lee & Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Anche questa notizia è imprecisa; secondo Nelson e Rourle, egli invece dovette tornare in Sudafrica nel 1805. Infatti per poter raccogliere nel paese tornato sotto controllo olandese era necessario un permesso; quest'ultimo venne rilasciato a Niven in data 3 aprile 1805, limitatamente alle piccole aree di Riebeek-Kaastel e Roodezand. Tuttavia già nel gennaio 1806 i britannici rioccuparono la colonia, e dal quel momento Niven potè muoversi liberamente; vi sarebbe rimasto per altri sei anni, fino al 1812. Durante i due soggiorni sudafricani, Niven esplorò gran parte della colonia del Capo; a nord si spinse fino al Kamiesberg, il massiccio più elevato del Namaqualand, dove raccolse Vexatorella alpina (pubblicata da Knight come Protea alpina); a est percorse le catene che corrono lungo la costa (monti di Riviersonderend, Langeberg e Outeniqua) e ancora più a est, attraverso la valle Langekloof, dove raccolse Protea tenax, raggiunse Kromme River e Gamtoos River, il punto più orientale dei suoi viaggi, Tuttavia raccolse la maggior parte degli esemplari in un raggio di 150 km da Città del Capo; i suoi luoghi di raccolta preferiti risultano i distretti di Tulbagh, le catene Drakenstein e Hottentots Holland e il monte di Worcester. I suoi committenti desideravano soprattutto semi e bulbi, Ciò significava esplorare ciascuna area almeno due volte: la prima durante la stagione di fioritura per identificare le specie e raccogliere esemplari d'erbario, la seconda qualche mese più tardi per raccogliere i semi. Per ritrovare con facilità le piante e identificarle con sicurezza, Niven creò per se stesso un erbario di campo: su ogni foglio di pesante carta grigiastra incollava più esemplari (mediamente tre) corredati da precise note sul luogo di raccolta, la stagione di fioritura, l'habitat, le caratteristiche ecologiche, talvolta il tipo di suolo. Le raccolte di Niven sono particolarmente importanti per due famiglie largamente presenti in Sudafrica, le Proteaceae e le Ericaceae. Grazie alle sue raccolte delle prime, George Hibbert ne poté vantare la più ampia collezione europea, Knight specializzarsi nella loro coltivazione, Salisbury e Brown pubblicare decine di nuove specie. Una delle più rare è Leucospermum grandiflorum, che nel 1799 fu raccolta sia da Roxburgh sia da Niven. Secondo Salisbury, che la descrisse in Paradisus Londinensis nel 1808, i semi raccolti da Niven furono seminati nella serra di Hibbert dove prosperarono. Anche per le Ericaceae (molte furono pubblicate da Henry Cranke Andrews nei sei volumi di The Heathery, le raccolte di Niven hanno grande importanza storica. Secondo Aiton, le specie di Erica introdotte da Niven in Gran Bretagna sono 31, un risultato notevole se si pensa che Masson nel corso dei suoi tre viaggi ne aveva già introdotte 86. E se i numeri sono inferiori, in compenso i dati relativi ai luoghi di raccolta e agli habitat sono di gran lunga più accurati rispetto a quelli del suo predecessore. Secondo la testimonianza del curatore dell'orto botanico di Edimburgo William McNab, che ebbe con lui molte conversazioni sull'argomento dopo il suo ritorno in Scozia, "il mio molto compianto amico James Niven certamente sapeva sulla natura e sulla coltivazione di questo genere più di ogni altro uomo che io abbia mai incontrato". 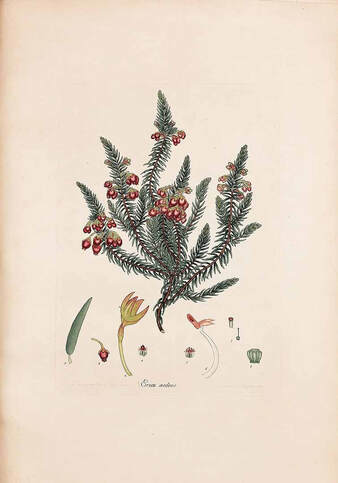 Miti e affabulazioni Dopo il suo ritorno in patria, sempre stando a Main, Niven "abbandonò le sue attività botaniche e orticole" e ritornò a Penicuik, dove aprì un'attività (non sappiamo di che genere) insieme a un fratello. Nel 1817 sposò Alison Abernethy (lo sposo aveva 40 anni, la sposa 26), da cui ebbe 5 figli; nel 1827, ad appena 50 anni morì. Main non manca di aggiungere un particolare melodrammatico: non appena la sua bara lasciò la casa, la vedova morì all'istante, lasciando cinque piccoli orfani. Documenti alla mano, è un altro mito: forse davvero per il dolore la donna ebbe un infarto o un ictus, ma morì e fu sepolta quattro settimane dopo il marito. La situazione dei bambini era comunque difficile, e i loro tutori furono costretti a vendere l'erbario; l'acquirente fu il già citato William McNab; passato al figlio John, capo giardiniere dell'orto botanico di Edimburgo, poi al nipote William Ramsay McNab, l'erbario finì a Dublino quando il suo ultimo possessore ottenne la cattedra di botanica al Collegio reale d'Irlanda. Alla sua morte precoce nel 1889, la vedova fu costretta a mettere in vendita la biblioteca, gli strumenti scientifici e l'erbario del marito, che comprendeva anche quello di Niven. In parte fu acquistato dal Museo nazionale irlandese (oggi è custodito all'erbario di Glasnevin), in parte dai Kew Gardens. Una serie di duplicati, forse in qualche modo acquisiti da Harvey, si trovano invece al Trinity College. L'erbario, già diviso, fu ulteriormente smembrato, e in parte rimase sconosciuto fino agli anni '70 del Novecento, quando venne in un certo senso "riscoperto" e studiato da un altro specialista di Proteaceae ed Ericacae, Ernest Charles Nelson dell'erbario dell'orto botanico di Glasnevin a Dublino, che si è anche incaricato di sfatare alcuni dei miti che hanno offuscato la vera storia di James Niven, Ne rimane uno, forse il più diffuso e tenace. Tra i personaggi più noti dell'orticultura irlandese troviamo Ninian Niven (1799-1879), che ridisegnò Phoenix Park, diresse per qualche anno l'orto botanico di Glasnevin, per poi diventare un affermato vivaista e un famoso architetto di giardini, nonché per diversi anni segretario della Royal Horticultural Society. Non è chiaro per quali ragioni, contro ogni evidenza, nel loro Biographical Index of British and Irish Botanists (1889) Boulger e Britten asserirono che Ninian Niven era figlio del nostro James Niven. Eppure Ninian Niven era nato a Kelvin Growe, presso Glasgow e suo padre, che si chiamava anche lui Ninian, era uno dei giardinieri di Keir House vicino a Stirling e non fu mai un cacciatore di piante. Senza contare che nel 1799 il nostro Niven aveva appena 22 anni ed era giusto arrivato in Sudafrica. I registri parrocchiali di Penicuik non lasciano dubbi: James Niven, come già sappiamo, si sposò quasi vent'anni dopo e nessuno dei suoi cinque figli era ovviamente Ninian Niven. Stranamente questa leggenda orticola è dura a morire: nel Dictonary of British Biography si legge: "suo padre, anche lui Ninian Niven, era un giardiniere di Keir House presso Stirling, e visitò due volte il Capo di Buona speranza raccogliendo piante per George Hibbert e l'imperatrice Giuseppina". Per concludere, un altro mito cinematografico. Nel notevole film Proteus, del regista canadese John Greyson, che racconta in modo romanzato la storia di due prigionieri giustiziati per sodomia in Sudafrica, compare un botanico scozzese chiamato Virgil Niven, ispirato a James Niven. A dispetto del fatto che la tragica vicenda sia avvenuta nel 1735, quarant'anni prima della sua nascita.  Iridaceae arbustive con fiori color cielo Il contributo di James Niven alla botanica e ai giardini britannici, da lui arricchiti di tante specie notevoli, è riconosciuto tanto da William Aiton, quando da Salisbury e Robert Brown, per una volta concordi. Lo ricordano gli eponimi di non molte specie sudafricane (Acmadenia nivenii, Erica niveniana, Serruria nivenii) e un genere ugualmente sudafricano, Nivenia. Glielo dedicò Ventenat sulla base di una delle molte specie da lui raccolte in Sudafrica e approdate alla Malmaison; in Decas Generum Novorum (1808) il botanico francese scrive: “questa specie è stata fornita dall’egregio Kennedy; perciò l’ho nominata dallo scopritore J. Niven, giardiniere inglese” (d'accordo, era scozzese, ma errore più errore meno...). Rispetto a questa laconica dedica, è ben più eloquente quella di Robert Brown per un secondo genere Nivenia (ovviamente non valido per la regola della priorità); dopo aver spiegato in che cosa il nuovo genere differisce da Paranomus di Salisbury, egli infatti scrive: "L’ho dunque nominato in onore di Mr. James Niven, un osservatore intelligente e un raccoglitore instancabile, con il quale i botanici sono indebitati di molte nuove specie delle due estese famiglie sudafricane delle Ericaceae e delle Proteaceae”. Nivenia Vent. è un piccolo genere della famiglia Iriaceae; insieme a Klattia e Witsenia, è uno dei soli tre generi della famiglia (tutti endemici del Sudafrica) a essere veri e propri arbusti sempreverdi, con fusti legnosi che producono vegetazione secondaria. Raggruppati nella sottofamiglia Niveoinioideae, tutti insieme comprendono appena quindici specie, contro le 1600 dell'intera famiglia (900 nel solo Sudafrica). Il genere più vasto del gruppo è proprio Nivenia, con undici specie accettate. Hanno tutte fiori azzurri e sono arbusti di medie dimensioni, con l'eccezione di tre specie a cuscino che crescono in habitat rocciosi aridi di montagna: N. levynsiae nelle Betty Bay-Kleimond Mountains, N. concinna al Viljoen Pass e N. fruticosa nel Lagenberg. Quest'ultima, di habitus quasi erbaceo e con un'infiorescenza poco vistosa di appena due fiori, fu la prima specie ad essere raccolta e descritta, da Peter Thunberg che la assegnò al genere Ixia. All'estremo opposto troviamo la specie più nota, l'unica coltivata al di fuori del Sudafrica, N. corymbosa, che cresce a Bain's Kloof e nelle montagne circostanti: gli esemplari più vecchi possono avere rami con un diametro di 4-5 cm lunghi anche tre metri. L'infiorescenza è un grande corimbo di circa 120 fiori in diverse tonalità di blu, che attirano folle di impollinatori, in particolare l'ape Amegilla fallax, dotata di una lunga ligula che le permette di raggiungere il nettare posto alla base del lungo tubo florale. A metà tra questi due specie estreme, si colloca la bella N. stokoei, un arbusto dal portamento arrotondato, che in aree protette può raggiungere il metro e mezzo, ma in aree aperte rimane molto più basso. Ha strette foglie lanceolate disposte a ventaglio che tradiscono immediatamente l'appartenenza alla famiglia, e fiori blu purissimo. E' un endemismo della Riserva della Biosfera Kogelberg. Tutte endemiche del Capo occidentale, spesso di aree estremamente limitate, purtroppo diverse specie di Nivenia sono in pericolo per la restrizione del loro habitat e anche per le conseguenze del cambiamento climatico. Tutte le sue undici specie sono incluse nella lista rossa delle piante sudafricane, due sono classificate come vulnerabili e cinque come rare.
0 Comments
Ancora negli anni '80 del Novecento, quando ormai era in pensione, era ben noto ai botanici che affluivano da ogni parte del mondo in Sudafrica per studiare la sua flora, che una visita da non perdere era quella alla piccola casa di Elsie Elisabeth Estrerhuyzen a Città del Capo. La sua competenza era tale da farla considerare un'enciclopedia vivente, mentre il suo contributo alla raccolta di nuove specie, soprattutto di alta montagna, l'aveva resa leggendaria: le è infatti accreditata la raccolta di ben 36.000 esemplari d'erbario. Eppure Elsie, come la chiamavano tutti, non era affatto una Indiana Jones della botanica in gonnella: era una piccola esile donna amante dei gatti e della montagna, che non guidava e si muoveva dappertutto in bicicletta; così modesta, che, una volta studiato a fondo un genere e, "colmati i vuoti" dell'erbario Bolus, dove lavorò per decenni, preferiva lasciare ad altri la pubblicazione. La ricordano due generi endemici delle montagne delle Provincie del Capo, che esplorò metodicamente per decenni: Esterhuysenia (Aizoaceae) e Trieenea (Scrophulariaceae). 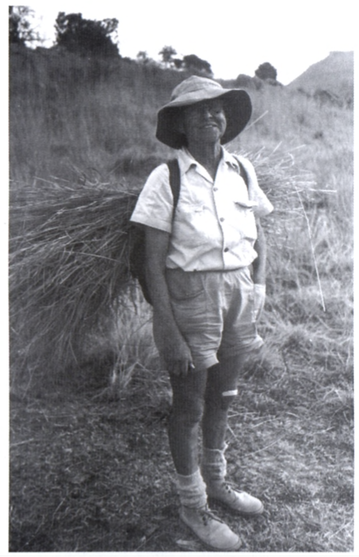 Raccogliere piante per "colmare i vuoti" Nel giugno 2006, nella sala conferenze dell'orto botanico di Kirstenbosch si riunì una piccola folla per dare l'ultimo saluto a Elsie Elizabeth Esterhuysen (1912-2006) che si era spenta all'inizio di quell'anno a 93 anni. John Rourke, curatore del Compton Herbarium e presidente della Botanical Society of South Africa, aprì il suo ricordo con queste parole: "Oggi siamo qui per celebrare la vita di una leggenda, perché Elsie era una leggenda, certamente lo era per la comunità botanica locale". A renderla tale non era solo la sua età venerabile, né una personalità indubbiamente fuori del comune, ma le sue incredibili raccolte botaniche: con 36.000 esemplari d'erbario, è stata uno dei più prolifici raccoglitori di sempre. Eppure non c'era nulla di eroico in questa piccola ed esile donna. Elsie era nata a Cape Town in una famiglia di avvocati; dopo aver studiato alla Wynberg Girls’ High School, si iscrisse all'Università di Cape Town dove nel 1933 conseguì la laurea di primo livello (Master of Arts) in botanica con una tesi sull'anatomia di Myrothamnus flabellifolius, una pianta xerofila nota come "resurrection plant" per la sua capacità di rinverdire alla prima pioggia anche quando sembra totalmente disseccata. Ma alle ricerche di laboratorio già allora preferiva di gran lunga quelle sul campo. Dopo aver lavorato per poco tempo nel Dipartimento educativo, nel 1935 grazie a una borsa di studio poté studiare la rigenerazione del fynbos a Kirstenbosch dopo l'eliminazione di piante aliene. La sua aspirazione era entrare a far parte del gruppo di ricerca che, guidato da Pole Evans, stava mappando la flora del Sudafrica, ma la sua domanda fu respinta per la semplice ragione che era una donna. Così nel 1936 accettò un posto di assistente al McGregor Museum di Kimberley, diretto dalla geologa e botanica Maria Wilman, che in quegli anni stava dirigendo un progetto di ricerca sulla flora del Griqualand occidentale. Dato che l'area da esplorare era vasta, per raggiungere i luoghi più remoti la direttrice insistette che imparasse a guidare. Ma un giorno Elsie Esterhuysen rimase bloccata a un passaggio a livello: si spaventò talmente che da quel giorno non guidò più. In compenso, si procurò una bicicletta e divenne una provetta ciclista. Nel 1938 tornò a Cape Town e cominciò a lavorare per il Bolus Herbarium, dove avrebbe trascorso tutta la sua vita professionale. Per ben 18 anni, però, non fece parte ufficialmente dello staff, venendo pagata di volta in volta con la cassa per le piccole spese; solo nel 1956, su insistenza del nuovo curatore, Ted Schelpe. fu creato per lei un posto di ricercatrice, con uno stipendio fisso. Grande appassionata di montagna, fin dal 1935 si era iscritta al club alpinistico del Sudafrica (MCSA). Conoscendo questa passione, le fu affidata la ricognizione della flora di alta quota delle montagne del Capo, che all'erbario era documentata in modo irregolare. Insomma, come lei stessa si espresse, il suo compito era "colmare i vuoti". Quasi ogni week end, approfittando del passaggio di qualche membro del MCSA, esplorava un angolo di quelle montagne, e tornava a valle con un sacco nero pieno di piante. Durante le vacanze, approfittava delle escursioni organizzate dal club per erborizzare in altre aree, come il Drakensberg. Non bisogna però pensare che raccogliesse a caso. Per "colmare i vuoti" concentrava la sua attenzione su un genere rappresentato in modo inadeguato e quando individuava una specie che poteva essere nuova, ritornava più volte nell'area per studiarne i tempi di fioritura e l'ecologia, raccogliere semi e frutti; esplorava i dintorni per mapparne la distribuzione e studiare specie affini, a volte per anni. Metteva a confronto le proprie raccolte con il materiale d'erbario e con le pubblicazioni, e, quando aveva finito, il genere era perfettamente documentato nelle sue schede, con gli esemplari ben montati nell'erbario e la loro tassonomia pronta per la pubblicazione. Un compito che però lasciava volentieri agli "accademici". Così, anche se scoprì almeno 150 taxa, pubblicò pochissimo. La maggiore eccezione è costituita dalle Restionaceae, di cui pubblicò una cinquantina di specie, soprattutto grazie alle insistenze del botanico svizzero Hans Peter Linder, uno dei tanti giovani studenti e perfezionandi che impararono ad amare e conoscere la flora sudafricana grazie alla sua generosità e disponibilità. Insieme a T. M. Salter, pubblicò inoltre alcune specie di Erica. Tra le sue scoperte più sensazionali, quella di Protea nubigena, una specie molto rara che vive solo nei pascoli ad alta quota dell'uKhahlamba-Drakenberg nel Natal. Nel 1989 l'Università di Città del Capo le conferì la laurea honoris causa (Master of Science). La lettera di accettazione al rettore la dice lunga sulla sua modestia: "Grazie per la sua cortese lettera del 9 gennaio. Accetto la laurea onoraria e apprezzo l'onore. Tuttavia mi chiedo se lo staff dell'erbario Bolus è stato consultato. Se la questione non fosse riservata, vorrei farlo io stessa, perché non mi sembra che il mio lavoro meriti questo grado. Spero che il Consiglio [di facoltà] non sia caduto in errore pensando che la scoperta di nuove specie sia chissà che risultato, perché non lo era. A parte questo, ho lavorato come tecnico mantenendo l'erbario in ordine e aggiornato". Altri tratti della sua singolare personalità - che dovette colpire profondamente chiunque la conobbe -emergono dai ricordi pubblicati in occasione della sua commemorazione. Ogni giorno, sulla sua fida bicicletta faceva la spola tra l'erbario e la sua modestissima casa, doveva viveva con alcuni adorati gatti; guidava studenti e perfezionandi in gite in bicicletta, distaccando anche i più giovani; detestava le ingiustizie ed era socialmente impegnata; ma il suo vero ambiente era la montagna, con la quale aveva un contatto così intimo che preferiva dormire all'aperto, su un giaciglio improvvisato di paglia ed erbe, piuttosto che in una tenda. Per celebrare i suoi ottant'anni, insieme agli amici del Club alpino, scalò lo Sneeuberg, la cima maggiore del Cederberg (2027 metri).  Tante specie e due generi A questa formidabile raccoglitrice, i tanti botanici con cui collaborò hanno dedicato una trentina di specie e due generi validi. Ad esempio, il suo "capo" Louisa Bolus le dedicò non meno di sette Aizoaceae, tra cui Delosperma esterhuyseniae e Gibbaeum esterhuyseniae; Compton Erica esterhuyseniae; Hilliard Selago elsiae (una specie oggi estinta) e Selago esterhuyseniae; Pillans Restio esterhuyseniae. Ci sono anche dediche più nascoste: alludendo alla sua passione per le montagne, dove si muoveva con l'agilità delle antilopi saltarupi Oreotragus oreotragus, E G. H. Oliver le dedicò Erica oreotragus. Con lo stesso gioco di parole, Karis pensava a lei nominando Monticapra ("capra di montagna") una sezione del genere Disparago. I generi dedicati a Elsie Esterhuyen sono tre, due in modo diretto, uno anch'esso in modo indiretto ed allusivo. Ad aprire le danze fu una delle sue colleghe al Bolus Herbarium, Frances Margaret Leighton, specialista dei generi Ornithogalum e Agapanthus, che nel 1944 le dedicò Elsiea con una motivazione semplice ed eloquente: "Il nome del genere onora Miss Elsie Esterhuysen del Bolus Herbarium, le cui raccolte hanno dato un valido contributo alla conoscenza della flora delle montagne più alte del Capo sudoccidentale". Il genere, stabilito sulla base di una specie raccolta quell'anno dalla stessa Esterhuysen, Elsiea corymbosa, è considerato sinonimo di Ornithogalum, e la specie è stata rinominata Ornithogalum esterhuyseniae. Nel 1967 Louisa Bolus, che, come abbiamo già visto, aveva già dedicato molte specie alla più prolifica dei suoi raccoglitori, le dedicò anche un genere, Esterhuysenia (Aizoaceae). Laconica (e tecnica) la dedica: per Elsie Elizabeth Esterhuysen, raccoglitrice del tipo, Provincia del Capo, nel distretto di Worcester; Hex River Mountains, Milner Peak, versante est, sulle sporgenze, 5,500-6,000 piedi, dicembre 1948. La specie in questione è Esterhuysenia alpina, una delle sei di questo piccole genere endemico di un'area relativamente ristretta della Provincia del Capo occidentale (distretti di Caledon, Ceres, Robertson, Worcester); sono piccoli arbusti nani, spesso a cuscinetto, che crescono tra le rocce intorno ai 2000 metri di altitudine. Hanno foglie carnose, tra quadrangolari a cilindriche, caratterizzate da un apice mucronato, fiori per lo più solitari con numerosissimi petali (in realtà staminoidi) bianchi, rosa o viola; i frutti sono capsule con cinque loculi, come quelli degli affini Ruschia e Lampranthus, di cui si distinguono perché mancano sia degli opercoli del primo, sia delle ampie ali del secondo. Tutte le specie sono rare, spesso limitate a aree molte ristrette, ma le loro popolazioni sono stabili. Anche il terzo genere dedicato a Esterhysen si deve a una botanica sudafricana, Olive Mary Hillard, nota soprattutto per aver fatto risorgere l'allora quasi moribondo orto botanico di Edimburgo, a sua volta una notevolissima raccoglitrice. Trovandosi già impiegati i possibili e più ovvii nomi ricavati da nome personale e cognome, Hillard dovette ricorrere a un vero e proprio gioco enigmistico: il suo Trieenea allude infatti alle tre E che formano le iniziali di Elsie Elisabeth Esterhuysen. Anch'esso endemico della Provincie del Capo occidentale e meridionale, questo genere della famiglia Scrophulariaceae comprende erbacee perenni o piccoli arbusti, più raramente annuali, che vivono in habitat montani; sette specie su dieci sono endemiche del Cedarberg, alcune note solo dagli esemplari d'erbario, altre ristrette ad aree molto limitate. Ha invece un areale relativamente più esteso T. glutinosa, in precedenza Phyllopodium glutinosum, che si spinge anche nella Provincia del Capo orientale. E' un piccolo arbusto che vive nelle spaccature delle rocce, con fusti eretti, foglie lievemente carnose con lamina quasi triangolare e margini dentati, piccoli fiori bianchi raccolti in brevi infiorescenze. Tra le specie del Cederberg, T. elsiae ricorda anche nell'eponimo Elsie Esterhuysen che la scoprì sul Sandfontein Peak, nel Cedarberg meridionale, il 5 aprile 1947. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, anche in Sud Africa alle donne si apre la carriera accademica. La prima ad insegnare botanica in istituto universitario sudafricano fu la statunitense Bertha Stoneman, che era stata una delle primissime laureate in scienze naturali del suo paese. La sua allieva Augusta Vera Duthie fu la prima persona formata in Sudafrica ad ottenere un lettorato di botanica, nel 1902, all'università di Stellenbosch. All'epoca aveva solo 21 anni. Come lettrice, poi come lettrice senior, vi avrebbe lavorato per quasi quarant'anni, dedicando le sue ricerche principalmente alle piante e all'ecologia degli Stellenbosch Flats, la pianura alluvionale dove sorge la città. A preservare almeno in parte questa flora ricca di endemismi, provvede la piccola riserva naturale che le è stata dedicata. Suo merito anche aver gettato le basi dello Stellenbosch Botanical Garden, il più antico orto botanico universitario del Sudafrica. A ricordarla la rara iridacea Duthiastrum linifolium.  Esplorare la flora... del campus universitario Il primo orto botanico universitario sudafricano, quello dell'Università di Stellenbosch, nacque nel 1902, e a fondarlo fu la botanica Augusta Vera Duthie (1881-1963), che fu anche la prima persona educata in Sudafrica ad ottenere un lettorato di botanica in un'università del paese. Augusta (ma in famiglia la chiamavano Avie) aveva trascorso l'infanzia nella tenuta di Belvidere, posta in splendida posizione panoramica sulla laguna di Knysna (Provincia occidentale del Capo) che apparteneva alla sua famiglia da oltre un secolo. Come i suoi fratelli, fu inizialmente educata in casa, finché a 17 anni si iscrisse all'Huguenot College di Wellington per studiare matematica e fisica. A indirizzarla verso la botanica fu una straordinaria insegnante, Bertha Stoneman (1866-1943), la prima donna in assoluto ad insegnare in un istituto universitario sudafricano. Nata negli Stati Uniti, nel 1894 Stoneman si era laureata in scienze naturali alla Cornell University di New York, specializzandosi in micologia (era una delle primissime donne a farlo). Dopo alcune esperienze di insegnamento in patria, nel 1897 accettò un incarico di un anno come lettrice di botanica all'Huguenot College, che era stato fondato appena due anni prima e fu il primo istituto sudafricano di istruzione superiore riservato alle ragazze. A convincerla a trasformare quell'incarico temporaneo nella sua occupazione per la vita furono, da una parte, la straordinaria ricchezza della flora sudafricana; dall'altra il suo impegno a favore dell'educazione scientifica femminile. Stoneman creò praticamente dal nulla il dipartimento di botanica del College, dotandolo di un erbario con le piante che raccoglieva nelle escursioni cui dedicava il tempo libero. Per le sue allieve nel 1906 pubblicò Plants and their Ways in South Africa che per molti decenni fu uno dei manuali scolastici più diffusi nel paese. Eccellente insegnante, formò generazioni di allieve preparate, tra le quali oltre a Avie Duthie, vale la pena di citare l'illustratrice Olive Coates Palgrave, autrice insieme al figlio Keith Coates Palgrave di Trees of Southern Africa; la micologa Averil Maud Bottomley, che lavorò presso il dipartimento delle crittogame dell'erbario nazionale di Pretoria, cui contribuì con importanti raccolte di funghi; e soprattutto la micologa e batteriologa Ethel Doidge, la prima donna ad ottenere un dottorato in Sudafrica, autrice del monumentale The South African fungi and lichens e di ricerche fondamentali sui patogeni di diverse colture agricole. All'inizio del Novecento, l'Hugenot College non assegnava ancora diplomi; così Augusta Duthie completò gli studi all'Università di Città del Capo e nel 1901 fu una delle prime allieve di Stoneman ad ottenere il diploma di Bachelor of Arts; l'anno dopo (aveva appena 21 anni) fu nominata lettrice di botanica presso il Victoria College (oggi Università di Stellenbosch). Come la sua maestra all'Huguent College, dovette creare dal nulla il dipartimento di botanica: aveva una stanza per le lezioni, ma non c'era né un laboratorio, né un erbario, né un orto botanico dove mostrare le piante agli allievi; per non parlare di microscopi e tanto meno di assistenti. Fortunatamente, però, benché sorgessero in una delle zone del Sudafrica più battute fino dal Seicento (Stellenbosch si trova a una cinquantina di km ad est di Cape Town), proprio attorno agli edifici universitari c'era molto da scoprire. Posta ai piedi dei rilievi della Stellenbosch Mountain, la città si trova in una pianura alluvionale (Stellenbosch Flats) con suolo argilloso e una vegetazione diversa da quella delle dune sabbiose dei Cape Flats di cui costituisce la continuazione. E' una zona di confine tra il fynbos granitco di Boland e il renosterveld dello Swartland, dove non mancano le piante rare o endemiche. Anche se era oberata dal lavoro (era costretta a supplire i magri proventi dello stipendio di lettrice con lezioni di inglese, storia e botanica in una scuola media), Duthie incominciò ad esplorare questo ricco terreno di caccia per creare un erbario e accanto all'edificio principale del Campus allestì alcune aiuole didattiche, il primo nucleo del futuro orto botanico. Per tre anni di seguito, il suo dipartimento riuscì a vincere il premo assegnato dal Dipartimento per l'educazione del Capo al miglior erbario montato e classificato, grazie al quale poterono essere acquistati libri, dieci microscopi e un microtomo. Nel 1904, l'erbario aveva raggiunto i 500 esemplari. Nel 1909, venne finalmente assunto un assistente part time, anche se in compartecipazione con il dipartimento di zoologia. Intanto Augusta aveva continuato a studiare e nel 1910 conseguì la laurea magistrale (Master of Arts) all'Università del Capo. Nel 1912 fu affiancata da un secondo lettore di botanica, l'inglese Sidney Garside, che si era laureato all'università di Manchester ed era specializzato in fisiologia vegetale. Duthie ne approfittò per ottenere un anno di congedo di studio, che trascorse in Inghilterra all'Università di Cambridge. Al suo ritorno in Sudafrica, nel 1913, riprese immediatamente ad occuparsi dell'espansione del dipartimento: entro il 1920, fu creato un laboratorio sperimentale e un museo botanico che presto divenne il più ampio del paese. Nel 1920, ottenne un secondo congedo per ragioni di salute, che trascorse in Australia ad erborizzare. All'inizio degli anni '20, al dipartimento di botanica ci furono molti cambiamenti: nel 1920 Garside tornò in Inghilterra; nel 1921 l'università decise di creare una cattedra di botanica, che però non fu assegnata ad Augusta Duthie, ma a uno dei suoi ex allievi, Gert Cornelius Nel, che dopo aver ottenuto la laurea di primo livello a Stellenbosch si era perfezionato a Berlino dove aveva studiato tra l'altro con Engler. Da quel momento, a Duthie, che era stata promossa lettrice senior, fu assegnato soprattutto l'insegnamento delle Crittogame e dei funghi; ma essendo venute meno molte incombenze amministrative, poté dedicare più tempo alle ricerche sul campo. Anche se fece raccolte pure nella zona di Knysna, si concentrò sulla flora degli Stellenbosch Flats che, grazie a una serie di articoli pubblicati da Duthie tra il 1924 e il 1940 sulla rivista dell'Università, Annale van die Universiteit van Stellenbosch, divenne la più studiata del paese. Il più ampio di questi lavori, Vegetation and Flora of the Stellenbosch Flats, pubblicato nel 1929 e presentato come tesi di laurea di dottorato all'Università del Capo, è un approfondito studio sull'intera ecologia dell'area e ancora oggi, dopo quasi un secolo, è un testo di riferimento. L'area è particolarmente ricca di bulbose e le sei specie di Angiosperme la cui scoperta e pubblicazione si deve a Duthie appartengono tutte alla famiglia Asparagaceae (generi Eriospermum, Ornithogalum e Drimia). Le sue ricerche toccarono però anche le crittogame dei generi Selaginella e Isoetes e i funghi Myxomyceti. Nel 1933 un evento tragico mutò la sua vita: in seguito alla morte dell'ultimo dei suoi fratelli, si trovò ad essere l'unica in grado di occuparsi della gestione della tenuta di famiglia. Alla fine del 1939, diede le dimissioni dal dipartimento di botanica e nell'agosto 1940 tornò a Knysna. Da quel momento non avrebbe più pubblicato e si sarebbe dedicata interamente all'azienda, dove morì ultraottantenne nel 1963.  Omaggi floreali e non solo Augusta Duthie era un'insegnante preparata e trascinante, e diversi dei suoi allievi diedero un importante contributo allo studio della flora sudafricana. Era anche una persona colta e affabile, in rapporti di scambio scientifico e amicizia con colleghi botanici in patria e all'estero. Particolarmente stretta fu la sua relazione con un'altra grande botanica sudafricana, Louisa Kensit Bolus, la curatrice dell'erbario Bolus, che le dedicò un Impatiens, un'Erica e tre specie di Aizoaceae da lei scoperte: Membryanthemum duthieae (oggi Ruschia duthieae), Psilocaulon duthieae (oggi Mesembryantemum articulatum), Stomatium duthieae. Anche il genere che la ricorda le è stato dedicato da una botanica, Miriam Phoebe de Vos, a sua volta grande specialista di bulbose, che fu sua allieva a Stellenbosch. Nel 1975 le dedicò con il nome Duthiella linifolia una nuova specie di Iridaceae; il nome però era illegittimo, perché esisteva già un genere Duthiella (famiglia Leskeaceae, muschi dell'Asia orientale e dell'Australia settentrionale); così ripubblicò il genere come Duthiastrum, commettendo però un errore ortografico (a rigori, il nome dovrebbe essere Duthieastrum, grafia adottata da diversi repertori, compreso il sito del SANBI, South African National Biodiversity Institute). L'unica specie di questo genere monotipico è Duthiastrum linifolium, una geofita endemica del Karoo settentrionale (Provincia settentrionale del Capo). Affine al genere Sparaxis, è una piccola bulbosa dotata di cormo con lunghi fiori tubolari aranciati con sei lobi lunghi e stretti disposti a stella, da cui il nome, letteralmente "stella di Duthie". Di lunga durata, per diversi giorni successivi si aprono all'inizio del pomeriggio e si chiudono subito dopo il tramonto. Come alcune specie di crochi, una volta che il fiore è stato fecondato, lo stelo si piega in modo che l'ovario rimanga interrato e maturi i frutti sottoterra (geocarpia). A ricordare Augusta Duthie e le sue ricerche, ci sono però anche l'orto botanico di cui gettò le basi e una riserva naturale. Lo Stellenbosch University Botanical Garden era originariamente ubicato di fronte all'edificio principale (Main Building) al lato occidentale del campus. Nel 1922, il neonominato Nel riuscì a convincere l'università ad assegnare al giardino un terreno apposito non lontano dal centro cittadino; la pianta del nuovo guardino, ispirato all'orto botanico di Padova, previde quattro aiuole principali a cerchi concentrici, separate da quattro viali a croce, più aiuole didattiche con le piante disposte per famiglie. Vennero anche costruite alcune serre, per proteggere le piante delicate dalle piogge invernali e dall'eccessivo calore estivo. Il giardino fu inaugurato ufficialmente nel 1925 ed ebbe come primo curatore il tedesco Hans Herre, che si era formato a Dalhem con Engler. Viste le limitate dimensioni del giardino, egli decise di concentrare le collezioni sulle piante succulente e per popolarlo fece molte spedizioni soprattutto nel Namaqualand. Oggi il compito principale del giardino, oltre agli scopi didattici, è la conservazione della flora nativa della regione del Capo, anche se non mancano rarità esotiche e collezioni speciali. Quando l'università si trasferì della vecchia sede, fu deciso di trasformare una parte dei terreni in una riserva naturale, battezzata Duthie Nature Reserve in onore della botanica che aveva dedicato tanta parte della sua vita allo studio della sua rara flora. Ricchissima di specie rare ed endemiche (per farvene un'idea potete sfogliare questa gallery), è oggi uno dei pochissimi luoghi dove cresce ancora in natura il rarissimo Haemanthus pumilio, oggetto di un progetto di riproduzione e salvataggio dell'Università di Stellenbosch. Rispetto alla conterranea, e quasi coetanea, Mary Barber, la figura di Caroline Hutton nata Atherstone è molto più convenzionale, anche se non mancano i tratti comuni: entrambe erano figlie di coloni del 1820, vissero nella Provincia orientale del Capo e divennero addirittura parenti; entrambe raccolsero esemplari per Harvey e Hooker, venendo ricordate dal primo con la dedica di un genere. Diversi furono invece i loro ambienti sociali e soprattutto la dedizione alla scienza. Caroline Atherstone era figlia e sorella di medici dai notevoli interessi scientifici e si trovò fin da bambina immersa in un ambiente colto e aperto; molto giovane sposò Henry Hutton, un funzionario dell'amministrazione civile, da cui ebbe moltissimi figli. Insieme a lui è ricordata da Harvey per le sue raccolte botaniche che non dovettero essere il centro della sua vita come per Barber, ma un hobby o una passione secondaria, sebbene abbastanza forte da persistere e forse intensificarsi anche quando era un'anziana vedova. Harvey le dedicò il genere di orchidee Huttonaea, la cui prima specie fu da lei scoperta sul Katberg. 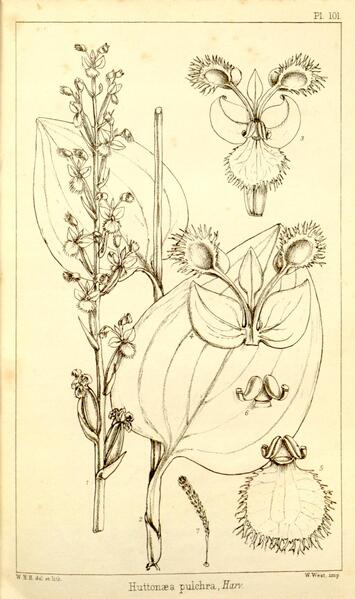 Raccolte in famiglia Come la famiglia Bowker, anche il dottor John Atherstone arrivò in Sudafrica con i coloni del 1820, ma, anziché diventare un fattore e un allevatore di bestiame, per qualche anno lavorò come chirurgo a Città del Capo, quindi nel 1828 venne nominato chirurgo del distretto di Albany sulla frontiera orientale, stabilendosi a Grahamstown. Quasi immediatamente fondò un gabinetto di lettura; fu qui, o dalla sua fornita biblioteca privata, che miss Bowker, ovvero la futura Mary Elizabeth Barber, prese in prestito la copia di Genera of South African Plants grazie alla quale scoprì la botanica. Del resto, era destinata a intrecciare strettamente la sua vita con quella della famiglia del medico: alla fine del 1839, il figlio maggiore di John Atherstone William Guybon tornò dall'Europa, dove era andato a laurearsi in medicina, accompagnato da uno dei suoi cugini inglesi: Frederick William Barber, ovvero il futuro marito di Mary. Oltre a diventare il più eminente medico della regione (tra l'altro, fu il primo a utilizzare l'anestesia durante un intervento chirurgico), William Atherstone aveva forti interessi scientifici. In Europa aveva studiato successivamente a Dublino, Londra e Parigi, ed era in contatto con molti scienziati tra cui Harvey e Hooker. Fu uno dei pionieri delle ricerche geologiche e paleontologiche in Sudafrica e nel 1855 fu tra i soci fondatori della Literary, Scientific and Medical Society di Grahamstown, le cui collezioni presto si trasformarono nell'Albany Museum, di cui per molti anni fu presidente e il maggior donatore, con esemplari che spaziavano in tutti i campi delle scienze naturali. Ma protagonista di questa storia non è il versatile dottore (cui pure il botanico della colonia Pappe dedicò il genere Athestonea, oggi ridotto a sinonimo), ma la più giovane delle sue sorelle, Caroline (1826-1908). Di lei non sapremmo nulla se non avesse lasciato traccia delle sue raccolte nei libri di Harvey e nei cataloghi dell'Albany Museum. Ignoriamo se abbia ricevuto una formazione formale, ma certo, nata in una famiglia colta, avrà condiviso l'interesse per le scienze naturali del brillante fratello maggiore, così come una delle sue sorelle, Bliss Ann (nota con il cognome da sposata White) che dopo il matrimonio fece importanti raccolte di rettili, insetti e altri animali nei dintorni di Brak Kloof, la fattoria che gestiva con il marito, donandole al museo di Albany. Nel 1848, la ventunenne Caroline sposò Henry Hutton che era arrivato in Sudafrica quattro anni prima; figlio di un pastore protestante, diciassettenne al momento del suo arrivo, forse per qualche tempo aveva lavorato per il futuro suocero, facendosi notare per l'intelligenza e gli interessi scientifici. Poi, forse con un spintarella di suocero e cognato, cui dovette essere legato da una forte amicizia, fece carriera; anche se durante le diverse guerre contro gli Xhosa egli ebbe anche qualche ruolo militare, servì soprattutto come impiegato pubblico, con compiti come sovrintendente dei forzati, giudice di pace, ispettore del dipartimento dei forzati, nonché tesoriere e segretario del Consiglio di divisione di Bedford, che lo portarono in varie località del distretto di Albany. Di tanto in tanto gestì anche una fattoria, anche per mantenere una famiglia sempre più numerosa (gli Hutton ebbero cinque figli e sette figlie, anche se solo sei raggiunsero l'età adulta). Probabilmente incoraggiati dal fratello e cognato, che era già in contatto con Harvey, forse già intorno al 1850 Caroline e Henry iniziarono a raccogliere esemplari e a inviarli a Dublino, come risulta dalla prefazione del primo volume di Flora capensis (1859), in cui il botanico ringrazia "l'egregio sig. Henry Hutton per le considerevoli raccolte fatte ad Albany". La collaborazione continuò per molti anni, anche oltre la morte di Harvey, quando il compito di completare l'opera fu assunto da Sonder e Tylseton-Dyer; i coniugi Hutter contribuirono con non meno di 120 diverse specie; come raccoglitore è in genere citato Henry, ma in una trentina di casi Caroline. Probabilmente spesso raccoglievano insieme e le raccolte dell'uno e dell'altra sono indistinguibili, ma a mantenere i contatti con Dublino e Londra provvedeva soprattutto il marito. Oltre che con Harvey, la coppia collaborò anche con il botanico coloniale Pieter MacOwan che nel 1867 cita Henry come uno dei cinque raccoglitori che avevano esplorato a fondo il distretto di Grahamstown. I coniugi Hutton spedirono esemplari anche a Hooker e ai Kew Gardens, ma il grosso delle loro raccolte fu donato al Museo di Albany, soprattutto dopo il 1891, quando si trasferirono nella fattoria Beaumont sul Fish River. Dopo la morte del marito nel 1896, Caroline, che ormai aveva settant'anni, continuò a raccogliere da sola. Nel 1900 viveva a Howick nel KwaZulu-Natal, da dove spedì 186 specie all'Albany Museum; altre spedizioni seguirono negli anni successivi, fino alla sua morte nel 1908.  Orchidee belle e rare Oltre che nel museo di Albany e nell'erbario del Natural History Museum, i coniugi Hutton hanno lasciato una traccia visibile nella nomenclatura botanica. Henry è ricordato da Lysimachia huttonii, che gli fu dedicata da Harvey già nel 1859; Moraea huttonii; Cyrtanthus huttonii, da lui raccolto nella distretto di Albany prima del 1864, data in cui fiorì per la prima volta a Kew; Ceropegia huttonii raccolta sul Botha Hill presso Grahamstown; Eulophia huttonii, Harveya huttonii, Printzia huttonii, Hesperantha huttonii e Wahlenbergia huttonii, tutte raccolte sul Katberg. Mancò invece la dedica di un genere, anche se forse ci contava. Sempre sul Katberg, una montagna a nord di Fort Beaufort, evidentemente il suo luogo di raccolta preferito, scoprì una pianta appartenente a un nuovo genere; ma Harvey la chiamò Bowiea volubilis, dedicandola, anziché a lui, al raccoglitore di Kew James Bowie. Caroline è ricordata da un numero molto minore di specie: Euphorbia huttoniae, Nerine huttoniae (oggi N. laticoma subsp. huttoniae), Sisyranthus huttoniae, Lachnagrostis huttoniae, le ultime tre risalenti agli anni della vedovanza, quando poteva "firmare" le sue raccolte senza lo schermo del marito. Se Harvey non le dedicò neppure una specie, al contrario di quanto fece con Henry, la compensò con un genere oltre tutto di notevole bellezza. Il secondo volume di Taesaurus capensis ( dedicato a suo fratello William che, ci informa Harvey, insieme a Henry Hutton, fu anche suo agente per la diffusione in Sudafrica di quest'opera e di Flora capensis), si apre con Huttonaea pulchra, una splendida e curiosa orchidea scoperta "nel marzo 1862 in angoli umidi, sotto gli alberi, sul Katberg, a 4000 piedi d'altezza, da Mrs. Henry Hutton". Ovvero dalla nostra Caroline. Il genere Huttonaea comprende cinque specie di orchidee terrestri endemiche di un'area ristretta alle montagne di Capo Orientale, KwaZulu-Natal, Stato Libero e Mpumulanga, con piogge estive. Tre specie (Huttonaea grandiflora, H. oreophila e H. woodii) vivono in spazi aperti erbosi, mentre le altre due (H. fimbriata e H. pulchra) nell'ombra delle foreste. La specie più diffusa, nonché quella che si spinge più in alto, è H. grandiflora (tra 2190 e 2800 m, dal Capo Orientale allo Stato Libero meridionale attraverso le montagne del KwaZulu-Natal), mentre la più rara è H. woodii che è stata raccolta solo tre volte in località diverse del KwaZulu-Natal. A seconda della specie, i fiori, raccolti in tozzi racemi, possono essere più piccoli e numerosi (fino a 25), oppure più grandi e pochi (2-4), ma tutti sono caratterizzati da una morfologia singolare: i sepali sono piatti, spesso verdastri, quelli superiori più o meno divergenti; i petali e il labello, da bianchi a crema, con macchie porpora, hanno margini fortemente sfrangiati; i petali hanno un'unghia più o meno lunga e sono più o meno fortemente saccati; formano così due sacchi gemelli (merianthium), una caratteristica rara tra le angiosperme e unica tra le orchidee, provvisti alla base di verruche ghiandolari che secernono olio: un "premio" ambitissimo dagli insetti impollinatori, le api del genere Rediviva. Mentre nelle altre specie l'angolo tra i petali permette a un insetto posato al centro del fiore di visitare contemporaneamente i due sacchi, in Huttonea pulchra essi formano un'angolo di 90 gradi, facendo divergere i sacchi e costringendo l'ape a visitarli separatamente. Anche se non è del tutto chiaro quali vantaggi comporti in termini di successo dell'impollinazione, è una caratteristica singolare che rende ancora più affascinante questa piccola orchidea scoperta nei boschi del Katberg da Caroline Hutton nel lontano 1862. Nella storia della botanica sudafricana, le donne hanno avuto un ruolo particolarmente incisivo. Un recente saggio ne ha recensite più di duecento, attive tra il 1699 e il 1950 come raccoglitrici, illustratrici, studiose. La più nota è sicuramente Louisa Bolus che per mezzo secolo diresse il Bolus Herbarium e fu un'autorità per Mesembryanthemum e altre Aizoaceaee; ma molto prima di lei c'è stata Mary Elizabeth Bowker Barber. Nata in Inghilterra, ma giunta in Sudafrica all'età di due anni, e sempre vissuta nella colonia, ad eccezione di un viaggio di pochi mesi in Europa, può essere considerata a tutti gli effetti la prima naturalista sudafricana. La prima in molte cose: la prima donna residente in Sudafrica a pubblicare un articolo scientifico su una rivista straniera, la prima a pubblicare un nome botanico, la prima donna in assoluto ad essere ammessa alla sudafricana South African Philosophical Society e alla viennese Ornithologischer Verein, la prima persona (indipendentemente dal sesso) a riconoscere la vera natura degli attrezzi litici preistorici rinvenuti in Sudafrica. Eppure era autodidatta, figlia e moglie di un allevatore di pecore di frontiera in tempi difficili. Corrispondente di Harvey, Joseph Dalton Hooker e Charles Darwin, è dedicataria dei generi Barberetta e Bowkeria, quest'ultimo insieme al fratello James Henri, militare ed entomologo.  Una vita da pioniera Tra i circa 4000 coloni britannici che nel 1820 (li chiamano proprio così, 1820 Settlers) emigrarono in Sudafrica nella speranza di una vita migliore, attirati dalla promessa della concessione di 100 acri di terra per ogni maschio di almeno 18 anni, c'era anche la famiglia Bowker: l'allevatore di pecore Miles Bowker, la moglie Anna Maria Mitford, gli otto figli maschi e l'unica femmina, Mary Elizabeth, che all'epoca aveva due anni. I Bowker arrivarono nel maggio 1820 e si stabilirono dapprima in una fattoria chiamata Oliveburn a una decina di km dal mare, poi nella più ampia Tharfield nel distretto di Albany, alla frontiera orientale della Colonia del Capo. Fu così che Mary Elizabeth Barber nata Bowker (1818-1899) crebbe in una delle zone più ricche di biodiversità del Sudafrica; la fattoria di famiglia si trovava nel bush, poco lontano dalla frontiera. Non c'erano scuole, e il padre, un uomo di classe media con una discreta cultura che aveva guidato in Sudafrica un gruppo di 23 coloni, tra famiglia, servitori e braccianti, ne aprì una per i figli suoi (in Sudafrica ne erano nati altri due, un bimbo e una bimba) e dei suoi dipendenti; egli dava grande importanza alle scienze naturali e il bush offriva infinite possibilità di osservare piante e animali in natura. Le due bambine ricevettero la stessa educazione dei maschi, come loro esploravano liberamente la campagna e Mary presto rivelò la sua grande capacità di osservazione. Precocissima, aveva imparato da sola a leggere e scrivere a soli quattro anni. La vita in quell'avamposto non era facile; nel 1834 la zona fu invasa dagli Xhosa, che erano stati respinti al di là della frontiera proprio per fare posto ai coloni, e anche i Bowker dovettero momentaneamente lasciare la fattoria. Negli anni successivi, i nove fratelli di Mary parteciparono anche con ruoli di comando al ciclo di guerre che seguirono (sesta, settima, ottava di guerra di confine). Ma nel frattempo Mary aveva trovato un rifugio e una somma gioia nella botanica, un hobby (la definizione è sua) che aveva scoperto per puro caso. Nel 1838 prese in prestito The Genera of South African Plants di Harvey, che contiene anche un'introduzione alla botanica e le istruzioni per raccogliere piante e tenere un erbario. Il botanico, che all'epoca lavorava a Città del Capo come tesoriere coloniale, chiedeva ai lettori di inviargli piante della loro zona, in vista di una più complessiva flora della Colonia del Capo. Mary gli scrisse, gli mandò semi ed esemplari, ma inizialmente nascose il suo sesso. Fu l'inizio di una collaborazione trentennale, nel corso della quale Mary avrebbe inviato a Harvey, che nel frattempo si era trasferito a Dublino come curatore dell'erbario del Trinity College, esemplari di circa mille specie di piante, accompagnate da note accurate, contribuendo più di ogni altro raccoglitore a Flora capensis; pittrice autodidatta, gli inviò anche molti schizzi, che però Harvey non pubblicò mai come tali, anche se ne trasse alcune delle illustrazioni di Thesaurus Capensis. Mary coinvolse nelle sue raccolte, il fratello minore James Henry Bowker, a sua volta corrispondente di Harvey e più tardi un notevole entomologo. Nel 1842 Mary sposò Frederick William Barber, anche lui allevatore di bestiame nonché chimico. Attraverso questo matrimonio, probabilmente basato soprattutto sulla convenienza, da cui nacquero due figli e una figlia, Mary Elizabeth Barber poté allargare i suoi contatti con altri naturalisti della Colonia. Barber era infatti cugino del medico William Guybon Atherstone, curatore del Museo di Albany e pioniere degli studi geologici in Sudafrica. Nel 1858 i Barber si stabilirono a Highlands, una fattoria situata in un crinale a 24 km da Grahamstown (Makhanda), un'area particolarmente adatta all'allevamento delle pecore, ma anche molto isolata. Inoltre il marito era spesso lontano da casa per spedizioni di caccia o per combattere gli Xhosa, e Mary trovava conforto negli studi naturalistici; oltre che di piante, incominciò ad interessarsi di uccelli ed insetti, che amava disegnare; incoraggiata dal fratello minore, appassionato collezionista di farfalle, nel 1863 scrisse all'entomologo Roland Trimen, che nel 1862 aveva pubblicato un primo piccolo volume sui lepidotteri sudafricani, offrendosi di illustrare il suo prossimo libro. Incominciò così a inviargli esemplari, schizzi e le sue osservazioni sugli insetti. Come vedremo più avanti, la collaborazione con Trimen, che presto si trasformò in amicizia, fu determinante per il futuro scientifico di Barber. Le cose andarono diversamente con l'ornitologo Edgar Leopold Layard, curatore dell'African Museum, che pure era un amico di famiglia; Mary gli fornì esemplari e disegni per il suo Birds of South Africa e nel 1868, quando Layard si accingeva a partire per l'Inghilterra, gli affidò un suo articolo chiedendogli di farlo pubblicare; Layard lo fece, ma sotto il nome Mr Layland, probabilmente un refuso per Layard. Il fattaccio lasciò sconcertata Barber, tanto più che l'entomologo, di fronte alle sue proteste, fece orecchie di mercante. Il riconoscimento come scienziata, e non solo come raccoglitrice o illustratrice, le arrivò poco dopo, grazie a illustri contatti inglesi, in parte propiziati da Trimen. Da tempo Mary Barber inviava semi ed exsiccata ai Kew Gardens, ma intorno al 1865, preoccupata per la salute declinante di Harvey (sarebbe infatti morto l'anno successivo) incominciò a corrispondere con James Dalton Hooker, sperando di trovare in lui un referente scientifico che lo sostituisse; il primo frutto della loro collaborazione, che si sarebbe protratta anch'essa per un trentennio, fu la pubblicazione sul Curtis's Botanical Magazine di un'illustrazione botanica di Mary Barber, quella della curiosa Brachystelma barberae, da lei scoperta e dedicatale da Harvey poco prima di morire. Più o meno nello stesso periodo attraverso Trimen Barber entrò in contatto anche con Charles Darwin. Nel 1862 quest'ultimo aveva pubblicato Fertilisation of Orchids, in cui per la prima volta espose le complesse relazioni ecologiche tra orchidee e insetti come risultato della selezione naturale e della coevoluzione; Trimen, che ammirava Darwin ma fino ad allora non aveva avuto il coraggio di contattarlo, stava studiando lo stesso argomento e nel 1863 gli spedì un suo articolo sulla morfologia dell'orchidea Disa grandiflora (ora D. uniflora), che molto doveva alle informazioni raccolte da Barber. In una lettera dello stesso anno, lo informò delle osservazioni di Mary sulle devastazioni delle pesche nell'area di Albany: secondo lei, la "colpevole" era una farfalla notturna, identificata da Trimen in Achaea chamaeleon, che perforava i frutti estraendone tutti i succhi fino a ridurle a buccia e nocciolo; Trimen dubitava che una farfalla fosse in grado di perforare una buccia così spessa, invece Darwin inclinava a dare ragione a Mary Barber. La connessione tra morfologia delle orchidee e impollinazione entomofila è anche l'argomento di due dei primi articoli di Barber, pubblicati grazie a Hooker e Darwin, Come ha dimostrato Tanja Hammel nella sua importante monografia sulla naturalista sudafricana, la loro pubblicazione era funzionale alla volontà dei due scienziati di supportare e far circolare la teoria della selezione naturale. Non a caso, il primissimo articolo di Mary Barber "On fascination", dedicato al supposto effetto ipnotico dello sguardo dei serpenti, le cui conclusioni non erano invece da loro condivise, fece la sua comparsa su una rivista divulgativa, Scientific Opinion. Fu invece il prestigioso Journal of Linnean Society ad ospitare gli articoli di Barber sull'impollinazione dell'orchidea Liparis bowkeri (1869), sul genere Aloe (1870) e sull'impollinazione e la disseminazione di Duvernoia adhatodoides (1871). Hooker pubblicò le sue osservazioni sulle piante carnivore e insettivore su Gardener's Chronicle (1870) e Darwin il suo articolo sul mutamento di colore delle larve e delle pupe di Papilio Nireus nelle Transactions of the Royal Entomological Society of London (1874). Inoltre nel suo saggio The expression of the emotions in man and animals la ringraziò pubblicamente per i suoi suggerimenti e contributi. Intanto, la scoperta dei diamanti nelle valli alluvionali dei fiumi Orange e Vaal nel 1867 stava mutando profondamente il volto del Sudafrica ma anche la sua vita personale. Anche Fred Barber fu contagiato dalla febbre e nel 1870 si spostò nei campi diamantiferi del Griqualand occidentale; moglie e figli lo raggiunsero l'anno dopo; dopo aver vissuto per mesi in tenda, acquistarono una piccola casa a Dutoitspan (Dorstfontein). Le condizioni di vita erano difficili, la ricchezza sperata non arrivò, ma Mary continuò le ricerche naturalistiche, scrisse diversi articoli sulla vita nei campi minerari, illustrati da suoi schizzi, e aggiunse ai suoi interessi un nuovo campo di ricerche, quello dei manufatti preistorici, divenendo anche una pioniera dell'archeologia sudafricana, la primissima a capire che quelle pietre erano arnesi lavorati da uomini vissuti in tempi preistorici. Nel 1872, sempre grazie a Trimen, fu la prima donna ad essere ammessa alla South African Philosophical Society; nelle Transactions di questa società nel 1878 pubblicò un importante lavoro in cui, attraverso molti esempi di animali maschi con livree vistose, appoggiò l'idea darwiniana della selezione sessuale. Intanto la sua vita personale era di nuovo mutata drammaticamente. Abbandonata la speranza di fare fortuna con i diamanti, nel 1874 i Barber acquistarono una fabbrica di soda e ginger ale, che all'inizio prosperò, ma poi si volse in perdita. Nel 1878, quando un incendio distrusse tutti i loro averi, Frederick decise di tornare in Inghilterra, dove un fratello aveva un ben avviato studio di fotografo. Mary per circa due anni visse ancora a Kimberley poi, venduta la proprietà, iniziò una vita errabonda. Solitamente trascorreva l'inverno a Durban con il fratello James Henry e le estati con i due figli, Frederick e Henry Barber. I due, insieme ai cugini Barber, erano molto attivi nella ricerca di giacimenti auriferi e intorno al 1884 trovarono un filone particolarmente ricco che chiamarono Barber's Reef: oggi vi sorge la città di Barberton. Mary orami aveva sessant'anni, ma continuava a osservare, studiare, scrivere e dipingere. Quando lesse in un giornale che il botanico dilettante Harry Bolus, il suo amico Trimen e l'esploratore ceco Emil Holub stavano per intraprendere una grande spedizione in cui avrebbero attraversato il continente nero da un capo all'altro, scrisse a Trimen per proporsi come "artista scientifica", una posizione più accettabile di quella di scienziata agli occhi dei maschi. Non se ne fece niente, ma al suo ritorno in Europa, Holub che era rimasto entusiasta dei suoi disegni di uccelli che gli erano stati mostrati dal figlio Frederick, li lodò in una conferenza tenuta alla Società ornitologica di Vienna e propose l'ammissione di Mary Barber alla Società come membro corrispondente, cosa che avvenne all'inizio del 1882. Nel 1883 la naturalista incontrò Marianne North, in visita nella Colonia. Nel 1886, mentre si trovava a Grahamstown, tenne una conferenza presso la Eastern Province Literary and Scientific Society in cui sottolineò l'importanza di preservare l'avifauna per controllare gli insetti dannosi all'agricoltura. L'intervento fu così incisivo che venne stampato come opuscolo. Nel 1889, insieme ai due figli, che ormai avevano fatto una discreta fortuna, giunse il momento di visitare l'Inghilterra e l'Europa. A Kew incontrò Marianne North e Thilseton-Dyer, il nuovo direttore dopo il pensionamento di Hooker. Alla fine dell'anno, anche Frederick Barber rientrò con loro in Sudafrica, ma non si ricongiunse alla moglie; visse a Grahamstown fino alla morte, avvenuta due anni dopo, mentre Mary divideva il suo tempo tra la casa del fratello a Durban e quella di sua figlia, che si era sposata e viveva a Pitermaritzburg; qui morì all'età di 81 anni. Un anno prima. il figlio Frederick era riuscito a fare pubblicare a Londra un volume delle poesie della madre, The Erythrina tree and other verses, la cui introduzione contiene un omaggio dell'amico di sempre Roland Trimen: "Ovunque la sorte l'abbia portata, la signora Barber si è sempre distinta per la sua equanimità, l'allegra fiducia in sé stessa, il fine senso dell'umorismo e il freddo coraggio, ma soprattutto per la costante perseveranza con cui ha continuato le sue ricerche di storia naturale".  Endemismi sudafricani Come ha dimostrato Tanja Hammel nella sua brillante monografia su Mary Barber, questa grande naturalista è stata anche una convinta sostenitrice della parità di genere. Contro la mentalità vittoriana, che assegnava alle donne il ruolo di angeli del focolare, pienamente realizzate solo come mogli e madri, rivendicava il diritto delle donne di scegliere il proprio destino e sognava una società in cui la cura della prole fosse equamente diviso tra entrambi i genitori, come aveva potuto osservare tra gli uccelli che studiava e dipingeva. Come aveva sperimentato nella sua infanzia, quando lei e sua sorella condividevano le stesse esperienze dei fratelli, la differenziazione di ruoli tra maschi e femmine non era innata, ma frutto di condizionamenti sociali. Così, la delusione più grande le venne dalla figlia Mary Ellen Barber e dalla nipote prediletta Mary Layard Bowker. La figlia era una ragazza intelligente, senza paura, capace di "fare di tutto" incluso "cavalcare qualsiasi animale, non importa quanto selvaggio", era la sua assistente e fin da bambina la aiutava nelle raccolte; eppure con il matrimonio lasciò da parte ogni velleità di indipendenza per trasformarsi nella madre di una nidiata di nove figli. Allora Barber ripose le sue speranze in Mary Layard; la incoraggiò a studiare e a diplomarsi. Nel 1888, alla morte della curatrice del Museo di Albany, le scrisse per convincerla a presentare la sua candidatura; non sappiamo se la giovane donna lo fece, ma nel 1889 rese orgogliosa la zia ottenendo l'abilitazione all'insegnamento, una professione che nella Colonia del Capo era ancora quasi esclusivamente maschile. Come sappiamo dalla prefazione di South African Butterflies, fornì diversi esemplari di farfalle a Trimen e altri li donò al Museo di Albany. Eppure a trentun anni si sposò (il marito era il figlio minore di Barber, Henry detto Hal), abbandonò l'insegnamento, mise fine a ogni interesse scientifico e si trasformò in moglie, madre e padrona di casa. Il contributo di Mary Barber alla conoscenza della flora sudafricana è testimoniato, oltre che dalle parole di riconoscenza scritte da Harvey nell'introduzione al I e al III volume di Flora Capensis, dalla dedica di diverse piante. Abbiamo già incontrato la straordinaria Brachystelma barberae (oggi Ceropegia barberae); altri omaggi di Harvey sono Dimorphoteca barberae e Polygala bowkerae, mentre si deve a Hooker Diascia barberae. Non dimentichiamo poi l'imponente Aloe barberae (oggi Aloidendron barberae), omaggio di Thilseton-Dyer. Harvey dedicò alla sua più prolifica raccoglitrice in Sudafrica anche due generi: uno solo per lei, l'altro in compartecipazione con il fratello minore James Henry Bowker. Il primo è Barberetta, un genere monotipico della famiglia Haemodoraceae rappresentato unicamente da Barberetta aurea, scoperta lungo il fiume Isomo da Mary Barber e suo fratello e "dedicata alla prima per gratitudine per le sue scoperte di numerose piante nei distretti della frontiera". Endemica della Provincia del Capo Orientale e del Natal e affine a Wachendorfia, è un'erbacea rizomatosa con foglie disposte a ventaglio e fitti racemi di fiori a stella giallo oro. Il genere in compartecipazione è Bowkeria: "Il nome generico vuole ricordare l'egregio Henry Bowker e sua sorella, la signora F. W. Barber, in precedenza Miss Bowker; entrambi hanno largamente contribuito alla nostra conoscenza delle piante della frontiera orientale, e io sono in debito con loro per molti esemplari interessanti, diversi dei quali sono stati presentati in questo volume". Tra cui l'unica specie del genere pubblicata da Harvey, B. triphylla, oggi B. verticillata, raccolta da Mrs F. W. Barber (la sigla sta per Fredrick William, a dimostrare qual era il ruolo delle donne nella società vittoriana). Oggi a questo genere della famiglia Stilbaceae sono assegnate tre specie, tutte endemiche del Sudafrica orientale: B. citrina, B. cymosa e B. verticillata; sono folti arbusti con foglie profondamente venate e intensamente profumate e curiosi fiori saccati bilobati con una stretta apertura, tanto da ricordare una conchiglia. Non risulta che Mary Barber le abbia studiate, ma certo sarebbe stata affascinata dalla loro morfologia e dalla relazione con gli impollinatori, le api del genere Rediviva; per attirarle, i fiori di Bowkeria nella sacca interna secernono un olio, per raccogliere il quale queste api si servono di setole specializzate poste sulle zampe anteriori; quindi lo trasferiscono sulle zampe posteriori e lo portano al nido dove viene trasformato in cibo per le larve e forse in rivestimento del nido stesso. Per concludere, due parole su James Henry Bowker (1825-1900), l'ultimo degli undici fratelli Bowker. Molto giovane, fu coinvolto nelle guerre di frontiera e fece carriera nell'esercito, fino a raggiungere il grado di colonnello. Convinto sostenitore dell'espansione della colonia, negli anni '70 divenne comandante della polizia di frontiera a cavallo e comandò la spedizione che portò all'annessione dei campi diamantiferi del Griqualand occidentale. Accanto a questo volto di militare imperialista, c'era però anche quello di scienziato. La sorella Mary, che gli era maggiore di sette anni, gli trasmise l'interesse per le piante; fui lui invece a trasmetterle quello per l'archeologia, scoprendo i primi manufatti preistorici negli scavi minerari abbandonati. Tuttavia la sua passione principale erano le farfalle. Scoprì non meno di 40 nuove specie e un nuovo genere; collaboratore da tempo di Trimen, dopo il pensionamento nel 1878 lo aiutò a scrivere i tre volumi di South African Butterflies (1887-1889). Assisté la sorella nelle sue raccolte botaniche, ma fece anche raccolte in proprio nei vari luoghi dove lo portò la carriera militare; nel 1853, in occasione di una visita a Londra, vendette una collezione di 350 esemplari a William Jackson Hooker, all'epoca direttore dei Kew Gardens (nonché padre di James Dalton Hooker). Dopo il pensionamento, si stabilì a Durban dove divenne giudice di pace; fu tra i fondatori del museo locali e donò collezioni a questo e altri musei; continuò ad inviare esemplari a Kew e negli ultimi anni sviluppò un grande interesse per i funghi. Oltre che dal genere Bowkeria, è ricordato dall'eponimo di diverse piante, come Bauhinia bowkeri e Ceropegia bowkeri. Come la sorella era membro corrispondente della South African Philosophical Society, ma, come maschio, ottenne molti più riconoscimenti di lei, inclusa all'ammissione alla Linnean Society, all'epoca chiusa alle donne, Intorno al 1817 in un giardino piemontese che presto sarebbe scomparso fiorisce e fruttifica, a quanto pare per la prima volta in Europa, un arbusto che si crede originario dell'Australia. E' così che il conte Freylino, grande appassionato di piante esotiche, ha avuto la ventura di dare il suo nome al piccolo genere Freylinia che, però, non viene dall'Australia, bensì dal Sud Africa, dove i suoi fiori dal profumo di miele fanno la delizia di farfalle e altri impollinatori.  Un conte giacobino e botanofilo Il 31 gennaio 1799 la piazza della cittadina piemontese di Buttigliera d'Asti ospitò un'animata cerimonia: l'innalzamento dell'albero della libertà, ornato di nastri tricolori. La "festa repubblicana" durò tre giorni: per tutti ci fu pane, riso e ottimi agnolotti, innaffiati dal vino spillato da due fontane: dall'una, "esquisito vino bianco di malvasia", dall'altra "ottimo vino di nebiolo", Il fatto più curioso è che ad offrire albero e intrattenimento fu il signore feudale del paese, Pietro Lorenzo Freylino, conte di Pino e Buttigliera. Ma forse in paese nessuno si stupì: non solo il conte, benché discendesse da una famiglia di finanzieri e consiglieri di Stato, era di idee giacobine. ma era anche abbastanza eccentrico da occuparsi più di botanica che di politica. Nel 1771 suo padre Pietro Giuseppe Freylino, già conte di Pino e proprietario di metà del feudo di Buttigliera, acquistò anche la seconda metà e con essa il palazzo che si affacciava sulla piazza del paese e il giardino attiguo. Il giovane Pietro Lorenzo (all'epoca un adolescente) ne fece il suo regno; sappiamo che già nel 1773 aveva incominciato a trasformarlo in un giardino di gusto ecclettico: c'erano statue, fontane e giochi d'acqua, per qualche tempo anche una stazione meteorologica e una serra. La località doveva godere di un'ottima esposizione (sappiamo da documenti d'epoca che vi si coltivavano gli olivi) e il conte ne approfittò per far crescere in piena terra le tipiche piante d'agrumi dei giardini all'italiana, che solitamente in Piemonte erano tenute in vaso e passavano l'inverno in una citroniera (così localmente si preferiva chiamare l'aranciera). Fin dall'inizio ci furono moltissime esotiche, per le quali Freylino sperimentava l'acclimatazione tanto in piena terra quanto in serra, con l'aiuto del "giardiniere ordinario" Andrea Pasta e del "giardiniere botanico" Giovanni Battista Rossi, così quotato che in seguito divenne capo giardiniere dei Borromeo all'Isola Madre e infine direttore dei Regi Giardini di Monza. Dal 1782 giunse anche nelle vesti di segretario, collaboratore, allievo e amico Maurizio Pangella che forse lo assistette nella stesura del primo catalogo del giardino: uscito nel 1785 (lo stesso anno della Flora pedemontana di Allioni) elencava 953 specie, utilizzando la terminologia linneana. Fu sicuramente Pangella ad occuparsi dell'aggiornamento, con due edizioni in francese uscite rispettivamente nel 1812 e nel 1818. Negli anni dell'effimera Repubblica piemontese, poi della Repubblica cisalpina, infine dell'annessione alla Francia, Freylino fu molto attivo, con una piccola carriera politica locale, culminata nella nomina a maire, ovvero sindaco di Buttigliera. Era piuttosto conosciuto negli ambienti botanici piemontesi; lo stesso Allioni ebbe a definirlo "indefessus botanophylus"; sappiamo che era in relazione, forse con scambi di semi e piante, con un altro nobile appassionato, il marchese de Spin, nonché con Balbis e Colla, giacobini come lui. Secondo la testimonianza dell'erudito astigiano Gian Secondo de Canis, nel 1814 il giardino conteneva "seimila piante tutte rare" e "alberi da ogni parte del mondo" e poteva senz'altro essere definito "il migliore che vi sia in Piemonte". Una gloria destinata a finire presto: nel luglio di quello stesso anno Vittorio Emanuele I rientrò a Torino ed ebbe inizio la restaurazione. A differenza di Balbis, forse il nobile conte Freylino non subì particolari ritorsioni; si ritirò nei suoi possedimenti astigiani e si occupò di piante, come prima più di prima. Tuttavia già nel 1820 morì e con la sua morte si aprì una vicenda giudiziaria degna di Casa desolata di Dickens; egli infatti nominò erede universale Maurizio Pangella, ma alcuni nobili parenti alla lontana del conte (che non aveva eredi diretti) impugnarono il testamento. Alla fine a Pangella venne riconosciuta la proprietà del palazzo e del giardino, mentre i beni feudali furono assegnati ai ricorrenti. Vittima della lunga causa fu soprattutto il giardino che, trascurato, finì per scomparire.  Dolce profumo di miele Prima del triste epilogo, un piccolo evento aveva fatto entrare il nostro conte botanofilo nella schiera dei dedicatari di un genere di piante. Nel maggio 1817 i lettori della Gazzetta piemontese potevano leggere la seguente notizia: "Nel ragguardevole numero di piante esotiche che il signor Conte Freylino coltiva nel suo giardino a Buttigliera, se ne trova una, creduta unica in Italia, la quale due anni sono fiorì ma non produsse alcun frutto. In quest'anno diede e fiore e frutto. Il direttore del giardino, signor Pangella, promette di darne fra breve un'esatta descrizione. Credesi questa pianta originaria della Nuova Olanda, e le verrà dato il nome di Freylinia oppositifolia. Molti rinomati botanici italiani ed oltramontani l'hanno riconosciuta per pianta nuova". Su quella "esatta descrizione" si basò l'amico Luigi Colla, che coltivava egli stesso quella pianta nel suo giardino di Rivoli e la pubblicò nel catalogo dello stesso (Hortus ripulensis, 1824). Non veniva però dalla Nuova Olanda (ovvero dall'Australia), ma dal Sudafrica. Oggi non si chiama più F. oppositifolia, ma F. lanceolata, perché era stata già descritta in precedenza dal figlio di Linneo come Capraria lanceolata. Oggi a Freylinia Pangella ex Colla (famiglia Scrophulariaceae) sono attribuite nove specie. Otto sono endemiche del Sudafrica, anzi della Provincia del Capo; l'eccezione è F. tropica, che è presente anche in Zimbabwe e Tanzania. Sono fitti arbusti sempreverdi di medie dimensioni, talvolta piccoli alberi, che al momento della fioritura si coprono di fiori tubolari con cinque lobi, in genere dolcemente profumati di miele, che attirano nugoli di farfalle e altri insetti. Ecco perché sono conosciute con il nome comune è honey bells. La specie più coltivata è F. lanceolata, con fiori giallo-aranciati o più raramente bianchi; quelli di F. crispa e F. visseri sono viola-porpora, mentre quelli di F. tropica possono essere bianchi, malva o azzurri; questa specie differisce dalle altre perché ha fiori raccolti in infiorescenze ascellari anziché in grandi infiorescenze terminali. Tutte fioriscono a profusione e sono estremamente eleganti anche nel portamento. Qualche informazione in più nella scheda. Negli anni che precedono immediatamente la rivoluzione francese, si intrecciano due storie che sembrerebbero non avere nulla in comune. Da una parte c'è il marinaio francese Nicolas Baudin, che l'origine borghese esclude da una carriera di comando nella marina reale; sceglie allora la marina mercantile, tanto più che è nipote di un armatore di Nantes dai traffici non sempre limpidi. Dall'altra parte, c'è una spedizione di botanici austriaci, che fallisce per la defezione di metà dei suoi membri. Finché, nell'isola di Haiti, dove forse è venuto a contrattare un carico di schiavi, il marinaio incontra il capo dei botanici e ne riceve una soffiata che cambierà per sempre la sua vita. Perché le piante non basta raccoglierle, bisogna anche che qualcuno le porti a casa. E magari le faccia arrivare vive. Questa diventa la specialità del capitano Baudin, che comanda una dopo l'altra ben tre Jardinière (ovvero serre viaggianti). Tutte, puntualmente, finite male. Su queste e altre navi navighiamo su e giù per l'Atlantico e l'Oceano Indiano, mentre i botanici erborizzano nelle Americhe, in Sud Africa e a Mauritius. Alla fine, a portare a casa un genere valido sono un austriaco e un francese: il giardiniere viennese Franz Bredemeyer, dedicatario di Bredemeyera (Polygalaceae), e il botanico Pierre André Ledru, dedicatario di Drusa (Apiaceae).  Come un capitano di marina si appassionò di botanica Il 9 termidoro dell'anno VI (27 luglio 1798) la folla parigina assiste a un grandioso spettacolo: muovendo dalla sede del Museo di storia naturale, un corteo di carri ornati di ghirlande raggiunge il Campo di Marte, dove verranno pronunciati numerosi discorsi e i musicisti del conservatorio offriranno un concerto. E' questo il modo scelto dal Direttorio per esporre coram populo i tesori trafugati durante la campagna d'Italia, in un'operazione propagandistica che trasforma un saccheggio in un atto di libertà: quei tesori, anziché essere gelosamente nascosti nei palazzi e nei conventi per il godimento di pochi privilegiati - si proclama - sono ora messi a disposizione di tutti nei musei della Repubblica, per il progresso delle scienze e delle arti. Il corteo è strutturato in tre divisioni: la prima è riservata alla storia naturale, con sei carri carichi di piante e animali esotici; la seconda alla scienza e alla tecnica, con altri sei carri ricolmi di libri, manoscritti, medaglie, spartiti; la terza, il clou dell'intera manifestazione, ai capolavori dell'arte: tra gli altri sfilano la quadriga di san Marco, la Venere capitolina, lo Spinario, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, quadri di Raffaello, Tiziano, Domenichino, Giulio Romano, per un totale di 300 tra statue e dipinti. Se questi ultimi sono stati strappati ai palazzi italiani, non è certo così per molta parte degli oggetti naturali: qualcosa arriva dall'Egitto, dove in quel momento si trova Napoleone, ma il grosso proviene dalle Antille, ed è stato aggiunto al corteo all'ultimo momento, su suggerimento di Antoine-Laurent de Jussieu. In un certo senso, sono anche quelli prede di guerra: è il bottino del viaggio di Nicolas Baudin ai Caraibi, un successo che di lì a un anno garantirà a questo marinaio di lungo corso il comando della più importante missione scientifica della Repubblica: la "spedizione Baudin" nelle Terre Australi. In attesa di raccontarla in un prossimo post, facciamo conoscenza con questo personaggio, le cui vicende si sono curiosamente intrecciate con quelle della "spedizione Märter", promossa dall'Austria di Giuseppe II. Nicolas Baudin (1754-1803) era nato nell'isola di Ré in una famiglia relativamente agiata; prese il mare a quindici anni, a bordo di uno dei vascelli dello zio materno Jean Peltier Dudoyer, un armatore che aveva iniziato la sua carriera armando navi negriere e aveva interessi sia in America sia nell'Oceano indiano; per molti anni Baudin navigò sulle navi sia dello zio sia della Compagnia delle Indie; quando scoppiò la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, Peltier Dudoyer fu uno degli armatori che fornirono navi e rifornimenti alle colonie ribelli; il nipote si trovò coinvolto in prima persona e si comportò con onore, tanto da essere promosso capitano. Nel 1780 gli fu assegnato il comando della fregata Apollon incaricata di trasportare truppe al Capo di Buona Speranza per sostenere gli olandesi contro i britannici; un compito squisitamente militare, tanto che il comandante del porto di Brest gli ritirò il comando per assegnarlo a un nobile (solo questi ultimi potevano diventare ufficiali della marina militare). Baudin per il momento abbandonò ogni speranza di farne parte e continuò a comandare navi mercantili. Nel 1785 come capitano della Caroline, anch'essa armata da Peltier Dudoyer, trasportò in Louisiana l'ultimo gruppo di Acadiani di Nantes; a New Orleans (all'epoca ancora francese, e ancora Nouvelle Orlèans) alcuni mercanti lo incaricarono di trasportare varie merci a Mauritius (all'epoca ancora francese e ancora Ile del France) a bordo della Joséphine (detta anche Pepita o Josepha). Forse per contrattare un trasporto di schiavi dal Madagascar nel viaggio di ritorno, egli fece scalo a Haiti, dove incontrò il botanico austriaco di origine tedesca Franz Joseph Märter (1753-1827). Facciamo un passo indietro per raccogliere questo secondo filone della nostra storia. Nel 1783 il direttore dell'orto botanico di Vienna Nikolaus von Jacquin convinse l'imperatore Giuseppe II ad inviare in America una spedizione alla ricerca di piante esotiche per i giardini di Schönbrunn. La capeggiava appunto Märter, professore di storia naturale al Theresianum, accompagnato da un altro botanico, Matthias Leopold Stupicz, dal pittore Adam Moll e dai giardinieri Franz Boos e Franz Bredemeyer. Imbarcatosi a Le Havre ad agosto, insieme al nuovo console imperiale negli Stati Uniti, il gruppo raggiunse Filadelfia dopo un viaggio di quaranta giorni, in cui sperimentò tre tempeste e Märter scoprì il proprio tallone d'Achille: un irrimediabile mal di mare. A Filadelfia egli incontrò William Bartram e avrebbe voluto senz'altro iniziare le raccolte prima dell'inverno, ma gli mancavano i libri e le attrezzature, che viaggiavano su un'altra nave. Poté così mettersi all'opera solo a novembre. Mentre tutti gli altri raggiungevano Charleston in nave, egli attraversò a cavallo Pennsylvania, Maryland, Virginia e le due Caroline, accompagnato dal medico e zoologo Johann David Schöpf, che aveva partecipato come volontario alla guerra d'indipendenza da parte britannica e aveva deciso di fermarsi nel paese per studiarne la fauna. Arrivato a Charleston nel gennaio 1784, Märter inizialmente pensò di inviare nelle Bahamas Stupicz e un giardiniere, mentre lui con gli altri esplorava le due Caroline e la Florida, ma, rendendosi conto che Stupicz non parlava quasi l'inglese, lo mandò nella Carolina del Nord, dove vivevano numerosi tedeschi. Mentre Moll e Bredemeyer rimanevano a Charleston, egli si imbarcò con Schöpf e Boos per le Bahamas, soffrendo di nuovo atrocemente il mal di mare. Fu così costretto a ritornare a Charleston, mentre nei mesi seguenti Boos, spesso in condizioni difficili, esplorò diverse isole, rientrando a Charleston verso la fine dell'anno. Nel frattempo Bredemeyer era stato inviato a Vienna con un primo trasporto; il viaggio, iniziato nel giugno 1784, si protrasse per cinque mesi con la perdita di molte piante. Poco dopo il suo arrivo, insieme all'aiuto giardiniere Schücht, egli fu rimandato in America per ricongiungersi alla spedizione, la cui situazione si era fatta piuttosto critica. All'inizio del 1785, Boos era a Charleston gravemente ammalato; Moll e Supicz, che in realtà si erano imbarcati proprio nella speranza di emigrare negli Stati Uniti, diedero le dimissioni uno dopo l'altro, per stabilirsi a Charleston, il primo come insegnante di disegno e incisore, il secondo come medico. A sua volta Märter aveva contratto la malaria. A maggio lo lasciò anche Boos, che partì per Europa con una parte delle collezioni: più fortunato di Bredemeyer, ebbe un viaggio breve e senza contrattempi, consegnando piante e animali in perfette condizioni. Poco dopo la sua partenza, Märter si imbarcò per la Martinica, fissata come punto d'incontro con Bredemeyer e Schücht. Ma il mal di mare lo tradì ancora una volta e dovette sbarcare a Guadalupa. Riuscì poi a raggiungere Haiti, dove nell'agosto 1785 finalmente arrivarono anche i due giardinieri. Tutti e tre erano malati; il più grave era proprio Märter, che fu bloccato per sei mesi e a lungo dovette anche essere ricoverato nell'Hôpital de la Charité a Cap-Français. Fu in queste circostanze che conobbe Baudin. Lo sfortunato botanico (che probabilmente lo aveva saputo da Bredemeyer) lo informò che il suo antico compagno Boos era stato inviato ad erborizzare al Capo di Buona Speranza ed era in attesa di un imbarco per Mauritius. Proprio la meta del nostro intraprendente capitano che non perse l'occasione, dirigendosi immediatamente al Capo. Almeno, questa è la storia vulgata: le date non coincidono perfettamente. Comunque, prendiamola per buona. Le collezioni americane di Franz Boos avevano fatto una tale impressione all'imperatore, che aveva deciso che, anziché tornare in America a dare supporto all'inconcludente Märter, era meglio andasse direttamente in Sud Africa, per poi passare a Mauritius. Boos partì da Vienna nell'ottobre 1785 insieme all'aiuto giardiniere Georg Scholl. Dopo un lungo e penoso viaggio, funestato dallo scoppio a bordo di un'epidemia che aveva fatto più di trenta morti, erano arrivati al Capo solo nel giugno 1786; furono generosamente ospitati dal colonnello Gordon, che comandava la guarnigione della Compagnia delle Indie olandesi; egli fece loro conoscere Francis Masson, con il quale esplorarono Swartand e il Karoo, fino ad allora non molto battuto dai botanici europei, raccogliendo non poche novità. Baudin arrivò al Capo nel febbraio 1787 e imbarcò Boos e una parte delle sue collezioni, mentre Scholl, secondo le istruzioni ricevute, rimaneva in Sud Africa. A marzo erano a Mauritius, dove Boos incontrò il governatore Ceré, che era già in corrispondenza con Vienna cui nel 1783 aveva inviato piante e semi. Boos gli consegnò i doni dell'imperatore e si trattenne a lungo a Pamplemousses, stringendo ottime relazioni con i botanici e gli appassionati che ruotavano attorno a quel magnifico orto botanico, ricevendo molte piante provenienti non solo a Mauritius, ma dall'intera Asia. Poté anche visitare l'Île Bourbon (ovvero La Réunion) ed esplorare le montagne dell'interno con il botanico Joseph Hubert. Intanto si era accordato con Baudin per noleggiare la Joséphine per trasportare a Vienna le sue collezioni, rese preziose dai contributi dei nuovi amici delle Mascarene. Nel dicembre 1787 la Joséphine-Pepita (che, tanto per aumentare la confusione, Boos aveva ribattezzato Pepinière, "vivaio") riprese il mare. Come ci informano i giornali dell'epoca, raggiunse il porto austriaco di Trieste il 18 giugno 1788. Il suo carico, che comprendeva anche qualche zebra viva, fece sensazione. Gli animali e le piante presero la via di Vienna, dove rientrò anche Boos. Durante quei lunghi mesi di viaggio, capitano e botanico avevano fatto amicizia. Boos illustrò a Baudin le tecniche migliori per preservare le piante e gli animali durante i lunghi viaggi oceanici; per Baudin fu la scoperta di una nuova vocazione: quella di raccoglitore-naturalista.  Avventure quasi corsare Il riuscito trasporto delle collezioni di Boos era senz'altro un ottimo biglietto da visita; Baudin sperava gli assicurasse il comando di una nuova spedizione di cui si andava vociferando: niente meno che la prima circumnavigazione austriaca del globo. Nel frattempo, al comando della nave commerciale Jardinière (ovvero "serra viaggiante", un nome non scelto a caso, visto che nel vaiggio di ritorno avrebbe dovuto imbarcare Scholl e le sue piante) partì per Canton, non è troppo chiaro se per conto proprio o della Compagnia imperiale delle Indie. Forse temendo guai con l'amministrazione cinese, viaggiava infatti sotto bandiera statunitense. Giunto a Canton, spedì il suo secondo in America per un traffico di pellicce, ma la Jardinière naufragò nelle Marianne settentrionali, di fronte all'isola di Asuncion. E' l'inizio di una serie di vicende rocambolesche: Baudin andò a Mauritius a procurarsi un'altra nave, che battezzò Jardinière II; il nome non portò fortuna: il 15 dicembre 1789 un ciclone colpì l'isola e la nave andò distrutta in porto. Allora Baudin si imbarcò come passeggero su una nave della Compagnia reale delle Filippine; di passaggio al Capo, poté prendere con sé solo una piccola parte delle collezioni di Georg Scholl. La nave era diretta a Cadice, ma non vi giunse mai. Lo scafo era in uno stato così deplorevole che si dovette fare rotta per le Antille e fare scalo a Trinidad, dove la collezione venne sbarcata. Baudin si imbarcò su un'altra nave e arrivò in Martinica, dove scrisse a Vienna per spiegare la situazione e riproporsi come comandante della progettata spedizione in Estremo oriente. Forse era giunta la volta buona. Nel gennaio 1792 la corte di Vienna gli concesse il titolo di capitano della Marina imperiale e gli affidò il comando di una nuova Jardinière che, oltre a prelevare Scholl e le sue collezioni, avrebbe dovuto esplorare le Indie Orientali e la Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Per accompagnarlo furono designati Franz Bredemeyer e l'aiuto giardiniere Joseph van der Schot che ad aprile si imbarcarono a Genova alla volta di Malaga. Ma i tempi erano cambiati: in Francia la monarchia era crollata, e pochi giorni dopo la loro partenza, il 20 aprile 1792, la Convenzione dichiarò guerra alla Prussia e all'Impero. Baudin all'improvviso diventava un nemico; raggiunta anch'egli Malaga, dapprima pensò di abbandonare la spedizione e cercò di negoziare il suo rientro nella marina francese; avendo avuto un rifiuto, continuò i preparativi, mentre Austria e Gran Bretagna chiedevano alle autorità spagnole il suo arresto e il sequestro della nave. Nella confusa situazione politica di quei mesi, in cui la Spagna tentava la difficile strada della neutralità, dopo una breve detenzione fu rilasciato e riprese possesso della nave. Lasciati i botanici a terra, il 1 ottobre la Jardinière salpò; ma Baudin, anziché tornare in Francia, cercò di realizzare da solo il programma scientifico inziale. Eccolo al Capo di Buona Speranza, dove caricò una parte delle collezioni di Scholl (che si accorse troppo tardi che ora la nave batteva bandiera francese); quindi si diresse verso la Nuova Olanda ma incappò in due cicloni successivi che la costrinsero ad attraccare a Bombay per riparazioni. La navigazione volse ora verso occidente, toccando il Golfo persico, il mar Rosso, la costa orientale dell'Africa, dove vennero raccolti esemplari di animali e piante, e terminò di fronte a Table Bay, dove la terza Jardinière si arenò durante una tempesta. Baudin si salvò e, a quanto pare, riuscì a recuperare almeno qualcosa delle sue raccolte, visto che anche queste finirono a Trinidad, dove passò durante il viaggio di ritorno, passeggero di una nave americana. Rientrato in Francia, nel marzo 1796 Baudin incontrò Antoine Laurent de Jussieu e gli suggerì di organizzare per conto del Museo nazionale una spedizione a Trinidad per recuperare le collezioni (sue o austriache, ormai poco importava...). Il direttorio accettò la proposta e il 30 settembre 1796 Baudin partì alla volta delle Antille al comando della Belle-Angelique. Lo accompagnava una piccola équipe scientifica: il botanico André Pierre Ledru, il giardiniere Anselme Riedlé, gli zoologhi René Maugé e Stanislas Levillain. Ma la nave era così inadatta a tenere il mare che alle Canarie Baudin dovette abbandonarla e sostituirla con una nuova nave, la Fanny, con la quale nell'aprile 1797 raggiunse Trinidad. Qui scoprì che l'isola era da poco passata nelle mani degli inglesi, che rifiutarono di consegnargli le collezioni. Baudin non era tipo da tornare in Francia a mani vuote. Nelle Antille c'erano diverse isole neutrali, come la portoghese São Tomé e la danese Saint Croix. Baudin e i suoi naturalisti le esplorarono e fecero buone raccolte di piante e animali; quindi a Saint Croix la Fanny venne sostituita con un vascello più agile, ribattezzato Belle-Angelique, a bordo della quale visitarono Porto Rico, quindi proseguirono per la Francia, dove giunsero nel giugno 1797, pochi giorni prima del grande corteo da cui abbiamo preso le mosse, giusto in tempo per esibire i loro trofei nella divisione di storia naturale. Quello stesso giorno, anche grazie ai buoni uffici del cugino Marie-Etienne Peltier - che dal 1794 batteva i mari come "corsaro della Repubblica - Baudin ricevette il comando della nave corsara Virginie; il 4 agosto fu reintegrato nella marina militare con il grado di capitano di vascello, e partecipò ad alcuni episodi della guerra contro l'Inghilterra. Ma la vera rivincita se la sarebbe presa nell'ottobre 1800, quando gli venne affidato il comando della grandiosa spedizione nelle Terre australi, più nota come "spedizione Baudin". In queste vesti lo ritroveremo in un prossimo post. E con lui tre dei naturalisti della Belle Angélique che lo seguirono nella nuova avventura, per perdervi la vita.  Epilogo: e vissero felici e contenti Molti sono i personaggi di questa storia affollata ad aver ricevuto l'onore della dedica di un genere botanico, anche se ne rimane valido uno solo. Ad aprire le danze è lo stesso capitano Baudin. Per ben due volte, De Candolle gli dedicò un genere Baudinia, ma entrambi sono ridotti a sinonimi: Baudinia (Myrtaceae) di Melaleuca e Baudinia (Goodeniaceae) di Scaevola. Si consola con l'eponimo di Limonium baudinii, una specie della Tasmania raccolta durante la sua celebre spedizione. Veniamo ora ai suoi compagni austriaci, raccontando ancora qualcosa delle loro vite dopo il turbinoso incontro con il capitano francese. L'ottimo Franz Boos (1753 - 1832) dopo il ritorno a Vienna fece carriera. Nel 1787, quando von Jacquin lasciò l'incarico, fu nominato direttore dei giardini e dell'orto botanico di Schönbrunn, cui nel 1790 si aggiunse la direzione del serraglio imperiale e del cosiddetto "Giardino olandese". Fino al ritiro nel 1827, continuò anche ad essere capo giardiniere e nel 1816 insieme al figlio Joseph Boos, anch'egli un valente professionista, pubblicò un catalogo delle piante selvatiche e coltivate di Schönbrunn. Nel 2001 il botanico austriaco Speta ha voluto ricordarlo con il genere Boosia, generalmente non accettato (è sinonimo di Drimia). Gli è stata anche dedicata una via nel quartiere di Hietzing. Dopo aver visto involarsi una parte delle sue collezioni per l'inganno di Baudin, Georg Scholl (1751-1831) rimase ancora in Sudafrica per diversi anni (il suo soggiorno ne durò in tutto dodici), ancora ospite del colonello Gordon. Le sue raccolte diventavano sempre più imponenti e sempre più difficili da trasportare, come ci informa Francis Masson nelle sue lettere a Joseph Banks. Di tanto in tanto, riusciva a spedire a Vienna bulbi e semi, tra cui quattro spedizioni tra il 1790 e il 1792 che, attraverso il console austriaco in Olanda, raggiunsero Vienna via Amsterdam. Solo nel 1799 gli fu possibile lasciare il paese, ritornando a Vienna con la collezione di piante vive sudafricane più importante d'Europa (ora capiamo meglio perché Banks, appena tornata la pace, si sia affrettato ad inviare al Capo il suo raccoglitore James Bowie). L'esemplare più sensazionale era una Fockea capensis, una specie così rara che a lungo si credette fosse estinta in natura. E' tuttora possibile ammirarla nella serra di Schöbrunn, grazie alla previdenza di un giardiniere che, durante la seconda guerra mondiale, lo salvò portandoselo a casa. Con i suoi 600 anni valutati, è considerata la più vecchia pianta in vaso del mondo. Quanto a Scholl, tornò a lavorare a Schönbrunn, quindi dal 1802 divenne capo giardiniere al Belvedere. Nel 1811 il figlio di von Jacquin gli dedicò Schollia (sinonimo di Hoya) e sempre nel 2001 Speta Geschollia (ugualmente sinonimo di Drimia). Lo ricorda l'eponimo dell'Aizoacea sudafricana Ruschia schollii. Nonostante la grande ricchezza e l'importanza storica delle collezioni di Boos e Scholl, la maggior gloria botanica è però riservata a Franz Bredemeyer (1758-1839), ricordato da un genere valido e da una decina di eponimi. Lo abbiamo lasciato ad Haiti al momento del ricongiungimento con Märter. Nel febbraio 1786 questi inviò lui e Schücht in Venezuela, dove contava di raggiungerli appena recuperata la salute. I due passarono da Porto Rico, che furono i primi botanici a visitare, quindi visitarono Caracas e il porto di La Guaira, dove avrebbe dovuto raggiungerli Märter. Nel frattempo questi aveva di nuovo cambiato idea e li richiamò, ma i due giardinieri ormai agivano in modo indipendente (e molto più efficace). Pur dovendo fare i conti con difficoltà economiche, carte sbagliate e i sospetti delle autorità spagnole, che temevano fossero spie, decisero di esplorare il più possibile quel paese tanto affascinante quanto quasi inedito per la botanica. Acquistarono dei muli e assunsero un assistente; a settembre viaggiarono a est di Caracas, visitando Guatire, Caucagua e la foresta pluviale nei pressi di Capaya (nell'attuale stato di Miranda); da marzo a maggio dell'anno successivo si spostarono verso ovest nell'attuale stato di Aragua e nei Llanos. Nell'aprile del 1788 si imbarcarono a La Guaira alla volta di Curaçao, dove noleggiarono la goletta americana The Commerce che li avrebbe riportati in Europa insieme a molte piante che fecero sensazione per l'aspetto decisamente esotico e tropicale. Li aveva preceduti di circa un anno lo stesso Märter. Invece di raggiungere i due giardinieri in Venezuela, era passato in Giamaica; qui aveva visitato le Blue Mountains, dove lo incontrò il botanico svedese Olof Schartz; secondo la testimonianza di quest'ultimo, era di nuovo malato, nonché depresso per la disgrazia in cui era caduto presso la corte di Vienna, che gli attributiva tutta la colpa del fallimento della spedizione. Nel maggio 1787 imbarcò totalmente a sue spese una collezione che secondo le sue dichiarazioni ammontava a non meno di 3000 esemplari, tra cui 1800 piante vive. Giunto a Londra, le fece svernare in serra; qui e in Olanda acquistò anche molti uccelli impagliati. Poté così presentarsi a testa alta all'imperatore che dovette perdonarlo, se lo nominò professore di botanica e storia naturale all'Università dei Paesi Bassi austriaci, fondata l'anno prima. Su sua raccomandazione, Bredemeyer venne nominato direttore dell'annesso orto botanico. Per entrambi, un incarico di brevissima durata. La rivoluzione del Brabante dell'ottobre 1789 li costrinse alla fuga. Una nuova occasione si presentò per Bredemeyer quando, come abbiamo anticipato, venne nominato naturalista della missione della terza Jardinière. Già sappiamo che l'avventura sfumò e il povero giardiniere rimase a terra, mentre Baudin partiva senza di lui. Non gli restava che tornare a Vienna. Nel 1793 divenne supervisore dei frutteti e dei parchi di Schönbrunn; in seguito si occupò dei giardini degli arciduchi, che nel 1802 accompagnò ad erborizzare in montagna. Al pensionamento di Boos, divenne a sua volta direttore dei giardini e del serraglio di corte. Sotto la sua direzione, furono allestite la "Casa delle giraffe" e una collezione di piante parassite. Divenuto consigliere imperiale e membro di molte società orticole, inclusa la Horticultural Society di Londra, morì ottantenne nel 1839. Le specie tropicali raccolte in Venezuela divennero una delle maggiori glorie delle serre di Schönbrunn, destando l'ammirazione di Humboldt, che fu spinto anche da quello spettacolo al suo viaggio in Sud America, dove non avrebbe mancato di ripercorrere le orme di Bredemeyer e Schücht. Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, conosceva bene Bredemeyer, delle cui note si servì ad esempio per descrivere le piantagioni di cacao del Venezuela, ombreggiate da alberi di bucaré (Erythrina poeppigiana) dagli smaglianti fiori rossi tra cui volavano eserciti di pappagalli dalle piume multicolori. Fu sicuramente lui a suggerire l'acquisto dell'erbario di Bredemeyer, 180 fogli del quale si trovano ora al Museo botanico di Berlino-Dahlem. Non stupisce dunque che sia stato proprio Willdenow a dedicargli il genere Bredemeyera, sulla base di una pianta raccolta da Franz Bredemeyer nei pressi di Caracas. Oggi a questo genere della famiglia Polygalaceae sono attribuite 18 specie, distribuite dal Messico al Paraguay settentrionale. Sono liane legnose o piccoli arbusti con foglie semplici, fiori con cinque sepali, due esterni e tre interni, con ali petaloidi; la corolla ha cinque petali (due laterali, la carena, e due rudimentali): i frutti sono capsule con semi protetti da un arillo con peli più lunghi dei semi stessi. La specie tipo descritta di Willdenow B. floribunda, diffusa dal Venezuela al Paraguay, presenta cospicui grappoli di fiori bianchi; è una specie officinale, con proprietà disintossicanti, cui la medicina tradizionale attribuisce efficacia contro i morsi dei serpenti. Tra le diverse specie che si fregiano dell'eponimo bredemeyeri o bredemeyerianus, vorrei ricordare almeno la spettacolare Bomarea bredemeyeriana: con i suoi grappoli di fiori a campana aranciati fu probabilmente una delle piante la cui vista colpì al cuore Humboldt. E Märter? forse qualcuno si domanderà. Sappiamo che la collezione d'uccelli fu da lui donata alla loggia massonica Zur true Eintracht (frequentata anche da Mozart e Schikaneder che ne avrebbero tratto ispirazione per l'uccellatore Papageno del Flauto magico) e andò dispersa quando il cattolicissimo imperatore Francesco bandì la massoneria nel 1794. Non ci è noto il destino della collezione botanica, forse meno favolosa di quanto Märter pretendesse. In condizione di professore "giubilato", ovvero in pensione, nel 1796 egli pubblicò una seconda edizione assai accresciuta di un libro sugli alberi austriaci che aveva pubblicato prima della spedizione (Verzeichniß der östreichischen Bäume, Stauden und Buschgewächse); l'anno successivo fu la volta di una monografia sulla batata dolce. Nel 1797, quando venne riaperta l'Accademia dei cavalieri teresiani, gli fu assegnata la cattedra di silvicoltura. La coltivazione di alberi da frutta e da legname era infatti ormai il suo interesse principale, tanto che nel 1799 aprì un vivaio con 300 piante da frutto; l'avrebbe venduto nel 1806 per motivi di salute, così come nel 1803 per la stessa ragione aveva dato le dimissioni dal Theresianum. Per altro morì più di vent'anni dopo, nel 1827, a 73 anni. Giuseppe II lo considerava streitsüchtig, ovvero polemico. A me pare piuttosto inconcludente. Sta di fatto che nessun botanico ha mai pensato di dedicargli, nonché un genere, neppure una specie. Fu invece nientemeno che de Candolle a dedicare un genere al solo botanico francese di questa storia, André Pierre Ledru (1761-1825), uno dei naturalisti della Belle Angélique. Sappiamo che era un sacerdote, da poco consacrato quando scoppiò la rivoluzione, cui aderì senza esitare, prestando giuramento alla Costituzione civile del clero. Nella fase più convulsa della controrivoluzione vandeana, come prete giurato si trovò in pericolo di vita; si trasferì così a Parigi, dove presumibilmente entrò in contatto con gli ambienti del Museum national e in particolare con Antoine Laurent de Jussieu (nel suo erbario si trovano esemplari donatogli da lui, comprese alcune piante coltivate al Trianon da suo zio Bernard de Jussieu). Grazie a queste frequentazioni, fu scelto come botanico della spedizione nelle Antille, durante la quale fece notevoli raccolte a Tenerife, Porto Rico e in diverse isole. Al suo rientro, tornò in provincia, divenendo insegnante, anche se non abbandonò mai del tutto la botanica, visto che allestì un orto botanico privato e possedeva un notevole erbario, ora conservato al Museo di Le Mans. De Candolle, che all'epoca lavorava ancora al Museum national, gli dedicò Drusa (Apiaceae), sulla base di un esemplare raccolto da Ledru (che egli definisce "ragguardevole botanico") a Tenerife, lungo la strada che conduce a La Orotava. La sua unica specie D. glandulosa è una piccola rampicante pelosa e appiccicosa, con fiori minuscoli e curiosi frutti dotati di ali dentate. Singolare la sua distribuzione: oltre che nelle Canarie e in Marocco (dove si ritiene introdotta), si trova in alcune stazioni della catena Cal Madow in Somalia. Napoleone è appena stato sconfitto e relegato all'Elba, quando sir Joseph Banks e il suo capo giardiniere William Townsend Aiton approfittano della pace ritrovata per inviare a caccia di piante i primi due "raccoglitori dei re" James Bowie e Allan Cunningham. Dopo una breve puntata in Brasile, il primo dovrà andare a raccogliere in Sud Africa, il secondo in Australia. La ripresa della guerra prolunga il soggiorno brasiliano e solo nel 1816 i due si dividono per raggiungere le destinazioni finali. In questo primo post seguiamo le avventure sudafricane di James Bowie, ricchissime di scoperte, finché il malcapitato botanico scopre sulla propria pelle che cosa succede quando, morto un re, se ne fa un altro. Da botanico del re cerca allora di rimettersi sul mercato come cacciatore di piante indipendente, ma l'impresa gli riuscirà solo per breve tempo. A ricordarlo la curiosissima Bowiea volubilis, oggi assai ricercata da appassionati e collezionisti. 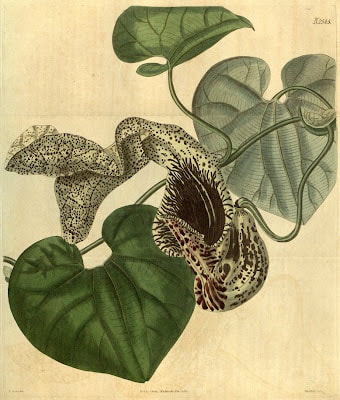 Australia, Sudafrica via Brasile Il 3 maggio 1814 lo sconfitto Napoleone sbarca all'Elba da una nave da guerra britannica. Per l'Europa è arrivato il momento della pace? Ne è convinto il capo giardiniere di Kew William Townsend Aiton che il 29 maggio ricorda a sir Joseph Banks che prima di ammalarsi re Giorgio III aveva espresso la volontà di inviare dei raccoglitori per incrementare le collezioni dei giardini reali e gli suggerisce di discuterne con il principe reggente. Il 7 giugno Banks risponde che la pace con la Francia ha riaperto la possibilità, e aggiunge che l'imperatore d'Austria ne sta già approfittando per spedire in giro i raccoglitori di Schönbrunn, l'unico vero rivale di Kew. Se il Reggente acconsentirà, ha già individuato tre possibili mete: il Capo, Buenos Aires e il Nuovo Galles del sud. Da parte sua, Aiton ha già in mente le persone adatte: due giovani giardinieri molto preparati che ha istruito lui stesso: James Bowie e Allan Cunningham. Alla fine le mete scelte sono due: il Sudafrica e l'Australia, con tappa intermedia in Brasile. Ci vuole ancora qualche mese per ottenere l'autorizzazione sia del Reggente, sia del governo portoghese. Terminati i preparativi, il 29 ottobre 1814 i "raccoglitori del re per Kew" Bowie e Cunningham si imbarcano sulla HMS Duncan alla volta di Rio de Janeiro, dove sbarcano il 29 dicembre. Dovrebbero fermarsi pochi mesi, ma la ripresa della guerra in Europa in seguito alla fuga di Napoleone dalla Elba cambia tutto: le comunicazioni intercontinentali sono di nuovo difficili e Banks usa tutto il suo prestigio per convincere i portoghesi a concedere ai suoi raccoglitori il permesso di addentrarsi nell' interno del paese, fino ad allora chiuso agli stranieri. Nei dintorni di Rio Bowie e Cunningham hanno trovato una ricca messe di piante e hanno già cominciato a inviare in patria esemplari d'erbario, semi e occasionalmente piante vive, che i francesi lasciano passare benevoli sempre grazie al prestigio internazionale di Banks. Nel aprile 1815 partono per Sao Paulo, che raggiungono dopo un mese di difficile viaggio a dorso di mulo. Si trattengono in questa regione che sono i primi europei ad esplorare per circa quattro mesi, per poi rientrare a Rio ad agosto. Dedicano l'autunno e l'anno successivo di nuovo ai dintorni di Rio, con escursioni a breve raggio nelle località più promettenti, in particolare alla Serra dos Orgãos, famosa per la sua ricchezza di biodiversità vegetale e animale. Se nelle zone più aride hanno raccolto soprattutto cactacee (sono loro a "scoprire" Rhipsalis grandiflora, Hatiora salicornioides e lo splendido Rhodocactus grandifolius), ora è la volta di bromeliacee e orchidee. Quelle che inviano a Kew sono soprattutto "piante da stufa", ovvero da serra calda. I loro apporti più noti sono la glossinia Sinningia speciosa e Jacaranda mimosifolia. Nel giugno 1816 arriva l'ordine di Banks di lasciare il Brasile e di imbarcarsi per le mete finali con la "primissima opportunità", ma, soprattutto per insistenza di Bowie che vuole completare l'esplorazione della Serra dos Orgãos, si trattengono ancora qualche mese. Infine, il 28 settembre 1816 entrambi si imbarcano per le rispettive destinazioni: Cunningham sulla Surry alla volta di Port Jackson (ovvero l'attuale Sideney) - dove lo raggiungeremo in un prossimo post -, Bowie sulla Mulgrave Castle per il Capo, dove sbarca il 1 novembre. 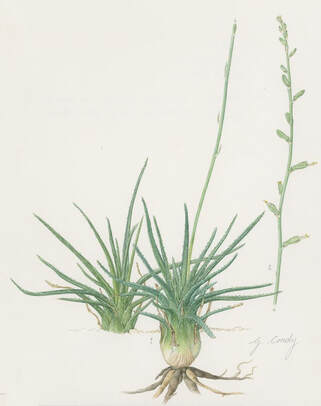 Quattro grandi spedizioni e un triste declino James Bowie (ca. 1789–1869), londinese, era figlio di un mercante di seta di Oxford Street. Intorno al 1810, a circa vent'anni, era stato assunto come giardiniere ai Kew Gardens, dove dunque prima di imbarcarsi per il Brasile aveva lavorato per quattro anni, venendo formato dalla stesso Aiton non solo in orticoltura, ma nelle migliori tecniche di raccolta e conservazione gli esemplari. Era un naturalista entusiasta e scrupoloso, ma, forse agli occhi di Banks, fino troppo intraprendente (e indipendente). Anche se aveva lasciato il Brasile con qualche rimpianto, il Sud Africa appariva ai suoi occhi ancora più promettente: "Nessun luogo è così produttivo del Capo di Buona Speranza [...]. Le piante di questo paese sono belle all'estremo e adatte alla conservazione". Banks la pensava nello stesso modo e non a caso aveva spedito qui il suo primissimo raccoglitore, Francis Masson, nell'orami lontano 1772; senza contare che le sudafricane, a differenza delle brasiliane, non erano "piante da stufa", ma specie rustiche o semirustiche, quindi più adatte alla coltivazione in giardino. Erano passati vent'anni da quanto Masson aveva lasciato definitivamente il Sudafrica, ed era ora di riallacciare quel filo interrotto dalla guerra, in una situazione politica per altro molto più favorevole, visto che nel 1797 gli inglesi avevano occupato la colonia del Capo e nel 1806 l'avevano annessa formalmente. Per circa un anno, Bowie erborizzò nei dintorni di città del Capo, finché nel marzo 1818 intraprese la prima spedizione nell'interno. Muovendosi a poca distanza della costa lungo quella che oggi è nota come Garden Route, esplorò la provincia del Capo occidentale, caratterizzata da clima mediterraneo con estati calde e asciutte e inverni miti e umidi, toccando successivamente Caledon, Gourits River, Great Brak River, George, Kaaimans River, Swart River, Goukamma e raggiungendo la costa a Knysna. Qui fece la conoscenza con George Rex, un ex funzionario britannico interessato alle scienze naturali che possedeva una fattoria detta Melkhoutkraal, che sarebbe diventata la sua base operativa nelle spedizioni successive. Quindi rientrò a Cape Town il 14 gennaio 1819. Si stabilì così una specie di routine: Bowie trascorreva i mesi estivi (ricordiamo che ci troviamo nell'emisfero sud, con stagioni invertite) caldi e asciutti, il periodo di stasi delle fioriture, a Città del Capo per preparare e spedire a Londra le raccolte di esemplari, semi, bulbi; all'inizio dell'autunno, ripartiva rientrando all'inizio dell'estate successiva. E' la falsariga della seconda spedizione (9 aprile 1819-22 gennaio 1820), durante la quale, dopo una sosta a Melkhoutkraal, si spinse fino a Plettenberg Bay, rientrando poi a Cape Town insieme a George Rex. Per la spedizione del 1820, ritornò a Knysna, dove fu ospite di Rex da marzo a settembre, quindi si mosse verso est fino ad Avontour, quindi a Uniondake nella Lang Kloof che separa la provincia del Capo occidentale da quella del Capo orientale; cambia anche il clima e ovviamente la vegetazione: dalla regione con piogge invernali, si passa a quella con piogge estive e inverni secchi e soleggiati, ma anche freddi di notte. Il viaggio proseguì per Uitenhage, Algoa Bay (l'attuale Port Elizabeth), Kowie, Grahamstown, quindi di nuovo Algoa Bay dalla quale Bowie rientrò a Cape Town il 29 gennaio 1821. La quarta e ultima spedizione fu la più lunga, occupando circa un anno e mezzo. Il suo punto di partenza fu quello di arrivo della spedizione precedente, Algoa Bay. Partitone nel giugno 1821, Bowie si diresse verso nord, toccando Graaff-Reinet e Eerste Poort, le località più settentrionali dei suoi viaggi. Rientrato a Algoa Bay, ne ripartì all'inizio del 1822. A febbraio a Uitenhage incontrò il botanico tedesco G.L.E. Krebs che aiutò a impacchettare bulbi e succulente. Una puntata ad est lo portò fino al Kowie River, l'estremo punto orientale delle sue spedizioni. Nel viaggio di ritorno toccò Avontuur, Van Stadens e Knysna, dove trascorse di nuovo tre mesi a casa di Rex, prima di rientrare a Cape Town il 4 dicembre 1822. Lo attendeva un'amara sorpresa. Nel 1820 erano morti sia Banks sia Giorgio III; per il nuovo sovrano Giorgio IV (il principe reggente che abbiamo incontrato all'inizio di questa storia), pochissimo interessato a piante e giardini, Kew cessava di essere una priorità; i fondi destinati ai Kew Gardens vennero dimezzati e fu deciso di richiamare uno dei due "raccoglitori del re", ovvero il nostro Bowie. Il motivo? "La mancanza di applicazione". Eppure egli era un raccoglitore formidabile, e le sue raccolte erano eccellenti per qualità e imponenti per quantità. I motivi veri erano altri: in primo luogo aveva dimostrato di essere troppo indipendente, di voler fare di testa sua, scegliendo in autonomia mete ed itinerari; in secondo luogo aveva preso due abitudini deprecabili agli occhi dei burocrati britannici: per arrotondare il magro salario vendeva sottobanco ai ricchi borghesi di Cape Town vistosi esemplari di piante molto richieste, come le Cycadaceae, le Strelitziae e i Crinum; per mantenere segreti i luoghi di raccolta, nelle note inviate a Kew li indicava in modo approssimativo o anche errato. Bowie dovette rassegnarsi a lasciare il Sudafrica. Non fu licenziato, ma assegnato all'erbario di Kew. Dopo otto anni di viaggi avventurosi e appassionanti, si sentiva stretto nei panni di botanico da scrivania. Sfogava la sua frustrazione nei bar e nei pub, raccontando ai compagni di bevute le sue mirabolanti avventure in Brasile e Sudafrica, magari stupendoli con un enorme serpente impagliato o altre bestie. Il suo unico sogno era tornare in Sudafrica, ma come raccoglitore indipendente. Ce ne informa nei particolari un breve articolo pubblicato all'inizio del 1827 sull'Edinburgh Journal of Science. L'autore (si tratta di William Jackson Hooker) esprime il suo rammarico per un provvedimento che ha rattristato "chiunque abbia a cuore la botanica", attesta l'eccellente qualità delle raccolte di Bowie, che ha potuto esaminare di persona a Kew; quindi scrive: "È ora suo [di Bowie] proposito tornare al Capo, ed esplorare di nuovo l'interno a proprio rischio, in cambio di un compenso per le sue grandi spese, nell'intento di mettere ciò che potrà raccogliere a disposizione dei naturalisti di questo paese". Segue un dettagliato prezzario: esemplari d'erbario, 2 sterline e 10 scellini il centinaio; semi, 5 sterline per cento dozzine; bulbi, come Ixia e simili, 10 scellini il centinaio; per quelli grandi, da 1 a 2 scellini e 6 centesimi l'uno; piante vive, 2 scellini e 6 centesimi l'una (per le piccole succulente, vale l'offerta tre per uno); Strelitziae, Zamiae e piante di dimensioni simili, 5 scellini l'una. Per le specie nuove si applica una maggiorazione. Grazie a questa inserzione e all'interessamento di amici come lo stesso Hooker, nell'aprile 1827 Bowie riuscì a ripartire per il Sudafrica e per qualche anno riprese le sue raccolte come cacciatore di piante free lance, inizialmente con qualche successo. Era anche un membro attivo della comunità scientifica della Colonia: fu tra i soci fondatori della South African Institution, la primissima società scientifica del Sudafrica, di fronte alla quale nella seduta del 31 agosto 1829 sostenne la necessità di creare un orto botanico a Cape Town dove le piante, in attesa di essere spedite in Europa, potessero essere acclimatate e studiate. Nel corso di tre sedute successive, presentò anche tre interventi intitolati "Sketches of the botany of South Africa", uno dei quali fu pubblicato da W. Bridekirk e rappresenta la prima guida della flora del Capo mai pubblicata. Considerato una specie di autorità, la cui conoscenza della flora del Capo era ritenuta senza pari, veniva anche consultato da ricchi proprietari di giardini, come il barone C.F.H. von Ludwig, che, quando la sua impresa fallì verso la metà degli anni '30, lo assunse come sovrintendente del proprio giardino. Sempre inquieto, lavorò alle sue dipendenze fino al 1841, quando riprese a viaggiare nell'interno a caccia di nuove piante; non ne aveva più né l'età né la fibra, anche perché "le sue abitudini erano tali da interferire con i suoi progetti" (dietro questa reticente formula vittoriana del Journal of botany si cela l'alcolismo). Si ridusse in estrema miseria, finché per carità Ralph H. Alderne lo assunse come giardiniere del suo giardino di Clarment. Bowie morì a Wynberg all'età di circa 80 anni. 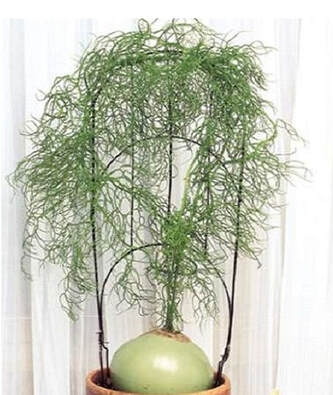 Una pianta più curiosa che bella? Hooker non era il solo ad apprezzare il lavoro di Bowie. Tra coloro che più si erano giovati dei suoi invii di succulente, c'era Adrian Haworth che nel 1824 denominò in suo onore Bowiea africana una delle piante da lui raccolte nell'ultima spedizione. La denominazione non è valida e oggi si chiama Aloe bowiea, conservando l'omaggio nell'epiteto. Un altro estimatore di Bowie era W. H. Harvey che, essendo stato ridotto Bowiea Haw. a sinonimo di Aloe, decise di recuperare il nome con una motivazione assai elogiativa che è anche un omaggio postumo a un uomo tanto bistrattato dalla sorte: "in molti anni di paziente lavoro nell'interno del Sudafrica ha arricchito i giardini europei con una varietà di succulente molto più ampia di qualsiasi altro viaggiatore in precedenza". Sono inoltre circa una ventina le specie, tanto brasiliane quanto sudafricane, che si fregiano degli epiteti bowiei e bowieanus; tra di esse Oxalis bowiei, Eriospermum bowieanum, Aspalathus bowieana. Bowiea Harv. ex Hook.f. (famiglia Asparagaceae) è un genere monotipico, rappresentato unicamente dalla sudafricana B. volubilis. Hooker figlio, che la pubblicò dopo la morte di Harvey, non la apprezzava più di tanto, ma ne era incuriosito; infatti scrive: "Per quanto possegga poca bellezza, è certamente una delle piante più curiose mai introdotte in Europa". E' proprio questa stranezza a farla oggi apprezzare dai collezionisti di bulbose e succulente. Affine a Drimia o Albuca, possiede un grande bulbo di colore verde chiaro che generalmente affiora dal terreno, rimanendo in gran parte scoperto, da cui nella stagione vegetativa emerge un fusto volubile molto ramificato che può raggiungere anche i tre metri. Le foglie che sono prodotte soprattutto vicino al bulbo in genere cadono poco dopo la nascita, mentre la funzione clorofilliana è svolta dal fusto e dai rami. Oltre che in Sudafrica, è presente in altri paesi adiacenti dell'Africa sud-orientale, dove cresce soprattutto in aree semiaride con piogge estive; in dormienza in inverno, con le prime piogge produce un fusto che cresce molto rapidamente. In primavera sbocciano anche i fiori, poco appariscenti e verdastri, seguiti a fine estate da capsule brunastre. Nel tardo autunno la pianta secca totalmente e entra in riposo. Di crescita lentissima (il bulbo può raggiungere il 15 cm di diametro, ma per farlo gli occorrono 25 anni) richiede coltivatori pazienti. In Sudafrica è diventata rara per l'eccessiva raccolta come pianta medicinale utilizzata per curare varie affezioni; le sono attribuite anche proprietà magiche come rendere i guerrieri coraggiosi, proteggere i viandanti, assicurare l'amore. Eppure è una pianta velenosissima tanto per gli uomini quanto per gli animali. Altre informazioni nella scheda. Nella Londra degli anni '20 e '30 dell'Ottocento, non erano pochi i visitatori stranieri che facevano una capatina a Chelsea, all'epoca ancora un villaggio fuori porta, per visitare il giardino e le collezioni naturalistiche dell'entomologo e botanico Adrian Hardy Haworth. Gentile ed affabile, accoglieva volentieri tutti e non si faceva pregare per dispensare i suoi consigli sulla coltivazione delle succulente. In questo campo era una vera autorità, un grande collezionista ma anche un tassonomista che scrisse pagine importanti per la classificazione di Mesembryanthemum, Aloe, Stapelia e generi affini. Si occupò meno di Cactaceae, ma non mancò di dare un contributo decisivo anche alla loro tassonomia. I suoi studi su Aloe aprirono la strada al francese Duval che ne separò i generi Gasteria e Haworthia. Quest'ultimo da allora è diventato un beniamino dei collezionisti; ma mentre aumentava il numero di specie e varietà, cresceva anche la confusione nomenclatoria. A mettere ordine nel caos ci hanno pensato di recente gli studi molecolari. Siete sicuri che le vostre Haworthia lo siano davvero? Tra farfalle e succulente Negli anni a cavallo tra Settecento e Ottocento, nei giardini e nelle serre europee si moltiplicano gli arrivi di succulente esotiche, dando inizio a quella che uno dei suoi maggiori protagonisti, Adrian Hardy Haworth (1767-1833), ha battezzato "l'età d'oro delle succulente". All'epoca, più che le Cactaceae, di cui si conoscevano ancora relativamente poche specie (la situazione incomincerà a cambiare a partire dagli anni '20 e '30, con le spedizioni botaniche in Messico e in Sud America) si trattava soprattutto di membri delle famiglie Aizoaceae, Crassulariaceae, Euphorbiaceae e Apocynaceae. Per lo più erano di origine sudafricana, e decisive per la loro conoscenza e introduzione in Europa furono le spedizioni di Francis Masson (1772-75, 1785-1795), grazie alle quali i Kew Gardens poterono riunire forse la principale collezione di succulente d'Europa. Fu proprio a Kew che Haworth le conobbe e se ne innamorò. Come molti naturalisti di primo piano del suo tempo, non era un professionista, ma un appassionato. Secondogenito di una facoltosa famiglia di mercanti e proprietari terrieri dello Yorkshire, era stato destinato dal padre alla carriera legale; aveva obbedito disciplinatamente ai suoi voleri, finché, all'età di 21 anni, la morte di lui gli diede l'indipendenza economica e la possibilità di seguire la sua vera vocazione: le scienze naturali. Stabilitosi in una proprietà di famiglia nel villaggio di Cottingham presso Hull, incominciò a raccogliere, collezionare e studiare insetti, uccelli, animali marini. Nel 1792, venticinquenne, si trasferì a Chelsea, all'epoca ancora un villaggio con giardini, vivai e un celebre mercato di fiori, senza dimenticare il Giardino dei farmacisti, che faceva ancora seria concorrenza a Kew per la ricchezza di piante esotiche. Uno dei suoi vicini era il mercante di vini William Jones, un altro appassionato che, dopo aver fatto fortuna, si era ritirato dall'attività per dedicarsi a raccogliere, studiare e dipingere le farfalle: ne nacquero le Jones Icones, una spettacolare raccolta di 1500 acquarelli di farfalle e falene. Jones diventò il mentore di Haworth: lo indirizzò allo studio dei lepidotteri, lo presentò alla Linnean Society, gli fece conoscere altri naturalisti, tra cui Joseph Banks. Quest'ultimo gli mise a disposizione le sue collezioni e la sua biblioteca e gli fece conoscere gli orti botanici di Kew e di Chelsea; Haworth incominciò a frequentarli assiduamente, dividendosi tra due passioni, l'entomologia e la botanica. Grazie all'amicizia con William Townsend Aiton, il sovrintendente di Kew, ottenne i primi esemplari della sua collezione di succulente. Proprio a un genere di succulente sudafricane dedicò anche la sua prima monografia, Observations on the Genus Mesembryanthemum (1794-95). L'entomologia era però il primo amore e occupava ancora il centro dei suoi interessi. In questi anni, da solo o con qualche amico, spesso partiva per una lunga scarpinata alla ricerca di insetti. Percorse così buona parte della Gran Bretagna. Insoddisfatto dello scarso peso dedicato all'entomologia dalla Linnean Society, alla quale era stato ammesso nel 1798, nel 1801 fondò l'Aurelian Society; il severo statuto da lui dettato, che tra l'altro imponeva agli aderenti di mettere in comune le loro collezioni, limitò le adesioni; la società non riuscì mai a superare i venti membri, finché nel 1806 venne sciolta. Di lì a poco dalle sue ceneri sarebbe sorta l'Entomological Society. Nel 1802, proprio all'Aurelian Society, Haworth presentò Prodromus lepidopterum britannicorum, in cui delineava il progetto di un catalogo completo dei lepidotteri britannici. L'anno dopo diede alle stampe il primo dei quattro volumi di Lepidoptera britannica (1803-1828), una pietra miliare in questo campo di studi, che sarebbe rimasto un'opera di riferimento per un cinquantennio. Per qualche anno, dal 1812 al 1817, Haworth tornò a vivere a Cottingham; scrisse un poema in versi in cui celebrava la natura e diede una mano a creare l'orto botanico di Hull. Nel 1817 ritornò definitivamente a Chelsea. Come aveva fatto Banks con lui, aprì volentieri le porte della sua casa agli amici entomologi e naturalisti: ne fece un punto di ritrovo dove, sorseggiando una tazza di tè, si discuteva, si presentavano le proprie ricerche, si esaminavano gli ultimi acquisti delle collezioni. Padrone di casa amabile e affabile, Haworth accoglieva volentieri i visitatori che giungevano anche dall'estero o i vivaisti che ricorrevano a lui per un consiglio su come classificare o coltivare le amate "grassottelle". Il giardino si trasformò in un orto botanico e la collezione di succulente, grazie agli esemplari ottenuti da Kew, vivai privati, corrispondenti e raccoglitori, raggiunse un migliaio di esemplari. La casa era un vero e proprio museo di storia naturale: al momento della morte di Haworth le sue collezioni comprendevano 40.000 esemplari di insetti, con 1100 specie e 300 varietà per i soli lepidotteri; un gabinetto di conchiglie; dodici teche di pesci e crostacei; un erbario di 20.000 esemplari; una biblioteca di 1600 volumi. Il 23 agosto del 1833 Haworth era in giardino ad annaffiare le sue piante quando incominciò a sentirsi male. Ventiquattro ore dopo era morto, una delle oltre 1400 vittime della recrudescenza del colera che nei due anni precedenti aveva già causato oltre 20.000 morti in Gran Bretagna. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. 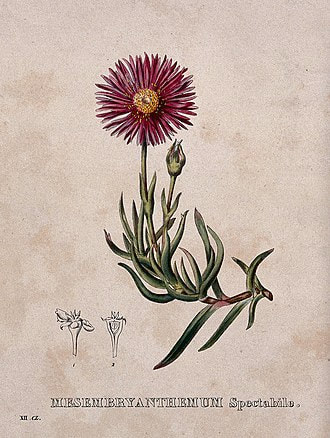 Classificare le succulente La collezione di succulente per Haworth era una passione, ma soprattutto uno strumento di lavoro. A causa dei loro tessuti carnosi, queste piante sono notoriamente difficili da essiccare e da conservare in un erbario; egli dunque privilegiava l'osservazione dal vivo, sia a Kew sia nel proprio giardino. Anche se continuava ad occuparsi anche di altri argomenti (oltre a completare la grande opera sui lepidotteri, scrisse moltissimo, pubblicando decine di contributi sugli insetti, sui crostacei, su altri gruppi di piante), per le succulente divenne un'autorità riconosciuta in tutta Europa. Purtroppo non dedicò loro un'opera complessiva, ma una serie di lavori di diversa ampiezza, che vanno dalla breve comunicazione alla corposa monografia; solo nel 1965 furono riuniti e resi più facilmente disponibili in A. H. Haworth, Complete Works on Succulent Plants. Risalgono al 1794 i primi due contributi, dedicati rispettivamente ai generi Mesembryanthemum (Aizoaceae) e Aloe (Asphodelaceae). Da quando Linneo li aveva ufficialmente creati nel 1753 in Species plantarum, il numero di specie note di entrambi i generi era cresciuto in modo esponenziale, rendendo urgente una risistemazione. Linneo aveva descritto 34 specie di Mesembryanthemum; nelle due serie di Observations on the genus Mesembryanthemum Haworth ne descrisse 130. Tornò poi sul genere ancora in Miscellanea naturalia (1803), Supplementum plantarum succulentarum (1819) e Revisiones plantarum succulentarum (1821), descrivendone in totale circa 160. Oltre a stabilire dozzine di nuove specie, fu anche il primo a tentare una classificazione del genere. In Miscellanea Naturalia lo suddivise in tredici sezioni, di cui fornì sinteticamente i caratteri diagnostici; di fronte all'arrivo di nuove specie, in Revisiones plantarum succulentarum rivide il proprio sistema, stabilendo otto sezioni e ben 69 sottosezioni e sottolineò che diversi di questi gruppi "possono essere considerati dei veri e propri generi naturali". Aprì così la strada ai botanici successivi che avrebbero elevato a genere alcuni di questi gruppi. Le specie linneane di Aloe sono nove; in A new arrangement of the genus Aloe Haworth ne descrisse 59 e ne discusse un'altra decina come dubbie o di difficile identificazione. Nel 1804, in una comunicazione pubblicata nelle Transactions della Linnean Society, le suddivise in tre sezioni: Parviflorae, Curviflorae e Grandiflorae. Qualche anno dopo (1809) il francese Duval in Plantae succulentae in Horto Alencionio mantenne in Aloe solo l'ultima e eresse le prime due sezioni a generi autonomi: la sezione Parviflorae divenne Haworthia, in onore del nostro, e la sezione Curviflorae Gasteria. In Synopsis plantarum succulentarum, un'opera che si presenta modestamente come un catalogo delle succulente coltivate nei dintorni di Londra (principalmente a Kew o da lui stesso), ma è in realtà una pietra miliare della storia della classificazione delle succulente, Haworth accettò i due nuovi generi di Duval, mantenne 31 specie di Aloe e ne propose una nuova sottodivisione in cinque gruppi (non tutti dotati di nome), sulla base non più dei fiori ma del caule. Synopsis plantarum succulentarum è importante anche per la trattazione delle Stapelieae. Nel 1810 Robert Brown sulla base delle caratteristiche della corolla aveva staccato dal genere linneano Stapelia i generi Huernia, Piaranthus e Caralluma. Haworth lo seguì sulla stessa strada, fissando altri nove generi. Alcuni più tardi furono ricondotti a sinonimi, ma ben cinque dedi generi di Haworth sono tuttora validi: Tridentea, Tromotriche, Orbea, Duvalia (con la quale Haworth rese il favore a Duval), Pectinaria. Non meno decisiva è la trattazione delle Cactaceae (fino ad allora egli si era occupato poco delle "succulente spinose"): Haworth dichiarò inutilizzabile il genere linneano Cactus e lo smembrò in sette generi (ne ho parlato qui). Supplementum plantarum succulentarum (1819), oltre a aggiunte su varie succulente, contiene un'importante revisione del genere Narcissus. Revisiones plantarum succulentarum (1821), oltre che per la nuova classificazione di Mesembryanthemum, si segnala per la creazione dei generi Cephalophyllum e Hymenogyne (due Aizoaceae della Provincia del Capo) e Monanthes, una Crassulacea endemica della Macaronesia.  Quando piccolo è bello La dedica a Haworth del genere Haworthia da parte di Duval è una delle più azzeccate della storia della botanica. Non solo perché il botanico inglese era stato il primo a descriverne molte specie e a studiare in modo sistematico questo gruppo di piante, ma perché con la sua grande varietà di forme e di colori è ricercatissimo dai collezionisti e dagli appassionati come lui stesso era. E' in questo che consiste la loro bellezza, molto più che nei fiori, come sottolineava lo stesso Haworth: "Le strutture curiose e perlacee che si trovano così di frequente in questa divisione compensano abbondantemente i loro fiori insignificanti. La loro bellezza equivale a quelle delle altre che sono sempre in fiore". Haworthia (Asphodelaceae) come è stato inteso per circa duecento anni, è un grande genere endemico del Sud Africa; alcune specie si estendono a Namibia, Lesotho, eSwatini (Swaziland) e Mozambico. Sono succulente nane a rosetta che vivono in una varietà di habitat e di comunità vegetali, dalle praterie aperte alle scogliere e alle montagne, in zone con precipitazioni sia estive sia invernali sia distribuite nell'arco dell'anno. A differenza di altre succulente, non amano il sole diretto: tipicamente, vivono ai piedi di arbusti, all'ombra di massi oppure nelle fessure delle rocce. Talvolta sono esemplari isolati, ma più frequentemente formano densi gruppi con decine o anche centinaia di rosette. A tanta varietà di habitat, corrisponde un'estrema varietà di forme: la rosetta può essere aperta o chiusa, le foglie possono essere più o meno carnose, arrotondate o acuminate, rigide o morbide, sottili o larghe, con spine o senza, pelose o glabre, con bande chiare, venature, verruche, escrescenze perlacee. Alcune specie presentano all'apice delle foglie delle specie di finestre traslucide e trasparenti: in natura vivono semi sommerse nel terreno e questa è l'unica parte che emerge, permettendo alla luce di diffondersi all'interno. Molto variabili anche i colori, dal verde lime al verde scuro, al grigiastro, al glauco, al marrone. A causa della forte varietà individuale anche all'interno della stessa specie, della facilità con cui si ibridano, dei confini labili tra una specie e l'altro, la tassonomia di questo gruppo è piuttosto complessa. Senza contare che se ne sono occupati soprattutto i collezionisti, che hanno moltiplicato i nomi e la confusione, con un accavallarsi di sinonimi. Si è arrivati a riconoscergli fino a 160 specie e più di 200 varietà. Nel 1947 ne fu separato il genere Astroloba. Sulla base di evidenti differenze morfologiche, nel 1971 Bayer divise Haworthia nei tre sottogeneri Haworthia, Hexangulares e Robustipedunculares. Ma la vera rivoluzione è iniziata intorno agli anni '10 del 2000, con le analisi molecolari che hanno dimostrato artificialità del genere. Nel 2013 Rowley e altri lo hanno diviso in tre generi, corrispondenti grosso modo ai tre precedenti sottogeneri: Haworthia (= Haworthia subgenus Haworthia), con 50-60 specie; Haworthiopsis (= Haworthia subgenus Hexangulares), con 18 specie; Tulista (= Haworthia subgenus Robustipedunculares), con 4 specie. Continuano ad essere Haworthia in senso stretto le piccole specie prive di stelo, con foglie carnose spesso dotate di finestre traslucide agli apici o bordate di spine; i fiori hanno sezione triangolare; diffuse in varie parti del Sud Africa, hanno centro di diversità nella Provincia del Capo occidentale. Tra quelle più note ai collezionisti Haworthia aracnoidea, H. cooperi, H. magnifica, H. retusa, H. truncata. Il genere Haworthiopsis ha centro di diversità più a est, nella Provincia orientale del capo. Comprende le specie con fiori con sezione esagonale, rosette a stella o disposte a spirale attorno allo stelo, con foglie più dure, talvolta fibrose, spesso caratterizzate dalla presenza di tubercoli e striature. E' indubbiamente il gruppo più noto ai collezionisti e ne fanno parte le specie di note (per lo più ancora commercializzate come Haworthia): Hawortiopsis attenuata (= Haworthia attenuata), H. fasciata (= Haworthia fasciata), H. limifolia (= Hawortia limifolia), Haworthiopsis reinwardtii (= Haworthia reinwardtii), Haworthiopsis venosa (= Hawortia venosa). Il piccolo genereTulista si distingue soprattutto per i fiori raccolti in infiorescenze ramificate e sorretti da un robusto peduncolo, per le dimensioni relativamente più grandi, per le foglie non fibrose con un essudato giallo. Almeno due delle sue specie sono abbastanza coltivate: Tulista pumila (= Haworthia pumila o anche Hawortia margaritifera), Tulista minima (= Haworthia minima). Tulista pumila è anche la prima specie del gruppo di Haworthia in senso lato ad essere stata raccolta e descritta; raccolta già negli anni sessanta del Seicento, nel 1682 fu pubblicata nel catalogo dell'orto botanico di Amsterdam come Aloe africana humilis spinis inermibus & verrucosis obsita, "Aloe africana di piccole dimensioni con spine inermi e cosparsa di verruche". Linneo la denominò Aloe pumila. Il che spiega anche il nome apparentemente incongruente: è la specie con rosette più grandi di tutto il gruppo, ma come Aloe, in effetti, era piccolina. Qualche informazione in più e una selezione di siti nelle schede di Haworthia e Haworthiopsis. Nel Seicento, l'Olanda vive il suo secolo d'oro. E' il paese più prospero d'Europa, all’avanguardia nei commerci, nelle scienze, nella cultura, nell’arte. E nei giardini: gli olandesi, sfruttando la loro secolare esperienza nel sottrarre terra al mare, ridisegnano la natura e creano un nuovo modello di giardino, in cui le siepi sagomate dalle forbici dei giardinieri disegnano stanze, padiglioni, teatri di verzura. A differenza del giardino all’italiana, in cui il verde domina, il giardino barocco olandese è colmo di fiori, con parterre multicolori simili ai tappeti persiani tanto amati da Vermeer o Rembrandt. Molti mercanti che si sono arricchiti con i traffici o le industrie investono il loro denaro in tenute di campagna che spesso ospitano vasti giardini, uno status symbol del loro potere e della loro ricchezza. Non possono mancare collezioni di piante esotiche: sono alla base della prosperità dell'Olanda e sono anche il simbolo del suo dominio sul mondo, il segno tangibile di quel nuovo Eden, paradiso in terra ricostruito, che per qualche decennio i Paesi Bassi si illudono di essere. E così non è un caso se Paul Hermann, il più importante botanico olandese del secolo, battezza Paradisus batavus, "Paradiso olandese", il suo libro dedicato alle rarità coltivate in quei giardini. Rarità che molto ha contribuito a introdurre in Europa, prima come esploratore del Capo di Buona Speranza e dell'isola di Ceylon, poi come direttore dell'Orto botanico di Leida. Linneo lo stimava tanto da proclamarlo "principe dei botanici" e da dedicargli, complice Pitton de Tournefort, il genere Hermannia.  Sud Africa, Ceylon... Leida Nel 1658, dopo una lunga guerra in cui intervenne a fianco dei sovrani locali (che ancora non sapevano che stavano per sostituire un occupante con l'altro), la VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie, Compagnia olandese delle Indie orientali) espulse definitivamente il Portogallo da Ceylon (oggi Sri Lanka). Da quel momento, esercitò il monopolio del commercio della cannella dell'isola, la migliore in assoluto. Ma impiegati e ufficiali si ammalavano con allarmante frequenza di malattie sconosciute in Europa che i farmacisti e i chirurghi al servizio della Compagnia non sapevano come curare; le medicine portate dall'Europa nel clima tropicale non sempre servivano e perdevano presto la loro efficacia; era urgente studiare la flora locale alla ricerca di piante medicinali alternative. Un influente uomo politico, Hieronymus van Beverningh, che era anche un accanito collezionista di piante esotiche, e il prefetto dell'orto botanico di Leida Arnold Seyen raccomandarono il giovane medico tedesco Paul Hermann (1646-1695), da poco laureato alla prestigiosa università di Padova; si dice fosse interessato alle piante fin da bambino, quando, a dieci anni, rischiò di annegare per esaminare delle piante acquatiche. I suoi sponsor speravano che, oltre a soddisfare gli obiettivi della Compagnia, potesse anche arricchire le loro collezioni. Dunque, in un certo senso Hermann è il primo cacciatore di piante al servizio di un orto botanico. Partito per Ceylon all'inizio del 1672, ad aprile approfittò dello scalo al Capo di Buona Speranza per raccogliere piante sudafricane; e altrettanto fece durante il viaggio di ritorno, nel marzo del 1680. A parte il precedente della piccola raccolta di Justus Heurnius (che però era un teologo, non un botanico), si tratta del primo contatto di un botanico europeo con la flora del Capo. Con gli esemplari raccolti (circa 800, secondo la testimonianza di Linneo) formò un erbario; spedì semi e bulbi in Olanda, e altri li affidò al chirurgo di bordo Hieremias Stolle, di ritorno in Europa. Questi a sua volta li passò all'anatomista danese Thomas Bartholin che nel 1775 pubblicò la breve nota "Plantae novae Africanae", la prima pubblicazione a stampa dedicata esclusivamente a piante sudafricane. A Ceylon, come "medico ordinario e medico capo" della VOC, Hermann si stabilì a Colombo, sede del quartier generale della Compagnia; creò e diresse un ospedale, esplorò assiduamente la flora dei dintorni, annotando i nomi locali e le proprietà medicinali delle piante. Con questi materiali mise insieme diversi libri di erbari e almeno un volume di illustrazioni (non è certo se di sua mano o di altri anonimi disegnatori); inoltre inviò più volte bulbi e semi in Olanda. Sebbene siano limitate alla zona intorno a Colombo (gli olandesi controllavano solo alcune aree costiere) e includano anche diverse specie coltivate introdotte, le sue raccolte sono impressionanti per quantità e per la qualità delle annotazioni, senza contare l'eccezionale valore storico, trattandosi del primo studioso europeo a esplorare la flora dell'isola, ai suoi occhi un vero Eden. Intorno al 1674 visitò anche brevemente il Malabar dove forse incontrò van Rheede, che potrebbe averlo consultato per il progetto che poi divenne Hortus malabaricus. L'esplorazione della flora singalese diede grande fama a Hermann, tanto che nel 1678, alla morte di Arnold Seyen, i rettori dell'Università di Leida decisero di chiamarlo a succedergli come professore di botanica e prefetto dell'Orto. Hermann accettò e tra la fine del 1679 e l'inizio del 1680 lasciò Ceylon per tornare in Olanda. Nelle sue lezioni, fu il primo botanico olandese a prestare attenzione alla tassonomia; creò anche un proprio sistema, basato sui frutti, che univa e modificava quelli di Ray e Morison. Oltre che a Leida, fu adottato in altri orti botanici, tra cui Uppsala ai tempi di Rudbeck il vecchio. Deciso a fare dell'Orto di Leida il migliore d'Europa, solitamente dedicava le pause accademiche a viaggi in altri paesi europei per consultare colleghi e appassionati e procurarsi piante; nel 1682 fu in l'Inghilterra, dove visitò tra l'altro gli orti botanici di Oxford e Chelsea, e ne riportò più di 200 piante vive (soprattutto nord americane); nel 1688 andò a Parigi ad incontrare Tournefort; qui strinse amicizia con l’inglese William Sherard, che decise di seguirlo a Leida. Dal 1686, assunse anche l'insegnamento di medicina pratica. Durante la sua gestione, l'orto botanico di Leida divenne il principale centro europeo di acclimatazione e diffusione delle piante provenienti dalle colonie americane, africane e asiatiche. Oltre alle sue introduzioni dirette dall'India e dal Sud Africa, poté sfruttare i suoi contatti con la VOC e con i principali collezionisti olandesi, nonché con l'Inghilterra e la Francia, per triplicare le collezioni (il suo catalogo del 1687 registra tremila specie, contro le circa 800 di inizio secolo); molte erano subtropicali o tropicali. Nel 1681, fu tra i primi a sperimentare una serra riscaldata. 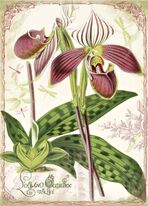 Olanda, un secondo Eden? Hermann morì nel 1695 a soli 49 anni (qui una sintesi biografica), lasciando incomplete e inedite diverse opere; l’unico suo libro pubblicato in vita fu infatti il catalogo dell’orto botanico di Leida (1687). Quella a cui teneva di più, e a cui lavorava da diversi anni, era Paradisus batavus, un catalogo illustrato delle piante di recente introduzione nei giardini olandesi. Già nel 1689 l'affezionato Sherard ne aveva pubblicato l’indice, e alla morte inaspettata del maestro e amico si assunse il compito (ingrato, visto lo stato del manoscritto) di curarne la pubblicazione; a spese della vedova di Hermann, l’opera uscì in una prima edizione relativamente economica in ottavo nel 1695, e in una seconda più pregevole edizione in quarto nel 1705 . Entrambe comprendono un centinaio di calcografie, su disegni in gran parte di mano dello stesso Hermann; per numerose specie, si tratta della prima immagine a stampa. Nonostante sia un lavoro diseguale (a causa della morte dell’autore, le piante sono trattate in modo variamente esteso e in alcuni casi l'illustrazione è priva di note d'accompagnamento) è di estremo interesse per la storia dell’introduzione delle piante orticole; tra di esse, come ho raccontato in questo post, le prime due orchidee tropicali coltivate in Europa. Ma è anche un documento in presa diretta della civiltà olandese del giardino nel secolo d’oro. Tra i giardini citati, oltre agli orti botanici di Leida e Amsterdam e a quelli principeschi di William e Mary (divenuti sovrani d’Inghilterra nel 1689, in seguito alla gloriosa rivoluzione), quelli di importanti uomini politici: il suo protettore Hieronymus van Beverningh, il segretario degli stati d’Olanda Simon van Beaumont, il pensionario di Haarlem Gaspar Fagel, il ciambellano Willem Bentinck (poi primo duca di Portland). Per questi uomini di potere, i giardini e il collezionismo di piante esotiche e rare avevano un preciso significato ideologico: come leggiamo in Den Nederlandtsen Hovenier , il popolare manuale di giardinaggio scritto da Jan van der Groen (circa 1635-1672), capo giardiniere dello statolder, la caduta di Adamo aveva reso imperfetta la natura, ma l’arte, la domesticazione e l’ordine potevano restituire la perfezione perduta e i giardini erano la prova materiale della riuscita dell’impresa. Il titolo del libro di Hermann, Paradisus batavus «paradiso olandese», si rifà esplicitamente a questa ideologia. Nel 1717, le note di campo scritte da Hermann a Ceylon furono pubblicate, sempre da Sherard, sotto il titolo Musaeum Zeylanicum. Ma per la storia della botanica sono molti più importanti gli erbari. Hermann aveva raccolto centinaia di esemplari sia per sé, sia per i suoi sponsor; al rientro da Ceylon, consegnò almeno un libro d’erbario a Beverningh e un altro a Jan Commelin, direttore dell'orto botanico di Amsterdan. Dopo la sua morte, la vedova, probabilmente per finanziare la stampa di Paradisus batavus, vendette il resto all’asta. Per cinquant’anni, se ne perse ogni traccia, finché nel 1744 giunsero nelle mani del farmacista reale danese August Günther cinque volumi, quattro d’erbario e uno di disegni. Günther li prestò a Linneo, che se ne servì sia per la sua unica pubblicazione sulla flora asiatica, Flora Zeylanica, sia per le piante singalesi di Species plantarum. Dopo diversi altri passaggi, il prezioso erbario fu acquistato da Joseph Banks e fa oggi parte delle collezioni del Natural History Museum di Londra. Il volume appartenuto a Commelin fu invece studiato dal botanico olandese Johannes Burman per il suo Thesaurus Zeylanicus.  Deliziose (e misconoscite) Hermanniae Hermann era stimatissimo dai botanici della generazione immediatamente successiva: Boerhaave lo definì «incomparabile per la conoscenza delle piante», Johannes Burman lo chiamò «sommo lume dell’Università di Leida». Quanto a Linneo, che premise a Flora Zeylanica una biografia di Hermann così elogiativa da sconfinare nella agiografia, lo salutò «principe dei botanici», un titolo che di solito riservava a se stesso, e scrisse: «Non c’era al mondo un botanico pari a Hermann per i meriti e le scoperte» . Grande stima ne aveva anche Tournefort che gli dedicò il genere Hermannia , sulla base dell’unica specie allora nota (nome attuale Hermannia hyssopifolia), una delle acquisizioni sudafricane di Hermann; il genere fu poi fatto proprio da Linneo . Hermannia L. della famiglia Malvaceae è un grande genere soprattutto sudafricano, dunque perfetto per celebrare il primo esploratore della flora del Capo. A parte una specie australiana e pochissime specie distribuite tra Messico e zone adiacenti degli Stati Uniti, buona parte delle circa 160 specie sono africane, 81 delle quali endemiche del Sud Africa, soprattutto delle province del Capo occidentale e settentrionale. Il genere è molto vario, e si è adattato a un’altrettanto grande varietà di ambienti. Sono piante erbacee o piccoli arbusti, spesso striscianti. Le specie che vivono nel veld tendono a lignificare alla base e a formare un fusto legnoso sotterraneo, in grado di superare i periodi di siccità o anche gli incendi. Anche se sono poco utilizzate nei giardini, molte specie sono assai decorative grazie alle masse di fiori penduli a campana, spesso in delicati colori pastello. Ne troverete una piccola selezione nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed