|
In un articolo pubblicato qualche anno fa, Paolo Pejrone ha definito Beaumontia grandiflora "una dominatrice come la Lady che per prima la coltivò". Il riferimento è a Diana Wentworth Beaumont che, anche se si atteggiava a gran dama, non era affatto una lady; anche il fatto che fosse una dominatrice non è per nulla certo. Vicini malevoli ce ne hanno consegnato un ritratto caricaturale che forse è solo il frutto di risentimenti e pregiudizi sociali; anche se il personaggio era indubbiamente sopra le righe, le testimonianze di Loudon, Wallich e del giardiniere Marnock vanno in senso totalmente diverso. Certo amava la grandiosità e l'ostentazione, e lo dimostra anche la sua maggiore realizzazione come "donna di piante": la spettacolare serra tropicale a cupola, la più grande del suo tempo. Poco dopo la sua morte fu smantellata e la conosciamo solo da qualche disegno.  Una discutibile leggenda nera Oggi è quasi dimenticato, ma al momento della sua uscita nel 1826 il romanzo satirico Almack's ebbe un certo successo. Prendeva infatti di mira una delle istituzioni dell'età della reggenza, Almack’s Assembly Rooms, che fu uno dei primissimi club ad ammettere sia uomini sia donne e divenne uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi ed esclusivi della capitale, con i suoi balli del mercoledì cui si poteva accedere solo dietro invito, a insindacabile giudizio delle patronesse, un gruppo di dame dell'alta società. Tra i personaggi figura una certa Lady Birmingham, descritta come una donna di bassa nascita, volgare e piena di pretese, che ostenta le sue ricchzze e i suoi diamanti. E' orgogliosisima del suo giardino; in una scena, a proposito delle piante americane della sua residenza di campagna, si vanta così: "Lee e Kennedy mi hanno detto che ho la collezione più bella dell'intero regno. Sono sicura che ben poche persone ne hanno così tante come me [...]. Al momento sono impegnatissima con gli arbusti, sto ampliando i miei impianti americani e sto creando un nuovo roseto; ne ho 180 nuove varietà". Dietro questo ritratto velenoso, i contemporanei riconoscevano facilmente una persona reale: Diana Wentworth Beaumont (1765–1831). Il romanzo fu pubblicato anonimo, ma era ben noto che l'autrice era Marianne Spencer-Stanhope Hudson. Gli Spencer-Stanhope erano vicini di casa dei Wentworth nello Yorkshire e, mentre i membri la vecchia generazione, rappresentata da sir Thomas Wentworth (1726-1792) di Bretton Hall e John Spencer di Cannon Hall, erano grandi amici, i giovani Spencer-Stanhope non perdevano occasione per prendere in giro la figlia maggiore ed erede Diana e le sue arie da gran dama e tra di loro la chiamavano sarcasticamente Madame Beaumont. Un'altra delle Spencer-Stanhope, Mrs Pickering, nata Anna Maria Wilhelmia Spencer-Stanhope, nelle sue memorie descrisse la giovane Diana come una serva di cucina che vendeva le uova al mercato di Pensitone; bambina al momento della morte di lei, doveva aver raccolto questa diceria dalla bocca di qualcuno dei suoi parenti. Si trattava certamente di una grossolana calunnia, che però in qualche modo rifletteva la nascita irregolare di Diana Wentworth. Suo padre, sir Thomas Wentworth, era stato uno scapolo impenitente e libertino che aveva sempre rifiutato di sposarsi, benché avesse avuto numerosi figli illegittimi da varie amanti. Un figlio e tre figlie, nate tra il 1765 e i 1775, di cui Diana era la maggiore, vennero riconosciuti e le ragazze, anziché servire in cucina, ebbero un'ottima educazione in collegi femminili. Sorprendentemente, nel suo ultimo testamento, scritto poche settimane prima della morte, sir Thomas, tranne un piccolo lascito e una rendita annuale, diseredò il maschio, lasciò cospicui lasciti alle figlie minori e le terre e il grosso del patrimonio a Diana. Non conosciamo il motivo di questa decisione controcorrente; Karen Lynch ipotizza che non ci fossero migliori mani di quelle di lei cui affidare l'amatissimo Bretton Hall; in effetti, una clausola del testamento stabiliva che la casa doveva continuare ad essere abitata dalla famiglia e che essa e i giardini dovevano essere mantenuti in perfetto ordine. Sir Thomas è stato descritto come un personaggio eccentrico i cui unici interessi dichiarati erano la caccia, i cavalli, le bevute, le donne e la tenuta di Bretton Hall; erede per parte materna della famiglia Blackett, proprietaria di miniere di carbone e piombo presso Durham, aveva investito grosse somme per rimodellare il parco. Inizialmente si affidò all'architetto Richard Woods, che creò un lago artificiale interrompendo il corso del fiume Dearne con una diga. Dopo il crollo della diga in seguito a una piena, preferì fare da solo "senza ricorrre a Capability [Brown] o a simili pretenziosi bricconi"; qualche anno dopo, volle un secondo lago "grande abbastanza per Giona e la sua balena". Nel parco, percorso da piacevoli viali, fece piantare molti alberi e creò diversi edifici di gusto gotico; uno degli isolotti ospitava addirittura un piccolo zoo. Diana condivideva con il padre l'amore per le piante e la natura, e probabilmente ne aveva ereditato anche l'eccentricità, la testardaggine e il gusto per l'eccesso. Nel 1786, a circa 20 anni, sposò un proprietario terriero dello Yorkshire di modesta fortuna, Thomas Richard Beaumont; nel 1792, dopo la morte di sir Thomas, la coppia fece di Bretton Hall la sua residenza principale, anche se soggiornava spesso anche a Hexam Abbey e in altre proprietà e durante la stagione mondana viveva a Londra. Grazie alle proprietà ereditate dal padre nello Yorkshire e nel Northumberland, Diana Wentworth Beaumont era già molto ricca; intelligente e dotata di un grande senso degli affari, durante la sua gestione raddoppiò il patrimonio, tanto che al momento della morte era considerata la commoner più ricca del paese. Il marito, che i contemporanei descrivono come una "testa debole" succube della moglie, forse era semplicemente abbastanza intelligente da delegare l'amministrazione a Diana, molto più abile di lui, che per altro spesso era lontano da casa come militare; tra il 1794 e il 1803 fu infatti colonnello di un reggimento di cavalleria. Thomas Richard intraprese anche una carriera politica; fu deputato per il Northumberland ininterrottamente dal 1795 al 1818. Era schierato con i Tory e con il governo e in questo lungo periodo non è noto che abbia preso la parola nemmeno una volta. La sua massima aspirazione - sicuramente condivisa dalla moglie - era ottenere un titolo nobiliare; corteggiava regolarmente il primo ministro di turno nella speranza di una baronia, ma nessun ministro gliela concesse mai, sicuro di avere comunque il suo voto. Il titolo non c'era, ma tanto nelle tenute di campagna quanto a Londra, i Beaumont vivevano in modo assai sfarzoso, secondo lo stile degli aristocratici; ma poiché non lo erano, suscitavano il riso di quella società intrisa di pregiudizi sociali. Gli Spencer-Stanhope si sbellicavano quando vedevano "Madame Beaumont" attraversare il villaggio con una carrozza trainata da due pariglie di cavalli neri e guidata da postiglioni in livrea di velluto; Lady Aynsley arricciva il naso ascoltandola vantare le rendite delle sue miniere di piombo. Certamente Diana era una donna imperiosa, tenace nel perseguire i suoi obiettivi, che aveva fama di litigare con tutti, compreso il figlio maggiore. Eppure, se ascoltiamo altre campane. il ritratto muta colore: non più una "dominatrice" soffocante, come l'ha definita anche Paolo Peirone, ma un'amministratrice puntuale, precisa e attenta ai bisogni e alla dignità dei suoi dipendenti. L'architetto paesaggista John Claudius Loudon. che visitò più volte Bretton Hall, ha scritto di lei: "Nessuna signora è stata una padrona più liberale e sollecita verso i suoi dipendenti, né una migliore proprietaria terriera rispetto ai suoi affittuari"; il ritratto tracciato dal capo giardiniere Robert Marnock - scritto vari anni dopo la morte di lei e quindi senza alcuna piaggeria interessata - è addirittura un peana: "Mrs Beaumont per la sua consuetudine con gli affari e l'ordine possedeva una mente dal potere gigantesco. Quando lavoravo come giardinere, mi dava spesso appuntamento presso un determinato albero, a un'ora e un minuto specifico e, sebbene questi appuntamenti fossero frequenti e a volte fissati una settimana o dieci giorni in anticipio, non ricordo una singola occasione in cui abbia mancato di presentarsi all'esatto minuto fissato; la sua puntualità e precisione non erano riservati alla sistemazione del giardino ma emergevano nella sua condotta nell'intera tenuta. Era un esempio ammirevole per i domestici, che dovrebbe essere seguito da padrone e padroni dei nostri giorni. Non si permise mai di entrare nell'orto durante l'orario di lavoro senza aver prima suonato la campana del giardino [...]. Proprio perché era così scrupolosa ed esatta nel disbrigo dei suoi affari, riusciva a trovare il tempo di dedicarsi al giardino e alla botanica, e all'occasione patrocinare meriti altrimenti senza sostegno". 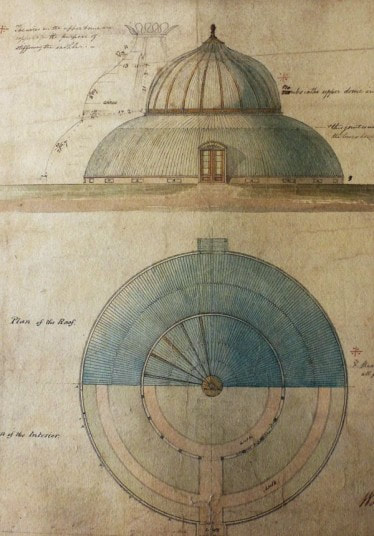 Un giardino senza rivali E' ora dunque di parlare di Mrs Beaumont come giardiniera e collezionista. La sua passione si esercitò soprattutto nel giardino di Bretton Hall che ereditò dal padre nel 1792 e continuò ad abbellire con interventi costanti per quarant'anni. Questi lavori, che non sembrano obbedire a un progetto coerente, ma piuttosto alle necessità e all'estro del momento, furono affidati di volta in volta ad architetti sempre diversi (che Diana litigasse con tutti non era forse così infondato). Il primo fu John Carr che già nel 1793 fu incaricato di ristrutturare la sala da pranzo e la biblioteca; nel 1803 un certo Mr Mickle disegnò le ringhiere del parco; nel 1804 un altro noto architetto, Willian Atkinson, disegnò un'aranciera, un museo per le collezioni naturalistiche, una latteria e l'Archway Lodge, una sorta di ingresso monumentale fiancheggiato da colonne con un arco abbastanza ampio da consetire l'ingresso di una carrozza. Fu poi la volta di William Lindley, cui si devono nuove cucine, la scuderia e una grotta con conchiglie; nel 1811 Jeffry Wyatt disegnò una voliera, alcuni cottage e la serra delle camelie che è uno dei pochi manufatti dell'epoca di Diana oggi conservato. Destinata ad ospitare la collezione di piante semirutiche provenienti dall'Asia, è un luminoso edifico in pietra ma con grandi finestre ad arco e un tetto in vetro e ghisa. I Beaumont ricevevano spesso (Mary Russell Mitford che fu loro ospite nel 1806 ricorda che ai loro pranzi partecipavano trenta o quaranta persone); si prestava dunque grande attenzione all'orto e al frutteto che dovevano provvedere una quantità sufficiente di verdure e frutti per la tavola della famiglia, del personale e degli ospiti. Fino al 1825 a occuparsene fu Christie Duff, rinomato per la coltivazione dei mirtilli rossi, del crescione, dei peschi a spalliera e la moltiplicazione dei rizomi di zenzero. Quando questi si licenziò, venne assunto come "caposquadra dell'orto" il già citato Robert Marnock (1800-1889) che quattro anni dopo sarebbe stato promosso capo giardiniere. I suoi ricordi, scritti una ventina di anni dopo, quando Marnock dirigeva l'orto botanico di Sheffield ed era una delle figure di punta del movimento Gardenesque, fanno rivivere i giardini di Bretton Hall negli anni d'oro: "Circa vent'anni fa, quando lo vidi la prima volta. Bretton Hall non aveva rivali per i suoi giardini, tanto per l'estensione quanto per la varietà. La forzatura di uva, ananas, pesche, fichi ecc. era praticata estesamente; c'era anche un'estesa collezione di piante da serra fredda e calda, un assortimento di piante erbacee rustiche che occupavano un'area circolare di non meno di tre acri, con le piante sistemate secondo il sistema di Linneo. Oltre a tutto questo, c'era un orto murato di sei o otto acri per la coltivazione delle verdure e la produzione di frutti rustici. All'epoca alla quale mi riferisco, c'erano sei grandi serre per la forzatura di pesche e nettarine; due vigne protette; una serra per i fichi; nove serre riscaldate per gli ananas con innumerevoli buche; due grandi aranciere e altrettante serre riscaldate. Infine un'immensa serra eretta dai Bailey di Holborn con una spesa 8.000 o 10.000 £, riscaldata con un complicato e costoso apparecchio a vapore". Siamo così arrivati alla celebre serra di Bretton Hall. Iniziata nel 1826, ma non completata fino al 1829 - non senza una causa legale che contrappose i coniugi Beaumont alla ditta londinese Bailey - era un edificio avveniristico, interamente costruito in vetro e ghisa; circolare, con un diametro di circa 18 metri, aveva un'alta volta a cupola, che raggiungeva l'altezza massima di circa 14 metri. Poco dopo il completamento della serra, il colonnello morì e la moglie lo seguì poco più di due anni dopo, nell'agosto del 1831. Il figlio ed erede, Thomas Wentworth Beaumont, in rotta con la madre che, dopo la sua maggiore età, aveva rifiutato di anticipargli l'eredità e aveva mantenuto il pieno controllo dei propri beni, non partecipò al funerale e si afffrettò a vendere all'asta tutto ciò che le ricordava la madre, di cui (lui educato a Eton e Cambridge) disapprovava gli eccessi. Almeno, questa è la versione che circolò. Forse, più prosaicamente, benché divenuto a sua volta il commoner più ricco del regno, aveva bisogno di liquidità per saldare i fornitori e i debiti in sospeso, e soprattutto per versare i cospicui lasciti testamentari che la madre aveva diposto per i figli e le figlie minori, dimostrando ancora una volta la sua indipendenza di pensiero. Tra i beni alienati, anche la serra circolare che fu svenduta a un fabbricante di birra, più interessato al sistema di riscaldamento che all'edificio in sè, che fu totalmente smantellato. Ne rimane solo qualche disegno.  Un'amicizia botanica e uno scambio intercontinentale Sia Marnock sia Loudon lamentarono che i vari interventi nel parco di Bretton Hall si erano succeduti senza un disegno unificante; in effetti, più che al parco in sè, Mrs Beaumont era interessata alla sua collezione di piante rare, per la quale aveva fatto costruire successivamente la grande aranciera vetrata e la serra circolare. Al contrario del suo doppio letterario, lady Birmingham, non raccoglieva piante americane, ma soprattutto asiatiche che le furono spedite con una certa frequenza da Nathaniel Wallich a partire dal 1815. Mrs Beaumont era interessata alle scienze naturali (abbiamo visto che aveva allestito un piccolo museo, con una collezione soprattutto di minerali, e che in una parte del suo giardino le piante erano sistemate in modo sistematico, come in un orto botanico); era abbonata alle Transactions della Linnean Society alla quale inviava regolarmente esemplari delle sue piante più rare. In tal modo era entrata in contatto con Smith, Lambert e Banks. Permetteva anche agli artisti botanici di frequentare il suo giardino per ritrarre le piante dal vivo. In tal modo si era fatta una certa fama di protettrice della botanica. Nathaniel Wallich che - ricordiamolo - era suddito danese e per questa ragione era stato anche imprigionato come cittadino di una potenza ostile - nel 1815 era entrato al servizio della Compagnia delle Indie e cercava un patrono influente. Ovviamente aveva pensato a Banks e si era messo in contatto con lui attraverso Thomas Hardwicke, suo amico e membro dell'Asiatic Society. Hardwicke gli suggerì di rivolgersi anche a Mrs Beaumont che, come moglie di un membro della Camera dei Comuni e proprietaria di estesi giardini, avrebbe potuto a sua volte offrire una via d'accesso a Banks, Lambert e i vertici della Compagnia delle Indie. Così Wallich nel dicembre 1815 le scrisse e le spedì piante vive e semi. Fu l'inizio di uno scambio botanico nelle due direzioni; confermandosi una donna concreta, sollecita e cortese, Diana non si accontentò di ringraziare ma ricambiò il dono, scrivendo: "Quest'autunno chiederò al mio giardiniere di raccogliere tutti i semi che egli riterrà accettabili per voi, per l'orto botanico di Calcutta; ne ho parlato ai direttori della Compagnia, chiedendo che vi vengano spediti. Ciò mi ha dato l'opportunità di menzionare i vostri propositi e di sostenerli con le mie più forti raccomandazioni, come ho fatto con sir Joseph Banks e Mr Lambert, e ho ogni ragione di sperare che se ne cureranno". Da quel momento Mrs Beaumont per Wallich divenne un punto di riferimento, una protettrice e un'amica. Dello scambio si arricchirono tanto Bretton Hall quanto l'orto botanico di Calcutta - anche se non sappiamo di quali piante; l'unico campione dell'erbario di Wallich indicato come "Beaumont" e proveniente da Bretton Hall è la leguminosa Senna multijuga, nativa del Messico e dell'America subtropicale. Wallich provvide Bretton Hall di molte piante raccolte in varie parti dell'India e in Nepal, e proprio per accoglierle al meglio Mrs Beaumont fece costruire la grande serra a cupola. Tra le piante introdotte da Mrs Beaumont attraverso Wallich e coltivate per la prima volta a Bretton Hall, possiamo citare Wallichia caryotoides, Callianthe striata, Garcinia dulcis, Clerodendrum nutans, Hovwa pannosa, Tupistra nutans, Tetracera sarmentosa. Senza dimenticare Beaumontia grandiflora, su cui torneremo tra poco, e lo splendido Rhododendron arboreum, di cui Mrs Beaumont aveva trasmesso i semi al vivaio di piante esotiche di Joseph Knight. In effetti, Diana fu utile a Wallich anche mettendolo in contatto con vivai che potevano essere interessati a commercializzare le sue piante. Nel 1829, qundo venne in Inghilterra, visitò Mrs Beaumont a Bretton Hall e visitò con lei proprio il vivaio di Knight. Eccoci dunque giunti a Beaumontia, il piccolo genere di rampicanti dell'Asia tropicale dedicato alla amica e protettrice nel 1824 con questa motivazione: "L'ho nominato in onore della Sig.a Diana Beaumont, devotissima all'orticoltura e alla scienza botanica in Inghilterra e munifica fautrice di entrambe, alla cui benevolenza il giardino di Calcutta deve molte piante esotiche soprattutto europee". Beaumontia (famiglia Apocynaceae) comprende otto-dieci specie di rampicanti e liane nativi della Cina, del subcontinente indiano e del sudest asiatico. La specie più coltivata è B. grandiflora, un vigoroso rampicante sempreverde (anche se può perdere le foglie nella stagione secca) che produce un lussureggiante fogliame verde lucido e profumatissimi fiori bianchi campanulati raccolti in infiorescenze terminali. Resistendo per brevi periodi a temperature prossime allo 0, può essere coltivata anche in parte del nostro paese, in pieno sole e in posizione protetta, ma senza dimenticare che può raggiungere dimensioni ragguardevoli e richiede un supporto robusto.
0 Comments
Nella prima metà dell'Ottocento, il numero di piante esotiche coltivate in Europa cresce esponenzialmente. Orti botanici, grandi vivai, istituzioni scientifiche sono in prima fila per inviare alla loro ricerca cacciatori di piante; ma ci sono anche raccoglitori indipendenti desiderosi di piazzare le loro scoperte (siano semi o esemplari d'erbario) ad un prezzo accettabile. A mettere in contatto raccoglitori e potenziali acquirenti - siano essi privati o istituzioni - e a mediare tra le loro esigenze si inserisce una nuova figura professionale: l'agente botanico. A rappresentarla nel modo migliore, stando alle testimonianze, dovette essere l'eccellente John Hunneman, dedicatario del genere Hunnemannia.  Come un libraio inventò un nuovo mestiere Nel 1827, una settimana prima di Natale, Johann Heinrich Friedrich Link, direttore dell'orto botanico di Berlino, scrive al suo omologo di Kew, William Jackson Hooker, per informarlo che, avendo saputo che era alla ricerca di semi di Nelumbo speciosum [oggi N. nucifera, il loto], ha raccolto per lui tutti quelli disponibili e glieli ha inviati, insieme a semi di Euryale ferox e alcuni altri che coltiva nel suo giardino, tramite Mr John Hunneman, 9 Queen Street, Soho Square, Londra. La cortese lettera di Link, oggi conservata nell'archivio dei Kew Gardens, è solo una delle numerose testimonianze della preziosa attività di mediazione svolta dal libraio e agente botanico John Hunneman (ca. 1760-1839) . Anche se oggi non conosciamo molto della sua vita personale, il nome di Hunneman (scritto anche Hunnemann e talvolta Hunneyman) era ben noto negli ambienti botanici della prima metà dell'Ottocento, e ricorre frequentemente nella corrispondenza e nelle riviste dell'epoca. Anche se era presumibilmente nato a Londra, come si può dedurre dal cognome era di origine tedesca, forse parente del pittore Christopher William Hunneman, che negli ultimi anni del Settecento viveva a Soho Square dove, come si legge nella lettera di Link, si trovava anche la libreria di John Hunneman. Il negozio era specializzato in testi di botanica, soprattutto importati dal continente, ma Hunneman aveva anche clienti all'estero cui procurava libri e riviste inglesi. Era particolarmente abile a trovare per gli uni e gli altri testi rari. In tal modo egli venne a trovarsi al centro di una rete di scambi tra botanici britannici e continentali; godeva di fama di grande affidabilità e a un certo punto oltre ai libri incominciò a trattare stampe botaniche, esemplari d'erbario e parcelle di piante vive. Almeno dal 1816 organizzò diversi ingenti trasporti di piante - in gran parte provenienti dai vivai Loddiges o in subordine da vivai tedeschi - per il parco e le serre di Eisenstadt come "agente botanico e orticolo" del principe Esterházy. Dai documenti conservati nell'archivio del genero William Pamplin, che fu suo stretto collaboratore e alla sua morte ne proseguì l'attività, a partire dal 1817 risultano pagamenti da parte di Christoff Friedrich Otto, ispettore dell'orto botanico di Berlino, per invii di piante e semi provenienti da vari vivai inglesi. Ma almeno dagli anni '20 il ruolo più tipico di Hunneman fu quello di "agente botanico" che metteva i raccoglitori di piante indipendenti in contatto con i possibili acquirenti, curandosi degli invii e dei trasporti e del rispetto dei contratti e dei pagamenti. Come tale figura in un'inserzione pubblicata nel 1829 su The Gardener's magazine in cui si comunica che un certo Mr. Fanning "proprietario dell'orto botanico di Caracas" ha portato con sé varie piante "molte delle quali nuove per questo paese"; entro poche settimane sarebbe rientrato a Caracas, ma "nel frattempo, sarebbe stato felice di entrare in corrispondenza con i naturalisti interessati. Il suo agente è Mr. Hunneman di Queen Street, Soho". Sappiamo che almeno alcuni di quegli esemplari furono acquistati da Lambert, nel cui erbario si trovano ancora. Tra i botanici-raccoglitori, il suo cliente più celebre è senza dubbio Nathaniel Wallich, che, tra la fine degli anni '20 e gli anni '30, grazie alla sua mediazione riuscì a vendere esemplari d'erbario agli orti botanici di Berlino, Liverpool, Londra ed Edimburgo, nonché a collezionisti privati. Probabilmente era entrato in contatto con lui attraverso William Jackson Hooker, quando questi era ancora professore a Glasgow. Infatti in The American journal of science and arts del 1820 leggiamo l'annuncio della prossima pubblicazione di due volumi in folio dedicati alle felci dell'India orientale, curati da Hooker e basati su raccolte di Wallich e Wight; a ricevere le sottoscrizioni dall'estero sarà "John Hunneman, Esq., No. 9 Queen street, London". Il volume non uscì mai e non sappiamo se Hunneman era stato coinvolto anche come potenziale editore; come tale figura invece nel frontespizio del secondo e del terzo volume di The genera and species of orchidaceous plants di John Lindley. Insomma, seppe rendersi indispensabile in vari modi ai botanici al di qua e al di là della Manica, come è evidente dal necrologio pubblicato dopo la sua morte nel 1839 sulla rivista della Botanical society: "Dobbiamo lamentare [...] la morte del nostro eccellente socio Mr John Hunneman. Non potrebbe esistere persona che più volentieri si prendesse ogni genere e grado di disturbo per compiacere i suoi amici e per stabilire utili scambi tra i botanici europei; [...] la sua perdita sarà un grave ostacolo alla libera comunicazione che da molti anni esiste tra loro. Era conosciuto da tutti, amato da tutti, e quella reciprocità di gentilezza che aveva il diritto di aspettarsi la rivolgeva spontaneamente a ogni botanico che desiderava introdurre nella confraternita scientifica che aveva fondato e che desiderava allargare".  Papaveri d'oro dal Messico La medesima stima, riconoscenza ed ammirazione era stata espressa qualche anno prima (1828) da Robert Sweet nel terzo volume di The British flower garden nel dedicare al libraio e agente botanico il genere Hunnemannia: "Lo abbiamo nominato in onore del nostro amico Mr John Hunnemann, il quale, attraverso i suoi numerosi corrispondenti in vari paesi, è stato strumentale all'introduzione nelle nostre collezioni di un numero di piante maggiore di ogni altro individuo, tanto che siamo un po' sorpresi che nessun genere gli sia stato dedicato in precedenza". Per creare il nuovo genere, Sweet si basò su una pianta di cui aveva ricevuto i semi da Robert Barclay, un ricco birraio e proprietario di un raffinato giardino, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal Messico. Si tratta di Hunnemannia fumariifolia, una della due specie di questo genere della famiglia Papaveraceae; a lungo è stata l'unica nota. Affine a Eschscholzia, è un papavero piuttosto alto con grandi fiori dorati a coppa e foglie glauche finemente divise, endemico degli altipiani del Messico (deserto di Chihuahua e Sierra madre orientale) tra 1500 e 2000 metri di altitudine. Relativamente rustico, è una perenne di breve vita solitamente coltivata come annuale. La seconda specie, Hunnemannia hintoniorum, fu scoperta e pubblicata solo nel 1992. Endemica del Nuevo León, differisce dalla precedente perché più bassa, scaposa, con fusti non ramificati e foglie più strette e limitate alla rosetta basale. Nelle riviste inglesi a cavallo tra Settecento e Ottocento, ci si imbatte continuamente nel nome del ricchissimo mercante George Hibbert che nel suo giardino di Clapham possedeva una collezione di piante rare seconda solo a quella dei Kew Gardens; anzi la prima al mondo per le Proteaceae, le sue piante preferite. Nulla di strano che l'editore di una di quelle riviste, che era anche un pittore ed approfittò largamente di quelle raccolte per i suoi libri, lo abbia ringraziato con la dedica di una delle piante che fioriva nel suo giardino. Il problema è che il grazioso genere Hibbertia onora una persona che, dal punto di vista attuale, non merita di essere onorata: come collezionista e promotore dell'introduzione di nuove piante Hibbert fece molto per la botanica, è innegabile; tuttavia egli non solo doveva la sua ingentissima ricchezza allo schiavismo (in questo sarebbe in larga compagnia, a cominciare dai presidenti americani Washington e Jefferson) ma fu probabilmente il nome più in vista della lobby di mercanti, trafficanti e piantatori che cercò di bloccare l'approvazione della legge che mise fine alla tratta degli schiavi in Inghilterra; e alla fine fu anche profumatamente pagato per averlo fatto. Secondo alcuni botanici, la botanica non può lavarsene le mani; secondo altri, mettere in discussione un nome per ragioni che prescindono le regole botaniche apre un vaso di Pandora che fa crollare i principi cardini del Codice internazionale di nomenclatura. Il dibattito è aperto. 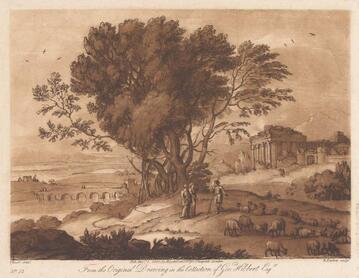 Il volto oscuro: lo schiavista Uno dei nomi che ricorrono con maggiore frequenza nelle pagine di The botanist's repository e del Curtis's botanical magazine nel ventebnnio tra il 1795 e il 1815 è quello di George Hibbert (1757-1837), nel cui giardino di Clapham fiorirono per la prima volta e furono disegnate molte delle novità presentate in quelle riviste. La sua collezione di piante rare provenienti da tutto il mondo rivaleggiava con quella dei Kew Gardens, ed era particolarmente ricca di specie del Capo, dove, come vedremo più avanti, operò per vari anni come cacciatore di piante uno dei suoi giardinieri, James Niven. Hibbert non era un mero collezionista di piante: era considerato un botanico più che dilettante, parlava fluentemente cinque lingue e ne capiva altre due, era un bibliofilo compulsivo e un po' megalomane che non badava a spese per acquisire libri rari, inclusa una copia della Bibbia di Gutenberg. Era membro di molti club e di società scientifiche, inclusa la Royal Society. Nel necrologio pubblicato sulla rivista della Linnean Society, James Main l'ha descritto come una persona che "ispirava fiducia e rispetto per il buon senso, la capacità di giudizio e la sagacia". Eppure questo stimato collezionista e botanofilo non solo doveva tutta la sua ricchezza al lavoro degli schiavi, ma fu anche il leader e il portavoce della lobby di mercanti e piantatori delle Antille britanniche che si oppose con tutte le forze all'abolizione della schiavitù. La famiglia Hibbert era coinvolta da lunga data nel commercio triangolare: il cotonificio del nonno e del padre, due agiati drappieri di Manchester, forniva cotonine e altre forniture ai trafficanti di schiavi; ma il vero salto di qualità si ebbe con lo zio Thomas, che si trasferì in Giamaica per recuperare le obbligazioni di alcuni trafficanti e in vent'anni divenne uno dei più ricchi piantatori dell'isola (possedeva tre estese piantagioni con oltre 900 schiavi); si fece costruire la più bella casa di Kingston, Hibbert House, oggi sede del National Trust della Giamaica. Grazie al successo e ai contatti di Thomas, gli Hibbert rimasti in Inghilterra, da drappieri e fornitori, si trasformarono in mercanti e armatori, specializzati nel commercio con la Giamaica. Nel 1770, un altro Thomas Hibbert, il fratello maggiore di George, si trasferì a Londra e insieme a due altri mercanti, John Purrier e Thomas Horton, fondò la ditta di import-export e trasporti navali Hibbert, Purrier & Horton che importava prodotti coloniali e forniva merci (e prestiti) a piantatori e trafficanti. George si unì alla ditta di famiglia come socio giovane nel 1780 (all'epoca aveva ventitré anni) con un capitale di 1500 £, cui se ne aggiunsero altre 1000 alla morte del padre nel 1784. Meno di dieci anni dopo, era diventato il capo della ditta (ora, con l'ingresso di altri soci si chiamava Hibbert, Fuhr & Hibbert) e un membro eminente della lobby che difendeva gli interessi dei piantatori e dei mercanti delle Indie occidentali, la London Society of West India Planters and Merchants. Nel 1790, nella sua testimonianza davanti alla commissione d'inchiesta sulla tratta degli schiavi, dichiarò di aver importato annualmente merci per un valore compreso tra 200.000 e 250.000 £ e di aver investito molti capitali in Giamaica sotto forma di prestiti ai piantatori. Almeno dal 1793, George Hibbert fu coinvolto in un progetto che stava molto a cuore ai lui e agli altri West Indiamen: la costruzione di una darsena riservata alle loro navi; infine autorizzata nel 1799 dal West India Dock Act, la darsena, collocata sull'Isola dei cani, fu inaugurata nel 1802; l'ingresso principale, posto all'estremità occidentale, presto noto come Hibbert Gate, era largo abbastanza da consentire l'ingresso di carri e vagoni, chiuso da una duplice cancellata di ferro e sormontato da una scultura che riproduceva una delle navi di George e soci, chiamata Hibberts. George Hibbert fu il primo presidente della West India Docks Company e negli anni successivi rivesti ripetutamente questo ruolo. Purtroppo, egli non doveva il suo largo seguito tra i West Indiamen solo alle abilità commerciali (la Hibbert, Fuhr & Hibbert era la prima per giro d'affari con la Giamaica) e alla grinta con cui difendeva i loro interessi: era anche il portavoce degli antiabolizionisti, e seppe muoversi con grande abilità manipolatoria e notevoli capacità dialettiche. Già nel 1790, quando era stato ascoltato dalla commissione parlamentare, aveva evidenziato che l'intera economia delle Antille britanniche - ma anche gran parte dell'industria manifatturiera della stessa Inghilterra - dipendeva dalla schiavitù; se questa fosse stata abolita, si andava incontro alla rovina, e migliaia di famiglie sarebbero state ridotte sul lastrico. Nel maggio 1789, una settimana dopo che Wilberforce ebbe pronunciato in Parlamento il suo celebre discorso abolizionista, i mercanti convocarono una riunione alla London City Tavern; Hibbert vi intervenne con un discorso di 40 minuti intitolato "L'indispensabilità della tratta degli schiavi" in cui cercò di demolire tutti gli argomenti di Wilberforce. L'anno dopo fu di nuovo ascoltato in Parlamento: per lui non era una questione morale, ma economica; la posizione degli abolizionisti era astratta (oggi si direbbe buonista o radical chic), andava contro i diritti e i privilegi acquisiti fin dai tempi di Elisabetta I, quindi la Common Law e il diritto consuetudinario; la schiavitù per altro non era neppure condannata dalla Bibbia, dove gli uomini erano considerati merci come tutte le altre. Proprio per difendere gli interessi dei West Indiamen (ovvero i suoi e dei suoi compari) si gettò anche in politica; già consigliere (alderman) della città di Londra dal 1798, nel 1802 si presentò come deputato per la City, ma non fu eletto; ebbe successo invece nel 1806, quando fu eletto senza opposizione nel collegio di Seaford (uno dei "borghi putridi" controllato dalla lobby dei mercanti delle Indie occidentali); nel suo primo discorso, nel febbraio 1807, dichiarò la sua assoluta ostilità all'abolizione della tratta e durante la discussione che avrebbe portato all'approvazione dello Slave Trade Act, intervenne in ogni passaggio cercando di bloccare la legge. Non ci riuscì, ma ottenne probabilmente ciò a cui mirava fin dall'inizio: l'approvazione di una mozione che garantiva il risarcimento ai piantatori e ai mercanti che traevano le loro ricchezze dalla schiavitù. La compensazione costò alla stato 20 milioni di sterline; Nick Hibbert Steel nel suo saggio sulla famiglia Hibbert l'ha chiamato il "prezzo dello zucchero". E' stato calcolato che agli Hibbert ne andarono 103.000 e allo stesso George Hibbert 16.000. Nel 1812 Hibbert fu nominato agente generale per la Giamaica, una posizione che mantenne fino al 1831, anche se già nel 1829 si ritirò a vita privata; nel 1824, aveva anche avuto modo di illustrarsi e come filantropo, in quanto membro fondatore e finanziatore di una società di soccorso navale, National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, precorritrice della Royal National Lifeboat Institution che ancora oggi nel proprio sito lo ricorda come benemerito fondatore.  Il volto luminoso: il collezionista Negli stessi anni in cui si metteva in luce in questo modo ai nostri occhi abominevole (ma non a quello di molti suoi contemporanei: nel 1812, quando si ritirò dal Parlamento, il leader dei whigs George Tierney lo nominò tra coloro "i cui servizi sarebbero stati rimpianti dalla nazione"), George Hibbert acquisiva grande rinomanza come collezionista di libri e proprietario di uno dei giardini più raffinati del paese. Come sostiene Katie Donington nel suo importante saggio dedicato alla famiglia Hibbert, The Bonds of Family, tra le due cose non c'è alcuna contraddizione: nel momento in cui una parte crescente dell'opinione pubblica incominciava a prendere le distanze dallo schiavismo, su cui si basava la sua ricchezza, il collezionismo era un modo per rendersi socialmente accettabile. Infatti Hibbert divenne un membro riconosciuto della comunità scientifica: nel 1805 lo troviamo tra i fondatori della London Institution, che anticipò l'Università di Londra nel rendere disponibile l'educazione scientifica ai dissidenti religiosi, esclusi dai college di Oxford e Cambridge; già membro della Linnean Society e della Antiquarian Society, nel 1811 fu ammesso alla Royal Society; nel 1816 entrò a far parte del Roxburghe Club, la più antica società di bibliofili del mondo. Non conosciamo con esattezza quando Hibbert abbia cominciato a collezionare libri e piante; nel 1829, quando si ritirò a vita privata e si trasferì a Munden House, una proprietà che la moglie aveva ereditato da uno zio, fu costretto a vendere la biblioteca; secondo il catalogo d'asta, di ben 8711 pezzi, non pochi dei quali rarissimi, la collezione era stata riunita dal proprietario in più di quarant'anni (dunque a partire dalla fine degli anni '80). Per quanto riguarda le piante, la prima data certa è il 1794: quell'anno Hibbert, che già possedeva una residenza a Portland Place, nel distretto di Marylebone, acquistò una casa e una proprietà chiamata The Hollies sul lato nord di Clapham (curiosamente, il distretto noto per essere stato la sede del movimento abolizionista noto come Clapham Sect o Clapham Saints). Allo stesso anno ci riporta il suo primo acquisto datato: alla fine del 1792 un altro ricco mercante e armatore, Gilbert Slater, legato alla Compagnia delle Indie, proprietario di un notevole giardino in Essex, inviò in Cina a caccia di piante il giardiniere scozzese James Main che fece buona caccia, riportando tra l'altro la famosa rosa Slaters' Crimson China; al suo ritorno nel 1794 però Slaters era deceduto da quasi un anno; le raccolte cinesi furono vendute e acquistate in parte dai Kew Gardens, in parte da Hibbert, che assunse Main come giardiniere (è dunque inesatta la notizia che si legge in Wikipedia inglese che già lavorasse per Hibbert in precedenza e che avesse viaggiato in Cina per conto sia di Hibbert sia di Slaters). Hibbert acquistò piante e semi, ma anche disegni cinesi: è dunque possibile che la passione per le piante sia nata indirettamente da quella per i libri e le opere d'arte. In ogni caso la vera passione di Hibbert divennero le Protee, forse perché erano rare, difficili da coltivare, dunque molto prestigiose. I semi delle prime erano state portate in Inghilterra da Masson tra il 1774 e il 1787; nel 1789 d verse specie furono descritte da Aiton in Hortus kewensis, il catalogo dei giardini reali di Kew che ne possedevano un'esclusiva collezione di 24 specie, diverse delle quali oggi assegnate ad altri generi della famiglia. Hibbert non voleva essere da meno e alla fine del 1798 o all'inizio del 1799 inviò in Sudafrica il giardiniere James Niven a fare raccolte di semi ed esemplari d'erbario; Niven rimase al Capo fino al 1803, quindi vi ritornò nel 1805, questa volta per un consorzio che oltre a Hibbert comprendeva il vivaio Lee e Kennedy (di cui secondo N. H. Steel Hibbert era "socio silente") e l'imperatrice Giuseppina, e vi rimase fino al 1812. Grazie alle sue raccolte, cui sia aggiunsero anche molte australiane, la collezione di Proteaceae di Hibbert divenne la più importante del mondo. Secondo le testimonianze del tempo, ne comprendeva circa 200 diverse specie che erano coltivate in vaso in una grande serra, dove trascorrevano i mesi invernali, per essere portate all'esterno nei mesi più caldi. Hibbert le affidò a un abilissimo giardiniere, Joseph Knight (1778-1855), che in precedenza aveva lavorato per il duca di Bedford; egli fu il primo in Europa a moltiplicarle tanto da talea quanto da seme. Hibbert (al contrario generoso con altre piante) era gelosissimo delle sue protee che scambiava solo con re Giorgio III e l'imperatrice Giuseppina. Nel 1809 Knight svelò i segreti della coltivazione delle preziose piante in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, a dispetto del titolo, riserva solo una dozzina di pagine all'argomento, mentre più di 100 sono dedicate a una revisione tassonomica della famiglia; benché non firmata, fu subito noto che l'autore di quest'ultima era Richard Salisbury. Ne seguì una polemica con Robert Brown e l'accusa di plagio rivolta a Salisbury, come ha raccontato in questo post. Qui ci interessa la prima parte, che documenta le tecniche di coltivazione applicate nel giardino e nella serra di Hibbert; inoltre ci rivela un altro aspetto del contraddittorio personaggio: la generosità. Dopo aver accennato alle raccolte di Thunberg e Masson, Knight infatti scrive "Un numero ancora più grande di specie sia note sia ignote sono poi state raccolte da Mr. James Niven, molte delle quali hanno fiorito a lungo in questo paese, ma da nessuna parte in modo così lussureggiante come nella collezione del mio precedente padrone, l'egregio George Hibbert di Clapham, grazie alla cui liberalità molte di esse sono ora in mio possesso". Dunque Hibbert cedette almeno alcune delle sue esclusivissime Proteaceae al suo capo giardiniere e probabilmente lo aiutò a mettersi in proprio; infatti nel 1808 Knight acquistò un terreno a Chelsea e lo trasformò in vivaio; poiché era affacciato sulla trafficata King Road, presto vi aggiunse un negozio (un antenato di un fornito garden center); inoltre nel 1829, quando si ritirò per andare a vivere in campagna, Hibbert passò a Knight tutte le sue piante vive. Con questa formidabile iniezione di rarità, il vivaio di Knight (più tardi Knight & Perry, quando venne gestito dal marito di una nipote del fondatore) divenne uno dei più importanti del paese, nonché il primo a commercializzare le Proteaceae. Ma nel giardino e nella serra di Clapham si coltivava anche molto altro; per scoprirlo basta sfogliare i fascioli di The Gardener's Repository o del Curtis's Botanical Magazine, dove il nome di Hibbert ricorre con grande frequenza; molte delle novità presentate in queste riviste fiorirono e furono ritratte per la prima volta a Clapham. A dominare sono ovviamente le sudafricane, grazie alle raccolte di Niven; ci sono molte bulbose e una ricca selezione di eriche, diverse delle quali sono presentate in Coloured Engravings of Heaths, l'opera più significativa di Henry Cranke Andrews, il genero di John Kennedy, nonché illustratore e editore di The Botanist's Repository; significativamente "G. Hibbert, Esq., Clapham Common, Surrey" è citato per primo nella lista delle sette persone ringraziate per aver permesso all'artista di ritrarre dal vivo le loro collezioni.  Questa pianta profumerebbe di più con un altro nome? Se le sudafricane dominavano, a Clapham c'erano però anche molte australiane; in effetti, anche se commerciava soprattutto con la Giamaica, Hibbert aveva qualche interesse anche nelle nuove rotte del Pacifico aperte dai viaggi di Cook; come armatore fu sicuramente coinvolto in alcuni dei trasporti interoceanici di piante organizzati da Banks (incluso quello degli alberi del pane, fortemente voluto dei piantatori delle Antille) e nel trasporto dei forzati a Botany Bay. Australiano è anche il genere Hibbertia, che gli fu dedicato da Andrews nel secondo numero di The botanist's repository. La motivazione ci dà un quadro illuminante (e magari un po' adulatorio) della reputazione botanica di Hibbert: "In precedenza è stato erroneamente assegnato al genere Dillenia, ma poiché differisce da ogni genere descritto in precedenza, gli ho dato il nome dell'egregio sig. G. Hibbert di Clapham, Surrey, la cui conoscenza e fervore per le ricerche botaniche, così come la sua liberalità nell'arricchire le nostre collezioni da tutti gli angoli del mondo, ma soprattutto dal Capo di Buona Speranza, non sono superate da nessuno; ne sono certo, nessun nome merita un posto nella memoria della botanica più di quello di Hibbert". E lo stesso Andrews (la cosa non stupisce) dedicò a Hibbert anche un'Erica, appunta E. hibbertia. Hibbertia è un grande genere della famiglia Dilleniaceae, anche se il numero di specie è altamente dibattutoi: si va dalle 150 generalmente assegnatogli nei data base australiani alle 350 riconosciute da Plants of the World on line; il centro di diversità è proprio l'Australia, con oltre 100 specie; altre vivono in Nuova Guinea e nelle isole del Pacifico, una in Madagascar. In inglese sono note sotto il nome comune guinea flower, non per la provenienza ma perché il colore e la forma dei loro fiori ricorderebbero quelli di una ghinea d'oro. La cifra del genere è la varietà. Sono per lo più arbusti eretti, ma c'è anche qualche rampicante, come la specie più nota, H. scandens, o arbusti prostrati che formano tappeti, come H. procumbens. Molto variabili le dimensioni: se molti sono piccoli arbusti non più alti di una decina di centimetri, la già citata H. scandens può superare i 5 metri. Le foglie sono intere, alternate, spesso raggruppate lungo brevi rami laterali, e nelle specie che vivono in zone aride sono ridotte; molto variabili le forme. Ancora più variabile la morfologia dei fiori; possono essere o meno protetti da brattee, hanno cinque sepali, quelli esterni leggermente sovrapposti a quelli interni, e cinque petali che possono essere disposti a simmetria radiale o a simmetria bilaterale; variabile pure il numero degli stami, da sei a oltre trenta, in genere raggruppati in gruppi di due o tre, in modo simmetrico o anche da un solo lato dei carpelli. La grande maggioranza delle specie ha fiori giallo vivo, ma in alcune specie i petali come H. stellaris o H. minita sono arancione. Sono indubbiamente piante graziosissime, di grande valore ornamentali, spesso anche profumate. E' giusto che portino il nome di un personaggio le cui idee "erano considerate abominevoli da molti critici già al suo tempo"? Il botanico australiano Kevin Thiele - che per inciso è un esperto di questo genere, una componente importante di molte comunità vegetali del suo paese - pensa di no, tanto più che questo grande genere continua ad essere arricchito da nuove scoperte e nuove denominazioni; e continua: "Proprio come si eliminano statue, nomi di edifici, strade e sobborghi, pensiamo che sia necessario fare i conti con i nomi di specie scientifiche che onorano persone che professavano idee o hanno agito in modi profondamente disonorevoli, altamente problematici o ripugnanti per gli standard moderni". La sua denuncia è stata ripresa da altri autori ed è sfociata nella proposta di modificare l'articolo 51 del Codice internazionale di nomenclatura, in modo che divenga possibile rigettare i nomi formalmente validi che riflettono "il potere coloniale e imperialista" o sono da ritenersi "culturalmente offensivi o inappropriati", compresi quelli che onorano "una persona che la comunità tassonomica ritiene concordemente non debba essere onorata". La proposta è sconvolgente perché mette in discussione i principi stessi su cui si fonda il Codice internazionale di nomenclatura: la stabilità della nomenclatura, la libertà scientifica e la neutralità politica della scienza. Più ancora dell'articolo 51, che recita "un nome legittimo non può essere rigettato solo perché esso, o il suo epiteto, è inappropriato o sgradevole", a traballare è lo stesso primo preambolo, dove si legge: "Lo scopo di questo Codice è fornire un metodo stabile per nominare i gruppi tassonomici, evitando o respingendo l'uso di nomi che possono causare errore o ambiguità o mettere la scienza in confusione. Ogni altra considerazione, come la correttezza grammaticale, la regolarità e l'eufonia dei nomi, le consuetudini più o meno prevalenti, il riguardo per le persone, nonostante la loro innegabile importanza, è relativamente accessoria". Alle considerazioni di Thiele e altri (potete leggere una delle più recenti versioni qui) ha risposto il botanico ucraino Sergei L. Mosyakin (il suo punto di vista qui), che le ha respinte con un'articolata argomentazione. Il dibattito è aperto, e forse avrà nuovi sviluppi in occasione del XX congresso botanico internazionale, che si terrà a Madrid tra il 21 e il 29 luglio 2024. Da parte mia considero queste piante deliziose non dedicate al discutibile Mr. Hibbert, ma a tutte le persone le cui sofferenze furono prolungate per causa sua. Se nella generazione dei fondatori del vivaio the Vineyard di Lee e Kennedy la figura di maggior spicco fu James Lee, nella seconda generazione a mettersi in luce fu John Kennedy. Mentre il suo socio si occupava abilmente della conduzione del vivaio, Kennedy badava a far conoscere le ultime novità con i testi di The botanist repository, illustrati da suo genero Henry C. Andrews. A partire dal 1803, il vivaio incominciò a rifornire di piante esotiche il giardino della Malmaison e Kennedy divenne consulente dell'imperatrice Giuseppina, che stava ridisegnando il parco secondo i canoni del giardino all'inglese. Tra le tante esotiche che, a dispetto della guerra e del blocco continentale, the Vineyard continuò a spedire all'imperatrice dei francesi c'erano indubbiamente anche rose, sebbene forse meno di quanto comunemente si crede. Alla collaborazione con Mme Bonaparte Kennedy deve anche la dedica del genere Kennedia, istituito da Ventenat nel bellissimo Le jardin de la Malmaison, illustrato da Redouté.  Piante nuove e rare da tutto il mondo Il momento di massimo fulgore di the Vineyard coincise con la gestione del secondo dei Kennedy, John (1759–1842), figlio del fondatore Lewis. Dovette iniziare a lavorare nel vivaio fin da ragazzino, e nel 1782, alla morte del padre, gli succedette alla testa dell'azienda a fianco di James Lee e poi, alla morte di questi nel 1795, del figlio James junior. Certo, anche quest'ultimo dovette essere un validissimo uomo d'affari, come lo era stato il padre, se lasciò ai figli un notevole patrimonio che permise loro di rilevare l'intero vivaio, quando John Kennedy si ritirò; ma certamente dopo la morte di James Lee senior il volto ufficiale della ditta, il nome più riconosciuto anche a livello internazionale, fu quello di Kennedy. La seconda generazione di the Vineyard rimase fedele alla strategia già adottata dai fondatori: cercare, moltiplicare e commercializzare piante "nuove e interessanti" e "novità di valore", come si legge in una lettera di James Lee junior a William Aiton. Un documento di grande interesse per conoscere le introduzioni del vivaio a cavallo dei due secoli sono i primi cinque fascicoli di The botanist repository, i cui testi furono redatti in gran parte dallo stesso John Kennedy. La rivista, che uscì tra il 1797 e il 1814, come ben specifica il sottotitolo for new and rare plants, era specificamente dedicata alle piante di recentissima introduzione e fu il più serio concorrente del Curtis's Botanical Magazine, rispetto al quale aveva meno pretese di scientificità: le illustrazioni, disegnate da Henry Cranke Andrews, che era anche l'editore, erano di grande impatto visivo, ma spesso imprecise e mancanti di particolari utili all'identificazione, così come i testi erano diseguali e privi di sinonimi e rimandi bibliografici. La rivista infatti non si rivolgeva tanto ai botanici quanto agli amatori e ai proprietari di giardini. Le illustrazioni di Andrews sono accompagnate da una breve descrizione bilingue (in latino e in inglese) e da un testo inglese con informazioni sulle peculiarità più desiderabili della pianta, la sua provenienza, le date di introduzione e di prima fioritura, le esigenze di coltivazione. Come ho anticipato, i testi dei primi cinque fascicoli, anche se non sono firmati, furono con grande probabilità scritti da John Kennedy; quelli del vol. 6 si devono a Adrian Haworth e quelli dei voll. 7-10 a George Jackson (voll. 7-10). Andrews forse fu incoraggiato a intraprendere l'impresa proprio da John Kennedy, che nel 1801 divenne suo suocero. Nei volumi curati da Kennedy, usciti tra il 1797 e il 1811, 40 specie risultano direttamente introdotte o almeno coltivate nel vivaio di Hammersmith (citato invece una sola volta nei volumi successivi). Ci sono parecchie bulbose, piante da fiore, arbusti, qualche succulenta, alcune orchidee, ma non sembra prevalere un indirizzo preciso nella scelta delle specie. La data di introduzione più bassa è il 1772, la più alta il 1800 (l'unica specie citata nei volumi successivi risale invece al 1813). Diciassette specie (42.5%) provengono dal Capo di Buona speranza; dodici (30%) dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, il resto dal Nord America, dalle Barbados, dalla Giamaica, dal Brasile, dalla Crimea e da Madera. Spesso il testo si limita a indicare che la pianta è stata introdotta da Lee e Kennedy o che è fiorita per la prima volta nel loro vivaio, ma talvolta ci sono indicazioni più specifiche, illuminanti per ricostruire le vie di introduzione. I due vivaisti potevano all'occorrenza rifornirsi da altri vivai: è il caso di Gladiolus praecox (oggi G. watsonius), acquistato nel 1791 presso Voorhelm & Co. di Haarlem, un vivaio olandese specializzato in bulbi da fiore; o di Rhododendron punctatum (oggi R. minus var. minus), reperito presso il vivaio dell'introduttore, il celebre vivaista e cacciatore di piante James Fraser. Più spesso però ricorrevano agli invii di viaggiatori o residenti all'estero a vario titolo: l'orchidea Prosthechea cochleata fu inviata dalla Giamaica dal botanico dell'isola Thomas Dancer, tramite una certa Mrs. Barrington; un'altra orchidea, Orchis ciliaris (oggi Platanthera ciliaris) fu spedita da Filadelfia da John Lyon, che all'epoca lavorava ancora come giardiniere; diverse piante sudafricane furono procurate da John Pringle, funzionario della Compagnia delle Indie al Capo; la brasiliana Amaryllis reticulata (oggi Hippeastrum reticulatum) fu spedita dal Portogallo da Edward Whitaker Gray. futuro curatore delle collezioni naturali del British museum, all'epoca residente ad Oporto dove aveva sposato l'erede di un importante esportatore di vini. Lee e Kennedy però avevano anche relazioni con orti botanici e studiosi: Pallas inviò i semi di due specie dalla Crimea e i semi di due piante del Capo furono forniti dal curatore dei giardini imperiali di Vienna, ovvero da von Jacquin. Non mancavano gli apporti di collezionisti, probabilmente al tempo stesso fornitori e clienti: è il caso di lady Sophia de Clifford, celebre per la sua collezione di piante esotiche, che condivise con Lee e Kennedy i bulbi di Ixia crispifolia flore coeruleo (oggi Codonorhiza corymbosa) appena ricevuti dal Capo e procurò altre piante sudafricane; oppure di Thomas Jones, creatore del giardino di Hafod in Galles che procurò Geranium punctatum (oggi Pelargonium punctatum). Tra questi contributori illustri, spicca il colonnello William Paterson, dal 1791 al 1793 governatore dell'isola di Norfolk, da cui inviò semi sia a Kew sia ai vivai Lee e Kennedy e Colvill; è citato per più piante tra cui Bignonia pandorana (oggi Pandorea pandorana). Quello di Paterson è l'unico nome menzionato per l'Australia (all'epoca Nuova Olanda); gli altri invii potrebbero essere dovuti a cacciatori di piante, quelli antecedenti il 1792 (l'anno della sua morte) forse a David Burton, che sappiamo lavorò sia per Kew sia per Lee e Kennedy. Potrebbe essere un cacciatore di piante l'altrimenti ignoto Mr. J. Elcock cui si deve l'invio di due specie dalle Barbados tra il 1789 e il 1791. Alcuni degli invii dal Sudafrica e forse anche uno da Madera potrebbero risalire a Francis Masson, che però è citato esplicitamente solo per Protea formosa (oggi Leucospermum formosum). Anche se non è citato in The botanist repository, diverse piante sudafricane furono presumibilmente procurate da James Niven, che nel 1798 o 1799 fu inviato al Capo dal ricco appassionato George Hibbert,per poi tornarvi nel 1805 finanziato da un consorzio di appassionati, giardinieri e vivaisti che, oltre a Hibbert, includeva Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Fornitore della Malmaison Siamo così arrivati alla più celebre dei clienti di the Vineyard: Joséphine de Beauharnais, la prima moglie di Napoleone. Nel 1799, mentre il marito si trovava in Egitto, ricorrendo a un prestito, essa acquistò il castello e il parco della Malmaison, a una quindicina di km da Parigi. Durante il consolato, divenne la residenza dei Bonaparte e tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuileries, fu sede del governo francese, prima di essere sostituita dal più istituzionale Saint Cloud. Per Joséphine era il luogo del cuore, e dopo il divorzio nel 1809 divenne la sua casa. I grandi lavori di trasformazione erano iniziati fin da subito. A partire dal 1800, venne costruita un'aranciera in stile neoclassico, così grande da poter ospitare 500 vasi di ananas; il parco venne ridisegnato secondo lo stile paesaggistico inglese; l'imperatrice si affidò dunque a specialisti britannici come il capo giardiniere Alexander Howatson eil giardiniere paesaggista scozzese Thomas Blaikie, che viveva in Francia da tempo e prima della rivoluzione aveva creato il giardino di Bagatelle per il conte di Artois e il parco Monceau per il duca d' Orlèans. Fu forse proprio Blakie a mettere in contatto Joséphine con Lee e Kennedy. La Malmaison era un giardino sperimentale ricco di piante provenienti da tutto il mondo. Molte piante australiane (ma anche animali) giunsero in seguito alla spedizione Baudin: l'allora prima console aveva ordinato che gli esemplari più belli, anziché al Museo di storia naturale, fossero portati alla Malmaison, il cui parco cominciò a popolarsi di eucalipti e mimose, tra cui scorrazzavano emù e canguri mentre sul laghetto si dondolavano cigni neri. Per avere un angolo da riservare alla sua passione per la botanica, tra il 1803 e il 1805 l'imperatrice fece costruire la Petite Malmaison, che comprendeva una grande serra calda per le esotiche, il primo edificio in Francia a fare ampio uso di vetrate. Contemporaneamente assunse come intendente il botanico Étienne Pierre Ventenat, il curatore del giardino-vivaio di Jacques Cels a Montrouge. Proprio come Lee e Kennedy in Inghilterra (con i quali corrispondeva) Cels era specializzato nella coltivazione e nella propagazione delle piante esotiche riportate dai naturalisti viaggiatori come Michaux o dai grandi viaggi di esplorazione. Egli si riforniva anche dai vivai inglesi ed era in ottime relazioni, nonostante lo stato quasi permanente di guerra, con Joseph Banks. Di questi contatti inglesi poterono approfittare anche il giardino della Malmaison e la sua proprietaria quando la pace di Amiens portò un breve periodo di tregua (marzo 1802-maggio 1804). Attraverso Ventenat, Joséphine si mise in contatto con Banks, che promise il suo aiuto nonché piante di Kew. In una lettera dell'aprile 1803, che accompagna il primo volume dello splendido catalogo Le Jardin de la Malmaison, con i suoi testi e le illustrazioni di Redouté, il botanico ringrazia Banks per le piante finora fornite e esprime l'augurio che la collaborazione posso continuare. Lo stesso anno, Lee e Kennedy ricevettero il primo ordine di piante per il giardino, per l'ammontare di 2600 sterline. Nel 1804, l'imperatrice lamentò accorata che un invio di semi era stato catturato e trattenuto, ma è uno dei rari incidenti di percorso: anche più tardi, quando il blocco continentale in teoria chiuse i porti di Francia ai vascelli inglesi, si continuò a fare eccezione per le navi che trasportavano le piante per i giardini dell'imperatrice. Un altro contatto inglese era George Hibbert, che, consultato per la progettazione del giardino all'inglese, dovette consigliare all'imperatrice di rivolgersi a Kennedy non solo come fornitore, ma anche come giardiniere paesaggista. Da quel momento, come consulente di Joséphine James Kennedy iniziò a fare la spola tra i due paesi, magari per accompagnare di persona qualche pianta particolarmente delicata, e suo figlio Lewis Kennedy (1789-1877) lavorò addirittura per qualche tempo sia alla Malmaison sia a Navarre, la tenuta normanna donata all'ex imperatrice dopo il divorzio (un po' come compensazione, un po' per tenerla lontana da Parigi in occasione delle seconde nozze dell'imperatore). Tra i più importanti risultati della collaborazione tra Mme Bonaparte e il vivaio inglese ci fu l'invio in Sudafrica del raccoglitore James Niven, che probabilmente ritornò al Capo nel 1805 e vi rimase fino al 1812, arricchendo il vivaio di Hammersmith e il giardino parigino soprattutto di eriche (il suo viaggio sudafricano però merita un post a parte). Tutti sanno che la piante preferite di Joséphine erano le rose; lo sanno tutti, ma non è detto che sia vero. Mentre conosciamo bene le piante esotiche coltivate alla Malmaison grazie al già citato catalogo curato di Ventenat e Redouté, proprio la collezione di rose è mal documentata, tanto da essere ritenuta da alcuni più un mito che una realtà. Coloro che visitarono il giardino subito dopo la morte non ne parlano; il celebre Les roses di Redouté, che di solito è ritenuto una sorta di catalogo del roseto dell'imperatrice, in realtà fu creato dal pittore dopo la sua morte (i tre volumi uscirono tra il 1817 e il 1824), ritraendo le rose coltivate in vari giardini e vivai parigini; in precedenza ne aveva dipinte alla Malmaison solo due - R. berberifolia e R. gallica purpurea veluntina. Anche se in molti testi si parla di una collezione di 250 diverse varietà di rose (e alcuni si spingono a specificare quali), le accurate ricerche del collezionista di rose antiche François Jouyaux hanno potuto identificarne solo una minima parte. Lee & Kennedy, insieme a molte esotiche, procurarono certamente all'imperatrice anche rose, in particolare le cinesi rifiorenti che in Francia erano ancora una novità, mentre avevano già incominciato a raggiungere l'Inghilterra da qualche anno - la prima fu introdotta proprio da loro nel 1787; dagli archivi nazionali risultano come introdotte tramite il vivaio di Hammersmith Rosa chinensis, R. multiflora ‘Cornea’, R. semperflorens (generalmente nota come Slaters Crimson China) e la rosa muschiata R. centifolia ‘muscosa alba’ (nota come Shailers White Moss). Dai documenti d'archivio, risulta inoltre che Joséphine importò tramite fornitori non identificati R. pendulina, R. virginiana, tre rose muschiate, una centifolia nota come ‘Unique’. Un altro esperto, Auguste de Pronville, ha aggiunto alla lista R. damascena carnea, una varietà della scozzese R. spinosissima e R. berberifolia. Presumibilmente, l'imperatrice si rifornì anche da vivai parigini, come Cels, Boursault e Vilmorin, ma negli archivi sono testimoniati acquisti solo dal coltivatore di rose amatoriale André du Pont che tra il 1808 e il 1809 procurò molte rose; purtroppo le fatture non ne riportano il nome. Un genere australiano per un grande introduttore di australiane
Anche se l'idea che la malinconica ex-imperatrice abbia acceso la scintilla della coltivazione delle rose in Francia è probabilmente sopravvalutata (a diffonderla, dopo la sua morte, sarebbero stati gli ibridatori di rose come Vibert, alla ricerca di un precedente romantico e nobilitante), resta il fatto che Lee & Kennedy lasciarono il segno nella storia della coltivazione delle rose diffondendo anche nel continente le cinesi: gli ibridatori francesi, incrociandole tra loro e con altre rose, avrebbero prodotto il primo ceppo di rose rifiorenti, le ibride perpetue. Non è alle rose, ma forse più giustamente a un'esotica australiana che John Kennedy deve il suo ingresso nel pantheon dei dedicatari di generi di piante. Il genere Kennedia è un tributo di Ventenat che in Le jardin de la Malmaison così scrive: "Devo i frutti di questa pianta e delle due successive allo zelo e alla benevolenza di M. Kennedy", definito in un altro passo "abile botanico e celebre vivaista inglese" e ripetutamente citato nel libro come fornitore di piante e semi. Kennedia (Fabaceae) è un genere endemico dell'Australia che comprende circa 14 specie di arbusti prostrati, ricadenti o rampicanti con sottili fusti legnosi, foglie composte per lo più tomentoso, solitamente trifoliate, e vistosi fiori papilionacei in technicolor: K. lateritia li ha rosso vivo, K. coccinea rosso aranciato con ali rosa e centro giallo, K. procurrens da viola a blu, K. prorepens da viola ad azzurro chiaro, K. nigricans quasi neri con macchie gialle e arancio; a diminare è comunque il rosso in infinite sfumature. Molte Kennedia sono vigorosi rampicanti che in Australia vengono anche utilizzati in interventi di rivegetazione: K. rubicunda può raggiungere un'altezza di cinque metri in una sola stagione. Relativamente rustica, è talvolta proposta anche dai nostri viavai, così come K. coccinea, di portamento prostrato e utilizzabile come tappezzante. Una selezione di specie e qualche informazione in più nella scheda. Jean-Baptiste Leschenault de La Tour è stato definito da Lucille Allorge "il più viaggiatore dei botanici viaggiatori". In effetti, da quando ventisettenne si imbarcò sul Géographe alla volta dell'Australia, non smise mai di spostarsi da un paese all'altro, eccetto quando ne fu impedito dalla guerra. Dal 1800 al 1803 fu appunto il botanico (l'unico rimasto) della spedizione Baudin nelle Terre Australi; sbarcato malato a Timor, si spostò a Giava, dove rimase tre anni a botanizzare in un ambiente naturale ricchissimo e quasi inesplorato. Dal 1807 al 1815 la guerra lo bloccò in Francia; ma, appena tornata la pace, eccolo ad esplorare l'India meridionale. Ritornò in patria solo nel 1822, ma dopo meno di un anno ripartì, alla volta del Sud America. La salute precaria (che già lo aveva tradito altre volte) lo costrinse a un rientro anticipato, l'ultimo. Si potrebbe però anche definirlo botanico coloniale perché dedicò quasi metà della sua vita a cercare piante adatte alla naturalizzazione nelle colonie francesi. A ricordarlo il bellissimo genere australiano Lechenaultia (o Leschenaultia), omaggio dell'amico Robert Brown. Australia, India, Sud America Non conosciamo molto della giovinezza di Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (1773-1826), soprattutto ignoriamo per quali vie si fosse avvicinato alla botanica. Nel 1798 dalla natia Borgogna si traferì a Parigi e si presentò a Antoine Laurent de Jussieu, nella speranza di essere ammesso come allievo al Museum National d'Histoire naturelle. Probabilmente ci riuscì, visto che Jussieu, nel sostenere la sua candidatura per la spedizione Baudin alle Terre australi, lo presenta come allievo dell'istituto. Si dice che Leschenault l'avesse presentata spinto dal motivo apposto rispetto allo zoologo François Péron: questi voleva partire perché il padre di lei gli aveva rifiutato la mano della ragazza che amava, lui invece voleva sottrarsi a un matrimonio mal riuscito. Come che sia, Jussieu era abbastanza soddisfatto delle sue competenze da proporlo come allievo botanico della spedizione; così scrive di lui: "Il cittadino Leschenault si occupa da qualche anno di botanica e ne sa abbastanza da nominare un certo numero di piante senza ricorrere a libri e da decifrare in questi ultimi la maggior parte di quelle che non conosce". Inoltre, sapeva essiccare correttamente le piante, le disegnava in modo abbastanza corretto, era di buon carattere e di eccellente educazione. Ma dopo la rinuncia di Ledru, da allievo Lechenault passò a botanico, rimasto poi l'unico della sventurata spedizione. In Australia, egli visse questa nuova responsabilità diviso tra un forte senso del dovere e la coscienza della propria inadeguatezza; entrambi i sentimenti emergono in una bella lettera inviata a Jussieu da Port Jackson in cui non può nascondere la sua invidia per il botanico della spedizione Flinders. A lui tocca raccogliere le piante, essiccarle, descriverle e pure disegnarle, visto che i disegnatori Lesueur e Petit sono divisi tra il lavoro per il comandante e quello per lo zoologo Péron. "Che contrasto - scrive - con gli aiuti di ogni tipo accordati al mio buon amico Robert Brown!" Certo fece il suo dovere fino in fondo e le sue raccolte furono notevolissime, anche se durante la spedizione ebbe ricorrenti problemi di salute. Durante il soggiorno a Port Jackson era tanto deteriorata che in un primo tempo egli pensò di chiedere l'autorizzazione a rientrare in Francia con il Naturaliste. Poi si riprese, poté partecipare a diverse escursioni botaniche nei dintorni di Port Jackson, a Parramatta e sulle Blue Mountains; ma a dissuaderlo fu soprattutto il capitano Baudin che seppe trovare le parole giuste per rassicurarlo, con un atteggiamento comprensivo e paterno (decisamente non era il mostro che è stato dipinto). Sicuramente Leschenault non si pentì di essere rimasto, visto che l'ultima parte del viaggio fu la più produttiva. Ma il prezzo fu il deterioramento della sua salute: nel maggio 1803 arrivò a Timor in tali condizioni che dovette essere lasciato a terra. Sperava di rimettersi e di tornare quanto prima a casa. Un mese dopo la partenza dei suoi compagni, si imbarcò su una nave olandese diretta a Batavia, dove giunse così malato da non potere proseguire. Chiese però il premesso di trasferirsi a Samarang, che godeva di un clima un po' meno insalubre. Vi giunse a ottobre e fu accolto dal governatore Engelhard, in cui trovò un uomo colto e interessato alle scienze naturali. Nacque così un nuovo progetto: Leschenault sarebbe rimasto a Giava e avrebbe esplorato le ricchezze naturalistiche dell'isola, solo marginalmente sfiorate dai naturalisti che l'avevano visitata in precedenza. L'amministrazione olandese fornì uomini e mezzi, permettendogli di muoversi in sicurezza e con relativo agio. L'esplorazione iniziò con un viaggio nelle due capitali dei sultanati di Surakarta e Yogykarta. Partito da Samarang il 24 ottobre, Leschenault si diresse dapprima a Surakarta, passando per i monti Ungaran, Merbabu e Merapi, un vulcano attivo; per un mese esplorò la città e i suoi dintorni, quindi passò a Yogykarta, visitando lungo il cammino le rovine del tempio buddista di Prambanang. Aveva di nuovo preteso troppo da se stesso: dopo due settimane a Yogyakarta, ebbe un crollo; trasportato in barella a Samarang, vi giacque malato dal febbraio all'ottobre 1804. Quando si fu ristabilito, ripartì per visitare la parte orientale di Giava, di cui toccò tutti i distretti costieri; quindi si imbarcò per l'isola di Madura, dalla quale sarebbe stata sua intenzione proseguire per l'arcipelago Kangean, ma la notizia di un'incursione di pirati malesi lo indusse a desistere; tornato sulla terraferma, esplorò la regione sud orientale fino a Banyuwangi, dove si fermò due mesi; quindi passò a Bali, di cui visitò le coste. Tornato a Banyuwangi, passando dall'interno e toccando i monti Tingar si diresse a Surabaya. Qui si imbarcò infine per Samarang, dove rientrò nell'agosto 1806, dopo un viaggio di 18 mesi. Andò poi a Batavia, con l'intenzione di imbarcarsi per la Francia. In Europa infuriava la guerra e non era facile trovare un imbarco su una nave neutrale, tanto più che portava con sé molte casse di piante, animali, conchiglie, oggetti etnografici; finalmente, a novembre riuscì a trovare un passaggio su una nave americana. Nell'aprile 1807 era a Filadelfia dove riuscì a ottenere dall'ambasciatore inglese un passaporto per sé e le proprie collezioni. A luglio, dopo sette anni di assenza, toccava il suolo francese. Quasi il suo primo atto fu scrivere a Jussieu per informarlo del suo ritorno e delle sue avventure. Le raccolte furono esaminate da una commissione designata dal ministero dell'Interno (ne facevano parte anche Lamarck e Cuvier) che le giudicò così importanti da proporre di considerare l'esplorazione di Giava parte integrante della missione nelle Terre Australi: a condizione che consegnasse le collezioni al Museum, era giusto pagargli quattro anni di stipendio arretrato e assegnargli una pensione analoga a quella concessa a Péron. Napoleone acconsentì. Fino alla caduta di quest'ultimo, venne l'ora di lavori da scrivania (tra gli altri, la stesura di un dizionario di lingua malese); nel 1816, ritornata la pace, ripartì. La nuova destinazione era Pondichéry (oggi Pondicherry), la capitale dell'"India francese", costituita da cinque empori situati lungo la costa del Malabar e recentemente restituita alla Francia dal Congresso di Vienna. Era invece rimasta in mani inglesi l'Ile de France, ovvero Mauritius: una perdita molto dolorosa perché per quasi un secolo l'isola e il suo giardino di Pamplemousses avevano costituito il principale luogo di acclimatazione delle specie esotiche da diffondere nelle colonie francesi. Ora quel ruolo passava all'altra isola delle Mascarene, la Réunion, tornata a chiamarsi Ile Bourbon con la restaurazione, e al suo giardino di Saint Denis, appena creato dal botanico Nicolas Bréon. La missione di Leschenault era proprio quella di cercare piante indiane utili per l'agricoltura e il commercio, da acclimatare a Bourbon per essere poi distribuite in quanto rimaneva delle colonie francesi. Il botanico prese molto sul serio il compito. Anche se nei sei anni in cui rimase in India raccolse anche un'imponente quantità di esemplari di piante, animali e minerali e si interessò di molti aspetti della vita e della cultura indiane, ne fece il principale oggetto delle proprie ricerche. Prima di partire per l'India, andò in Inghilterra ad incontrare il vecchio Banks, per ottenere lettere di raccomandazione per gli amministratori e i botanici inglesi, che in effetti gli furono di grande aiuto. Giunto a Pondichéry nel settembre 1816, dedicò il primo anno allo studio dei sistemi di coltivazione in uso lungo la costa del Coromandel. Studiò anche le tecniche tintorie tradizionali a Karikal, l'altra enclave francese. Nel 1818, il primo viaggio alla ricerca di piante utili lo portò a Salem, da cui riportò, oltre a un erbario di 400 specie e semi di circa 160, il primo carico di piante vive e semi destinato a Bourbon: c'era la pianta tintoria Nerium tinctorium (oggi Wrightia tinctoria), due specie di canna da zucchero, una nera e una bianca, alberi di sandalo e di teak, semi di papavero da oppio e di quattro tipi di cotone. Poi la salute lo tradì di nuovo: nel mese di ottobre ripartì per visitare i Ghati occidentali, ma a Coimbatore fu colpito da un pericoloso attacco di febbre gialla che lo costrinse a rientrare a Pondichéry. Appena il tempo di ristabilirsi, ed eccolo di nuovo a Coimbatore, punto di partenza per una lunga escursione sulle Nigiri Hills, in cui fu accompagnato da due amici inglesi, Mr. Sullivan e il dr. Jones. Su queste montagne, non molto elevate ma dai fianchi assai ripidi e difficili da scalare, caratterizzate da un clima fresco e ricchezza di acqua, trovò una ricca flora con molti generi presenti anche in Europa (Rhododedndron, Rubus, Geranium, Impatiens, Rosa, Salix, Berberis), che egli giudicò particolarmente adatte alla naturalizzazione nei giardini europei; tra le piante utili, una nuova specie di Berberis che per le sue eccellenti qualità tintorie battezzò B. tinctoria. Nel 1819 andò in nave in Bengala e ne tornò con molte piante da inviare a Bourbon, ma anche in Senegal. Oltre a molti alberi da legname o falegnameria, nella sua relazione all'Accademia delle scienze, egli cita la palma da zucchero Saguerus rumphii (oggi Arenga pinnata), Ficus elastica per la sua gomma elastica, piante tessili come Asclepias (oggi Marsdenia) tenacissima, Urtica tenacissima (oggi Bohemeria nivea), Boswellia thurifera (oggi B. serrata), da cui si ricava un tipo d'incenso. Il viaggio più lungo e impegnativo fu l'ultimo, dedicato all'estrema regione dell'India sud-orientale e all'isola di Ceylon. Leschenault visitò i due piccoli regni di Thanjavur e Tondiman, il distretto di Madurai e le montagne di Cottalam, punto di incontro tra i due monsoni, con una flora assai variata. Dal sud dell'India inviò a Pondichéry un convoglio di carri con 35 balle di alberi di 42 specie diverse, tra cui il teak Tectona grandis. Al loro arrivo, furono trapiantati nel giardino del governatore, primo nucleo dell'orto botanico di Pondichéry che sarebbe stato creato nel 1826 sui terreni dell'ex Campo di Marte. Torniamo a Leschenault. Dopo aver visitato la provincia di Tinnevelly, si imbarcò per Ceylon; dopo aver soggiornato per qualche tempo a Colombo, ottenne il permesso di visitare l'interno, cosa che fece per tre mesi, finché nel febbraio 1821 l'ennesima malattia lo costrinse a imbarcarsi per Pondichéry. Portava però con sé molti esemplari di Cinnamomum verum, l'albero da cui si ricava la pregiata cannella di Ceylon. Ad agosto lasciò l'India per Bourbon, accompagnato da cinque pecore e da un montone della razza di Coimbatore, 130 piante vive, compresi 32 pianticelle di Cinnamomum verum, e circa 200 specie di semi. Mentre si trovava sull'isola, con l'aiuto di Bréon tentò esperimenti di innesto del cotone su Thespesia populnea, Hibiscus liliflorus e Guazuma ulmifolia. Infine, il 15 febbraio 1822 si imbarcò alla volta della Francia via Capo della Buona speranza, dove approfittò di uno scalo di due settimane per incrementare la collezione di semi, acquistare qualche tartaruga e una nuova specie di uccello. Al suo rientro in Francia l'enorme contributo alle collezioni botaniche, zoologiche e mineralogiche del Museo e all'introduzione di specie coloniali utili gli valse l'attribuzione della Legion d'onore. Dopo meno d'un anno, arrivò una nuova missione: con il titolo ufficiale di "botanico della corona" (ne aveva fatta di strada dai tempi in cui era "allievo botanico"!) fu inviato nella Guaiana francese per rilanciare l'agricoltura di quella colonia. L'11 giugno 1823 egli partì da Brest in compagnia di A. J. L. Doumerc, diretto a Cayenne, dove giunse il 5 novembre, dopo due scali a Rio e Bahia. Portava con sé pianticelle di tè per l'orto botanico. Dopo un breve soggiorno nella capitale, i due si spostarono a Nouvelle Angoulême sul fiume Mana, dove si separarono. Doumerc visitò le tribù amerinde Galibi e Arrowali, mentre Leschenault proseguiva alla volta del Suriname (Guaiana olandese). Anche qui fece notevoli raccolte, ma la salute malferma lo costrinse a interrompere il viaggio e a rientrare a Parigi nel novembre 1824. Quando sembrava aver recuperato, morì all'improvviso il 14 marzo 1826 all'età di 52 anni.  Lechenaultia o Leschenaultia? Sempre in viaggio, Leschenault de La Tour raccolse moltissimo ma pubblicò molto poco. Al ritorno da Giava diede alle stampe due brevi testi relativi alla spedizione Baudin, uno sulla città di Kupang a Timor, l'altro sulla vegetazione della Nuova Olanda (pubblicato nel secondo volume della relazione ufficiale di Péron e Freycinet), e una memoria su alcune piante velenose di Giava. Ugualmente scarsi gli scritti sull'India, che si limitano alla relazione sul viaggio letta all'Accademia delle scienze, alla pubblicazione del Berberis scoperto sulle Nigiri Hills e a una memoria sulla cannella di Ceylon. Ad approfittare delle sue raccolte e dei suoi erbari furono altri naturalisti. Senza dimenticare che quando Leschenault tornò in Europa Robert Brown, che invece era rientrato nel 1805, aveva già fatto in tempo a pubblicare un certo numero di specie australiane raccolte da entrambi, rendendo in qualche modo superato almeno in parte un suo eventuale lavoro. Un certo numero di piante raccolte da Leschenault in Australia furono descritte da Etienne Ventenat e da Aimé Bonpland nelle loro opere sul giardino di Malmaison, altre furono pubblicate da Labillardière, altre ancora da R. L. Desfointaines, che descrisse anche alcune delle sue specie indiane nei cataloghi delle collezioni del Jardin des plantes. Moltissimo ovviamente rimase non pubblicato nei depositi del Museo Nazionale. Diverse decine di piante ricordano il nostro botanico viaggiatore nel nome specifico e con le loro diverse origini riassumono le tappe dei suoi viaggi: tra le altre, citiamo le australiane Beyeria leschenaultii e Calitrix leschenaultii, le indonesiane Hypericum leschenaultii e Aralia leschenaultii, le indiane Argureya leschenaultii e Impatiens leschenaultii. Tra gli animali, ricordiamo il corriere di Leschenault Charadius leschenaultii, il cuculo di Sirkeer Toccocua leschenaultii, il codaforcuta capobianco Enicurus leschenaulti, il pipistrello Rousettus leschenaultii, la lucertola Ophiosops leschenaultii. In Australia conserva il suo nome la bellissima laguna Leschenault Estuary, separata dall'Oceano Indiano dalla penisola Leschenault. Nel breve periodo in cui entrambi si trovavano a Port Jackson come botanici rispettivamente delle spedizioni Baudin e Flinders, Leschenault de La Tour e Robert Brown avevano stretto amicizia. Nel giugno 1802 fecero almeno un'escursione insieme, nella quale lo scozzese ebbe modo di apprezzarne le doti di acuto osservatore. Fu proprio lui a dedicare un genere al collega francese in Prodromus Florae Novae Hollandiae, con una motivazione piena di elogi: "L'ho nominato in onore del mio stimato amico Lechenault, celebre viaggiatore, esperto botanico, da cui si attende avidamente la pubblicazione delle piante della costa occidentale della Nuova Olanda e delle isole di Giava e Timor". La grafia del cognome non è un mio errore di battitura: così lo trascrive un po' ad orecchio Brown, che infatti denominò il nuovo genere Lechenaultia, senza esse. Qualche anno dopo George Bentham lo corresse in Leschenaultia, nome che si impose a lungo, finché in rispetto delle norme della nomenclatura botanica, si è tornati alla denominazione originale. Ma l'incertezza rimane: mentre nella letteratura botanica prevale Lechenaultia, Plants of the World on line usa Leschenaultia, che è anche la forma più usata come nome comune. Lechenaultia / Leschenaultia (famiglia Goodeniaceae) è un genere endemico dell'Australia con una ventina di specie; per lo più sono piccoli arbusti, con qualche erbacea annuale; in genere hanno portamento prostrato e tappezzante. La maggior parte si trova nei suoli sabbiosi e nel clima arido o semi-arido dell'Australia occidentale, una in condizioni simili nell'Australia orientale, due nella regione tropicale del nord; L. filiformis si spinge in Nuova Guinea, unica specie al di fuori dell'Australia. Attraenti sia per l'aspetto generale sia per le fioriture, diverse specie sono coltivate come ornamentali. Solitamente hanno foglie lineari e carnose, di colore grigio-verde, che al momento della fioritura formano uno sfondo perfetto per i numerosi fiori dalle coloratissime corolle asimmetriche: blu intenso per L. biloba, giallo luminoso o rosso carminio per L. formosa, rosa carico per L. macrantha. Anche da noi in vivai ben forniti è possibile reperire almeno la prima, di cui sono state selezionate alcune cultivar, ma coltivarla e mantenerla in vita per più di pochi anni non è semplice. Qualche approfondimento nella scheda. Non stupisce che la duchessa di Beaufort, grande appassionata senza problemi di mezzi, appena vide le serre riscaldate di Hampton Court, si affrettasse a farsi costruire un'analoga "serra tropicale" per i suoi giardini di Badminton. Più curioso è che anche prima di lei se ne fosse dotato un semplice maestro di scuola: il dr. Robert Uvedale. Come per la ben più ricca nobildonna, anche per lui le piante erano una ragione di vita ed era così abile nel coltivarle che la sua reputazione di esperto orticoltore travalicava le frontiere britanniche. Gli è attribuita l'introduzione in Inghilterra di due piante: quella dubbia del cedro del Libano e quella documentata del pisello odoroso. A ricordarlo, tramite l'amico Petiver, l'epiteto linneano di Smallanthus uvedalia, e il genere australiano Uvedalia (Phrymaceae).  Piselli siciliani e cedri libanesi I britannici hanno una vera passione per i piselli odorosi Lathyrus odoratus. Non solo li coltivano ampiamente nei loro giardini, magari facendoli arrampicare su apposite piramidi sullo sfondo dei mixed border, ma ne fanno i protagonisti di premi e concorsi e ne arricchiscono continuamente la gamma con nuove selezioni e varietà. I nomi di due di esse, 'Cupani' e 'Robert Uvedale', ci portano all'origine di questa passione. Lathyrus odoratus è un endemismo della Sicilia e di alcune aree dell'Italia meridionale. Il primo a darne una descrizione fu Francesco Cupani in Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum (1694) e poi nuovamente in Hortus catholicus (1696). Nel 1699 ne inviò i semi a Caspar Commelin dell'orto botanico di Amsterdam, che li coltivò con successo e fece ritrarre la pianta nel quarto volume del Moninckx Atlas (1699) come Lathyrus siculus. La bella specie, deliziosamente profumata, che ogni tanto produceva fiori bianchi, ottenne successo; nel 1737 Burman attesta che era ormai coltivatissimo nei giardini dei Paesi bassi, compreso quello del patrono di Linneo George Clifford, dove il botanico svedese lo vide, ripubblicandolo in Hortus cliffortianus come Lathyrus odoratus. Cupani inviò semi anche ad altri corrispondenti, uno dei quali era l'inglese Robert Uvedale (1642-1722). Laureato in teologia a Cambridge, Uvedale era un semplice maestro di scuola: dirigeva la Grammar School di Enfield, a nord di Londra, ma soprattutto era famoso in tutta l'Inghilterra come grande esperto di orticultura e floricoltura; la sua specialità erano le piante esotiche, per coltivare le quali si era dotato di arancere e di una delle primissime serre riscaldate del paese. I semi di Cupani capitarono dunque in ottime mani, non solo perché Uvedale li coltivò nel migliore dei modi, ma anche perché li diffuse tra i suoi amici. Anche se egli stesso non ne faceva parte, alcuni di essi erano i colti gentiluomini che si riunivano nel Temple Coffee House Botany Club: Leonard Plukenet, che forse era stato suo compagno di scuola, il farmacista James Petiver e il dr. Sloane, almeno un nipote del quale fu suo allievo; tra i corrispondenti più assidui il medico, antiquario e collezionista Richard Richardson. Nel 1700 Plukenet pubblicò la nuova specie in Almagesti Botanici Mantissa e diversi esemplari coltivati a Enfield sono tuttora conservati nel suo erbario. Come in Olanda, anche in Inghilterra quel fiore profumatissimo piacque molto; nel 1724 cominciò ad essere disponibile nei cataloghi dei vivai. Era l'inizio di un grande amore che perdura tuttora. Oggi le varietà si contano a centinaia. Tra di esse 'Cupani', la più simile al pisello odoroso originario: ha solo due fiori per stelo, piccoli e bicolori, ma profumatissimi. C'è anche 'Robert Uvedale', con grandissimi fiori rosa intenso. Il pisello odoroso non è l'unica specie la cui introduzione è attribuita a Uvedale. Ma dal campo dei fatti, passiamo in quello della leggenda. Fino al 1920, presso l'Enfield Palace si poteva ammirare un esemplare secolare di cedro del Libano Cedrus libani, che sarebbe stato piantato da Uvedale tra il 1662 e il 1670, da semi portati da Gerusalemme da un allievo. Si tratterebbe del primo esemplare piantato in Inghilterra, se non in Europa. E' una pretesa largamente infondata. Le prime pigne di cedro furono portate in Inghilterra nel 1639 da Edward Peckock, Cappellano della compagnia turca ad Aleppo, che le passò al fratello, cappellano del conte di Pembroke a Wilton (Devon); intorno al 1640 due esemplari nati dai loro semi furono messi a dimora nel parco di Wilton e vissero fino al 1874. Più tardi Peckock divenne rettore di Childrey, Oxfordshire, e piantò nel giardino del rettorato un esemplare che sopravvive tuttora. Quando Uvedale piantò il suo a Enfield, dunque, se la data tradizionale è fondata, il cedro di Childrey era già un bell'albero di 40 o 30 anni, Ma anche quella data è stata contestata. In nessuna delle lettere di Uvedale ai suoi numerosi corrispondenti egli cita l'albero né viene menzionato nella descrizione del giardino di Enfield contenuta in Short Account of several Gardens near London di J. Gibson (1691). John Ray, un altro dei corrispondenti di Uvedale, parlando dei quattro esemplari di cedro piantati al Chelsea Physic Gardens nel 1683, si dice convinto che siano i primi ad essere piantati in Inghilterra (come abbiamo visto, non lo sono; ma furono i primi a fruttificare, e da loro discendono i virgulti portati al Jardin des Plantes da Bernard de Jussieu), Dal libro di Gibson ricaviamo interessanti informazioni sul giardino di Enfield: "Il dr. Uvedale di Enfield è un grande amante delle piante e, avendo un'arte straordinaria nel coltivarle, è riuscito a creare una delle più grandi e rare collezioni di esotiche che si siano viste in questo paese. Il giardino comprende cinque o sei edifici o ambienti. Il più vasto è occupato da aranci e da grandissimi mirti, un altro è riempito da mirti più piccoli; le piante più graziose e curiose, che richiedono maggior cura, si trovano in stanze più calde, alcune delle quali possono essere riscaldate all'occorrenza. I fiori sono scelti, l'assortimento ricco, la coltivazione metodica e curiosa; non vale però la pena di parlare dell'aspetto generale del giardino, perché la sua delizia e la sua cura più che nel piacere dell'occhio risiedono nella coltivazione di piante rare". Insomma, ancora lontano dal giardino paesaggistico all'inglese, il giardino di Uvedale è ancora essenzialmente una camera delle meraviglie barocca, in cui il sommo piacere è dato dall'ostentazione di piante rare, la cui coltivazione è resa possibile da una serie di stanze con temperature variabili; che una o più siano riscaldabili è una novità nell'Inghilterra del 1691, se pensiamo che sono precedute solo dalla "stufa" del giardino dei farmacisti a Chelsea (forse 1681) e dalle tre serre della regina a Hampton Court (1690). Persino la "serra delle esotiche" della ben più ricca duchessa di Beaufort arriva dopo. Né ricco né nobile, questo modesto insegnante di provincia, non di rado in conflitto con i suoi superiori, traeva dalla rarità delle collezioni, dalla suprema abilità di coltivatore e dalla frequentazione di dotti e stimati botanici un prestigio capace di elevarne lo status e di farne una figura riconosciuta, come abbiamo visto, persino in Sicilia. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1722, la collezioni di piante vive fu acquistata da Robert Walpole per Houghton Hall; l'erbario fu invece acquisito da Sloane. Anch'esso documenta la rete di corrispondenti di Uvedale, con esemplari ottenuti non solo da corrispondenti inglesi come Sherard, Richardson, Petiver, Plukenet, Bobart, Doody, Sloane, Du Bois, ma anche da corrispondenti continentali come Tournefort, Magnol, Vaillant e altri.  Dediche intricate Il dr. Uvedale doveva anche possedere il talento dei rapporti umani, tanto che riuscì a conservarsi l'amicizia sia di Plukenet sia di Petiver, nonostante l'ostilità tra i due. Al primo forniva piante per i suoi libri e per i giardini di Hampton Court, il secondo lo onorò battezzando Wedalia (il cognome poteva essere scritto in vari modi, incluso Wedal) una bella asteracea nordamericana con foglie palmate e capolini giallo oro. Linneo, prima in Hortus cliffortianus poi in Species plantarum, riprese la denominazione di Petiver, ma ne normalizzò la grafia e la trasformò in epiteto, ribattezzando la specie Polymnia uvedalia. Oggi si chiama Smallanthus uvedalia. Del nome generico così rimasto disponibile si ricordò a inizio Ottocento Robert Brown che in Prodromus Florae Novae Hollandiae (1810) istituì il genere Uvedalia per una piccola pianta da lui scoperta in Australia, U. linearis. Nella breve motivazione sono citati esplicitamente Plukenet, Petiver e il giardino di Enfield: "Questo genere, forse troppo affine a Mimulus, l'ho battezzato Uvedalia in memoria del dottore in teologia e legge Uvedale, lodato da Plukenet e Petiver, che nei pressi di Enfield creò un giardino soprattutto ricco di esotiche". Che fosse troppo affine a Mimulus lo pensavano sicuramente de Candolle che nel 1813 soppresse il genere e lo fece confluire in Mimulus, nonché Bentham che nel 1835 ribattezzò la specie di Brown dapprima Mimulus linearis, quindi M. uvedaliae, con un assurdo genitivo. Questa è stata la situazione per circa 200 anni, fino al 2012, quando Barker e Beardsley hanno fatto risorgere Uvedalia nell'ambito di una revisione generale di Mimulus, che ha comportato il distacco delle specie australiane, assegnate a sei piccoli generi, tra cui appunto Uvedalia con due specie, U. linearis e U. clementii. Ovviamente una soluzione che non piace a tutti: altri preferirebbero un genere Mimulus onnicomprensivo, sulla scia della linea adottata di recente per Salvia. Al momento, però, Uvedalia resiste. U. linearis è una piccola erbacea che vive nei suoli sabbiosi dei territori del nord dell'Australia, con foglie lineari e fiori con corolla bilabiata blu-violaceo con gola gialla, oppure gialla a volte puntinata di rosso nella varietà lutea. La poco nota e rara U. clementii è invece nativa dell'Australia nord occidentale. Quello del Bounty è probabilmente l'ammutinamento più celebre della storia della marina, anche grazie a diversi film hoolywoodiani. Nei quali il cattivo è, immancabilmente, il tirannico capitano William Bligh. Ma forse la realtà è un po' diversa. E soprattutto, in quei film manca l'altro protagonista, senza il quale forse quella rivolta non sarebbe mai scoppiata: l'albero del pane, Artocarpus altilis. Dopo tante vicissitudini, il discusso capitano riuscì nella sua impresa di importarlo nelle Antille, e, en passant, riportò dal viaggio anche un'altra pianta dai frutti eduli. In suo onore, fu battezzata Blighia sapida. 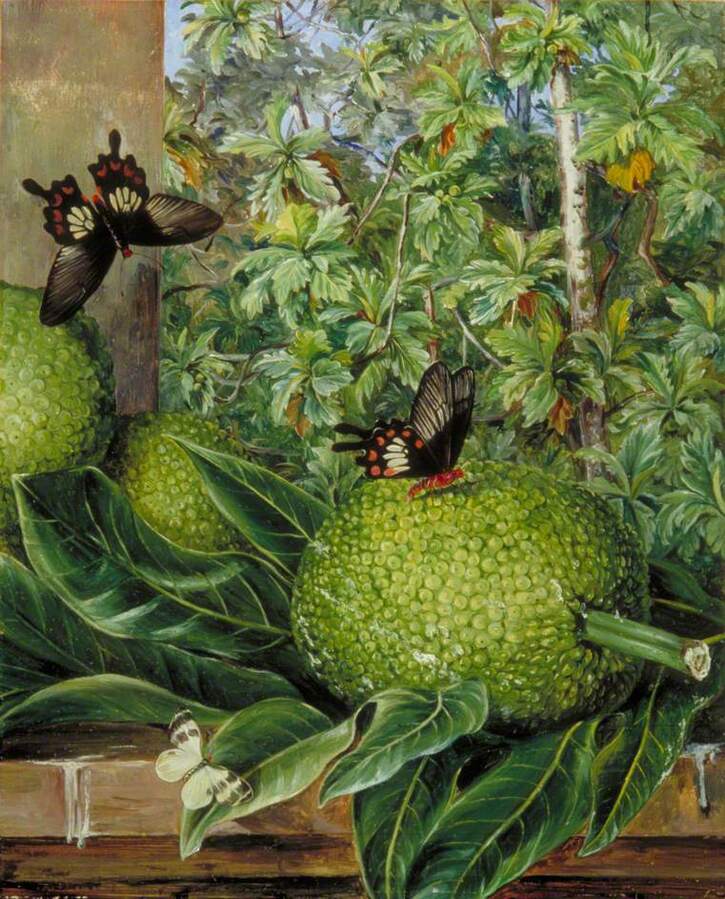 L'albero più utile delle Indie orientali L'albero del pane Artocarpus altilis è una delle più importanti piante alimentari del pianeta. Un singolo albero adulto può produrre, a seconda delle condizioni in cui cresce, da 50 a 150 frutti l'anno, e ciascun frutto può pesare fino a 5 kg. I frutti cotti hanno un gusto e un profumo simili a quelli del pane e sono ricchi di carboidrati, fibre e minerali. Una porzione fornisce il potassio di due patate e mezzo, oppure di dieci banane o ancora di venti tazze di riso. Oggi è coltivato in almeno novanta paesi tropicali e ha salvato dalla fame milioni di persone. Questa specie tanto utile è originaria della Nuova Guinea, delle isole Maluku e delle Filippine. Nel corso della loro espansione in Asia Orientale e in Oceania fu conosciuta e domesticata dai popoli austronesiani, che la importarono in quasi tutte le isole dell'Oceania, facendone una delle basi della loro alimentazione e della loro economia. Il primo europeo a descrivere l'albero del pane fu William Dampier, che lo conobbe nell'isola di Guam nel 1687, quando i suoi frutti salvarono dalla fame l'equipaggio stremato della Cygnet; nella sua relazione all'ammiragliato, fu anche il primo a raccomandarne l'introduzioni nei Caraibi. Negli anni '40 del Settecento, l'ammiraglio George Anson ne esaltò le virtù, dichiarando che i suoi marinai lo preferivano al pane. Durante il loro soggiorno a Tahiti nel corso del primo viaggio di Cook, sia il capitano sia Banks furono impressionati dalla sua grande produttività (tre raccolti all'anno), dalla facilità di propagazione, dallo scarso fabbisogno di manodopera e della sua resistenza al vento. Al loro ritorno in Europa, ne parlarono con tanto entusiasmo che incominciò ad affacciarsi l'idea di importalo nelle colonie americane. Nel 1772, poco dopo il rientro della spedizione, Valentine Morris, governatore di St Vincent, scrisse a Banks (un vecchio compagno di scuola dei tempi di Eton) per chiedergli informazioni di prima mano. Nel 1775 John Ellis pubblicò A Description of the Mangostan and the Breadfruit in cui definì l'albero il più utile delle Indie orientali, e aggiunse che la sua introduzione sarebbe stata "estremamente benefica per gli abitanti delle nostre isole delle Indie occidentali". Nel 1777 la Society of Arts offrì un premio e una medaglia d'oro a chi fosse riuscito a trasportare con successo l'albero in Gran Bretagna. Ovviamente Banks, che nel 1784 era diventato presidente della Royal Society, divenne il principale promotore del progetto che, tuttavia, a causa della ribellione delle colonie americane e della guerra d'indipendenza, dovette attendere qualche anno. Fu così soltanto nel 1786 che egli riuscì a convincere il re e il primo ministro William Pitt il giovane a finanziare una spedizione finalizzata al trasporto di virgulti di albero del pane da Tahiti alle Antille britanniche; la propagazione per seme era infatti impossibile, dal momento che le varietà tahitiane erano sterili e prive di semi. Per l'occasione, la marina britannica acquistò e fece adattare una piccola nave, ribattezzata Bounty "Premio", probabilmente in riferimento al premio offerto dalla Society of Arts che ancora nessuno era riuscito ad aggiudicarsi. Come comandante, Banks raccomandò il luogotenente William Bligh, che era stato l'idrografo della Resolution nel terzo viaggio di Cook; benché poco più che trentenne, aveva una lunghissima esperienza di navigazione e inoltre conosceva bene sia Tahiti sia le Antille, che aveva visitato quando serviva nella marina mercantile. Per occuparsi della propagazione delle piante e del loro benessere durante il lungo viaggio, a bordo ci sarebbero stati anche due giardinieri: David Nelson (anche lui un reduce del terzo viaggio di Cook) e l'aiuto giardiniere William Brown.  Il primo e il secondo viaggio dell'albero del pane Bligh era indubbiamente un lupo di mare. Aveva cominciato a navigare a sette anni, per poi diventare, via via, marinaio scelto, guardia marina, sailing master, luogotenente. Il viaggio agli ordini di Cook (all'epoca aveva poco più di vent'anni) era stato per lui una grande scuola di navigazione e di vita. Successivamente si era distinto nella battaglia di Dogger Bank e nella difesa di Gibilterra, raggiungendo il grado di luogotenente. Tornata la pace, era stato messo a mezza paga e tra il 1783 e il 1787 aveva comandato diverse navi mercantili. Il comando del Bounty era dunque l'occasione che aspettava da un po' per far ripartire la sua carriera Il Bounty era una piccola carboniera a tre alberi di 215 tonnellate, lunga appena 27 metri. Per adattarla al trasporto delle piante, la grande cabina, normalmente riservata al comandante, venne estesa a un terzo della lunghezza della nave e trasformata in una serra viaggiante, con una stufa a carbone e un secondo livello di tavole forate, atte a ospitare 626 vasi. Lo spazio divenne dunque estremamente angusto; Bligh, privato del simbolo della sua autorità di comando, dovette accontentarsi di dormire in un bugigattolo e fu costretto a condividere ogni momento della giornata con i suoi sotto ufficiali. Era l'unico ufficiale a bordo, e non c'erano soldati che potessero aiutarlo in circostanze difficili. Oltre a lui, c'erano 43 marinai, molti dei quali alla prima esperienza di navigazione, e i due giardinieri: in tutto, 46 uomini. A causa del maltempo, che aveva ritardato la partenza prevista per ottobre, la nave salpò da Spithead il 23 dicembre 1787; incappò così in venti contrari che per oltre un mese le impedirono di superare il Capo Horn, finché Bligh si rassegnò a seguire la rotta più lunga, attraverso il Capo di Buona Speranza e l'Oceano Indiano; dopo una sosta relativamente lunga al Capo, l'unico scalo intermedio fu Adventure Bay, in Tasmania, dove si manifestarono le prime tensioni con alcuni sottoufficiali e morì un marinaio, forse mal curato dal chirurgo di bordo, un ubriacone impenitente. Per giustificarsi, questi attribuì il decesso allo scorbuto; di conseguenze Bligh rese ancora più severe le poco gradite misure anti-scorbuto imparate da Cook. Il Bounty raggiunse Tahiti solo il 26 ottobre 1788, dopo dieci mesi di navigazione. Sotto la guida di Nelson, i marinai dovettero trasformarsi in aiuto giardinieri: bisognava scegliere le piante adatte, prelevare le talee, trapiantarle, seguirne la crescita. Prima che le pianticelle fossero pronte per affrontare il viaggio, erano trascorsi cinque mesi. Bligh permise ai suoi uomini di vivere a terra; molti socializzarono con i nativi e diversi uomini, compreso il secondo Fletcher Christian, strinsero relazioni sentimentali con ragazze tahitiane. I compiti dei marinai erano poco impegnativi e incominciò a diffondersi un'atmosfera di rilassatezza e di indolenza che irritava sommamente il capitano. Era un uomo dalla lingua tagliente, e ci furono altri momenti di tensione. All'inizio di gennaio 1789, tre marinai sottrassero una lancia e disertarono; vennero catturati dopo pochi giorni e Bligh si accontentò di farli frustare. A febbraio erano pronte ben 1015 pianticelle, e iniziò il loro trasporto nella cabina-serra; il lavoro fu completato il 1 aprile e il 4 aprile il Bounty lasciò Tahiti. Dato che era morto anche l'etilico chirurgo, ora a bordo erano in 44. Il 22 aprile, a Nomuka, una delle Tonga, dove la nave aveva fatto scalo per completare le provviste, ci fu uno scontro tra Bligh e Christian che forse fu la causa scatenante dell'ammutinamento. Questo iniziò nelle prime ore del 28 aprile, quando Christian, insieme ad alcuni marinai che aveva convinto a seguirlo, prese il controllo del ponte superiore e si impadronì delle armi; tre uomini irruppero nella cabina di Bligh, profondamente addormentato, lo legarono e lo trascinarono fuori senza neppure permettergli di rivestirsi. Seguirono scene di grande confusione; gli ammutinati erano in minoranza (19 uomini su 44), ma gli uomini rimasti fedeli, privi di armi e annichiliti dalla cattura del comandante, non apposero resistenza. Bligh e 18 uomini furono imbarcati a forza su una lancia, con provviste e acqua per circa una settimana, senza carte e senza strumenti nautici, eccetto una bussola, un quadrante, un sestante rotto e un orologio da tasca. Tra i "fedeli" c'era anche Nelson, mentre Brown si schierò con gli ammutinati. Non c'è bisogno di dire che le povere piante di albero del pane furono scaraventate fuori bordo. Da allora gli storici si dividono sulle cause (e sulle responsabilità) dell'ammutinamento. Registi e sceneggiatori di Hollywood (con l'eccezione di una pellicola "revisionista") non hanno dubbi: Bligh era un tiranno, e fu la sua crudeltà insensata a spingere Christian e gli altri alla rivolta. Ma probabilmente la realtà è più complessa; Bligh, rispetto agli standard della marina britannica, non era particolarmente violento, anzi era probabilmente molto meno duro dello stesso Cook. D'altra parte, era noto per il carattere irascibile e il linguaggio intemperante. Probabilmente si sommarono diversi fattori: lo spazio sovraffollato della nave, inadatta al compito cui era destinata; la mancanza di gradi intermedi tra il comandante e i marinai specializzati; il lungo piacevole soggiorno a Tahiti, che aveva allentato la disciplina e creato relazioni di cui i marinai avevano nostalgia; rivalità personali tra Bligh e i suoi sotto ufficiali, primo tra tutti Christian, che all'inizio egli aveva favorito anche troppo, e alla fine umiliato in pubblico. Ovviamente il cattivo carattere del comandante e la sua totale mancanza di diplomazia avranno giocato la loro parte. E' certo invece che Bligh era un grande uomo di mare, e lo dimostrò realizzando un'impresa senza precedenti. Dato che la destinazione degli ammutinati era Tahiti, la meta obbligata del comandante era la colonia olandese di Timor, 3618 miglia nautiche (6700 km) di distanza. Grazie alla grande esperienza di marinaio, con l'aiuto di alcune carte di navigazione e dei pochissimi strumenti disponibili, ma affidandosi soprattutto alla memoria e al suo eccezionale talento di cartografo, Bligh riuscì a trovare la rotta giusta e a coprire la distanza in appena quarantasette giorni, un vero record. A poche miglia dal luogo dell'ammutinamento, il capitano e i suoi sostarono a Tofua per caricare acqua e provviste; tuttavia, furono attaccati dagli indigeni e un uomo perse la vita. Con l'imbarcazione sovraccarica, con un tempo spesso tempestoso e razioni ridotte a 40 g di pane al giorno, continuarono la navigazione senza altre soste in quel mare insidioso e il 29 maggio riuscirono a raggiungere la grande barriera corallina. Quel giorno sbarcarono in una piccola isola al largo dell'Australia occidentale: la battezzarono Restoration Island, perché vi trovarono ostriche e frutti che diedero loro grande ristoro, e anche perché era l'anniversario della restaurazione della monarchia, nel 1660. All'inizio di giugno superarono l'Endevour Strait e si trovarono di nuovo in mare aperto. Infine, il 14 giugno giunsero a Kupang nell'isola di Timor. Erano sopravvissuti tutti, ma erano così deboli che diversi uomini morirono nei giorni successivi. Tra di loro il giardiniere David Nelson. Quando tornò in Inghiterra, Bligh fu processato (era un atto obbligato per chi avesse perso una nave della Royal Navy) e fu assolto con onore, anche se i parenti di alcuni degli ammutinati, di condizione sociale molto superiore alla sua, orchestrano una campagna di stampa contro di lui. Molti, non ultimo il re Giorgio III, lo considerarono invece un eroe e anche Banks non perse la sua fiducia in lui. Promosso capitano, tre anni dopo poté completare l'impresa interrotta dall'ammutinamento. Nell'agosto del 1791, al comando della Providence, accompagnata dall'Assistence, comandata da Nathaniel Portlock (un altro veterano dell'ultimo viaggio di Cook), Bligh salpò una seconda volta per Tahiti; a bordo c'era di nuovo una coppia di uomini di Banks, James Wiles e Christopher Smith, incaricati non solo di preparare le piante di albero del pane, ma anche di raccogliere altre piante per Kew. Molto efficienti e solerti, fecero raccolte in Sud Africa, a Tahiti, in Tasmania e a Timor; particolarmente importanti quelle fatte a Adventure Bay in Tasmania. Questa volta la missione fu un successo: Smith e Wiles prepararono ben 1600 pianticelle; qualcuna morì durante il viaggio, qualcuna fu sostituita con pianticelle raccolte a Timor, qualcuna fu lasciata a Sant'Elena per essere acclimata o essere spedita in Inghilterra; 678 piante vive nel gennaio 1793 arrivarono nelle Antille. Alexander Anderson, il sovrintendente dell'orto botanico di Saint Vincent, salì sulla Providence per accogliere di persona le sue; altre furono sbarcate in Giamaica, insieme al giardiniere James Wiles, che preferì rimanere a prendersi cura di loro nel vivaio di Bath; più tardi diventò sovrintendente dell'orto botanico di Liguanea, quindi fu nominato Botanico dell'isola e redasse Hortus Eestensis, il catalogo del giardino. Si sposò, aprì due piccoli caffè e visse in Giamaica fino alla morte, nel 1851, all'età di 83 anni. Smith tornò a casa, ma già l'anno successivo fu assunto come giardiniere del giardino della Compagnia delle Indie a Calcutta; tra 1795 e il 1805 viaggiò nelle Molucche come cacciatore di piante di Kew e terminò la sua carriera come sovrintendente dell'orto botanico di Penang dove morì nel 1807. Bligh rientrò in Inghilterra nell'estate del 1793 e a gennaio dell'anno successivo ricevette la medaglia d'oro messa in palio dalla Society of arts. La sua carriera proseguì tra luci e ombre (inclusi altri due ammutinamenti e tre processi), per le quali rimando alla biografia.  Blighia, un'altra pianta viaggiatrice In Giamaica il capitano Bligh conobbe e riportò con sé in Inghilterra un'altra pianta dai frutti eduli, nota come ackee. In realtà non si tratta di una pianta indigena: era arrivata nell'isola (di cui oggi è considerata il frutto nazionale) solo una ventina di anni prima dall'Africa occidentale. E' infatti originaria della Costa d'Avorio e del Ghana. In onore del capitano, nel 1806 il botanico di origine tedesca Charles Konig, che all'epoca lavorava al British Museum, la denominò Blighia sapida. E' la più nota delle tre specie del genere Blighia, famiglia Sapindaceae. L'ackee è un albero sempreverde di medie dimensioni, con foglie pinnate, e fiori stellati raccolti in brevi pannocchie. Il frutto è una capsula ovale trilobata con buccia coriacea rossa o aranciata, che contiene tre semi, ciascuno dei quali alla base è avvolto da un arillo carnoso giallo; mentre l'arillo maturo è edule, tutte le altre parti del frutto sono tossiche. Per eliminare la tossicità, il frutto dell'ackee va raccolto quando è completamente aperto, in modo da poter separare con facilità gli arilli; questi ultimi vengono sbollentati in acqua o latte, e quindi utilizzati come ingredienti di vari piatti: curry, zuppe, stufati, riso. In Giamaica il piatto più comune è ackee and saltfish (Aki ah saalfish), preparato con varie verdure, baccalà ammollato e ackee. Abitualmente viene servito con banane verdi e frutti dell'albero del pane: una conclusione perfetta per questa storia! Qualche approfondimento sulle altre specie del genere Blighia nella scheda. Diverse specie del genere Galinsoga rientrano indubbiamente nel novero delle piante viaggiatrici, o anche in quello delle piante vagabonde. Originarie delle aree montuose del centro America e dell'America tropicale, nell'arco di pochi secoli sono riuscite a colonizzare tutti i continenti (eccetto l'Antartide), sfuggendo dagli orti botanici dove erano state introdotte come curiosità per intrufolarsi ovunque trasportate dal vento e dall'acqua, infiltrate negli imballaggi e in veicoli di ogni genere, mescolate a terricci, sementi e prodotti agricoli. A donare il suo nome a queste infaticabili viaggiatrici dall'aspetto apparentemente innocente, oggi tra le infestanti più temute, è stato un medico e uomo di potere della Spagna di fine Settecento, Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga, primo medico della regina Maria Luisa e intendente dell'orto botanico di Madrid. Morto piuttosto giovane, si segnala soprattutto per essere stato uno dei primi specialisti di ginecologia; come tale lanciò i suoi strali contro un aggeggio di moda, o meglio di tortura: il corsetto, che donava alle dame un vitino di vespa a prezzo di gravi menomazioni fisiche. Insomma, nel suo nome si incrociano due storie di effetti collaterali. 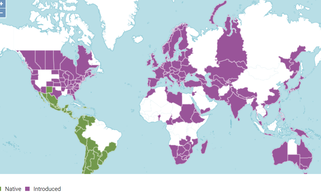 L'inarrestabile viaggio di Galinsoga All'interno della loro numerosissima famiglia (sono Asteraceae, la più vasta tra le fanerogame) le specie del genere Galinsoga non possono certo aspirare al primato per bellezza o vistosità, ma in qualcosa sono indubbiamente delle campionesse: la capacità di viaggiare e diffondersi in ogni dove, con mezzi propri, ma soprattutto con l'aiuto più o meno incauto degli esseri umani. Originarie dell'America tropicale e subtropicale, con centro di diversità nelle aree montuose del centro America, sono annuali con semi privi di dormienza che germinano rapidamente, fioriscono molto presto, completano il ciclo vitale in circa cinquanta giorni, il che permette molteplici generazioni nell'arco di una stagione e, ovviamente, producono semi copiosissimi con una straordinaria vitalità (oltre il 90%). Poco esigenti, possono vivere ovunque, ma danno il meglio (o il peggio) di sé in suoli umidi e dove possono godere di lunghe giornate di luce. Tra i luoghi preferiti, i terreni disturbati, i giardini, gli orti e coltivi di ogni tipo, incluso grano, granoturco, tabacco, cotone, patate, e ogni altra coltivazione da reddito che riuscite ad immaginare. Dalle loro sedi originarie due specie (le altre sono endemismi poco diffusi e se ne stanno tranquille) sono partite alla conquista del mondo verso la fine del XVIII secolo, quando i botanici si sono accorti di loro, hanno dato loro un nome (ne parliamo tra poco) e le hanno tanto entusiasticamente quanto incautamente seminate negli orti botanici. Per prima è arrivata Galinsoga parviflora, approdata all'orto botanico di Madrid nel 1795 e ai Kew Gardens nel 1796; tempo pochi decenni, aveva già conquistato l'Inghilterra meridionale, tanto da guadagnarsi il nome di Kew weed, l'erbaccia di Kew. Nel corso dell'Ottocento, di orto botanico in orto botanico, si è diffusa nel continente europeo; poi ha continuato il suo cammino, trasportata dal vento, dalle acque, da animali, da veicoli di ogni tipo, dai vestiti e dalle suole delle scarpe, nascosta in scatole e imballaggi, mescolata a terriccio, ammendanti, sementi e ortaggi. Oggi è presente in tutti i continenti eccetto l'Antartide e in moltissimi paesi è considerata una infestante tra le peggiori. Qualche dato sulla sua attuale diffusione nel mondo in questa pagina di CABI (Centre of Agricolture and Bioscience international). Un po' più lenta ma non meno trionfale la marcia di Galinsoga quadriradiata (spesso nota con il sinonimo G. ciliata). Nel 1836 la troviamo a Filadelfia nel Bartram Botanical Garden; ne sfugge presto, si naturalizza prima nei dintorni e poi prosegue verso nord; oggi è naturalizzata in gran parte degli Stati Uniti e in Canada ed è arrivata persino in Alaska. Il primo approdo in Europa è forse l'orto botanico di San Pietroburgo, nel 1846; in Germania la prima segnalazione è del 1892, ad Amburgo; nel corso del Novecento si diffonde a macchia d'olio in tutto il continente. Oggi gli unici paesi europei in cui non sembra arrivata sono l'Islanda, le isole Faroe e la Groenlandia. Anche per questa specie, diffusa anche nel resto del mondo, rinvio alla scheda di CABI. Anche nel nostro paese, dove entrambe le specie sono naturalizzate e presenti in tutte le regioni, la prima ad essersi diffusa risulta G. parviflora, segnalata per la prima volta in un orto di Tezze Valsugana nel 1820; da qui si diffuse prima nella Valsugana, quindi nella provincia, e così via. Non abbiamo dati così precisi per G. quadriradiata che potrebbe essere arrivata nella seconda metà dell'Ottocento, anche se per molte regioni le prime segnalazioni risalgono al secolo scorso. Ha fatto però in fretta a recuperare e oggi sembra più diffusa della prima arrivata.  Una carriera di successo e una battaglia igienico-sanitaria Il nome di questa vigorosissima ed inarrestabile erbaccia è un omaggio dei soliti Ruiz e Pavon a un personaggio all'epoca assai influente, Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga, primo medico della regina di Spagna e intendente dell'orto botanico di Madrid. Nel 1794, quando i due botanici crearono il genere sulla base delle loro raccolte in Perù, la sua posizione a corte era seconda solo a quella del protomedico Francisco Martinez Sobral. Galinsoga la doveva in parte a una solida preparazione professionale, ma ancor più alla alla protezione della regina Maria Luisa. Aveva iniziato la carriera a 21 anni come chirurgo, o meglio come cirujano latino. il titolo che distingueva gli abilitati in chirurgia con formazione universitaria, inclusa la conoscenza del latino, dagli illetterati cirujanos romancistas con formazione pratica attraverso l'apprendistato. Laureatosi in medicina all'Università di Valladolid, dove serviva come chirurgo militare, era poi passato nella capitale, dove frequentò gli ambienti accademici e incominciò a farsi conoscere come specialista in malattie femminili (noi oggi diremmo in ginecologia). Fu così che fu più volte incaricato di selezionare le balie per i nuovi nati della coppia regale; un incarico che svolse con scrupolo, visitando i villaggi che avevano fama di maggiore salubrità, alla ricerca di gestanti di eccellente salute e sani principi morali. Si dimostrò così abile ed efficiente, che nel 1789 fu nominato medico della famiglia reale, dando inizio a un'ascesa quasi inarrestabile come la marcia della Galinsoga. Nel 1790 era medico di camera e nel 1791 primo medico di camera della regina; come tale, nell'ambito della ristrutturazione del Tribunale del Protomedicato, l'istituzione che regolava tutte le professioni sanitarie e esaminava i futuri medici, ne fu nominato vicepresidente, con salario, prerogative e incarichi equivalenti a quelli del presidente, il medico di camera del re, don Francisco Martinez de Sobral, con il quale avrebbe dovuto alternarsi nella direzione effettiva. Inutile dire che il medico più anziano (all'epoca Sobral era sessantenne, mentre il rampante Galinsoga aveva appena 34 anni) non la prese affatto bene, tanto più che mai in precedenza il medico della regina aveva avuto tali privilegi. Ne seguirono tensioni e conflitti di competenza, che il re cercò di risolvere rafforzando la posizione di Galinsoga, che alla fine del 1791 fu nominato intendente dell'Orto botanico di Madrid e protomedico dell'esercito (incarichi fino ad allora tradizionalmente affidati al medico del re). Una decisione destinata ad aumentare le tensioni, più che a sopirle. Era questa la situazione a corte quando Ruiz e Pavon in Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus (1794) pubblicarono i 149 nuovi generi raccolti nella spedizione in Perù, dedicandoli prevalentemente a glorie della scienza e della medicina iberica, di cui volevano dimostrare l'eccellenza. Per non fare torto a nessuno, uno toccò a Galinsoga, un altro a Sobral. Ma se guardiamo alle piante assegnate rispettivamente ai due protomedici rivali, forse non si tratta di una scelta di equidistanza: Galinsoga, lo abbiamo visto, comprende piccole annuali dalle fioriture insignificanti, Sobralia raffinate orchidee dalle fioriture spettacolari. Poco dopo, fu la morte precoce del più giovane (una sintesi biografica nella sezione biografie) a mettere fine alla rivalità e alla vita di Galinsoga, morto a solo quarant'anni nel 1797. Oltre che medico di successo, fu anche insegnante universitario, membro di innumerevoli società scientifiche, membro fondatore della Real Academia nacional de Medicina; tra i suoi meriti, la creazione presso l'Ospedale generale di Madrid dello Studio reale di medicina pratica (1795) dove i futuri medici avrebbero svolto i due anni di praticantato prescritti, che in precedenza erano costretti a svolgere privatamente sotto la supervisione di un medico. Quanto alla sua gestione del Reale orto botanico, non sembra aver lasciato molte tracce; ma la carica di intendente era amministrativa e politica, mentre la reale direzione era nelle mani del primo professore di botanica, all'epoca Casimiro Gomez Ortega. Prima di congedarci da Galinsoga, vale la pena di dedicare qualche riga alla sua unica opera a stampa, il curioso opuscolo Demostración mecánica de las enfermedades que produce el uso de las cotillas, pubblicato nel 1784. Tra gli accessori indispensabili delle dame dell'epoca c'era il corsetto (il modello spagnolo si chiamava cotilla, letteralmente "piccola corazza") in stoffa e stecche di balena, che aveva lo scopo di modellare la figura assottigliando il punto vita e spingendo verso l'alto il seno; stretto da una serie di lacci, obbligava a una postura rigida e impediva parzialmente i movimenti. Nel corso del Settecento, con l'Illuminismo e il Preromanticismo, cominciò tuttavia a diffondersi anche nella moda l'esigenza di una maggiore naturalezza e praticità e il corsetto finì sotto attacco. Ne è un esempio l'articolo scritto nel 1785 da Jean Jacques Rousseau per The lancet. In questa polemica si inserisce perfettamente l'opuscolo di Galinsoga, che, rispetto ad altri critici, i quali fanno spesso appello a considerazioni moralistiche, si muove su un piano strettamente medico. Nella prefazione, egli afferma di poter provare che molte delle infermità di cui soffrono le madrilene sono causate da questa moda funesta; basta paragonare la costituzione debole e asfittica delle dame della corte con la salute robusta, briosa e costante delle popolane delle campagne; la colpa è tutta del corsetto che "tormenta tutte le viscere del basso ventre, le strangola, ne disloca la posizione, e ne muta la forma, tanto che tutte le operazioni di questi organi ne diventano imperfette". Tra le conseguenze, trombosi a causa della cattiva circolazione venosa; neuriti per compressione; sincopi, svenimenti e letargia per difficoltà cardio-respiratorie; ernie e prolassi genitali; difficoltà digestive, nausee, vomiti e indigestioni. Galinsoga si spinge addirittura a accusare i corsetti di provocare alcune malattie veneree: "La leucorrea e la gonorrea semplice sono cattivi inquilini di Madrid, e non si vedono mai tra i contadini". Non parliamo poi delle conseguenze per la prole, decimata dagli aborti o contraffatta nella figura, nuovamente con gli alti e gagliardi montanari contrapposti ai miserevoli madrileni, rattrappiti nel ventre materno dai malefici corsetti a detrimento della nazione iberica.  Soldati galanti in marcia Per concludere, torniamo brevemente sul genere Galinsoga. cui sono assegnate dodici specie diffuse spontaneamente tra Messico, Antille e Sud America. Sono erbacee annuali dal fusto gracile, con foglie opposte da lanceolate a quasi romboidali, con margini interi o serrati, glabre oppure pelose. Le infiorescenze sono capolini di piccole dimensioni, con fiori del disco solitamente gialli, con corolle tubolari a cinque denti, che formano un bottoncino dorato, tutto sommato più appariscente dei fiori del raggio tridentati, bianchi o gialli, minuti e piuttosto radi. A parte le ormai onnipresenti G. parviflora e G. quadriradiata, le altre specie sono solitamente endemismi diffusi in aree circoscritte: ad esempio, G. caligensis è una specie peruviana presente solo nelle regioni desertiche della regione di Lima; G. durangensis è invece originaria degli stati di Durango e Sinaloa nel Messico nordoccidentale; G. formosa vive solo nello stato messicano di Oaxaca. Quest'ultima specie è la miss del genere: i numerosissimi fiori del disco (circa cento) formano una cupola molto rilevata, circondata da 5-15 fiori del raggio gialli, talvolta soffusi di porpora. Tradizionalmente usate nella medicina popolare fresche o in decotto, le galinsoga sono anche commestibili, anzi proprio l'umile G. parviflora è l'irrinunciabile protagonista di alcuni piatti della cucina sudamericana, cui dona un particolarissimo aroma. Un'ultima curiosità: il nome comune inglese di questa specie è gallant soldier, "soldato galante" o "coraggioso", un'etimologia popolare ovvero una reinterpretazione ad orecchio del nome botanico, incomprensibile per i britannici. Per analogia, l'altra specie naturalizzata, la villosa G. quadriradiata, è diventata shaggy soldier, "soldato capellone". Non sembra esserci molto di militaresco nelle Galinsoga, ma è innegabile che questi soldatini più o meno capelluti e ben poco galanti, ma indubbiamente coraggiosi, si sono inesorabilmente messi in marcia. Qualche approfondimento nella scheda. Quando approdarono in Europa a inizio Ottocento, alle orchidee esotiche non mancava nulla per accendere i cuori: erano bellissime, erano rare, si ammantavano di mistero, ed erano pure molto costose, il che alimentava un certo snobismo. Fu così che la fioritura di quella che di lì a poco sarebbe stata battezzata Cattleya labiata segnò l'inizio di una passione collettiva: l'orchidelirium, ovvero il delirio per le orchidee. Nacque persino una nuova professione: quella dei cacciatori di orchidee, inviati a cercarle ai quattro angoli del mondo da ricchi privati o da aziende intraprendenti. Alle aste, le più nuove e le più rare raggiungevano prezzi da capogiro. Per settant'anni la più ambita e ricercata continuò ad essere Cattleya labiata. Fino a fine secolo, molte spedizioni andarono a cercarla a casa sua in Brasile, ma sempre senza esito. Niente di strano che la sua storia sia stata trasformata in leggenda, anzi quasi in una fiaba, con lei, la regina delle orchidee, nelle vesti di Cenerentola e lui, William Cattley, nelle vesti di principe azzurro. Quasi spiace ammettere che la realtà sia molto più prosaica.  Un'imbottitura a sorpresa... o forse no Come tutte le leggende, anche la storia dell'arrivo in Europa e della prima fioritura di Cattleya labiata è stata raccontata in diverse versioni. La più comune vuole che il giovane naturalista John William Swainson (1789-1855) nel 1818 abbia spedito in patria dal Brasile un pacco di piante contenente rari licheni (o felci, secondo un'altra versione); per preservarli nel lungo viaggio, come imbottitura usò una liana o pianta parassita che credeva senza valore. Il destinatario dell'invio era il mercante William Cattley, grande appassionato di piante esotiche che coltivava nella sua serra di Barnet, alla periferia londinese. Aprendo il pacco, in mezzo a quell'ammasso di materiale secco, egli individuò quello che riconobbe come uno pseudobulbo di orchidea; doverosamente coltivato, prosperò e giunse a fioritura, producendo bellissimi fiori lilla, i più belli che mai si fossero visti. Arrivata nelle vesti dimesse di Cenerentola, la sconosciuta si era rivelata una splendida principessa, anzi la regina delle orchidee. Nel 1821, il futuro padre dell'orchidologia John Lindley (1799-1865) la descrisse e la pubblicò con il nome di Cattleya labiata in onore del suo "salvatore". Mi spiace deludervi, ma le cose non sono affatto andate così. Insieme a molte altre piante, tra cui un Oncidium barbatum (oggi Gomesa barbata), la nostra pseudo Cenerentola venne inviata da Swainson non a Cattley, ma a William Jackson Hooker, che all'epoca insegnava botanica all'Università di Glasgow. Swainson l'aveva vista in fioritura e sapeva perfettamente di quale meraviglia si trattasse; appena arrivata, fu trattata con tutte le cure del caso e in quello stesso anno, come riferisce Hooker nel terzo volume di Exotic flora (1827), fiorì nella serra del suo giardino di Halesworth nel Suffolk; Hooker affidò uno o più pseudobulbi all'amico Cattley, noto come infallibile pollice verde, che in effetti riuscì a portarla a fioritura nel novembre 1820; riprodotta per divisione, infine nel 1824 fiorì della serra dell'orto botanico di Glasgow. Benché avessero tutti la stessa origine, la pianta di Cattley emanava un delicato profumo, assente nelle altre. In ogni caso, tanto Lindley quanto Hooker ne erano entusiasti: per il primo era "senza eccezione, la più bella specie del suo ordine che io abbia visto dal vivo", per il secondo "la più splendida, forse, di tutte le orchidacee". Dunque, nella nostra fiaba mancata non c'è né Cenerentola, né principe azzurro: Cattley non salvò la misconosciuta pianta, che non fiorì per la prima volta a casa sua; molto più prosaicamente, era il finanziatore di Collectanea botanica (1821-26), la pubblicazione in cui Lindley la descrisse, dedicandogliela con queste parole: "ho avuto grande piacere a pubblicarla, perché mi ha dato l'opportunità di offrire un omaggio a un gentiluomo il cui ardore nel collezionare e il cui inarrivabile successo nel coltivare la difficile tribù di piante cui appartiene lo rendono da tempo la persona più adatta a questo omaggio". 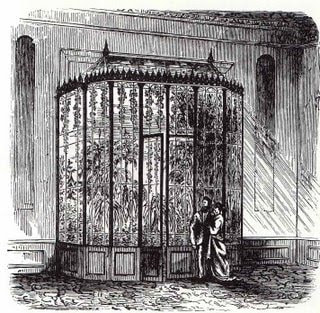 Un collezionista di piante esotiche E' dunque ora di sapere qualcosa di più su di lui. Cattley apparteneva a una grande famiglia di commercianti, con interessi soprattutto in Russia, da dove importava granaglie. Negli anni turbolenti delle guerre napoleoniche, i suoi affari avevano prosperato, permettendogli di dedicare tempo e denaro alla sua grande passione: le piante esotiche. Divenne un collezionista piuttosto noto, il cui nome ricorre in pubblicazioni dell'epoca come Curtis's Botanical Magazine o Edward's Botanical Register, relativamente all'introduzione di nuove specie, che a quanto pare riusciva a far prosperare nella serra della sua casa di Barnet, a nord di Londra. Era membro della Linnean Society e della Horticultural Society, che nel novembre 1820 lo premiò con una medaglia d'argento per la sua abilità nel coltivare le piante esotiche, in particolare per essere riuscito a far fruttificare una nuova specie di guaiava che venne denominata in suo onore Psidium cattleyanum. Anche se le orchidee non erano la sua passione esclusiva, dovettero essere una parte importante della sua collezione: in un'epoca in cui le serre inglesi, secondo le parole dello stesso Hooker, erano la tomba delle orchidee e nulla si sapeva della loro riproduzione e molto poco della loro coltivazione, era uno dei pochi che riusciva a coltivarle con successo. A nostri occhi, il suo merito maggior è di essere stato il mecenate di John Lindley, all'epoca ancora giovanissimo. Poco più che adolescente, il promettente botanico aveva conosciuto Hooker che lo aveva raccomandato a Banks, il quale lo aveva assunto come assistente per il suo erbario. Nel 1820, alla morte di Banks, sempre Hooker - che conosceva bene Cattley perché entrambi erano membri delle stesse società scientifiche nonché accaniti collezionisti che si scambiavano esemplari - gli suggerì di assumere Lindley per riordinare e disegnare le sue collezioni. Per circa un anno, Lindley fu stipendiato da Cattley, che finanziò la pubblicazione di Digitalium Monographia, una monografia sul genere Digitalis illustrata da Bauer, e soprattutto Collectanea Botanica. Contrariamente a quanto si legge in molte fonti anche autorevoli, quest'ultima non è un catalogo delle collezioni di Cattley, ma una rassegna di piante rare coltivate tanto da lui quanto da altri; quelle coltivate a Barnet sono solo 8 su 41. Circa un quarto delle piante trattate sono orchidee (tra di loro la nostra Cattleya labiata); fu proprio grazie a Cattley, alla sua collezione e a questo lavoro che Lindley scoprì il fascino di questa famiglia di piante, cui avrebbe dedicato tutta la vita, divenendo il padre dell'orchidologia. Tuttavia dopo poco più di un anno di collaborazione, la ditta di Cattley ebbe un rovescio di fortuna. Il mercante non poté più finanziare Lindley, e la pubblicazione di Collectanea Botanica venne interrotta; Lindely dovette ridimensionare il progetto e pubblicare gli ultimi fascicoli a sue spese con una notevole dilazione, E' per questa ragione che il fascicolo 7, dove si trova la descrizione di C. labiata, anche se è datato 1821, in realtà fu stampato presumibilmente nel 1824. Quanto a Cattley, sebbene con mezzi ridotti, continuò a curare la sua collezione, visto che il suo nome continua a comparire nei periodici dell'epoca, dove è definito "il più ardente collezionista di piante rare dei nostri giorni". Morì a Londra nel 1835. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Alla ricerca dell'orchidea perduta Nel frattempo, la fioritura di C. labiata aveva destato grande sensazione. Non era certo la prima orchidea esotica a fiorire in Europa (come ho raccontato in questo post, la prima era stata Brasavola nodosa nel 1698), ma non si era mai visto un fiore così appariscente, così raffinato, così esotico, con sepali e petali di un delicatissimo lilla e un grande labello sfrangiato porpora, con la gola giallo profondo. E fu subito orchidelirum, come venne chiamata l'ossessione per le orchidee che travolse l'Inghilterra vittoriana. Vennero organizzate costose e difficili spedizioni nei paesi tropicali (soprattutto in Sud America e nel sudest asiatico) per procurarsi sempre nuove specie. Nacquero ditte specializzate e una nuova professione, quella di cacciatore di orchidee. Alle aste che venivano organizzate a Londra al loro ritorno, quelle più rare raggiungevano prezzi da capogiro, come le 80 ghinee (equivalenti a circa 9000 euro) sborsate da Sigismund Rucker negli anni '40 per una Barkeria spectabilis. Le più ambite erano ovviamente quelle più rare e più difficili da trovare. Ovviamente, in testa alla lista c'era Cattleya labiata, la cui ricerca in natura deluse le aspettative per ben 70 anni. Swainson non aveva rivelato dove l'avesse raccolta e la leggenda fiorita sul suo invio contribuì a confondere i ricercatori. Poiché egli aveva fatto base a Rio, si pensò provenisse da quell'area, dove per anni i cacciatori di orchidee andarono a cercarla senza successo (in realtà, Swainson l'aveva raccolta nel Pernambuco). Nel 1846, destò dunque grande sensazione la pubblicazione di Travels in the Interior of Brazil del chirurgo e naturalista George Gardner (1812-1849) in cui raccontava come l'avesse ritrovata nel 1836 sulle rocce a precipizio sul mare della Pedra de Gavea, a una quindicina di miglia da Rio. Gardener si sbagliava: esaminando i suoi campioni, l'ormai autorevolissimo Lindley decretò che non si trattava di C. labiata, ma di un'altra specie che denominò C. lobata. Nel suo Flower Garden, Joseph Paxton (famoso sopratutto come creatore del Crystal Palace) riprese la notizia, accompagnandola con la versione più nota, potremmo dire ormai ufficiale, del famoso invio di C. labiata come imbottitura. Inutile dire che diverse spedizioni batterono le montagne della foresta di Tujica alla ricerca dell'orchidea perduta, inondando il mercato europeo di centinaia di nuove specie, ma senza mai ritrovarla. Gardner pensò di aver fatto centro durante un secondo viaggio in Brasile, quando credette di averla ritrovata sulle rive del fiume Parabaya, al confine tra gli Stati di Rio e Minas Gerais. Si sbagliava di nuovo: si trattava di C. warneri. Di conseguenza diverse spedizioni setacciarono la regione; inutilmente, tanto che qualche botanico incominciò a pensare che C. labiata fosse ormai estinta in natura. Finalmente, la notizia del ritrovamento, questa volta vero, arrivò nel 1889. E, vero schiaffo all'orgoglio nazionale britannico, il merito andava ai francesi. Monsieur Moreau, un entomologo parigino, aveva finanziato una spedizione entomologica nel Brasile centrale e settentrionale; sapendo che era anche collezionista di orchidee, i raccoglitori gli inviarono anche una cinquantina di piante di un'orchidea dai grandi fiori lavanda raccolte nel Pernambuco. A questo punto, storia e leggenda tornano a mescolarsi: si racconta che, per un'incredibile coincidenza, Frederick Sander (1847-1920), ovvero il re delle orchidee, a capo del vivaio specializzato più importante d'Europa, facesse visita a Moreau proprio mentre le piante iniziavano a fiorire: gli bastò un'occhiata per capire che si trattava della perduta C. labiata. Il francese non ebbe problemi a rivelargli dove era stata raccolta, e Sanders poté inviare i suoi cacciatori a raccoglierla a colpo sicuro. Già nel 1892 fu in grado di immettere sul mercato ben 25.000 esemplari. Ma non manca una versione più romantica, secondo la quale l'orchidea perduta fu ritrovata sempre a Parigi, ma durante una serata mondana, appuntata alla scollatura di una dama.  E infine, Cattleya! Nell'Ottocento, mentre sempre nuovi generi e specie di orchidee si riversavano come un fiume in piena nell'avido mercato europeo, Cattleya mantenne il suo primato di regina delle orchidee. Era il genere più amato, più ricercato, apprezzato soprattutto come fiore reciso per comporre lussuosi bouquet e per ornare scollature. A ostentare una Cattleya non era solo la misteriosa (e presumibilmente inesistente) dama parigina della leggenda, ma anche Odette, la bella demi-mondaine amata da Swann nella Recherche di Proust; il gesto di Swann, che si offre di sistemarle il fiore appuntato sul petto, diventa il preludio al loro primo rapporto sessuale: da quel momento i due amanti lo chiameranno eufemisticamente faire Cattleya, "fare Cattleya". Le circa centoventi specie del genere Cattleya sono orchidee epifite, o più raramente terrestri, originarie delle foreste pluviali dell'America latina, dalla Costa Rica al Brasile. I fiori, raccolti in infiorescenze terminali, hanno sepali e petali liberi; il petalo inferiore è modificato a formare un labello sfrangiato, solitamente di colore contrastante. Sono orchidee simpodiali, con pseudobulbi alla cui estremità si sviluppano una o due foglie. Proprio in base a questa caratteristica, vengono divise in due grandi gruppi: monofoliate e bifoliate. Le prime sono le Cattleyae classiche, piante robuste a forte sviluppo con grandi fiori; le seconde hanno fiori più piccoli, ma spesso forme e colori affascinanti. In coltivazione sono state introdotte almeno una cinquantina di specie, senza contare i numerosissimi ibridi. Il primo si deve a un altro grande collezionista, John Dominy, che nel 1853 incrociò C. loddigesii e C. guttata. Da allora ne sono stati prodotti centinaia e centinaia. Come se non bastasse, Cattleya forma ibridi intergenerici (nothogenera) con altri generi del vasto gruppo di orchidee neotropicali detto Cattleya alliance: i più noti sono Brassavola, Encyclia, Epidendrum, Laelia, Rhyncholaelia, con i quali forma rispettivamente x Brassocattleya, x Catyclia, x Epicattleya, x Laeliocattleya, x Rhyncolaeliocattleya. Tra gli ibridi che coinvolgono tre generi il più noto è senza dubbio Brassolaeliocattleya (Brassavola x Laelia x Cattleya), ma non mancano ibridi ancora più complessi che ne coinvolgono da quattro in su, come Andersonara (Brassavola x Cattleya x Guarianthe x Laelia x Ryncholaelia). Un tempo la coltivazione degli ibridi era rivolta soprattutto al mercato dei fiori recisi, oggi meno importante a favore della vendita come pianta fiorita. Tuttavia Cattleya mantiene un ruolo di una certa importanza anche come fiore reciso grazie alle fioriture indipendenti dalla stagione. Infatti sono piante brevidiurne, che tendono a fiorire quando le giornate si accorciano. Diminuendo artificialmente le ore di luce, possono dunque essere indotte a fiorire in ogni momento dell'anno. Nella scheda notizie sulla classificazione di Cattleya, link selezionati e una selezione di specie notevoli. Con la sua pretesa di rinominare gli esseri viventi secondo il nuovo sistema binominale, Linneo si attirò l'accusa di sfrontatezza e arroganza. Tuttavia, mano a mano che crescevano le adesioni e i seguaci, essere immortalati dal nome di una pianta, ricevendo da Linneo in persona la dedica di un genere, divenne l'aspirazione principale di botanici e "curiosi", come venivano chiamato i dilettanti che sempre più numerosi si innamoravano della botanica grazie alla semplicità del sistema linneano. Ma anche su questo punto le critiche non mancarono: il principe dei naturalisti venne accusato di elargire nomi ad amici e studenti con eccessiva parzialità, sicché si fece assai prudente. Anzi talvolta riluttante, come nel caso del dottor Alexander Garden, medico scozzese trapiantato in South Carolina, che riuscì da aggiudicarsi il prestigioso genere Gardenia solo in seguito a una vera e propria manovra di accerchiamento di un altro linneano, John Ellis. 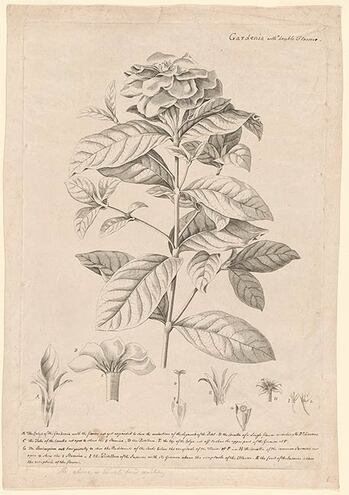 Come una pianta cinese fu scambiata per un gelsomino sudafricano e ebbe il nome di un medico americano I cinesi la chiamavano zhi-zi e la coltivavano da secoli. Con viaggi complicati, che comprendono una tappa nella colonia del Capo in Sud Africa, nel 1754 la varietà a fiori doppi arrivò in Inghilterra e nel 1758 fiorì per la prima volta nella serra del botanico Richard Warner (ca. 1711-1775). Con le lussureggianti foglie verde scuro e i candidi fiori stradoppi dal pervasivo profumo, divenne l'idolo del momento e attorno alla sua classificazione e denominazione scoppiò una disputa botanica. Philip Miller, il cocciuto capo giardiniere del Chelsea Physic Garden, pensò si trattasse di un gelsomino, e la battezzò Jasminum capense, ovvero "gelsomino del Capo di Buona Speranza". John Ellis, mercante e naturalista più che dilettante, non ne era convinto: pensava appartenesse a un genere sconosciuto, e ne inviò un esemplare essiccato a Linneo che confermò il suo parere. Intanto l'abilissimo vivaista James Gordon era riuscito ad averne quattro talee e le aveva moltiplicate con tanto successo che nel giro di pochi anni riuscì a guadagnare 500 sterline, rivendendo le cento piante che ne aveva ricavato. Nel suo vivaio di Miles End la ritrasse il più famoso artista botanico dell'epoca, Georg Dionysius Ehret, etichettandola provvisoriamente con il nome proposto da Miller. Ricevuta la conferma da Linneo, Ellis gli riscrisse proponendogli di battezzare il nuovo genere Warneria in onore del primo proprietario. Questa proposta imbarazzava enormemente Warner, che era amico di Miller e non desiderava contraddirlo; perciò si affrettò a scrivere a sua volta a Linneo, chiedendogli di rifiutarla. Ellis non demordeva e, dopo qualche esitazione, nel 1760 propose a Linneo un nuovo nome: Gardenia, in onore di un amico comune, il medico scozzese Alexander Garden. Anche questa volta Linneo rifiutò: non aveva nessuna intenzione di farsi coinvolgere in queste dispute tra botanici inglesi, inoltre non capiva qualche nesso ci fosse tra Garden e la pianta: non l'aveva né scoperta né coltivata, anzi neppure mai vista. Era disponibile a dedicargli a una pianta americana, ma che aveva mai a che fare con questa sudafricana (che, come noi sappiamo, in realtà era cinese)? Per mesi si dimostrò irremovibile, scrivendo tra l'altro: "Desidero tutelarmi dalle malevole obiezioni, tanto spesso sollevate contro di me, di chi mi accusa di battezzare le piante con i nomi di miei amici che non hanno dato alcun pubblico contributo al progresso della scienza". Alla fine Ellis mise Linneo di fronte al fatto compiuto: gli scrisse che Garden era già stato messo al corrente della dedica e che, al di là dell'Atlantico, la pianta era ormai nota come Gardenia. Poi la pubblicò lui stesso nelle Transactions della Royal Society. Linneo, che non desiderava esautorare il suo principale sostenitore in Inghilterra, che oltre tutto proprio in quei mesi aveva accolto ospitalmente Solander, dovette abbozzare, In questo modo contorto la bella zhi-zi ricevette il nome botanico Gardenia jasminoides J. Ellis.  Uno scrupoloso ricercatore linneano E' ora di fare la conoscenza con l'inconsapevole oggetto umano di quella disputa, il dottor Alexander Garden, che - a posteriori - confermò che tanto onore non era stato immeritato. Scozzese, aveva studiato medicina a Edimburgo; nel 1752, essendosi ammalato di tubercolosi, nella speranza di un clima più propizio si trasferì a Charleston in South Carolina, dove esercitò la professione medica per molti anni. Come studente di medicina, aveva cominciato a studiare botanica in patria seguendo i sistemi di Ray e Tournefort; ma quando arrivò in Carolina, da una parte fu affascinato dalla varietà della flora di quella regione benedetta dalla natura, dall'altra fu frustrato dalla sua incapacità di ricondurre le specie non ancora descritte a quei complicati sistemi. In queste ricerche, dichiarerà più tardi, gettò via tre anni. Anche la sua salute non trovò il giovamento sperato. Dopo un anno di clima particolarmente avverso, nel 1754 decise di fare un viaggio a nord. Capitò così a New York, dove fu ospite Cadwallader Colden e di sua figlia Jane (la prima botanica americana), che gli misero a disposizione la loro biblioteca; su quegli scaffali, Garden trovò il suo santo Graal: Flora virginica di Gronovius, nonché Classes plantarum e Fundamenta botanica, due delle prime opere di Linneo. Passò poi da Philadelphia, dove incontrò John Bartram appena rientrato dalla sua escursione nelle Catskill mountains. Al suo ritorno in Carolina, Garden ebbe egli stesso occasione di conoscere più da vicino la selvaggia natura americana, visitando le Blue Montains in qualità di medico della missione incaricata di cercare l'alleanza dei Cherokee contro la Francia. Tornato poi a Charleston, si mise a studiare le opere di Linneo, e, come d'incanto, tutto quello che gli era rimasto oscuro, si chiarì: il cristallino sistema sessuale gli fornì il filo d'Arianna che cercava e si convertì in un fervente seguace del luminare svedese. Nel marzo 1755 osò scrivere al suo idolo una prima lettera, che rimase senza risposta. Solo dopo tre anni (e dopo molte lettere senza risposta) Linneo si degnò infine di rispondergli, iniziando una duratura e feconda corrispondenza. Il grande svedese non era l'unico corrispondente di Garden; l'ambiente in cui viveva, così ricco di specie da scoprire, era invece assai povero di naturalisti, tanto da fargli scrivere: "qui non c'è anima viva che conosca anche solo una iota di storia naturale". Iniziò così a corrispondere con moltissimi naturalisti al di qua e al di là dell'Oceano, come Colden, Bartram, Gronovius, Collinson, e soprattutto John Ellis, che divenne anche il suo principale intermediario con Linneo. Era a lui che inviava gli esemplari di piante e animali che andava raccogliendo nelle escursioni che alternava alla pur molto impegnativa attività di medico. Era un linneano così fervente che, quando Ellis gli propose di pubblicare alcune specie da lui scoperte sulle Transactions della Royal Society, rifiutò, perché avrebbe dovuto scriverle in inglese, mentre Linneo usava solo il latino. Il suo sogno era scoprire un genere sconosciuto, e che magari Linneo gli desse il suo nome. Dapprima credette di aver fatto centro quando gli inviò una pianta che propose di denominare Ellisia in onore dell'amico comune; ma Linneo lo disilluse, determinandola come Swertia difformis (oggi Sabatia difformis). E quando fu il turno di un nuovo tipo di storace, lo deluse di nuovo preferendo dedicarla, su suggerimento di Ellis, con il nome di Halesia a uno studioso ben più illustre di lui, il reverendo Stephen Hales. Il successo sarebbe arrivato solo nel 1765, con la scoperta di ben due nuovi generi; ma ormai Gardenia gli era già dedicato, ed essi furono battezzati Fothergilla e Stillingia, in onore rispettivamente di John Fothergill e Benjamin Stilling-Fleet. Il suo contributo alla scoperta del primo è comunque ricordato dal nome specifico Fothergilla gardenii. Più ancora che alle piante della Carolina, Linneo era però interessato agli insetti, ai rettili e agli anfibi di quella regione che sapeva ricca di specie sconosciute. Garden accondiscese alle sue richieste e da botanico diventò zoologo, inviando a Uppsala le sue eccellenti descrizioni dal vivo e dozzine di esemplari perfettamente conservati nel rum. Sono così almeno una trentina le specie di anfibi, rettili e pesci descritti in Systema naturae la cui scoperta si deve a Garden. La più nota di tutte è Siren lucertina, un anfibio anguiforme che gli sembrava intermedio tra una lucertola e un'anguilla. Qualche anno più tardi, nel 1774, Garden ebbe occasione di studiare le proprietà elettriche di alcune "anguille" giunte vive a Charleston dal Suriname. Le sottopose ad esperimenti ed inviò le sue osservazioni alla Royal Society di Londra, insieme a un esemplare vivo e ad alcuni esemplari perfettamente conservati sotto alcool, di cui John Hunter poté così studiare gli organi elettrici. L'anno prima, Garden aveva ottenuto l'ammissione alla Royal Society. Allo scoppio delle ostilità tra la Gran Bretagna e le colonie, si schierò con i lealisti. Nel 1781 le sue proprietà furono confiscate e due anni dopo ritornò in patria, stabilendosi nei pressi di Londra. Molto rispettato per "la sua benevolenza, la sua allegria, e le sue buone maniere", divenne vicepresidente della Royal Society. Morì di tubercolosi nel 1791. Una sintesi biografica nella sezione biografie.  Gardenia, un fiore da leggenda Con circa 150-200 specie di arbusti e alberi sempreverdi diffusi nell'Africa e nell'Asia tropicale e subtropicale, il genere Gardenia è uno dei più notevoli della famiglia Rubiaceae. La specie più nota è indubbiamente G. jasminoides, tanto apprezzata per la sua bellezza e il suo profumo, quanto famigerata per la sua capricciosità. Croce e delizia dei giardinieri, è una pianta mitica, simbolo di bellezza, lusso e seduzione: era il fiore preferito di Sigmund Freud, i dandies francesi della fin du siècle la portavano all'occhiello e Billie Holiday ne appuntava tre alla chioma, tanto da essere soprannominata la "gardenia bianca del jazz"; la scelgono le spose per i loro bouquet, i bar Tiki la ostentano riunite in corone e le usano come ingrediente segreto dei cocktail. Oltre a una celebre rivista di giardinaggio, presta il suo nome a decine di ditte, esercizi commerciali, prodotti di bellezza, associazioni sui temi più vari. In giardino ne sono state selezionate innumerevoli varietà; già la forma doppia a tutti famigliare è frutto della selezione orticola millenaria in Cina, dove è stata preferita alla originaria forma a fiore semplice. Oggi si punta sempre più su quelle un po' più rustiche e meno schizzinose, come G. jasminoides radicans, di dimensioni minori, capace di sopportare l'inverno all'esterno, oppure 'Crown jewel', rustica fino a -10 gradi. Tuttavia, non c'è solo G. jasminoides. Al contrario di questa cinese entrata nella storia della botanica travestita da sudafricana, arriva davvero dalle foreste della regione del Capo G. thumbergia, la seconda specie a giungere in Europa intorno al 1773 grazie a Thunberg e al suo amico Masson. Arriva invece dall'India G. latifolia, un vero piccolo albero, apprezzato non solo per l'ombra offerta dalla densa chioma sempreverde e i fiori, ma anche per i frutti eduli, ampiamente coltivato nel subcontinente e introdotto in molte zone dell'Africa. Numerose sono le specie originarie delle isole del Pacifico, uno dei principali centri di diversità; tra di esse G. taitensis, che fu raccolta per la prima volta a Tahiti durante la seconda spedizione di Cook, uno dei fiori simbolo delle isole, molto apprezzato in profumeria. E non tutte le gardenie hanno fiori bianchi: ad esempio, l'asiatica G. tubifera ha corolle giallo oro. Qualche approfondimento sulle "altre gardenie" nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
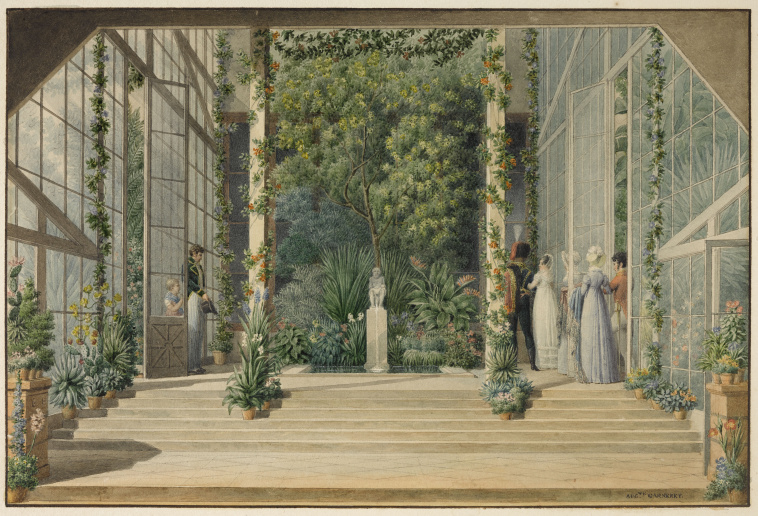

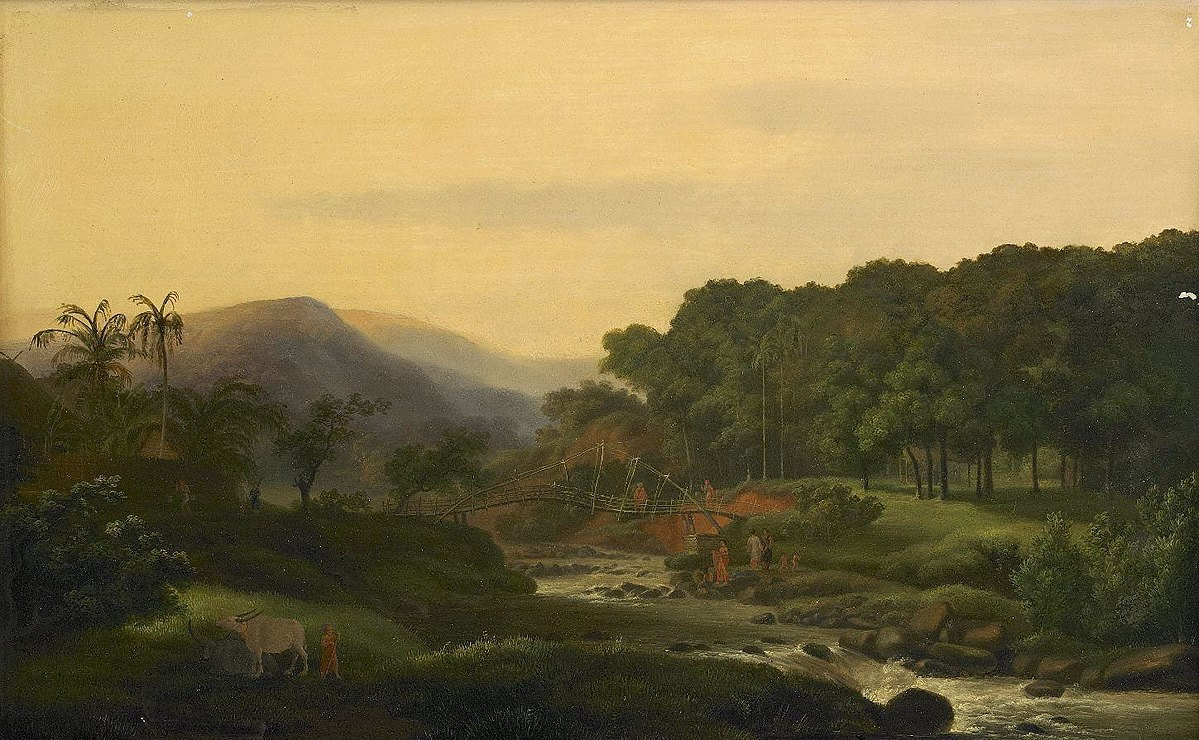

 RSS Feed
RSS Feed