|
Joséphine de Beauharnais, ovvero l'imperatrice Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, è nota per la passione per la botanica, che profuse nella creazione dello splendido parco del castello di Malmaison, successivamente residenza dei Bonaparte negli anni del consolato, poi casa di campagna e rifugio in quelli dell'impero, infine, dopo il divorzio, la sua casa, la sua consolazione, il luogo dove morì. Dotato di una serra calda all'avanguardia, fu funzionale all'introduzione in Francia di quasi duecento specie esotiche, soprattutto australiane. Per tutti, Joséphine è anche l'imperatrice delle rose, che certamente amava, ma probabilmente non di quell'amore esclusivo che le attribuisce il mito. A ricordarla contribuisce anche la splendida e capricciosa Lapageria (dal suo nome da ragazza, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie). Un parco all'inglese Il noto motto latino nomen omen, "nel nome c'è il destino", almeno a Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (1763-1814) parrebbe calzare. Fino a quando Napoleone Bonaparte la ribattezzò con il nome con cui è passata alla storia, per tutti fu Rose, un nome che preannunciava l'importanza che nella sua vita ebbero le piante, comprese le rose. Quando si incontarono per la prima volta in un salotto parigino, lei era Mme Rose de Beauharnais. Lui aveva 26 anni, lei 32, e aveva già alle spalle una vita tumultuosa e molto chiacchierata. Era nata in Martinica nella piantagione di una famiglia nobile ma impoverita; poi, ad appena 16 anni, erano arrivati il matrimonio con un nobile dissipatore e femminiere, prima dei vent'anni un figlio e una figlia, quindi la separazione, il carcere durante il terrore, la vedovanza in seguito all'esecuzione del marito Alexandre de Beauharnais. E debiti, tanti debiti, e amanti veri o presunti. L'ultimo, quello in carica al momento, si diceva fosse Paul Barras, uno dei cinque direttori. Che, secondo una delle varie versioni, sarebbe anche colui che presentò ufficialmente la bella vedova a Napoleone, che aveva appena nominato generale per essersi distinto nella repressione di un'insurrezione monarchica. Fu l'inizio di un amore appassionato da parte di lui - un po' meno da parte di lei - che sfociò nel matrimonio il 9 marzo 1796, due giorni prima che Bonaparte partisse per la Campagna d'Italia. Rose non era più Rose, ma Joséphine, come Napoleone l'aveva ribattezzata a partire dal suo secondo nome, forse per rifarla propria e cancellare quel passato tanto chiacchierato. E mentre Napoleone diventava Napoleone, Joséphine aveva finalmente un giardino. Nell'aprile 1799, mentre il marito era impegnato nella Campagna d'Egitto, ricorrendo a un prestito - era abituata a fare debiti - acquistò per 325.00 franchi il castello e la tenuta di Malmaison, a una dozzina di km da Parigi. Al suo ritorno Bonaparte andò su tutte le furie per quella spesa folle, ma, dopo il colpo di stato del 18 brumaio che lo rese padrone della Francia, si addossò il debito, forse attingendo al denaro predato in Italia ed estese addirittura il parco dagli iniziali 60 a 260 ettari. Anche per lui, Malmaison divenne la casa del cuore e per tutto il consolato ne fece la propria residenza; tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuilerie, fu addirittura la sede del governo. Joséphine era decisa a trasformare la tenuta "nel giardino più bello e curioso d'Europa, un modello di buona coltivazione". Inizialmente i lavori vennero affidati agli architetti Percier e Fontaine, che, oltre a restaurare il castello (loro avrebbero voluto abbatterlo e ricostruirlo, ma Napoleone optò per una più economica ristrutturazione), nel 1801 incominciano a recintare il parco, costruirono strutture di servizio come stalle per i cavalli e padiglioni di guardia, eressero il cancello principale e, per le piante di Joséphine, una orangerie riscaldata in grado di produrre 300 piante di ananas. Tuttavia presto emersero contrasti con Mme Bonaparte, che considerava il loro gusto in fatto di giardini troppo classico; desiderava un giardino all'inglese di gusto romantico e paesaggistico. Si rivolse così ai due guru del giardino all'inglese in Francia, lo scozzese Thomas Blaikie, che aveva disegnato il giardino di Bagatelle per il conte d'Artois, e Jean-Marie Morel, autore dell'influente Théorie des Jardin (1777). Morel costruì uno chalet svizzero, una stalla per le mucche, una latteria e una casa per i vaccari fatti venire dalla Svizzera e iniziò la costruzione della serra riscaldata (Grande serre chaude), completata nel 1805 da Thibault e Vignon. Costruita secondo i criteri più avanzati dell'epoca, era la prima in Francia a prevedere una così ampia superficie in vetro; lunga circa 50 metri e larga 19, era riscaldata da 12 stufe e poteva ospitare piante alte fino a 5 metri. La serra era addossata a un elegantissimo padiglione con una serie di salotti e una rotonda centrale raffinatamente arredati in cui era possibile riposarsi, intrattenersi ed ammirare piante rare e una collezione di vasi greci. Neppure Morel soddisfaceva del tutto il gusto romantico della ormai imperatrice (fu incoronata dallo stesso marito e congiuntamente a lui il 2 dicembre 1804); alla fine del 1805 gli subentrò Louis-Martin Berthault, in cui Joséphine trovò quasi un'anima gemella che l'avrebbe servita fino alla morte. Egli costruì una nuova galleria per ospitare le collezioni d'arte e a partire dal 1807 ridisegnò completamente il parco, creando un parco chiuso di 70 ettari perfettamente integrato nel paesaggio, con gli alberi disposti in modo da permettere allo sguardo di spaziare su monumenti già esistenti come l'acquedotto di Marly o il castello di Saint Germain. Berthault disegnò sentieri serpeggianti, fece scavare un corso d'acqua sinuoso che si allargava a formare un laghetto e disseminò il parco di edifici di gusto romantico: il Tempio dell'amore, il tumulo funerario della Malinconia, una grotta con rocce fatte venire da Fontainbleau. Tutte cose che facevano impazzire l'imperatrice, ma non l'imperatore, che le definiva sprezzantemente niaiseries "stupidaggini", e volle per sè un angolo di gusto più classico. Per ospitare gli animali giunti dall'Australia - li ritroveremo tra poco - c'erano una voliera e uno zoo; alla fattoria si aggiuns un allevamento modello di pecore merino. 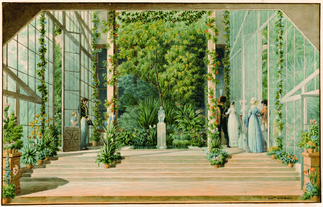 Le piante e gli uomini di Malmaison Fin dall'acquisto di Malmaison, Joshéphine era intenzionata a popolarne il parco e le serre con una collezione unica di piante esotiche. In primo luogo, forse già dalla primavera del 1800, si rivolse a André Thouin, il capo giardiniere del Jardins des Plantes che, oltre ad essere il massimo esperto di acclimatazione di esotiche in terra di Francia, negli anni aveva costruito un'immensa rete di corrispondenti che includeva botanici, giardinieri, vivaisti e collezionisti sia nel paese sia all'estero. In una lettera dell'agosto 1800, firmata Lapagerie Bonaparte, la futura imperatrice lo ringrazia per l'invio di frutti di fico-banana (Ficus pleurocarpa) che "mi hanno ricordato il paese natale e mi hanno dimostrato che siete capace di trionfare di ogni clima e di portare ogni cosa a perfezione". Scrisse anche alla madre, che continuava a vivere in Martinica; in una lettera del 1802 leggiamo: "Mandatemi tutti i semi d'America e tutti i frutti: batate, babane, aranci, manghi, infine tutto ciò che potrete". Thouin la mise in contatto con Jacques Martin Cels (1740-1806), un collezionista che, rovinato dalla rivoluzione, aveva trasformato la sua passione in professione, aprendo a Montrouge, nella periferia sud di Parigi, un vivaio in cui coltivava soprattutto piante americane introdotte da André Michaux. Il suo lavoro fu continuato dal figlio François (1771-1832) che allargò il vivaio e si specializzò nella coltivazione di esotiche ornamentali; nel suo catalogo del 1817 troviamo, accanto alle americane, anche molte sudafricane, dalie, e una notevole collezione di rose, circa 200 varietà, principalmente Gallica. Sicuramente il vivaio Cels fu uno dei principali fornitori di Malmaison, anche per le rose (ma su questo tornerò più avanti), insieme a quello di un altro contatto di Thouin, Louis Claude Noisette (1772-1849). Figlio di un giardiniere del conte di Provenza, intorno al 1798 aveva aperto un vivaio dove coltivava soprattutto piante americane, ottenute attraverso uno dei suoi fratelli, Philippe Stanislas, che viveva a Charleston. Uno dei suoi invii è Old Blush Noisette, la prima delle rose Noisette; ma giunse in Francia nel 1814, troppo tardi per essere coltivata a Malmaison. Joséphine ottenne molte piante dal Jardin des Plantes, e molto lo acquistò dai vivai, spendendo somme folli; è del marzo 1804 una consegna di 2014 tra erbacee, alberi e arbusti. Seppe inoltre approfittare del potere del marito; piante le giunsero dai botanici che accompagnarono Napoleone in Egitto e durante le campagne napoleoniche; in Italia come a Vienna, piante furono requisite dai giardini degli sconfitti per essere inviate a Malmaison. L'imperatore sollecitava diplomatici, ufficiali di marina e funzionari ad approfittare di ogni occasione per soddisfare la passione botanica della moglie e Joséphine stessa faceva pressione su ministri, dignitari, agenti francesi all'estero. Ad arricchirne il parco e le serre di piante in precedenza mai viste in Europa fu però soprattutto la sventurata spedizione Baudin, sponsorizzata da Napoleone primo console, ed in particolare il ricco carico del Géographe, che raggiunse Lorient nel marzo 1804. Napoleone aveva ordinato che il giardino di Malmaison avesse la precedenza sul Jardin des Plantes e quando Thouin ispezionò il carico, scoprì di essere già stato preceduto da Mirbel, il sovrintendente di Malmaison; così, delle 230 piante sopravvissute al tumultuoso viaggio, le 98 più sane presero direttamente la strada delle serre di Joséphine. Insieme a loro viaggiavano anche canguri, emù e una coppia di cigni neri, che divennero quasi un simbolo del giardino dell'imperatrice. Da quel momento, d'un colpo le serre di Malmaison ospitarono la più importante collezione europea di piante australiane, più ricca di quella degli stessi Kew Gardens. Per altro, le piante inglesi o importate dai britannici non mancavano. Come ho già raccontato parlando del vivaio Lee & Kennedy, a partire dal 1803 The Vineyard divenne il maggiore fornitore dei giardini dell'imperatrice; grazie alla compiacenza di Banks, con il quale Joséphine era in contatto attraverso il botanico Etienne Ventenat, ottenne anche alcune piante di Kew e soprattutto un passaporto che permise a Kennedy di continuare a fare la spola tra Francia e Inghilterra con i suoi carichi di piante nonostante lo stato di guerra e il blocco continentale. Con Kennedy, Joséphine creò addirittura un consorzio per inviare in Sudafrica il cacciatore di piante James Niven. Joséphine seppe anche circondarsi di personale molto qualificato. Nel 1801 ingaggiò un giardiniere scozzese, Alexander Howatson; in tempo di guerra, avere un dipendente britannico spiaceva assai a Napoleone, che nel 1805 approfittò del conto troppo salato di un trasporto di piante per licenziarlo. Egli fu così sostituito da Felix Delahaye, che era stato il giadiniere della spedizione Entrecasteaux, durante la quale aveva fatto estese raccolte; aveva poi lavorato per un certo periodo nel giardino di Pamplemousses a Mauritius e dopo il ritorno in Francia aveva restaurato i giardini del Trainon e il vecchio giardino di Maria Antonietta a Versailles. Era dunque un esperto di coltivazione di esotiche e, soprattutto, era forse l'unico giardiniere europeo ad avere visto le piante australiane in natura e molte le aveva raccolte lui stesso. Abbiamo già incontrato di passaggio due dei botanici che lavorarono per Joséphine a Malmaison, Mirbel e Ventenat. Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854) ad appena vent'anni era diventato assistente naturalista al Muséum ed era un promettente scienziato, destinato a diventare il padre fondatore della citologia; nel 1803 Mme Bonaparte lo assunse come sovrintendente di Malmaison, dove poté continuare i suoi studi sui tessuti vegetali, l'evoluzione degli organi delle piante e le epatiche del genere Marchantia. Nel 1806 però egli lasciò Malmaison per entrare al servizio del re d'Olanda Luigi Bonaparte, che oltre ad essere fratello di Napoleone, era anche genero di Joséphine in quanto marito di sua figlia Hortense Beauharnais. A sostituirlo fu Etienne Pierre Ventenat (1757-1808). Fratello di Louis Ventenat, cappellano e naturalista morto durante la spedizione Entrecasteaux, era entrato nell'orbita dell'imperatrice grazie a Cels. Allievo e collaboratore di L'Héritier de Brutelle, in gioventù si era segnalato per la traduzione in francese di Genera plantarum di Antoine Laurent de Jussieu, poi, come il suo maestro, aveva focalizzato la sua attenzione sulla pubblicazione di piante nuove per la scienza. Nel 1799 pubblicò Descriptions des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels, illustrato da 100 tavole in gran parte dovute ai fratelli Pierre-Joseph e Henri-Joseph Redouté. La raffinatezza di quest'opera attirò l'attenzione di Joséphine che volle qualcosa di simile per far conoscere al mondo le proprie collezioni di cui era estremamente fiera. Commissionò così a Ventenat i testi e Pierre-Joseph le illustrazioni del magnifico Jardin de Malmaison; in due tomi, usciti in 20 fascicoli tra l'aprile 1803 e il novembre 1805, comprendo 120 calcografie a colori incise da Allain a partire da acquarelli di Redouté e la descrizione di 161 specie, molte delle quali nuove per la scienza, scritta da Ventenat. Come ho anticipato, nel 1806 Ventenat fu nominato intendente e prese così sul serio l'incarico da morire, esausto di fatica, appena due anni dopo. A succedergli fu Aimé Bonpland, che era stato compagno di Humboldt nel suo viaggio sudamericano. Egli curò tra l'altro i testi di Descriptions des Plantes Rares Cultivées à la Malmaison (1812-1817), anch'esso illustrato da Redouté. Anche questo grande artista, soprannominato il "Raffaello dei fiori", può essere annoverato tra gli uomini di Joséphine. Oltre alle due opere già citate, i fiori di Malmaison ispirarono il suo capolavoro, Les Liliacées; pubblicato in 8 volumi di grande formato, usciti tra il 1802 e il 1816, comprende 486 incisioni a colori di altrettante specie di bulbose e monocotiledoni (non solo Liliaceae in senso stretto). Joséphine riuscì a convincere il ministro dell'interno Chaptal ad acquistarne 80 copie che furono distribuite tra dignitari e biblioteche in tutto il paese e all'estero. L'altro libro più noto di Redouté, Les Roses (1817-1824) fu creato dopo la morte dell'Imperatrice e ritrae rose coltivate in vari giardini francesi, non solo a Malmaison. Furono invece commissionate da Joséphine intorno al 1812 al pittore Auguste Garneray le 12 vedute del parco e della serra, oggi un documento inestimabile per ricostruirne l'aspetto. Essi infatti non sopravvissero a lungo alla loro creatrice, Nel 1809, essendo chiaro che, per la sua età, Joséphine non gli avrebbe mai dato un erede, Napoleone si decise a chiedere l'annullamento del matrimonio, sancito nel gennaio 1810. Fu però generoso con la ex moglie, con cui mantenne rapporti cordiali: essa conservò il titolo di imperatrice, cui si aggiunse quello di duchessa di Navarre (dal castello in Normandia che le donò dopo il divorzio, un po' per compensarla, un po' per tenerla lontana da Parigi mentre si celebrava il suo matrimonio con Maria Luigia d'Asbrugo), ottenne la piena proprietà di Malmaison e una pensione di 5 milioni di franchi. Mentre si completavano i lavori di adattamento per ospitare la sua piccola corte di quasi 200 persone, Joséphine visse a Navarre, poi tornò a Malmaison, che continuò ad accrescere ed abbellire fino alla morte. Il 29 maggio 1814 vi morì di polmonite. Si dice l'avesse contratta passeggiando nel parco con lo zar Alessandro, che avrebbe implorato di permetterle di unirsi al marito nell'esilio all'Elba. Quando Napoleone seppe della sua morte, si chiuse per due giorni nella sua camera; dopo la disfatta di Waterloo, prima di consegnarsi agli inglesi, risiedette a Malmaison che, però, senza la sua Joséphine, non era più la stessa. Poi iniziò la decadenza. L'imperatrice aveva lasciato debiti imponenti, riscaldare la serra era troppo costoso e le piante esotiche, abbandonate a se stesse, morirono; la casa e il giardino furono saccheggiati e vandalizzati; la proprietà fu parcellizzata e messa in vendita. Dopo diverse vicissitudini, nel 1903 il castello e il parco, ridotto a 6 ettari, passarono allo stato e divennero un museo. 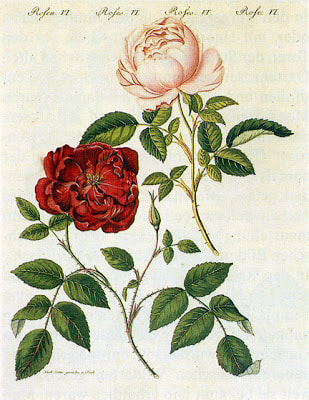 E finalmente... le rose Il parco di Malmaison non era un orto botanico, con le piante disposte in modo sistematico, ma un giardino di piacere. Era anche un giardino sperimentale dove vennero acclimatate piante che poi avrebbero profondamentro modificato i giardini e il paesaggio francese. Secondo L'impératrice Joséphine et les sciences naturelles (catalogo della mostra tenutasi a Malmaison nel 1997), le piante che vi furono coltivate per la prima volta in Francia tra il 1804 e il 1814 ammontano a 184. La corrispondenza tra l'intendente Mirbel e il prefetto delle Alpi Marittime Marc Joseph Dubouchage attesta l'invio in Costa azzurra di numerose piante soprattutto australiane acclimatate a Malmaison; tra di esse, Casuarina equisetifolia, Phormium tenax, varie specie dei generi Eucalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, cui forse va aggiunta Acacia dealbata, la mimosa oggi onnipresente, che fiorì per la prima volta a Malmaison nel 1811. A fare da tramite all'introduzione di queste e altre specie esotiche nella Francia meridionale, il cui clima mite era considerato il più propizio all'acclimatazione di piante tropicali e subtropicali, fu il giardino di acclimatazione creato nel settembre 1801 nel recinto della Scuola centrale del dipartimento delle Alpi marittime a Nizza. E poi, naturalmente, c'è il capitolo rose. Ne ho già parlato in questo post, e qui mi limito a riassumere le informazioni principali. Secondo la vulgata erano le piante preferite di Joséphine che ne avrebbe fatte coltivare ben 250 varietà; molti si spingono anche a dire che, insoddisfatta delle rose europee non rifiorenti, avrebbe incoraggiato l'introduzione di rose cinesi e le ibridazioni che avrebbero portato alla nascita delle rose moderne. Altri parlano di migliaia di rose (peccato che nessuno delle persone che visitò quel giardino poco dopo la morte della imperatrice ne faccia parola e proprio le rose manchino le vedute di Garneray). In realtà, Joséphine era interessata in generale alle piante, specialmente esotiche, e non aveva una speciale predilezione per le rose; certamente a Malmaison non mancavano, ma non è neppure certo che ci fosse un roseto; molte delle piante più preziose erano infatti coltivate in vaso, ed esposte all'esterno al momento della fioritura. Purtroppo, mentre i cataloghi di Ventenat e Bompland documentano bene le esotiche coltivate nella serra e in giardino, non possediamo niente di simile per le rose. Come ho anticipato, Les roses di Redouté, che molti considerano un catalogo delle rose di Malmaison, fu scritto solo dopo la morte dell'imperatrice e ritrae le rose coltivate in vari giardini e vivai francesi che Redouté e Thory, l'autore dei testi, visitarono e citarono scrupolosamente; i giardini dp Malmaison sono ricordati solo per due rose, R. berberifolia e R. gallica. Questo equivoco è probabilmente all'origine della leggenda del roseto di Malmaison, nonchè dei vari pretesi elenchi delle rose che vi erano coltivate. Rimandando al post già citato per le specie sicuramente identificate, molte delle quali importate dall'Inghilterra attraverso Kennedy e altri vivai, vorrei qui aggiungere solo qualche informazione sui fornitori parigini. Presumibilmente il principale era André Dupont, che non fu mai un giardiniere di Malmaison come spesso si legge, anzi neppure un vivaista, ma un collezionista privato; prima della rivoluzione era il custode (e non il giardinere) del palazzo di Lussemburgo. Secondo il suo biografo V. Darkenne, incominciò a interessarsi di rose intorno al 1785, quando affittò un piccolo terreno dai monaci cerctosini nel pressi del Lussemburgo. Durante il Terrore fu imprigionato due volte e per quattro volte, per salvarla, dovette spostare la sua collezione di rose. Nel 1796, la sistemò nell'amgolo orientale del giardino del Lussemburgo, con le rose classificate per specie; nel 1801, la sua collezione (la chimava "éecole de roses"), di specie tanto native quanto esotiche, era la più completa d'Europa. Secondo la testimonianza di Antoine Laurent de Jussieu, Joséphine si rivolse a Dupont per chiedergli di rifornire di rose Malmaison ed egli accettò, come attestano le fatture (che purtroppo non indicano di quali vareità si trattasse). Darkenne stima che nel 1806 gliene abbia fornite da 200 a 500, presumibilmente più di un esemplare per varietà, visto che nel catalogo delle rose coltivate da Dupont nel 1813 (pubblicato da Thory nel 1819, Catalogo inedito Rosarum quas Andreas Du Pont in horto suo studiose colebat anno 1813) ne sono elencate 218. La collezione di Dupont comprendeva numerose rose botaniche europee, un'ampia selezione di alba, centifolia, damascena e soprattutto gallica (una sessatina, pochissime esotiche e qualche cinese, l'unica delle quali identificabile con certezza è la rosa di Macartney (R. bracteata, introdotta in Europa intorno al 1795). Dupont è considerato un pioniere dell'ibridazione artificiale delle rose e a volte gli viene attribuita la creazione di un numero impressionante di ibridi. In realtà nel catalogo compaiono solo 19 ibridi di gallica, non necessariamente tutti creati da lui. Come collezionista, riceveva rose da tutta Europa; come abbiamo visto in questo post, fu lui a introdurre la rosa Portland dall'Inghilterra; potremmo aggiungere 'Belle Sultane', che invece importò dall'Olanda. Gli ibridi di Gallica erano all'epoca le rose più alla moda ed è probabile che ce ne fossero parecchi tra quelle fornite all'imperatrice; lo stesso varrà anche per un altro probabile fornitore, Cels; il catalogo pubblicato da Cels figlio nel 1817 (Catalogue des arbres, arbustes, et autre plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre) offre circa 170 varietà di rose; una buona percentuale sono ibridi recenti dai nomi evocativi ('Belle sans flatterie', 'Panachée admirable'. 'Roi des pourpres') di cui si è per lo più persa ogni traccia. Ovviamente non ne conosciamo il pedigree; è invece giunta fino a noi R. celsiana (nel catalogo figura come grande Cels), un vigoroso ibrido di damascena. Abbiamo già visto che a Malmaison non potevano esserci rose Noisette, essendo la prima giunta in Francia dopo la morte dell'imperatrice. E lo stesso vale per le rose Boursault. Jean-François Boursault detto Malherbe era un ex attore che con la rivoluzione si era dato alla politica e agli affari, accumulando una grande ricchezza che investì tra l'altro in uno splendido giardino con tanto di serre calde. Forse potrebbe aver ceduto a Joséphine una talea della cinese Rosa multiflora carnea, che fu il primo a introdurre in Francia nel 1808, ma non Rosa banksiae 'Alba plena', giuntagli nel 1817, nè il primo ibrido Boursault, ottenuto nel 1818 incrociando R. pendulina non con una cinese, come si è creduto a lungo, ma con la nordamericana R. blanda. Quali e quante fossero le rose coltivate a Malmaison, in assenza di documenti, non lo sapremo mai. Ma anche se il roseto di Joséphine fosse un mito, da più di un secolo è diventato realtà. Nel 1911, dopo che quanto rimaneva del parco era stato donato allo stato, il compito di ri-crearlo venne affidato a Jules Graveraux, il creatore della Roseraie de L'Haÿ; egli, consultando i cataloghi dell'epoca, individuò 197 specie e cultivar disponibili ai tempi dell'imperatrice e ne fece dono al giardino; il suo elenco comprendeva 107 galliche, 27 centifolia, 3 muscose, 9 damascene, 22 bengalesi (ovvero cultivar di R. chinensis), 4 spinosissime, 8 alba, 3 lutee, 1 moscata e le specie alpina, arvensis, banksiae, carolina, cinnamomaea, clinophylla, glauca, laevigata, rugosa, sempervirens e setigera. Certamente è un falso storico, ma almeno su un punto anche oggi siamo d'accordo: Gravereux correttamente privilegiò le galliche, che erano ancora le rose più coltivate, come risulta anche dai cataloghi di Dupont e Cels. In occasione del bicentenario della scomparsa dell'imperatrice, il roseto è stato restaurato e ospita oggi 750 rose del Primo e del Secondo Impero.  Una bella capricciosa A Joséphine de Beauharnais, creatrice di un magnifico giardino, patrona delle arti e della scienza, ma soprattutto moglie di un uomo che per un quindicennio fu il più potente d'Europa, non mancarono gli omaggi botanici, di sapore innegabilmente cortigiano. Nel 1802, quando Mme Bonaparte era ancora la "consulesse", Ruiz e Pavon dedicarono congiuntamente a marito e moglie, rispettivamente, Bonapartea e Lapageria; mentre la dedica a Napoleone (ne parlo qui) è un capolavoro di adulazione, quella a Joséphine è relativamente sobria: "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Ventenat volle anche lui omaggiare con la dedica di un genere colei che in definitiva era la sua datrice di lavoro; per farlo scelse una delle quattro piante australiane nate dai semi portati in patria dalla prima nave della spedizione Baudin a rientrare, il Naturaliste, che precedette il Géographe di circa un anno. Era una pianta modestissima, per nulla imperiale, ma aveva il fascino della primizia, e. dato che Joséphine era appena stata incoronata imperatrice, la battezzò Josephinia imperatricis. Certo era sinceramente legato a colei che lo chiamava il "suo botanico" e lo aveva scelto come intendente del suo amato giardino, ma la sua dedica è decisamente meno moderata rispetto a quella dei due spagnoli: "L'onore di dedicare un genere all'illustre Imperatrice di Francesi dovrebbe essere ambito dall'autore del Jardin de la Malmaison. Possa questo debole omaggio ricordare al posteri la protezione illuminata che essa accorda alla scienza e lo splendore con cui la abbellisce". Il genere Josephinia fu ridotto a sinonimo di Sesamum, e il suo nome attuale della piante è Sesamum imperatricis che, più che i fasti imperiali, evoca la cucina. Sopravvive invece il genere creato da Ruiz e Pavon, che per bellezza e fascino esotico calza perfettamente alla dedicataria. Lapageria (famiglia Philesiaceae) è un genere monospecifico endemico del Cile, di cui l'unico rappresentante, L. rosea, è il fiore nazionale. Originaria delle foreste sclerofile e caducifolie dell'area centrale e centro-meridionale, dalla regione di Valparaiso a quello di Los Lagos, questa splendida pianta è un rampicante sempreverde con fusti contorti e sottili, foglie semplici, lanceolate, coriacee, lucide e grandi fiori solitari penduli a campana formati da sei tepali cerosi. Il colore delle corolle (tra selvatiche e coltivate, se ne conoscono 25 varietà) varia dal bianco purissimo fino al rosso passando da varie sfumature di rosa. I fiori sono impollinati da insetti, altri animali, ma soprattutto colibrì, e sono seguiti da bacche allungate eduli. La coltivazione è considerata piuttosto difficile. Da noi viene solitamente coltivata in vaso; necessita di ombra luminosa, ottima areazione (ma senza correnti d'aria) e un ambiente umido. Non sopporta né il freddo né il caldo eccessivo. Ama essere frequentemente nebulizzata e, poiché non tollera il calcare, va annaffiata con acqua demineralizzata. Insomma, coltivarla è una vera sfida, ma se trova le condizioni giuste può arrivare a 4-5 metri d'altezza e regalare sontuose fioriture.
0 Comments
Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland, fu una formidabile collezionista; collezionava oggetti naturali, in particolare conchiglie, ma anche procellane e altri manufatti. Se il suo nome oggi non è ricordato come quello di personaggi come Sloane, è perché dopo la sua morte la sua collezione di oltre 60.000 pezzi fu venduta all'asta e andò interamente dispersa. La famiglia poté riacquistare solo alcuni dei pezzi più preziosi, tra cui il celebre vaso Portland. Era anche un'abile giardiniera e aveva una notevole competenza botanica; dopo i decisivi incontri con Rousseau, Banks e Solander, questa passione raggiunse il culmine con la trasformazione di una parte del parco della sua residenza, Bulstrode Park, in orto botanico i cui fiori furono immortalati da Dionysius Ehret e dall'amica di lunga data Mrs Delany. Alcune delle vere e proprie leggende nate attorno alle rose Portland, un gruppo di rose antiche rifiorenti, le attribuiscono anche l'introduzione della prima rosa di questo gruppo. Ma la loro origine e la loro ascendenza costituiscono un duplice enigma, che è stato sciolto solo di recente. Nessun mistero invece nella dedica del genere Portlandia, con vistose fioriture che evocano i Tropici. La duchessa delle collezioni Per gli amanti dell'antichità, il nome Portland è richiama indubbamente il favoloso "vaso Portland", un vaso vitreo di epoca augustea oggi custodito al British Museum. Per gli amanti delle rose, evoca invece un gruppo di rose antiche rifiorenti. L'uno e le altre sono in qualche modo associati a Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland (1715-1785), la donna più ricca della Gran Bretagna dei suoi tempi, nonché la massima collezionista. Era nata come Margaret Harley e in lei, come unica erede sopravvissuta, si concentrarono i patrimoni del padre, Edward Harley, secondo conte di Oxford e Mortimer, e della madre Henrietta Holles, a sua volta ricchissima erede dei Newcastle e dei Cavendish. La piccola Maria (così veniva chiamata in famiglia) crebbe a Wimpole Hall, la principale residenza di famiglia, circondata da libri, dipinti, sculture e fin da bambina fu incoraggiata a collezionare animali, conchiglie e altri oggetti naturali; sia il nonno paterno (un importante uomo politico) sia il padre erano a loro volta collezionisti, bibliofili e protettori delle arti. Nel 1734, diciannovenne, sposò William Bentinck, secondo duca di Portland, che, al contrario del padre, il primo duca, braccio destro di Gugliemo III, non occupò alcun incarico pubblico e preferì concentrarsi nella vita di famiglia. La coppia ebbe sei figli, quattro dei quali raggiunsero l'età adulta; tra di essi, il terzo duca di Portland, due volte primo ministro, uno dei principali uomini politici britannici della sua epoca. La famiglia divideva il suo tempo tra Londra, dove possedeva una casa a Whitehall e frequentava la corte, i concerti e gli eventi della stagione mondana, e la tenuta di Bulstrode circondata da un vastissimo parco dove già il nonno dell'attuale duca aveva creato un magnifico giardino - di origini olandesi, aveva portato dalla sua patria il gusto per i "paradisi" che costituivano l'orgoglio dell'élite della Repubblica delle province unite - e una notevole Menagerie con voliere di uccelli esotici. Anche se Maria, come abbiamo visto, collezionava conchiglie fin da bambina e aveva ereditato almeno una parte delle collezioni paterne, la passione per il collezionismo esplose negli anni '60, quando rimase vedova (l'amato marito Will morì nel 1761); grazie a una dote di 20.000 sterline, cui, dopo la morte della madre nel 1755, si aggiunsero la proprietà di Welbeck Abbey e una rendita annuale di ulteriori 8000 sterline, era una donna indipendente di larghissimi mezzi che poteva permettersi, letteralmente, ogni capriccio. Amante degli animali fin dall'infanzia, rifondò la menagerie, arricchendola di moltissimi animali; spiritosamente, in una lettera una delle sue più care amiche, Mrs Delany, scrisse: "La duchessa è ansiosa di collezionare animali come se prevedesse un altro diluvio e ne radunasse di ogni tipo per preservarne la specie". Arricchì il parco di varie strutture, tra cui una grotta artificiale (Grotto) che adornò lei stessa di conchiglie con l'aiuto di Mrs Delany. Collezionava soprattutto oggetti naturali, ma anche dipinti, smalti, porcellane, manufatti di varia natura, ogni cosa colpisse la sua curiosità, che, a quanto pare, andavano a mescolarsi in allegra confusione nei corridoi e nelle stanze di Bulstrode Hall, ormai trasformato in un vero e proprio museo aperto ai visitatori. Colta e raffinata, la duchessa di Portland frequentava altre dame con interessi simili (inclusa la regina Carlotta); tra le amiche più strette troviamo Elizabeth Montagu, la creatrice della cosidetta Blue Stockings Society, un club informale che incoraggiava l'educazione e l'espressione artistica delle donne, con la quale iniziò una scambio epistolare nel 1731, quando era appena sedicenne. Un'altra amica di lunga data era la già citata Mary Delany, che la duchessa aveva conosciuto poco dopo il matrimonio, quando ancora si chiamava Mrs Pendarves (dal nome del primo marito); le accumunavano molti interessi e hobby: entrambe parlavano fluentemente italiano e francese, suonavano il clavicembalo, erano abili nel ricamo e in lavori in legno o con conchiglie, amavano la natura, gli animali, le piante, le lunghe passeggiate nel parco. Poi l'amica rimase vedova, si risposò con Mr Delany e si trasferì in Irlanda. Tornò in Inghilterra dopo il 1770, quando rimase vedova per la seconda volta e da quel momento trascorse circa sei mesi all'anno a Bulstrode; ormai sulla settantina, si era perfezionata nell'arte del découpage e il suo soggetto preferito divennero i fiori: formati anche di centinaia di pezzi, i suoi accuratissimi collage ritraggono con precisione anche i particolari più minuti, come gli stami, il pistillo, le nervature delle foglie. Per consentirle un minimo di indipendenza economica, la duchessa le assegnò una piccola casa a Windsor e una pensione di 300 sterline. Un altro artista protetto dalla duchessa di Portland fu Dyonisius Ehret. che probabilmente ella conobbe nel giardino di Chelsea oppure le fu presentato da Miller (di cui Ehret aveva sposato la cognata). Il pittore dipinse per lei su pergamena circa 300 piante esotiche e 500 inglesi, e insegnò disegno alle sue figlie. Possiamo considerarlo un membro a tutti gli effetti della vera e propria équipe scientifica che aiutava la duchessa ad organizzare, catalogare e documentare la sua collezione. A presiederla era il pastore John Lightfoot; nominato cappellano dal duca, due volte la settimana celebrava nella cappella di Bulstrode, dove trascorreva tutto il tempo lasciatogli libero dalla sua attività come pastore di Uxbridge, insegnando botanica alla duchessa, curando la biblioteca e aiutandola con le collezioni. Ottimo botanico, autore di Flora scotica, corrispondeva con Linneo e introdusse la nobile allieva al sistema linneano. Fino al 1770, la botanica, alla quale, come abbiamo visto, era stata avviata da Lightfoot, era un interesse relativamente secondario per la duchessa, anche se amava le piante, teneva un erbario ed era un'appassionata giardiniera, particolarmente abile nella propagazione mediante propaggine. Un incontro importante fu quello con il filosofo Jean Jacques Rousseau, che nel 1766 visse per qualche tempo a Wootton Hall nello Staffordshire, dove intraprese addirittura un inventario della flora locale. Fu presumibilmente introdotto presso la duchessa di Portland da un vicino, Bernard Granville, fratello di Mary Delaney (nata Mary Granville). Rousseau si offrì di diventare il suo "erborista", ovvero di raccogliere per lei semi e campioni d'erbario, cosa che poi fece. Anche se espresse idee francamente maschiliste sulla predisposizione scientifica delle donne, il filosofo ammirava la competenza botanica della duchessa che riteneva ben superiore alla sua. Per più di dieci anni il ginevrino e la nobildonna scambiarono lettere, esemplari, libri, finché nel 1775 o nel 1776 la duchessa commise l'errore di inviargli una copia di Herbarium amboinense di Rumphius. Rousseau tollerava appena la coltivazione dei giardini e aborriva quella delle piante esotiche, che considerava una violenza contro la natura; dunque restituì il dono e interruppe la corrispondenza. La vera svolta si produsse però qualche anno dopo. La duchessa aveva conosciuto Daniel Solander, forse presentatogli da Collinson, poco tempo dopo il suo arrivo dalla Svezia. Nel novembre 1771, dopo il ritorno dall'Australia, egli si recò con Banks a Bulstrode per farle omaggio di semi e campioni d'erbario. Seguirono dotte discussioni in cui fu coinvolto Lightfoot. Pochi giorni dopo, la duchessa e Mrs Delany visitarono il British Museum, con Solander a fare loro da cicerone. Si spostarono poi a casa di Banks che mostrò loro altri esemplari. Questi eventi acutizzarono l'interesse della duchessa per la botanica, e ne nacquero probabilmente l'erbario dipinto affidato a Ehret e l'erbario a decoupage creato da Mrs Delany. Ma la conseguenza principale fu la trasformazione di una parte del giardino in vasto orto botanico secondo il modello del giardino dei farmacisti di Chelsea, con le piante "piantate separatamente secondo la loro specie". Fu probabilmente in questo stesso periodo che, per usare le parole di Lightfoot, la duchessa concepì il progetto di "far descrivere e pubbicare tutte le specie sconosciute dei tre regni della natura". Incaricò Solander di occuparsi delle conchiglie; secondo la testimoniamza di Banks, egli dedicava a questo compito un giorno alla settimana. Tuttavia le morti di Solander nel 1782 e quella della stessa duchessa tre anni dopo, misero fine a questo sogno tanto ambizioso quanto impossibile. Poco dopo la sua scomparsa, il figlio, il terzo duca di Portland, decise di mettere in vendita l'enorme collezione creata dalla madre (erano almeno 60.000 oggetti): c'erano creditori da pagare ed egli stesso aveva bisogno di denaro per la sua carriera poltica. Lightfoot dovette trasformare il catalogo della collezione cui lavorava da anni in catalogo d'asta; quest'ultima, tenuta nella residenza di Whitehall, si aprì il 24 aprile 1786 e si protrasse per oltre due mesi, terminando il 3 luglio. Vi parteciparono centinaia di londinesi e la collezione, divisa in 4000 lotti, fu interamente dissolta. La famiglia riacquistò solo alcuni pezzi di interesse artististico, tra cui un prezioso vaso vitreo di epoca augustea con decorazioni a cammeo; la duchessa l'aveva acquistato nel 1784 da sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli; in precedenza per 150 anni era appartenuto alla famiglia Barberini. Era il pezzo più prezioso, fu messo in vendita il penultimo giorno dell'asta e per aggiudicarselo il duca dovette sborsare 1,029 sterline, una somma enorme per l'epoca. Oggi è una delle gemme del British Museum ed è noto come Vaso Portland.  Un enigma botanico Quanto alle "rose Portland", la loro storia è molto meno lineare, anzi è tanto contraddittoria e intricata da costituire un vero mistero. La versione a lungo dominante è quella riportata da Graham Stuart Thomas in Le rose antiche da giardino (data originale 1979): la progenitrice di questo gruppo di rose era presente nel vivaio Dupont di Parigi nel 1809; Dupont l'avrebbe ottenuta dall'Inghilterra e le avrebbe dato il nome della duchessa di Portland "che probabilmente la trovò o la ottenne dall'Italia all'inizio del secolo". In Inghilterra fu chiamata Rosa paestana, perché si riteneva fosse originaria della zona di Paestum, oppure "Scarlet four season Rose" perché era rosso vivido e ripeteva la fioritura in autunno. Se questa versione è corretta, dato che, come abbiamo visto, la nostra duchessa di Portland morì nel 1785, l'introduttrice non sarebbe lei, ma un'altra duchessa. Beales in Le rose classiche (data originale 1985) si rifà sostanzialmente alla medesima versione, ma si discosta da Thomas affermando che giù in Inghilterra era chiamata Rosa portlandica; aggiunge poi in nota che Sally Festing, autrice di una biografia della seconda duchessa, ha evidenziato che era già elencata nel catalogo di un vivaio inglese nel 1784, il che "deve pure mettere in dubbio l'Italia come suo paese d'origine". E, aggiungo io, rimettere in gioco la nostra duchessa. Ulteriore enigma è l'ascendenza di questa rosa. Nell'opera già citata, Thomas riporta che "era considerata come un incrocio tra la rosa francese (Gallica) e la Damascena autunnale"; egli però la ritiene piuttosto "una ibrido rosa Cinese - Damascena - rosa Francese" e aggiunge: "Dal colore e dal comportamento nano [...] si può presumere che la rosa Cinese progenitrice in questione fosse la cremisi Cinese di Slater" (Slater's Crimson China). Beales è invece convinto che "nessuna rosa cinese sia comunuqe coinvolta" ma che vi abbiano avuto parte attiva la Rosa x damascena bifera ('Quatre Saisons') per la rifiorenza e la R. gallica officinalis ('Rosa del farmacista') per il portamento ordinato e compatto. Il mistero ha ovviamente sollecitato la curiosità dei rodologhi e suscitato ulteriori ricerche. A fare il punto, e dare la risposta definitiva, è Peter Harkness in The Rose. A Colourful Inheritance (2005). In primo luogo egli ricorda che la rosa Portland è conosciuta sotto ben otto nomi: Rosa paestana, R. 'Portlandica', 'Duchess of Portland', Portland Crimson, 'Monthly Rose', 'Portlandia', 'Portlandica', 'Rosier de Portland'. Quindi riassume lo stato dell'arte così: "Le descrizioni di questa rosa nella letteratura non si contano. Si dice che sia originaria del Dorset, o di Beaconsfield, o forse di Napoli, negli anni '70 o '90 del 1700. Quanto alla sua ascendenza, si dice che coivolga unicamente gallica, oppure una damascena e una gallica, o una cinese e una damascena". Secondo Harkness, tutto questo garbuglio nasce dal fatto che "in realtà ci sono due diverse Portland", una nata in Inghilterra negli anni '70 del Settecento, l'altra introdotta da Dupont, giardiniere dell'imperatrice Giuseppina, all'inizio dell'Ottocento. La differenza salta all'occhio osservando la prima nel giardino della Royal National Rose Society, dove è coltivata sotto l'etichetta 'Duchess of Portland', e la seconda nel giardino parigino della Bagatelle, dove è coltivata come R. paestana. La rosa "inglese" (chiamiamola così per comodità), come risulta da cataloghi di vivai e da testi dell'epoca (come la monografia Roses, pubblicata da Henry C. Andrews nel 1805) nacque nei giardini del duca di Portland a Bulstrode prima del 1775, data in cui è elencata da Weston tra le rose "facilmente reperibili" sotto il nome 'Portland Crimson Monthly Rose'; la stessa data è riportata da Trees & Shrubs Hardy in the British Isles che però la chiama 'Portlandica'. Nel 1782, come ‘Portland’ era presente nel catalogo del vivaio Brunton e Forbes di Birmingham; veniva venduta a uno scellino, prezzo che, secondo Harkness, "suggerisce che non si trattasse di una novità". Intorno al 1785, fece la sua comparsa in Francia. E' identificabile nella rosa della Royal National Rose Society; l'aspetto generale, le foglie, i fiori rosa profondo indicano la parentela con la gallica, mentre la modesta rifiorenza riflette quella con la damascena. Veniamo invece a quella "francese"; l'unica certezza è che André Dupont iniziò a coltivarla nel 1803, quando la ricevette dall'Inghilterra. Nel 1809 era chiamata Rosier de Portland e Redouté la dipinse sotto questo nome. Nel 1811 Claude-Thomas Guerrepain nell'Almanach des Roses ne diede una precisa descrizione esaltandone "la preziosa qualità di fiorire dalla primavera all'autunno" e il bellissimo punto di rosso. E' la rosa di Bagatelle. Il brillante colore scarlatto e la rifiorenza hanno fatto a lungo pensare che uno dei genitori fosse una rosa rossa cinese, anche se l'aspetto generale, le foglie e i cinorrodi mostrano maggiori affinità con la Damascena. Le analisi del DNA di cinque rose Portland, condotte da Olivier Raymond dell'università di Lione, ha mostrato parentele con Damascena, Gallica e Centifolia, ma non con le cinesi. Rimane da capire la ragione del nome Portland e l'eventuale connessione con la seconda o la terza duchessa. Nel 1805, parlando della rosa di Bulstrode, Andrews riferisce che sarebbe stata chiamata così "in onore della defunta duchessa di Portland"; Harkness contesta questa affermazione: a suo parere nel Settecento non era ancora invalsa l'abitudine di dare alle rose il nome di una persona; gli sembra più probabile che i nomi 'Portland' o 'Portlandica' si riferiscano al luogo di origine, la tenuta di Bulstrode dei duchi di Portland. Quanto alla rosa "francese", abbiamo due versioni: una, che abbiamo già visto sotto la penna di Graham Stuart Thomas, pretende che una duchessa di Portland l'abbia portata o ottenuta dall'Italia attorno al 1800; l'altra che Dupont l'abbia ottenuta dall'Inghilterra nel 1803 e battezzata 'Rosier de Portland' in segno gratitudine per la terza duchessa di Portland per averlo aiutato a persuadere l'Ammirigliato, nonostante il blocco continentale, a concedere un passaporto al vivaista John Kennedy per trasportare in Francia questa e altre rose destinate ai giardini della Malmaison . Nessuna delle due storie può essere vera, per la semplice ragione che né nel 1800 né nel 1803 viveva una qualche duchessa di Portland. Sappiamo già che la seconda duchessa, ovvero Margaret Cavendish Bentinck, morì nel 1785. La terza duchessa, ovvero sua nuora Dorothy Bentinck nata Cavendish, morì a sua volta nel 1794, e non ci sarebbe stata una quarta duchessa fino al 1809, quando, con la morte del terzo duca, che non si risposò, il titolo passò al quarto duca e a sua moglie. Inoltre, Dupont non chiamò la rosa 'Duchess de Portland', ma 'Rosier de Portland'; l'ipotesi di Harkness è che l'omaggio fosse diretto al terzo duca di Portland il quale, come Segretario di stato ininterrottamente dal 1794 al 1801, quindi, dopo un breve periodo all'opposizione, dal 1803 Presidente del Consiglio privato e poi Primo ministro, "era certamente nella posizione di aiutarlo a ottenere un passaporto per le sue rose". Anche il nome R. paestana probabilmente non ha alcun rapporto diretto con l'Italia e Paestum; si tratta piuttosto di una semplice reminescenza della letteratura classica in cui le rose di Paestum erano celebrate per la loro bellezza, il profumo, il vivace colore rosso e la rifiorenza autunnale. 
In anni decisivi per la storia della botanica inglese, tra fine Seicento e inizio Settecento, il farmacista James Petiver riesce a conquistare prestigio nella società colta grazie alla sua formidabile collezione di esemplari d'erbario, conchiglie, insetti, fossili e così via, seconda solo a quella del ben più ricco Hans Sloane. Raggiunge l'intento tessendo una straordinaria rete di contatti, con almeno un centinaio di corrispondenti tra Europa, Americhe, Asia meridionale e orientale, Africa occidentale e Sudafrica: studiosi e appassionati come lui, ma soprattutto persone comuni, giardinieri, capitani di marina, medici, chirurghi e sacerdoti che vivono nelle colonie e contribuiscono chi con un esemplare, chi con molti, pur di essere citati nelle sue Centurie e di partecipare al progresso delle scienze. Un modello di cui farà tesoro lo stesso Linneo, che lo ricordò con il monotipico genere Petiveria. 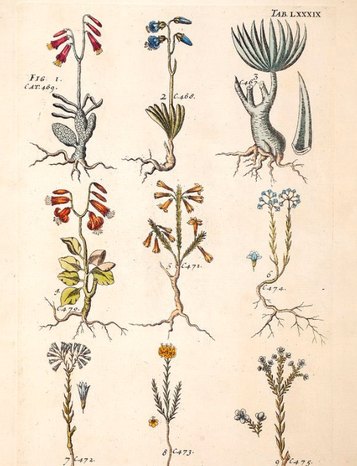 Come nacque una grande collezione Nel 1706, con la morte del curatore Samuel Doody, tra i farmacisti londinesi riprese l'eterno dibattito: aveva senso continuare a mantenere il costoso Physic Garden di Chelsea, o era meglio liberarsi di quell'impianto mangia-soldi? Per valutare la situazione finanziaria, venne formato un comitato che fu anche incaricato di prendere contatto con il proprietario del terreno, sir Charles Cheyne, per verificarne l'eventuale acquisto. Cheyne chiese una cifra irraggiungibile: 400 sterline. Nonostante ciò, il comitato si pronunciò a favore del mantenimento del giardino e per far fronte ai debiti indisse una sottoscrizione straordinaria, alla quale, per dare l'esempio, i suoi membri aderirono per primi. Il seguito tra gli altrui soci fu modesto, ma il giardino sopravvisse. Gran parte del merito va ascritto al membro più autorevole del comitato stesso, il farmacista James Petiver (1663-1718), che succedette a Doody come curatore del giardino, ma anche come "dimostratore di botanica". I suoi compiti principali erano due: da una parte, impartire lezioni di botanica pratica ("dimostrazioni") ai giovani apprendisti, da tenersi almeno due volte al mese nel Physic Garden nei mesi estivi; dall'altra, organizzare la Grande erborizzazione annuale, con la partecipazione di maestri ed apprendisti. Abbiamo già incontrato Petiver come amico di Doody e attivo membro del Temple Coffee House Botanical Club; è ora di conoscerlo meglio. Figlio di un merciaio di Rugby, poco dopo la morte di quest'ultimo dovette interrompere gli studi e sempre ne ebbe rammarico, soprattutto per non aver potuto acquisire una sufficiente padronanza del latino, all'epoca la lingua ufficiale delle scienza. Nel giugno 1677, quattordicenne, iniziò il suo apprendistato sotto Charles Feltham, il farmacista del St Bartholomew's Hospital di Londra. Intorno al 1680 conobbe Whatts e cominciò a frequentare il giardino di Chelsea, stringendo amicizia con Doody; a quanto risulta dal suo erbario, almeno dal 1683 prese regolarmente parte agli herborizing organizzati dalla Società dei farmacisti. Nel 1685, terminati i previsti otto anni di apprendistato, ottenne la licenza e tra il 1686 e il 1687 aprì una propria farmacia all'insegna della Croce bianca in Aldersgate Street (nei pressi dell'attuale Barbican Centre), che avrebbe gestito fino alla fine dei suoi giorni. A questo punto doveva già essersi fatto un nome come esperto botanico, visto che nel 1688, insieme all'amico Doody, viene ringraziato da John Ray per l'aiuto prestato per il secondo volume di Historia Plantarum. Probabilmente attraverso Doody, conobbe Sloane, rientrato dalla Giamaica nel 1689 con un'enorme collezione di naturalia, e incominciò a frequentare il Temple Coffee House Botanical Club, di cui diventò la personalità più nota dopo lo stesso Sloane. Forse incoraggiato dall'esempio di questi, decise di creare una propria collezione, che sarebbe stato anche il migliore biglietto da visita per garantire a lui, semplice farmacista "illetterato", l'accesso alla società colta londinese. Non aveva le enormi disponibilità finanziare di Sloane, ma poteva trarre profitto da un altro vantaggio: come farmacista e fornitore di farmaci di alcuni ospedali londinesi, nella sua bottega già affluivano spezie e piante medicinali da molte parti del mondo; era dunque in contatto con membri della Compagnia delle Indie e mercanti che praticavano il commercio internazionale. Come risulta dalle sue lettere, almeno dal 1690 Petiver incominciò a tessere quella formidabile rete di contatti che gli avrebbe permesso di essere il più importante collezionista del suo tempo dopo il ricchissimo Sloane. Uno dei suoi primi corrispondenti documentati è il chirurgo Samuel Browne, che lavorava per la Compagnia delle Indie orientali a Fort St George in Bengala (oggi Chennai). Non solo Browne raccolse per lui molte piante, che gli inviò in Inghilterra accompagnate da note con i nomi locali, ma a sua volta lo mise in contatto con altre persone: il reverendo George Lewis, collezionista di conchiglie, e soprattutto il missionario gesuita Georg Joseph Kamel, pioniere dello studio della flora delle Filippine. A sua volta Petiver fece da tramite tra Kamel e Ray, che pubblicò l’opera del missionario moravo in appendice al terzo volume di Historia Plantarum. Si tratta solo del nucleo iniziale di una vastissima rete di corrispondenti e contributori, che giunse a comprendere oltre cento persone: alcuni erano noti scienziati, come Boerhaave o Tournefort, oppure collezionisti e proprietari di grandi giardini come i fratelli Sherard, la duchessa di Beaufort o il vescovo Compton, ma la stragrande maggioranza era costituita da persone comuni: chirurghi, medici, capitani di nave, mercanti, sacerdoti, giardinieri che contribuirono chi con un esemplare, chi con dozzine e dozzine di piante, insetti e altri animali, conchiglie, fossili, spediti da vari paesi europei, dalla Cina, dall’India, dal Sud Africa, dal Sud e dal Nord America. È stato sottolineato che almeno un terzo di queste persone era legato in un modo o nell’altro al commercio triangolare, o in altri termini alla tratta degli schiavi. Oltre a Browne, i contributori più importanti furono Hendrik Oldenland, il curatore dell’orto botanico della VOC a Table Bay, e James Cunninghame, un chirurgo scozzese che lavorava per la Compagnia delle Indie nelle basi di Zhoushan e Amoy (oggi Xiamen) in Cina e fu il primo europeo a raccogliere un significativo erbario di piante cinesi. Per i suoi contributori, Petiver giunse a stilare prima liste di "desiderata", poi vere e proprie istruzioni stampate sulle modalità di raccolta, conservazione e spedizione, che costituiscono un modello e un'anticipazione delle indicazioni di Linneo ai suoi apostoli. Col tempo, la sua bottega di Aldersgate Street si trasformò in una specie di centro di interscambio, dove da tutto il mondo giungevano pacchi di esemplari, libri, lettere con richieste di consulenza ma anche di materiali. Per Petiver, infatti, il collezionismo di naturalia era anche un'attività lucrativa: se tratteneva per sé gli esemplari che considerava più prestigiosi o interessanti, altri li vendeva a caro prezzo ad altri collezionisti. 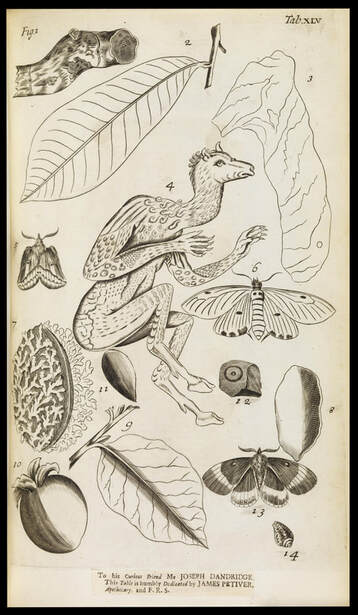 Collezionista e dimostratore Con la sola eccezione di un viaggio nei Paesi Bassi di cui parleremo più avanti, Petiver limitò le sue attività di raccolta diretta a qualche escursione in Inghilterra; oltre che nei dintorni di Londra, sono documentati viaggi nelle Midlands, in Essex, a Bath, a Bristol, nell'Essex e nel Suffolk. Il grosso delle sue collezioni arrivava però dai suoi corrispondenti che lo misero in contatto, letteralmente, con tutti i continenti (eccetto l'ancora inesplorata Oceania), permettendogli di accumulare una collezione che, oltre a centinaia e centinaia di altri esemplari, comprendeva almeno 5000 piante essiccate. A partire dal 1695, cominciò a pubblicare gli esemplari più curiosi, rari o significativi in una serie di cataloghi, dapprima senza immagini, poi illustrati, organizzati come "centurie", ovvero in serie di cento esemplari. Il primo è Musei Petiveriani centuria prima (1695), che descrive cento tra insetti, conchiglie, fossili e piante provenienti da Europa, America settentrionale, Africa occidentale, Asia meridionale e orientale; tra il 1698 e il 1703 seguirono altre cinque centurie, per un totale di seicento naturalia. Petiver pubblicò inoltre dozzine di brevi articoli nella rivista The Monthly Miscellany e molti contributi nelle Transactions della Royal Society, di cui divenne membro nel 1695 (nella stessa seduta dell'amico Samuel Doody). I suoi lavori più rilevanti sono la relazione sulle piante indiane ricevute da Browne An account of some Indian plants (1698) e due scritti di entomologia: Gazophylacium naturae et artis (1702–6), un catalogo illustrato degli insetti britannici, e Papilionum Brittaniae Icones, la prima rassegna completa dei lepidotteri inglesi che lo ha fatto salutare come «padre delle farfalle britanniche», che non di rado ha battezzato con il nome comune che portano ancora oggi. Petiver era anche un abile uomo d’affari e mise la sua competenza manageriale al servizio sia della Royal society, sia del Chelsea Physic Garden, anche se, di fronte ai suoi mille impegni professionali (oltre che del St Bartholomew, divenne anche farmacista della Charterhouse school and hospital), il suo incarico di dimostratore passava un po’ in secondo piano, tanto che presto dovette essere affiancato da Isaac Rand; il suo maggior merito fu sistematizzare e estendere le escursioni botaniche. Mentre in precedenza se ne teneva solo una all’anno, con Petiver e Rand il loro numero crebbe fino a sei, una al mese per tutta la bella stagione, a partire da aprile. Accompagnati dal dimostratore, gli apprendisti raggiungevano località come Hampstead Head, Putney e Greenwich per escursioni di una ventina di miglia; durante il pranzo, che di solito si teneva in qualche osteria, le piante venivano esaminate e identificate e ne venivano descritte le particolarità e le virtù medicinali. L’ultima escursione, detta General Herborizing, poteva durare due giorni, coprire una sessantina di miglia, era riservata ai maestri e ai loro ospiti, spesso membri eminenti dei Collegi dei medici e dei chirurghi, ed era anche un’importante occasione sociale. Anche il Chelsea Physic Garden poté beneficiare della rete di Petiver per un sensibile arricchimento delle collezioni. In particolare, nel 1711, per incarico di Hans Sloane, Petiver si recò in Olanda per trattare l’acquisto delle collezioni di Paul Hermann, messe all’asta dalla vedova; fu l’occasione per conoscere di persona Boerhaave e per rinnovare la collaborazione e gli scambi tra i due orti botanici. Tra il 1711 e il 1714, Petiver pubblicò sulle Philosophical Transactions una serie di articoli molto interessanti per chi studia la storia delle introduzioni delle piante esotiche, perché vi recensì le piante rare recentemente introdotte dal Nord America, dalla Cina e dalla Provincia del Capo e coltivate con successo nei giardini del vescovo di Londra a Fulham, in quello della duchessa di Beaufort e soprattutto a Chelsea. A partire dal 1716, la sua salute cominciò a declinare. Alla sua morte, nel 1718, le sue collezioni furono acquistate da Sloane, che ebbe a lamentare il grande disordine in cui erano tenute; ora sono in parte conservate nel Natural History Museum di Londra.  Un'erbacea... odorosa Anche Petiver fa parte del nutrito gruppo di naturalisti omaggiati da Plumier e Linneo con la dedica di un genere botanico. Il francese fece in tempo a vedere il primo catalogo della sua collezione, e lo loda per la ricchezza dei materiali e il buon ordine in cui sono disposti (il che contrasta con le lamentele di Sloane, ma anche con ciò che riferiscono alcuni viaggiatori che ebbero l'occasione di vederle di persona). Linneo attinse ampiamente alle pubblicazioni di Petiver sia per le piante esotiche, da lui documentate per la prima volta, sia per gli insetti, e apprezzava il fatto che in alcuni dei suoi contributi sulle Transactions il farmacista avesse abbozzato una classificazione naturale. Il genere Petiveria L. (appartenente a una famiglia propria, Petiveriaceae) comprende una sola specie, P. alliacea: caratterizzata come dice il nome da un forte odore di aglio, è una grande erbacea perenne cespugliosa, con foglie intere obovate e infiorescenze a spiga di piccoli fiori biancastri, cui nei paesi d’origine (gran parte dell’America subtropicale e tropicale, dalle Florida al Perù) sono attribuite innumerevoli proprietà terapeutiche; per l’odore, è però utilizzato anche come repellente. Qualche informazione in più nella scheda. Alice Eastwood è stata probabilmente la più nota botanica statunitense: per quasi sessant'anni diresse il dipartimento di botanica dell'Accademia delle Scienze di California, fu la massima esperta della flora degli Stati Uniti occidentali, descrisse e classificò 395 specie, scrisse oltre 300 tra articoli e libri. E soprattutto, fece risorgere letteralmente dalle ceneri l'erbario dell'Accademia, di cui la terribile mattina del terremoto di San Francisco riuscì a salvare il nucleo più prezioso con un impulsivo atto eroico. A ricordarla, l'epiteto di numerose specie e sottospecie, e due generi: Eastwoodia e Aliciella. Una preziosa collezione strappata alle fiamme All'alba del 18 aprile 1906 un violento terremoto si abbatté sulla città di San Francisco, con due scosse successive, la seconda delle quali violentissima. Moltissimi edifici furono lesionati, altri crollarono e centinaia di persone (non sapremo mai esattamente quante) rimasero sotto le macerie; ma i danni peggiori non furono causati dal sisma, bensì dal terribile incendio (negli Stati Uniti è passato alla storia come Great Fire) che continuò ad ardere per quattro giorni e quattro notti, distruggendo circa 25.000 edifici. Tra gli abitanti della città che in quella mattina tragica persero tutto c'era anche Alice Eastwood, la curatrice dell'erbario dell'Accademia delle Scienze della California. Preoccupata per la sorte delle collezioni di cui era la custode, si precipitò in Market Street, dove sorgeva la sede dell'Accademia. Dato che il ponticello che dava accesso all'ingresso principale del Museo era crollato, Alice si portò sul retro, dove si era raccolto un gruppetto di curatori e assistenti dei vari dipartimenti dell'Accademia. Nel cortile invaso dai detriti, tutti guardavano in su, impotenti e desolati. L'edifico era lesionato, e la scala in marmo che dava accesso ai piani superiori era parzialmente crollata. Anche se non c'era pericolo di crollo immediato, alcuni edifici vicini erano già in fiamme ed era evidente che presto l'incendio avrebbe raggiunto anche il Museo. Impossibile mettere in salvo la biblioteca, i documenti, le inestimabili collezioni naturalistiche, tutti custoditi ai piani superiori. Vedendo che il lavoro suo e degli scienziati che avevamo fatto di quella istituzione la più importante degli Stati Uniti occidentali stava per essere distrutto, Alice Eastwood prese una rapida decisione. Durante la sua gestione, aveva inaugurato una pratica all'epoca inconsueta: quella di custodire a parte gli esemplari tipo, ovvero quelli usati per descrivere e determinare le nuove entità. Almeno quello, il nucleo più prezioso dell'erbario, doveva essere salvato. Ma come raggiungerlo, visto che si trovava al sesto piano, nell'ufficio della curatrice? Con un coraggio che rasenta l'incoscienza, insieme al suo assistente Robert Porter, Alice (era un'alpinista provetta) salì sulla ringhiera di ferro della scala semicrollata e si arrampicò fin lassù mettendo i piedi tra i pioli. Dal suo ufficio prese un solo oggetto, un paio di occhiali, e incominciò a impacchettare i preziosi esemplari che poi vennero calati in cortile con l'aiuto di corde improvvisate. In tal modo salvò 1497 esemplari tipo, che vennero poi trasportati in un edificio sicuro; nel pomeriggio l'incendio si estese all'Accademia che arse per tre giorni, distruggendo tutto il resto, compresa la collezione personale della coraggiosa botanica. Diciannove giorni dopo Eastwood scrisse: "Non sento la perdita come qualcosa di personale, ma è una grande perdita per il mondo scientifico e una perdita irreparabile per la California. Non mi lamento del mio lavoro che è andato perduto, dato che per me è stato una gioia quando l'ho fatto, e lo sarà di nuovo quando ricomincerò". E sarebbe stato proprio così.  Ritratto di una botanica da giovane Abbiamo già incontrato Alice Eastwood parlando di Townshend e Catharine Brandegee. E' ora di conoscerla meglio. Alice era nata in Canada, a Toronto, ma adolescente si era trasferita con la famiglia a Denver in Colorado. Mentre ancora studiava alla scuola superiore, un casuale soggiorno in montagna l'aveva fatta innamorare delle piante delle Montagne rocciose e l'aveva spinta a studiare botanica da autodidatta sui pochi manuali disponibili e a creare un erbario. Anche se era una studentessa brillante, le condizioni economiche della famiglia le impedivano di andare all'Università; così, dopo il diploma rimase a insegnare al Shawa Convent Catholic High School, la scuola dove aveva studiato. Era una supplente sottopagata, cui veniva richiesto di insegnare ogni tipo di materia e di correggere una montagna di compiti. Tutto il poco che riusciva a risparmiare lo destinava ad acquistare libri di botanica e a pagarsi le vacanze estive, che trascorreva arrampicandosi su colline e montagne alla ricerca delle amate piante. Poco alla volta, incominciò a farsi un nome come esperta della flora del Colorado. Nel 1887 guidò sul Gray's Peak il celebre naturalista inglese Alfred Russel Wallace, che si trova negli Stati Uniti per un tour di conferenze. Nel 1889 accompagnò il naturalista Theodore Alison Cockerell a botanizzare nella Wet Mountain Valley, e grazie a lui fu nominata segretaria della Colorado Biological Association. Divenuta amica della famiglia Wetherill, che possedeva un ranch nella Mesa verde, ne fece la sua base per numerose escursioni nella cosiddetta Four Corner Region, l'area al confine tra Colorado, Utah, Arizona e New Mexico. Ormai sulla trentina, Alice desiderava lasciare l'insegnamento e diventare una botanica di professione. Alcuni investimenti le avevano permesso di farsi una piccola rendita che la rendeva economicamente indipendente. Nell'inverno 1890-91 visitò per la prima volta la California e incontrò i Brandegee. Katharine Brandegee, impressionata dalla qualità del suo erbario, le chiese di scrivere degli articoli per la sua rivista e le propose di lavorare con lei, ma Alice era piuttosto riluttante a lasciare il Colorado, tanto più che proprio in quel periodo stava scrivendo un libro, uscito nel 1893 con il titolo A popular flora of Denver, Colorado. Nell'estate del 1892, accompagnata da Al Wetherill fece una lunga escursione nell'Utah sudoccidentale alla ricerca di piante del deserto. Solo nel dicembre di quell'anno si trasferì definitivamente a San Francisco, come curatrice aggiunta dell'erbario, poi, dal 1894, al ritiro della signora Brandegee, come curatrice e capo del dipartimento di botanica dell'Accademia delle Scienze. Oltre a occuparsi della gestione dell'erbario e a scrivere articoli per varie riviste, in questo periodo Alice fece importanti raccolte botaniche, in particolare esplorando la allora poco studiata Catena costiera meridionale fino alla regione di Big Sur, che all'epoca non era collegata da nessuna strada. Escursionista e alpinista instancabile, era anche una colonna di associazioni di appassionati come il Sierra Club (con il quale nel 1903 scalò il Monte Withney, la cima più alta degli Stati Uniti esclusa l'Alaska) e il Botanical Club, per il quale scrisse anche una guida al riconoscimento delle piante selvatiche. Ottima divulgatrice, nel 1905 pubblicò A Handbook of the Trees of California, nella cui prefazione scrisse: "L'obiettivo è sempre stato la brevità e la chiarezza, il desiderio di aiutare piuttosto che di brillare".  La ricostruzione dell'erbario Ad eccoci tornati a quel maledetto 18 aprile 1906 quando tutte le collezioni dell'Accademia delle Scienze andarono in fumo, ad eccezione dei 1497 esemplari botanici salvati da Alice e di pochi documenti. Appena possibile, incominciò la ricostruzione. Mentre veniva costruita la nuova sede nel Golden Gate Park, Alice Eastwood andò a studiare nei più importanti erbari statunitensi ed europei: il Gray Herbarium di Harvard, gli erbari del New York Botanical Garden, del British Museum, di Kew e del Museo di storia naturale di Parigi. Questi viaggi le permisero anche di stabilire rapporti personali con molti colleghi. Così nel 1912, quando la nuova sede venne inaugurata e le fu nuovamente offerto il posto di curatrice del Dipartimento di botanica, era pronta per ricominciare. Il suo asso nella manica era l'eccezionale ricchezza della flora californiana, una delle regioni floristiche più ricche del pianeta, con quasi 4700 specie native di cui 1400 endemismi. Alice Eastwood percorse lo stato in centinaia di escursioni, da sola o alla guida di gruppi di cui era allo stesso tempo cuoca, organizzatrice, guida e responsabile scientifico. Esplorò i deserti e le montagne, gli angoli con caratteristiche geologiche peculiari, le zone minacciate dall'espansione urbana e agricola, la cui flora rischiava di sparire prima ancora di essere conosciuta. Le vacanze erano riservate a spedizioni più ampie negli Stati Uniti occidentali (Alaska, Arizona, Utah, Idaho). Grazie a queste estensive raccolte, Eastwood poté realizzare un intenso programma di scambi con altri orti botanici, in particolare con Harward e Kew. Infatti, mentre i primi esemplari andavano a incrementare la collezione dell'Accademia delle Scienze, i duplicati venivano scambiati con altri erbari in giro per il mondo. In cambio delle piante native della West Coast, ricercava soprattutto esemplari che la aiutassero ad identificare correttamente le numerose specie esotiche tropicali e subtropicali che fin dall'Ottocento erano venute a popolare i giardini e i vivai californiani, non di rado naturalizzandosi. Per ricostruire gli itinerari di queste piante migratrici, studiò a fondo i documenti sulle prime spedizioni europee in California. Nel 1949, quando andò in pensione, era riuscita ad aggiungere all'erbario 340.000 esemplari, più di tre volte tanto quelli perduti nell'incendio. I suoi sforzi furono diretti anche a ricostruire la biblioteca, che era andata totalmente distrutta. Lei stessa scrisse moltissimo: la sua bibliografia conta più di trecento titoli, tanto scientifici quanto divulgativi. Appassionata di giardinaggio, cercò di creare un ponte tra il mondo scientifico, i coltivatori e gli amatori. Per rendere popolare la botanica, volle che nell'atrio dell'Accademia si alternassero mostre di fiori freschi. Si impegnò per diffondere la coltivazione delle piante native nei giardini californiani e per la loro salvaguardia, battendosi per la creazione del Parco nazionale del Monte Tamalpais, una delle sue aree di raccolta preferite. Nel 1929 fu tra i soci fondatori della Fuchsia American Society e promosse il censimento delle specie e varietà di fucsie coltivate in California e l'introduzione di nuove varietà. Quando aveva 73 anni fu investita da un'automobile, riportando la frattura di un ginocchio; da quel momento, dovette servirsi di un bastone e rinunciò alle scarpinate. Ma non certo alle escursioni. Adesso, invece che a piedi o a cavallo, si muoveva in automobile, una Ford T, e mentre il suo assistente Thomas Howell si spingeva più lontano, si accontentava di erborizzare nei pressi. In piena salute fino quasi alla morte, andò in pensione nel 1949, a novant'anni, ma continuò a scrivere e a frequentare il suo vecchio ufficio all'Accademia. Nel 1950, il Settimo congresso internazionale di botanica, tenutosi a Stoccolma, la elesse Presidente onoraria (una specie di Oscar alla carriera); per rimarcare tanto onore, venne fatta sedere sul seggio che era stato di Linneo.  L'elegante Eastwoodia e le rare Aliciella Come autrice di nomi botanici, Alice Eastwood è stata una delle botaniche più prolifiche, con 652 taxa e 395 specie. Si tratta di endemismi delle Montagne rocciose e dell'Utah, da lei scoperti in gioventù, e ovviamente di piante californiane. Dato che tra le sue preferite c'erano le Liliaceae, cui dedicò vari importanti studi, vorrei citare le specie endemiche di Allium che scoprì, studiò e nominò: Allium cratericola Eastw., Allium hickmenii Eastw., Allium howellii Eastw., Allium yosemitense Eastw. Sono numerose anche le specie, sottospecie e varietà che la ricordano; tra di esse Fritillaria eastwoodiae, un endemismo della Sierra Nevada, della Cascade Mountains e dell'Oregon meridionale; Erigeron aliceae, una perenne dei pascoli e delle boscaglie del Nord-ovest pacifico; Ranunculus eastwoodinus, nativo dell'Alaska. Veniamo infine ai due generi che si fregiano del suo nome. Il primo in ordine di tempo è Eastwoodia, che gli fu dedicato nel 1894 da Townshend Brandegee. La sua unica specie, E. elegans, endemica di ambienti aridi delle praterie e delle colline della California centrale, negli anni precedenti era stata raccolta da diversi raccoglitori, tra i quale anche Alice Eastwood. Appartenente alla famiglia Asteraceae, è un arbustino alto fino a un metro, molto ramificato e con piccolissime foglie, che al momento della fioritura si fa notare per i numerosissimi capolini gialli globosi, composti unicamente di flosculi ligulati. Una sintetica presentazione nella scheda. Più complicate le vicende del secondo genere dedicato alla nostra protagonista. Nel 1892, erborizzando in Utah, Eastwood scoprì una nuova specie di Gilia che pubblicò come Gilia triodon. Nel 1905 il botanico tedesco August Brand ritenne che si differenziasse abbastanza dalle altre Gilia per essere assegnata a un nuovo genere, che denominò Aliciella in onore della scopritrice. La proposta di Brand non fu generalmente accettata, e il nuovo genere fu presto abbandonato. Tuttavia, in anni recenti è stato ripristinato sulla base di studi genetici. Appartenente alla famiglia Polemoniaceae, gli sono oggi assegnate oltre venti specie, distribuite in varie aree degli Stati Uniti occidentali, dall'Utah al New Mexico. Sono piccole annuali, biennali e perenni dei deserti o delle montagne, adattate ad ambienti molto specifici, il che le rende fragili e minacciate. Alcune sono anche molto belle, e l'eccessiva raccolta è uno dei pericoli che le insidia. La maggior parte delle specie cresce tra le fessure delle rocce o sui ghiaioni; sono terreni spesso instabili, cui si ancorano penetrando in profondità con le lunghe radici a fittone, talvolta più sviluppate della parte aerea. In questi habitat apparentemente inospitali, dove ben poche piante riescono a crescere, queste fragili bellezze non devono affrontare la concorrenza di altre specie. Mentre le specie annuali sono in genere abbastanza insignificanti, molte tra le perenni sono dei piccoli gioielli dalle fioriture smaglianti. Tra le più notevoli, anche le due più rare: A. caespitosa, un endemismo della Wayne County in Utah che cresce tra le fessure delle rocce di arenaria, oggi nota in solo sei stazioni; e la minuscola e bellissima A. sedifolia delle San Juan Mountains in Colorado, di diffusione così limitata che fino al 2007 si pensava fosse estinta. Ne furono poi scoperte due sole stazioni. Nella scheda qualche informazione anche su altre specie di notevole impatto estetico. Minuscole, tenaci, eleganti, sono tutte perfette per celebrare Alice Eastwood, che non solo amava gli ambienti impervi dove vivono, ma era lei stessa piccola di statura, piena di energia, sempre elegante anche durante le escursioni più avventurose. E da vera signora, non usciva mai senza cappello. Anche nel Seicento un giardiniere di successo poteva venire in contatto con molti potenti; se era disposto a viaggiare e a ricercare con energia novità per arricchire i giardini, poteva mettere da parte qualche soldo e pensare addirittura di rivaleggiare con i gentiluomini come collezionista. Così John Tradescant il vecchio fonda l'Arca, il primo museo pubblico a noi noto. Introduce talmente tante piante che dopo di lui i giardini e i frutteti inglesi non saranno più gli stessi. Suo figlio John Tradescant continua l'opera paterna, anche se alla sua morte c'è un piccolo giallo. L'attiva e esuberante Tradescantia è la pianta giusta per ricordare i due intraprendenti giardinieri.  L'Arca dei Tradescant Se oggi nei tour di Londra tra le attrazioni più popolari non manca mai il museo delle cere (divertente e alquanto kitsch), nel Seicento veniva raccomandato ad ogni viaggiatore di non farsi sfuggire il Tradescant Museum, comunemente soprannominato "l'Arca dei Tradescant". Pagando un biglietto di soli sei scellini, il visitatore poteva ammirare "ogni cosa strana e rara". Tra gli oggetti esposti, monete e medaglie, quadri e stampe, libri, suppellettili preziose, ma anche oggetti rari e curiosi provenienti dal mondo naturale (naturalia) o costruiti dall'uomo (artificialia). Tra i primi animali impagliati, uova e penne d'uccello, conchiglie, insetti, pesci, serpenti, fossili, minerali, cristalli, frutti esotici, semi e foglie essiccate; c'erano un dodo, cavallucci marini, uova di coccodrillo, colibrì, ma anche esemplari improbabili come la mano di una sirena, un artiglio dell'uccello Rock, il sangue piovuto nell'isola di Whigt, il vello di un agnello vegetale o Barometz, le penne della fenice, un drago lungo due pollici. Tra i secondi collezioni di abiti e scarpe di ogni foggia, armi tra cui diversi tomahawk, strumenti medici, parti di cannoni, noccioli di ciliegia o susina finemente intagliati, la culla del re Enrico VI, i guanti di Enrico VIII e Anna Bolena, il mantello di Powhattan (il padre di Pocahontas), un frammento della vera croce. La visita continuava nel giardino adiacente dove i Tradescant avevano raccolto più 700 piante, molte delle quali fino ad allora non coltivate in Inghilterra. I gabinetti delle curiosità, noti anche con l'espressione tedesca Wunderkammer, erano nati nel Cinquecento come forma di collezionismo riservato a sovrani o in ogni caso a uomini ricchi e potenti; la particolarità dell'Arca è di essere stato creata come impresa privata da due persone comuni, che alla loro attività di giardinieri al servizio di grandi nobili e del re Carlo I avevano unito quella di procacciatori di piante e curiosità; essi avevano accesso a una vasta rete di conoscenze cui facevano ricorso per procurare rarità ai loro committenti e al loro stesso museo, il primo in Europa ad essere aperto a chiunque potesse pagare il biglietto d'ingresso. Che si trattasse di un'impresa commerciale è dimostrato dal fatto che, come in un moderno museo, c'era anche un piccolo negozio dove si poteva acquistare il catalogo; inoltre è probabile che il giardino avesse anche la funzione di vivaio, con piante coltivate per la vendita.  Padre e figlio intraprendenti I creatori dell'Arca, John Tradescant il vecchio (ca 1570-1638) e John Tradescant il giovane (1608-1662) sembrano personaggi da romanzo (e infatti Philippa Gregory, nota scrittrice inglese, ha dedicato loro due romanzi storici, al padre Earthly Joys e al figlio Virgin Earth). Il primo Tradescant come giardiniere servì il fior fiore della nobiltà inglese e il suo re Carlo I. Prese parte a un'ambasciata in Russia; visitò i frutteti olandesi; partecipò a una spedizione contro i pirati; accompagnò il suo signore lord Buckingham - quello dei Tre moschettieri - all'assedio della Rochelle. In tutti questi viaggi raccolse piante, semi e bulbi e curiosità per i suoi clienti ma anche per creare la collezione che sarà raccolta nell'Arca, situata a Londra nel quartiere meridionale di Vauxall. Il figlio John Tradescant il giovane (1608-1668) collaborò con il padre come giardiniere e raccoglitore di piante e curiosità; tra il 1628 e il 1637 fece un viaggio in Virginia in cui raccolse piante e molte curiosità americane per il museo. Dopo la morte del padre divenne giardiniere capo del re Carlo I; continuò ad arricchire il museo di cui scrisse anche il primo catalogo. Alla morte del suo unico figlio, promise di legare la collezione a Elias Ashmole; tuttavia alla sua morte si aprì un contenzioso con la vedova di John, Ester. Qualche tempo dopo Ester fu trovata annegata in uno stagno del giardino: incidente, suicidio, assassinio? In ogni caso, gli oggetti raccolti nell'Arca finirono a Ashmole, che alla sua morte li donò all'Università di Oxford, dove andarono a costituire il primo nucleo del celebre Ashmolean Museum. Altre informazione sui due Tradescant nella sezione biografie. Entrambi i Tradescant furono sepolti nel cimitero della chiesa di St. Mary a Lambeth; salvata dalla demolizione, la chiesa a partire dal 1977 ospita il Garden Museum, che recentemente ha riaperto dopo un'importante ristrutturazione che ha permesso di aggiungere due nuovi padiglioni con una parziale ricostruzione dell'Arca. I Tradescant riposano ancora nelle loro tombe circondate da un bel giardino a nodi.  Hortus tradescantianus I Tradescant sono considerati in Inghilterra i padri fondatori del giardinaggio inglese. Lo sanno bene i soci della Royal Horticultural Society, che per anni hanno letto nella rivista dell'associazione una rubrica firmata Trad's Diary (pseudonimo assunto dal pubblicista Hugh Johnson proprio in loro onore). Grazie ai viaggi e all'incessante attività di raccolta e coltivazione dei Tradescant fecero il loro ingresso nei giardini, negli orti e nei frutteti inglesi decine di piante provenienti dall'Impero ottomano, dal Nord Africa, da molti paesi europei, dal Nord America e dalle Indie. L'elenco delle nuove introduzioni è infinito: nuove varietà di peri, meli, pesche, nettarine, viti, ciliegie, noci; melograni, albicocchi, limette, pompelmi, ananas; nuove varietà di rose, gigli, anemoni, iris, clematidi e fragole; tulipani, fritillarie, gelsomini, vite vergine, Agapanthus, Anemone nemorosa, glicine, alcune varietà di rododendri; alberi come il larice, Liriodendrum tulipifera, Taxodium distichum, l'ippocastano, la robinia, il gelso... E l'elenco potrebbe continuare. Tra le piante americane introdotte dai Tradescant c'è anche quella che ne tramanda il nome: Tradescantia virginiana. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non fu introdotta dal figlio, ma dal padre che la ebbe da un amico, secondo la testimonianza del grande botanico John Parkinson, grazie alla quale risulta che la pianta era già coltivata nel 1629. Il legame con i Tradescant è presente fin dall'inizio, sia nel nome latino Phalangium virginianum Tradescanti sia in quello inglese Tradescant's Virginian spiderwort. Linneo ufficializzerà il nome Tradescantia virginiana nella prima edizione di Species plantarum del 1753. Tradescantia è un vasto genere di Commelinacaee, familiare a tutti, talmente facile da coltivare e comune nelle nostre case da essersi guadagnato il nome volgare "erba miseria". Racchiude piante talmente attraenti, varie e generose che vale la pena di rivalutarlo. Nella scheda se ne parla più diffusamente. La città francese di Rochefort, sulla costa Atlantica, offre al turista due attrazioni da non perdere: il grande edificio della Corderie Royale, al centro dell'Arsenale militare voluto da Luigi XIV, e il Conservatoire du Begonia, che vanta la più importante collezione di begonie d'Europa. Tra di esse c'è un legame: Michel Bégon, ri-fondatore della città e patrono del genere Begonia.  Un porto e un arsenale per il Re Sole La Francia del Re Sole non possedeva una flotta all'altezza delle altre potenze europee, dalla Spagna all'Inghilterra ai Paesi Bassi. Il re chiese dunque al superministro Colbert di costruire un grande porto militare dotato del "più grande e più bell'arsenale d'Occidente". La scelta cadde su un'area paludosa in un'ansa della foce del fiume Charente, che garantiva l'accesso al mare ma anche una posizione facilmente difendibile. Nel 1666 nasce così Rochefort. Quando Michel Bégon (1638-1710) vi approda, nel 1688, l'arsenale è operativo da pochi anni, ma resta ancora molto da fare. Su sua iniziativa vengono riedificati in pietra i quartieri abitativi, fino ad allora occupati da baracche di legno; inoltre opere di canalizzazione rendono più salubre l'abitato, infestato dalla malaria. Come ricorda il suo epitaffio, "Trovò questa città nascente in legno, la lasciò di pietra". Bégon, appassionato collezionista e cultore di botanica, ha fitti rapporti epistolari con scienziati, come Plumier o Tournefort che aveva conosciuto quando era intendente delle galere di Marsiglia. Anche grazie al suo impulso, Rochefort diventa la base di partenza delle spedizioni naturalistiche, che incominciano a infittirsi alla fine del XVII secolo. La città è il porto d'arrivo delle piante esotiche che arrivano dalle America, dall'Asia e dall'Africa, come ci ricorda il suggestivo nome di "Jardin des Retours" (Giardino dei ritorni) con il quale è stato battezzato il parco che circonda la Corderie royale (inaugurato nel 1991). Altre notizie su Bégon, sicuramente un personaggio interessante al di là dei suoi meriti botanici, nella sezione biografie.  Rochefort, capitale mondiale della Begonia Ma veniamo alla Begonia, di cui Rochefort si proclama la "capitale mondiale". Intorno al 1690, rientrato a Rochefort dal suo primo viaggio nelle Antille Charles Plumier dedica all'intendente della città la Begonia flore roseo folio orbiculare (oggi Begonia rotundifolia). In tal modo il frate paga un debito di riconoscenza: era stato proprio Bégon, in quel momento Intendente delle galere di Marsiglia, a fare il suo nome come botanico e disegnatore della spedizione nelle Antille. Inoltre l'uomo politico ben conosceva le isole, di cui era stato Intendente negli anni 1682-83. Botanofilo, si era interessato della flora locale e ne aveva redatto un catalogo. Passano i secoli e Rochefort sembra dimenticarsi della Begonia; in Francia il fiore non è molto di moda. Fa eccezione una straordinaria figura di coltivatore. Negli anni '60 del Novecento, il giardiniere Vincent Millerioux, specializzato in piante tropicali, incomincia a coltivare e collezionare begonie, mettendo a punto un substrato specifico. Quando nel 1985 cessa l'attività, la sua collezione, che comprende 400 tra specie e ibridi, rischia di essere dispersa; la città di Rochefort decide di acquisirla. Le circa 200 talee che arrivano nel 1986 saranno il primo nucleo del Conservatoire du Begonia che vanta oggi circa 1500 esemplari, 500 specie e 1000 ibridi. A partire dal 1988, le begonie trovano casa in una magnifica serra alla periferia della città, indovinate a quale indirizzo? in rue Charles Plumier n. 1! Nella gallery potete vedere alcune fotografie scattate in un afoso e indimenticabile pomeriggio del luglio 2011. Non mancate almeno una visita virtuale al sito del Conservatoire. Nella sezione schede notizie e curiosità sul genere Begonia. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

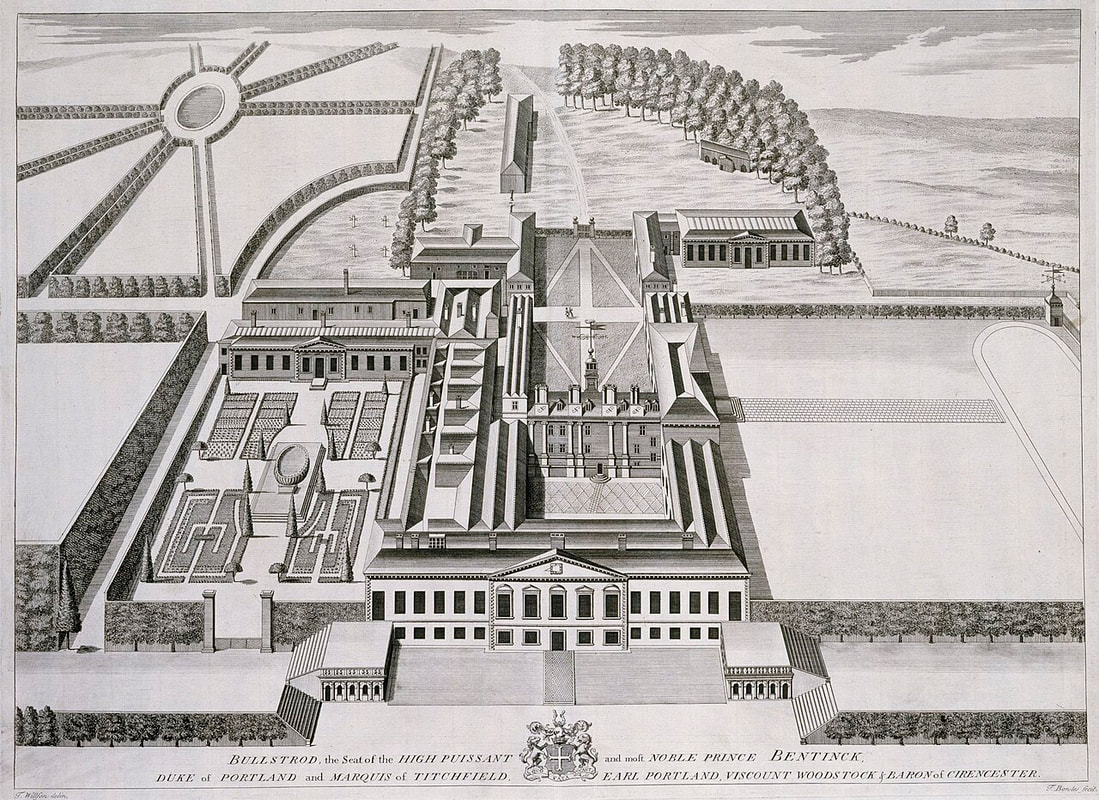














 RSS Feed
RSS Feed