|
In un articolo pubblicato qualche anno fa, Paolo Pejrone ha definito Beaumontia grandiflora "una dominatrice come la Lady che per prima la coltivò". Il riferimento è a Diana Wentworth Beaumont che, anche se si atteggiava a gran dama, non era affatto una lady; anche il fatto che fosse una dominatrice non è per nulla certo. Vicini malevoli ce ne hanno consegnato un ritratto caricaturale che forse è solo il frutto di risentimenti e pregiudizi sociali; anche se il personaggio era indubbiamente sopra le righe, le testimonianze di Loudon, Wallich e del giardiniere Marnock vanno in senso totalmente diverso. Certo amava la grandiosità e l'ostentazione, e lo dimostra anche la sua maggiore realizzazione come "donna di piante": la spettacolare serra tropicale a cupola, la più grande del suo tempo. Poco dopo la sua morte fu smantellata e la conosciamo solo da qualche disegno.  Una discutibile leggenda nera Oggi è quasi dimenticato, ma al momento della sua uscita nel 1826 il romanzo satirico Almack's ebbe un certo successo. Prendeva infatti di mira una delle istituzioni dell'età della reggenza, Almack’s Assembly Rooms, che fu uno dei primissimi club ad ammettere sia uomini sia donne e divenne uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi ed esclusivi della capitale, con i suoi balli del mercoledì cui si poteva accedere solo dietro invito, a insindacabile giudizio delle patronesse, un gruppo di dame dell'alta società. Tra i personaggi figura una certa Lady Birmingham, descritta come una donna di bassa nascita, volgare e piena di pretese, che ostenta le sue ricchzze e i suoi diamanti. E' orgogliosisima del suo giardino; in una scena, a proposito delle piante americane della sua residenza di campagna, si vanta così: "Lee e Kennedy mi hanno detto che ho la collezione più bella dell'intero regno. Sono sicura che ben poche persone ne hanno così tante come me [...]. Al momento sono impegnatissima con gli arbusti, sto ampliando i miei impianti americani e sto creando un nuovo roseto; ne ho 180 nuove varietà". Dietro questo ritratto velenoso, i contemporanei riconoscevano facilmente una persona reale: Diana Wentworth Beaumont (1765–1831). Il romanzo fu pubblicato anonimo, ma era ben noto che l'autrice era Marianne Spencer-Stanhope Hudson. Gli Spencer-Stanhope erano vicini di casa dei Wentworth nello Yorkshire e, mentre i membri la vecchia generazione, rappresentata da sir Thomas Wentworth (1726-1792) di Bretton Hall e John Spencer di Cannon Hall, erano grandi amici, i giovani Spencer-Stanhope non perdevano occasione per prendere in giro la figlia maggiore ed erede Diana e le sue arie da gran dama e tra di loro la chiamavano sarcasticamente Madame Beaumont. Un'altra delle Spencer-Stanhope, Mrs Pickering, nata Anna Maria Wilhelmia Spencer-Stanhope, nelle sue memorie descrisse la giovane Diana come una serva di cucina che vendeva le uova al mercato di Pensitone; bambina al momento della morte di lei, doveva aver raccolto questa diceria dalla bocca di qualcuno dei suoi parenti. Si trattava certamente di una grossolana calunnia, che però in qualche modo rifletteva la nascita irregolare di Diana Wentworth. Suo padre, sir Thomas Wentworth, era stato uno scapolo impenitente e libertino che aveva sempre rifiutato di sposarsi, benché avesse avuto numerosi figli illegittimi da varie amanti. Un figlio e tre figlie, nate tra il 1765 e i 1775, di cui Diana era la maggiore, vennero riconosciuti e le ragazze, anziché servire in cucina, ebbero un'ottima educazione in collegi femminili. Sorprendentemente, nel suo ultimo testamento, scritto poche settimane prima della morte, sir Thomas, tranne un piccolo lascito e una rendita annuale, diseredò il maschio, lasciò cospicui lasciti alle figlie minori e le terre e il grosso del patrimonio a Diana. Non conosciamo il motivo di questa decisione controcorrente; Karen Lynch ipotizza che non ci fossero migliori mani di quelle di lei cui affidare l'amatissimo Bretton Hall; in effetti, una clausola del testamento stabiliva che la casa doveva continuare ad essere abitata dalla famiglia e che essa e i giardini dovevano essere mantenuti in perfetto ordine. Sir Thomas è stato descritto come un personaggio eccentrico i cui unici interessi dichiarati erano la caccia, i cavalli, le bevute, le donne e la tenuta di Bretton Hall; erede per parte materna della famiglia Blackett, proprietaria di miniere di carbone e piombo presso Durham, aveva investito grosse somme per rimodellare il parco. Inizialmente si affidò all'architetto Richard Woods, che creò un lago artificiale interrompendo il corso del fiume Dearne con una diga. Dopo il crollo della diga in seguito a una piena, preferì fare da solo "senza ricorrre a Capability [Brown] o a simili pretenziosi bricconi"; qualche anno dopo, volle un secondo lago "grande abbastanza per Giona e la sua balena". Nel parco, percorso da piacevoli viali, fece piantare molti alberi e creò diversi edifici di gusto gotico; uno degli isolotti ospitava addirittura un piccolo zoo. Diana condivideva con il padre l'amore per le piante e la natura, e probabilmente ne aveva ereditato anche l'eccentricità, la testardaggine e il gusto per l'eccesso. Nel 1786, a circa 20 anni, sposò un proprietario terriero dello Yorkshire di modesta fortuna, Thomas Richard Beaumont; nel 1792, dopo la morte di sir Thomas, la coppia fece di Bretton Hall la sua residenza principale, anche se soggiornava spesso anche a Hexam Abbey e in altre proprietà e durante la stagione mondana viveva a Londra. Grazie alle proprietà ereditate dal padre nello Yorkshire e nel Northumberland, Diana Wentworth Beaumont era già molto ricca; intelligente e dotata di un grande senso degli affari, durante la sua gestione raddoppiò il patrimonio, tanto che al momento della morte era considerata la commoner più ricca del paese. Il marito, che i contemporanei descrivono come una "testa debole" succube della moglie, forse era semplicemente abbastanza intelligente da delegare l'amministrazione a Diana, molto più abile di lui, che per altro spesso era lontano da casa come militare; tra il 1794 e il 1803 fu infatti colonnello di un reggimento di cavalleria. Thomas Richard intraprese anche una carriera politica; fu deputato per il Northumberland ininterrottamente dal 1795 al 1818. Era schierato con i Tory e con il governo e in questo lungo periodo non è noto che abbia preso la parola nemmeno una volta. La sua massima aspirazione - sicuramente condivisa dalla moglie - era ottenere un titolo nobiliare; corteggiava regolarmente il primo ministro di turno nella speranza di una baronia, ma nessun ministro gliela concesse mai, sicuro di avere comunque il suo voto. Il titolo non c'era, ma tanto nelle tenute di campagna quanto a Londra, i Beaumont vivevano in modo assai sfarzoso, secondo lo stile degli aristocratici; ma poiché non lo erano, suscitavano il riso di quella società intrisa di pregiudizi sociali. Gli Spencer-Stanhope si sbellicavano quando vedevano "Madame Beaumont" attraversare il villaggio con una carrozza trainata da due pariglie di cavalli neri e guidata da postiglioni in livrea di velluto; Lady Aynsley arricciva il naso ascoltandola vantare le rendite delle sue miniere di piombo. Certamente Diana era una donna imperiosa, tenace nel perseguire i suoi obiettivi, che aveva fama di litigare con tutti, compreso il figlio maggiore. Eppure, se ascoltiamo altre campane. il ritratto muta colore: non più una "dominatrice" soffocante, come l'ha definita anche Paolo Peirone, ma un'amministratrice puntuale, precisa e attenta ai bisogni e alla dignità dei suoi dipendenti. L'architetto paesaggista John Claudius Loudon. che visitò più volte Bretton Hall, ha scritto di lei: "Nessuna signora è stata una padrona più liberale e sollecita verso i suoi dipendenti, né una migliore proprietaria terriera rispetto ai suoi affittuari"; il ritratto tracciato dal capo giardiniere Robert Marnock - scritto vari anni dopo la morte di lei e quindi senza alcuna piaggeria interessata - è addirittura un peana: "Mrs Beaumont per la sua consuetudine con gli affari e l'ordine possedeva una mente dal potere gigantesco. Quando lavoravo come giardinere, mi dava spesso appuntamento presso un determinato albero, a un'ora e un minuto specifico e, sebbene questi appuntamenti fossero frequenti e a volte fissati una settimana o dieci giorni in anticipio, non ricordo una singola occasione in cui abbia mancato di presentarsi all'esatto minuto fissato; la sua puntualità e precisione non erano riservati alla sistemazione del giardino ma emergevano nella sua condotta nell'intera tenuta. Era un esempio ammirevole per i domestici, che dovrebbe essere seguito da padrone e padroni dei nostri giorni. Non si permise mai di entrare nell'orto durante l'orario di lavoro senza aver prima suonato la campana del giardino [...]. Proprio perché era così scrupolosa ed esatta nel disbrigo dei suoi affari, riusciva a trovare il tempo di dedicarsi al giardino e alla botanica, e all'occasione patrocinare meriti altrimenti senza sostegno". 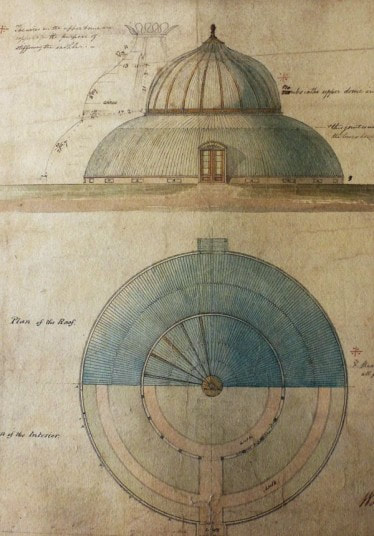 Un giardino senza rivali E' ora dunque di parlare di Mrs Beaumont come giardiniera e collezionista. La sua passione si esercitò soprattutto nel giardino di Bretton Hall che ereditò dal padre nel 1792 e continuò ad abbellire con interventi costanti per quarant'anni. Questi lavori, che non sembrano obbedire a un progetto coerente, ma piuttosto alle necessità e all'estro del momento, furono affidati di volta in volta ad architetti sempre diversi (che Diana litigasse con tutti non era forse così infondato). Il primo fu John Carr che già nel 1793 fu incaricato di ristrutturare la sala da pranzo e la biblioteca; nel 1803 un certo Mr Mickle disegnò le ringhiere del parco; nel 1804 un altro noto architetto, Willian Atkinson, disegnò un'aranciera, un museo per le collezioni naturalistiche, una latteria e l'Archway Lodge, una sorta di ingresso monumentale fiancheggiato da colonne con un arco abbastanza ampio da consetire l'ingresso di una carrozza. Fu poi la volta di William Lindley, cui si devono nuove cucine, la scuderia e una grotta con conchiglie; nel 1811 Jeffry Wyatt disegnò una voliera, alcuni cottage e la serra delle camelie che è uno dei pochi manufatti dell'epoca di Diana oggi conservato. Destinata ad ospitare la collezione di piante semirutiche provenienti dall'Asia, è un luminoso edifico in pietra ma con grandi finestre ad arco e un tetto in vetro e ghisa. I Beaumont ricevevano spesso (Mary Russell Mitford che fu loro ospite nel 1806 ricorda che ai loro pranzi partecipavano trenta o quaranta persone); si prestava dunque grande attenzione all'orto e al frutteto che dovevano provvedere una quantità sufficiente di verdure e frutti per la tavola della famiglia, del personale e degli ospiti. Fino al 1825 a occuparsene fu Christie Duff, rinomato per la coltivazione dei mirtilli rossi, del crescione, dei peschi a spalliera e la moltiplicazione dei rizomi di zenzero. Quando questi si licenziò, venne assunto come "caposquadra dell'orto" il già citato Robert Marnock (1800-1889) che quattro anni dopo sarebbe stato promosso capo giardiniere. I suoi ricordi, scritti una ventina di anni dopo, quando Marnock dirigeva l'orto botanico di Sheffield ed era una delle figure di punta del movimento Gardenesque, fanno rivivere i giardini di Bretton Hall negli anni d'oro: "Circa vent'anni fa, quando lo vidi la prima volta. Bretton Hall non aveva rivali per i suoi giardini, tanto per l'estensione quanto per la varietà. La forzatura di uva, ananas, pesche, fichi ecc. era praticata estesamente; c'era anche un'estesa collezione di piante da serra fredda e calda, un assortimento di piante erbacee rustiche che occupavano un'area circolare di non meno di tre acri, con le piante sistemate secondo il sistema di Linneo. Oltre a tutto questo, c'era un orto murato di sei o otto acri per la coltivazione delle verdure e la produzione di frutti rustici. All'epoca alla quale mi riferisco, c'erano sei grandi serre per la forzatura di pesche e nettarine; due vigne protette; una serra per i fichi; nove serre riscaldate per gli ananas con innumerevoli buche; due grandi aranciere e altrettante serre riscaldate. Infine un'immensa serra eretta dai Bailey di Holborn con una spesa 8.000 o 10.000 £, riscaldata con un complicato e costoso apparecchio a vapore". Siamo così arrivati alla celebre serra di Bretton Hall. Iniziata nel 1826, ma non completata fino al 1829 - non senza una causa legale che contrappose i coniugi Beaumont alla ditta londinese Bailey - era un edificio avveniristico, interamente costruito in vetro e ghisa; circolare, con un diametro di circa 18 metri, aveva un'alta volta a cupola, che raggiungeva l'altezza massima di circa 14 metri. Poco dopo il completamento della serra, il colonnello morì e la moglie lo seguì poco più di due anni dopo, nell'agosto del 1831. Il figlio ed erede, Thomas Wentworth Beaumont, in rotta con la madre che, dopo la sua maggiore età, aveva rifiutato di anticipargli l'eredità e aveva mantenuto il pieno controllo dei propri beni, non partecipò al funerale e si afffrettò a vendere all'asta tutto ciò che le ricordava la madre, di cui (lui educato a Eton e Cambridge) disapprovava gli eccessi. Almeno, questa è la versione che circolò. Forse, più prosaicamente, benché divenuto a sua volta il commoner più ricco del regno, aveva bisogno di liquidità per saldare i fornitori e i debiti in sospeso, e soprattutto per versare i cospicui lasciti testamentari che la madre aveva diposto per i figli e le figlie minori, dimostrando ancora una volta la sua indipendenza di pensiero. Tra i beni alienati, anche la serra circolare che fu svenduta a un fabbricante di birra, più interessato al sistema di riscaldamento che all'edificio in sè, che fu totalmente smantellato. Ne rimane solo qualche disegno.  Un'amicizia botanica e uno scambio intercontinentale Sia Marnock sia Loudon lamentarono che i vari interventi nel parco di Bretton Hall si erano succeduti senza un disegno unificante; in effetti, più che al parco in sè, Mrs Beaumont era interessata alla sua collezione di piante rare, per la quale aveva fatto costruire successivamente la grande aranciera vetrata e la serra circolare. Al contrario del suo doppio letterario, lady Birmingham, non raccoglieva piante americane, ma soprattutto asiatiche che le furono spedite con una certa frequenza da Nathaniel Wallich a partire dal 1815. Mrs Beaumont era interessata alle scienze naturali (abbiamo visto che aveva allestito un piccolo museo, con una collezione soprattutto di minerali, e che in una parte del suo giardino le piante erano sistemate in modo sistematico, come in un orto botanico); era abbonata alle Transactions della Linnean Society alla quale inviava regolarmente esemplari delle sue piante più rare. In tal modo era entrata in contatto con Smith, Lambert e Banks. Permetteva anche agli artisti botanici di frequentare il suo giardino per ritrarre le piante dal vivo. In tal modo si era fatta una certa fama di protettrice della botanica. Nathaniel Wallich che - ricordiamolo - era suddito danese e per questa ragione era stato anche imprigionato come cittadino di una potenza ostile - nel 1815 era entrato al servizio della Compagnia delle Indie e cercava un patrono influente. Ovviamente aveva pensato a Banks e si era messo in contatto con lui attraverso Thomas Hardwicke, suo amico e membro dell'Asiatic Society. Hardwicke gli suggerì di rivolgersi anche a Mrs Beaumont che, come moglie di un membro della Camera dei Comuni e proprietaria di estesi giardini, avrebbe potuto a sua volte offrire una via d'accesso a Banks, Lambert e i vertici della Compagnia delle Indie. Così Wallich nel dicembre 1815 le scrisse e le spedì piante vive e semi. Fu l'inizio di uno scambio botanico nelle due direzioni; confermandosi una donna concreta, sollecita e cortese, Diana non si accontentò di ringraziare ma ricambiò il dono, scrivendo: "Quest'autunno chiederò al mio giardiniere di raccogliere tutti i semi che egli riterrà accettabili per voi, per l'orto botanico di Calcutta; ne ho parlato ai direttori della Compagnia, chiedendo che vi vengano spediti. Ciò mi ha dato l'opportunità di menzionare i vostri propositi e di sostenerli con le mie più forti raccomandazioni, come ho fatto con sir Joseph Banks e Mr Lambert, e ho ogni ragione di sperare che se ne cureranno". Da quel momento Mrs Beaumont per Wallich divenne un punto di riferimento, una protettrice e un'amica. Dello scambio si arricchirono tanto Bretton Hall quanto l'orto botanico di Calcutta - anche se non sappiamo di quali piante; l'unico campione dell'erbario di Wallich indicato come "Beaumont" e proveniente da Bretton Hall è la leguminosa Senna multijuga, nativa del Messico e dell'America subtropicale. Wallich provvide Bretton Hall di molte piante raccolte in varie parti dell'India e in Nepal, e proprio per accoglierle al meglio Mrs Beaumont fece costruire la grande serra a cupola. Tra le piante introdotte da Mrs Beaumont attraverso Wallich e coltivate per la prima volta a Bretton Hall, possiamo citare Wallichia caryotoides, Callianthe striata, Garcinia dulcis, Clerodendrum nutans, Hovwa pannosa, Tupistra nutans, Tetracera sarmentosa. Senza dimenticare Beaumontia grandiflora, su cui torneremo tra poco, e lo splendido Rhododendron arboreum, di cui Mrs Beaumont aveva trasmesso i semi al vivaio di piante esotiche di Joseph Knight. In effetti, Diana fu utile a Wallich anche mettendolo in contatto con vivai che potevano essere interessati a commercializzare le sue piante. Nel 1829, qundo venne in Inghilterra, visitò Mrs Beaumont a Bretton Hall e visitò con lei proprio il vivaio di Knight. Eccoci dunque giunti a Beaumontia, il piccolo genere di rampicanti dell'Asia tropicale dedicato alla amica e protettrice nel 1824 con questa motivazione: "L'ho nominato in onore della Sig.a Diana Beaumont, devotissima all'orticoltura e alla scienza botanica in Inghilterra e munifica fautrice di entrambe, alla cui benevolenza il giardino di Calcutta deve molte piante esotiche soprattutto europee". Beaumontia (famiglia Apocynaceae) comprende otto-dieci specie di rampicanti e liane nativi della Cina, del subcontinente indiano e del sudest asiatico. La specie più coltivata è B. grandiflora, un vigoroso rampicante sempreverde (anche se può perdere le foglie nella stagione secca) che produce un lussureggiante fogliame verde lucido e profumatissimi fiori bianchi campanulati raccolti in infiorescenze terminali. Resistendo per brevi periodi a temperature prossime allo 0, può essere coltivata anche in parte del nostro paese, in pieno sole e in posizione protetta, ma senza dimenticare che può raggiungere dimensioni ragguardevoli e richiede un supporto robusto.
0 Comments
Joséphine de Beauharnais, ovvero l'imperatrice Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, è nota per la passione per la botanica, che profuse nella creazione dello splendido parco del castello di Malmaison, successivamente residenza dei Bonaparte negli anni del consolato, poi casa di campagna e rifugio in quelli dell'impero, infine, dopo il divorzio, la sua casa, la sua consolazione, il luogo dove morì. Dotato di una serra calda all'avanguardia, fu funzionale all'introduzione in Francia di quasi duecento specie esotiche, soprattutto australiane. Per tutti, Joséphine è anche l'imperatrice delle rose, che certamente amava, ma probabilmente non di quell'amore esclusivo che le attribuisce il mito. A ricordarla contribuisce anche la splendida e capricciosa Lapageria (dal suo nome da ragazza, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie). Un parco all'inglese Il noto motto latino nomen omen, "nel nome c'è il destino", almeno a Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (1763-1814) parrebbe calzare. Fino a quando Napoleone Bonaparte la ribattezzò con il nome con cui è passata alla storia, per tutti fu Rose, un nome che preannunciava l'importanza che nella sua vita ebbero le piante, comprese le rose. Quando si incontarono per la prima volta in un salotto parigino, lei era Mme Rose de Beauharnais. Lui aveva 26 anni, lei 32, e aveva già alle spalle una vita tumultuosa e molto chiacchierata. Era nata in Martinica nella piantagione di una famiglia nobile ma impoverita; poi, ad appena 16 anni, erano arrivati il matrimonio con un nobile dissipatore e femminiere, prima dei vent'anni un figlio e una figlia, quindi la separazione, il carcere durante il terrore, la vedovanza in seguito all'esecuzione del marito Alexandre de Beauharnais. E debiti, tanti debiti, e amanti veri o presunti. L'ultimo, quello in carica al momento, si diceva fosse Paul Barras, uno dei cinque direttori. Che, secondo una delle varie versioni, sarebbe anche colui che presentò ufficialmente la bella vedova a Napoleone, che aveva appena nominato generale per essersi distinto nella repressione di un'insurrezione monarchica. Fu l'inizio di un amore appassionato da parte di lui - un po' meno da parte di lei - che sfociò nel matrimonio il 9 marzo 1796, due giorni prima che Bonaparte partisse per la Campagna d'Italia. Rose non era più Rose, ma Joséphine, come Napoleone l'aveva ribattezzata a partire dal suo secondo nome, forse per rifarla propria e cancellare quel passato tanto chiacchierato. E mentre Napoleone diventava Napoleone, Joséphine aveva finalmente un giardino. Nell'aprile 1799, mentre il marito era impegnato nella Campagna d'Egitto, ricorrendo a un prestito - era abituata a fare debiti - acquistò per 325.00 franchi il castello e la tenuta di Malmaison, a una dozzina di km da Parigi. Al suo ritorno Bonaparte andò su tutte le furie per quella spesa folle, ma, dopo il colpo di stato del 18 brumaio che lo rese padrone della Francia, si addossò il debito, forse attingendo al denaro predato in Italia ed estese addirittura il parco dagli iniziali 60 a 260 ettari. Anche per lui, Malmaison divenne la casa del cuore e per tutto il consolato ne fece la propria residenza; tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuilerie, fu addirittura la sede del governo. Joséphine era decisa a trasformare la tenuta "nel giardino più bello e curioso d'Europa, un modello di buona coltivazione". Inizialmente i lavori vennero affidati agli architetti Percier e Fontaine, che, oltre a restaurare il castello (loro avrebbero voluto abbatterlo e ricostruirlo, ma Napoleone optò per una più economica ristrutturazione), nel 1801 incominciano a recintare il parco, costruirono strutture di servizio come stalle per i cavalli e padiglioni di guardia, eressero il cancello principale e, per le piante di Joséphine, una orangerie riscaldata in grado di produrre 300 piante di ananas. Tuttavia presto emersero contrasti con Mme Bonaparte, che considerava il loro gusto in fatto di giardini troppo classico; desiderava un giardino all'inglese di gusto romantico e paesaggistico. Si rivolse così ai due guru del giardino all'inglese in Francia, lo scozzese Thomas Blaikie, che aveva disegnato il giardino di Bagatelle per il conte d'Artois, e Jean-Marie Morel, autore dell'influente Théorie des Jardin (1777). Morel costruì uno chalet svizzero, una stalla per le mucche, una latteria e una casa per i vaccari fatti venire dalla Svizzera e iniziò la costruzione della serra riscaldata (Grande serre chaude), completata nel 1805 da Thibault e Vignon. Costruita secondo i criteri più avanzati dell'epoca, era la prima in Francia a prevedere una così ampia superficie in vetro; lunga circa 50 metri e larga 19, era riscaldata da 12 stufe e poteva ospitare piante alte fino a 5 metri. La serra era addossata a un elegantissimo padiglione con una serie di salotti e una rotonda centrale raffinatamente arredati in cui era possibile riposarsi, intrattenersi ed ammirare piante rare e una collezione di vasi greci. Neppure Morel soddisfaceva del tutto il gusto romantico della ormai imperatrice (fu incoronata dallo stesso marito e congiuntamente a lui il 2 dicembre 1804); alla fine del 1805 gli subentrò Louis-Martin Berthault, in cui Joséphine trovò quasi un'anima gemella che l'avrebbe servita fino alla morte. Egli costruì una nuova galleria per ospitare le collezioni d'arte e a partire dal 1807 ridisegnò completamente il parco, creando un parco chiuso di 70 ettari perfettamente integrato nel paesaggio, con gli alberi disposti in modo da permettere allo sguardo di spaziare su monumenti già esistenti come l'acquedotto di Marly o il castello di Saint Germain. Berthault disegnò sentieri serpeggianti, fece scavare un corso d'acqua sinuoso che si allargava a formare un laghetto e disseminò il parco di edifici di gusto romantico: il Tempio dell'amore, il tumulo funerario della Malinconia, una grotta con rocce fatte venire da Fontainbleau. Tutte cose che facevano impazzire l'imperatrice, ma non l'imperatore, che le definiva sprezzantemente niaiseries "stupidaggini", e volle per sè un angolo di gusto più classico. Per ospitare gli animali giunti dall'Australia - li ritroveremo tra poco - c'erano una voliera e uno zoo; alla fattoria si aggiuns un allevamento modello di pecore merino. 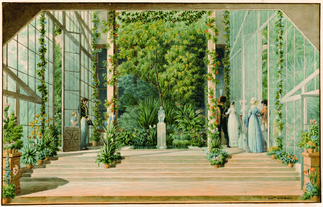 Le piante e gli uomini di Malmaison Fin dall'acquisto di Malmaison, Joshéphine era intenzionata a popolarne il parco e le serre con una collezione unica di piante esotiche. In primo luogo, forse già dalla primavera del 1800, si rivolse a André Thouin, il capo giardiniere del Jardins des Plantes che, oltre ad essere il massimo esperto di acclimatazione di esotiche in terra di Francia, negli anni aveva costruito un'immensa rete di corrispondenti che includeva botanici, giardinieri, vivaisti e collezionisti sia nel paese sia all'estero. In una lettera dell'agosto 1800, firmata Lapagerie Bonaparte, la futura imperatrice lo ringrazia per l'invio di frutti di fico-banana (Ficus pleurocarpa) che "mi hanno ricordato il paese natale e mi hanno dimostrato che siete capace di trionfare di ogni clima e di portare ogni cosa a perfezione". Scrisse anche alla madre, che continuava a vivere in Martinica; in una lettera del 1802 leggiamo: "Mandatemi tutti i semi d'America e tutti i frutti: batate, babane, aranci, manghi, infine tutto ciò che potrete". Thouin la mise in contatto con Jacques Martin Cels (1740-1806), un collezionista che, rovinato dalla rivoluzione, aveva trasformato la sua passione in professione, aprendo a Montrouge, nella periferia sud di Parigi, un vivaio in cui coltivava soprattutto piante americane introdotte da André Michaux. Il suo lavoro fu continuato dal figlio François (1771-1832) che allargò il vivaio e si specializzò nella coltivazione di esotiche ornamentali; nel suo catalogo del 1817 troviamo, accanto alle americane, anche molte sudafricane, dalie, e una notevole collezione di rose, circa 200 varietà, principalmente Gallica. Sicuramente il vivaio Cels fu uno dei principali fornitori di Malmaison, anche per le rose (ma su questo tornerò più avanti), insieme a quello di un altro contatto di Thouin, Louis Claude Noisette (1772-1849). Figlio di un giardiniere del conte di Provenza, intorno al 1798 aveva aperto un vivaio dove coltivava soprattutto piante americane, ottenute attraverso uno dei suoi fratelli, Philippe Stanislas, che viveva a Charleston. Uno dei suoi invii è Old Blush Noisette, la prima delle rose Noisette; ma giunse in Francia nel 1814, troppo tardi per essere coltivata a Malmaison. Joséphine ottenne molte piante dal Jardin des Plantes, e molto lo acquistò dai vivai, spendendo somme folli; è del marzo 1804 una consegna di 2014 tra erbacee, alberi e arbusti. Seppe inoltre approfittare del potere del marito; piante le giunsero dai botanici che accompagnarono Napoleone in Egitto e durante le campagne napoleoniche; in Italia come a Vienna, piante furono requisite dai giardini degli sconfitti per essere inviate a Malmaison. L'imperatore sollecitava diplomatici, ufficiali di marina e funzionari ad approfittare di ogni occasione per soddisfare la passione botanica della moglie e Joséphine stessa faceva pressione su ministri, dignitari, agenti francesi all'estero. Ad arricchirne il parco e le serre di piante in precedenza mai viste in Europa fu però soprattutto la sventurata spedizione Baudin, sponsorizzata da Napoleone primo console, ed in particolare il ricco carico del Géographe, che raggiunse Lorient nel marzo 1804. Napoleone aveva ordinato che il giardino di Malmaison avesse la precedenza sul Jardin des Plantes e quando Thouin ispezionò il carico, scoprì di essere già stato preceduto da Mirbel, il sovrintendente di Malmaison; così, delle 230 piante sopravvissute al tumultuoso viaggio, le 98 più sane presero direttamente la strada delle serre di Joséphine. Insieme a loro viaggiavano anche canguri, emù e una coppia di cigni neri, che divennero quasi un simbolo del giardino dell'imperatrice. Da quel momento, d'un colpo le serre di Malmaison ospitarono la più importante collezione europea di piante australiane, più ricca di quella degli stessi Kew Gardens. Per altro, le piante inglesi o importate dai britannici non mancavano. Come ho già raccontato parlando del vivaio Lee & Kennedy, a partire dal 1803 The Vineyard divenne il maggiore fornitore dei giardini dell'imperatrice; grazie alla compiacenza di Banks, con il quale Joséphine era in contatto attraverso il botanico Etienne Ventenat, ottenne anche alcune piante di Kew e soprattutto un passaporto che permise a Kennedy di continuare a fare la spola tra Francia e Inghilterra con i suoi carichi di piante nonostante lo stato di guerra e il blocco continentale. Con Kennedy, Joséphine creò addirittura un consorzio per inviare in Sudafrica il cacciatore di piante James Niven. Joséphine seppe anche circondarsi di personale molto qualificato. Nel 1801 ingaggiò un giardiniere scozzese, Alexander Howatson; in tempo di guerra, avere un dipendente britannico spiaceva assai a Napoleone, che nel 1805 approfittò del conto troppo salato di un trasporto di piante per licenziarlo. Egli fu così sostituito da Felix Delahaye, che era stato il giadiniere della spedizione Entrecasteaux, durante la quale aveva fatto estese raccolte; aveva poi lavorato per un certo periodo nel giardino di Pamplemousses a Mauritius e dopo il ritorno in Francia aveva restaurato i giardini del Trainon e il vecchio giardino di Maria Antonietta a Versailles. Era dunque un esperto di coltivazione di esotiche e, soprattutto, era forse l'unico giardiniere europeo ad avere visto le piante australiane in natura e molte le aveva raccolte lui stesso. Abbiamo già incontrato di passaggio due dei botanici che lavorarono per Joséphine a Malmaison, Mirbel e Ventenat. Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854) ad appena vent'anni era diventato assistente naturalista al Muséum ed era un promettente scienziato, destinato a diventare il padre fondatore della citologia; nel 1803 Mme Bonaparte lo assunse come sovrintendente di Malmaison, dove poté continuare i suoi studi sui tessuti vegetali, l'evoluzione degli organi delle piante e le epatiche del genere Marchantia. Nel 1806 però egli lasciò Malmaison per entrare al servizio del re d'Olanda Luigi Bonaparte, che oltre ad essere fratello di Napoleone, era anche genero di Joséphine in quanto marito di sua figlia Hortense Beauharnais. A sostituirlo fu Etienne Pierre Ventenat (1757-1808). Fratello di Louis Ventenat, cappellano e naturalista morto durante la spedizione Entrecasteaux, era entrato nell'orbita dell'imperatrice grazie a Cels. Allievo e collaboratore di L'Héritier de Brutelle, in gioventù si era segnalato per la traduzione in francese di Genera plantarum di Antoine Laurent de Jussieu, poi, come il suo maestro, aveva focalizzato la sua attenzione sulla pubblicazione di piante nuove per la scienza. Nel 1799 pubblicò Descriptions des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels, illustrato da 100 tavole in gran parte dovute ai fratelli Pierre-Joseph e Henri-Joseph Redouté. La raffinatezza di quest'opera attirò l'attenzione di Joséphine che volle qualcosa di simile per far conoscere al mondo le proprie collezioni di cui era estremamente fiera. Commissionò così a Ventenat i testi e Pierre-Joseph le illustrazioni del magnifico Jardin de Malmaison; in due tomi, usciti in 20 fascicoli tra l'aprile 1803 e il novembre 1805, comprendo 120 calcografie a colori incise da Allain a partire da acquarelli di Redouté e la descrizione di 161 specie, molte delle quali nuove per la scienza, scritta da Ventenat. Come ho anticipato, nel 1806 Ventenat fu nominato intendente e prese così sul serio l'incarico da morire, esausto di fatica, appena due anni dopo. A succedergli fu Aimé Bonpland, che era stato compagno di Humboldt nel suo viaggio sudamericano. Egli curò tra l'altro i testi di Descriptions des Plantes Rares Cultivées à la Malmaison (1812-1817), anch'esso illustrato da Redouté. Anche questo grande artista, soprannominato il "Raffaello dei fiori", può essere annoverato tra gli uomini di Joséphine. Oltre alle due opere già citate, i fiori di Malmaison ispirarono il suo capolavoro, Les Liliacées; pubblicato in 8 volumi di grande formato, usciti tra il 1802 e il 1816, comprende 486 incisioni a colori di altrettante specie di bulbose e monocotiledoni (non solo Liliaceae in senso stretto). Joséphine riuscì a convincere il ministro dell'interno Chaptal ad acquistarne 80 copie che furono distribuite tra dignitari e biblioteche in tutto il paese e all'estero. L'altro libro più noto di Redouté, Les Roses (1817-1824) fu creato dopo la morte dell'Imperatrice e ritrae rose coltivate in vari giardini francesi, non solo a Malmaison. Furono invece commissionate da Joséphine intorno al 1812 al pittore Auguste Garneray le 12 vedute del parco e della serra, oggi un documento inestimabile per ricostruirne l'aspetto. Essi infatti non sopravvissero a lungo alla loro creatrice, Nel 1809, essendo chiaro che, per la sua età, Joséphine non gli avrebbe mai dato un erede, Napoleone si decise a chiedere l'annullamento del matrimonio, sancito nel gennaio 1810. Fu però generoso con la ex moglie, con cui mantenne rapporti cordiali: essa conservò il titolo di imperatrice, cui si aggiunse quello di duchessa di Navarre (dal castello in Normandia che le donò dopo il divorzio, un po' per compensarla, un po' per tenerla lontana da Parigi mentre si celebrava il suo matrimonio con Maria Luigia d'Asbrugo), ottenne la piena proprietà di Malmaison e una pensione di 5 milioni di franchi. Mentre si completavano i lavori di adattamento per ospitare la sua piccola corte di quasi 200 persone, Joséphine visse a Navarre, poi tornò a Malmaison, che continuò ad accrescere ed abbellire fino alla morte. Il 29 maggio 1814 vi morì di polmonite. Si dice l'avesse contratta passeggiando nel parco con lo zar Alessandro, che avrebbe implorato di permetterle di unirsi al marito nell'esilio all'Elba. Quando Napoleone seppe della sua morte, si chiuse per due giorni nella sua camera; dopo la disfatta di Waterloo, prima di consegnarsi agli inglesi, risiedette a Malmaison che, però, senza la sua Joséphine, non era più la stessa. Poi iniziò la decadenza. L'imperatrice aveva lasciato debiti imponenti, riscaldare la serra era troppo costoso e le piante esotiche, abbandonate a se stesse, morirono; la casa e il giardino furono saccheggiati e vandalizzati; la proprietà fu parcellizzata e messa in vendita. Dopo diverse vicissitudini, nel 1903 il castello e il parco, ridotto a 6 ettari, passarono allo stato e divennero un museo. 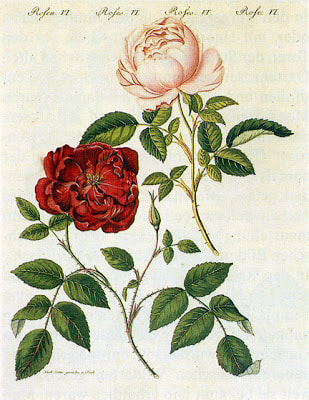 E finalmente... le rose Il parco di Malmaison non era un orto botanico, con le piante disposte in modo sistematico, ma un giardino di piacere. Era anche un giardino sperimentale dove vennero acclimatate piante che poi avrebbero profondamentro modificato i giardini e il paesaggio francese. Secondo L'impératrice Joséphine et les sciences naturelles (catalogo della mostra tenutasi a Malmaison nel 1997), le piante che vi furono coltivate per la prima volta in Francia tra il 1804 e il 1814 ammontano a 184. La corrispondenza tra l'intendente Mirbel e il prefetto delle Alpi Marittime Marc Joseph Dubouchage attesta l'invio in Costa azzurra di numerose piante soprattutto australiane acclimatate a Malmaison; tra di esse, Casuarina equisetifolia, Phormium tenax, varie specie dei generi Eucalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, cui forse va aggiunta Acacia dealbata, la mimosa oggi onnipresente, che fiorì per la prima volta a Malmaison nel 1811. A fare da tramite all'introduzione di queste e altre specie esotiche nella Francia meridionale, il cui clima mite era considerato il più propizio all'acclimatazione di piante tropicali e subtropicali, fu il giardino di acclimatazione creato nel settembre 1801 nel recinto della Scuola centrale del dipartimento delle Alpi marittime a Nizza. E poi, naturalmente, c'è il capitolo rose. Ne ho già parlato in questo post, e qui mi limito a riassumere le informazioni principali. Secondo la vulgata erano le piante preferite di Joséphine che ne avrebbe fatte coltivare ben 250 varietà; molti si spingono anche a dire che, insoddisfatta delle rose europee non rifiorenti, avrebbe incoraggiato l'introduzione di rose cinesi e le ibridazioni che avrebbero portato alla nascita delle rose moderne. Altri parlano di migliaia di rose (peccato che nessuno delle persone che visitò quel giardino poco dopo la morte della imperatrice ne faccia parola e proprio le rose manchino le vedute di Garneray). In realtà, Joséphine era interessata in generale alle piante, specialmente esotiche, e non aveva una speciale predilezione per le rose; certamente a Malmaison non mancavano, ma non è neppure certo che ci fosse un roseto; molte delle piante più preziose erano infatti coltivate in vaso, ed esposte all'esterno al momento della fioritura. Purtroppo, mentre i cataloghi di Ventenat e Bompland documentano bene le esotiche coltivate nella serra e in giardino, non possediamo niente di simile per le rose. Come ho anticipato, Les roses di Redouté, che molti considerano un catalogo delle rose di Malmaison, fu scritto solo dopo la morte dell'imperatrice e ritrae le rose coltivate in vari giardini e vivai francesi che Redouté e Thory, l'autore dei testi, visitarono e citarono scrupolosamente; i giardini dp Malmaison sono ricordati solo per due rose, R. berberifolia e R. gallica. Questo equivoco è probabilmente all'origine della leggenda del roseto di Malmaison, nonchè dei vari pretesi elenchi delle rose che vi erano coltivate. Rimandando al post già citato per le specie sicuramente identificate, molte delle quali importate dall'Inghilterra attraverso Kennedy e altri vivai, vorrei qui aggiungere solo qualche informazione sui fornitori parigini. Presumibilmente il principale era André Dupont, che non fu mai un giardiniere di Malmaison come spesso si legge, anzi neppure un vivaista, ma un collezionista privato; prima della rivoluzione era il custode (e non il giardinere) del palazzo di Lussemburgo. Secondo il suo biografo V. Darkenne, incominciò a interessarsi di rose intorno al 1785, quando affittò un piccolo terreno dai monaci cerctosini nel pressi del Lussemburgo. Durante il Terrore fu imprigionato due volte e per quattro volte, per salvarla, dovette spostare la sua collezione di rose. Nel 1796, la sistemò nell'amgolo orientale del giardino del Lussemburgo, con le rose classificate per specie; nel 1801, la sua collezione (la chimava "éecole de roses"), di specie tanto native quanto esotiche, era la più completa d'Europa. Secondo la testimonianza di Antoine Laurent de Jussieu, Joséphine si rivolse a Dupont per chiedergli di rifornire di rose Malmaison ed egli accettò, come attestano le fatture (che purtroppo non indicano di quali vareità si trattasse). Darkenne stima che nel 1806 gliene abbia fornite da 200 a 500, presumibilmente più di un esemplare per varietà, visto che nel catalogo delle rose coltivate da Dupont nel 1813 (pubblicato da Thory nel 1819, Catalogo inedito Rosarum quas Andreas Du Pont in horto suo studiose colebat anno 1813) ne sono elencate 218. La collezione di Dupont comprendeva numerose rose botaniche europee, un'ampia selezione di alba, centifolia, damascena e soprattutto gallica (una sessatina, pochissime esotiche e qualche cinese, l'unica delle quali identificabile con certezza è la rosa di Macartney (R. bracteata, introdotta in Europa intorno al 1795). Dupont è considerato un pioniere dell'ibridazione artificiale delle rose e a volte gli viene attribuita la creazione di un numero impressionante di ibridi. In realtà nel catalogo compaiono solo 19 ibridi di gallica, non necessariamente tutti creati da lui. Come collezionista, riceveva rose da tutta Europa; come abbiamo visto in questo post, fu lui a introdurre la rosa Portland dall'Inghilterra; potremmo aggiungere 'Belle Sultane', che invece importò dall'Olanda. Gli ibridi di Gallica erano all'epoca le rose più alla moda ed è probabile che ce ne fossero parecchi tra quelle fornite all'imperatrice; lo stesso varrà anche per un altro probabile fornitore, Cels; il catalogo pubblicato da Cels figlio nel 1817 (Catalogue des arbres, arbustes, et autre plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre) offre circa 170 varietà di rose; una buona percentuale sono ibridi recenti dai nomi evocativi ('Belle sans flatterie', 'Panachée admirable'. 'Roi des pourpres') di cui si è per lo più persa ogni traccia. Ovviamente non ne conosciamo il pedigree; è invece giunta fino a noi R. celsiana (nel catalogo figura come grande Cels), un vigoroso ibrido di damascena. Abbiamo già visto che a Malmaison non potevano esserci rose Noisette, essendo la prima giunta in Francia dopo la morte dell'imperatrice. E lo stesso vale per le rose Boursault. Jean-François Boursault detto Malherbe era un ex attore che con la rivoluzione si era dato alla politica e agli affari, accumulando una grande ricchezza che investì tra l'altro in uno splendido giardino con tanto di serre calde. Forse potrebbe aver ceduto a Joséphine una talea della cinese Rosa multiflora carnea, che fu il primo a introdurre in Francia nel 1808, ma non Rosa banksiae 'Alba plena', giuntagli nel 1817, nè il primo ibrido Boursault, ottenuto nel 1818 incrociando R. pendulina non con una cinese, come si è creduto a lungo, ma con la nordamericana R. blanda. Quali e quante fossero le rose coltivate a Malmaison, in assenza di documenti, non lo sapremo mai. Ma anche se il roseto di Joséphine fosse un mito, da più di un secolo è diventato realtà. Nel 1911, dopo che quanto rimaneva del parco era stato donato allo stato, il compito di ri-crearlo venne affidato a Jules Graveraux, il creatore della Roseraie de L'Haÿ; egli, consultando i cataloghi dell'epoca, individuò 197 specie e cultivar disponibili ai tempi dell'imperatrice e ne fece dono al giardino; il suo elenco comprendeva 107 galliche, 27 centifolia, 3 muscose, 9 damascene, 22 bengalesi (ovvero cultivar di R. chinensis), 4 spinosissime, 8 alba, 3 lutee, 1 moscata e le specie alpina, arvensis, banksiae, carolina, cinnamomaea, clinophylla, glauca, laevigata, rugosa, sempervirens e setigera. Certamente è un falso storico, ma almeno su un punto anche oggi siamo d'accordo: Gravereux correttamente privilegiò le galliche, che erano ancora le rose più coltivate, come risulta anche dai cataloghi di Dupont e Cels. In occasione del bicentenario della scomparsa dell'imperatrice, il roseto è stato restaurato e ospita oggi 750 rose del Primo e del Secondo Impero.  Una bella capricciosa A Joséphine de Beauharnais, creatrice di un magnifico giardino, patrona delle arti e della scienza, ma soprattutto moglie di un uomo che per un quindicennio fu il più potente d'Europa, non mancarono gli omaggi botanici, di sapore innegabilmente cortigiano. Nel 1802, quando Mme Bonaparte era ancora la "consulesse", Ruiz e Pavon dedicarono congiuntamente a marito e moglie, rispettivamente, Bonapartea e Lapageria; mentre la dedica a Napoleone (ne parlo qui) è un capolavoro di adulazione, quella a Joséphine è relativamente sobria: "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Ventenat volle anche lui omaggiare con la dedica di un genere colei che in definitiva era la sua datrice di lavoro; per farlo scelse una delle quattro piante australiane nate dai semi portati in patria dalla prima nave della spedizione Baudin a rientrare, il Naturaliste, che precedette il Géographe di circa un anno. Era una pianta modestissima, per nulla imperiale, ma aveva il fascino della primizia, e. dato che Joséphine era appena stata incoronata imperatrice, la battezzò Josephinia imperatricis. Certo era sinceramente legato a colei che lo chiamava il "suo botanico" e lo aveva scelto come intendente del suo amato giardino, ma la sua dedica è decisamente meno moderata rispetto a quella dei due spagnoli: "L'onore di dedicare un genere all'illustre Imperatrice di Francesi dovrebbe essere ambito dall'autore del Jardin de la Malmaison. Possa questo debole omaggio ricordare al posteri la protezione illuminata che essa accorda alla scienza e lo splendore con cui la abbellisce". Il genere Josephinia fu ridotto a sinonimo di Sesamum, e il suo nome attuale della piante è Sesamum imperatricis che, più che i fasti imperiali, evoca la cucina. Sopravvive invece il genere creato da Ruiz e Pavon, che per bellezza e fascino esotico calza perfettamente alla dedicataria. Lapageria (famiglia Philesiaceae) è un genere monospecifico endemico del Cile, di cui l'unico rappresentante, L. rosea, è il fiore nazionale. Originaria delle foreste sclerofile e caducifolie dell'area centrale e centro-meridionale, dalla regione di Valparaiso a quello di Los Lagos, questa splendida pianta è un rampicante sempreverde con fusti contorti e sottili, foglie semplici, lanceolate, coriacee, lucide e grandi fiori solitari penduli a campana formati da sei tepali cerosi. Il colore delle corolle (tra selvatiche e coltivate, se ne conoscono 25 varietà) varia dal bianco purissimo fino al rosso passando da varie sfumature di rosa. I fiori sono impollinati da insetti, altri animali, ma soprattutto colibrì, e sono seguiti da bacche allungate eduli. La coltivazione è considerata piuttosto difficile. Da noi viene solitamente coltivata in vaso; necessita di ombra luminosa, ottima areazione (ma senza correnti d'aria) e un ambiente umido. Non sopporta né il freddo né il caldo eccessivo. Ama essere frequentemente nebulizzata e, poiché non tollera il calcare, va annaffiata con acqua demineralizzata. Insomma, coltivarla è una vera sfida, ma se trova le condizioni giuste può arrivare a 4-5 metri d'altezza e regalare sontuose fioriture. Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland, fu una formidabile collezionista; collezionava oggetti naturali, in particolare conchiglie, ma anche procellane e altri manufatti. Se il suo nome oggi non è ricordato come quello di personaggi come Sloane, è perché dopo la sua morte la sua collezione di oltre 60.000 pezzi fu venduta all'asta e andò interamente dispersa. La famiglia poté riacquistare solo alcuni dei pezzi più preziosi, tra cui il celebre vaso Portland. Era anche un'abile giardiniera e aveva una notevole competenza botanica; dopo i decisivi incontri con Rousseau, Banks e Solander, questa passione raggiunse il culmine con la trasformazione di una parte del parco della sua residenza, Bulstrode Park, in orto botanico i cui fiori furono immortalati da Dionysius Ehret e dall'amica di lunga data Mrs Delany. Alcune delle vere e proprie leggende nate attorno alle rose Portland, un gruppo di rose antiche rifiorenti, le attribuiscono anche l'introduzione della prima rosa di questo gruppo. Ma la loro origine e la loro ascendenza costituiscono un duplice enigma, che è stato sciolto solo di recente. Nessun mistero invece nella dedica del genere Portlandia, con vistose fioriture che evocano i Tropici. La duchessa delle collezioni Per gli amanti dell'antichità, il nome Portland è richiama indubbamente il favoloso "vaso Portland", un vaso vitreo di epoca augustea oggi custodito al British Museum. Per gli amanti delle rose, evoca invece un gruppo di rose antiche rifiorenti. L'uno e le altre sono in qualche modo associati a Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland (1715-1785), la donna più ricca della Gran Bretagna dei suoi tempi, nonché la massima collezionista. Era nata come Margaret Harley e in lei, come unica erede sopravvissuta, si concentrarono i patrimoni del padre, Edward Harley, secondo conte di Oxford e Mortimer, e della madre Henrietta Holles, a sua volta ricchissima erede dei Newcastle e dei Cavendish. La piccola Maria (così veniva chiamata in famiglia) crebbe a Wimpole Hall, la principale residenza di famiglia, circondata da libri, dipinti, sculture e fin da bambina fu incoraggiata a collezionare animali, conchiglie e altri oggetti naturali; sia il nonno paterno (un importante uomo politico) sia il padre erano a loro volta collezionisti, bibliofili e protettori delle arti. Nel 1734, diciannovenne, sposò William Bentinck, secondo duca di Portland, che, al contrario del padre, il primo duca, braccio destro di Gugliemo III, non occupò alcun incarico pubblico e preferì concentrarsi nella vita di famiglia. La coppia ebbe sei figli, quattro dei quali raggiunsero l'età adulta; tra di essi, il terzo duca di Portland, due volte primo ministro, uno dei principali uomini politici britannici della sua epoca. La famiglia divideva il suo tempo tra Londra, dove possedeva una casa a Whitehall e frequentava la corte, i concerti e gli eventi della stagione mondana, e la tenuta di Bulstrode circondata da un vastissimo parco dove già il nonno dell'attuale duca aveva creato un magnifico giardino - di origini olandesi, aveva portato dalla sua patria il gusto per i "paradisi" che costituivano l'orgoglio dell'élite della Repubblica delle province unite - e una notevole Menagerie con voliere di uccelli esotici. Anche se Maria, come abbiamo visto, collezionava conchiglie fin da bambina e aveva ereditato almeno una parte delle collezioni paterne, la passione per il collezionismo esplose negli anni '60, quando rimase vedova (l'amato marito Will morì nel 1761); grazie a una dote di 20.000 sterline, cui, dopo la morte della madre nel 1755, si aggiunsero la proprietà di Welbeck Abbey e una rendita annuale di ulteriori 8000 sterline, era una donna indipendente di larghissimi mezzi che poteva permettersi, letteralmente, ogni capriccio. Amante degli animali fin dall'infanzia, rifondò la menagerie, arricchendola di moltissimi animali; spiritosamente, in una lettera una delle sue più care amiche, Mrs Delany, scrisse: "La duchessa è ansiosa di collezionare animali come se prevedesse un altro diluvio e ne radunasse di ogni tipo per preservarne la specie". Arricchì il parco di varie strutture, tra cui una grotta artificiale (Grotto) che adornò lei stessa di conchiglie con l'aiuto di Mrs Delany. Collezionava soprattutto oggetti naturali, ma anche dipinti, smalti, porcellane, manufatti di varia natura, ogni cosa colpisse la sua curiosità, che, a quanto pare, andavano a mescolarsi in allegra confusione nei corridoi e nelle stanze di Bulstrode Hall, ormai trasformato in un vero e proprio museo aperto ai visitatori. Colta e raffinata, la duchessa di Portland frequentava altre dame con interessi simili (inclusa la regina Carlotta); tra le amiche più strette troviamo Elizabeth Montagu, la creatrice della cosidetta Blue Stockings Society, un club informale che incoraggiava l'educazione e l'espressione artistica delle donne, con la quale iniziò una scambio epistolare nel 1731, quando era appena sedicenne. Un'altra amica di lunga data era la già citata Mary Delany, che la duchessa aveva conosciuto poco dopo il matrimonio, quando ancora si chiamava Mrs Pendarves (dal nome del primo marito); le accumunavano molti interessi e hobby: entrambe parlavano fluentemente italiano e francese, suonavano il clavicembalo, erano abili nel ricamo e in lavori in legno o con conchiglie, amavano la natura, gli animali, le piante, le lunghe passeggiate nel parco. Poi l'amica rimase vedova, si risposò con Mr Delany e si trasferì in Irlanda. Tornò in Inghilterra dopo il 1770, quando rimase vedova per la seconda volta e da quel momento trascorse circa sei mesi all'anno a Bulstrode; ormai sulla settantina, si era perfezionata nell'arte del découpage e il suo soggetto preferito divennero i fiori: formati anche di centinaia di pezzi, i suoi accuratissimi collage ritraggono con precisione anche i particolari più minuti, come gli stami, il pistillo, le nervature delle foglie. Per consentirle un minimo di indipendenza economica, la duchessa le assegnò una piccola casa a Windsor e una pensione di 300 sterline. Un altro artista protetto dalla duchessa di Portland fu Dyonisius Ehret. che probabilmente ella conobbe nel giardino di Chelsea oppure le fu presentato da Miller (di cui Ehret aveva sposato la cognata). Il pittore dipinse per lei su pergamena circa 300 piante esotiche e 500 inglesi, e insegnò disegno alle sue figlie. Possiamo considerarlo un membro a tutti gli effetti della vera e propria équipe scientifica che aiutava la duchessa ad organizzare, catalogare e documentare la sua collezione. A presiederla era il pastore John Lightfoot; nominato cappellano dal duca, due volte la settimana celebrava nella cappella di Bulstrode, dove trascorreva tutto il tempo lasciatogli libero dalla sua attività come pastore di Uxbridge, insegnando botanica alla duchessa, curando la biblioteca e aiutandola con le collezioni. Ottimo botanico, autore di Flora scotica, corrispondeva con Linneo e introdusse la nobile allieva al sistema linneano. Fino al 1770, la botanica, alla quale, come abbiamo visto, era stata avviata da Lightfoot, era un interesse relativamente secondario per la duchessa, anche se amava le piante, teneva un erbario ed era un'appassionata giardiniera, particolarmente abile nella propagazione mediante propaggine. Un incontro importante fu quello con il filosofo Jean Jacques Rousseau, che nel 1766 visse per qualche tempo a Wootton Hall nello Staffordshire, dove intraprese addirittura un inventario della flora locale. Fu presumibilmente introdotto presso la duchessa di Portland da un vicino, Bernard Granville, fratello di Mary Delaney (nata Mary Granville). Rousseau si offrì di diventare il suo "erborista", ovvero di raccogliere per lei semi e campioni d'erbario, cosa che poi fece. Anche se espresse idee francamente maschiliste sulla predisposizione scientifica delle donne, il filosofo ammirava la competenza botanica della duchessa che riteneva ben superiore alla sua. Per più di dieci anni il ginevrino e la nobildonna scambiarono lettere, esemplari, libri, finché nel 1775 o nel 1776 la duchessa commise l'errore di inviargli una copia di Herbarium amboinense di Rumphius. Rousseau tollerava appena la coltivazione dei giardini e aborriva quella delle piante esotiche, che considerava una violenza contro la natura; dunque restituì il dono e interruppe la corrispondenza. La vera svolta si produsse però qualche anno dopo. La duchessa aveva conosciuto Daniel Solander, forse presentatogli da Collinson, poco tempo dopo il suo arrivo dalla Svezia. Nel novembre 1771, dopo il ritorno dall'Australia, egli si recò con Banks a Bulstrode per farle omaggio di semi e campioni d'erbario. Seguirono dotte discussioni in cui fu coinvolto Lightfoot. Pochi giorni dopo, la duchessa e Mrs Delany visitarono il British Museum, con Solander a fare loro da cicerone. Si spostarono poi a casa di Banks che mostrò loro altri esemplari. Questi eventi acutizzarono l'interesse della duchessa per la botanica, e ne nacquero probabilmente l'erbario dipinto affidato a Ehret e l'erbario a decoupage creato da Mrs Delany. Ma la conseguenza principale fu la trasformazione di una parte del giardino in vasto orto botanico secondo il modello del giardino dei farmacisti di Chelsea, con le piante "piantate separatamente secondo la loro specie". Fu probabilmente in questo stesso periodo che, per usare le parole di Lightfoot, la duchessa concepì il progetto di "far descrivere e pubbicare tutte le specie sconosciute dei tre regni della natura". Incaricò Solander di occuparsi delle conchiglie; secondo la testimoniamza di Banks, egli dedicava a questo compito un giorno alla settimana. Tuttavia le morti di Solander nel 1782 e quella della stessa duchessa tre anni dopo, misero fine a questo sogno tanto ambizioso quanto impossibile. Poco dopo la sua scomparsa, il figlio, il terzo duca di Portland, decise di mettere in vendita l'enorme collezione creata dalla madre (erano almeno 60.000 oggetti): c'erano creditori da pagare ed egli stesso aveva bisogno di denaro per la sua carriera poltica. Lightfoot dovette trasformare il catalogo della collezione cui lavorava da anni in catalogo d'asta; quest'ultima, tenuta nella residenza di Whitehall, si aprì il 24 aprile 1786 e si protrasse per oltre due mesi, terminando il 3 luglio. Vi parteciparono centinaia di londinesi e la collezione, divisa in 4000 lotti, fu interamente dissolta. La famiglia riacquistò solo alcuni pezzi di interesse artististico, tra cui un prezioso vaso vitreo di epoca augustea con decorazioni a cammeo; la duchessa l'aveva acquistato nel 1784 da sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli; in precedenza per 150 anni era appartenuto alla famiglia Barberini. Era il pezzo più prezioso, fu messo in vendita il penultimo giorno dell'asta e per aggiudicarselo il duca dovette sborsare 1,029 sterline, una somma enorme per l'epoca. Oggi è una delle gemme del British Museum ed è noto come Vaso Portland.  Un enigma botanico Quanto alle "rose Portland", la loro storia è molto meno lineare, anzi è tanto contraddittoria e intricata da costituire un vero mistero. La versione a lungo dominante è quella riportata da Graham Stuart Thomas in Le rose antiche da giardino (data originale 1979): la progenitrice di questo gruppo di rose era presente nel vivaio Dupont di Parigi nel 1809; Dupont l'avrebbe ottenuta dall'Inghilterra e le avrebbe dato il nome della duchessa di Portland "che probabilmente la trovò o la ottenne dall'Italia all'inizio del secolo". In Inghilterra fu chiamata Rosa paestana, perché si riteneva fosse originaria della zona di Paestum, oppure "Scarlet four season Rose" perché era rosso vivido e ripeteva la fioritura in autunno. Se questa versione è corretta, dato che, come abbiamo visto, la nostra duchessa di Portland morì nel 1785, l'introduttrice non sarebbe lei, ma un'altra duchessa. Beales in Le rose classiche (data originale 1985) si rifà sostanzialmente alla medesima versione, ma si discosta da Thomas affermando che giù in Inghilterra era chiamata Rosa portlandica; aggiunge poi in nota che Sally Festing, autrice di una biografia della seconda duchessa, ha evidenziato che era già elencata nel catalogo di un vivaio inglese nel 1784, il che "deve pure mettere in dubbio l'Italia come suo paese d'origine". E, aggiungo io, rimettere in gioco la nostra duchessa. Ulteriore enigma è l'ascendenza di questa rosa. Nell'opera già citata, Thomas riporta che "era considerata come un incrocio tra la rosa francese (Gallica) e la Damascena autunnale"; egli però la ritiene piuttosto "una ibrido rosa Cinese - Damascena - rosa Francese" e aggiunge: "Dal colore e dal comportamento nano [...] si può presumere che la rosa Cinese progenitrice in questione fosse la cremisi Cinese di Slater" (Slater's Crimson China). Beales è invece convinto che "nessuna rosa cinese sia comunuqe coinvolta" ma che vi abbiano avuto parte attiva la Rosa x damascena bifera ('Quatre Saisons') per la rifiorenza e la R. gallica officinalis ('Rosa del farmacista') per il portamento ordinato e compatto. Il mistero ha ovviamente sollecitato la curiosità dei rodologhi e suscitato ulteriori ricerche. A fare il punto, e dare la risposta definitiva, è Peter Harkness in The Rose. A Colourful Inheritance (2005). In primo luogo egli ricorda che la rosa Portland è conosciuta sotto ben otto nomi: Rosa paestana, R. 'Portlandica', 'Duchess of Portland', Portland Crimson, 'Monthly Rose', 'Portlandia', 'Portlandica', 'Rosier de Portland'. Quindi riassume lo stato dell'arte così: "Le descrizioni di questa rosa nella letteratura non si contano. Si dice che sia originaria del Dorset, o di Beaconsfield, o forse di Napoli, negli anni '70 o '90 del 1700. Quanto alla sua ascendenza, si dice che coivolga unicamente gallica, oppure una damascena e una gallica, o una cinese e una damascena". Secondo Harkness, tutto questo garbuglio nasce dal fatto che "in realtà ci sono due diverse Portland", una nata in Inghilterra negli anni '70 del Settecento, l'altra introdotta da Dupont, giardiniere dell'imperatrice Giuseppina, all'inizio dell'Ottocento. La differenza salta all'occhio osservando la prima nel giardino della Royal National Rose Society, dove è coltivata sotto l'etichetta 'Duchess of Portland', e la seconda nel giardino parigino della Bagatelle, dove è coltivata come R. paestana. La rosa "inglese" (chiamiamola così per comodità), come risulta da cataloghi di vivai e da testi dell'epoca (come la monografia Roses, pubblicata da Henry C. Andrews nel 1805) nacque nei giardini del duca di Portland a Bulstrode prima del 1775, data in cui è elencata da Weston tra le rose "facilmente reperibili" sotto il nome 'Portland Crimson Monthly Rose'; la stessa data è riportata da Trees & Shrubs Hardy in the British Isles che però la chiama 'Portlandica'. Nel 1782, come ‘Portland’ era presente nel catalogo del vivaio Brunton e Forbes di Birmingham; veniva venduta a uno scellino, prezzo che, secondo Harkness, "suggerisce che non si trattasse di una novità". Intorno al 1785, fece la sua comparsa in Francia. E' identificabile nella rosa della Royal National Rose Society; l'aspetto generale, le foglie, i fiori rosa profondo indicano la parentela con la gallica, mentre la modesta rifiorenza riflette quella con la damascena. Veniamo invece a quella "francese"; l'unica certezza è che André Dupont iniziò a coltivarla nel 1803, quando la ricevette dall'Inghilterra. Nel 1809 era chiamata Rosier de Portland e Redouté la dipinse sotto questo nome. Nel 1811 Claude-Thomas Guerrepain nell'Almanach des Roses ne diede una precisa descrizione esaltandone "la preziosa qualità di fiorire dalla primavera all'autunno" e il bellissimo punto di rosso. E' la rosa di Bagatelle. Il brillante colore scarlatto e la rifiorenza hanno fatto a lungo pensare che uno dei genitori fosse una rosa rossa cinese, anche se l'aspetto generale, le foglie e i cinorrodi mostrano maggiori affinità con la Damascena. Le analisi del DNA di cinque rose Portland, condotte da Olivier Raymond dell'università di Lione, ha mostrato parentele con Damascena, Gallica e Centifolia, ma non con le cinesi. Rimane da capire la ragione del nome Portland e l'eventuale connessione con la seconda o la terza duchessa. Nel 1805, parlando della rosa di Bulstrode, Andrews riferisce che sarebbe stata chiamata così "in onore della defunta duchessa di Portland"; Harkness contesta questa affermazione: a suo parere nel Settecento non era ancora invalsa l'abitudine di dare alle rose il nome di una persona; gli sembra più probabile che i nomi 'Portland' o 'Portlandica' si riferiscano al luogo di origine, la tenuta di Bulstrode dei duchi di Portland. Quanto alla rosa "francese", abbiamo due versioni: una, che abbiamo già visto sotto la penna di Graham Stuart Thomas, pretende che una duchessa di Portland l'abbia portata o ottenuta dall'Italia attorno al 1800; l'altra che Dupont l'abbia ottenuta dall'Inghilterra nel 1803 e battezzata 'Rosier de Portland' in segno gratitudine per la terza duchessa di Portland per averlo aiutato a persuadere l'Ammirigliato, nonostante il blocco continentale, a concedere un passaporto al vivaista John Kennedy per trasportare in Francia questa e altre rose destinate ai giardini della Malmaison . Nessuna delle due storie può essere vera, per la semplice ragione che né nel 1800 né nel 1803 viveva una qualche duchessa di Portland. Sappiamo già che la seconda duchessa, ovvero Margaret Cavendish Bentinck, morì nel 1785. La terza duchessa, ovvero sua nuora Dorothy Bentinck nata Cavendish, morì a sua volta nel 1794, e non ci sarebbe stata una quarta duchessa fino al 1809, quando, con la morte del terzo duca, che non si risposò, il titolo passò al quarto duca e a sua moglie. Inoltre, Dupont non chiamò la rosa 'Duchess de Portland', ma 'Rosier de Portland'; l'ipotesi di Harkness è che l'omaggio fosse diretto al terzo duca di Portland il quale, come Segretario di stato ininterrottamente dal 1794 al 1801, quindi, dopo un breve periodo all'opposizione, dal 1803 Presidente del Consiglio privato e poi Primo ministro, "era certamente nella posizione di aiutarlo a ottenere un passaporto per le sue rose". Anche il nome R. paestana probabilmente non ha alcun rapporto diretto con l'Italia e Paestum; si tratta piuttosto di una semplice reminescenza della letteratura classica in cui le rose di Paestum erano celebrate per la loro bellezza, il profumo, il vivace colore rosso e la rifiorenza autunnale. 
Il 20 giugno 1837 sale al trono la regina Vittoria, destinata a regnare sul Regno Unito per 63 anni, dando il nome a un'intera epoca. Caso vuole che proprio negli stessi giorni giunga in Inghilterra la notizia della scoperta in Amazzonia di una magnifica e gigantesca ninfea; per il nome, lo scopritore ha già pensato a lei, all'epoca ancora principessa, e propone di chiamarla Nimphaea victoria. Quale migliore simbolo per inaugurare un regno che si spera rinverdisca i fasti imperiali della Gran Bretagna? Il nome della nuova pianta diventa quasi un affare di Stato e scatena la rivalità di società scientifiche e botanici. Alla fine, grazie al potente appoggio di Hooker, la spunteranno Lindley e il nome Victoria regia. Si susseguono sfortunati tentativi di coltivarla in Inghilterra, finché l'abile giardiniere Joseph Paxton riesce a farla fiorire per la prima volta. La mette in mostra a Chatsworth House con un'installazione che farà epoca; gli stupefatti visitatori ne ammirano i fiori e le foglie gigantesche, su una delle quali sta composta una bimba elegantemente vestita: è Annie, la figlioletta del giardiniere. Da quel momento una Victoria lily house, ovvero una serra tropicale di cui la spettacolare pianta è il maggiore punto di attrazione, diventerà irrinunciabile per orti botanici e ricchi collezionisti. La pianta era indubbiamente regale, per non dire imperiale, e la regina Vittoria accolse lusingata l'omaggio. Quando era giovane forse le piante e i giardini erano per lei una piacevole cornice, dove amava sedere e passeggiare. Il vero appassionato di famiglia era il marito, il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Ma quando rimase vedova prendersi cura delle piante che lui aveva piantato e proseguire i suoi progetti orticoli divenne un compito quasi sacro. Tra le sicure benemerenze della sovrana, il sostegno che diede alla nascita di quello che è oggi il Chelsea Flower Show, la più importante esposizione floricola della Gran Bretagna, forse del mondo. 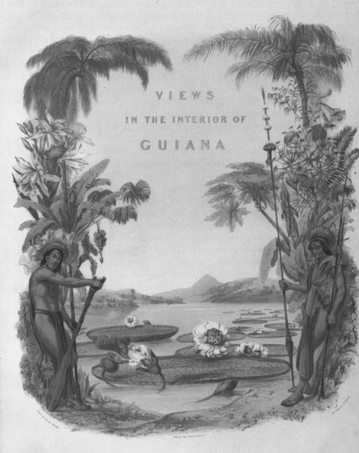 Una scoperta plurima e una polemica nominalistica Con le sue enormi foglie che assomigliano a tondi vassoi galleggianti, dal diametro fino a tre metri, e i meravigliosi fiori dagli innumerevoli petali, ammirare le Victoria nel loro ambiente naturale deve essere un'esperienza indimenticabile. Ovviamente gli indigeni le conoscevano da sempre, e le chiamavano con molti nomi; il più poetico è forse auapé-yaponna, da auapé (Jacana incana), un piccolo uccello di ripa che si vede spesso correre sulle foglie di Victoria amazonica. Ma per i primi botanici europei che le "scoprirono" fu addirittura un'esperienza mistica. Il primo in assoluto sembra sia stato Thaddäus Haenke, il botanico della spedizione Malaspina. Alla fine del viaggio, si era fermato in Sudamerica e nel 1801, in Bolivia, si imbatté in Victoria amazonica mentre esplorava il Rio Marmoré, uno dei tributari superiori del Rio delle Amazzoni. Ne fu folgorato al punto da cadere in ginocchio adorante. Quasi vent'anni dopo, nel 1819, nella stessa area la vide anche Aimée Bonpland, l'ex compagno di viaggio di Humboldt; non cadde in ginocchio, ma si gettò fuori dalla zattera per ammirarla da vicino e per un mese non parlò d'altro. Nel 1825, ne inviò semi e una completa descrizione a Mirbel, professore di orticultura al Jardin des Plantes di Parigi, ma il suo invio rimase quasi inosservato. Più posate le reazioni di Alcide d'Orbigny, lo scopritore della specie più meridionale, Victoria cruziana. La scoprì nel 1827 su due tributari del Rio della Plata, il Paranà e il Riochuelo, nella provincia argentina di Corrientes, presso la frontiera con il Paraguay; riempì la sua barca di fiori, foglie e frutti; la disegnò accuratamente, la descrisse, e spedì esemplari d'erbario, disegni e descrizioni al Jardin des Plantes. Continuando i suoi viaggi in Sudamerica, visitò anche la Bolivia e nel 1832 vide fluttuare la specie amazzonica sul Rio Madeiras; fu così il primo a capire che si trattava di due specie diverse. Più o meno contemporaneamente, il botanico e esploratore tedesco Eduard Poeppig la vide presso il Rio Solimões, e nel 1832 fu il primo a pubblicarne la descrizione sulla rivista di Weimar Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, assegnandola come Euryale amazonica al genere Euryale, di cui si conosceva già una specie asiatica, E. ferox. Infine, il primo gennaio 1837 un altro esploratore tedesco, Robert Schomburgk, che però lavorava per la Royal Geographical Society (RGS) britannica, la trovò sul Berbice River nella Guiana Britannica; rimase non meno folgorato dei suoi predecessori, la misurò, la disegnò e si affrettò a inviare disegni, descrizione e campioni d'erbario alla RGS. Nulla sapeva delle scoperte precedenti; riteneva si trattasse di una specie ignota di Nymphaea e suggerì che la "più interessante delle mie scoperte" fosse dedicata alla "nobile ninfa vivente, la giovane principessa Vittoria", con il nome Nymphaea victoria, sempre che ella concedesse il suo assenso. Lettera e materiali giunsero a Londra proprio in coincidenza con il delicato passaggio della salita al trono della diciottenne Vittoria (Alexandrina Victoria di Kent), succeduta allo zio Guglielmo IV, morto il 20 giugno 1837. Era l'unica erede di una dinastia che rischiava di estinguersi; in lei, salutata come la "rosa d'Inghilterra", si ponevano tutte le speranze del paese. Assicurarsi il suo alto patronato era importante per le società scientifiche, ed era vitale per la stessa sopravvivenza dei Kew Gardens. Il sovrano defunto se ne era disinteressato, con il risultato di un degrado tale che il Tesoro per verificare la situazione e valutare se mantenerli o dismetterli nominò una commissione composta dai giardinieri Joseph Paxton e Joseph Wilson e dal botanico John Lindley, strenuo difensore della loro sopravvivenza nonché segretario della Horticultural Society; anche quest'ultima necessitava del sostegno regio per risolvere i suoi annosi problemi finanziari. Per ragioni diverse, il grazioso patrocinio di sua Maestà era quanto mai indispensabile anche per la neonata Botanical Society of London, presieduta da John Edward Gray, il curatore della sezione zoologica del British Museum, e fondata appena un anno prima in polemica non tanto velata con le più antiche e prestigiose Linnean Society e Horticultural Society. Proprio a lui Schomburgk, che aveva potuto constatare il disinteresse della RGS per le scienze naturali, chiedeva di passare i materiali per la pubblicazione; inoltre in una seconda lettera privata al presidente della RGS, il capitano Washington, lo pregava di darsi da fare per ottenere l'assenso della principessa (così era quando egli la scrisse) e di fare eseguire da un illustratore professionista una copia del suo migliore disegno da donare alla illustre dedicataria; la spesa poteva essere coperta dalla somma che la Horticultural Society gli doveva per certi materiali botanici spediti dalla Guyana. Washington contattò Lindley che capì che non di una Nymphaea si trattava, ma di un genere nuovo; facendo in parte propria la proposta di Schomburgk, propose di battezzarla Victoria regia. Seguirono intensi contatti tra Washington e Lindley, ambedue intenzionati ad approfittare dell'occasione per assicurarsi il patrocinio della sovrana per le rispettive istituzioni. Fu la RGS a compiere i passaggi previsti dal protocollo, ottenendo l'assenso della regina sia per la dedica sia per il nome proposto da Lindley. Solo a questo punto, i materiali furono comunicati anche a Gray. Anche quest'ultimo, che credeva gli fosse stata consegnata l'unica copia, riconobbe in modo indipendente che si trattava di un nuovo genere; forzando un po' la mano nella speranza di ottenere il patronato della fino ad allora sfuggente Vittoria, il 7 settembre 1837 in una riunione della Botanical Society lesse il resoconto della scoperta di Schomburgk, quindi propose di fare della magnifica pianta il nuovo emblema della società sotto il nome Victoria regina (attenzione! c'è una enne in più). Due giorni dopo il resoconto della seduta e il nuovo nome venivano pubblicati nella rivista divulgativa Athaeneum. Nel frattempo l'Horticultural Society si era affrettata a far giungere le sue congratulazioni ufficiali alla nuova regina; e lo aveva fatto con un messaggio decorato con un'immagine di Victoria, copiata da miss Drake per incarico di Lindley da uno dei disegni originali di Schomburgk. Lo stesso Lindley aveva ricevuto dalla RGS l'incarico di preparare la pubblicazione ufficiale della scoperta. Il risultato fu la lussuosa monografia A Notice of Victoria Regia; in grande formato (62 x 48 cm), comprendeva una dedicatoria - che conteneva tra l'altro l'augurio che "il regno della regina Vittoria possa distinguersi negli annali della storia come la maestosa pianta che d'ora in poi porterà il suo regale nome è preminente nella Flora del suo paese natale" -, una copia del migliore disegno di Schomburgk colorata a mano e tre pagine di descrizione; ne vennero stampate solo 25 copie, da presentare alla regina e da riservare a un pubblico selezionatissimo. Uscì ad ottobre, un mese dopo l'articolo di Athaeneum. A questo punto iniziarono a circolare entrambi i nomi e iniziò anche una polemica piuttosto aspra tra Gray e Lindley per quella enne in più o in meno, con accuse reciproche di furto e plagio; vi si inserì anche d'Orbugny, indignato che Lindley gli avesse rubato il diritto di primogenitura. Finché nel 1850 - vedremo in quali circostanze - Hooker, con tutto il peso della sua autorità, optò per Victoria regia, che divenne il nome prevalente, tanto che lo stesso Gray finì per accettarlo, inchinandosi al fatto compiuto. A dire il vero, già nel 1847 il tedesco Klotzsch aveva fatto notare che la precedenza andava a Euryale amazonica di Poepping, quindi il nome corretto secondo le regole era Victoria amazonica; ma nessuno in Inghilterra era disposto ad ammetterlo, almeno finché la regina era viva. Infatti questo nome fu accettato solo dopo la sua morte nel 1901. Come Victoria amazonica fiorì per la prima volta in Inghilterra Attraverso queste ingarbugliate vicende, la spettacolare ninfea dell'Amazzonia divenne l'emblema della nuova monarchia britannica e del suo destino imperiale. Ma finora in Europa si erano visti solo disegni e esemplari d'erbario; ora il massimo desiderio era possederla e coltivarla. Il primo a provarci fu lo stesso Schomburgk che tentò di coltivarla a Georgetown in Guyana ma i suoi esemplari morirono tutti. Hooker mise in azione la rete dei corrispondenti dei Kew Gardens e fu all'origine di diversi tentativi di introduzione. Nel 1845 l'esploratore, botanico e cacciatore di piante Thomas Bridges visitò la Bolivia, cadde puntualmente innamorato dell'ammaliatrice Victoria, ne scrisse un'entusiastica descrizione per il Journal of Botany e ne spedì in Inghilterra i semi; per mantenerli umidi, li sistemò in una bottiglia con argilla bagnata. Dei 25 ricevuti nel 1846 dai Kew Gardens, solo tre germinarono, due pianticelle sembrarono prosperare, ma morirono l'inverno successivo. Nel 1848 Edward G. Boughton, un medico inglese residente a Leguan nella Guiana britannica, spedì a Kew alcune radici in una cassa di Ward, ma quando fu aperta risultarono marce e inservibili; separatamente spedì anche alcune capsule contenenti semi e altri semi in una bottiglia di acqua fangosa, ma nessuno germinò. Il successo arrise l'anno dopo a Hugh Rodie, un altro medico, e a un certo Luckie di Demerara, sempre nella Guyana Britannica, che invece sistemarono i semi in piccole fiale di acqua pura; il primo invio raggiunse Kew il 28 febbraio 1849, seguito da altri tre. Alcuni di questi semi germinarono e nell'estate del 1849 si erano sviluppate sei pianticelle; tre vennero trattenute a Kew, una fu inviata a Regent Park, dove la Botanical Society aveva la sede, due furono affidate ai duchi di Devonshire e di Northumberland, che possedevano serre adatte a piante tropicali rispettivamente a Chatsworth House e a Syon House. Il capo giardiniere di Chatsworth House era l'abilissimo Joseph Paxton, che abbiamo già incontrato come membro del comitato incaricato di valutare l'eventuale sopravvivenza di Kew. Andò a prendere personalmente la pianticella a Kew (era piccolina, con appena 4 foglie non dispiegate, la maggiore di 12 cm di diametro) e la portò il più rapidamente possibile a Chatsworth, dove la sistemò in un barile di acqua pura, che poi collocò in un lettorino a 30°, mentre provvedeva a creare una grande vasca riscaldata. Appena fu pronta, la sistemò al centro, su una collinetta di terra preparata; in due mesi e mezzo, la pianta occupò l'intera vasca, e il 1 novembre emerse il primo fiore. Il 14 era totalmente aperto; Paxton partì immediatamente per Windsor e il giorno dopo presentò il fiore e una foglia a sua Maestà. Perfettamente coltivata, la sua pianta continuava a prosperare: a un anno dalla prima fioritura, aveva prodotto 150 foglie e 126 fiori, senza mai smettere di fiorire. Era necessario provvederle una nuova casa. Paxton disegnò per lei una serra speciale in ghisa e vetro, con al centro la vasca della meravigliosa pianta; quando arrivavano visitatori illustri, per stupirli ancora di più metteva la figlioletta Annie di sette anni in posa su una foglia, che ormai aveva raggiunto il diametro di due metri. Ottenne uno straordinario successo mediatico, tanto che nel 1851, benché non avesse alcuna esperienza come architetto, gli fu affidata la costruzione del Crystal Palace, la sede della prima Esposizione universale; Paxton per la prima volta si avvalse di moduli prefabbricati e nel disegnare la cupola e il frontone replicò la struttura delle foglie della Victoria. La regina omonima lo premiò con il cavalierato. La tecnologia messa a punto da Paxton fu impiegata anche a Syon House e a Kew, dove due Victoria fiorirono l'anno successivo; quella di Kew iniziò a fiorire nel giugno 1850 e la fioritura si protrasse fino a Natale. William Jackson Hooker, che dal 1841 era direttore dei Kew Gardens, ne seppe sfruttare il fascino per rilanciare il giardino e trasformarlo in un centro di studi botanici di importanza mondiale. Quando assunse l'incarico, i Kew Gardens, in stato miserevole, misuravano appena 8 acri; quattro anni dopo, grazie alla generosità della sovrana e al passaggio dal patrimonio regale alla nazione, avevano raggiunto 650 acri. Nel 1847 Hooker dedicò alla "ninfea reale" il primo numero dell'anno del Curtis's botanical magazine; vi sintetizzò tutte le vicende dell'incontro dei botanici europei con la quella meraviglia della natura, accludendo un puntuale confronto con il genere Euryale, una nota di Bridges sulle condizioni di crescita e 4 tavole riprese dai disegni di Schomburgk. Quando finalmente la Victoria di Kew fiorì, la regina, accompagnata dal presidente della Repubblica francese (che poi sarebbe diventato Napoleone III) visitò il giardino per ammirarla. Hooker si mise al lavoro per preparare una monografia degna di tanta pianta e di tanto onore; i testi erano un rielaborazione di ciò che aveva già scritto per il Curtis's, ma la vera novità era costituita dalle tavole botaniche, che egli commissionò a Fitch, che disegnò i fiori in tutti i particolari, sulla base degli esemplari di Kew e Syon House; era un lussuoso ma smilzo in folio che fu stampato e presentato alla regina nel 1851, in tempo per l'esposizione universale. Approfittando di un nuova linea di autobus, furono moltissimi coloro che fecero il viaggio fino a Kew per ammirare i giardini e la fioritura della sua maggiore attrazione, la Victoria regia finalmente conquistata: mentre nel 1844 i giardini erano stati visitati da 15.000 persone, nel 1851 furono 240.000. Nel pieno della moda per le serre e la coltivazione di piante esotiche, possedere una Victoria (e una serra adatta ad ospitarla) divenne uno status symbol. Non era neppure più necessario andare fino in Bolivia o in Guyana per procurarsela: infatti le piante di Chatsworth e Kew avevano incominciato a produrre semi vitali e ad essere riprodotte. Semi o pianticelle vennero distribuiti in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Ad assicurarsi la prima fioritura al di fuori della Gran Bretagna fu van Houtte di Gand nell'aprile 1850 (anticipando anche Kew). Nel 1851 fu la volta degli Stati Uniti, dove la prima Victoria amazonica fiorì nel giardino di Caleb Cope, il presidente della Horticultural Society della Pennsylvania. 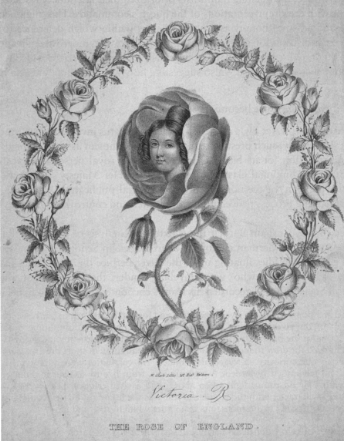 La regina Vittoria e i suoi giardini La spettacolare ninfea dell'Amazzonia, giunta in Inghilterra per singolare coincidenza proprio all'esodio del regno di Vittoria, ne divenne dunque il simbolo, quasi l'incarnazione. Era rara ed esotica, ma l'ingegno e la tecnologia britannici erano riusciti a rapirla e imbrigliarla; gigantesca come lo stesso impero britannico; costosissima ma allo stesso tempo disposta a farsi ammirare da tutti al modico prezzo di un biglietto di entrata; sensuale e delicata, ma allo stesso tempo indomabile. Era perfetta per rappresentare l'Inghilterra vittoriana, esattamente come la regina, con il suo regno protrattosi per più di sessant'anni. Secondo le tradizioni di famiglia (dopo tutto, Kew era stato fondato dai suoi bisnonni e reso splendido dal nonno Giorgio III), certamente amava le piante, ma il vero appassionato di orticultura era il marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, che la sovrana sposò nel 1840. Sotto la supervisione del principe consorte, i vari giardini delle residenze reali londinesi che in precedenza provvedevano allo scopo furono sostituti dal grande orto-frutteto (Kitchen Garden) di Winsor, dove si producevano le verdure e la frutta per la tavola regale, e anche fiori da taglio; era dotato di serre e considerato tra i più avanzati ed efficienti dell'epoca. Alberto profuse la sua passione per le piante soprattutto nelle residenze private. Vittoria e Alberto ne crearono principalmente due, Osborne House nell'isola di Wight e il castello di Balmoral in Scozia. Osborne fu costruito a partire dal 1844. Dato che la baia ricordava ad Alberto quella di Napoli, la casa e i giardini si ispirarono allo stile italiano, con terrazze formali, parterre, balaustre, fontane e statue. C'erano piante da tutto il mondo e per la prima volta per le aiuole estive vennero usate grandi quantità di annuali, coltivate a tale scopo nelle serre. Per i bambini (la coppia ne ebbe nove) fu costruito uno chalet in stile svizzero attorniato da un giardino con aiuole dove essi potevano coltivare personalmente le loro piante. C'era anche un giardino murato con alberi da frutto e due serre. Balmoral fu invece acquistato nel 1852. Anche in questo caso, la costruzione deve molto ad Alberto, che lo fece edificare in uno stile eclettico che mescola elementi della sua nativa Turingia con reminiscenze elisabettiane. Al contrario del formale Osborne, ad eccezione dei parterre più vicini al castello, si tratta di un vastissimo parco in stile paesaggistico, reso suggestivo da un panorama "romantico" e circondato da una densa foresta. Alberto vi fece piantare molte conifere esotiche, sovrintese alla creazione di parterre, di deviazioni della strada principale, di un nuovo ponte e di vari edifici agricoli, tra cui un caseificio modello. Nel 1861, ad appena 42 anni, Alberto morì di febbre tifoidea. Da quel momento per Vittoria, che lo aveva amato teneramente e ne venerava la memoria, preservare le piante che egli aveva piantato e mantenere i suoi progetti per Osborne e Balmoral divenne un sacro dovere. Fedele al suo lascito, completò l'acquisto della foresta di Ballochbuie, salvando dalla distruzione uno dei più significativi resti dell'antica foresta di conifere della Caledonia. Inclusa nella tenuta di Balmoral, fu uno dei primi progetti di conservazione del patrimonio forestale scozzese. Osborne e Balmoral continuarono a essere luoghi della memoria, dove ogni albero le parlava del marito defunto e dove a sua volta fece piantare molti alberi commemorativi. Ma con il passare degli anni il suo giardino del cuore divenne quello di Frogmore House, all'interno del parco di Windsor, dove fece costruire i mausolei per la madre, Victoria di Sassonia-Saalfeld, per il marito e per se stessa. Altri edifici si aggiunsero: una casa da tè e un chiosco indiano; nei suoi ultimi anni, in estate non era raro vederla sbrigare la corrispondenza in una tenda allestita nel giardino. Da Alberto, Vittoria ereditò anche il ruolo istituzionale di patrona di varie istituzioni connesse con l'orticultura e il giardinaggio. Particolarmente stretta fu la relazione della coppia reale con l'Horticultural Society: nel 1858 il principe consorte ne divenne presidente; nel 1861, ottenuto il patrocinio reale, l'associazione mutò nome in Royal Horticultural Society. L'inaugurazione del nuovo giardino della RHS a Kensington il 5 giugno 1861 fu l'ultima apparizione pubblica di Alberto, che sarebbe morto a dicembre. Vittoria avrebbe voluto succedergli ella stessa come presidente della RHS, ma ne fu dissuasa dai suoi consiglieri. Seguì un lungo periodo di lutto e quasi di autoreclusione; quando lo zio Leopoldo del Belgio, per lei quasi un secondo padre, la avvertì che non mostrarsi in pubblico avrebbe potuto alienarle l'affetto dei sudditi, riprese a farlo, ma sempre raramente. Faceva eccezione proprio per la RHS; nel 1864 la sua prima visita pubblica dopo il periodo di isolamento fu proprio al giardino di Kensington, dove era stata organizzata una festa per celebrare il suo compleanno. Successivamente, visitò con una certa assiduità il Great Spring Show (ovvero quello che è oggi noto come Chelsea Flower Show; ai suoi tempi si teneva in altre sedi). Nel 1897, in occasione del sessantesimo anniversario dell'ascesa al trono della sovrana, "a perpetua memoria del glorioso regno di sua Maestà" la RHS istituì la Victoria Medal of Honour, assegnata ai migliori orticultori britannici. La regina Vittoria è la più celebrata dei monarchi britannici, ricordata da innumerevoli monumenti, edifici, parchi, località in tutto l'impero; non stupisce che, oltre al genere Victoria, le siano state dedicate anche altre piante, in genere di notevole impatto estetico: Agave victoriae-reginae, probabilmente la più nota, Dendrobium victoriae-reginae, Banksia victoria, Lobelia cardinalis 'Queen Victoria'. Sembra però che la sua preferenza andasse a fiori più modesti: le violette e le primule che, si dice, inviava in dono al primo ministro con cui ebbe più feeling, Benjamin Disraeli.  Il genere Victoria E' ora di dire qualche parola in più del genere Victoria e delle sue tre specie. Appartenenti alla famiglia Nymphaeaceae, sono piante acquatiche galleggianti che vivono nelle acque calme, nelle lanche e nelle praterie allagate dei bacini del Rio delle Amazzoni (Victoria amazonica e V. boliviana) e del Rio della Plata (V. cruziana). Victoria boliviana è stata riconosciuta come specie a sé solo nel 2022. Nel 2016 due orti botanici boliviani, quelli di Santa Cruz de La Sierra e di La Rinconada, donarono ai Kew Gardens semi di Victoria provenienti dai Llanos de Moxos, nella provincia di Beni. Potendo osservare fianco a fianco nelle serre di Kew sia questa pianta sia Victoria amazonica, Carlos Magdalena, uno degli orticoltori botanici senior di Kew, nonché esperto di ninfee, poté notare che si trattava di due specie diverse. Le sue osservazioni sono state poi confermate dall'analisi del DNA, e hanno portato nel 2022 alla pubblicazione della nuova specie come V. boliviana. Nuova fino a un certo punto: essa infatti assomiglia in modo impressionante a un disegno di Walter Hood Fitch tratto da un esemplare raccolto in Bolivia nel 1845 (presumibilmente uno di quelli inviati da Bridges). V. boliviana si distingue dalle altre specie del genere per la diversa distribuzione delle spine, la mancanza di tricomi sui tepali esterni e l'ovario e la forma dei semi; ha anche strappato a V. amazonica il record di "ninfea più grande del mondo", quando le foglie di un esemplare coltivato a La Rinconada hanno raggiunto un diametro di 3.2 metri. Abbiamo già visto che V. cruziana fu identificata come specie a sé da Alcide d'Orbigny che la pubblicò nel 1840 dedicandola al presidente della Bolivia Andrés de Santa Cruz che aveva reso possibile la sua spedizione. Rispetto alle altre due specie, può crescere in acque più fresche, il che permette la sua coltivazione all'aperto anche in zone temperate. Cresce in acque ferme fresche, ma perché il fiore possa sbocciare sono necessarie alte temperature ambientali. Ha fiori lievemente più piccoli di V. amazonica e foglie con la pagina inferiore viola invece che rossa e ricoperta da una peluria simile a quella delle pesche; al contrario di quelli della specie amazzonica, i boccioli non sono tozzi ma appuntiti e glabri anziché spinosi. Durante la loro crescita, tutte e tre le specie spingono gradualmente da parte le altre piante, escludendole via via dalla luce del sole, finché rimangono le sole ad occupare quel tratto d'acqua. Il fiore si forma sott'acqua ed emerge quando è pronto alla fioritura. Tutti i fiori di un singolo cespo di V. amazonica si aprono nella stesso momento, nella tarda serata, e hanno petali candidi; un meccanismo di riscaldamento noto come termogenesi fa sì che la temperatura interna superi anche di 10 gradi quella esterna, aiutando a rilasciare un intenso profumo fruttato che attrae gli scarabei dei genere Cyclocaephala, che trovano una ricompensa amidacea negli staminoidi (stami non funzionali). Mentre banchettano, al calar della notte il fiore cessa di emettere profumo, si chiude e intrappola gli insetti nelle sue appendici carpellari. Il giorno successivo la pianta rilascia antociani e il fiore cambia colore, virando dal bianco al rosa, segno che è stato impollinato. La seconda sera si riapre per lasciare uscire gli scarabei, che passando attraverso gli stami si ricoprono di polline. Andranno così a fecondare i fiori di un altro cespo. E' possibile anche l'autoimpollinazione (abbiamo visto che le piante di Kew e Chatsworth produssero semi vitali) ma di solito viene evitata; in serra e in coltivazione al fuori delle zone d'origine l'impollinazione è dunque effettuata a mano, Un'altra caratteristica affascinante delle Victoria, che come abbiamo visto colpì ed ispirò Paxton, è la struttura delle foglie. Sono tonde, piatte, simili a grandi vassoi con un bordo rialzato. La pagina inferiore, rossastra in V. amazonica e violacea in V. cruziana, è coperta di spine che la proteggono dagli attacchi dei pesci e segnata da una fitta rete di costolature rilevate che da una parte formano camere che intrappolano l'aria permettendole di galleggiare, dall'altra ne irrobustiscono la struttura tanto che possono reggere il peso anche di una 40 di kg (vi ricordate della piccola Annie Paxton?). Nella seconda metà del secolo scorso si è anche cominciato a incrociare V. amazonica e V. cruziana per ottenere ibridi con lle migliori caratteristiche dei genitori, compresa la rusticità della specie più meridionale; il primo, tuttora in produzione, fu ottenuto nel 1961 presso i Longwood Gardens (Pennsylvania); è 'Longwood Hybrid', caratterizzato da grandi foglie con belle nervature, bordo rossastro, tolleranza al freddo; successivamente negli Stati Uniti e in altri paesi ne sono stati prodotti numerosi altri, tra cui 'Adventure', con fiori bianco crema la prima notte e rosa medio la seconda; 'Atlantis', con petali lievemente appuntiti bianchi la prima notte, rosso scuro la seconda notte in acque calde, rosati in acque più fresche; 'Columbia', con petali arrotondati, che virano dal bianco crema al rosa chiaro; 'Challenger', caratterizzata da bordi ondulati; 'Discovery', con fiori che virano dal bianco al rosa scuro. Tra i dedicatari di generi vegetali ci sono molti sovrani, ma un solo papa: è Niccolò V, al secolo Tommaso Parentucelli. Uomo coltissimo, fu il primo papa umanista; protettore delle scienze e delle arti, creò il primo nucleo della Biblioteca apostolica vaticana. Alcuni lo ritengono anche il fondatore dell'orto botanico di Roma; certamente arricchì i giardini del Vaticano, ma probabilmente l'affermazione è esagerata. Merito sicuro è invece aver fatto tradurre dal greco l'Almagesto di Tolomeo e le opere botaniche di Teofrasto, auree fonti di sapienza da cui sarebbero risorte le scienze naturali, come sottolinea Domenico Viviani nel dedicare al dottissimo pontefice il genere Parentucellia (Orobanchaceae).  Un pontefice umanista L'unico papa a cui è stato dedicato un genere vegetale sicuramente amava le piante, e forse ne aveva una buona conoscenza. Si tratta di Niccolò V, al secolo Tommaso Parentucelli (1397-1455). Sia il padre (che perse piccolissimo), sia il patrigno erano medici, e potrebbe aver imparato in famiglia ad apprezzare le piante, soprattutto quelle medicinali, in un'epoca in cui la maggior parte dei farmaci era di origine vegetale. Del resto, oltre ad essere un ottimo oratore e un fine teologo, era tanto erudito in ogni campo dello scibile che il suo amico-rivale Enea Silvio Piccolomini, papa a sua volta come Pio II, diceva di lui "ciò che non sa è al di fuori del campo della conoscenza umana". Aveva incominciato a farsi notare negli ambienti intellettuali di Firenze, dove si era trasferito adolescente (era nato presumibilmente a Sarzana) e, giovane orfano senza mezzi, si guadagnava la vita come precettore nella casa del colto banchiere Palla Strozzi. Le sue qualità intellettuali attirarono l'attenzione del vescovo di Bologna Niccolò Albergati, che lo volle con sé, ne finanziò gli studi e ne propiziò la carriera ecclesiastica. Quando Albergati divenne cardinale, Parentucelli ebbe modo di accompagnarlo in un viaggio diplomatico in vari paesi europei, che gli permise anche di raccogliere numerosi manoscritti. Quindi si mise in luce nel Concilio di Firenze per le sue posizioni anti conciliariste. Alla morte di Albergati nel 1444, divenne a sua volta vescovo di Bologna; fu poi inviato in Germania come diplomatico e si mosse con tanta abilità che per ricompensa nel 1446 fu nominato cardinale. Un anno dopo, un conclave lampo di appena due giorni lo elesse papa e, in ricordo del suo protettore, volle assumere il nome di Niccolò. Ad aprirgli la strada fu l'opposizione della famiglia Orsini, all'elezione del candidato più forte, il cardinale Prospero Colonna, ma contarono certamente la sua fama di erudito, la vicinanza al papa precedente Eugenio IV (di cui pronunciò l'orazione funebre(, e la sua grande abilità di diplomatico. Il suo pontificato durò appena otto anni, ma fu assai incisivo. Sul piano politico, conobbe successi, come il concordato stipulato con l'imperatore Federico III che avrebbe regolato i rapporti tra Asburgo e Santa Sede fino all'inizio dell'Ottocento, ma anche l'amarezza della caduta di Costantinopoli nel 1453, per evitare la quale aveva inutilmente cercato di organizzare una guerra santa. Niccolò V è però ricordato soprattutto come il primo papa umanista. Fin dall'avvento al pontificato, si impegnò nella creazione di una biblioteca papale, nella quale investì gran parte delle entrate del giubileo da lui indetto per l'anno 1450. I suoi agenti setacciavano le biblioteche di tutta Europa e non badavano a spese per acquistare (o ottenere in prestito per essere copiati, se l'acquisto era impossibile) i manoscritti più rari. Essi operavano in Francia, in Inghilterra, nell'Europa centrale e non trascurarono la Grecia e Costantinopoli; in tal modo, nell'arco dei pochi anni del suo pontificato furono raccolti 1200 manoscritti (400 dei quali greci) che andarono a costituire il primo nucleo della Biblioteca apostolica vaticana. Si circondò di umanisti e protesse studiosi anche controversi come Lorenzo Valla, incoraggiò il lavoro dei filologi per giungere a testi criticamente fondati, promosse una vasta serie di versioni latine integrali di caposaldi della letteratura e della scienza greca; su sua richiesta, Filelfo tradusse I detti degli Spartani di Plutarco, Valla Le storie di Tucidide, Guarino Veronese la Geografia di Strabone, Teodoro Gaza De Natura Plantarum di Teofrasto e i Problemata attribuiti ad Aristotele, tradotti anche dal Trapezunzio, autore pure di una versione latina dell'Almagesto di Tolomeo. Significativamente, gli ultimi due erano greci in fuga dall'avanzata turca; come umanista, papa Parentucelli sentì la caduta di Costantinopoli come un colpo non solo alla cristianità, ma anche alla cultura, tanto da scrivere ad Enea Silvio Piccolomini che essa era "una seconda morte per Omero e per Platone". Il recupero di manoscritti, il programma di traduzioni, l'accoglienza riservata ai sapienti greci ebbero un ruolo importantissimo nella riscoperta della cultura greca e nella sua piena integrazione nell'umanesimo. Notevole fu anche l'impegno urbanistico di Niccolò V, forse ispirato da Leon Battista Alberti, che aveva conosciuto in gioventù e nel 1452 gli dedicò il trattato De re aedificatoria. Il pontefice varò un ampio piano di riassetto della città (noto come "piano nicolino"), basato su cinque capisaldi: il rafforzamento delle mura, la costruzione di un nuovo acquedotto, la ricostruzione del palazzo del Vaticano, il restauro della Basilica di San Pietro e di altre chiese, la ristrutturazione del Palazzo apostolico dove fu realizzata la Cappella nicolina con dipinti del Beato Angelico e di Benozzo Gozzoli. Numerosi lavori vennero realizzati in previsione del giubileo del 1450 che richiamò a Roma moltissimi pellegrini. Nell'ambito di queste ristrutturazioni, Niccolò V si occupò anche dei giardini vaticani. La creazione degli Horti vaticani si deve a un altro Niccolò, terzo del nome, che intorno al 1280 trasferì la residenza del pontefice sul colle del Vaticano e la fece circondare da nuove mura, all'interno delle quali fece impiantare un orto-giardino (viridarium), un prato (pratellum) e un frutteto (pomerium). Secondo alcuni studiosi, nel viridarium, forse già all'epoca di Niccolò III o a partire dal 1288, per opera del medico personale di Niccolò IV, il frate simplicista Simone da Genova, si coltivavano anche piante medicinali. Nella sua biografia di Niccolò V, l'umanista fiorentino Giannozzo Manetti riferisce che, in seguito alla ristrutturazione ordinata da papa Parentucelli, l'area verde a ridosso del palazzo del Vaticano venne trasformata in "un grande e splendido giardino, ricco di ogni genere di erbe e di frutti e irrigato dall'acqua perenne, che il pontefice aveva portato fin lì con grandi spese e ancor maggiore abilità tecnica dalla cima del monte" (si tratta del già citati acquedotto). Sempre secondo Manetti, una seconda area verde fu creata a ovest del Palazzo, dove poi sarebbe sorto il Belvedere. Su questo secondo giardino si affacciava una loggia, oggi scomparsa, destinata alle celebrazioni liturgiche pontificie. Un'altra testimonianza si deve a Giovanni Ruccellai che nella sua relazione sul giubileo del 1450 scrive con ammirazione della residenza del pontefice e dei suoi giardini: "Il Palazzo del Papa... bellissima abitazione, con giardini grandi et piccoli et con una peschiera et fontane d'acqua et con una conigliera". L'aspetto generale del complesso del Vaticano è infine documentato da un affresco di Bonozzo Gozzoli, conservato nella chiesa di Sant'Agostino a San Gimignano; nella parte alta del dipinto, all'interno della cinta muraria si vede un'ampia zona libera, genericamente sistemata a verde (potrebbe trattarsi di orti o frutteti) e una seconda area, prospicente al Palazzo con loggiato, nei pressi della Porta Viridaria, con un giardino formale, dove si osservano aiuole squadrate, con al centro un albero, che circondano una specie di padiglione piramidale, con una struttura fissa probabilmente in legno che fa da supporto a piante rampicanti. Insomma, certamente Niccolò V fece ristrutturare i giardini vaticani con una certa magnificenza, in accordo con il suo programma urbanistico di rilancio della città in generale e del Vaticano in particolare, ma si può davvero dire che sia anche il fondatore dell'Orto botanico di Roma, come si legge in vari siti, secondo i quali avrebbe fatto adibire una parte degli Horti vaticani a "orto medico per lo studio e l'insegnamento della botanica"? Escludiamo subito "lo studio e l'insegnamento": il decreto papale che istituisce l'insegnamento della botanica farmaceutica (declaratio simplicium medicinae) presso l'università di Roma è del 1513 (regnante Leone X) e l'istituzione di un orto botanico, come vedremo più avanti, addirittura del 1566. Che poi in una parte degli Horti vaticani si coltivassero piante medicinali, è possibilissimo, anzi probabile, ma non per questo possiamo parlare (senza documenti di sorta a provarlo) di hortus medicus e tanto meno di orto botanico. A riguardo sono ancora valide le considerazioni di Saccardo: "Già nel 1288 esisteva un orto farmaceutico (non didattico) nel Vaticano, piantatovi dal celebre Simone Genuense, allora medico di papa Niccolò IV. E di simile specie doveva essere l'orto che Niccolò V faceva coltivare pure nel Vaticano intorno al 1447 cunctis herbarum generibus refertus [pieno di ogni genere di erbe], come dice il Muratori. Un vero orto scientifico-didattico sorse nel Vaticano solo nel 1566 per opera di Michele Mercati, professore insigne e medico di Clemente VIII, già discepolo e amico di Cesalpino".  Modeste erbacee semiparassite Che Nicolò V avesse fondato non solo la Biblioteca vaticana ma anche l'orto botanico di Roma era convinto invece Domenico Viviani che, nel dedicare il genere Parentucellia al conterraneo (erano entrambi spezzini, Viviani di Levanto, Parentucelli di Sarzana) scrive così: "Ho nominato questo genere in onore di T. Parentucelli, nativo di Sarzana in Liguria, meritatamente ritenuto uno degli uomini più dotti del XV secolo, che assunto al pontificato con il nome di Niccolò V, fondò la Biblioteca vaticana e l'orto botanico di Roma; accolse con amabile ospitalità a Roma i sapienti cacciati dalla Grecia dai Turchi; e ad essi, affinché i loro frutti non andassero perduti per noi, affidò la traduzione in latino degli scritti dei filosofi greci; a Teodoro Gaza Historia plantarum di Teofrasto e De animalibus di Aristotele, al Trapezunzio i Problemata di Aristotele ed altro. Così, con i propizi auspici di tanto uomo, da queste fonti di aurea dottrina rifulse la prima luce delle scienze naturali". Possiamo convenire con Viviani che aver fatto risorgere Teofrasto sia un merito sufficiente a fare entrare papa Parentucelli nel canone dei dedicatari di generi botanici. Il genere Parentucellia (Orobanchaceae) non ha per altro nulla di pontificale o celebrativo. Raccoglie infatti da una a tre specie di modeste annuali erbacee semiparassite diffuse nel bacino del Mediterraneo; come altre specie di questa famiglia, benché siano provviste di clorofilla, traggono una parte dei nutrienti dalle radici di piante ospiti con cui si connettono mediante austori. Come tutti i generi di questo gruppo, affini a Bartsia, ha avuto una storia tassonomica travagliata. Separato appunto da Viviani da Euphrasia, è stato alternativamente riconosciuto o inserito in altri generi. POWO gli attribuisce tre specie: P. latifolia, P. viscosa e P. flaviflora, che potrebbero però essere ridotte a una sola se P. viscosa va inserito in Bellardia, come sostengono sulla base di dati molecolari Uribe-Convers e Tank, e se P. flaviflora va considerato una sottospecie di P. latifolia. Questa linea è stata seguita anche da Acta plantarum, che considera valida la denominazione Bellardia viscosa, come anch'io ho fatto qui. In tal caso, nella flora italiana troviamo una sola specie di Parentucellia, appunto P. latifolia. Ha un ampio areale che va dalle Canarie all'Afghanistan, e nel nostro paese è presente in quasi tutte le regioni (manca nel Nord est), tipicamente in pascoli aridi o incolti con terreno calcareo, in collina o in montagna fino a 1200 metri; ha fusti eretti, semplici o ramificati solo nella porzione superiore, foglie talvolta dentate ricoperte da peli ghiandolari; i piccoli fiori sono raggruppati in infiorescenze apicali compatte, da subsferiche a cilindriche, e hanno corolla zigomorfa a cinque lobi da rossastri a viola, da cui il nome comune perlina rossiccia. P. flaviflora, diffusa dal Mediterraneo Orientale all'Asia centrale, è molto simile, tanto che come ho anticipato alcuni la considerato una sottospecie della precedente; è di dimensioni minori e ha fiori da bianchi a giallastri. In questa storia si incontrano due misteri a prima vista senza connessioni. Il primo: chi era lo sfuggente "signore di Reynoutre" cui il botanico olandese Maarten Houttuyn dedicò il genere Reynoutria? Il secondo: chi ha creato o commissionato i bellissimi Libri picturati A16-30, uno dei massimi capolavori dell'illustrazione botanica del Rinascimento? E ancora: c'entra qualcosa Carolus Clusius? E come sono finiti alla Staatsbibliothek di Berlino? Le risposte convergono verso un luogo, un'epoca e una persona: le Fiandre meridionali della seconda metà del Cinquecento e il nobile Charles de Saint Omer, il primo mecenate di Clusius.  Sulle tracce dei Libri picturati: Berlino, anni 30 Prima storia e primo mistero. Nel 1777 ad Amsterdam il botanico olandese Maarten Houttuyn pubblica il settimo tomo del secondo volume della sua Natuurlyke historie. Nel capitolo dedicato all'annuale acquatica Callitriche verna (oggi si chiama Callitriche palustris subsp. palustris) riassume quanto ne hanno scritto i botanici preceedenti e, a proposito di Mathias de Lobel, scrive: "E' stata descritta e raffigurata sotto il nome Stellaria da Lobel, il quale dice che il signore di Reynoutre, un grande amante delle piante a lui noto, non badò a spese per fare raffigurare dopo la vita piante tanto straniere quanto autoctone, tra cui questa specie". Nell'ottavo tomo, pubblicato lo stesso anno, si ricordò del signore di Reynoutre per dedicargli il nuovo genere Reynoutria con queste parole: "Per un certo signore di Reynoutre, che, secondo la testimonianza di Lobel, ha dato grandi servizi alla scienza delle erbe, come ho già segnalato". Houttuyn non ne sa di più; e continuano a non sapere altro molti siti, in cui si legge "in onore del Barone van Reynoutre (sec. XVI), grande amante delle piante" oppure "in onore del Barone van Reynoutre (sec. XVI) che, secondo Lobelius, era un appassionato estimatore delle piante". Genaust ne sa anche meno: "Nome di Houttuyn per una Polygonacea dell'Asia orientale; etimo non chiaro". Seconda storia anche più misteriosa, nonché intricata. Nel 1941, in seguito a pesanti bombardamenti, viene deciso di evacuare i più preziosi manoscritti della Biblioteca nazionale di Berlino, tra cui l'inestimabile raccolta nota come Libri picturati: ben 144 volumi di migliaia di illustrazioni di piante, animali, persone, provenienti dalle collezioni personali del re di Prussia. La raccolta viene smembrata in lotti che vengono trasportati in diversi luoghi ritenuti sicuri. Uno viene inizialmente ricoverato nel castello di Fürstenstein in Slesia, quindi nel 1943 nuovamente trasferito nel monastero benedettino di Grüssau (oggi Krzeszów). Poi per anni e anni non se ne sa più nulla. Solo nel 1977 lo zoologo Peter Whitehead ritrova i manoscritti nella Biblioteka Jagiellońska di Cracovia, dove erano stati portati nel 1947 senza che la notizia fosse trapelata in Occidente, e dove si trovano tuttora. I Libri picturati della Jagellonska possono essere divisi in due nuclei principali, di data e provenienza diversa; i volumi A32-A38 contengono materiali iconografici relativi all'esplorazione del Brasile olandese promossa da Giovanni Maurizio di Nassau Siegen, che ne fu governatore dal 1636 al 1644; quando tornò in Europa, il principe, in cambio di titoli e proprietà, ne fece dono all'elettore Federico Guglielmo di Prussia che incaricò di selezionarli e riunirli in volume il suo medico personale Christian Mentzel; questi, nel volume A 38, noto come Miscellanea Cleyeri, incluse anche rappresentazioni etnografiche e acquarelli di piante asiatiche che gli erano state inviate dal suo corrispondente Andreas Cleyer. Il mistero riguarda le origini e la vicenda degli altri volumi del lotto, i Libri picturati A16-31. Al contrario di quelli "brasiliani", non hanno né titolo né frontespizio, né ci sono ex-libris o altre note di possesso. I 15 volumi in folio contengono oltre 1400 acquarelli di piante e animali; lo stile dei disegni e dettagli delle annotazioni rimandano alle Fiandre della seconda metà del Cinquecento; la rilegatura però risale a circa il 1660 o anche dopo, ed alcune immagini furono presumibilmente inserite in un secondo tempo. Chi abbia dipinto gli acquarelli, chi abbia ordinato o messo insieme la raccolta, quale mano abbia scritto le note che accompagnano molte immagini, per quali vie il manoscritto sia giunto a Berlino, è ancora oggetto di dibattito, anche se, come vedremo, orami sono noti glie elementi essenziali. La qualità delle immagini è eccezionale e si tratta senza dubbio di una delle più importanti collezioni di acquarelli naturalistici del Rinascimento; eppure hanno attirato l'attenzione degli studiosi solo dopo il loro "miracoloso ritrovamento" (la definizione è di Whitehead). Unica eccezione il bibliotecario tedesco Hans Wegener che negli anni '30 lavorava nel dipartimento dei manoscritti della Biblioteca statale di Berlino; studiando attentamente le immagini, notò che diverse avevano una stretta affinità con le xilografie di opere di Carolus Clusius stampate da Plantin tra il 1574 e il 1576; trovò corrispondenze anche con xilografie della prima edizione del Kruydtboeck di Lobel (1581) e con la prima parte di Rariorum plantarum historia di Clusius (1601). Osservò poi che nelle annotazioni erano citate regioni come la Provenza e città come Salamanca, Montpellier e Marsiglia, tutte località visitate da Clusius; c'erano parecchi riferimenti a località fiamminghe, e in particolare a Moerkerke, dove Clusius trascorse un lungo periodo nel castello di Charles de Saint Omer. Comparivano anche i nomi dei fratelli Laurin, di Jacobus van den Eede di Bruges e del farmacista di Anversa Peeter van Coudenberghe, tutti noti amici di Clusius. Sulla base di tutti questi elementi, Wegener giunse a una conclusione che gli sembrava tanto chiara quanto inappuntabile: a predisporre quella raccolta non poteva essere stato che il grande botanico fiammingo, e in un suo articolo del 1936 fin dal titolo non esitò a definire il manoscritto Das grosse Bilderwerk des Carolus Clusius, ovvero "La grande opera pittorica di Carolus Clusius". Inoltre, nel catalogo della biblioteca dell'elettore compilato nel 1668, individuò la menzione di "XVI tomi tam Animalium quam Plantarum ex Bibliotheca Cancellarii Weinmanni" (16 tomi sia di animali sia di piante, provenienti dalla biblioteca del cancelliere Weinmann). Si trattava senza dubbio dei Libri picturati A16-31, giunti a Berlino o come dono del cancelliere di Kleve Daniel Weinmann o come acquisto di Federico Guglielmo. Molto rimaneva da scoprire, ma ostacoli burocratici prima, lo scoppio della Seconda guerra mondiale poi gli impedirono di continuare le ricerche. 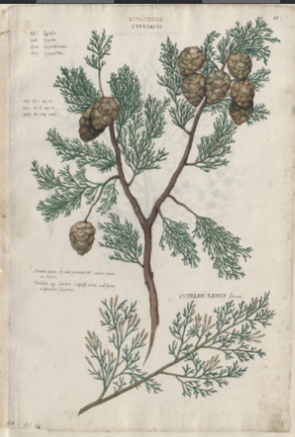 Clutius versus Clusius? No, Saint Omer! Il ritrovamento dei manoscritti riaccese l'interesse degli studiosi. Nel 1989, Whitehead, van Vliet e Stearn pubblicarono un'accurata descrizione dell'intero lotto, in cui distinsero segmenti risalenti a periodi compresi tra il XVI e addirittura il XIX secolo. Per quanto riguarda i Libri picturati A16-30 (A31 non fa parte della serie, perché fu prodotto nel XVII secolo ed è per lo più costituito da copie di disegni di piante dei volumi A18-A30), suggerirono che i contenuti dei volumi fossero stati riordinati e fatti rilegare da un altro medico di Federico Guglielmo, Johann Elsholz. Il volume A16 contiene immagini di pesci e mammiferi, A 17 di uccelli, A18-30 circa 1500 acquarelli di piante, relativi a 1860 taxa (alcuni fogli raffigurano infatti più di una specie). In genere accettavano la conclusione di Wegener che Clusius avesse avuto un ruolo chiave nella creazione della raccolta, ma pensavano anche che non tutti i disegni fossero stati commissionati o ispirati da lui. A puntare in tutt'altra direzione pensò la storica statunitense Claudia Swan che in un saggio del 1995 sostenne che la raccolta non andava attribuita a Clusius, ma a Clutius, ovvero non a Charles de l'Ecluse, ma al suo amico Dirck Outgaertsz. Cluyt, primo hortulanus dell'orto botanico di Leida. L'ipotesi di Swan non ha trovato seguito, ma ebbe il merito di riaccendere il dibattito. In un saggio pubblicato l'anno successivo, la storica dell'arte belga Helena Wille respinse in poche righe la tesi di Swan, per suggerire una propria ipotesi diversa da quella del "libro di Clusius". Le evidenze raccolte da Wegener dimostravano senza dubbio che c'era un legame tra Clusius e la raccolta, "ma ciò che non significava che egli fosse colui che l'aveva commissionata". Sappiamo che Clusius possedeva una biblioteca, una piccola raccolta di curiosità, un erbario, ma non una collezione di acquarelli; inoltre, sempre squattrinato com'era, non avrebbe certo potuto permettersela. Non avendo né un giardino proprio, né adeguate risorse finanziare, la soluzione ideale per studiare piante esotiche e averne le illustrazioni per i suoi libri era ricorrere a un mecenate appassionato di piante. Quando viveva in Austria, l'aveva trovato nel nobile Boldiszar de Batthyani, che l'aveva più volte invitato nel suo castello ungherese e aveva fatto dipingere piante per lui. Un mecenate c'era anche nelle Fiandre, e lo abbiamo già incontrato: Charles de Saint Omer, membro di una delle più illustri casate del paese, appassionato di piante, amico di Clusius, che aveva ospitato sia a Bruges sia nel suo castello di Moerkerke. Anzi, lo abbiamo già incontrato due volte, sotto nomi diversi. I Saint Omer erano originari dell'Artois, ma alcuni rami avevano signorie nelle Fiandre, e il nostro poteva indifferentemente chiamarsi in francese Charles de Saint Omer, in fiammingo Karel van Sint Omaars, ma anche, usando i titoli nobiliari com'era d'uso per un gentiluomo, Charles de Saint Omer, detto di Moerbeke, signore de Moerkercke, Dranoutre (ovvero Ranoutre o Reynoutre), o ancora Mijnheer de Reynoutre. Ovvero il personaggio citato da Lobel, che ci ha già informato che il nobiluomo non aveva lesinato spese per fare ritrarre le sue amate piante. Anzi è proprio sulla base di puntuali corrispondenze tra alcuni acquarelli dei Libri picturati e le corrispondenti immagini del Kruydtboeck di Lobel (1581), nel cui testo viene esplicitamente citato Mijnheer de Reynoutre, che Wille dimostra il ruolo di Charles de Saint Omer come committente della collezione. Inoltre, individua il probabile autore degli acquarelli, o almeno di buona parte di essi, nel valente pittore Jacques (o Jacob) Corenhuyse, membro della Gilda di San Luca di Bruges. Una lettera, inviata nel 1595 a Clusius da Carlo di Arenberg, un altro gentiluomo appassionato di piante, le permette infine di trovare un anello di collegamento tra Charles de Saint Omer, morto nel 1569, e il cancelliere Weinmann che quasi un secolo dopo fece giungere i volumi a Berlino. Arenberg informa il botanico di aver acquistato "le livre de feu Monsieur Ranoutre", (il libro del fu signor Ranoutre), che come abbiamo visto è uno dei tanti modi per designare il defunto Charles de Saint Omer. La lettera era stata già pubblicata qualche anno prima da un archivista, che però non aveva identificato il personaggio. Wille osserva che è comprensibile: il fatto stesso che fosse designato in modo diversi dimostra che "questo eminente amante delle piante era stato davvero dimenticato". Dalla lettera di Arenberg, la studiosa belga ricava un ultimo dettaglio importante: Clusius è stato direttamente coinvolto nella confezione dei Libri picturati, non come committente, ma come esperto: è sua la mano che ha scritto le annotazioni che accompagnano molti acquarelli. Queste dunque le sue conclusioni: "Abbiamo in realtà a che fare con il catalogo dipinto della collezione di oggetti naturali riuniti nello studio e nel giardino di Karel van Sint Omaars, successivamente riordinato e integrato da Karel van Arenberg, anch'egli grande amante delle piante, dipinto per la maggior parte da Jacques van Corenhuyse e annotato da Clusius". 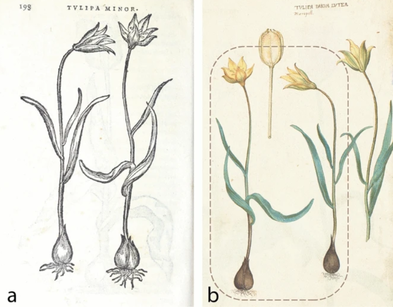 Mijnherr de Reynoutre svelato L'articolo di Wille ha costituito la base per gli studi successivi, che, seppur discostandosi dalle sue conclusioni in alcuni particolari, ne hanno sostanzialmente confermato l'impianto. Di particolare importanza i contributi di Luis Ramón-Laca, che nel 2011 sulla base dei marchi della carte ha dimostrato che la maggior parte degli acquerelli formavano già una raccolta nel XVI secolo; su 1400 fogli, più di 1100 utilizzano una carta prodotta a Fabriano a partire dal 1554. In 625 di questi fogli gli acquerelli sono accompagnati da annotazioni "di una mano professionale", mentre i restanti in genere non sono terminati e spesso corrispondono a xilografie delle opere di Clusius. Le due serie differiscono anche per lo stile: da una parte ci sono acquarelli molto realistici, dipinti dal vivo, quasi sempre annotati, dall'altra disegni molto più schematici, per lo più non terminati e tratti da esemplari d'erbario. Nel 2008 Florike Egmond, una specialista di Clusius di cui ha curato la pubblicazione dell'epistolario, ha fatto il punto sullo stato delle ricerche in un ampio articolo in cui, dopo aver demolito la tesi di Swan con un'ampia argomentazione, analizza in modo puntuale i luoghi e le persone citati nelle annotazioni, la corrispondenza tra le immagini e opere a stampa coeve, le informazioni in nostro possesso su Charles de Saint Omer, le sue collezioni e la sua relazione con Clusius e con i possibili artisti coinvolti, per concludere con un approfondimento sul contesto culturale in cui è nata l'opera, il circolo umanistico di Bruges. E così conclude: "La conclusione appare inevitabile: il nucleo centrale dei Libri picturati A16-30 [...] fu messo insieme e posseduto da Charles de Saint Omer con l'assistenza e la consulenza di Clusius negli anni '60 (probabilmente tra il 1562-63 e il 1568). Clusius stimolò o forse innescò l'interesse di Saint Omer per gli oggetti naturali ed è probabile che lo abbia incoraggiato a far pubblicare i suoi acquarelli botanici [...]. Un considerevole numero di acquarelli appartenenti a questo nucleo sono stati probabilmente dipinti da Corenhuyse e possibilmente da Van der Bosch. Le annotazioni della 'mano professionale' su un gruppo di 625 acquarelli botanici in tutta probabilità sono state fatte da Clusius. Nel corso del XVI secolo alla collezione sono state fatte aggiunte, certamente da Aremberg, possibilmente da Clusius stesso, e probabilmente da altri". Contrariamente a Wille, non ritiene però che i Libri picturati 16-30 siano un catalogo del giardino e della Wunderkammer del castello di Moerkerke, ma piuttosto "una specie di enciclopedia di casa, in cui potevano essere inclusi dipinti, copie di opuscoli su animali curiosi e piante esotiche inviate a Saint Omer, a Clusius o a uno dei loro amici". Nel 2008 l'editore Brill ha pubblicato lo spettacolare volume Drawn after Nature: The Complete Botanical Watercolours of the 16th-Century Libri Picturati, che contiene tutte le immagini botaniche dei Libri picturati 18-30, introdotte da un team internazionale cui si devono anche numerosi saggi che indagano la storia, il contesto e il valore artistico e scientifico di quello che ormai potremmo chiamare "il libro di botanica di Charles de Saint Omer". E' dunque ora di conoscere meglio questo appassionato di piante che ha rischiato di essere totalmente dimenticato. Charles de Saint Omer (1533-1569) alias Karel van Sint Omaars alias Mijnherr de Reynoutre, era il secondogenito di Josse (Joos) de Saint Omer, signore di Oudeneem, Merris e Dranouter, e di Anna van Praet, dama di Moerkerke. Tra i suoi antenati troviamo uomini d'arme e di potere, come il bisnonno Josse, consigliere e ciambellano ordinario prima di Carlo il Temerario poi dell'imperatore Massimiliano d'Asburgo. Dopo aver forse frequentato l'università a Lovanio, intraprese il mestiere delle armi che però presto dovette abbandonare a causa della salute malferma. Molto ricco e colto, si ritirò a vivere nella tenuta e nel castello di Moerkerke non lontano da Bruges, che aveva ereditato dalla madre (morta nel 1559), dove si dedicò agli studi umanistici, forse alla poesia, e soprattutto alle scienze naturali. Possedeva anche una casa a Bruges, dove in genere trascorreva i mesi invernali, ma Moerkerke era la residenza principale della famiglia. Conosceva diverse lingue: il francese, la sua lingua madre, il fiammingo, il latino, e probabilmente aveva qualche nozione di greco, tedesco e italiano. Come ha sottolineato Florike Egmond, faceva parte del circolo umanistico di Bruges ed era strettamente legato ai fratelli Mathias e Guido Laurin (o Laurinus), che condividevano i suoi interessi naturalistici. Si sposò due volte, prima con Françoise de Blois, detta Trèslong, poi con Anne d'Oingnies, ma non ebbe figli. Della sua vita personale in realtà conosciamo pochissimo. Sappiamo invece qualcosa di più sulle sue collezioni e soprattutto sul suo giardino. Nel castello di Moerkerke c'erano una biblioteca, con opere in greco, latino, francese e italiano, e due gabinetti di curiosità, uno attiguo alla camera del signore, l'altro alla camera della moglie; il primo conteneva oggetti considerati più maschili, come una collezione di armi, il secondo le vere e proprie rarità, compresi "un cofanetto con dentro quattro libri di erbe dipinte", "l'inizio di un libro degli uccelli", "l'inizio di un libro sui pesci e altri animali", "una scatola di minerali". come leggiamo nell'inventario che fu redatto dopo la sua morte. In base al contratto matrimoniale, gli oggetti contenuti nel gabinetto di Anne rimasero di sua proprietà anche dopo la morte del marito. I futuri Libri picturati probabilmente furono venduti dopo la sua morte nel 1577, fino a finire nelle mani di Arenberg, ma non conosciamo i passaggi intermedi. Quanto al giardino, era considerato uno dei più raffinati della regione. E' ricordato anche da Lodovico Guicciardini che ebbe modo di visitarlo e nella sua Descrizione dei Paesi Bassi scrive: "Anche il signor Carlo di Sant'Omero nella signoria di Moerkerke, a un miglio e mezzo da Bruges, ha un giardino con innumerevoli varietà eccellenti e mille altre cose belle che faranno sì che questo luogo, ma anche il Signore, sia famoso e lodato per sempre". Forse esisteva già in precedenza, ma Charles lo rimodellò secondo il gusto del tempo, avvalendosi dei consigli (e delle piante) di Clusius. Si trovava all'esterno della corte superiore del castello, sui lati sud ed est, ed era diviso in due parti: il giardino di piacere e il giardino delle erbe; inoltre c'era un grande frutteto. Nel giardino delle erbe si coltivavano piante sia autoctone sia esotiche, alcune delle quali procurate da Clusius: "sedotto dall'amore per le piante dell'illustre signore di Dranoutere" dalla Spagna gli inviò semi attraverso il comune amico Guido Laurinus; nel 1566 gli donò semi di pepe brasiliano (Schinus terebinthifolia) di cui Saint Omer riuscì a coltivarne un esemplare che fiorì nell'autunno dello stesso anno; gli donò anche uno dei due germogli di Aloe americana che aveva prelevano in un giardino di Valencia e aveva portato con sé nelle Fiandre. E' probabile dunque che ci fosse qualche struttura per proteggere le esotiche dai rigori invernali. Dall'inventario dei beni risulta che nei gabinetti di Charles e Anne c'erano anche "un couffre pour y mectre les semences" (un cofanetto per riporre i semi) e 'ung grand ormaire pour garder sementes', un grande armadio per conservare i semi. Questi ultimi venivano raccolti e conservati per riseminarli nel giardino, ma anche per scambiarli con altri collezionisti, come sappiamo dalla corrispondenza di Clusius. Vengono menzionati anche i nomi dei due giardinieri che si occupavano l'uno del giardino, l'altro del frutteto, rispettivamente Paul de Witte e Zegher de Wever. Inoltre, a Moerkerke c'era anche un piccolo zoo, con animali da fattoria ma anche qualche rarità esotica o curiosa. Secondo la testimonianza di Lobel, Charles de Saint Omer coltivava piante esotiche anche nel giardino della sua casa di Bruges: nel suo Kruydtboeck infatti egli scrive che intorno al 1567 vi cresceva il grano dei turchi, cioè il mais, quasi introvabile nei Paesi Bassi. Per concludere, due parole su Charles de Saint Omer come mecenate di Clusius. Il botanico dovette incontrarlo prima di partire per la Spagna, come si evince dal già citato invio di semi. Al suo ritorno in patria, venne ospitato da Saint Omer dal settembre 1565 al novembre 1567. Egli poté così dedicarsi alla stesura della sua prima opera, la traduzione dei Coloquios dos simples di Garcia da Orta (Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia, 1567). Ma per il suo lavoro di "consulente botanico" riceveva, oltre a vitto e alloggio, anche un salario di 200 lire. Principale frutto dei due anni di coabitazione e collaborazione con Saint Omer, come già sappiamo furono i Libri picturati, che però non vennero né completati né stampati, sia per la morte precoce del nobiluomo, a soli 36 anni, sia per la situazione politica delle Fiandre spagnole, in rivolta dal 1566. Secondo Jacques de Groote, che nel suo sito ha raccolto una grande massa di informazioni su Charles de Saint Omer, egli si ricordò del suo protetto lasciandogli in eredità i suoi libri greci e latini, anche se probabilmente Clusius non riuscì mai a recuperarli (secondo altri, si trattava di libri suoi che aveva lasciato a Moerkerke). Quanto al botanico, nella sua prima opera così ricorda il suo primo protettore: "Un uomo non solo espertissimo in materia di piante e che fece dipingere le piante stesse, gli uccelli e i quadrupedi con eccezionale abilità in colori vivaci, ma anche molto interessato alla natura di ogni sorta di cose meravigliose".  Reynoutria, un pericolo venuto da Oriente Ed eccoci ritornati a Reynoutria, il genere dedicato da Houttuyn al signore di Reynoutre, ovvero a Charles de Saint Omer, separandolo da Polygonum. Una scelta presto messa in discussione: nel 1848 la sua Reynoutria japonica fu riclassificata come Polygonum sieboldii, per poi essere inserita nel genere Fallopia. Le ricerche filogenetiche basate sul DNA ne hanno invece confermato l'indipedenza, anche se vari autori continuano a considerarlo una sezione del genere Fallopia. Ne è derivata una certa confusione terminologica, con la stessa pianta denominata da autori diversi Polygonum, Fallopia o Reynotria. Inteso come genere indipendente, Reynoutria comprende cinque specie accettate, tutte originarie dell'Asia orientale, più un ibrido naturale, R. x bohemica, originato dall'incrocio tra R. japonica e R. sachalinensis. La specie più nota (o famigerata) è R. japonica, originaria di Giappone, Cina e Corea; portata in Europa dal Giappone da von Siebold, incominciò ad essere commercializzata negli anni '40 dell'Ottocento. Entro il 1850, Siebold ne donò un esemplare ai Kew Gardens; il dono fu molto apprezzato e determinò il successo della pianta, che piaceva ai giardinieri perché i suoi fusti assomigliavano ai bambù e "facevano oriente", senza contare che era facile da coltivare e cresceva dappertutto. Verso la fine del secolo si era naturalizzato in varie parti d'Europa, ma dato che nel nostro continente (e in America) non si riproduce per seme, non causava problemi. Le cose sono cambiate nel Novecento, quando la creazione di infrastrutture, i movimenti di terra e le inondazioni ne hanno scatenato le potenzialità invasive. Basta infatti un frammento di rizoma perché attecchisca e incominci a formare una colonia, che diventerà così fitta da escludere ogni altra pianta, inclusa l'erba. Oggi è inserita nella lista delle piante aliene invasive più aggressive e difficili da controllare. E' tuttavia molto bella; chi l'apprezza, può ripiegare sulla cultivar 'Variegata', con foglie cuoriformi spruzzate di giallo, di crescita rapida, ma non considerata invasiva. Lo sono invece anche le altre due specie ampiamente introdotte in Europa. R. sachalinensis, una specie simile alla precedente ma di dimensioni molto maggiori, fu originariamente introdotta (1864) dall'orto botanico di San Pietroburgo per poi diffondersi soprattutto verso la fine dell'Ottocento, quando una prolungata siccità ne favorì l'impiego come foraggio. Introdotta in Italia nel 1897 come ornamentale a Roma, oggi è presente in quasi tutte le regioni settentrionali, in Toscana e in Lazio. Presenta gli stessi problemi di R. japonica e si espande soprattutto lungo i corsi d'acqua, per il trasporto da parte della corrente dei rizomi delle piante che crescono lungo gli argini. L'ibrido tra le due specie R. x bohemica era già coltivata nei giardini inglesi nel 1872, ma è stata individuata e descritta per la prima volta solo nel 1983, per la Repubblica ceca (da cui l'eponimo); è infatti difficile da distinguere dai genitori, con cui è stata a lungo confusa. E' dunque problematico determinare con precisione la data della sua introduzione. Oggi in Italia anch'essa è classificata come aliena invasiva in quasi tutte le regioni dell'Italia settentrionale e in Toscana. Ha probabilmente potenzialità invasive anche R. multiflora (nota anche con il sinonimo Pleuropterus multiflorus), che, a differenza delle altre specie, tutte erbacee perenni decidue, è una rampicante; diffusa dalla Cina all'Indocina, è una specie officinale, uno dei tonici più importanti della medicina traduzionale cinese. Da queste specie aggressive sembra distinguersi R. compacta, una specie di piccole dimensioni con fiori femminili rossastri e fiori maschili biancastri, talvolta coltivata come ornamentale. L'ultima specie, R. cilinervis, originaria della Cina e della Corea, sembra non sia mai stata introdotta nei giardini occidentali. E, viste le sue parentele, verrebbe da aggiungere: per fortuna! Tra il 1683 e il 1685, il farmacista e pittore di origine tedesca Heinrich Claudius prese parte a due spedizioni nel Namaqualand (Sudafrica); durante la seconda, comandata dal governatore van der Steel in persona, fu incaricato di illustrare il diario della spedizione. Le sue illustrazioni della flora sudafricana, tra le primissime a raggiungere l'Europa, attirarono l'attenzione dei collezionisti. Tra di essi anche il sindaco di Amsterdam Nicolaes Witsen, che, non sappiamo se in Europa o a Città del Capo, fece copiare diverse tavole botaniche di Claudius per includerle nella sua collezione di illustrazioni botaniche, il cosiddetto Codex Witsenii. Secondo Boerhaave aveva dimensioni favolose, ma solo pochissimi dei disegni originali che ne facevano parte sono giunti fino a noi, seguendo vie alquanto tortuose. La botanica (per qualche tempo fu anche commissario dell'orto botanico di Amsterdam) non fu per altro che uno dei tanti interessi del multiforme Witsen, non solo uno dei più grandi collezionisti del suo tempo, ma anche uomo politico, diplomatico, cartografo, esperto di costruzioni navali, nonché amico e corrispondente dello zar Pietro il grande. A ricordarlo il singolare genere sudafricano Witsenia, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae. 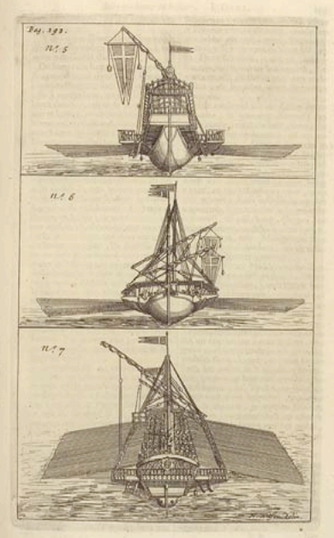 Uno zar eccentrico e un sindaco dai molteplici interessi Nel marzo 1697, il giovane zar Pietro, all'epoca venticinquenne, si imbarcò per quella che è passato alla storia come "Grande ambasciata". La missione aveva un obiettivo diplomatico che non si realizzò (costruire una grande alleanza antiturca), ma anche obiettivi non certo minori agli occhi di Pietro, che furono conseguiti con successo. Egli infatti desiderava anche acquistare armi e attrezzature militari e ingaggiare specialisti che lo aiutassero a modernizzare il suo paese; a cuore gli stava soprattutto la creazione di una flotta all'altezza dei migliori standard europei. Una delle tappe principali del suo viaggio fu dunque la Repubblica delle Province unite, dove giunse ad agosto, dopo aver incontrato il duca di Curlandia e aver stretto un'alleanza con il re di Prussia. Desideroso di apprendere di persona le tecniche di costruzione navale, accompagnato da dodici volontari e vestito con abiti comuni, prima ancora di raggiungere la frontiera olandese Pietro si separò dalla delegazione ufficiale, che proseguiva più lentamente alla volta di Amsterdam, e si imbarcò per Zaandam, dove si trovavano importanti cantieri navali. La mattina stessa del suo arrivo, fu riconosciuto dal fabbro Gerrit Kist che aveva lavorato a Mosca, e lo convinse ad affittargli una stanza nella sua casetta di legno, tuttora conservata. Quindi, per otto giorni, sotto il nome di Pëtr Michailov, lavorò come carpentiere in uno dei cantieri. Tuttavia, la sua presenza non passò certo inosservata, tanto più che Pietro era un gigante di oltre 2 metri. Stufo delle crescenti attenzioni, egli scrisse al sindaco di Amsterdam e direttore della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Nicolaes Witsen (1641-1717) che gli consigliò di spostarsi a Amsterdam dove avrebbe potuto lavorare lontano da occhi indiscreti in uno dei moli della compagna. Così lo zar lasciò Zaandam e il 27 agosto assistette in incognito all'arrivo della delegazione russa, con la quale visitò il municipio e l'orfanatrofio e il giorno seguente i cantieri della VOC. Intanto Witsen si era dato da fare e aveva convinto i vertici della Compagnia ad autorizzare Pietro a lavorare nel cantiere di Oostenburg, dove appositamente per lui sarebbe iniziata la costruzione di una nuova fregata. Così, dal 30 agosto, per 4 mesi, il "mastro Pietro", come amava farsi chiamare, lavorò come apprendista carpentiere nel cantiere della VOC; contemporaneamente, c'erano anche gli incontri ufficiali (il 10 settembre andò ad Utrecht per incontrare lo statolder Guglielmo, che dal 1689 era anche re d'Inghilterra), le visite culturali, gli stages presso esperti, la campagna acquisti di studiosi e artigiani da attirare in Russia. A organizzare molte di queste attività fu Witsen, con il quale lo zar corrispondeva da tempo, tanto da considerarlo un amico personale. Del resto, il borgomastro era noto come il massimo esperto di affari russi dell'Europa occidentale. Nel 1664 aveva vistato la Russia come membro di un'ambasceria e si era trattenuto nel paese per tre anni, spingendosi fino al mar Caspio. Durante i suoi viaggi, incontrò persone di ogni ceto, strinse utili relazioni e raccolse molti materiali etnografici; nel 1667, prima di rientrare in Olanda, fu ricevuto dal padre di Pietro, lo zar Aleksej Michajlovič. Nei vent'anni successivi, continuò a coltivare un grande interesse per la Russia che culminò tra il 1690 e il 1692 con la pubblicazione della prima carta della Siberia e di Noord en Oost Tartarye ("La Tartaria settentrionale e orientale"), un'ampia trattazione di geografia, etnografia, linguistica, flora e fauna di ciò che all'epoca si chiamava Tartaria, ovvero il vastissimo territorio situato tra il Mar Caspio e l'Oceano Pacifico; non la sola Siberia, dunque, ma il Caucaso, l'Asia centrale, l'Asia Interna, e oltre, fino alla Manciuria, la Mongolia, la Corea e lo stesso Giappone. Insieme a un resoconto del suo viaggio in Russia, ne inviò una copia allo zar Pietro, che però era molto più interessato al secondo campo di studio di Witsen: le costruzioni navali. Nel 1671 egli aveva infatti pubblicato la prima edizione di Aeloude and hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier ("Cantieristica e gestione navale antica e contemporanea"), che presto divenne un'opera di riferimento. Lo zar iniziò a corrispondere con Witsen, che divenne di fatto il suo agente ufficioso in Olanda; ne seguì un ordine di navi da guerra ai cantieri navali di Amsterdam e un ukase sul commercio russo-olandese che garantiva alla Repubblica l'importazione di grano, legno, talco, catrame e pellami. Allo studio della cartografia e delle costruzioni navali il multiforme Witsen dedicava il tempo libero. Per tradizione familiare, era infatti una delle personalità più in vista dell'economia e della politica dei Paesi Bassi. Già il padre Cornelis Jan Witsen era stato sindaco di Amsterdam, membro del consiglio dell'Ammiragliato e direttore della Compagnia delle Indie Occidentali. A sua volta, Nicolaes fu borgomastro di Amsterdam per 13 volte (l'ultima nel 1705) e dal 1693 direttore della VOC; nel 1690 fu inviato come ambasciatore straordinario in Inghilterra, dove Guglielmo III si era appena insediato; nel 1702 fu coinvolto nelle trattative tra gli Stati generali olandesi e il re di Prussia. All'epoca, Amsterdam era il porto più trafficato d'Europa ed era il paradiso dei collezionisti; in città si contavano almeno una cinquantina di Wunderkammer, e ovviamente una delle più prestigiose era quella di Witsen, che aveva iniziato a raccogliere curiosità in gioventù durante il viaggio in Russia e continuò ad arricchire gli scaffali e i cassetti del suo gabinetto, avvantaggiandosi della sua posizione di direttore della VOC. Profondamente convinto che le conoscenze scientifiche giovassero agli affari, incoraggiò le ricerche degli agenti della compagnia; protesse Rumphius, il primo studioso della flora delle Molucche; incoraggiò i viaggi di Cornelis de Bruijn, che visitò e dipinse le rovine di Persepoli; promosse la spedizione di Willem de Vlamingh nell'Australia occidentale (1696-97). Dai suoi corrispondenti riceveva informazioni di prima mano, ma anche rarità di varia natura per il suo gabinetto di curiosità. De Brujn gli inviò i suoi disegni di Persepoli e Vlamingh una cassa di conchiglie, frutti e piante australiani, insieme a undici disegni del disegnatore e cartografo della spedizione Victor Victorsz. Negli anni '90, su suo incoraggiamento Herbert de Jager realizzò disegni della flora di Giava (che però nel 1695 vennero sequestrati dalla VOC, che temeva che la loro conoscenza potesse avvantaggiare mercanti rivali). Quella di Witsen, come apprendiamo dal catalogo dell'asta che fece seguito alla sua morte, era una collezione universale: c'erano monete antiche e reperti archeologici, pietre preziose, armi, curiosità etnografiche, oggetti laccati, porcellane e dipinti provenienti dall'Asia. Anche se il suo interesse principale andava alla geografia, all'etnografia e alla linguistica, non disdegnava le scienze naturali: nel suo gabinetto di curiosità c'erano pietre, minerali, fossili, conchiglie, coralli, preparazioni animali (tra cui un rospo del Suriname Pipa pipa sotto spirito), insetti, zanne di mammut, corna di ogni tipo (tra cui una zanna di narvalo, che secondo Witsen era all'origine del mito degli unicorni). Non risulta avesse un erbario, ma certamente possedeva una ricca collezione di illustrazioni botaniche che, secondo la testimonianza di Hermann Boerhaave, giunse a comprendere oltre 1500 tavole. Tuttavia esse non risultano nel catalogo d'asta. Ne conosciamo solo una selezione, però in modo indiretto ed enigmatico. Intorno al 1692, Witsen fece eseguire o piuttosto copiare, non sappiamo se a Città del Capo o in Europa, numerosi acquarelli di piante sudafricane, dipinte dal pittore tedesco Heinrich Claudius, che nel 1685 aveva partecipato come disegnatore ufficiale alla spedizione nel Namqualand diretta dal governatore de Steel. Ne risultò un manoscritto di tre volumi, noto come Codex Witsenii o Codex witsenianus; Witsen, che all'epoca era anche uno dei commissari dell'orto botanico di Amsterdam, lo affidò a Caspar Commelin perché identificasse le piante e ne redigesse il catalogo. Alla sua morte nel 1717, il codice rimase nelle mani di Commelin, che a sua volta morì nel 1731; il catalogo è andato perduto, mentre il Codice fu ceduto a Johannes Burman dalla vedova del figlio di Commelin. Burman ne trasse 92 delle illustrazioni del suo Rariorum africanarum plantarum Decades; altre furono tratte da altri codici, almeno uno dei quali, Herbarium witsenianum, appartenuto allo stesso Witsen. Quindi il codice passò al figlio Nicolaas Laurens; qualche anno dopo la morte di quest'ultimo, nel 1800, la biblioteca dei Burman venne messa all'asta e il codice fu acquistato da un acquirente ignoto e scomparve. Nel 1829 Johannes Andreas Truter, presidente della corte di Giustizia del Capo e membro della Società letteraria del Sudafrica, donò alla stessa un manoscritto, di cui si ignora come fosse venuto in possesso, oggi conservato presso l'Iziko South African Museum di Cape Town. Certamente era uno dei codici utilizzati da Burman, che ne annotò di sua mano diverse parti, e si ritiene generalmente facesse parte del Codex Witsenii. In tal caso, poiché include appena 59 illustrazioni botaniche, ne costituirebbe solo una parte. Altri disegni di Claudius, non sappiamo se passati per le mani di Witsen, sono conservati in diverse biblioteche sia in Europa sia in Sudafrica. Il manoscritto più consistente si trova all'Africana Museum di Johannesburg: consiste di 433 fogli di disegni, 343 dei quali di piante; 78 sono molto simili alle immagini dell'opera di Burman, di cui potrebbero costituire gli originali. Anche questo volume potrebbe dunque aver fatto parte del Codex Witsenii, ma ne ignoriamo del tutto le vicende.  Un fiore singolare e dolcissimo Insomma, il codice Witsen rimane un enigma. Siamo più informati su un altro lascito botanico del borgomastro; nel 1705, quando era ancora in auge (proprio a quell'anno risale il suo ultimo mandato come sindaco; poi la sua stella politica si eclissò e si ritirò a vita privata, lasciando anche la direzione della VOC), fece recapitare all'Orto botanico di Amsterdam due pianticelle di caffè, provenienti da Batavia. Sistemate in serra e curate amorosamente, prosperarono, produssero frutti e semi. La coltivazione di pianticelle di caffè divenne così una specialità del giardino, che le vendeva a un prezzo variabile tra 17 e 26 guilder. Ad acquistarle erano i ricchi collezionisti, ma soprattutto erano destinate alle piantagioni americane. Qualche anno dopo pianticelle e semi da Amsterdam raggiunsero il Suriname; più tardi dal Suriname qualcuno le portò in Brasile. Nel 1715 il sindaco di Amsterdam (che non era più Witsen) ne inviò in dono diplomatico due pianticelle al re Sole; una fu trapiantata nel parco del castello reale di Marly, l'altra al Jardin des plantes di Parigi. Anch'esse prosperarono. Nel 1720, due pianticelle furono affidate al capitano de Clieu perché le portasse in Martinica; dopo un viaggio rocambolesco, riuscì a farne arrivare a destinazione solo una. La sopravvissuta si ambientò così bene che nell'arco di pochi anni la coltivazione del caffè si era estesa a tutte le Antille francesi e alla Guyana. Nel 1728, il governatore Nicholas Lawes introdusse alcune piante della Martinica in Giamaica. Sono le antenate del pregiato caffè Blue Mountain. Ecco perché all'orto botanico di Amsterdam affermano con orgoglio che tutto il caffè del Nuovo mondo discende dalle due pianticelle donate alle sue serre nel lontano 1705 da Nicolaas Witsen. Anche se probabilmente, da buon olandese d'adozione, anche lui amava il caffè, non fu per questo merito, ma come mecenate della scienza che Carl Peter Thunberg volle celebrarlo; nel dedicargli il genere Witsenia, infatti così scrive: "Gli ho dato questo nome in memoria del signor Witsen, borgomastro di Amsterdam, e sommo patrono e protettore delle scienze in generale". La pianta scelta da Thunberg sarebbe sicuramente piaciuta a Witsen, che amava gli aspetti più curiosi e bizzarri della natura. Questo genere monotipico, il cui unico rappresentante è W. maura: insieme a Nivenia e Klattia è infatti uno dei soli tre arbustivi della famiglia Iridaceae. Fu anche il primo del gruppo ad essere descritto: W. maura fu infatti inizialmente pubblicata da Linneo nel 1771 come Antholyza maura. E' una specie piuttosto rara che vive nelle aree costiere, basse e paludose, della Provincia del Capo occidentale, dalla penisola del Capo meridionale a Caledon. Il suo habitat tipico è il fynbos paludoso; purtroppo è seriamente minacciata dall'urbanizzazione e dalle specie aliene invasive. Inoltre, essendo di difficile coltivazione, è raramente coltivata anche nello stesso Sudafrica. E' un vero e proprio arbusto di ragguardevoli dimensioni; di portamento eretto o disordinatamente ricadente, può raggiungere un'altezza di 3 metri; le lunghe foglie lanceolate, verde-glauco e simili anche nella forma a quelle delle iris, sono raccolte a ventaglio e possono superare 1 metro di lunghezza. I fiori, che si aprono nei mesi invernali, sono molto vistosi: raggruppati in cime di 6-8 e lunghi fino a 85 cm, sono disposti in coppie tenute insieme da tre-cinque brattee e hanno tepali, pubescenti all'esterno, nerastri nella metà inferiore e giallo brillante in quella superiore. Non passano certo inosservati! Un richiamo irresistibile per gli uccelli nettarinidi e per lo zuccheriere del Capo Promerops cafer, che impollinandoli si vedranno premiati dal dolcissimo nettare di questa singolare specie, il cui contenuto di zuccheri varia dall'11 al 13%. Nelle riviste inglesi a cavallo tra Settecento e Ottocento, ci si imbatte continuamente nel nome del ricchissimo mercante George Hibbert che nel suo giardino di Clapham possedeva una collezione di piante rare seconda solo a quella dei Kew Gardens; anzi la prima al mondo per le Proteaceae, le sue piante preferite. Nulla di strano che l'editore di una di quelle riviste, che era anche un pittore ed approfittò largamente di quelle raccolte per i suoi libri, lo abbia ringraziato con la dedica di una delle piante che fioriva nel suo giardino. Il problema è che il grazioso genere Hibbertia onora una persona che, dal punto di vista attuale, non merita di essere onorata: come collezionista e promotore dell'introduzione di nuove piante Hibbert fece molto per la botanica, è innegabile; tuttavia egli non solo doveva la sua ingentissima ricchezza allo schiavismo (in questo sarebbe in larga compagnia, a cominciare dai presidenti americani Washington e Jefferson) ma fu probabilmente il nome più in vista della lobby di mercanti, trafficanti e piantatori che cercò di bloccare l'approvazione della legge che mise fine alla tratta degli schiavi in Inghilterra; e alla fine fu anche profumatamente pagato per averlo fatto. Secondo alcuni botanici, la botanica non può lavarsene le mani; secondo altri, mettere in discussione un nome per ragioni che prescindono le regole botaniche apre un vaso di Pandora che fa crollare i principi cardini del Codice internazionale di nomenclatura. Il dibattito è aperto. 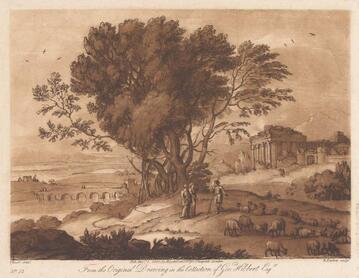 Il volto oscuro: lo schiavista Uno dei nomi che ricorrono con maggiore frequenza nelle pagine di The botanist's repository e del Curtis's botanical magazine nel ventebnnio tra il 1795 e il 1815 è quello di George Hibbert (1757-1837), nel cui giardino di Clapham fiorirono per la prima volta e furono disegnate molte delle novità presentate in quelle riviste. La sua collezione di piante rare provenienti da tutto il mondo rivaleggiava con quella dei Kew Gardens, ed era particolarmente ricca di specie del Capo, dove, come vedremo più avanti, operò per vari anni come cacciatore di piante uno dei suoi giardinieri, James Niven. Hibbert non era un mero collezionista di piante: era considerato un botanico più che dilettante, parlava fluentemente cinque lingue e ne capiva altre due, era un bibliofilo compulsivo e un po' megalomane che non badava a spese per acquisire libri rari, inclusa una copia della Bibbia di Gutenberg. Era membro di molti club e di società scientifiche, inclusa la Royal Society. Nel necrologio pubblicato sulla rivista della Linnean Society, James Main l'ha descritto come una persona che "ispirava fiducia e rispetto per il buon senso, la capacità di giudizio e la sagacia". Eppure questo stimato collezionista e botanofilo non solo doveva tutta la sua ricchezza al lavoro degli schiavi, ma fu anche il leader e il portavoce della lobby di mercanti e piantatori delle Antille britanniche che si oppose con tutte le forze all'abolizione della schiavitù. La famiglia Hibbert era coinvolta da lunga data nel commercio triangolare: il cotonificio del nonno e del padre, due agiati drappieri di Manchester, forniva cotonine e altre forniture ai trafficanti di schiavi; ma il vero salto di qualità si ebbe con lo zio Thomas, che si trasferì in Giamaica per recuperare le obbligazioni di alcuni trafficanti e in vent'anni divenne uno dei più ricchi piantatori dell'isola (possedeva tre estese piantagioni con oltre 900 schiavi); si fece costruire la più bella casa di Kingston, Hibbert House, oggi sede del National Trust della Giamaica. Grazie al successo e ai contatti di Thomas, gli Hibbert rimasti in Inghilterra, da drappieri e fornitori, si trasformarono in mercanti e armatori, specializzati nel commercio con la Giamaica. Nel 1770, un altro Thomas Hibbert, il fratello maggiore di George, si trasferì a Londra e insieme a due altri mercanti, John Purrier e Thomas Horton, fondò la ditta di import-export e trasporti navali Hibbert, Purrier & Horton che importava prodotti coloniali e forniva merci (e prestiti) a piantatori e trafficanti. George si unì alla ditta di famiglia come socio giovane nel 1780 (all'epoca aveva ventitré anni) con un capitale di 1500 £, cui se ne aggiunsero altre 1000 alla morte del padre nel 1784. Meno di dieci anni dopo, era diventato il capo della ditta (ora, con l'ingresso di altri soci si chiamava Hibbert, Fuhr & Hibbert) e un membro eminente della lobby che difendeva gli interessi dei piantatori e dei mercanti delle Indie occidentali, la London Society of West India Planters and Merchants. Nel 1790, nella sua testimonianza davanti alla commissione d'inchiesta sulla tratta degli schiavi, dichiarò di aver importato annualmente merci per un valore compreso tra 200.000 e 250.000 £ e di aver investito molti capitali in Giamaica sotto forma di prestiti ai piantatori. Almeno dal 1793, George Hibbert fu coinvolto in un progetto che stava molto a cuore ai lui e agli altri West Indiamen: la costruzione di una darsena riservata alle loro navi; infine autorizzata nel 1799 dal West India Dock Act, la darsena, collocata sull'Isola dei cani, fu inaugurata nel 1802; l'ingresso principale, posto all'estremità occidentale, presto noto come Hibbert Gate, era largo abbastanza da consentire l'ingresso di carri e vagoni, chiuso da una duplice cancellata di ferro e sormontato da una scultura che riproduceva una delle navi di George e soci, chiamata Hibberts. George Hibbert fu il primo presidente della West India Docks Company e negli anni successivi rivesti ripetutamente questo ruolo. Purtroppo, egli non doveva il suo largo seguito tra i West Indiamen solo alle abilità commerciali (la Hibbert, Fuhr & Hibbert era la prima per giro d'affari con la Giamaica) e alla grinta con cui difendeva i loro interessi: era anche il portavoce degli antiabolizionisti, e seppe muoversi con grande abilità manipolatoria e notevoli capacità dialettiche. Già nel 1790, quando era stato ascoltato dalla commissione parlamentare, aveva evidenziato che l'intera economia delle Antille britanniche - ma anche gran parte dell'industria manifatturiera della stessa Inghilterra - dipendeva dalla schiavitù; se questa fosse stata abolita, si andava incontro alla rovina, e migliaia di famiglie sarebbero state ridotte sul lastrico. Nel maggio 1789, una settimana dopo che Wilberforce ebbe pronunciato in Parlamento il suo celebre discorso abolizionista, i mercanti convocarono una riunione alla London City Tavern; Hibbert vi intervenne con un discorso di 40 minuti intitolato "L'indispensabilità della tratta degli schiavi" in cui cercò di demolire tutti gli argomenti di Wilberforce. L'anno dopo fu di nuovo ascoltato in Parlamento: per lui non era una questione morale, ma economica; la posizione degli abolizionisti era astratta (oggi si direbbe buonista o radical chic), andava contro i diritti e i privilegi acquisiti fin dai tempi di Elisabetta I, quindi la Common Law e il diritto consuetudinario; la schiavitù per altro non era neppure condannata dalla Bibbia, dove gli uomini erano considerati merci come tutte le altre. Proprio per difendere gli interessi dei West Indiamen (ovvero i suoi e dei suoi compari) si gettò anche in politica; già consigliere (alderman) della città di Londra dal 1798, nel 1802 si presentò come deputato per la City, ma non fu eletto; ebbe successo invece nel 1806, quando fu eletto senza opposizione nel collegio di Seaford (uno dei "borghi putridi" controllato dalla lobby dei mercanti delle Indie occidentali); nel suo primo discorso, nel febbraio 1807, dichiarò la sua assoluta ostilità all'abolizione della tratta e durante la discussione che avrebbe portato all'approvazione dello Slave Trade Act, intervenne in ogni passaggio cercando di bloccare la legge. Non ci riuscì, ma ottenne probabilmente ciò a cui mirava fin dall'inizio: l'approvazione di una mozione che garantiva il risarcimento ai piantatori e ai mercanti che traevano le loro ricchezze dalla schiavitù. La compensazione costò alla stato 20 milioni di sterline; Nick Hibbert Steel nel suo saggio sulla famiglia Hibbert l'ha chiamato il "prezzo dello zucchero". E' stato calcolato che agli Hibbert ne andarono 103.000 e allo stesso George Hibbert 16.000. Nel 1812 Hibbert fu nominato agente generale per la Giamaica, una posizione che mantenne fino al 1831, anche se già nel 1829 si ritirò a vita privata; nel 1824, aveva anche avuto modo di illustrarsi e come filantropo, in quanto membro fondatore e finanziatore di una società di soccorso navale, National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, precorritrice della Royal National Lifeboat Institution che ancora oggi nel proprio sito lo ricorda come benemerito fondatore.  Il volto luminoso: il collezionista Negli stessi anni in cui si metteva in luce in questo modo ai nostri occhi abominevole (ma non a quello di molti suoi contemporanei: nel 1812, quando si ritirò dal Parlamento, il leader dei whigs George Tierney lo nominò tra coloro "i cui servizi sarebbero stati rimpianti dalla nazione"), George Hibbert acquisiva grande rinomanza come collezionista di libri e proprietario di uno dei giardini più raffinati del paese. Come sostiene Katie Donington nel suo importante saggio dedicato alla famiglia Hibbert, The Bonds of Family, tra le due cose non c'è alcuna contraddizione: nel momento in cui una parte crescente dell'opinione pubblica incominciava a prendere le distanze dallo schiavismo, su cui si basava la sua ricchezza, il collezionismo era un modo per rendersi socialmente accettabile. Infatti Hibbert divenne un membro riconosciuto della comunità scientifica: nel 1805 lo troviamo tra i fondatori della London Institution, che anticipò l'Università di Londra nel rendere disponibile l'educazione scientifica ai dissidenti religiosi, esclusi dai college di Oxford e Cambridge; già membro della Linnean Society e della Antiquarian Society, nel 1811 fu ammesso alla Royal Society; nel 1816 entrò a far parte del Roxburghe Club, la più antica società di bibliofili del mondo. Non conosciamo con esattezza quando Hibbert abbia cominciato a collezionare libri e piante; nel 1829, quando si ritirò a vita privata e si trasferì a Munden House, una proprietà che la moglie aveva ereditato da uno zio, fu costretto a vendere la biblioteca; secondo il catalogo d'asta, di ben 8711 pezzi, non pochi dei quali rarissimi, la collezione era stata riunita dal proprietario in più di quarant'anni (dunque a partire dalla fine degli anni '80). Per quanto riguarda le piante, la prima data certa è il 1794: quell'anno Hibbert, che già possedeva una residenza a Portland Place, nel distretto di Marylebone, acquistò una casa e una proprietà chiamata The Hollies sul lato nord di Clapham (curiosamente, il distretto noto per essere stato la sede del movimento abolizionista noto come Clapham Sect o Clapham Saints). Allo stesso anno ci riporta il suo primo acquisto datato: alla fine del 1792 un altro ricco mercante e armatore, Gilbert Slater, legato alla Compagnia delle Indie, proprietario di un notevole giardino in Essex, inviò in Cina a caccia di piante il giardiniere scozzese James Main che fece buona caccia, riportando tra l'altro la famosa rosa Slaters' Crimson China; al suo ritorno nel 1794 però Slaters era deceduto da quasi un anno; le raccolte cinesi furono vendute e acquistate in parte dai Kew Gardens, in parte da Hibbert, che assunse Main come giardiniere (è dunque inesatta la notizia che si legge in Wikipedia inglese che già lavorasse per Hibbert in precedenza e che avesse viaggiato in Cina per conto sia di Hibbert sia di Slaters). Hibbert acquistò piante e semi, ma anche disegni cinesi: è dunque possibile che la passione per le piante sia nata indirettamente da quella per i libri e le opere d'arte. In ogni caso la vera passione di Hibbert divennero le Protee, forse perché erano rare, difficili da coltivare, dunque molto prestigiose. I semi delle prime erano state portate in Inghilterra da Masson tra il 1774 e il 1787; nel 1789 d verse specie furono descritte da Aiton in Hortus kewensis, il catalogo dei giardini reali di Kew che ne possedevano un'esclusiva collezione di 24 specie, diverse delle quali oggi assegnate ad altri generi della famiglia. Hibbert non voleva essere da meno e alla fine del 1798 o all'inizio del 1799 inviò in Sudafrica il giardiniere James Niven a fare raccolte di semi ed esemplari d'erbario; Niven rimase al Capo fino al 1803, quindi vi ritornò nel 1805, questa volta per un consorzio che oltre a Hibbert comprendeva il vivaio Lee e Kennedy (di cui secondo N. H. Steel Hibbert era "socio silente") e l'imperatrice Giuseppina, e vi rimase fino al 1812. Grazie alle sue raccolte, cui sia aggiunsero anche molte australiane, la collezione di Proteaceae di Hibbert divenne la più importante del mondo. Secondo le testimonianze del tempo, ne comprendeva circa 200 diverse specie che erano coltivate in vaso in una grande serra, dove trascorrevano i mesi invernali, per essere portate all'esterno nei mesi più caldi. Hibbert le affidò a un abilissimo giardiniere, Joseph Knight (1778-1855), che in precedenza aveva lavorato per il duca di Bedford; egli fu il primo in Europa a moltiplicarle tanto da talea quanto da seme. Hibbert (al contrario generoso con altre piante) era gelosissimo delle sue protee che scambiava solo con re Giorgio III e l'imperatrice Giuseppina. Nel 1809 Knight svelò i segreti della coltivazione delle preziose piante in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, a dispetto del titolo, riserva solo una dozzina di pagine all'argomento, mentre più di 100 sono dedicate a una revisione tassonomica della famiglia; benché non firmata, fu subito noto che l'autore di quest'ultima era Richard Salisbury. Ne seguì una polemica con Robert Brown e l'accusa di plagio rivolta a Salisbury, come ha raccontato in questo post. Qui ci interessa la prima parte, che documenta le tecniche di coltivazione applicate nel giardino e nella serra di Hibbert; inoltre ci rivela un altro aspetto del contraddittorio personaggio: la generosità. Dopo aver accennato alle raccolte di Thunberg e Masson, Knight infatti scrive "Un numero ancora più grande di specie sia note sia ignote sono poi state raccolte da Mr. James Niven, molte delle quali hanno fiorito a lungo in questo paese, ma da nessuna parte in modo così lussureggiante come nella collezione del mio precedente padrone, l'egregio George Hibbert di Clapham, grazie alla cui liberalità molte di esse sono ora in mio possesso". Dunque Hibbert cedette almeno alcune delle sue esclusivissime Proteaceae al suo capo giardiniere e probabilmente lo aiutò a mettersi in proprio; infatti nel 1808 Knight acquistò un terreno a Chelsea e lo trasformò in vivaio; poiché era affacciato sulla trafficata King Road, presto vi aggiunse un negozio (un antenato di un fornito garden center); inoltre nel 1829, quando si ritirò per andare a vivere in campagna, Hibbert passò a Knight tutte le sue piante vive. Con questa formidabile iniezione di rarità, il vivaio di Knight (più tardi Knight & Perry, quando venne gestito dal marito di una nipote del fondatore) divenne uno dei più importanti del paese, nonché il primo a commercializzare le Proteaceae. Ma nel giardino e nella serra di Clapham si coltivava anche molto altro; per scoprirlo basta sfogliare i fascioli di The Gardener's Repository o del Curtis's Botanical Magazine, dove il nome di Hibbert ricorre con grande frequenza; molte delle novità presentate in queste riviste fiorirono e furono ritratte per la prima volta a Clapham. A dominare sono ovviamente le sudafricane, grazie alle raccolte di Niven; ci sono molte bulbose e una ricca selezione di eriche, diverse delle quali sono presentate in Coloured Engravings of Heaths, l'opera più significativa di Henry Cranke Andrews, il genero di John Kennedy, nonché illustratore e editore di The Botanist's Repository; significativamente "G. Hibbert, Esq., Clapham Common, Surrey" è citato per primo nella lista delle sette persone ringraziate per aver permesso all'artista di ritrarre dal vivo le loro collezioni.  Questa pianta profumerebbe di più con un altro nome? Se le sudafricane dominavano, a Clapham c'erano però anche molte australiane; in effetti, anche se commerciava soprattutto con la Giamaica, Hibbert aveva qualche interesse anche nelle nuove rotte del Pacifico aperte dai viaggi di Cook; come armatore fu sicuramente coinvolto in alcuni dei trasporti interoceanici di piante organizzati da Banks (incluso quello degli alberi del pane, fortemente voluto dei piantatori delle Antille) e nel trasporto dei forzati a Botany Bay. Australiano è anche il genere Hibbertia, che gli fu dedicato da Andrews nel secondo numero di The botanist's repository. La motivazione ci dà un quadro illuminante (e magari un po' adulatorio) della reputazione botanica di Hibbert: "In precedenza è stato erroneamente assegnato al genere Dillenia, ma poiché differisce da ogni genere descritto in precedenza, gli ho dato il nome dell'egregio sig. G. Hibbert di Clapham, Surrey, la cui conoscenza e fervore per le ricerche botaniche, così come la sua liberalità nell'arricchire le nostre collezioni da tutti gli angoli del mondo, ma soprattutto dal Capo di Buona Speranza, non sono superate da nessuno; ne sono certo, nessun nome merita un posto nella memoria della botanica più di quello di Hibbert". E lo stesso Andrews (la cosa non stupisce) dedicò a Hibbert anche un'Erica, appunta E. hibbertia. Hibbertia è un grande genere della famiglia Dilleniaceae, anche se il numero di specie è altamente dibattutoi: si va dalle 150 generalmente assegnatogli nei data base australiani alle 350 riconosciute da Plants of the World on line; il centro di diversità è proprio l'Australia, con oltre 100 specie; altre vivono in Nuova Guinea e nelle isole del Pacifico, una in Madagascar. In inglese sono note sotto il nome comune guinea flower, non per la provenienza ma perché il colore e la forma dei loro fiori ricorderebbero quelli di una ghinea d'oro. La cifra del genere è la varietà. Sono per lo più arbusti eretti, ma c'è anche qualche rampicante, come la specie più nota, H. scandens, o arbusti prostrati che formano tappeti, come H. procumbens. Molto variabili le dimensioni: se molti sono piccoli arbusti non più alti di una decina di centimetri, la già citata H. scandens può superare i 5 metri. Le foglie sono intere, alternate, spesso raggruppate lungo brevi rami laterali, e nelle specie che vivono in zone aride sono ridotte; molto variabili le forme. Ancora più variabile la morfologia dei fiori; possono essere o meno protetti da brattee, hanno cinque sepali, quelli esterni leggermente sovrapposti a quelli interni, e cinque petali che possono essere disposti a simmetria radiale o a simmetria bilaterale; variabile pure il numero degli stami, da sei a oltre trenta, in genere raggruppati in gruppi di due o tre, in modo simmetrico o anche da un solo lato dei carpelli. La grande maggioranza delle specie ha fiori giallo vivo, ma in alcune specie i petali come H. stellaris o H. minita sono arancione. Sono indubbiamente piante graziosissime, di grande valore ornamentali, spesso anche profumate. E' giusto che portino il nome di un personaggio le cui idee "erano considerate abominevoli da molti critici già al suo tempo"? Il botanico australiano Kevin Thiele - che per inciso è un esperto di questo genere, una componente importante di molte comunità vegetali del suo paese - pensa di no, tanto più che questo grande genere continua ad essere arricchito da nuove scoperte e nuove denominazioni; e continua: "Proprio come si eliminano statue, nomi di edifici, strade e sobborghi, pensiamo che sia necessario fare i conti con i nomi di specie scientifiche che onorano persone che professavano idee o hanno agito in modi profondamente disonorevoli, altamente problematici o ripugnanti per gli standard moderni". La sua denuncia è stata ripresa da altri autori ed è sfociata nella proposta di modificare l'articolo 51 del Codice internazionale di nomenclatura, in modo che divenga possibile rigettare i nomi formalmente validi che riflettono "il potere coloniale e imperialista" o sono da ritenersi "culturalmente offensivi o inappropriati", compresi quelli che onorano "una persona che la comunità tassonomica ritiene concordemente non debba essere onorata". La proposta è sconvolgente perché mette in discussione i principi stessi su cui si fonda il Codice internazionale di nomenclatura: la stabilità della nomenclatura, la libertà scientifica e la neutralità politica della scienza. Più ancora dell'articolo 51, che recita "un nome legittimo non può essere rigettato solo perché esso, o il suo epiteto, è inappropriato o sgradevole", a traballare è lo stesso primo preambolo, dove si legge: "Lo scopo di questo Codice è fornire un metodo stabile per nominare i gruppi tassonomici, evitando o respingendo l'uso di nomi che possono causare errore o ambiguità o mettere la scienza in confusione. Ogni altra considerazione, come la correttezza grammaticale, la regolarità e l'eufonia dei nomi, le consuetudini più o meno prevalenti, il riguardo per le persone, nonostante la loro innegabile importanza, è relativamente accessoria". Alle considerazioni di Thiele e altri (potete leggere una delle più recenti versioni qui) ha risposto il botanico ucraino Sergei L. Mosyakin (il suo punto di vista qui), che le ha respinte con un'articolata argomentazione. Il dibattito è aperto, e forse avrà nuovi sviluppi in occasione del XX congresso botanico internazionale, che si terrà a Madrid tra il 21 e il 29 luglio 2024. Da parte mia considero queste piante deliziose non dedicate al discutibile Mr. Hibbert, ma a tutte le persone le cui sofferenze furono prolungate per causa sua. I due più antichi orti botanici della Lombardia nascono quasi contemporaneamente, nell'ultimo quarto del Settecento, nell'ambito delle grandi riforme teresiane che ebbero tra gli obiettivi anche lo svecchiamento dell'istruzione con una maggiore attenzione alla scienza. Erano infatti strettamente legati a due istituzioni didattiche: l'Università di Pavia e le scuole palatine di Brera. Anche se il personaggio è enigmatico e le decisioni in definitiva venivano prese a Vienna, nella loro nascita e primo sviluppo ebbe un qualche ruolo il conte Firmian, plenipotenziario per la Lombardia austriaca. Un merito che gli venne riconosciuto da Marsili con la dedica del notevole genere Firmiana (Malvaceae). 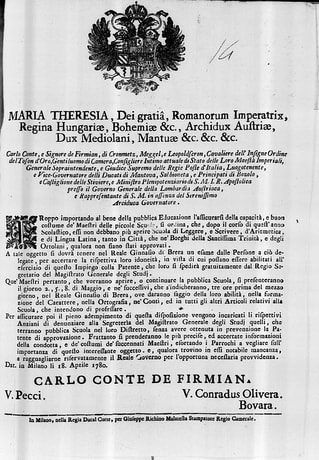 Mecenate delle arti e della scienza Intorno al 1760, all'abate Filippo Antonio Farsetti, proprietario del celebre giardino di Sala nel Padovano, giunsero "mandate non so da chi né da qual paese" sementi contrassegnate con la vaghissima etichetta Arbor excelsa ex China ("albero di grande altezza della Cina"). Seminate dall'abile giardiniere Francesco Pomai, produssero molte pianticelle che furono poi trapiantate tanto in serra quanto all'aperto; una, che "aveva perduto la cima e si era lateralmente divaricata in tre rami" fu donata da Sala a Giovanni Marsili, prefetto dell'Orto dei semplici di Padova. Allevata "diligentemente" e protetta d'inverno nella serra fredda, trapiantata in vasi via via più grandi, prosperò e "fu sì grata e cortese che in pochi anni volle a me dare il geniale e desiderato spettacolo de' primi suoi fiori coi primi suoi frutti condotti a perfetta maturità". Così Marsili racconta la prima fioritura in Europa della spettacolare Firmiana simplex, avvenuta nell'orto botanico padovano nel 1775. Diversi degli altri esemplari di Sala giunsero anch'essi a fioritura, ma solo qualche tempo dopo. La pianta, seppure sotto altri nomi, non era una novità assoluta. Sloane l'aveva vista in fioritura, ma in Giamaica (la pubblicò come Malva arborea), mentre Linneo, che ne possedeva un esemplare dal fusto non ramificato (per questo lo chiamò Hibiscus simplex) non lo aveva mai visto fiorire. Dunque Marsili fu il primo a poterne studiare fiori e frutti, capendo che andava assegnata a un genere proprio. Era un albero senz'altro di grande bellezza, dunque perfetto da dedicare a un potente. Marsili scelse il conte Carlo Firmian, ministro plenipotenziario della Lombardia austriaca, morto pochi anni prima, che poteva vantare qualche merito come mecenate della botanica: "E' a lui dovuto dai Botanici tributo di particolare riconoscenza per la recente fondazione del Regio Giardino di Pavia, portato in breve spazio d' anni, mercé le provide di Lui cure, la Sovrana munificenza, e la perizia, vigilanza e dottrina de' valenti suoi Presidi e Direttori, a tal grado di floridezza e di celebrità , che già gareggia co' più rinomati d'Europa". Come altre piante portano i nomi di Begon, Bignon, Eugenio di Savoia, Carlo di Braunschweig (dedicatario di Brunsvingia) o il patrizio veneto Morosini (dedicatario di Maurocenia), "la cui memoria anima l'industria, risveglia all' azione gl' ingegni e rincuora l' umanità - concludeva - passi a' posteri al pari d'esse nobilitato e fastoso con quello di FIRMIANA". Il conte Carlo Giuseppe Gottardo (Karl Joseph Gotthard) von Firmian (1716-1782) fu ministro plenipotenziario della Lombardia per 23 anni, dal 1758 alla morte. Gli storici sono divisi sul suo ruolo nella grande stagione delle riforme austriache in Lombardia: si va da chi vede in lui "il can da guardia dell'assolutismo" o almeno un mero esecutore, per altro indolente, delle direttive di Vienna, a chi al contrario ne sottolinea il ruolo propulsivo, soprattutto per quanto riguarda le riforme ecclesiastiche e l'applicazione delle dottrine giurisdizionaliste. Cadetto di una famiglia della nobiltà trentina che da secoli forniva funzionari tanto al principe vescovo di Trento quanto agli Asburgo e che nel Settecento ebbe un momento di gloria grazie all'arcivescovo di Salisburgo Leopold Anton Eleutherius von Firmian, zio del nostro, ebbe una formazione cosmopolita prima in Baviera e in Austria, poi nei Paesi Bassi dove studiò giurisprudenza, quindi a Parigi, dove frequentò gli ambienti giansenisti; un lungo viaggio di formazione lo portò in Italia, prima a Firenze poi a Roma, dove entrò in contatto con vari circoli intellettuali e iniziò a coltivare interessi filologici e antiquari. Tornato a Vienna, fu ammesso al Consiglio aulico; piuttosto attivo e impegnato nel suo ruolo, riunì attorno a sé una piccola accademia privata, in cui si discutevano e diffondevano le idee di Muratori, Genovesi, Montesquieu. Dal 1752 al 1758 fu ministro plenipotenziario, ovvero ambasciatore, a Napoli, quindi fu trasferito a Milano. In Lombardia la sua stella brillò soprattutto nel decennio 1760-1771: il suo stesso carattere indolente corrispondeva al prudente riformismo teresiano; spiacque invece a Giuseppe II, fin da quando visitò Milano nel 1769: lo giudicava titubante e inadeguato, così come riteneva datate e superate le sue idee. Per rispetto alla madre, che invece aveva grande stima del vecchio funzionario, lo mantenne al suo posto, ma lo affiancò con uno dei suoi fratelli, l'arciduca Ferdinando, nominato governatore di Milano nel 1771; dal 1778, fu costretto a coabitare con il suo successore designato, il conte Wilczek. Per altro, i suoi ultimi anni furono di estremo decadimento anche fisico. Al di là della difficoltà di separare quanto nelle sue azioni politiche si deve a lui e quanto alle direttive di Vienna, anche gli estimatori di Firmian ammettono che la sua presenza fu più incisiva come mecenate che come politico. Amava circondarsi di artisti e intellettuali; alla sua morte (oltre a una montagna di debiti) lasciò una collezione di quadri e di stampe e una biblioteca di oltre 40.000 volumi. Cesare Beccaria gli dedicò Dei delitti e delle pene, e sempre ne ebbe stima, al contrario di Pietro Verri che ne lasciò un giudizio impietoso sul piano tanto fisico (oggi si parlerebbe di body shaming) quanto morale. Talvolta suggerite da lui, talaltra da Vienna, troviamo lo zampino di Firmian in diverse iniziative collegate alla riforma scolastica, già iniziata in Austria intorno al 1757 e estesa alla Lombardia a partire dal 1765; sia pure con molte lentezze e contraddizioni, si ebbe un deciso avanzamento dell'accesso all'istruzione dei ceti popolari e uno svecchiamento dei metodi e dei contenuti didattici, con una forte valorizzazione delle materie scientifiche. In un suo memoriale del 1765, Firmian la collocò al primo posti tra le riforme più urgenti a necessarie. A giovarsi del vento di riforma fu in primo luogo l'Università di Pavia. Nel 1769, per interessamento di Firmian, ad insegnare scienze naturali venne chiamato Lazzaro Spallanzani; nel 1771, con l'arrivo da Vienna di sette casse di minerali e altri materiali naturalistici, che avrebbero permesso al professore "di dimostrare colla loro spiegazione le varie vie che tiene la Natura nel suo operare", prendeva avvio il Museo di Scienze naturali. Erano i primi atti del rilancio dell'ateneo patavino, a insegnare nel quale nel giro di pochi anni sarebbero stati chiamati altri scienziati di risonanza europea: il botanico Giovanni Antonio Scopoli, l'anatomista Antonio Scarpa, il fisico Alessandro Volta, che sarebbe diventato anche rettore. Nel 1772 fu aperta al pubblico la Biblioteca universitaria, dal 1779 ospitata dallo splendido Salone teresiano, e nel 1773 fu fondato l'orto botanico, la cui sede fu individuata dallo stesso Firmian nell'area della chiesa di S. Epifanio e del convento dei Canonici Lateranensi. La creazione di strutture scientifiche riguardò anche Milano. Nel 1773, il barnabita Ermenegildo Pini fu incaricato di creare un Museo di storia naturale presso le scuole Arcimboldi. Forse l'iniziativa fu presa a Vienna, ma certo fu Firmian a suggerire la trasformazione del complesso di Brera in una vera e propria cittadella della cultura. Il Palazzo di Brera era stato costruito nella seconda metà del Cinquecento per ospitare il Collegio della Compagnia di Gesù; intorno al 1760 vi venne realizzato un osservatorio astronomico, diretto da padri gesuiti che erano anche rinomati astronomi. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia, il palazzo e le aree adiacenti divennero di proprietà dello stato, che veniva così a disporre in pieno centro di un luogo ideale per riunirvi tutte le istituzioni culturali che la città aspettava da tempo. Firmian ne fu entusiasta e così scrisse a Kaunitz: "Brera dovrebbe servire per il Ginnasio ed Istituto di scienze di questa città di Milano[…] Si dovrebbero riunire in Brera le scuole Palatine, l’Aula per le dimostrazioni di Fisica sperimentale, la Camera ottica, il Laboratorio per la fusione dei metalli, il Museo delle antichità sacre e civili ed il Museo di storia naturale […] Al detto Istituto di Scienze si potrà trasportare la Biblioteca Pertusati, e formare una sala con quella di Brera […] Resterà in Brera la Specola e l’abate Lagrange […] In Brera vi sono poi le scuole inferiori […] Finalmente si potrebbe formare in Brera l’Accademia delle Arti e delle Scienze combinandola con tutti”. Il progetto trovò quasi completa attuazione negli anni successivi: già a partire dal 1774 vennero trasferite a Brera le scuole palatine, destinate all'istruzione superiore; nel 1776 venne aperta l'Accademia di Belle Arti; nel 1786, la Biblioteca Braidense, che oltre ad accogliere le biblioteche degli stessi gesuiti e quella del conte Pertusati, acquistata nel 1763 dalla Congregazione dello Stato di Milano, ricca di oltre 24.000 volumi, si divise con Pavia quella del celebre scienziato elvetico Albrecht von Haller, acquisita nel 1778 da Giuseppe II insieme al suo importantissimo erbario. Dei lavori di riallestimento del palazzo fu incaricato l'architetto Piermarini, che, oltre a predisporre le aule e ridisegnare la biblioteca, elevò nuove torri per l'osservatorio astronomico e fu coinvolto nella progettazione dell'orto botanico. Quest'ultimo fu sistemato in un terreno adiacente al lato meridionale del palazzo, che già al tempo dei Gesuiti ospitava un boschetto e un giardino, allo stesso tempo luogo di passeggio e meditazione e orto per le necessità di cucina. Al contrario di quello di Pavia, concepito come un grande orto botanico chiamato, oltre che a servire le esigenze didattiche della cattedra di chimica e botanica, a dare lustro all'Università con collezioni ricche di piante esotiche, Firmian pensava a un piccolo orto dei semplici didattico, dove coltivare le piante da utilizzare durante le lezioni pratiche (dimostrazioni) impartite agli studenti di botanica delle scuole palatine; sempre su sua proposta, nel 1774 la cattedra fu assegnata all'abate villambrosiano Fulgenzio Vitman (o Withman), che era stato il primo prefetto del giardino di Pavia. Secondo le intenzioni iniziali di Firmian, egli avrebbe dovuto provvedere anche al riadattamento del vecchio giardino dei gesuiti che, si illudeva, sarebbe avvenuto "senza spese alcuna"; per rifornirlo delle piante necessarie alle lezioni da avviare nella primavera successiva egli riteneva sufficienti due viaggi che Vitman compì tra l'estate e l'autunno del 1774, uno negli Appennini fino a Villombrosa, l'altro all'orto botanico di Torino. La realizzazione di un vero orto botanico e la coltivazione di piante esotiche dovevano aspettare tempi futuri. Vitman giunse a Milano all'inizio del 1775 e si recò ad ispezionare il giardino insieme a Piermarini, tecnici ed amministratori, scoprendo che erano necessarie opere ben più impegnative e costose; venne predisposto un progetto, che includeva anche una serra disegnata da Piermarini. Il governo approvò, ma lesinò il denaro, con la conseguenza che la serra non fu mai costruita. Vitman, tra mille difficoltà, riuscì comunque ad accrescere le collezioni, grazie a contatti con altri orti botanici, tanto in Italia quando all'estero: in primo luogo quello di Torino, ma anche Firenze e Parma, Vienna, Zurigo, Parigi e Madrid, tanto che nel 1778 il poligrafo Carlo Amoretti poté scrivere che il professore di botanica "ha un giardino sufficientemente ben fornito per le sue dimostrazioni". Un pochino lo aiutò anche Firmian che nel 1782 scrisse a Londra e a Zurigo per ordinare semi di alberi esotici per il boschetto.  Le grandi foglie dell'albero parasole Insomma, sono ben due gli orti botanici che, più o meno direttamente, devono la loro nascita e il primo sviluppo a Firmian. Dunque, d'accordo con Marsili, possiamo concludere che si sia meritata la fastosa dedica di Firmiana. Il genere, appartenente alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), comprende circa 18 specie di alberi o più raramente arbusti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e il Pacifico, con centro di diversità in Cina. Decidui, sono caratterizzati da grandi foglie palmate e da fiori unisessuali riuniti in grandi infiorescenze panicolate o più raramente racemose; la stessa pianta porta sia fiori staminati sia fiori pistillati; uno dei tipo prevale, con pochi fiori dell'altro tipo. Per favorire l'impollinazione incrociata, i fiori maschili tendono ad aprirsi prima di quelli femminili. I frutti sono follicoli con endocarpo membranoso che rimangono a lungo sulla pianta prima di aprirsi. La specie più nota e coltivata è senza dubbio F. simplex, anche nota come parasole cinese. Di medie dimensioni (10-15 metri), si fa notare soprattutto per le grandissime foglie lobate dal diametro fino a 30 cm; a maturità ha una chioma arrotondata che offre una densa ombra. Di crescita rapida, è relativamente rustica, ma per fiorire ha bisogno di sole e di un'estate calda; i fiori giallo-verdastri, raccolti in appariscenti pannocchie pendule, sono seguiti da frutti piuttosto decorativi, a volte usati in composizioni di fiori e frutti secchi. Non invasiva alle nostre latitudini, lo è invece negli Stati Uniti meridionali, dove è stata introdotta come albero da legname a crescita rapida. In Cina era tradizionalmente piantata nei giardini di letterati e poeti, di cui è dunque diventata emblema. In Cina e Corea corteccia, foglie e semi hanno diversi usi medicinali. Ad attirare gli sguardi su F. colorata sono invece i fiori, campanelle pendule ricoperte di una soffice peluria rosso-aranciata, tanto più che la fioritura si produce quando l'albero è ancora spoglio. Piuttosto comune nelle foreste umide dei Ghati occidentali e del Deccan, è presente anche nello Yunnan meridionale e in Indocina. Ha anch'essa belle foglie palmate e, poiché il fusto tende ad ingrossarsi alla base, è talvolta commercializzata come caudiciforme da vaso. Nella primavera del 1788, il botanico francese André Michaux e suo figlio François André visitano la Florida occidentale dove sono accolti con squisita cortesia dal governatore Vicente Manuel de Céspedes. Memore di quell'accoglienza, qualche anno dopo Michaux gli dedica uno dei suoi nuovi generi americani, ma un errore di lettura o una svista del tipografo trasformano il buon governatore in Lespedez e il genere in Lespedeza. 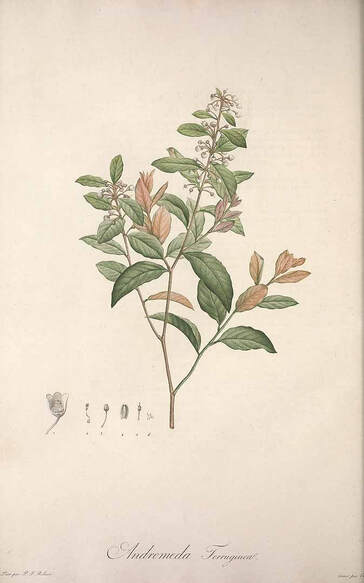 Un memorabile viaggio in Florida Inviato negli Stati Uniti come botanico reale alla ricerca di piante utili per ripopolare le foreste francesi, André Michaux era invece intenzionato ad andare oltre questo mandato: voleva scrivere una flora del Nord America, e per questo desiderava visitare tutte le zone accessibili, incluse la Florida spagnola e le Bahamas, nonostante la loro flora tropicale o subtropicale poco si adattasse all'introduzione in terra francese. Già nel 1787 aveva comunicato al Conte d'Angevilliers, direttore generale dei Bâtiments du Roi (da cui dipendeva la sua missione) la sua intenzione di visitare la Georgia e la Florida. Tensioni di frontiera bloccarono per qualche mese il progetto, finché alla fine del febbraio 1788, accompagnato dal figlio François André e da un servitore, egli salpò da Charleston alla volta di St. Augustine, la capitale della Florida occidentale. Agli ufficiali di porto dichiarò di essere stato autorizzato a studiare la storia naturale della provincia dal governatore, Vicente Manuel de Céspedes (o Zéspedes), al quale evidentemente aveva scritto, anche se il carteggio non ci è pervenuto. Condotto alla presenza del governatore, fu ricevuto con grande calore e cortesia. Solo qualche giorno dopo scrisse nuovamente a d'Angevilliers per ottenere il permesso ufficiale di fare raccolte botaniche in Florida. Di fatto, si era già messo al lavoro. Oltre a esplorare i dintorni della città, dove scoprì una nuova specie di Ericacea, Lyonia ferruginea, si era procurato un terreno dove creare un vivaio temporaneo e aveva affittato una canoa e due rematori. Il 12 marzo partì alla volta dell'Anastasia Island, dove fu ospite del mercante Jesse Fish che nella sua residenza, chiamata El Verge, aveva creato un giardino ricco di olivi, palme da dattero, limoni e aranci; Michaux nelle sue memorie lo definisce un paradiso. Era la prima tappa di un viaggio, parte in canoa, parte a piedi, parte a cavallo, che li portò in direzione sud, sempre erborizzando, ad esplorare la costa orientale della Florida lungo il Northwest River e l'Indian River fino all'altezza dell'attuale Bonaventure, dove giunsero all'inizio di aprile; oltre non era possibile andare, essendo ormai penetrati in territorio indiano. Durante il viaggio di ritorno affittarono dei cavalli per riportare le raccolte a St. Augustine e osservarono un incendio: sia gli indiani sia gli europei usavano applicare incendi per facilitare la caccia o per liberare terreni per il bestiame, una pratica altamente disapprovata da Michaux. Rientrato a St. Augustine il 17 aprile, Michaux fece subito visita al governatore, che nei giorni successivi volle visitare di persona le collezioni e invitò il botanico a pranzo. Quest'ultimo era impegnato a riordinare le raccolte (stando al suo diario, fino a quel momento ammontavano a 105 specie), a scrivere lettere in Francia e ai rappresentanti diplomatici francesi, anche per battere cassa, e a preparare la prossima escursione. Il 29 aprile era infatti di nuovo in partenza con gli stessi compagni, questa volta a cavallo, alla volta della residenza di Job Wiggins, che aveva accompagnato William Barton nella spedizione del 1774. Situata sulla riva orientale del St. Johns River, era un buon punto di partenza per esplorare il bacino del fiume, il maggiore della colonia; nei dintorni, Michaux trovò una nuova specie di graminacea, Stenopholis obtusata. Da quel momento il viaggio proseguì in canoa, toccando Mount Royal, una collina sabbiosa visitata e così denominata da John Bartram nel 1765, e Drayton Island sul lago George; quindi continuò lungo il St Johns River e nella strettoia oggi chiamata Salt Springs Run fino alla sorgente dove Michaux raccolse Illicium parviflorum, già osservato nei lori viaggi dai due Bartram ma ancora non descritto. Quindi il gruppo esplorò Silver Gleb Spring e proseguì fino alla confluenza tra il lago George e il St. Johns River, quindi lungo il fiume dove dopo qualche giorno si imbatté in correnti contrarie e grandi masse di alligatori; giunto all'altezza dell'attuale High Bank, avendo trovato poche specie nuove, Michaux decise di rientrare a St. Augustine. Il viaggio volgeva al termine. Dopo un'ulteriore visita al governatore e ad alcune famiglie influenti, i Michaux si imbarcarono con loro raccolte alla volta di Charleston; qui le talee prese in Florida furono trapiantate nel vivaio, mentre i semi di molte piante venivano spediti in Francia; tra le altre, Guilandina bonduc, Sophora tomentosa, Chiococca alba, Ceanothus microphyllus, Conocarpus erectus, Psychoria nervosa, Amyris eleifera, Zamia integrifolia, Tillandsia utriculata, Modiola caroliniana.  Ripopolare la Florida E' ora di sapere qualcosa di più dell'ospitale governatore Vicente Manuel de Céspedes (1721?-1794); appartenente a una famiglia di militari e militare egli stesso, prima di arrivare in Florida per circa un anno era stato governatore facente funzione a Santiago de Cuba; nel 1783 fu nominato primo governatore della Florida orientale che, dopo vent'anni di occupazione britannica, tornava sotto sovranità spagnola in forza del trattato di Parigi. Céspedes si trovò così a gestire una difficile transizione. Il problema principale era quello del popolamento. La popolazione era molto mista: c'erano spagnoli provenienti dalla madre patria, cubani, minorchini (Minorca nel Settecento era passata più volte dalla sovranità spagnola a quella britannica e viceversa, e molti erano di lingua inglese), francesi, italiani, greci, britannici che durante l'occupazione inglese erano subentrati agli spagnoli che avevano preferito lasciare la colonia. Il timore era che con il tempo gli anglofoni potessero prendere il sopravvento o che gli Stati Uniti decidessero di invadere il paese; venne così fissato l'obiettivo di aumentare la popolazione, fino a eguagliare nell'arco di 25 anni quella della Georgia. La corona fissò regole molto stringenti per i nuovi immigrati, la principale delle quali era che dovevano essere di religione cattolica; anche gli stranieri erano ben accetti, purché fossero appunto cattolici e imparassero la lingua spagnola. Céspedes, da parte sua, cercò di favorire i nuovi arrivi, garantendo dieci anni di esenzione dalle tasse, terre, aiuti come bestiame, sementi, attrezzi. Buona parte del territorio era disabitato, e le terre non mancavano, ma la questione del ripopolamento si incrociava con quella delle proprietà. Alcune, i cui proprietari ispanici avevano preferito lasciare la Florida, erano rimaste vacanti al momento dell'occupazione inglese, altre erano state abbandonate dagli inglesi al ritorno degli spagnoli. Céspedes propose che tutte le proprietà vacanti e non rivendicate entro una certa data fossero confiscate dalla corona, per essere ridistribuite ai nuovi immigrati, in particolare i cosiddetti floridanos, ovvero quelle persone che si erano stabilite a Cuba dopo l'occupazione inglese della Florida, di cui voleva incoraggiare il ritorno nella penisola. Un'ultima questione riguardava gli schiavi neri. Poiché nella Florida spagnola non c'erano né piantagioni né miniere, erano pochi; inoltre, nel 1693, il re Carlo II aveva emanato un decreto che concedeva la libertà agli schiavi fuggiti dall'America britannica, purché accettassero la religione cattolica. Così si era formato un notevole insediamento di neri liberi a nord di S. Augustine; godevano della libertà personale, non erano discriminati e formarono persino un reggimento di milizia. Altri schiavi fuggiti si erano rifugiati presso gli indigeni Creek e Seminole. Durante il ventennio di occupazione, i coloni britannici avevano introdotto l'economia di piantagione (si coltivavano cotone, indaco, canna da zucchero) e con essa schiavi neri portati dall'Africa. Al ritorno degli Spagnoli, essi chiesero di essere liberati in osservanza alla legge di Carlo II, mentre i loro proprietari, che ora si era stabiliti in Georgia o nelle Caroline, ne chiedevano la restituzione; Céspedes, anche se temeva che molte conversioni fossero di comodo, li trattenne in Florida. Buona parte del territorio era inesplorato; gli abitati si concentravano lungo la costa, con centro principale a St. Augustine (Jacsksonville e Miami non esistevano ancora) e non si spingevano oltre il Río de Mosquitos, forse a sud dell'attuale Cape Canaveral. Gli inglesi avevano poi creato una serie di piantagioni lungo il St Johns River, il più lungo e importante della regione anche per i commerci, anche se, per le sue acque basse e paludose, era navigabile solo in canoa. Si capisce dunque perché il governatore si sia mostrato così amichevole verso Michaux e abbia incoraggiato la sua esplorazione. Nel 1784, ordinò un censimento, seguito nel 1786 da un secondo più dettagliato. La conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche geografiche e umane, delle sue risorse, erano per lui un dovere d'ufficio, come dimostra il suo unico scritto noto, Descripción de la Florida Oriental: su clima, terreno, productos, ríos, barras, bahías, puertos, números y calidades de la gente que la habitan, un manoscritto inedito oggi conservato nell'Audiencia de Santo Domingo dell'Archivio General de Indias, da lui inteso come una vera e propria guida per indirizzare la politica immigratoria. Il documento inizia con una una descrizione geografica della Florida orientale, soffermandosi sull'estensione, il clima, le forme del territorio; si trattano poi i fiumi principali, i laghi, le lagune costiere, sempre indicando gli eventuali popolamenti e la loro consistenza, i pochi nuclei urbani. Dopo aver trattato in modo abbastanza generico le risorse naturali (che sono comunque abbondanti e promettenti), Céspedes conclude con la parte più politica: le sue indicazioni per incrementare il commercio (che a suo parere deve avvenire soprattutto da e verso Cuba) e per favorire l'immigrazione, terminando con le Reglas y condiciones para pobladores tanto extranjeros como naturales di cui abbiamo già parlato. L'incarico di Céspedes terminò nel 1790; dovette quindi ritornare a Cuba, dove sappiamo che morì nel 1794 e fu sepolto nella cattedrale dell'Avana.  Un errore... di sbaglio Michaux non dimenticò mai la cortesia con la quale era stato accolto dal governatore Céspedes, che la sua lotta con l'avara e poco sollecita amministrazione francese prima e dopo la rivoluzione gli facevano apprezzare anche più. Così nella sua Flora boreali-americana non poteva mancare di rendergli omaggio, dedicandogli uno dei suoi nuovi generi. Il libro fu pubblicato postumo nel 1803 a cura del figlio François André e questo forse spiega il fattaccio: tanto il nome del genere quanto quello del dedicatario sono infatti sbagliati. Il genere si chiama Lespedeza, non Cespdeza o Zespedeza (le due forme sotto le quali conosciamo il nome del governatore) e del dedicatario si dice "Per il sig. Lespedez, governatore della Florida, cortesissimo nei confronti dei miei viaggi". Eppure anche François André era della partita... ma, come si dice in questi casi, la colpa è del proto che avrà scambiato la lettera iniziale C con L. Lespedeza Mich. è un genere di una quarantina di specie della famiglia Fabaceae, con una distribuzione nettamente disgiunta: una trentina vivono nelle zone temperate e subtropicali dell'Asia orientale e in Australia, mentre le altre sono originarie del Nord America orientale. Il numero delle specie e la loro corretta individuazione hanno dato filo da torcere ai botanici a causa sia dell'estrema variabilità delle specie, sia della tendenza a produrre con facilità ibridi naturali. Il genere, caratterizzato dai fiori papilionacei (ma molte specie hanno anche fiori cleistogami, cioè autofecondanti, privi di petali) e da baccelli tipici di questa famiglia, è piuttosto vario: comprende infatti erbacee perenni, arbusti e rampicanti. La specie più nota e coltivata nei giardini è senza dubbio L. thunbergii, uno splendido arbusto originario della Cina e del Giappone con eleganti rami arcuati che alla fine dell'estate si trasformano in una cascata di fiori rosa-porpora. L'americana L. capitata è invece famosa per altre ragioni: già gli indiani ne usavano le foglie per preparare tisane medicamentose; oggi è usata in fitoterapia per le sue proprietà drenanti, diuretiche e antiossidanti, che la rendono particolarmente indicata per migliorare le funzioni renali. Come molte leguminose, anche le piante di questo genere hanno radici dotate di noduli che ospitano batteri in grado di fissare l'azoto, arricchendo così il terreno. In Asia diverse specie sono usate come foraggere e appunto per il sovescio. Le loro forti radici sono utili anche per arginare il terreno, contenendo gli smottamenti. Ma queste belle qualità possono anche presentare un rovescio della medaglia, come dimostra la storia dell'asiatica L. cuneata. Questa pianta è stata introdotta in diversi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti dove venne piantata per la prima volta nel 1896 nel Nord Carolina per bonificare i terreni di miniere abbandonate, e anche come foraggiera; grazie alle radici molto profonde, non solo trattiene il terreno, ma riesce a sopravvivere a lunghi periodi di siccità. Ne sono anche state sviluppate diverse varietà. Eppure tanto vigore ha un rovescio della medaglia: una singola pianta può produrre 1000 semi all'anno, dove si insedia invade gli spazi delle piante native, inibisce la crescita dei semenzali degli alberi, produce sostanze chimiche che inibiscono la crescita di altre piante. Negli Stati Uniti è già un problema, in Europa non ancora, ma l'Unione europea l'ha inserita nella lista delle piante invasive e ne ha vietato la commercializzazione. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

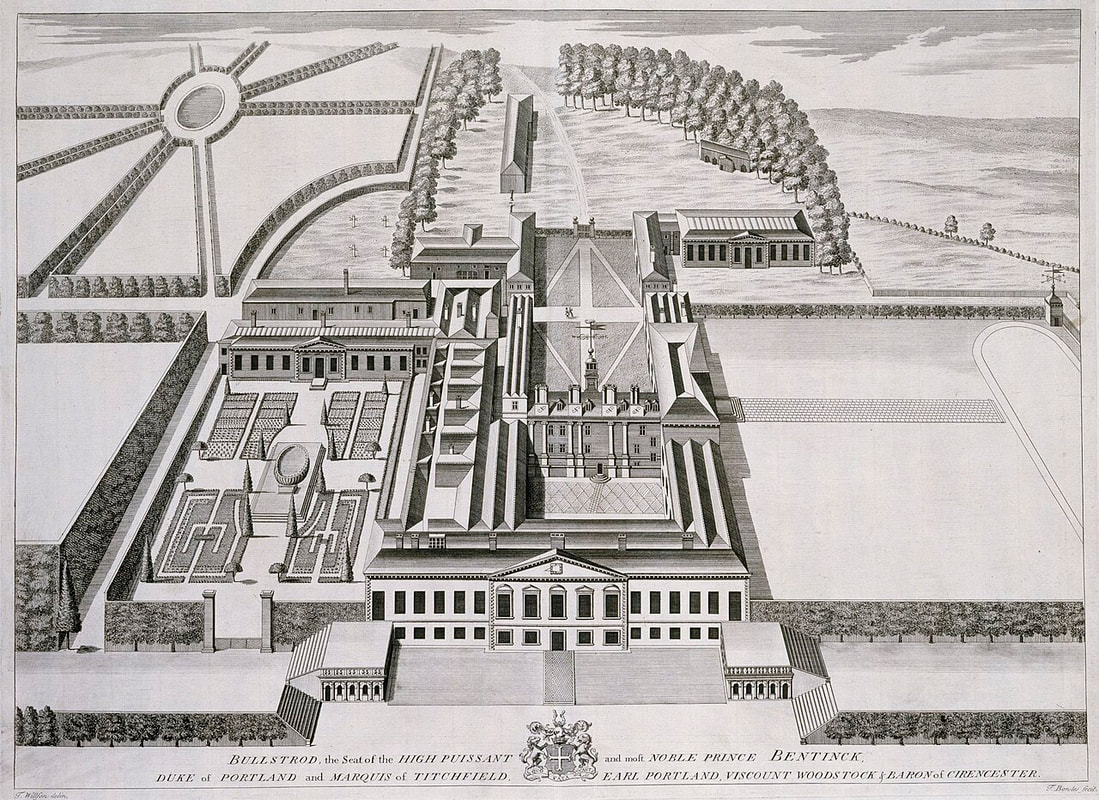
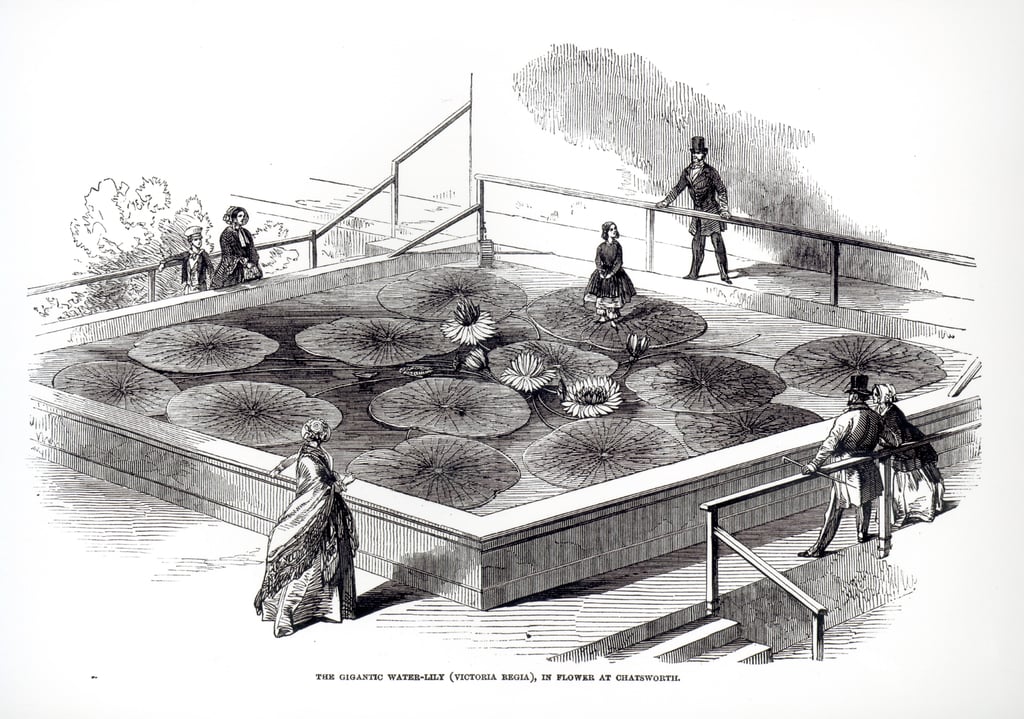

 RSS Feed
RSS Feed