|
Schiller ne fece il protagonista di una novella romantica, Carl Peter Thunberg lo ebbe a compagno delle sue escursioni naturalistiche a Giava, la Società delle Scienze e delle arti di Batavia lo ebbe come primo segretario. E' Friedrich von Wurmb, nobiluomo tedesco e funzionario della VOC a Batavia, promettente naturalista morto troppo presto lasciando una manciata di articoli, uno dei quali dedicato alle palme, con la prima pubblicazione di un nuovo genere e due nuove specie. A ricordarlo provvide Thunberg con l'interessante genere Wurmbea,  Eroe romantico o naturalista? Nel 1782 nella rivista Wurtembergisches Repertorium der Literatur comparve un racconto anonimo intitolato Eine großmütige Handlung, aus der neuesten Geschichte (Un gesto magnanimo, da una storia recente). La trama racconta di due fratelli che amano la stessa donna. Quando se ne rendono conto, grande è la costernazione loro e della fanciulla, che rifiuta di scegliere l'uno piuttosto che l'altro. I fratelli fanno allora un patto: il maggiore andrà all'estero e se riuscirà a resistere lontano dall'amata, il minore sarà libero di sposarla. Egli va ad Amsterdam, ma presto si ammala ed è costretto a tornare. Ora è l'altro fratello a partire: va addirittura a Batavia in Indonesia, e da lì scrive che si sente abbastanza forte per superare la separazione e rinunciare al suo amore. Il fratello maggiore e la ragazza si sposano, ma appena un anno dopo lei muore e sul letto di morte rivela che il suo preferito era il fratello minore. Il marito si risposa mentre l'amato promette che rimarrà per sempre celibe. L'autore del racconto era lo scrittore Friedrich Schiller che si era ispirato a una storia vera, quella dei fratelli Ludwig e Friedrich von Wurmb, che gli era stata riferita dall'unica sorella dei due, sua suocera Louise von Lengefeld nata von Wurmb. Anche se la fonte era diretta e il racconto rispettava a grandi linee lo svolgimento dei fatti (i fratelli von Wurmb si erano davvero innamorati della stessa donna, Christiane von Werthern, Friedrich era davvero immigrato a Batavia, Ludwig aveva davvero sposato Christiane, ne era rimasto presto vedovo e si era risposato) ma Schiller si era permesso qualche licenza poetica. A spingere Christoph Carl Friedrich von Wurmb (1742-1781, questo il suo nome completo), a lasciare la Germania ed ad arruolarsi della VOC (la Compagnia olandese delle Indie orientali) forse più che l'amore impossibile, furono gli scarsi mezzi della famiglia, nobile ma impoverita. Non era inconsueto che giovani tedeschi cercassero fortuna nelle file della VOC come militari o come funzionari civili, tanto che, dopo gli olandesi, costituivano il gruppo nazionale più numeroso sia in Sudafrica sia in Indonesia. Dopo il suo arrivo a Batavia, Friedrich mantenne una regolare corrispondenza con Ludwig, a cui spedì anche qualche materiale naturalistico, ricevendone in cambio libri e riviste. In una di queste lettere, che furono pubblicate dal fratello dopo la sua morte, espresse il desiderio di tornare in patria e di risposarsi. Friedrich von Wurmb arrivò a Batavia via Amsterdam nel giugno 1775; all'epoca aveva 33 anni. Inizialmente era sotto mercante, il rango più basso nella gerarchia dei funzionari civili della VOC; poi fece una modestissima carriera: per due anni (1776-1778) fu contabile presso l'ospedale, quindi dal 1779 fino alla morte secondo amministratore del Waterpoort. Era dunque uno dei funzionari più umili tra coloro che prestavano servizio a Batavia e come tale figura all'ultimo posto nella lista dei membri della Società delle scienze e delle arti di Batavia, di cui nell'aprile del 1778 fu uno dei soci fondatori. Le sue competenze come naturalista (botanico ma anche zoologo) dovettero emergere in occasione del secondo soggiorno di Thunberg a Giava (dicembre 1776-giugno 1777); il tedesco gli fu compagno in una serie di escursioni nelle zone montuose dell'interno, muovendo da Batavia e Buitenzorg. Fu forse tramite lo svedese che von Wurmb entrò in contatto con il presidente della futura società Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher, che lo volle nel comitato direttivo ristretto; inoltre lo raccomandò come membro corrispondente della Società delle scienze e delle arti di Haarlem e lo scelse come secondo segretario, accanto al reverendo Joshua van Iperen; alla morte di questi nel 1780 von Wurmb gli subentrò come primo segretario. In questo ruolo svolgeva compiti amministrativi; seguiva la preparazione e la stampa del bollettino della Società; teneva in ordine e classificava le collezioni; inoltre, quando l'assessore Sirardus Bartlo donò una parte del suo giardino, venne incaricato di allestirvi un piccolo orto botanico. Nei primi tre numeri dei rendiconti della società Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen furono pubblicati sette suoi articoli; grazie al fratello Ludwig dopo la sua morte furono ripubblicati in tedesco sulla rivista di Gotha Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte dove comparvero anche due articoli postumi. Tralasciando un articolo su un minuscolo nano di Bali, domina la zoologia con brevi testi su un esemplare di orango del Borneo ucciso di recente, sul kahau o scimmia dal lungo naso (Nasalis larvatus) che von Wurmb fu probabilmente il primo a descrivere, sul cervo nano di Giava, su alcune specie di uccelli, sui nidi di rondine e altri nidi commestibili. Wurmb scrisse invece un solo articolo di botanica, De orde der palmboomen (L'ordine delle palme), comparso nel 1779 nel primo numero dei rendiconti. Egli vi tratta 17 generi e una ventina di specie di palme; i riferimenti più diretti sono Systema naturae e Species plantarum di Linneo, nonché la trattazione di Houttuyn nel primo volume della seconda parte di Natuurlyke Historie, ma ampi sono i riferimenti a Rumphius, Hortus malabaricus e altre pubblicazioni di autori olandesi. Il merito maggiore è aver introdotto il genere Licuala e due nuove specie Nypa fruticans e Saguerus pinnatus, oggi Arenga pinnata. Come succedeva a una percentuale impressionante di funzionari della VOC, il clima e le pessime condizioni igieniche di Batavia ebbero presto la meglio su Friedrich von Wurmb che morì nel marzo 1781, meno di cinque anni dopo essere arrivato a Giava. Non aveva ancora compiuto 39 anni. La sua morte fu un colpo durissimo per Radermacher, che contava su di lui per studiare sistematicamente la natura di Giava. Si rivolse così a Thunberg chiedendogli di inviare a Batavia uno dei suoi allievi come degno successore. Ciò non avvenne mai e lo stesso Radermacher sarebbe morto tragicamente appena due anni dopo, determinando quasi una paralisi della Società scientifica di Batavia che tanto si era battuto per creare.  Bellezze non sempre profumate Qualche mese prima di venire informato della morte di Friedrich von Wurmb Thunberg aveva già provveduto a celebrarlo con la dedica di uno dei nuovi generi da lui scoperti in Sudafrica, Wurmbea, con parole di grande elogio: "Gli ho dato il nome in onore del sig. barone Friedrich von Wurmb, ora mercante della Compagnia delle Indie orientali e segretario della celebre Società delle scienze di Batavia, espertissimo conoscitore della storia naturale e di altre scienze e generoso patrono dei loro cultori". Il genere Wurmbea (famiglia Colchicaceae) con una cinquantina di specie, è caratterizzato da un areale nettamente disgiunto: circa metà delle specie sono distribuite nell'Africa subsahariana, con centro di diversità in Sudafrica, l'altra metà tra Australia e Nuova Zelanda. Sono erbacee perenni geofite dotate di cormi tunicati simili a bulbi, con foglie lineari e fiori a stella riuniti in infiorescenze a spiga. In Sudafrica sono presenti sia nell'area con piogge invernali, sia in quella con piogge estive. La specie probabilmente più diffusa è W. stricta (in precedenza Onixotis stricta), che vive in paludi e stagni stagionalmente allagati del Capo occidentale e del Namaqualand, dove forma comunità molto numerose che fioriscono in massa tra il tardo inverno e la primavera per due o settimane. Poi la pianta perde le foglie e durante la stagione estiva arida va in riposo, per risvegliarsi alle prime piogge autunnali. I fiori, da bianchi a rosati, con due ghiandole nettarifere alla base, sono impollinati da api e piacevolmente profumati, al contrario di quelli di altri rappresentanti del genere che sono impollinati da mosche ed emanano un odore sgradevole. È il caso di W. marginata, una specie dei flats calcarei e limosi del Capo occidentale, che produce impressionanti spighe di fiori viola scuro quasi nero che contrastano con le antere gialle. Poco piacevole anche l'odore di sterco (ma è stato paragonato anche a mischio) dei fiori di W. elatior, che cresce lungo i margini dei corsi d'acqua e nelle paludi di Capo orientale, KwaZulu Nathal e Lesotho intorno ai 1200 metri, dunque nell'area a piogge estive; fiorisce a fine estate va in riposo in inverno. I fiori, bellissimi, hanno tepali bianchi macchiati al centro di rosso o di viola. Per venire alle specie australiane, vorrei segnalare almeno W. dioica, comune in gran parte del paese; che come dice il nome porta fiori maschili e femminili (e occasionalmente bisessuali) su individui diversi. Ha dimensioni molti più contenute delle cugine africane e fiori bianchi con una macchia viola alla base del nettario. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
Il mercante e alto funzionario della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher si rese benemerito come fondatore e animatore di una delle prime società erudite dell'Asia orientale, la Reale società delle Arti e delle Scienze di Batavia, alla quale donò la prima sede, la propria biblioteca e la propria collezione di curiosità naturali, oggetti etnografici, strumenti musicali, opere d'arte. Anche se non sono giunti fino a noi, c'erano sicuramente anche fogli d'erbario, dato che sappiamo che ricevette campioni dal Giappone da Thunberg ed egli stesso fece raccolte a Giava e inviò exssiccata a Houttuyn. Tra i suoi vasti e variegati interessi c'era infatti anche la botanica, come testimonia una delle sue opere, una lista delle piante dell'isola. A ricordarlo il genere Radermachera, che fu inizialmente descritto proprio sulla base di una specie presente anche in Indonesia. Un dilettante curioso e la nascita di una società scientifica Quando lasciò per la prima volta l'Olanda alla volta dell'Indonesia (le Indie orientali olandesi, come le chiamavano allora), Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783) aveva appena sedici anni. Se non fosse rimasto orfano di padre a sette anni forse non avrebbe avuto bisogno di cercare fortuna in Oriente. La sua era una infatti famiglia influente. Il bisnonno Johan Radermacher era stato balivo di Middelburg e direttore della WIC (la Compagnia olandese delle Indie Occidentali), il padre Johan Cornelis tesoriere generale del principe e primo grande maestro della loggia massonica L'Union. La decisione di mandarlo a Batavia ad imparare il mestiere di mercante nonostante la giovanissima età probabilmente fu presa dallo zio Samuel Radermacher che era uno dei direttori della VOC, come lo sarebbe stato dopo di lui il figlio Daniel. Così il 30 dicembre Jacobus (d'ora in avanti lo chiameremo con il primo nome, come del resto era d'uso) si imbarcò con il grado di sottomercante sulla nave "Middelburg" diretta a Batavia. Qui fece rapidamente carriera, certamente anche grazie alla protezione dello zio e del cugino: un anno dopo era secondo amministratore del Groote Winkel ("grande negozio") e pochi mesi dopo secondo amministratore del Graanmagazijn (il magazzino principale). Il 10 gennaio 1761 gli fu conferito il grado di mercante e il 6 aprile 1762, quando aveva appena 21 anni, fu nominato capo commerciante e contemporaneamente capitano di porto per la popolazione nativa non cristiana. Lo stesso anno, seguendo la tradizione familiare, fondò la loggia massonica La Choisie, la più antica dell'Asia orientale. Nel frattempo si era sposato con Margaretha Verijssel, figlia di un consigliere delle Indie Orientali, e di Sophia Francisca Westpalm, che, rimasta vedova, si era risposata con Reinier de Klerk, all'epoca consigliere straordinario del Consiglio delle Indie. Nonostante la rapida e brillante carriera, Jacobus doveva essere insoddisfatto e chiese di rientrare in patria. Ottenuta l'autorizzazione, nell'ottobre 1763 si imbarcò alla volta dell'Olanda con la moglie. Si stabilì all'Aja e incominciò a studiare legge privatamente; per conseguire la laurea, si iscrisse all'Università di Harderwijk, un diplomificio noto per per conferire diplomi lampo (lo stesso dove una trentina di anni prima si era laureato Linneo): nel suo caso, dall'iscrizione alla laurea passò appena un giorno! Quindi prestò giuramento all'avvocatura di Arnheim, ma qualcosa dovette andare storto e dopo appena sei mesi incominciò a fare pressione sulla direzione della VOC per essere richiamato a Batavia. Incontrò ripetuti rifiuti, forse dovuti all'ostilità che gli aveva procurato il suo scritto "Riflessioni sullo stato attuale dei Paesi Bassi", in cui prendeva atto della crisi della Compagnia, ne criticava le scelte nei confronti dei dipendenti e dei nativi e proponeva una serie di riforme. Aveva idee progressiste anche in altri campi: era contrario alla pena di morte, con l'argomentazione "economicista" che uccidere un reo non portava vantaggio a nessuno, mentre un reo rieducato avrebbe potuto essere utile alla società anche per mezzo secolo. Infine gli fu accordato il permesso di partire, ma a proprie spese e senza alcun incarico ufficiale. Il 20 dicembre la famiglia Radermacher (nel frattempo erano nati due bimbi) si imbarcò sulla nave "Tulpenburg"; il giorno di Natale, mentre erano ancora nella rada di Texel in attesa di un tempo più propizio, il più piccolo dei bimbi morì. Era il mesto inizio di un viaggio difficile, che si protrasse per più di otto mesi e fu segnato dalla morte di un quinto dei passeggeri. Al suo arrivo a Batavia il 21 agosto 1767, Radermarcher, che aveva annotato scrupolosamente gli eventi nel proprio diario di viaggio e aveva incominciato ad interessarsi di cartografia come reazione alle ripetute perdite di rotta, scoprì che nel frattempo era stato nuovamente assunto dalla VOC. La seconda parte della sua carriera non fu più quella di un mercante, ma di un amministratore e alto funzionario. Nel 1768 fu nominato balivo di Batavia, ufficiale giudiziario e curatore della chiesa; nel 1775 consigliere straordinario delle Indie orientali; nel 1777 presidente degli assessori, colonnello della borghesia, presidente del consiglio di amministrazione delle scuole cittadine e commissario delle Terre Alte. Contemporaneamente era diventato uno degli animatori della vita culturale di Batavia; si interessava di tutto (amministrazione, cartografia, geografia, letteratura e linguistica, religione, navigazione, scienze naturali), collezionava curiosità naturali e possedeva una biblioteca aggiornata con libri in varie lingue, un Dictionaire Encyclopedique in 17 volumi e 68 volumi delle opere di Voltaire, di cui evidentemente era ammiratore. Fin dagli anni '60 con alcuni amici, ispirandosi al modello della Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Reale società olandese delle scienze e delle arti) di Haarlem, la più antica e prestigiosa società scientifica olandese, propose di creare a Batavia una società erudita, ma il progetto fu messo da parte per il totale disinteresse dei vertici della società e dei governatori van der Parra e van Riemsdijk. Una svolta si ebbe nel 1777, anno in cui si celebrava il 25esimo anniversario della società di Haarlem; probabilmente grazie al cugino Daniel, che presiedeva diverse società, sia Radermacher sia Reinier de Klerk, il patrigno della moglie Margharete, ne furono nominati amministratori. Poco dopo il governatore van Riemsdijk morì e fu sostituito proprio da de Klerk, che condivideva gli interessi culturali del genero. La strada per la fondazione della Reale società delle scienze e delle arti Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) era spianata. Essa nacque ufficialmente il 24 aprile 1778, con il motto "A beneficio della comunità"; non era un ramo della società di Haarlem, ma una società scientifica indipendente, interessata "alla storia naturale, alle antichità, alla morale e ai costumi del popolo". Ne facevano parte di diritto il governatore generale e alti ufficiali della VOC, tra i quali venne scelto un comitato che si riuniva il primo lunedì di ogni mese al casa di Radermacher. Un anno dopo nel palazzo del governatore si tenne la prima riunione generale in cui Radermacher annunziò tra l'altro la sua intenzione di donare alla società un edificio, i propri libri e le proprie collezioni per allestire una biblioteca e un museo. Suggerì anche di acquistare un giardino dove coltivare le piante native: è considerato il precursore dell'orto botanico di Buitenzorg. La società si diede anche un organo, la rivista Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, che iniziò le pubblicazioni nel 1779. Lo stesso anno il museo venne aperto al pubblico, anche se solo per due ore la settimana, la mattina del mercoledì. Radermacher era il vero animatore sia della società sia della rivista, sulla quale pubblicò una serie di articoli sugli argomenti più diversi; per fare un solo esempio, nel numero del 1780, oltre alla relazione sulle attività annuali, leggiamo suoi saggi sul Borneo, sulla cura della gotta, sulle carte nautiche. Intanto egli aveva raggiunto il culmine della carriera: nel marzo del 1781 in occasione dello scoppio della guerra con l'Inghilterra fu nominato commissario delle opere difensive (ovvero responsabile della difesa di Batavia in caso di attacco inglese) e poco dopo commissario della flotta e dell'esercito, Lo stesso anno subì il grave lutto della perdita della moglie; tuttavia già nel 1783 si risposò con l'adolescente Anna Bosch (lui aveva 42 anni, lei 15). Poco dopo gli giunse la notizia che era stato nominato consigliere ordinario del Consiglio delle Indie orientali. Ma Jacobus aveva altri piani: sempre più sofferente per la gotta che lo tormentava da anni, aveva chiesto di tornare in patria, dove contava di vivere di rendita grazie alla dote della ricca moglie. Il permesso gli venne accordato, anzi venne nominato ammiraglio della flotta di ritorno. Così lui e Anna si imbarcarono sulla nave "Java"; il 24 dicembre, mentre si trovavano al largo, una ventina di marinai cinesi assalì gli ufficiali. Jacobus venne accoltellato a morte, Anna fu ferita ma si salvò. La rivolta fu quasi immediatamente soffocata, gli ammutinati furono rinchiusi nella stiva e il giorno di Natale eliminati uno dopo l'altro con un atto di giustizia sommaria. Per sua fortuna, Frans Reinier, l'unico figlio superstite di Radermacher, era rimasto a Batavia.  Una lista di piante di Giava e una pianta cinese Tra i molteplici interessi di Radermacher c'era anche la botanica. Come commissario delle Terre alte visitò diverse aree dell'isola; conosciamo l'itinerario di due di queste ispezioni: nell'agosto 1776 da Batavia mosse per Krawang, Klapanungal, Buitenzorg, Pondokgede, Tjipanas; nel novembre dell'anno successivo ripercorse la medesima via, per poi proseguire per Megamendung, Telaga Warna, Tjiandjoer e rientrare via Tangerang; nel maggio 1777 fu la volta delle regioni occidentali. Sicuramente approfittò di questi viaggi nell'interno per fare raccolte botaniche e raccogliere informazioni sui nomi e sugli usi tradizionali delle piante di Giava. Anche se non ci è giunto, certamente creò un erbario che entrò a far parte delle collezioni del museo della Società batava delle scienze e delle arti; non a caso, nel primo volume della rivista volle includere istruzioni su come essiccare e conservare i vegetali. Oltre alle raccolte fatte da Radermacher a Giava (e forse a Sumatra), l'erbario presumibilmente comprendeva campioni inviati da Thunberg dal Giappone. Radermacher e Thunberg si erano conosciuti nell'estate del 1775, quando lo svedese era arrivato a Batavia dal Sudafrica; aveva poi proseguito quasi immediatamente per il Giappone, non senza aver preso accordi con Radermacher perché facesse da intermediario con uno dei suoi sponsor, il naturalista Martinus Houttuyn. Il primo di questi invii, spedito da Thunberg a Radermacher a Batavia e da questi inoltrato a Houttuyn ad Amsterdam, dovette raggiungere i Paesi Bassi nel maggio-giugno 1777, come dimostra la nota editoriale dell'ottavo volume della seconda parte di Natuurlijke historie (31 Dicembre 1777) di Houttuyn dove compaiono le prime specie giapponesi. Altre raccolte Thunberg le consegnò di persona quando tornò a Giava da Dejima, nel dicembre 1776. Tra l'altro gli affidò una collezione di pesci, che Radermacher si affrettò a inoltrare ad Houttuyn il quale nel 1782 avrebbe pubblicato 36 specie di pesci giapponesi (21 dei quali nuovi per la scienza) nell'articolo Beschrijving van eenige japansche visschen en andere zee-schepselen (Descrizione di alcuni pesci giapponesi e di alcune altre creature marine). Al secondo passaggio, Thunberg si trattenne a Giava per circa sei mesi e fece estese esplorazioni dell'interno; Radermacher cercò inutilmente di convincerlo a rimanere nell'isola. Anche se non accettò, lo svedese fu profondamente colpito dalla sua personalità e generosità, tanto da dedicargli il genere Radermachia (oggi sinonimo di Artocarpus) con parole di sincera riconoscenza: "Il nome è in onore del sommo mecenate, patrono e massimo fautore delle scienze naturali Jacobus Cornelis Matteus Radermacher, consigliere del Consiglio delle Indie e illustre presidente dell'Accademia delle Scienze di Batavia". Non sappiamo se Radermacher e Houttuyn si conoscessero già in precedenza (è possibile, visto che entrambi erano membri delle società scientifiche di Haarlem e di Vlessingen), ma, oltre a fare "da postino" per gli invii di Thunberg, Radermacher ne aggiunse anche di propri, permettendo al suo corrispondente di pubblicare per primo piante indonesiane come l'albero della canfora di Sumatra Dryobalanops aromaticus. Il suo interesse per la botanica per altro andava oltre i ruoli di mecenate e raccoglitore-collezionista; gli si deve infatti almeno un'opera di botanica, Naamlijst der planten die gevonden worden op het eiland Java (Elenco delle piante trovate sull'isola di Giava) in tre volumi. Il primo, dopo un'introduzione di carattere generale che è anche un omaggio a Linneo di cui viene illustrato sinteticamente il sistema, è costituito dalla descrizione di 99 piante giavanesi, in ordine alfabetico secondo il nome locale. Le descrizioni sono sempre molto sintetiche, ma abbastanza precise. Ad esempio, alla voce Sampar o Tinguli (una delle poche per le quali è fornito anche il nome botanico Cassia fistula), si legge: "Un grande albero con foglie ovali lunghe quattro pollici; fiore con calice a cinque sepali, cinque petali gialli, dieci stami; frutto retto da un gambo rotondo marrone lungo 30 cm che contiene una polpa bianca usata in medicina. Appartiene alla 1a classe Decandria. Il Tingulong descritto da Rumphius è un'altra pianta". Segue un indice in cui, salvo eccezioni, ad ogni specie si fa corrispondere il genere botanico. Da indici sono costituiti anche il secondo e il terzo volume che elencano le piante in olandese, latino, malay (trascritto in caratteri latini). C'è anche una lista dei nomi di Rumphius con i supposti equivalenti latini. Stampata a Batavia nella tipografia della VOC tra il 1780 e il 1782, l'opera ebbe scarsa circolazione ed è stata quasi totalmente ignorata dai botanici successivi. Era tuttavia nota a H. Zollinger e A. Moritzi che proprio in ragione di quest'opera gli dedicarono il genere Radermachera scrivendo: "In onore del sig. J. C. M. Radermacher, che scrisse Naamlyst der planten op het eiland Java e altre opere simili, Batavia 1780-4, amico e protettore di Thunberg, membro del Consiglio delle Indie". La specie sulla base della quale i due botanici svizzeri crearono il genere è R. stricta, oggi R. glandulosa, in precedenza descritta da Blume come Spathoidea glandulosa. È una delle poche specie presenti anche in Indonesia. Infatti il centro di diversità di questo genere dell'Asia tropicale di circa 17 specie delle famiglia Bignoniaceae è la Cina, con sette specie. E alla Cina (anche se il suo areale è molto più vasto) fa riferimento l'eponimo della specie più nota, R. sinica, che da qualche anno ha incominciato ad acquisire in certa popolarità come pianta da appartamento magari in forma di bonsai. Le Radermachera in effetti sono alberi, anche di grandi dimensioni (alcune specie possono raggiungere in 40 metri) con foglie composte sempreverdi e grandi fiori a tromba bianchi, viola o gialli, raccolti in infiorescenze a pannocchia. R. sinica però si adatta anche alla coltivazione in vaso; in queste condizioni mantiene dimensioni contenute (al massimo mezzo metro) e si fa apprezzare per il bellissimo fogliame lucido verde smeraldo, mentre raramente fiorisce. Invece in natura è un albero che può raggiungere i 30 metri con grandi fiori bianchi che si aprono al tramonto e al mattino già sfioriscono. È a questi fiori candidi che deve uno dei suoi numerosi nomignoli "bambola di porcellana"; si riferisce invece ai frutti, lunghe e strette capsule che possono ricordare serpentelli, il soprannome "albero serpente" e al colore delle foglie "albero smeraldo". Per la vastità e la diversità degli argomenti toccati, la Storia naturale (Natuurlyke Historie) dell'olandese Martinus Houttuyn, con i suoi 37 volumi, può essere paragonata solo all'Histoire naturelle di Bouffon, che ne comprende 36. Certamente è meno originale e brillante, ma è stato osservato che, per quanto riguarda gli animali, il francese non andò oltre gli uccelli e i quadrupedi e omise le piante, mentre l'olandese trattò in modo completo il regno animale, inclusi gli insetti e altri invertebrati, e non trascurò quello vegetale. Inoltre, mentre Buffon poté avvalersi dell'assistenza di Daubenton e Gueneau de Montbeillard, Houttuyn lavorò completamente da solo, realizzando uno straordinario one's man work, che lo impegnò per un trentennio. Senza dimenticare che, per le sue ricerche, il conte di Buffon poteva disporre delle raccolte del Jardin du Roi, delle collezioni, delle biblioteche e dei laboratori della capitale culturale d'Europa, nonché di un notevole patrimonio personale, mentre Martinus Houttuyn viveva in una Amsterdam orami relativamente provinciale e poteva contare solo sui gabinetti di curiosità di alcuni amici, e soprattutto sul suo, messo insieme barcamenandosi tra un lavoro editoriale e l'altro. Membro di due società scientifiche e corrispondente di diversi naturalisti di primo piano, tra cui Carl Peter Thunberg, in vita Houttuyn godette di una certa fama, ma poi fu quasi totalmente dimenticato. Il motivo principale è che aveva scritto in olandese, limitando fortemente la diffusione di quell'opera gigantesca, già di per sé costosa e adatta a poche tasche. Al di fuori degli specialisti, a mantenere vivo il suo ricordo è dunque soprattutto il genere Houttuynia che gli fu dedicato appunto da Thunberg.  L'one man's work di un naturalista olandese Dopo trent'anni di lavoro, dovette essere certamente con sollievo che Martinus Houttuyn (1720-1798) scrisse l'ultima parola della sua Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus (Storia naturale o descrizione dettagliata di animali, piante e minerali, secondo la classificazione del signor Linneo). Un sollievo che traspare nei versi commossi (e commoventi) che chiudono il 37esimo e ultimo volume; l'opera di una vita è terminata e il sessantacinquenne Houttuyn può pensare all'eternità: "O Creatore della natura la cui meravigliosa mano ha portato il mondo a una condizione così bella, ha ornato il Regno terrestre di persone, animali e piante e il suo interno di metalli e diamanti preziosi, tu che tutto mantieni, tu, o buon Signore, che hai avuto la compiacenza di assistermi per più di trent'anni dedicati ad osservare le tue creature per rafforzare il sapere dei miei connazionali, ora che - sei volte dieci più cinque - il ciclo dei miei anni si chiude, concedi che, dopo questo, il mio nobile spirito nell'eternità si avvicini meglio alla tua sapienza, si diverta con le creature celesti nel coro degli angeli, mentre il Paradiso mi offre i suoi frutti". Traspare anche una profonda religiosità, che Martinus (Maarten nella forma olandese, che però il naturalista non usò mai nei suoi scritti) dovette assorbire fin dalla nascita nella piccola congregazione mennonita di Hoorn, di cui il padre Willem era allo stesso tempo medico e predicatore laico. Fu il padre ad impartirgli una accurata educazione, che, oltre alla medicina, comprendeva matematica, geometria, fisica, astronomia, botanica sistematica (secondo il sistema di Tournefort) e "l'enorme diversità della natura". Nel 1647, a 27 anni, si iscrisse alla facoltà di medicina di Leida e conseguì la laurea due anni dopo; era un'età avanzata per l'epoca, probabilmente spiegata dalla scarsa disponibilità economica della famiglia, e quindi dal desiderio di abbreviare il più possibile il soggiorno nella costosa città universitaria. Dopo la laurea Martinus Houttuyn tornò per breve tempo ad Hoorn, per poi trasferirsi con la famiglia (nel frattempo si era sposato e aveva un figlio) a Amsterdam dove dal 1753 risulta registrato come cittadino e medico; secondo alcune fonti, prestò servizio come medico della comunità mennonita di Amsterdam, ma presto il suo lavoro principale divenne quello editoriale. Incominciò infatti a lavorare per il secondo cugino Frans Houttuyn, un editore stampatore che, probabilmente proprio approfittando del talento linguistico e delle vaste competenze di Martinus, a partire dal 1755 cominciò pubblicare "Uitgezogte Verhandelingen" (Articoli selezionati), una rivista trimestrale che presentava al pubblico olandese traduzioni o recensioni delle migliori e più importanti pubblicazioni delle principali società scientifiche straniere. Come capo redattore Martinus Houttuyn, oltre a coordinare il lavoro degli altri collaboratori (non tutti sono stati identificati, visto che firmavano solo con l'iniziale; uno di loro però era lo zoologo Cornelius Nozeman), forniva la maggior parte delle traduzioni e anche qualche articolo originale; all'inizio si concentrò sui testi medici, ma poi allargò sempre più il suo interesse alle scienze naturali. La rivista proseguì le pubblicazioni per dieci anni, fino al 1765, quando lo stesso Houttuyn decise di mettervi fine, sia in seguito alla morte del cugino (gli ultimi numeri furono pubblicati dagli eredi - De erven van F. Houttuyn - o meglio dai tutori o dagli esecutori testamentari dei figli bambini di Frans) sia per l'ingentissimo impegno della pubblicazione di Natuurlyke Historie, di cui nel frattempo erano usciti i primi volumi. Fu certamente l'esperienza della rivista a convincere Martinus Houttuyn dell'urgenza di un'ampia trattazione enciclopedica che presentasse in lingua olandese l'intero campo delle scienze naturali a un pubblico di media cultura che non leggeva il latino. Si imbarcò così nell'impresa di descrivere animali, piante, minerali, usando come punto di riferimento la dodicesima e ultima edizione di Systema naturae di Linneo. Il primo volume di Natuurlyke Historie "Sull'uomo e alcuni mammiferi" uscì per i tipi di Frans Houttuyn nel 1761; i volumi successivi uscirono con cadenza regolare nell'arco di quasi 25 anni (il volume 37 uscì infatti nel 1785). Dopo la morte di Frans Houttuyn, avvenuta come abbiamo già detto nel 1765, la pubblicazione fu continuata dai suoi eredi, per poi essere completata dall'editore J. van der Burgh che stampò gli ultimi quattro volumi (1784-85). Come vedremo meglio più avanti, quell'opera monumentale non fu certo un successo commerciale. Per mantenere sé stesso e la famiglia, Houttuyn dovette continuare a lavorare come traduttore (tradusse tra l'altro dal francese Description des expériences de la machine aérostatique de MM. Montgolfier et celles auxquelles cette découverte a donné lieu di Barthélemy Faujas de Saint-Fond, facendolo precedere da un'ampia introduzione e arricchendolo con numerose note); continuava anche a collaborare a diverse riviste e a scrivere contributi di varia estensione e argomento. La pubblicazione di Natuurlyke Historie e il possesso di un ricco gabinetto di curiosità, che aveva creato essenzialmente come strumento di studio per la compilazione della sua enciclopedia, gli diedero una certa fama in patria e all'estero. Nel 1775 fu ammesso alla Società scientifica della Zelanda di Vlissingen e nel 1780 alla Società scientifica olandese di Haarlem. Corrispondeva regolarmente con la prima, frequentava attivamente le riunioni della seconda e collaborava alle riviste di entrambe con articoli di zoologia, botanica e mineralogia e traduzioni di articoli di scienziati stranieri (tra cui Carl Peter Thunberg, che aveva conosciuto quando questi viveva in Olanda, divenendo probabilmente uno degli sponsor del suo viaggio in Sudafrica e Giappone). Dopo la conclusione di Natuurlyke Historie, Houttuyn fu coinvolto in un'altra importante impresa editoriale: nel 1786 gli fu richiesto di continuare Nederlandsche Vogelen (Gli uccelli olandesi), rimasto incompleto per la morte dell'autore Cornelius Nozeman; sfortunatamente neppure lui poté ultimarlo; morì infatti nel 1798 senza aver concluso il compito. Il suo ricco gabinetto di curiosità era già stato venduto qualche anno prima, in due aste tenutesi rispettivamente nel 1787 e nel 1789.  Non solo "divulgatore" di Linneo Riccamente illustrata (le tavole calcografiche, di eccellente qualità, si devono a Jan Caspar e Caspar Philips) e graficamente curata, Natuurlyke Historie era un'opera di proporzioni monumentali estremamente costosa. Da questo punto di vista mancò l'obiettivo di Houttuyn di divulgare la storia naturale presso il largo pubblico, che non poteva permettersi di acquistarla e incominciava a trovare anche in lingua olandese opere molto più maneggevoli ed economiche. Incontrò invece una discreta accoglienza e giudizi positivi da parte degli addetti ai lavori. Tuttavia il fatto che fosse scritta in olandese ne limitò la diffusione al di fuori dei Paesi Bassi. Unica eccezione, la Germania, dove a partire dal 1777 ne venne pubblicata una traduzione riveduta e corretta a cura di Statius Müller per la parte zoologica e di Christmann & Panzer per quella botanica. Gli editori tedeschi, per ragioni puramente commerciali, la presentarono non come un'opera originale ma come una riedizione di Systema naturae: nel frontespizio Linneo figura come autore, mentre Houttuyn come semplice curatore: "Del cavaliere Carl von Linné Sistema naturale completo preparato secondo la dodicesima edizione e secondo le istruzioni dell'opera olandese di Houttuyn". D'altra parte, anche nel frontespizio dell'edizione olandese figurava solo il nome di Linneo e bisognava andare a cercare il nome del modestissimo Houttuyn nelle pagine interne, in calce alle prefazioni ai singoli volumi. Ciò ha fatto sì che anche oggi il naturalista olandese sia conosciuto più come divulgatore di Linneo che come studioso indipendente, contro ogni evidenza: Natuurlyke Historie comprende 21.500 pagine di testo e 296 tavole calcografiche, contro 2370 pagine e 3 tavole della dodicesima edizione di Systema naturae. Del resto, l'intento era totalmente diverso: non classificare l'intero mondo naturale in ordine gerarchico, ma illustrare approfonditamente un numero ridotto di specie significative, raccogliendo tutte le informazioni disponibili nella letteratura scientifica, se possibile integrandole con l'osservazione diretta. Così, per limitarci al regno vegetale, contro le 6000 specie elencate da Linneo e descritte con una succinta diagnosi che raramente supera le dieci parole, ecco le 275 specie esaminate da Houttuyn in capitoli che quasi sempre si dilungano per più pagine, con puntuali riferimenti e spesso citazioni della letteratura botanica contemporanea, che ci riportano al taglio enciclopedico e al sapere erudito dei naturalisti rinascimentali. Houttuyn divise il suo magnum opus in tre parti: zoologia (prima parte, 18 volumi), botanica (seconda parte, 14 volumi), mineralogia (terza parte, 5 volumi). La parte (Deel) di botanica uscì tra il 1773 e il 1783. Estesa per 8600 pagine e illustrata da 105 tavole calcografiche, presenta 275 specie, un centinaio delle quali nuove o poco note. Il primo volume inizia con una estesa trattazione dei principi generali della botanica, seguita da un profilo storico che dà ampio spazio ai sistemi di classificazione, da quello classico di Tournefort a quello recente di Michel Adanson. Si passa poi al primo gruppo di piante, le palme (anche in Linneo sono una categoria tassonomica a sé) con 12 specie. Nei volumi successivi le piante sono sì classificate nelle 24 classi linneane, ma anche raggruppate in più vaste e tradizionali categorie: ecco dunque gli alberi (vol. 2-3), gli arbusti (vol. 4-6), le erbacee (vol. 7-11), le bulbose (vol. 12), le graminacee (vol. 13) e, a concludere il tutto, le crittogame (felci, alghe, muschi e funghi). Come sappiamo dai cataloghi che Houttuyn redasse per le aste del 1787 e del 1789, lo studioso olandese possedeva un vasto erbario di piante esotiche (oggi in parte conservato pressoml'erbariomdi Ginevra); anche se egli stesso non si era mai allontanato dai Paesi Bassi, poté arricchirlo grazie a campioni raccolti da altri e in particolare da Carl Peter Thunberg, di cui, nonostante le scarse disponibilità economiche, dovette essere uno dei finanziatori se lo svedese si premurò di fargli arrivare esemplari di piante inedite dal Sudafrica, da Ceylon, dal Giappone e da Giava, spesso accompagnati da qualche nota e talvolta da un nome. Un altro dei fornitori di Houttuyn fu l'alto funzionario della VOC e botanico dilettante Jacobus Cornelius Matheus Radermacher che, oltre a fare da tramite tra Houttuyn e Thunberg (gli inviò piante giapponesi che lo svedese aveva mandato a Batavia), contribuì egli stesso con almeno due invii di piante raccolte a Giava. In Natuurlyke Historie Houttuyn propose 11 nuovi generi e circa 140 nuove specie o combinazioni. Anche se la loro pubblicazione precede le descrizioni dello stesso Thunberg o del figlio di Linneo, vista la scarsa circolazione dell'opera, poche delle sue denominazioni furono accolte dai botanici successivi. Tra i generi l'unico accettato è Reynoutria; venti invece sono le specie, e tra di esse piante notevoli come le sudafricane Massonia depressa, Ornithogalum dubium, Ixia campanulata, le giapponesi Leonuros japonicus e Reynoutria japonica, e soprattutto Myristica fragrans, l'albero che produce le noci moscate.  La pianta camaleonte La morte di Houttuyn (avvenuta, come si è detto, nel 1798), coincise con il tramonto della potenza mercantile dei Paesi Bassi e con la perdita della stessa indipendenza politica, con la trasformazione in uno dei paesi satelliti della Francia rivoluzionaria prima, napoleonica poi. Anche queste circostanze contribuirono ad offuscare la memoria del naturalista olandese, che nell'Ottocento era al massimo ricordato - come abbiamo visto, a torto - come divulgatore di Linneo. A ricordarlo è dunque rimasto soprattutto il genere Houttuynia, pubblicato da Thunberg in Flora japonica nel 1784, con una dedica laconica: "Ho imposto al genere questo nome in onore del sig. Houttuyn, olandese, botanico meritevole e dottore in medicina". Houttuynia Thunb. (famiglia Saururaceae) è un genere monospecifico rappresentato da una nota pianta da giardino, H. cordata. Originaria del sudest asiatico (e in particolare della Cina e del Giappone), è una vigorosa tappezzante amante dei terreni umidi e delle posizione ombrose. Più che per i modesti fiori bianchi, è apprezzata per le belle foglie cordate, soprattutto nella varietà 'Chameleon' (nota anche con i sinonimi 'Variegata' e Tricolor'), con vivaci variegature crema e rosso-rosate più vivide se esposta al sole. Le foglie sono aromatiche e in Giappone e in Corea sono usate secche per preparare tisane, mentre fresche sono un ingrediente della cucina vietnamita. Anche i rizomi sono eduli e sono particolarmente apprezzati nella cucina della Cina sudorientale. Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland, fu una formidabile collezionista; collezionava oggetti naturali, in particolare conchiglie, ma anche procellane e altri manufatti. Se il suo nome oggi non è ricordato come quello di personaggi come Sloane, è perché dopo la sua morte la sua collezione di oltre 60.000 pezzi fu venduta all'asta e andò interamente dispersa. La famiglia poté riacquistare solo alcuni dei pezzi più preziosi, tra cui il celebre vaso Portland. Era anche un'abile giardiniera e aveva una notevole competenza botanica; dopo i decisivi incontri con Rousseau, Banks e Solander, questa passione raggiunse il culmine con la trasformazione di una parte del parco della sua residenza, Bulstrode Park, in orto botanico i cui fiori furono immortalati da Dionysius Ehret e dall'amica di lunga data Mrs Delany. Alcune delle vere e proprie leggende nate attorno alle rose Portland, un gruppo di rose antiche rifiorenti, le attribuiscono anche l'introduzione della prima rosa di questo gruppo. Ma la loro origine e la loro ascendenza costituiscono un duplice enigma, che è stato sciolto solo di recente. Nessun mistero invece nella dedica del genere Portlandia, con vistose fioriture che evocano i Tropici. La duchessa delle collezioni Per gli amanti dell'antichità, il nome Portland è richiama indubbamente il favoloso "vaso Portland", un vaso vitreo di epoca augustea oggi custodito al British Museum. Per gli amanti delle rose, evoca invece un gruppo di rose antiche rifiorenti. L'uno e le altre sono in qualche modo associati a Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland (1715-1785), la donna più ricca della Gran Bretagna dei suoi tempi, nonché la massima collezionista. Era nata come Margaret Harley e in lei, come unica erede sopravvissuta, si concentrarono i patrimoni del padre, Edward Harley, secondo conte di Oxford e Mortimer, e della madre Henrietta Holles, a sua volta ricchissima erede dei Newcastle e dei Cavendish. La piccola Maria (così veniva chiamata in famiglia) crebbe a Wimpole Hall, la principale residenza di famiglia, circondata da libri, dipinti, sculture e fin da bambina fu incoraggiata a collezionare animali, conchiglie e altri oggetti naturali; sia il nonno paterno (un importante uomo politico) sia il padre erano a loro volta collezionisti, bibliofili e protettori delle arti. Nel 1734, diciannovenne, sposò William Bentinck, secondo duca di Portland, che, al contrario del padre, il primo duca, braccio destro di Gugliemo III, non occupò alcun incarico pubblico e preferì concentrarsi nella vita di famiglia. La coppia ebbe sei figli, quattro dei quali raggiunsero l'età adulta; tra di essi, il terzo duca di Portland, due volte primo ministro, uno dei principali uomini politici britannici della sua epoca. La famiglia divideva il suo tempo tra Londra, dove possedeva una casa a Whitehall e frequentava la corte, i concerti e gli eventi della stagione mondana, e la tenuta di Bulstrode circondata da un vastissimo parco dove già il nonno dell'attuale duca aveva creato un magnifico giardino - di origini olandesi, aveva portato dalla sua patria il gusto per i "paradisi" che costituivano l'orgoglio dell'élite della Repubblica delle province unite - e una notevole Menagerie con voliere di uccelli esotici. Anche se Maria, come abbiamo visto, collezionava conchiglie fin da bambina e aveva ereditato almeno una parte delle collezioni paterne, la passione per il collezionismo esplose negli anni '60, quando rimase vedova (l'amato marito Will morì nel 1761); grazie a una dote di 20.000 sterline, cui, dopo la morte della madre nel 1755, si aggiunsero la proprietà di Welbeck Abbey e una rendita annuale di ulteriori 8000 sterline, era una donna indipendente di larghissimi mezzi che poteva permettersi, letteralmente, ogni capriccio. Amante degli animali fin dall'infanzia, rifondò la menagerie, arricchendola di moltissimi animali; spiritosamente, in una lettera una delle sue più care amiche, Mrs Delany, scrisse: "La duchessa è ansiosa di collezionare animali come se prevedesse un altro diluvio e ne radunasse di ogni tipo per preservarne la specie". Arricchì il parco di varie strutture, tra cui una grotta artificiale (Grotto) che adornò lei stessa di conchiglie con l'aiuto di Mrs Delany. Collezionava soprattutto oggetti naturali, ma anche dipinti, smalti, porcellane, manufatti di varia natura, ogni cosa colpisse la sua curiosità, che, a quanto pare, andavano a mescolarsi in allegra confusione nei corridoi e nelle stanze di Bulstrode Hall, ormai trasformato in un vero e proprio museo aperto ai visitatori. Colta e raffinata, la duchessa di Portland frequentava altre dame con interessi simili (inclusa la regina Carlotta); tra le amiche più strette troviamo Elizabeth Montagu, la creatrice della cosidetta Blue Stockings Society, un club informale che incoraggiava l'educazione e l'espressione artistica delle donne, con la quale iniziò una scambio epistolare nel 1731, quando era appena sedicenne. Un'altra amica di lunga data era la già citata Mary Delany, che la duchessa aveva conosciuto poco dopo il matrimonio, quando ancora si chiamava Mrs Pendarves (dal nome del primo marito); le accumunavano molti interessi e hobby: entrambe parlavano fluentemente italiano e francese, suonavano il clavicembalo, erano abili nel ricamo e in lavori in legno o con conchiglie, amavano la natura, gli animali, le piante, le lunghe passeggiate nel parco. Poi l'amica rimase vedova, si risposò con Mr Delany e si trasferì in Irlanda. Tornò in Inghilterra dopo il 1770, quando rimase vedova per la seconda volta e da quel momento trascorse circa sei mesi all'anno a Bulstrode; ormai sulla settantina, si era perfezionata nell'arte del découpage e il suo soggetto preferito divennero i fiori: formati anche di centinaia di pezzi, i suoi accuratissimi collage ritraggono con precisione anche i particolari più minuti, come gli stami, il pistillo, le nervature delle foglie. Per consentirle un minimo di indipendenza economica, la duchessa le assegnò una piccola casa a Windsor e una pensione di 300 sterline. Un altro artista protetto dalla duchessa di Portland fu Dyonisius Ehret. che probabilmente ella conobbe nel giardino di Chelsea oppure le fu presentato da Miller (di cui Ehret aveva sposato la cognata). Il pittore dipinse per lei su pergamena circa 300 piante esotiche e 500 inglesi, e insegnò disegno alle sue figlie. Possiamo considerarlo un membro a tutti gli effetti della vera e propria équipe scientifica che aiutava la duchessa ad organizzare, catalogare e documentare la sua collezione. A presiederla era il pastore John Lightfoot; nominato cappellano dal duca, due volte la settimana celebrava nella cappella di Bulstrode, dove trascorreva tutto il tempo lasciatogli libero dalla sua attività come pastore di Uxbridge, insegnando botanica alla duchessa, curando la biblioteca e aiutandola con le collezioni. Ottimo botanico, autore di Flora scotica, corrispondeva con Linneo e introdusse la nobile allieva al sistema linneano. Fino al 1770, la botanica, alla quale, come abbiamo visto, era stata avviata da Lightfoot, era un interesse relativamente secondario per la duchessa, anche se amava le piante, teneva un erbario ed era un'appassionata giardiniera, particolarmente abile nella propagazione mediante propaggine. Un incontro importante fu quello con il filosofo Jean Jacques Rousseau, che nel 1766 visse per qualche tempo a Wootton Hall nello Staffordshire, dove intraprese addirittura un inventario della flora locale. Fu presumibilmente introdotto presso la duchessa di Portland da un vicino, Bernard Granville, fratello di Mary Delaney (nata Mary Granville). Rousseau si offrì di diventare il suo "erborista", ovvero di raccogliere per lei semi e campioni d'erbario, cosa che poi fece. Anche se espresse idee francamente maschiliste sulla predisposizione scientifica delle donne, il filosofo ammirava la competenza botanica della duchessa che riteneva ben superiore alla sua. Per più di dieci anni il ginevrino e la nobildonna scambiarono lettere, esemplari, libri, finché nel 1775 o nel 1776 la duchessa commise l'errore di inviargli una copia di Herbarium amboinense di Rumphius. Rousseau tollerava appena la coltivazione dei giardini e aborriva quella delle piante esotiche, che considerava una violenza contro la natura; dunque restituì il dono e interruppe la corrispondenza. La vera svolta si produsse però qualche anno dopo. La duchessa aveva conosciuto Daniel Solander, forse presentatogli da Collinson, poco tempo dopo il suo arrivo dalla Svezia. Nel novembre 1771, dopo il ritorno dall'Australia, egli si recò con Banks a Bulstrode per farle omaggio di semi e campioni d'erbario. Seguirono dotte discussioni in cui fu coinvolto Lightfoot. Pochi giorni dopo, la duchessa e Mrs Delany visitarono il British Museum, con Solander a fare loro da cicerone. Si spostarono poi a casa di Banks che mostrò loro altri esemplari. Questi eventi acutizzarono l'interesse della duchessa per la botanica, e ne nacquero probabilmente l'erbario dipinto affidato a Ehret e l'erbario a decoupage creato da Mrs Delany. Ma la conseguenza principale fu la trasformazione di una parte del giardino in vasto orto botanico secondo il modello del giardino dei farmacisti di Chelsea, con le piante "piantate separatamente secondo la loro specie". Fu probabilmente in questo stesso periodo che, per usare le parole di Lightfoot, la duchessa concepì il progetto di "far descrivere e pubbicare tutte le specie sconosciute dei tre regni della natura". Incaricò Solander di occuparsi delle conchiglie; secondo la testimoniamza di Banks, egli dedicava a questo compito un giorno alla settimana. Tuttavia le morti di Solander nel 1782 e quella della stessa duchessa tre anni dopo, misero fine a questo sogno tanto ambizioso quanto impossibile. Poco dopo la sua scomparsa, il figlio, il terzo duca di Portland, decise di mettere in vendita l'enorme collezione creata dalla madre (erano almeno 60.000 oggetti): c'erano creditori da pagare ed egli stesso aveva bisogno di denaro per la sua carriera poltica. Lightfoot dovette trasformare il catalogo della collezione cui lavorava da anni in catalogo d'asta; quest'ultima, tenuta nella residenza di Whitehall, si aprì il 24 aprile 1786 e si protrasse per oltre due mesi, terminando il 3 luglio. Vi parteciparono centinaia di londinesi e la collezione, divisa in 4000 lotti, fu interamente dissolta. La famiglia riacquistò solo alcuni pezzi di interesse artististico, tra cui un prezioso vaso vitreo di epoca augustea con decorazioni a cammeo; la duchessa l'aveva acquistato nel 1784 da sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli; in precedenza per 150 anni era appartenuto alla famiglia Barberini. Era il pezzo più prezioso, fu messo in vendita il penultimo giorno dell'asta e per aggiudicarselo il duca dovette sborsare 1,029 sterline, una somma enorme per l'epoca. Oggi è una delle gemme del British Museum ed è noto come Vaso Portland.  Un enigma botanico Quanto alle "rose Portland", la loro storia è molto meno lineare, anzi è tanto contraddittoria e intricata da costituire un vero mistero. La versione a lungo dominante è quella riportata da Graham Stuart Thomas in Le rose antiche da giardino (data originale 1979): la progenitrice di questo gruppo di rose era presente nel vivaio Dupont di Parigi nel 1809; Dupont l'avrebbe ottenuta dall'Inghilterra e le avrebbe dato il nome della duchessa di Portland "che probabilmente la trovò o la ottenne dall'Italia all'inizio del secolo". In Inghilterra fu chiamata Rosa paestana, perché si riteneva fosse originaria della zona di Paestum, oppure "Scarlet four season Rose" perché era rosso vivido e ripeteva la fioritura in autunno. Se questa versione è corretta, dato che, come abbiamo visto, la nostra duchessa di Portland morì nel 1785, l'introduttrice non sarebbe lei, ma un'altra duchessa. Beales in Le rose classiche (data originale 1985) si rifà sostanzialmente alla medesima versione, ma si discosta da Thomas affermando che giù in Inghilterra era chiamata Rosa portlandica; aggiunge poi in nota che Sally Festing, autrice di una biografia della seconda duchessa, ha evidenziato che era già elencata nel catalogo di un vivaio inglese nel 1784, il che "deve pure mettere in dubbio l'Italia come suo paese d'origine". E, aggiungo io, rimettere in gioco la nostra duchessa. Ulteriore enigma è l'ascendenza di questa rosa. Nell'opera già citata, Thomas riporta che "era considerata come un incrocio tra la rosa francese (Gallica) e la Damascena autunnale"; egli però la ritiene piuttosto "una ibrido rosa Cinese - Damascena - rosa Francese" e aggiunge: "Dal colore e dal comportamento nano [...] si può presumere che la rosa Cinese progenitrice in questione fosse la cremisi Cinese di Slater" (Slater's Crimson China). Beales è invece convinto che "nessuna rosa cinese sia comunuqe coinvolta" ma che vi abbiano avuto parte attiva la Rosa x damascena bifera ('Quatre Saisons') per la rifiorenza e la R. gallica officinalis ('Rosa del farmacista') per il portamento ordinato e compatto. Il mistero ha ovviamente sollecitato la curiosità dei rodologhi e suscitato ulteriori ricerche. A fare il punto, e dare la risposta definitiva, è Peter Harkness in The Rose. A Colourful Inheritance (2005). In primo luogo egli ricorda che la rosa Portland è conosciuta sotto ben otto nomi: Rosa paestana, R. 'Portlandica', 'Duchess of Portland', Portland Crimson, 'Monthly Rose', 'Portlandia', 'Portlandica', 'Rosier de Portland'. Quindi riassume lo stato dell'arte così: "Le descrizioni di questa rosa nella letteratura non si contano. Si dice che sia originaria del Dorset, o di Beaconsfield, o forse di Napoli, negli anni '70 o '90 del 1700. Quanto alla sua ascendenza, si dice che coivolga unicamente gallica, oppure una damascena e una gallica, o una cinese e una damascena". Secondo Harkness, tutto questo garbuglio nasce dal fatto che "in realtà ci sono due diverse Portland", una nata in Inghilterra negli anni '70 del Settecento, l'altra introdotta da Dupont, giardiniere dell'imperatrice Giuseppina, all'inizio dell'Ottocento. La differenza salta all'occhio osservando la prima nel giardino della Royal National Rose Society, dove è coltivata sotto l'etichetta 'Duchess of Portland', e la seconda nel giardino parigino della Bagatelle, dove è coltivata come R. paestana. La rosa "inglese" (chiamiamola così per comodità), come risulta da cataloghi di vivai e da testi dell'epoca (come la monografia Roses, pubblicata da Henry C. Andrews nel 1805) nacque nei giardini del duca di Portland a Bulstrode prima del 1775, data in cui è elencata da Weston tra le rose "facilmente reperibili" sotto il nome 'Portland Crimson Monthly Rose'; la stessa data è riportata da Trees & Shrubs Hardy in the British Isles che però la chiama 'Portlandica'. Nel 1782, come ‘Portland’ era presente nel catalogo del vivaio Brunton e Forbes di Birmingham; veniva venduta a uno scellino, prezzo che, secondo Harkness, "suggerisce che non si trattasse di una novità". Intorno al 1785, fece la sua comparsa in Francia. E' identificabile nella rosa della Royal National Rose Society; l'aspetto generale, le foglie, i fiori rosa profondo indicano la parentela con la gallica, mentre la modesta rifiorenza riflette quella con la damascena. Veniamo invece a quella "francese"; l'unica certezza è che André Dupont iniziò a coltivarla nel 1803, quando la ricevette dall'Inghilterra. Nel 1809 era chiamata Rosier de Portland e Redouté la dipinse sotto questo nome. Nel 1811 Claude-Thomas Guerrepain nell'Almanach des Roses ne diede una precisa descrizione esaltandone "la preziosa qualità di fiorire dalla primavera all'autunno" e il bellissimo punto di rosso. E' la rosa di Bagatelle. Il brillante colore scarlatto e la rifiorenza hanno fatto a lungo pensare che uno dei genitori fosse una rosa rossa cinese, anche se l'aspetto generale, le foglie e i cinorrodi mostrano maggiori affinità con la Damascena. Le analisi del DNA di cinque rose Portland, condotte da Olivier Raymond dell'università di Lione, ha mostrato parentele con Damascena, Gallica e Centifolia, ma non con le cinesi. Rimane da capire la ragione del nome Portland e l'eventuale connessione con la seconda o la terza duchessa. Nel 1805, parlando della rosa di Bulstrode, Andrews riferisce che sarebbe stata chiamata così "in onore della defunta duchessa di Portland"; Harkness contesta questa affermazione: a suo parere nel Settecento non era ancora invalsa l'abitudine di dare alle rose il nome di una persona; gli sembra più probabile che i nomi 'Portland' o 'Portlandica' si riferiscano al luogo di origine, la tenuta di Bulstrode dei duchi di Portland. Quanto alla rosa "francese", abbiamo due versioni: una, che abbiamo già visto sotto la penna di Graham Stuart Thomas, pretende che una duchessa di Portland l'abbia portata o ottenuta dall'Italia attorno al 1800; l'altra che Dupont l'abbia ottenuta dall'Inghilterra nel 1803 e battezzata 'Rosier de Portland' in segno gratitudine per la terza duchessa di Portland per averlo aiutato a persuadere l'Ammirigliato, nonostante il blocco continentale, a concedere un passaporto al vivaista John Kennedy per trasportare in Francia questa e altre rose destinate ai giardini della Malmaison . Nessuna delle due storie può essere vera, per la semplice ragione che né nel 1800 né nel 1803 viveva una qualche duchessa di Portland. Sappiamo già che la seconda duchessa, ovvero Margaret Cavendish Bentinck, morì nel 1785. La terza duchessa, ovvero sua nuora Dorothy Bentinck nata Cavendish, morì a sua volta nel 1794, e non ci sarebbe stata una quarta duchessa fino al 1809, quando, con la morte del terzo duca, che non si risposò, il titolo passò al quarto duca e a sua moglie. Inoltre, Dupont non chiamò la rosa 'Duchess de Portland', ma 'Rosier de Portland'; l'ipotesi di Harkness è che l'omaggio fosse diretto al terzo duca di Portland il quale, come Segretario di stato ininterrottamente dal 1794 al 1801, quindi, dopo un breve periodo all'opposizione, dal 1803 Presidente del Consiglio privato e poi Primo ministro, "era certamente nella posizione di aiutarlo a ottenere un passaporto per le sue rose". Anche il nome R. paestana probabilmente non ha alcun rapporto diretto con l'Italia e Paestum; si tratta piuttosto di una semplice reminescenza della letteratura classica in cui le rose di Paestum erano celebrate per la loro bellezza, il profumo, il vivace colore rosso e la rifiorenza autunnale. 
Fresco di laurea, il medico di Basilea Werner de Lachenal si affrettò ad inviare la sua tesi ad Albrecht von Haller. Per anni, mentre lavorava come medico e farmacista, ne fu uno dei più assidui corrispondenti, informatori e raccoglitori, divenendo un reputato esperto della flora di Basilea e del Giura. Solo dopo diversi anni ottenne la cattedra di anatomia e botanica presso l'Università di Basilea, illustrandosi con due benemerenze: fece rinascere l'orto botanico universitario, pagando in gran parte di tasca propria, e salvò quanto rimaneva dell'erbario di Caspar Bauhin, oggi perla dell'erbario di Basilea. A ricordarlo il bellissimo genere di bulbose sudafricane Lachenalia, che meriterebbe di essere coltivato più spesso. 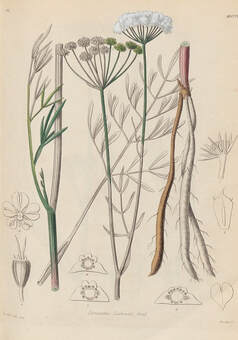 Una lunga collaborazione con von Haller Come abbiamo visto in questo post, per ottenere gli esemplari e le informazioni necessari alle due edizioni della sua monumentale flora della Svizzera, Albrecht von Haller si servì, oltre della raccolta diretta, di una vasta rete di informatori, corrispondenti, raccoglitori. Ciò divenne tanto più indispensabile quando l'età, la gotta e la corpulenza lo costrinsero a delegare ad altri il grosso del lavoro di raccolta. I candidati ideali erano giovani medici o studenti di medicina, di cui nel suo saggio Making Natural History: Doing the Enlightenment, Bettina Dietz ha tracciato un identikit: "essere fisicamente abbastanza robusti da far fronte alle fatiche di escursioni in montagna protratte per diverse settimane; avere una buona conoscenza della botanica; avere scarse pretese per i pagamenti, che Haller sborsava di tasca propria; seguire le sue istruzioni su cosa cercare; consegnare ad Haller il bottino delle loro escursioni botaniche in ottimo stato". Quando entrò in contatto con von Haller, il neo-medico di Basilea Werner de Lachenal (1736-1800), che fu uno dei principali raccoglitori-informatori per Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, apparve subito riunire tutti in requisiti. Figlio di un farmacista, fu egli stesso avviato alla farmacia, per poi iscriversi all'università di Basilea; nel 1755 ottenne il titolo di magister di filosofia e nel 1759 la licenza per esercitare la medicina con una tesi (Specimen Inaugurale Observationum Botanicarum) dedicata ad alcune piante poco note o mal determinate della flora locale. Si affrettò a mandarne copia a von Haller che ne fu piacevolmente colpito, gli rispose con una lettera di elogi e gli chiese di inviargli campioni di alcune di quelle specie rare. La corrispondenza proseguì mentre il giovane medico completava la sua formazione all'università di Strasburgo e il tirocinio pratico a Montbéliard con il medico di corte del Württemberg David Charles Emmanuel Berdot. Avendo ormai verificato la sua preparazione e la sua affidabilità, Haller gli propose una prima escursione botanica per suo conto e a sue spese, che nell'estate del 1760 portò Lachenal nel Vallese e nelle Alpi Graie fino al Piccolo San Bernardo. L'estate successiva, insieme a un altro giovane medico, Jean Jacques Châtelain (1736-1822), lo inviò fino a Mendrisio in Canton Ticino. un'area che riteneva quasi inesplorata. Anche se Lachenal fu piuttosto deluso della flora della meta designata, molto meno ricca di quanto pensasse, durante il viaggio fece molte raccolte e ne informò puntualmente von Haller, così soddisfatto del lavoro dei due botanici da elogiarli con insolito calore: "Non potevo sperare di riunire in un medesimo viaggio due compagni di uguale ardore. E' impossibile che l'uno superi l'altro per perizia e per passione". L'anno dopo avrebbe ancora voluto inviare Lachenal in Valtellina e in Engadina, ma questa terza spedizione non avvenne mai. Per il medico di Basilea era infatti ora di pensare a una sistemazione stabile. Haller aveva sì cercato di usare tutta la sua influenza per fargli assegnare una cattedra a Gottinga, ed egli era stato incluso nella terna dei nomi selezionabili, ma non si era andati oltre. Nel 1763 Lachenal conseguì il dottorato in medicina, quindi rilevò la licenza decennale per una farmacia. Con gli impegni professionali come medico e farmacista, i lunghi viaggi erano fuori discussione; continuò invece ad esplorare la flora dei dintorni e quella del vicino Giura borgognone e a soddisfare con sollecitudine le richieste di Haller, che non di rado gli chiedeva di procurargli questa o quella pianta. Raccoglieva anche per sè, in vista di una flora della regione di Basilea. La relazione tra Lachenal e Haller non era ovviamente paritaria, ma tipicamente quella tra discepolo e maestro; una volta il bernese giunse persino a rimproverare il suo giovane corrispondente per aver usato il nome linneano per designare Trifolium fragiferum; al che Lachenal ritenne necessario giustificarsi, spiegando che aveva usato quel nome perché al momento non ne aveva a disposizione nessun altro La corrispondenza tra i due botanici svizzeri durò 18 anni (dal 21 aprile 1759 al 31 giugno 1774). Durante questo lungo periodo, che lo vide trasformarsi da giovanissimo neolaureato in affermato medico di mezza età e riconosciuto esperto della flora locale, oltre che con moltissimi invii di campioni di erbario, Lachenal si rese utile al suo maestro come correttore delle bozze dei supplementi alla flora elvetica (Emendationes et auctaria ad stirpium Helveticarum historiam), pubblicati presso un tipografo di Basilea; compito difficilissimo e ingrato, vista l'impazienza di Haller e la sua grafia sempre più illegibile.  La rinascita dell'orto botanico La grande svolta nella vita di Lachenal, forse inattesa persino per lui, avvenne nel 1776, quando per sorteggio gli fu infine assegnata la cattedra di anatomia e botanica all'università di Basilea. Era una cattedra prestigiosa con una lunga storia: quella di anatomia era stata creata addirittura nel 1571 da Felix Platter, grande anatomista e allievo di Rondelet a Montpellier, a sua volta maestro di Caspar Bauhin che nel 1589 fondò l'orto botanico universitario, uno dei più antichi d'Europa e il fu il primo titolare della cattedra di anatomia e botanica. Quando Lachenal assunse la cattedra, erano glorie del passato. Il suo predecessore Johann Rudolf Stähelin (titolare della cattedra di anatomia e botanica dal 1753, dal 1776 passò alla cattedra di medicina teorica) all'insegnamento preferiva l'esercizio della professione e i segni della trascuratezza si facevano sentire. Da un sopralluogo di quello stesso anno il teatro anatomico risultò "così fatiscente che rischiava di crollare da un momento all’altro”. Lachenal suggerì addirittura di demolirlo e trasferirlo nell'orto botanico; il consiglio cittadino preferì ristrutturarlo, rendendolo più ampio e luminoso. Né migliore era la sitazione dell'orto botanico; c'era un solo giardiniere, che, salvo qualche piccola regalia occasionale, non riceveva alcun salario; di fatto, gli era stato permesso di trasformare l'orto botanico in orto, frutteto e vigna, dalla vendita dei cui prodotti ricavava il suo unico reddito. Nel 1754 il Comune fece costruire una modesta casetta, composta da un atrio, due stanze e alcuni locali laterali, che serviva sia da appartamento del professore sia da auditorium per le lezioni. Anch'essa era inadeguata. Lachenal chiese la ristrutturazione del giardino, condizioni migliori per il giardiniere, un appartamento dignitoso per il professore. Offrì di pagare un quarto delle spese e di cedere all'università la sua biblioteca; in cambio, chiedeva di mantenere la cattedra vita natural durante e il versamento di una pensione alla moglie, nel caso gli fosse sopravvissuta. Nell'agosto 1777 le condizioni furono accettate e i lavori procedettero abbastanza celermente. L'orto botanico poté disporre di un budget annuale e da quel momento rinacque. Venne anche costruita una serra che, a quanto pare, Lachenal pagò di tasca propria. Nel venticinquennio in cui insegnò all'università di Basilea, egli acquisì una solida reputazione internazionale, anche se non pubblicò quasi nulla. Corrispondeva con numerosi colleghi, con i quali scambiava esemplari d'erbario, scriveva articoli per qualche rivista, ma non riuscì mai a completare e pubblicare la sua flora di Basilea (Catalogus stirpium Basiliensis). Conosciamo la sua esistenza, oltre che dalla corrispondenza con von Haller, che più volte lo sollecitò a concluderla, da diverse testimonianze contemporanee, ma dopo la morte di Lachenal l'opera scomparve. Il manoscritto incompleto è stato riscoperto solo nel 1987 durante lavori di ristrutturazione dell'Istituto botanico di Basilea e rimane inedito. Presumibilmente, Lachenal lo aveva lasciato in eredità all'istituto botanico, insieme a tutti i suoi libri e al suo erbario, di enorme importanza storica perché egli vi aveva incluso l'erbario di Caspar Bauhin, che aveva acquistato da un discendente del grande botanico intorno al 1774. Contrariamente all'uso del tempo, l'erbario di Bauhin non era rilegato, ma costituito da fogli sciolti, che egli poteva così facilmente riorganizzare per i suoi lavori tassonomici. Ciò ne aveva però favorito anche la dispersione, perché nel corso dei decenni la famiglia Bauhin aveva permesso a diversi botanici di consultarlo e anche di attingervi; quando Lachenal lo acquistò, era ridotto a un terzo dell'originale. Nuovamente separato da quello di Lachenal, oggi costuisce una collezione separata dell'erbario di Basilea ed è preziosissimo, sia come testimonianza del lavoro di uno dei padri fondatori della botanica moderna, sia come uno dei pochissimi erbari rinascimentali giunti fino a noi, Quanto all'erbario personale di Lachenal, comprendeva circa 3000 specie, in prevalenza elvetiche, ma anche un certo numero di esotiche, ottenute da corrispondenti o orti botanici; è interessante notare che per etichettare le piante svizzere egli usò le denominazioni di von Haller, per tutte le altre quelle di Linneo.  Splendide bulbose sudafricane A ricordare Lachenal è oggi un busto nell'orto botanico di Basilea che ebbe il merito di far rinascere, l'eponimo di alcune piante più o meno rare che fu il primo a raccogliere o segnalare, come Hieracium lachenalii, Carex lachenalii, Festuca lachenalii e Oenanthe lachenalii, ma anche il bellissimo genere sudafricano Lachenalia, omaggio di Joseph Franz von Jacquin (il figlio di Nikolaus) che era uno dei suoi corrispondenti e gli fece visita quando passò dalla Svizzera durante il suo viaggio in Europa del 1788-91. In una lettera dell'ottobre 1790 al padre, lo ricorda con grande affetto e gli chiede di scrivergli per ringraziarlo delle tante cortesie che gli ha dimostrato. Ma a ben vedere lo aveva già ringraziato lui anticipatamente (la dedica risale al 1784) dedicandogli questo notevolissimo genere. Lachenalia (famiglia Asparagaceae) comprende circa 130 specie di bulbose perenni originarie della Namibia e del Sudafrica, distribuite in zone con piogge invernali; durante la stagione estiva, calda e arida, vanno in dormienza per poi entrare in vegetazione alle prime piogge autunnali; la fioritura, che è di relativamente lunga durata, avviene in inverno o all'inizio della primavera. Le foglie, che in alcune specie sono emesse prima dei fiori, in altre quasi contemporaneamente ad essi, sono basali e spesso graziosamente maculate, così come gli steli fiorali. I fiori campanulati, tubolari o cilindrici sono raccolti in spighe o racemi; a seconda delle specie, le corolle presentano una grande varietà di colori, dal bianco al rosa, dal lilla all'azzurro, dal giallo all'arancio e al rosso vivo. Il colore più raro e straordinario è il verde-turchese dei fiori di L. viridiflora. In varie specie, i fiori sono molti colori grazie agli apici più scuri. Le dimensioni dei bulbi e delle piante in fioritura sono molto varie, dai 5 cm di L. ensifolia e L. flava ai 40 di certe varietà di L. aloides. Lachenalia ha una lunga storia orticola, ma non è mai diventatomun genere popolare. La prima attestazione è un disegno dell'attuale L. hirta, risalente alla spedizione del Namaqualand del 1685-1686; da quel momento varie specie, sotto vari nomi, fecero qua e là la loro comparsa nel mercato dei bulbi e nelle raccolte dei collezionisti; il primo a studiare sistematicamente questo genere fu però verso la fine del Settecento von Jacquin padre, grazie alle raccolte sudafricane dei cacciatori di piante di Schönbrunn; come ho anticipato, il genere fu creato nel 1784 da suo figlio. Mano a mano che venivano scoperte nuove specie, con la loro grande varietà di dimensioni, forme e colori, attirarono l'attenzione degli ibridatori; il primo ibrido riconosciuto venne realizzato nel 1888 dal reverendo John G. Nelson, incrociando L. reflexa e L. aloides. A partire dal 1965, un vasto programma di ibridazioni è stato avviato dal Roodeplant Vegetable and Ornamental Plant Institute del Sudafrica; lo scopo era produrre, più che bulbi da giardino, fiori da taglio (i fiori di Lachenalia durano da due a quattro settimane) e piante fiorite in vaso per l'esportazione. I primi ibridi furono commercialmente disponibili nel 1997-1998, ma il programma fu rallentato da vari fattori, che vanno dall'isolamento politico del paese a causa dell'apartheid alle peculiarità del clima sudafricano che resero difficile adattare le condizioni di crescita di crescita all'emisfero nord. I primi ibridi (è la serie African Beauty) furono commercializzati alla fine del secolo, ma la risposta del mercato europeo fu minore di quanto sperato; il potenziale di queste splendide piante è ancora in gran parte da scoprire. Sono ancora soprattutto piante da collezionisti, piuttosto costose e non sempre facili da reperire. Anche in Olanda sono essenzialmente commercializzate da specialisti di bulbose rare; talvolta, come altre bulbose sudafricane, come Albuca o Ledebouria, sono offerte tra le succulente. Eppure sono bellissime e, a quanto pare, di non difficile coltivazione. Morto a soli 35 anni senza aver pubblicato nulla, il botanico inglese Edmund Davall - visse però gran parte della sua vita adulta in Svizzera - non avrebbe lasciato molte tracce di sè se non fosse stato amico e assiduo corrispondente di James Edward Smith, presidente e fondatore della Linnean Society. Una selezione delle sue lettere, pubblicata nelle memorie di Smith, ci fanno conoscere da vicino questo giovane di grande sensibilità e humour, un vero figlio del preromantcismo diviso tra l'entusiasmo per la natura e la malinconia di quello che considerava un vero e proprio esilio. Grazie a Smith, a ricordarlo ci sono soprattutto le bellissime felci del genere Davallia. Una vita attraverso le lettere Nel 1832, la vedova di James Edward Smith, Pleasance Reeve Smith, completò e pubblicò le memorie del defunto consorte, che includono una scelta della sua ampissima corrispondenza. Come sottolineava Mme de Lessens nella sua recensione di Memoirs and Correspondence of Sir James Edward Smith, "tra i corrispondenti più gradevoli di Mr. Smith, c'è un giovane svizzero, Mr. Davall di Orbe, entusiasta della botanica, della natura e del grande apprezzamento che ricevono in Inghilterra. Le sue lettere sono assai piacevoli". Queste lettere sono quasi tutto ciò che rimane di questo sfortunato botanico, morto troppo presto e senza aver potuto pubblicare nulla. Al contrario di quanto scrive Mme de Lessens, Edmund Davall (1762-1798) non era propriamente svizzero, ma piuttosti anglo-elvetico. Era infatti nato a Londra dall'omonimo Edmund Davall, ufficiale di approvvigionamento dell'ammiragliato, e da Charlotte Thomasset, figlia di una vedova svizzera che si era trasferita nella capitale inglese dove insieme alle sue figlie gestiva con un certo successo una scuola per giovinette. Come racconta egli stesso in una delle sue lettere al "più caro degli amici" Smith, benché avesse un'inclinazione per le scienze naturali, il loro studio non aveva fatto parte della formazione del giovane Edmund. Si interessava però di giardinaggio, e aveva acquistato una copia di The Gardeners Calendar di Miller, dove per la prima volta vide uno schema del sistema linneano, Ne fu "istantaneamente ispirato" e decise di "perseguire uno studio che certamente mi avrebbe procurato maggior felicità di qualsiasi progetto volto a un vantaggio pecuniario". Iniziò dunque a studiare la botanica da autodidatta e nel febbraio 1784 arrivò in Svizzera, deciso a esplorare la flora delle sue montagne. Si stabilì a Orbe, nella casa delle sue numerose zie Thomasset che erano tornate in Svizzera intorno al 1777; pochi mesi dopo, il padre morì in seguito a un'ampitazione e la madre decise di tornare in patria. Quattro anni dopo sarebbe morta anche lei, lasciando definitivamente legato il figlio a Orbe e alle "buone vecchie zie", di cui nelle lettere egli traccia un memoriabile ritratto dolce-amaro. Se in Inghilterra erano considerate povere, in Svizzera un piccolo patrimonio e qualche terra al sole le facevano senz'altro rientrare nella "bonne societé". Amavano ricevere e trascorrevano ore intere a giocare alle carte. A sentire il nipote, il jeu de Quadrille era la loro unica passione e il loro unico argomento di conversazione, al punto che una di loro sarebbe "letteralmente morta con le carte in mano". La migliore stanza della casa era dedicata alle interminabili partite di carte che riunivano il "gregge troppo numeroso" della buona società di Orbe, "eternamente desideroso di ammazzare il tempo che non sapeva come impiegare" e che esprimeva "la sua stima per chi aveva interessi intellettuali con un'alzata di spalle". Per sfuggire alla noia, Davall si gettò più che mai nella botanica. Creò un giardino che curava personalmente e intensificò le escursioni alla ricerca di piante da trapiantare e da montare nel suo erbario. Orbe sorge in un'amena posizione nel cuore del Giura svizzero; con una breve passeggiata si può raggiungere la cima del Suchet, dalla quale si gode uno splendido panorama sugli altopiani del Giura e su tutto l'arco alpino. Sulle sue pendici calcaree Davall trovò una flora particolare e interessante. Nell'estate del 1787 scoprì alcune piante rare in compagnia di Albrecht von Haller junior, il figlio omonimo del grande von Haller. Davall avea infatti cominciato a farsi conoscere nell'ambiente dei botanici svizzeri, in ciò incoraggiato da Charles Victor de Bonstetten, ultimo balivo di Nyon e membro del "gruppo di Coppet", un sodalizio intellettuale informale che si riuniva attorno a Mme de Stael e Benjamin Constant. Entrò così in contatto con il pastore e naturalista di Berna Jakob Samuel Wyttenbach, con il pastore, bibliotecario e botanico di Ginevra Jean Senebier e con il professore di anatomia e botanica dell'Università di Basilea Werner de Lachenal. Saussure nel suo Voyage dans les Alpes ricorda di avergli fatto visita ad Orbe. Nel 1784, munito di lettere di presentazione di Wyttenbach e Senebier, Davall partì per Londra e si presentò a James Edward Smith che aveva da poco creato la Linnean Society. Smith lo accolse con grande affabilità, lo ospitò in casa sua, lo presentò ai suoi amici e lo fece entrare nella Linnean Society, di cui Davall fu così uno dei primissimi membri. Da parte sua, Davall intodusse Smith presso la marchesa di Rockingham, con la quale forse era in contatto grazie alla posizione del padre all'ammiragliato. La nobildonna, grande appassionata di piante esotiche, avrebbe poi ispirato a Smith le magnifiche Icones pictae, in cui Sowerby ritrasse numerose piante coltivate nelle serre e nei giardini di Hillingdon. I giardini inglesi con le loro collezioni di piante esotiche, le società scientifiche con le loro animate discussioni, la grande considerazione in cui era tenuta la botanica entusiasmarono Davall e fecero del soggiorno londinese "il periodo più memorabile e felice della mia vita", nonostante cominciassero già amanifetarsi imprimi segni di una salute malferma. Lui e Smith erano quasi coetanei e strinsero una profonda amicizia, destinata a durare quanto la sua vita, anche se dopo il suo ritorno a Orbe non si sarebbero mai più incontrati. Continuarono invece a scriversi con assiduità; le lettere di Davall, pervase dall'entusiasmo e dal sentimento religioso per la natura, ma anche da quello che egli stesso definisce mal du pays, ovvero dalla nostalgia per l'Inghilterra, piacevolissime e spesso piene di humour, informano di gioie e dolori (il matrimonio, la nascita dei figli, la dolorosissima morte della primogenita a soli undici mesi), dei fastidi di una piccola vita di provincia, delle aspirazioni intellettuali presto frustrate da un ambiente chiuso, dalle necessità pratiche, ma soprattutto da una salute sempre più traballante. Nella casa di Orbe, dove il salotto buono rimaneva intoccabile santuario all'eterno gioco di carte, poté ricavare per sè solo un piccolo studio, dove un "angolo sacro" riuniva le opere di Linneo, il suo modesto erbario e due prezosi cimeli incorniciati sotto vetro: un esemplare di Diapensia lapponica, raccolto da Linneo in persona, dono dell'amico Smith ("un frammento della vera croce è meno prezioso per un cattolico bigotto"), e uno di Smithia sensitiva. Una grande fonte di piacere era il giardino, che egli coltivava di persona dedicandogli molto tempo e cura; e un'altra le escursioni botaniche in montagna. Ne riportava piante per il suo giardino ed esemplari che essiccava per il suo erbario e che spediva regolarmente all'amico Smith. Visitò ripetutamente il Suchet, ma le lettere documentano anche viaggi a più ampio raggio: attraversò il ghiacciaio di Valsorey nel Vallese alla ricerca di una pianta segnalata da von Haller e si spinse fino al Gran San Bernardo. Sappiamo che lavorò a lungo a un saggio sulla flora svizzera, ma non riuscì a terminarlo. Più ancora delle contingenze della vita materiale, a impedirglielo furono i problemi di vista sempre più gravi e una salute sempre più precaria. Le lettere stesse incominciarono a diradarsi. Davall iniziò l'ultima il 13 febbraio 1798. Ma ormai stava così male che non poté finirla; Smith l'avrebbe ricevuta solo dopo la sua morte. Certo avrà letto con grande commozione le ultime righe: "a lungo la mia più cara e unica speranza è stata quella di incontrare il mio amico in un mondo diverso e migliore". A informarci degli ultimi mesi di Davall sono le lettere a Smith di un altro amico comune: il veterinario Bracy Clark. Tra il 1797 e il 1798 egli fu impegnato in un grand tour continentale, anche se le condizioni di guerra gli impedirono di visitare la Francia. Soggiornò invece per qualche tempo in Svizzera; nel dicembre 1797 a Berna fece visita a Wyttenbach che lo informò che l'amico di Smith Davall aveva sofferto gravemente, forse di una paralisi, e gli scrisse una lettera di presentazione per lui. Il cattivo tempo e copiose nevicate impedirono a Clark di recarsi ad Orbe fino alla fine di marzo. Davall lo accolse cordialmente e lo ospitò a casa sua; era assai provato nel corpo e profondamente turbato dalla situazione politica, con i venti della rivoluzione che soffiavano anche in Svizzera. Durante l'estate, che Clark trascorse per lo più a Orbe, sembrò migliorare; poi la situazione precipitò e il 27 settembre Davall morì, ad appena 35 anni. Onorando le sue ultime volontà, la vedova fece pervenire a Smith la lettera mai terminata, l'erbario, i libri e i manoscritti del marito. Quest'ultimi sono tuttora conservati nella biblioteca della Linnean Society, mentre l'erbario è andato perduto. Nel pubblicare la corrispondenza di Davall con il marito, Pleasance Reeve scrive: "Assomigliava all'amico scelto dal suo cuore nel calore e nella devozione degli affetti, ma poté resistere meno di lui ai mali della vita. Molti passi delle lettere [...] mostrano il valore, la tenerezza, il raro affetto, la devozione alla scienza, il suo amore per la natura strettamente legato all'amore di Dio [...]. Se qualcuno considerasse [questi sentimenti] troppo acuti o riprovevoli, si ricordi che «quei teneri desideri che assorbivano la sua anima, logoravano il suo spirito, minavano la sua salute», erano i dolori di un uomo esiliato. Lasciamo che coloro che possono comandare a piacimento tanto il piacere quanto la società contemplino con profonda compassione il generoso e disinteressato Davall".  Rizomi con la pelliccia Nella speranza che l'amico con le sue opere occupasse prima o poi il posto che gli spettava nella scienza delle piante, fin dal 1793 Smith aveva provveduto ad eternarne il nome con la dedica del genere Davallia, scrivendo: "Ho dedicato questo nuovo genere con grandissimo piacere al botanico instancabile e acutissimo, amabile di carattere, così come illustre per scienza, Edmund Davall, membro della Linnean Society, che vive in Svizzera". Gli dedicò anche Carex davalliana, una specie che cresceva copiosa nelle aree unide di orbe e che Davall aveva distinto per primo. Al contrario della insignificante Smithia - una dedica lievemente maligna, come ho raccontato in questo post, di cui il presidente della Linnean Society avrebbe volentieri fatto a meno - il genere dedicato all'amico del cuore è davvero un dono sontuoso. Davallia è l'unico genere della famiglia Davalliaceae (alcuni studiosi però preferiscono classificarla nelle Polypodiaceae, intese in senso largo) e raggruppa una cinquantina di specie di felci epifite o litofite delle aree tropicali e subtropicali del Vecchio mondo e dell'Australia. La caratteristica più evidente sono i lunghi rizomi aerei grazie ai quali si abbarbicano sulla corteccia degli alberi o si insinuano nelle fessure delle rocce. Intricati e solitamente ricoperti da fitte squame simili a una pelliccia, le hanno guadagnato nomignoli come "felce ragno", "felce zampa di coniglio", "felce zampa di scoiattolo". Curiose e molto decorative, diverse specie sono apprezzate come piante da interni. Alcune però sono rustiche e possono essere coltivate in giardino. È il caso della giapponese D. mariesii, una piccola felce decidua con sottili rizomi pelosi e fronde triangolari, che può essere utilizzata come coprisuolo in angoli ombrosi e umidi. Meno resistente al freddo è invece D. canariensis, una specie originaria della Macaronesia e del Mediterraneo occidentale (Marocco e penisola iberica occidentale), che in natura cresce sui tronchi e i rami degli alberi e sulle rocce silicee umide e muschiose, soprattutto dove può godere dell'umidità oceanica. Da noi viene solitamente coltivata in vaso o anche su zattera o bark per orchidee, in modo da godere dell'intrico delle radici che si interesecano e pendono al di fuori. Tra le specie solitamente coltivate all'interno, la più nota è probabilmente D. solida var. fejeensis, originaria delle isole Figi, un'epifita caratterizzata da rizomi densamente ricoperti da squame grigio-rosate e da brevi fronde triangolari. Per mettere in risalto la bellezza dei rizomi, è spesso coltivata in cestini appesi, così come D. tyermannii, originaria della Cina e dell'Asia orientale, nota anche come felce tarantola o felce ragno per l'intrico di lunghi rizomi pelosi che evocherebbero a questi animali. A Bex i Thomas non erano i soli a raccogliere piante e a commercializzare campioni d'erbario e semi di piante alpine. A far loro concorrenza, negli ultimissimi anni del Settecento e nei primi due decenni dell'Ottocento, c'era il farmacista di origini tedesche Johann Christoph Schleicher, che fu il primo ad avere l'idea di pubblicizzare il suo commercio prima con annunci in riviste scientifiche, poi con un catalogo che comprendeva circa 2000 piante e giunse a quattro edizioni. Pubblicò anche a più riprese cataloghi specifici per le crittogame. Per qualche anno ottenne un notevole successo, come testimonia la presenza dei suoi campioni negli erbari di moltissime istituzioni e di qualche pianta nata dai suoi semi nei cataloghi dei vivai inglesi. Poi si fecero sentire l'età e la concorrenza del molto più giovane e aguerrito Emmanuel Thomas, tanto che fu costretto a vendere il suo erbario e terminò i suoi giorni in miseria. Oltre all'eponimo di diverse specie, lo ricorda il genere asiatico Schleichera (Sapindaceae). 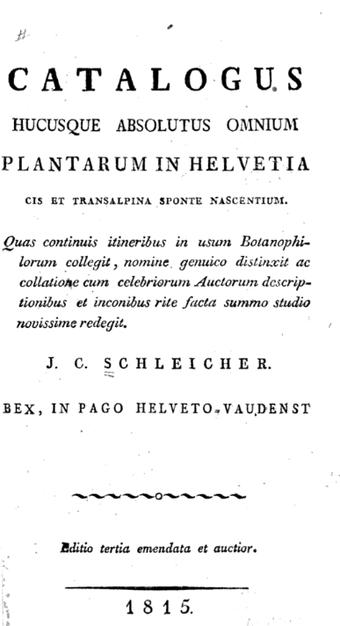 Campioni d'erbario e semi a modico prezzo Intorno al 1790, si stabilì a Bex nel Vaud un giovane di origine tedesca, Johann Christoph Schleicher (1768/70-1834), che nella nuova patria si sarebbe fatto chiamare anche Jean Charles. Talvolta viene definito dottore, ma era piuttosto farmacista, e difficilmente, per la giovane età, avrà avuto una formazione completa. Dei suoi primi anni sappiamo pochissimo. Incerta è la stessa data di nascita, 1768 secondo alcune fonti, 1770 secondo altre. Nato a Hofgeismar nell'Assia da Anna Marie Sawitzky, ebbe inizialmente il cognome materno per poi assumere quello con cui è noto quando fu adottato da un certo Carl Schleicher. Nulla sappiamo della sua formazione; secondo varie fonti, incluso il data base biografico dell'Università di Gottinga, il botanico Heinrich Schräder sarebbe stato il suo padrino; la notizia è certamente priva di fondamento per banali ragioni anagrafiche: i due erano praticamente coetanei, essendo nato Schräder nel 1767. Al momento dell'arrivo di Schleicher, a Bex il ricordo (e il magistero) di Albrecht von Haller era tenuto vivo, oltre che dall'attività commerciale della famiglia Thomas, dai medici Bernard Jean François e Jean David Ricou. Bernard Jean François Ricou (1730-1798), medico cittadino, farmacista e capo chirurgo dell'ospedale, negli anni '50 era stato uno dei raccoglitori di von Haller, per il quale aveva erborizzato nelle valli di Saint-Nicolas e di Bagnes e nelle regioni del Sempione, del Gran San Bernardo, di Alesse e di Fully. Nel 1764, insieme al pastore Abram-Louis Decoppet, pubblicò nelle "Memorie della società economica" di Berna una lista di 128 piante della flora elvetica con i nomi in dialetto, francese e latino (Essai d'une collection de noms vulgaires ou patois des principales plantes de Suisse). Certamente si deve a lui la creazione del "bell'erbario" segnalato nel 1804 nella guida della Svizzera di Johann Gottfried Ebel, all'epoca di proprietà del figlio Jean David, anch'egli medico. Schleicher dovette legarsi strettamente alla famiglia Ricou (probabilmente lavorò per loro come aiuto farmacista e nel 1797 sposò Julie, figlia di Jean David) e fu probabilmente l'esempio delle raccolte di Bernard Jean François a spingerlo a sua volta a percorrere le montagne alla ricerca di piante rare. Il suo scopo era chiaramente commerciale: l'opera di von Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici e degli amatori sulla flora elvetica e il mercato di campioni d'erbario era fiorente. Dotato di notevole spirito imprenditoriale, ispirato dall'esempio di raccoglitori di piante tedeschi, già nel 1794, nel numero 41 della rivista di Lipsia "Annalen der Botanik" Schleicher, sotto forma di lettera ai signori Le Royer e Tingry, proprietari di un'importante farmacia di Ginevra, offrì in vendita, al prezzo di 2 talleri francesi, una centuria di piante svizzere, assicurando la consegna in 4-6 settimane. Altre due centurie avrebbero fatto seguito nel numero successivo, pubblicato lo stesso anno. Nel 1796, ancora su "Annalen der Botanik" la snelle centurie si trasformarono in una più ambiziosa lista di quasi 700 "piante raccolte nel Vallese e nelle Alpi vicine nel 1795 da Schleicher", indicate con un nome binomiale, preceduto però (tranne un'appendice di una quarantina di specie scoperte successivamente alla pubblicazione di quest'opera) dal numero con cui compaiono in Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata di von Haller; non compaiono più né prezzi né indicazioni esplicite del fine commerciale, non perché Schleicher avesse cambiato intenzioni, ma probabilmente perché aveva ormai una clientela consolidata. Due anni dopo, sempre sulla stessa rivista, comparve una seconda lista sotto il titolo "Indice delle piante raccolte nel Vallese e nella Svizzera transalpina nel 1796 da C. Schleicher"; le modalità erano le stesse, ma la lista si era allungata, passando da 9 a 12 pagine, e, soprattutto, ora compariva a parte un elenco di 84 Musci & Algae (in realtà ci sono anche felci e numerosi licheni). Si trattava di un nuovo segmento di mercato che, come vedremo, sarebbe diventato una specialità del raccoglitore tedesco. Poi, nel 1800, il salto di qualità. Con quello che dovette essere un notevole impegno anche finanziario, Schleicher pubblicò a Bex quello che è considerato il primo catalogo commerciale di piante svizzero, Catalogus plantarum in Helvetia cis- et transalpina sponte nascentium; il sottotitolo precisa: "raccolte dall'autore con continui viaggi ad uso dei botanofili e verificate con sommo studio sulle descrizioni e le immagini degli autori più celebri". Nel volumetto di una settantina di pagine sono elencate circa 2000 piante, con il nome binomiale seguito dal nome d'autore e preceduto, nella maggior parte dei casi, dal rinvio numerico all'opera di Haller. Mentre le felci sono elencate nel catalogo generale, sono presentate nuovamente a parte alcune centinaia di Musci, Algae et Fungi. A chiudere il catalogo, una selezione di semi "raccolti e offerti da Schleicher"; come facevano anche i Thomas, anche i semi, come i campioni d'erbario, erano per lo più raccolti in natura. Anzi, da questo punto di vista sembra che Schleicher non andasse tanto per il sottile; secondo una nota pubblicata nel "Bulletin de l’Association pour la protection des plantes" del 1884, "distrusse [appositamente] diverse specie al solo scopo di aumentare il valore dei campioni che vendeva agli erbari, rendendole rare". Almeno alcune piante tuttavia dovevano essere coltivate nell'orto botanico che Schleicher aveva creato a Bévieux, non lontano dalla salina. Sempre secondo la guida di Ebel, meritava una visita; dopo aver parlato dell'erbario di Ricou, egli ci informa inoltre che "Suo genero M. Schleicher, abile erborizzatore che ha percorso gran parte delle montagne della Svizzera occidentale e meridionale, ha un consideravole magazzino di piante essiccate che vende per un luigi il centinaio. Ha scoperto una quantità di specie prima sconosciute in Svizzera". Per qualche anno il commercio di piante di Schleicher dovette andare a gonfie vele; numerosi suoi campioni sono presenti nei principali erbari europei; era in corrispondenza con molti importanti botanici (vendette molti esemplari a Balbis e ci è rimasta una lettera a Persoon); forniva semi al celebre vivaio londinese Loddiges che lo cita come fornitore di varie piante alpine offerte per la prima volta sul mercato britannico. L'ampliamento dell'offerta è testimaniato dalle successive edizioni del catalogo (1807, 1815, 1821, le ultime due con il titolo Catalogus hucusque absolutus omnium plantarum in Helvetia cis et transalpina sponte nascentium), e da una serie di cataloghi specifici, uno riservato ai salici (1807) e diversi alle crittogame (Plantae Cryptogamicae Helvetiae 1803-1807), parzialmente riprodotti nella rivista diretta da Schräder "Neues Journal für die Botanik", nella quale nel 1805 Schleicher pubblicò anche il resoconto di un viaggio nella Svizzera italiana. Nelle liste delle crittogame si precisa che esse erano state reccolte e essicate da Schleicher; la precisazione è significativa se considerimo che al raccoglitore tedesco si deve l'introduzione del sublimato corrosivo (cloruro di mercurio) per la trattazione dei campioni d'erbario. Tra riedizioni, supplementi e cataloghi specifici, le pubblicazioni si intensificarono tra il 1803 e il 1808, poi intorno al 1815 il successo dovette cominciare a declinare. Ne è spia la curiosa iniziativa che Schleicher prese nel 1816: una lotteria il cui premio era costituito da exsiccata. Probabilmente, incominciava a farsi sentire la concorrenza dei fratelli Thomas, che avevano pubblicato il loro primo catalogo intorno al 1806. Seguendo il loro esempio, nel catalogo del 1815, Schleicher aggiunse all'offerta minerali e plantule di conifere; c'erano anche campioni di erbario di piante esotiche, provenienti da Francia meridionale, Italia e Ungheria, e prezzi differenziati: cento esemplari costavano 36 lire francesi per acquisti di meno di 200 campioni, 30 lire da 200 a meno di 400, solo 24 lire da 400 in su. Offriva inoltre erbari completi della flora Svizzera, collezioni di piante medicinali, i semi di "tutte le piante che si coltivano o si possono coltivare in giardino" al costo di 24 lire il centinaio, piante a radice nuda pronte da piantare a 6 soldi l'una quelle erbacee, 9 soldi quelle arbustive e arboree. L'offerta non finiva qui. Leggiamo infatti: "Quest'anno e i seguenti, se Dio vorrà, a casa mia nel villaggio subalpino di Bex, darò lezioni di botanica - un corso completo di questa scienza - ai giovani botanici che me ne faranno richiesta. Quando il tempo lo permetterà, accompagnerò gli allievi in escursioni botaniche, non solo perché vedano e raccolgano le piante nel loro luogo natale, ma anche perché osservino con me le caratteristiche della flora d'altitudine. Mostrerò loro il metodo per essiccare le piante durante il viaggio stesso, in modo che conservate nel modo più perfetto possano ornare l'erbario". Lezioni in lingua francese e prezzi da concordare. Sei anni dopo, nella quarta e ultima edizione, escursioni botaniche e lezioni private non ci sono più (ora Schleicher era sulla cinquantina, e probabilmente non se la sentiva più). Scompaiono anche i minerali, mentre rimangono inalterati prezzi e offerta di exisiccata, erbari completi, semi e piante vive. Compare invece una nuova postilla che ci informa su cosa coltivasse Schleicher nel suo giardino botanico: "Oltre alle piante svizzere, coltivo un grande numero di sassifraghe esotiche, indicate in una speciale appendice in calce al catalogo. In questo giardino spuntano già diverse specie dei generi Aconithum, Delphinium, Narcissus e Allium di cui gli amanti di questi generi possono trovare presso di me un catalogo annuale, sia delle specie che possiedo sia di una moltitudine di piante esotiche che giungono per scambi con gli amici". Non abbiamo traccia di questi cataloghi annuali (erano forse manoscritti? o non furono mai realizzati?). In ogni caso, gli anni felici erano orami alle spalle. Vecchio e malato, Schleicher non poteva più salire in montagna e per sopravvivere dovette smantellare il suo prezioso erbario personale. Contrasse molti debiti; tra i suoi creditori c'era anche Emmanuel Thomas, al quale fu costretto a cedere, come pagamento, tutte le crittogame dell'erbario e diversi generi di fanerogame. Nel 1832 si rivolse al Consiglio di Stato per mettere in vendita quanto rimaneva: "Dal momento che la mia età e la mia salute non mi consentono più di salire in montagna e di continuare il mio commercio di piante, mi vedo costretto a vendere la mia biblioteca e il mio erbario per vivere". Le autorità incaricarono della perizia il direttore delle saline Jean de Charpentier, che provvide con l'assistenza dell'amico Emmanuel Thomas; nella sua relazione, emerge che l'erbario delle piante straniere (circa 10.000) "un tempo veramente magnifico, ha considerevolmente perso valore perché ne sono state tolte le specie più rare e interi generi"; per contro, il lotto di 4073 specie e varietà della flora svizzera "era ed è ancora unico nel suo genre, perché è senza discussione la collezioni più completa e curata della Svizzera. Vi si trovano non solo le piante selvatiche, ma anche le variazioni che subiscono in coltivazione". La vendita andò in porto e l'erbario delle fanerogame fu acquistato dal Museo di scienze naturali di Losanna. Schleicher investì una parte del ricavato per riscattare gli esemplari che aveva dovuto cedere a Emmanuel Thomas. Morì due anni dopo, nel 1834; nel 1837 gli eredi vendettero allo stesso museo l'erbario delle crittogame. La parte più preziosa di questa collezione è costituita dai licheni; nella proposta d'acquista dei conservatori del museo leggiamo: "Questa collezione, composta da più di 1060 campioni, la maggior parte su pietra o legno, è preziosa da ogni punto di vista [...]. Ha grande valore agli occhi dei botanici perché i campioni sono stati determinati con cura e perché è il frutto del lavoro di molti anni ed ha potuto essere formata solo a prezzo di pene, cure e spese".  Dalla Svizzera all'Asia sud-orientale Il significativo ruolo per la conoscenza della flora elvetica di questo farmacista divenuto cacciatore e commerciante di piante alpine è testimoniato dalla sua notevole presenza nella nomenclatura botanica. In primo luogo, anche se i suoi cataloghi sono meri elenchi, grazie al riferimento numerico alla flora di Haller (che, lo ricordo, usava nomi polinomiali, quindi non validi) ha introdotto alcuni nomi validi, come Hieracium canescens e Cnicus nudiflorus. Più numerose le denominazioni risalenti a lui ma introdotte attraverso altri autori che lo conobbero, erborizzarono con lui o furono sui clienti, come Campanula excisa introdotto da Murith, Phyteuma umile, Pedicularis ascendens e Festuca valesiaca introdotti da Gaudin, Lotus alpinus introdotto da Ramond. Una ventina di taxa portano in suo onore gli epiteti schleicheri e schleicherianus; si tratta di specie delle Alpi elvetiche per lo più presenti nei suoi cataloghi o nel suo erbario, ma in qualche caso anche da lui introdotte nei giardini britannici attraverso i vivai che acquistavano i suoi semi. Quattro sono tuttora validi: Alpagrostis schleicheri, Erigeron schleicheri, Fumaria schleicheri, Rubus schleicheri. Nel 1806 Willdenow, direttore di uno degli orti botanici cui forniva campioni e sementi, quello di Berlino, gli dedicò il genere Schleichera, purtroppo senza esplicitare la motivazione; si limitò infatti a scrivere "Ho nominato questo genere in memoria del celebre Schleicher, svizzero". Con questo genere monotipico della famiglia Sapindaceae ci allontaniamo dalle Alpi svizzere per spostarci sulle pendici dell'Himalaya, sull'altopiano del Deccan e nelle foreste del sudest asiatico. Il suo unico rappresentante S. oleosa è infatti un albero tropicale presente soprattutto nelle aree aride e aperte del subcontinente indiano, di Ceylon, della Thailandia e dell'Indonesia. L'epiteto è dovuto all'alto contenuto di olio dei suoi semi; quest'ultimo, noto come olio di kusum, dal nome più comune della pianta in India, viene utilizzato per la cura dei capelli, ma anche come combustibile, in cucina e come unguento medicinale. Lo svizzero Albrecht von Haller fu una delle personalità più eminenti del secolo dei Lumi. Come poeta, ha mutato il modo di vedere la montagna, ha influenzato il sentimento romantico della natura e lanciato la moda delle escursioni alpine; come medico, ha distinto le funzioni dei nervi da quella dei muscoli e dato la prima descrizione completa delle funzioni del corpo umano; genio universale, poligrafo, giornalista e polemista, i suoi scritti si contano a migliaia, incluse le 9000 recensioni di pubblicazioni su argomenti che vanno dalla filosofia alla religione alla politica alla letteratura alle scienze naturali; ha influenzato il pensiero di personalità tanto diverse tra loro come Kant, Schiller e Hegel. Come botanico, ha donato alla Svizzera la flora più completa del suo tempo. Non era né amabile né modesto, anzi adorava la polemica, e Linneo era uno dei bersagli preferiti dei suoi strali; tuttavia non gli ha fatto mancare la dedica del vistoso genere Halleria. 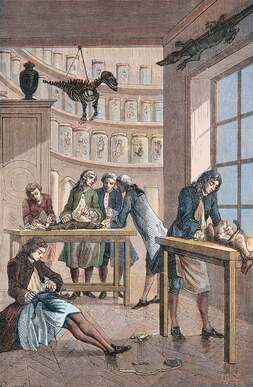 Poeta, fisiologo, bibliografo... Nel luglio 1777, di ritorno da Parigi, dove si era recato anche per risolvere l'imbarazzante situazione matrimoniale della sorella Maria Antonietta (a sette anni dalle nozze, mancava ancora un erede, per una ragione molto semplice: il matrimonio non era mai stato consumato), l'imperatore Giuseppe II passò da Berna. Viaggiava in incognito, sotto il nome di conte di Falkestein, e fece visita a una sola persona: il medico e scienziato Albrecht von Haller (1708-1777); tralasciò invece Ferney, con grande disappunto di Voltaire. Haller era da tempo malato (sarebbe morto pochi mesi dopo) e ricevette l'augusto e inatteso il visitatore in veste da camera e berretto da notte, semisdraiato su una bergère. L'imperatore conversò con lui per oltre un'ora, riconoscendo in quel vecchio piegato dalla malattia almeno lo spirito che l'aveva reso uno degli uomini più ammirati dell'Europa dei Lumi. A commento dell'episodio, nella mostra che il Museo storico di Berna dedicò al più illustre dei bernesi in occasione del trecentenario della nascita leggiamo: "Il segno di ammirazione più prestigioso gli fu tributato dall'imperatore d'Austria Giuseppe II che andò a fargli visita nella sua casa di Berna". E prosegue: "Un erudito universale e enciclopedico: Albrecht von Haller fu uno degli ultimi a poter abbracciare tutte le conoscenze del suo tempo". La sua cultura era vastissima e la sua opera ha lasciato un'impronta profonda nei campi più disparati: come poeta e cantore delle Alpi, mutò la concezione della montagna e lanciò la moda del turismo alpino in Svizzera; come medico, gettò le basi della moderna fisiologia del corpo umano; come botanico, scrisse la prima flora completa della Svizzera. Ma si occupò anche politica, della relazione tra scienza e fede, scrisse tre romanzi, creò una delle biblioteche più importanti d'Europa (ben 23.000 volumi). La sua corrispondenza conta quasi 17.000 lettere, scambiate con 1.139 corrispondenti. Haller (per quarant'anni non ci sarà alcun von davanti al suo cognome) era figlio di un avvocato e funzionario; dopo la formazione iniziale nella città natale, adolescente iniziò gli studi di medicina a Tubinga, poi li continuò a Leida dove fu allievo del grande Boerhaave, che gli trasmise un metodo strettamente sperimentale. A Leida incontrò un altro svizzero affamato di conoscenza, lo zurighese Johannes Gessner, con il quale strinse una fervida amicizia. Dopo la laurea nel 1727, approfondì gli studi di medicina a Londra e a Parigi; qui assistette a molti interventi chirurgici, praticamente tutti mortali, e decise che non sarebbe stato chrirugo, ma anatomista. A Parigi ritrovò anche Gessener, con il quale andò a Basilea per seguire i corsi di matematica di Bernoulli e nell'estate fece un memorabile viaggio a piedi nel Giura e nelle Alpi. Reduce dal soggiorno parigino, fu profondamente colpito dalla maestosità delle Alpi e dalla semplicità della vita dei loro abitanti, che contrapponeva a quella artificiosa e corrotta dei cittadini; sono i sentimenti che ispirarono il più celebre dei suoi poemi, Die Alpen ("Le Alpi"), scritto nel 1729. Come vedremo meglio più avanti, l'incontro con le montagne fu anche quello con la flora alpina. Per qualche anno fu attivo come medico a Berna, dove creò un teatro anatomico, ma non ebbe molto successo; dal 1735 fu bibliotecario della città. Anche se aveva già iniziato le ricerche di fisiologia e botanica che lo avrebbero reso famoso, in questi anni era noto soprattutto come poeta (è del 1732 la raccolta Versuch schweizerischer Gedichte): la sua è una poesia filosofica, in cui riflette sulla fede e sui limiti della ragione, sull'origine del male, sull'eternità. Aspirava a una carriera politica e polemizzò ferocemente contro la corruzione e la degenerazione oligarchica del governo della sua città; ciò finì per chiudergli tutte le porte. Nel 1736, quando le sue candidature a medico cittadino e professore di eloquenza furono respinte, decise di accettare la cattedra di anatomia, chirurgia e botanica all'Università di Gottinga. L'università Georg-August era appena nata (era stata fondata due anni prima dall'elettore di Hannover, ovvero dal re d'Inghilterra Giorgio II), Gottinga era ancora una cittadina di provincia, non mancarono le difficoltà e i lutti privati (la morte delle prime due mogli), ma si respirava un'atmosfera aperta di libera ricerca. Haller creò il teatro anatomico, l'orto botanico e la prima clinica ostetrica di Germania. Come insegnante, attirò frotte di studenti da tutta la Germania. All'insegnamento poté affiancare un'ampissima attività sperimentale; grazie a non meno di 350 autopsie e a esperimenti sistematici sugli animali (purtroppo sì, su di essi praticava la vivisezione) diede una descrizione completa del sistema arterioso, approfondì le conoscenze sulla respirazione e lo sviluppo del feto e dimostrò che l'irritabilità è dovuta ai muscoli e la sensibilità ai nervi. Cominciarono a susseguirsi una serie di opere monumentali, a cominciare dai sette volumi di Erläuterungen zu Boerhaaves Institutiones (1739-1744) e dagli otto fascicolo delle Icones anatomicae (1743-1756), per culminare con gli otto volumi di Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766). In questo testo di riferimento fondamentale, riedito fino all'inizio del Novecento, che lo fece salutare "padre della fisiologia", diede una descrizione completa delle strutture del corpo umano e delle loro funzioni. Non meno importante il suo ruolo come organizzatore culturale. Nel 1747 fu nominato direttore scientifico della rivista Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, che nel 1752 mutò il titolo in Göttingische Gelehrte Anzeigen e dal 1753 divenne l'organo della Società reale delle Scienze di Gottinga. Di quest'ultima, fondata nel 1751 per volontà di Giorgio II, fu uno dei soci fondatori e presidente a vita. La rivista, seguitissima anche al di fuori della Germania, aveva (anzi ha, visto che ancora esiste ed è la più antica rivista scientifica di lingua tedesca ancora in attività) carattere universalistico e pubblicava recensioni critiche delle pubblicazioni tedesche e straniere in campo letterario, scientifico, economico, storico, ecc. Per Haller divenne la palestra dove esercitare il suo sapere enciclopedico e il suo spirito critico (e non di rado la sua vis polemica). Continuò a scrivervi anche dopo il ritorno a Berna, pubblicando più di 9000 recensioni. Inoltre collaborava con moltissime altre riviste scientifiche, sulle quali pubblicava soprattutto articoli di medicina e botanica. La fama e gli onori incominciarono a moltiplicarsi. Nel 1743 fu ammesso alla Royal Society, nel 1747 all'Accademia delle Scienze svedese; le università di Oxford e Utrecht gli offrirono una cattedra, le rifiutò così come l'invito di Federico II a trasferirsi a Berlino. Accolse invece con soddisfazione il cavalierato e il titolo onorifico di medico di corte conferitogli da Giorgio II e il titolo nobiliare che venne dall'imperatore Francesco. Ma il suo vero sogno era tornare in patria e ottenere il meritato riconoscimento di una carriera pubblica. Fin dal 1745, benché risiedesse a Gottinga, era membro del Gran consiglio della città e nel 1753, rifiutato per la seconda volta l'invito di Federico II, tornò a Berna. Come si sa, nemo profeta in patria. I maggiorenti della città non aveva dimenticato le satire politiche dell'età giovanile. Ottenne solo incarichi di secondo piano: dal 1753 al 1757 fu intendente di palazzo della città (Rathausammann); fu eletto presidente della Società economica e cofondatore dell'orfanatrofio. Nel 1758 fu nominato direttore delle saline di Roche nel Vaud e dal 1762 vicegovernatore d'Aigle; fino al 1764, quando l'incarico terminò, visse a Roche, dove ebbe modo di estendere i suoi studi ai modi più economici per ricavare il sale e poté riprendere le ricerche sulla flora alpina. Nel 1764 acquistò la signoria de Goumoens-le-Jux e assunse il nome di Haller von Goumoens. Fece poi ritorno a Berna. Tra il 1764 e il 1773, per ben nove volte, si candidò al Piccolo consiglio, ma non fu mai eletto. Nel 1769, fu richiamato a Gottinga nella veste di cancelliere, ma rifiutò in seguito alla nomina ad assessore perpetuo del Consiglio della sanità di Berna. A trattenerlo a Berna era anche la salute ormai compromessa. Da ragazzo, era stato malaticcio, ma poi le camminate e le scalate lo avevano reso un agile e vigoroso alpinista. A Göttingen, con il superlavoro, vennero l'insonnia, i mal di testa feroci, lo stomaco in disordine. Con l'età si aggiunsero verigini, artrite, gotta, obesità, una tormentosa infezione delle vie urinarie. Per ritrovare il sonno ed alleviare il dolore incominciò a ricorrere all'oppio; ne divenne dipendente e dovette assumerme quantità sempre maggiori. I suoi ultimi anni furono quelli di un valetudinario, precocemente invecchiato. Eppure riuscì ancora a scrivere un'altra opera gigantesca, la quattro Bibliothecae, in parte pubblicate postume: Bibliotheca botanica (1771-72), Bibliotheca anatomica (1774-1777), Bibliotheca chirurgica (1774-1775), Bibliotheca medicinae practicae (1788). Si tratta di una bibliografia completa, e spesso di un esame critico, di tutto ciò che era stato pubblicato su queste materie dall'antichità ai suoi tempi, per un totale di 52.000 titoli. Nei suoi ultimi anni, la maggiore preoccupazione di von Haller andava alla sorte della sua immensa biblioteca. Dopo la sua morte, gli eredi la vendettero al governo austriaco, a condizione che fosse mantenuta intatta; destinata alla Lombardia, fu invece smembrata tra varie biblioteche. I due fondi più consistenti sono conservati alla Braidense di Milano e alla biblioteca universitaria di Pavia, con circa 3000 volumi e altrettante dissertazioni. A Pavia era giunto anche l'immenso erbario di Haller; durante la Campagna d'Italia nel 1796 i francesi se ne appropriarono e fu portato a Parigi; dopo la caduta di Napoleone, il governo austriaco non lo reclamò (scarso interesse per la botanica?) e lì è rimasto. I suoi 59 volumi in folio sono oggi conservati all'Herbier national presso il Museum d'Histoire naturelle. 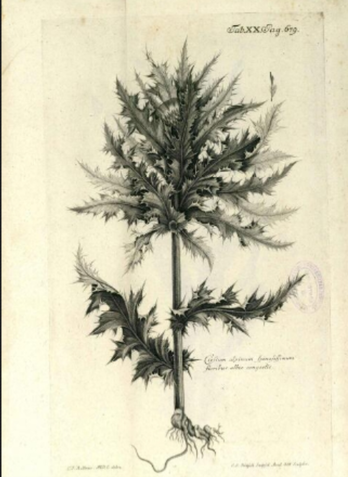 E botanico! Quel gigantesco erbario era frutto degli invii dei suoi numerosissimi corrispondenti, ma in larga parte anche delle raccolte dirette di van Haller che nella sola Svizzera compì almeno 25 escursioni botaniche. Infatti la botanica, dopo la fisiologia e l'anatomia, fu il campo scientifico cui più applicò il suo genio. Egli aveva trascorso l'infanzia in una piccola proprietà a circa cinque km da Berna, sulla riva dell'Aar, tra una collina e una foresta, un paesaggio amato che indirizzò i suoi futuri sentimenti verso la natura. All'epoca la botanica (dalle piante si ricavano gran parte dei medicamenti) faceva parte del bagaglio professionale di ogni medico, e certo Haller l'avrà studiata già a Tubinga, ma il primo contatto documentato avvenne a Leida, dove il venerato maestro Boerhaave nella stagione propizia aveva l'abitudine di iniziare ogni giornata didattica con una rituale visita all'orto botanico, circondato dai suoi studenti. La botanica era già una passione per l'amico Gessner, che prima di spostarsi a Leida aveva raccolto un erbario nello zurighese e sulle Alpi. È possibile che, quando studiavano insieme a Basilea, sia stato lui a proporre di percorrere a piedi i distretti alpini della Svizzera occidentale e centrale durante le vacanze accademiche, anche e soprattutto per raccogliere piante. Se fino ad allora per Haller il loro studio aveva fatto parte del necessario bagaglio professionale, quel viaggio fatidico ebbe il senso di una duplice scoperta: delle Alpi e dei loro abitanti, cantati nel suo celebre poema, e delle piante alpine. Dopo il ritorno a Berna nella primavera del 1729, Halle rcominciò a dedicare il tempo libero agli studi botanici; fece molte spedizioni, brevi o lunghe, in diverse valli alpine e fino alla sua partenza per Gottinga ogni anno dedicò a questi viaggi botanici almeno un mese delle vacanze estive. Per quest'uomo iperattivo e fondamentalmente asociale, che oggi definiremmo senza mezzi termini workaholic, le lunghe escursioni, le scalate anche impegnative, il contatto con la gente semplice della montagna, la raccolta e la metodica preparazione delle piante alpine aveva anche un forte valore terapeutico. Lettore compulsivo, accompagnava la ricerca sul campo con lo studio metodico di tutto ciò che era stato scritto e si andava scrivendo sulla scienza delle piante; aveva grande venerazione per i grandi botanici del passato, e in particolare per Tournefort, la cui opera a suo parere segnava un tale spartiacque che in Bibliotheca botanica intitolerà il primo tomo "Epoche prima di Tournefort" e il secondo "Da Tournefort ai nostri tempi". Tuttavia il suo approccio era totalmente diverso; anche in botanica era essenzialmente un empirico e rifiutava una netta gerarchia tra classi, ordini, generi. Il suo stesso concetto di specie era aperto e sfumato (e sorprendentemente moderno): al contrario di Linneo, che credeva nella fissità delle specie, immutate dal momento della creazione, egli aveva invece constatato che in natura la variabilità è la norma: non solo la vegetazione muta con l'ambiente e l'altitudine, ma la stessa pianta cresciuta in ambienti diversi, oppure in natura o in coltivazione, assume caratteristiche differenti. Strumento essenziale per studiare questa variabilità era l'erbario, dove raccoglieva molti esemplari della stessa pianta in diversi stadi di sviluppo raccolti in più località e habitat. Mentre andava preparando un'opera complessiva sulla flora svizzera, pubblicò su varie riviste scientifiche brevi articoli di argomento botanico o monografie su generi specifici, come De alii genere naturali (1745); infine nel 1742, diede alle stampe la prima versione della sua flora svizzera, Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, in due volumi, corredati da 24 eccellenti tavole disegnate dal pittore ginevrino Jean Huber e incise dall'artista di Gottinga G.D. Heumann. Mentre il suo amico Johannes Gessner fu uno due primi ad adottare il sistema linneano, Haller lo considerava del tutto lontano dalla natura; si sforzò dunque di creare un proprio sistema "naturale" basandosi su un insieme di caratteristiche, e in particolare la mancanza o la presenza di fiori e semi, le caratteristiche dei fiori e quelle dei semi. A inaugurare l'opera sono le tre classi delle "piante apetale prive di stami", ovvero alghe, funghi, licheni, "piante apetale prive di stami cospicui", ovvero muschi, licopodi, marsilie, "piante con semi prive di fiori e apici cospicui", ovvero le felci. Seguono le piante "dotate di petali e stami cospicui", suddivise in un numerose classi, generi e ordini (una categoria inferiore al genere, corrispondente grosso modo al sottogenere). Di ogni specie è data una breve diagnosi, che ne è anche il nome polinomiale, seguita dai sinonimi degli autori precedenti, una descrizione più dettagliata, informazioni sulla localizzazione e l'habitat (mai così attente e dettagliate in nessun autore precedente); concludono, ove noti, gli eventuali usi medici e economici. Rilevante per il gran numero di specie descritte e per l'attenzione riservata a distribuzione e habitat, l'opera è particolarmente notevole per le crittogame, molte delle quali descritte per la prima volta. Essa fu pubblicata a Gottinga, che Haller aveva trasformato in un importante centro di studi botanici con la creazione di un orto botanico che si ispirava a quello di Leida. Presto si arricchì di piante fatte venire dai quattro angoli del mondo e divenne una delle principali attrazioni della città. Haller ne diede anche il catalogo; inoltre completò e pubblicò Flora jenensis di Heinrich Bernhard Ruppius. Intanto continuava ad arricchire il suo erbario grazie agli invii dei suoi corrispondenti, perfezionava il suo sistema e meditava una seconda edizione della sua flora. A dare nuovo impulso alle sue ricerche sulla flora elvetica fu però la nomina a sovrintendente delle saline e il trasferimento a Roche, nel cuore delle montagne del Vaud. Riprese a percorrere le montagne, ma soprattutto ingaggiò, perché raccogliessero per lui, le guardie forestali delle saline; i più attivi ed abili si rivelarono Pierre e Abraham Thomas. Anche altri raccoglievano per lui; citiamo almeno il giovane Horace Bénédict de Saussure che fece la sua prima escursione nella Valle di Chamonix proprio come raccoglitore di von Haller. Il risultato non fu una semplice seconda edizione, ma una nuova opera fortemente ampliata, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, in tre volumi, pubblicata a Berna nel 1768. Secondo Cuvier, "a quei tempi era la più ricca flora d'Europa". Arricchito era anche l'apparato iconografico, con 25 tavole aggiuntive. Complessivamente, tra piante da fiore, felci, muschi, licheni, alghe e funghi, le specie trattate sono circa 2000; le specie descritte per la prima volta, prevalentemente alpine, sono circa 300. Il primo volume si apre con una prefazione di enorme importanza storica, De plantis Helveticis, in cui von Haller illustra le caratteristiche geografiche, climatiche, geologiche del paesaggio elvetico, individua una serie di ambienti naturali e analizza la distribuzione delle specie in base all'altitudine e al clima, giungendo anche a definire diverse associazioni vegatali. È insomma un vero saggio di fitogeografia che non mancherà di influenzare Humbold. Rispetto all'ancora incerto sistema di Enumeratio methodica, Haller ha fatto enormi passi nella ricerca di un sistema naturale; ora le piante sono raggruppate in diciannove classi, a partire da quelle dotate di petali e stami fino ai funghi ("plantae staminibus nullis"), procedendo quindi in ordine inverso rispetto all'opera precedente. Siamo ancora lontani dal sistema naturale basato sul concetto di famiglia (anche se qualche famiglia naturale fa qua e là capolino), ma il sistema di Haller non mancò di esercitare qualche influenza su de Candolle. De Candolle ruppe con il sistema sessuale di Linneo a favore di sistema naturale, ma mantenne la nomenclatura binaria. Invece von Haller rimase ostinatamente legato alla tradizionale nomenclatura polinomia. Le motivazioni sono molteplici; c'entravano il rispetto per la tradizione e i grandi botanici del passato, la rivalità personale con Linneo, ma soprattutto per lui era inaccettabile una nomenclatura basata sui concetti di genere e specie; abbiamo già visto che concepiva le specie in modo diverso da Linneo; quanto al genere, a parte qualche caso evidente, distaccandosi anche dall'ammirato Tournefort, lo riteneva un'unità artificiale, una creazione speculativa dei botanici. Non comprendendo l'importanza di separare la denominazione dalla determinazione, riteneva i nomi binomi inadeguati e imprecisi. Questa scelta gli costò cara: dato che la nomenclatura binomiale è diventata lo standard, le specie da lui scoperte, prive di un nome binomiale valido, oggi portano nomi stabiliti da altri; qualcuno lo recuperò, adattandolo, il suo discepolo de Saussure.  Alle offese, si risponde con un fiore Fin dalla gioventù, quando si alienò i maggiorenti di Berna con le sue satire, von Haller non si tirava indietro quando si trattava di polemizzare. Polemizzò con Voltaire, di cui lui, luterano profondamente religioso, detestava l'irriverenza, il teismo e la filosofia pessimistica della storia; con il materialismo di La Mettrie, che riduceva il corpo umano a una macchina; con le idee politiche di Rousseau, che pure era un grande ammiratore della sua flora. E soprattutto, polemizzò instancabilmente contrò Linneo, il suo sistema, i suoi nomi, la sua pretesa di essere il "principe dei botanici" e il "nuovo Adamo" che aveva ribattezzato piante e animali. Nelle sue lettere a de Saussure, lo chiamava sarcasticamente "il tiranno del Nord". Al di là delle concezioni profondamente diverse della botanica, contavano molto anche tratti caratteriali e il desiderio di entrambi di imporre la propria supremazia sulla "repubblica delle lettere". Un contemporaneo svedese ebbe a dire: "Assomigliavano a Cesare e Pompeo. Uno, il nostro Linneo, non tollerava uguali, e l'altro, Haller, non tollerava superiori. E vice versa". Per qualche anno i due avevano manifestato reciproca stima, furono addirittura amici di penna e corrisposero a lungo. Nonostante le critiche di Haller alla sua Flora svecica (1743), Linneo manifestò grande apprezzamento per la trattazione della crittogame di Enumeratio methodica e nel 1747 favorì l'ammissione di Haller all'Accademia svedese delle scienze. Poi le cose incominciarono a guastarsi, tra insinuazioni e pettegolezzi dei reciproci entourages, e nel 1749 le relazioni si interruppero definitivamente. Nelle sue recensioni per la rivista di Gottinga, lo svizzero demolì sistematicamente le opere dello svedese e addirittura tra il 1750 e il 1753 incaricò il figlio Gottlieb Emanuel di scrivere una serie di pamphlet contro Linneo. Bisogna ammettere che in questo scontro il più signorile fu quest'ultimo: come aveva promesso al comune maestro Boerhaave non interveniva mai di persona nelle polemiche, e in Species plantarum fu abbastanza magnanimo da confermare la dedica al rivale di un genere che aveva istituito ai tempi della loro amicizia, in Hortus Cliffortianus, Halleria "in onore del dottissimo botanico Albrecht Haller, professor di botanica a Gottinga. E non si tratta di una pianta sgradevole e puzzolente, come la Siegesbeckia affibiata all'odiato Siegesbeck, o di un ritratto vegetale per lo meno ambiguo come Milleria per un altro pervicace oppositore delle denominazioni binomiali, Philip Miller. Le sudafricane Halleria lucida e H. elliptica, le due specie note a Linneo, sono infatti piante di sontuosa bellezza, potremmo dire un omaggio regale. Il genere Halleria (Stilbaceae, in precedenza Scrophulariaceae) comprende cinque specie di alberi e arbusti diffusi nell'Africa tropicale e meridionale e in Madagascar. Per i loro fiori spettacolari in inglese sono dette Tree fuchsia, fuchsia arborea, anche se con le vere fucsie non hanno alcuna parentela. Il centro di diversità è il Sudafrica, dove sono presenti tre specie su cinque, una delle quali (H. ovata) endemica; H. ligustrifolia e H. parviflora sono endemiche del Madagscar; H. lucida ha un ampio areale che va dall'Etiopia al Sudafrica, mentre H. elliptica ha distribuzione digiunta ( Malawi, Sudafrica, Madagascar). La specie di maggiore diffusione è anche probabilmente la più attraente. H. lucida è un piccolo albero dalla chioma arrotondata, con rami elegantemente arcuati e foglie lucide persistenti; diventa spettacolare al momento della fioritura, quando si ricopre di fiori tubolari da arancio a rosso mattone, raccolti in infiorescenze a grappolo alle ascelle delle foglie o portate direttamente sul tronco. Molto attraenti anche i frutti, bacche dapprima verdi poi nere a maturazione, eduli, di sapore dolce ma tendenzialmente allappanti. I fiori sono ricchi di nettare e sono impollinati da uccelli nettarini. Non è raro che un genere celebrativo onori allo stesso tempo due persone: un padre e un figlio, come Tradescantia per i due John Tradescant, due fratelli come Bauhinia per Jean e Gaspard Bauhin, magari due ricercatori che hanno collaborato, come Whitesloanea per gli specialisti di Cactaceae A. C. White e B. L. Sloane. Tuttavia è certo eccezionale il caso del genere Thomasia che celebra ben cinque persone, ovvero tre generazioni della stessa famiglia, quella dei raccoglitori e commercianti di piante svizzeri Thomas. A inaugurare la serie è a metà Settecento Pierre, guida e raccoglitore di Albrecht von Haller; quindi suo figlio Abraham, che ne prosegue l'attività e collabora con molti botanici affascinati dalle piante alpine; infine i suoi tre figli Philippe, esploratore della flora sardo-corsa, Louis, grande raccoglitore della flora calabra e collaboratore di Tenore, e Emmanuel, che trasformò la raccolta di piante e semi in un'impresa commerciale di successo. Tutti insieme scrissero una pagina importante della scoperta delle piante svizzere (ma anche italiane). I fondatori: Pierre e Abraham Nel 1754 il grande scienziato Albrecht von Haller venne nominato sovrintendente delle saline del distretto di Aigle nel Vaud, di proprietà del cantone di Berna. Egli prese molto sul serio l'incarico, benché gli garantisse entrate più che modeste: gli permetteva infatti di ritrovare l'amato paesaggio delle Alpi, alle quali in gioventù aveva dedicato un celebre poema, e di riprendere le ricerche sulla flora svizzera, in vista della seconda edizione ampliata della sua Enumeratio metodica stirpium Helvetiae indigenarum (la prima edizione era uscita nel 1742). Dal 1758 al 1764 visse nel castello di Roche, come un po' pomposamente veniva chiamata la dimora del sovrintendente, vi traferì la sua immensa biblioteca, il suo studio e il suo laboratorio; finché l'età e la salute glielo permisero, percorreva regolarmente le foreste e le montagne del distretto, sia per assolvere le sue funzioni sia per raccogliere piante e studiarle dal vivo. A fargli da guida erano le guardie forestali dipendenti dalle saline, alle quali demandò la raccolta di piante, quando per lui si fece difficile salire in montagna, o, come si espresse poeticamente, "alzarsi come un uccello sulle altezze". Insegnò loro a raccogliere e seccare correttamente gli esemplari, a distinguere le piante rare, a osservare e annotare i luoghi di raccolta, le condizioni di crescita, gli habitat. Nella prefazione a Historia Stirpium Indigenarum Helvetiae Inchoata, Haller ricordò con gratitudine i nomi di alcuni di loro; tra tutti spiccano quelli di Pierre Thomas (1708-1781) e di suo figlio Abraham (1740-1824). Pierre era un montanaro di Frenières; abitava con la moglie Madeleine in uno chalet della frazione di Les Plans, situata a circa 1000 metri in una valle circondata da imponenti monti calcarei; dai documenti risulta che fu assunto ufficialmente come guardia forestale delle saline nel 1761, ma il suo incontro con Haller risale a diversi anni prima. Anche se la sua istruzione era quella modesta dell'abitante di un piccolo villaggio di montagna, era dotato di intelligenza naturale, di una grande capacità di osservazione ed era un camminatore instancabile; a cementare l'insolita amicizia tra questo montanaro taciturno e il patrizio bernese Haller, il comune amore per la montagna e le sue piante. Pierre dapprima lo accompagnò alla scoperta delle montagne che circondano Les Plains, poi percorse per lui alla ricerca di piante il Vallese, i Grigioni e si spinse fino alle Alpi italiane. Ecco l'itinerario di uno di questi viaggi: nel 1763, partito da Bex, Pierre attraverso il passo di Cheville che collega il Vaud con il Vallese raggiunse Zermatt, quindi passò in Valtournenche, rientrando attraverso il colle del Gran San Bernardo. Gli era compagno il figlio Abraham, che partecipava alle raccolte paterne fin da bambino; era così abile e sveglio che appena diciottenne fu inviato da Haller ad esplorare da solo l'area del Furka. L'opera di Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici sulla flora delle montagne svizzere e il ritorno dello studioso a Berna (il suo incarico terminò nel 1764) non mise fine alle attività botaniche di Pierre ed Abraham, che anzi si traformarono in un piccolo commercio. I Thomas accompagnavano i visitatori come guide in spedizioni botaniche, raccoglievano e preparavano esemplari per i collezionisti; si deve probabilmente a Abraham la creazione di un piccolo orto botanico dove seminava piante alpine destinate soprattutto alla produzione di sementi e piante vendute a radice nuda. Nel 1775, per essere più vicini ai potenziali clienti, i Thomas trasferirono la loro abitazione a Fenalet, a metà strada tra i Plans e Bex. Pierre incominciava a sentire il peso dell'età; nel 1764 chiese alla direzione delle saline di essere affiancato come guardia forestale dal figlio, che nel 1779 gli subentrò. Due anni dopo Pierre moriva all'età di 73 anni. Grazie alle testimonianze dei diversi visitatori che nell'ultimo quarto del secolo frequentarono la casa di Fenalet, trasformata in un vero e proprio cenacolo di botanica da Abraham, conosciamo il figlio molto meglio del padre. Il giardiniere e botanico Thomas Blaikie (il creatore del parco di Bagatelle) che fu più volte ospite dei Thomas nel 1775, ha scritto di lui: "superava suo padre in intelligenza. Era dotato di un'agilità, di un vigore e di una memoria stupefacenti, accompagnati da un vero genio per l'osservazione". Un altro habitué, il poeta tedesco Matthison, afferma: "quest'uomo conosce a memoria e in modo esatto la flora alpina [...]. Mostrategli una qualsiasi montagna del Vallese o del distretto di Aigle: vi indicherà in modo infallibile le piante di ogni zona, il mese di fioritura, se all'ombra o al sole, nelle paludi o vicino a una sorgente, nel bosco o tra le rocce". Furono molti i visitatori che approfittarono della sua sapienza (e della sua agilità: sempre secondo Matthison, già vecchio nelle arrampicate ancora sfidava camosci e stambecchi)le della generosa ospitalità di sua moglie Marie-Susanne-Catherine Echenard - una grande appassionata di mitologia, sempre con un libro in mano mentre si occupava della cucina e delle faccende di casa: il botanico ginevrino Jacques Roux, il naturalista di Nechâtel Louis Perrot, il pastore e botanico Gaudin, autore di Flora helvetica, l'allievo di questi Jacques Étienne Gay, il canonico Laurent-Joseph Murith, autore del primo libro dedicato alla flora del Vallese, Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais, che molto deve all'assistenza di Abraham Thomas e di suo figlio Louis, costante compagno di viaggio del canonico. Murith collezionava anche minerali, conchiglie e fossili, che probabilmente su suo suggerimento andarono ad aggiungersi agli oggetti naturali raccolti e forniti dai Thomas. In quarant'anni di attività, Abraham fece progredire la conoscenza delle piante alpine, percorrendo e ripercorrendo le valli di Saas, Saint-Nicolas, Bagnes, Anniviers, Hérens e Binn, le pendici del Gran San Bernardo, del Cervino, del Monte Moro e i passi del Sempione, del Gries, del Furka, del Grimsel, della Gemmi, e molti altri. Stimato dai concittadini, nel 1781 fu nominato "giustiziere e consigliere di Bex per la competenza di Fenalet". Intorno al 1802, la famiglia si spostò ai Dévens, dove Abraham fece costruire per la comodità dei suoi ospiti la "casa rossa", attorno alla quale trasferì il suo orto botanico alpino. Una sola cosa mancava a quest'uomo ammirevole: il senso degli affari. Era troppo generoso con i suoi clienti, che considerava più che tali amici ed ospiti, per arricchirsi con il commercio di exsiccata, sementi, minerali, conchiglie, e di un "tè svizzero" la cui formula gli era stata insegnata da von Haller in persona. Mme la justicière trattava fin troppo generosamente i visitatori che, tra una scalata e l'altra, erano ospiti dello chalet di Fenalet e il marito non di rado inseriva una pianta rara, a titolo gratuito, nel plico di un invio. Intanto la famiglia cresceva: la coppia Thomas ebbe sette figli, due femmine e cinque maschi, ma solo tre raggiunsero l'età adulta: in ordine di età, Philippe, Louis e Emmanuel. .  I figli: Philippe, Louis e Emmanuel Come il nonno e il padre, i tre ragazzi Thomas avevano la botanica nel DNA. Fin da piccoli furono abituati a percorrere le montagne e ad imparare a distinguere le piante direttamente dal libro della natura, ma contrariamente a loro poterono anche viaggiare e godere di un'educazione formale. Quello che conosciamo meno è il maggiore dei tre sopravvissuti, Philippe (Pierre-Philippe-Louis, 1782-1831), al quale finora non è stato dedicato alcun studio approfondito, nonostante la sua importanza tra i primi esploratori della flora corso-sarda. Sappiamo che studiò medicina e che, oltre che in Svizzera e sulle Alpi, fece raccolte nei Pirenei. Nel 1814 fu la guida di William Jackson Hooker in un ampio viaggio in Svizzera. In una lettera di diversi anni dopo a Henry Fox Talbot, Hooker lo ricorda così: "Il Thomas che mi accompagnò in larghissima parte della Svizzera era Philippe; lo considero un compagno eccellente e onorevole, profondo conoscitore della botanica dell'intero paese [...]. Thomas intendeva visitare alcune isole del Mediterraneo". Qualche anno dopo avrebbe realizzato il suo sogno trasferendosi come medico a Cagliari, dove giunse tra il 1823 e il 1825. Presto entrò in contatto con Moris, di cui divenne uno dei più assidui collaboratori; in Flora sardoa, è citato quasi cento volte per esemplari raccolti sia in Sardegna, sia (sono i più numerosi) in Corsica. Doveva spedire regolarmente le sue raccolte al fratello Emmanuel che vendette piante sarde a musei, orti botanici e collezionisti. Ne troviamo un elenco nei due cataloghi (Catalogue des plantes de Sardaigne, qui se vendent chez Emmanuel Thomas, à Bex), pubblicati da Emmanuel rispettivamente nel 1837 e nel 1841. All'epoca però Philippe era già morto; morì infatti a Cagliari nel 1831. Un ruolo ancora più importante di quello di Philippe per la flora sardo-corsa ebbe Louis (Charles-François-Louis-Alexandre, 1784-1823) per la flora del regno di Napoli. Anch'egli naturalmente ricevette l'addestramento paterno en plein air e fu frequente compagno di escursioni del canonico Murith, che fu dunque il suo secondo maestro. Aveva ereditato dal nonno e dal padre l'occhio clinico e ancora ragazzo scoprì nuove specie. Ma fece anche buoni studi: studiò latino e scienze naturali, quindi si spostò a Parigi e al Jardin des Plantes seguì le lezioni di botanica di Desfontaines e quelle di mineralogia di Haüy. Quindi viaggiò nel sud della Francia, nella Repubblica di Genova, in Piemonte e in Lombardia, dove frequentò per qualche tempo l'università di Pavia. Ritornato in patria, fu nominato guardia forestale del distretto di Aigle. Probabilmente progettava di rimanere in Svizzera e di rilanciare su basi economicamente più solide l'attività di famiglia. Seguendo l'esempio di un vicino e concorrente, J.-C. Schleicher, un farmacista di origine tedesca considerato l'inventore del primo catalogo commerciale di piante, Louis predispose e fece stampare il primo Catalogue de plantes suisses, pubblicato intorno al 1806. Nell'avvertenza ai lettori, Louis scrive: «Sull'esempio di mio padre, al quale l'immortale Haller ispirò il gusto per la botanica, consacrandone il nome nei suoi scritti, anch'io, fin dalla più tenera giovinezza ho dedicato gran parte del mio tempo a percorrere diverse parti della Svizzera, e soprattutto le Alpi, nelle cui vicinanze abito. Avendo così formato una numerosa collezione di piante, di cui posso fornire agli amatori esemplari ben preparati, così come semi e radici di specie rare che io coltivo a tale scopo in un giardino, ho ritenuto di dover porre sotto gli occhi del pubblico il catalogo di queste piante. Avrei potuto aumentarlo con un gran numero di specie comuni che non mi è sembrato necessario nominare; tuttavia coloro che desiderano procurasi un erbario completo della Svizzera lo troveranno presso di me». Forse alla fine del 1806 o all'inizio del 1807, il giovane botanico slesiano Berger, in viaggio per le Calabrie da poco riconquistate dai francesi, di passaggio in Svizzera propose a Louis di unirsi a lui nell'esplorazione della flora di quella regione ancora tutta da scoprire. Egli accettò e i due, muniti di salvacondotti, poterono fare ampie raccolte, che poi affidarono per la pubblicazione a Michele Tenore. Sulla strada del ritorno, erborizzarono in Puglia, quindi rientrarono a Bex dove si divisero. Ma Louis non rimase a lungo in patria; egli soffriva di una grave forma di asma, aggravata dal rigido clima alpino. In Italia era entrato in contatto con Louis Reynier, un funzionario originario del Vaud, appassionato di botanica; nel 1808 Murat lo nominò direttore delle poste e responsabile delle foreste. In questa veste, egli offrì a Louis Thomas l'incarico di ispettore forestale delle due Calabrie. Egli assolse così bene questa funzione che il governo borbonico gli mantenne l'incarico, aggiungendovi anzi la direzione di una salina. Con le sue raccolte della flora calabra, diede un prezioso e imponente contributo alla Flora napoletana di Tenore che così scrive di lui "diligentissimo e dotto botanico, corrispondente al Real Giardino per le Calabrie", arrivando addirittura a definirlo "divus Thomas". Anche se non pubblicò nulla, il suo contributo è ricordato dalle numerose specie da lui scoperte e dedicatogli da Tenore: Crocus thomasii, Sison thomasii, Cerastium thomasii, Quercus thomasii, Ranunculus thomasii, Campanula thomasii. Purtroppo anche in Calabria la sua asma andò progressivamente aggravandosi e Louis Thomas morì nel 1823, a soli 39 anni. A portare avanti gli affari di famiglia rimaneva il solo Emmanuel (Abraham Louis Emmanuel 1788-1859). Aveva ricevuto la stessa educazione dei fratelli e ne condivideva la competenza botanica e l'occhio del raccoglitore, ma in più aveva il senso degli affari. Fu lui a trasformare il piccolo commercio avviato dal nonno e dal padre in un'impresa commerciale di risonanza europea. Come il nonno Pierre aveva scoperto la botanica grazie a Haller, così Emmanuel trovò un amico in un grande studioso, Jean de Charpentier. Nominato direttore delle saline nel 1813, egli le rilanciò, sostituendo l'estrazione diretta del salgemma allo sfutttamento delle acque delle sorgenti salate che andavano progressivamente esaurendosi. Appena arrivato a Dévens, in attesa che la direzione delle saline gli costruisse una casa, Charpentier si stabilì al primo piano della casa rossa, mentre i Thomas abitavano al piano terra. Tra Emmanuel Thomas e Charpentier si stabilì una grande amicizia e uno scambio scientifico, che andava nelle due direzioni: grazie a Charpentier, Thomas divenne un eccellente conoscitore dei minerali della Svizzera, mentre a sua volta incoraggiò Charpentier a creare un erbario e lo assisté nella stesura della sua unica opera di botanica (Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les districts d'Aigle). Ma soprattutto, la presenza di Charpentier (divenuto una celebrità europea per i suoi studi sui ghiacciai) attirò ai Dévens molti rinomati naturalisti. La casa rossa e la casa del direttore delle saline sorgevano l'una vicina all'altra e le piante - alpine ma anche esotiche - passavano da un giardino all'altro, così come i visitatori. Tra di loro, per citare solo qualche nome più familiare agli amanti della botanica, troviamo Alphonse de Candolle, Adrien de Jussieu, Jean Gaudin, Jean Muret, creatore del più completo erbario della flora svizzera; tra i geologhi, Charles Lardy, Elie de Beaumont, Leopold von Buch, Louis Agassiz. L'attività commerciale di Emmanuel è testimoniata dai tre cataloghi (Catalogue des plantes suisses qui se vendent chez Emmanuel Thomas à Bex) che egli pubblicò tra il 1818 e il 1841, cui vanno aggiunti i due già citati cataloghi di piante sarde e due supplementi, usciti rispettivamente nel 1842 e nel 1853. Il più ricco è quello del 1837 che offre più di 600 generi e quasi 2000 specie. Il grosso è costituito da gimnosperme e angiosperme, ma c'è anche una discreta scelta di felci e qualche equiseto e licopodio. Il catalogo del 1841 è invece interamente dedicato alle crittogame e ai licheni, per reggere la concorrenza di Scleicher che era uno specialista di muschi e licheni. Per mettere insieme le collezioni, Emmanuel Thomas continuava a raccogliere in natura, viaggiava molto raccogliendo anche in Piemonte, nelle Alpi italiane, in Austria; per curare le relazioni con la sua clientela internazionale (musei, orti botanici, studiosi, grandi collezionisti) fu anche a Vienna, Parigi, Londra, dove visitò l'esposizione universale. Una parte dello stock di piante vive e semi, probabilmente minoritaria, era coltivata nel giardino-vivaio di Dévens, di cui però non conosciamo l'estensione (dunque neppure le capacità produttive). I prezzi erano modici e le consegne relativamente rapide. Una delle specialità erano le conifere. Nel 1807 già Abraham Thomas pubblicò una memoria sull'utilità di pini e abeti per il rimboschimento. Tra il 1835 e il 1872, la famiglia Thomas consegnò 250.000 pianticelle e più di quattro tonnellate di semi di larice, abete rosso e bianco, pino cembro e altre conifere. Il cliente più importante era il cantone del Vaud, ma molte piante venivano inviate in altre parti della Svizzera, in Francia o addirittura in Inghilterra. Il commercio delle conifere acquistò sempre più importanza mano a mano che ne perdeva quello di exsiccata e piante rare. Dopo la morte di Emmanuel nel 1859, la ditta continuò sotto la direzione del figlio Jean-Louis (1824-1886) e poi dei suoi discendenti, ma i tempi d'oro erano terminati. Gli erbari dei musei e dei grandi orti botanici possedevano già esemplari anche delle piante svizzere più rare e tenere un erbario non era più un hobby alla moda, la concorrenza era sempre più forte e nessuno cercava più guide alpine esperte di piante. Il cliente principale divenne il vivaio Vilmorin, al quale i Thomas inviavano piante vive e sementi. Sempre più in crisi, resistettero fino al 1900, quando la ditta cessò di esistere. Ai Dévens si possono ancora vedere la casa rossa e la casa grigia, che Emmanuel fece costruire intorno al 1825, poco dopo la nascita dell'unico figlio maschio Jean-Louis. L'orto botanico di Abraham e Emmanuel è tornato ad essere un semplice orto. Tuttavia nel 1891 per iniziativa della città di Bex il botanico Ernest Wilczek, direttore dell'orto botanico di Losanna, creò un orto botanico alpino nella Valle di Nant, al di sopra dei Plans-sur-Bex, dove era iniziata l'epopea dei Thomas. Battezzato in loro onore La Thomasia, ospita un arboreto e una collezione di quasi 3000 piante alpine provenienti da tutto il mondo.  Un genere australiano per i botanici delle Alpi Abbiamo già visto che Tenore dedicò al "divus Thomas" diverse specie. Lo stesso onore è toccato ai fratelli Philippe, ricordato da specie della flora corsa come Armeria thomasii (oggi A. leucocephala) o sarda come Olopitum thomasii, ed Emmanuel, ricordato da una quindicina di specie alpine. Fu però un antico ospite della famiglia, il botanico Jacques Étienne Gay, nato nel Vaud ma fattosi parigino, a celebrare allo stesso tempo tre generazioni della famiglia con la dedica cumulativa del genere Thomasia: "Ho consacrato questo genere agli svizzeri Pierre e Abraham Thomas, contemporaei di Haller, nonché ai fratelli Philippe, Louis e Emmanuel Thomas, figli di Abraham e nipoti di Pierre, che, presi da fervido amore per la botanica, per un sessantennio non cessarono di percorrere le montagne e di conquistare piante per l'uso dei botanofili, che infine, grazie allo loro operosità, diedero un catalogo della flora svizzera tale che oggi essa è considerata tra le più ricche della superficie terrestre". A questi instancabili raccoglitori della flora elvetica però Gay non dedicò un genere svizzero e neppure alpino: le circa trenta specie del genere Thomasia (famiglia Malvaceae, in precedenza Sterculiaceae) sono infatti endemiche dell'Australia sud-occidentale, eccetto T. petalocalyx che è nativa del Victoria nell'Australia sud-orientale. Vivono in diversi ambienti, che vanno dalle dune sabbiose e gli affioramenti rocciosi, come T. sarotes, al sottobosco delle boscaglie come T. solanacea, alle brughiere come T. purpurea, alle foreste di eucalipti come T. petalocalyx. Sono arbusti da nani a medi, spesso con foglie molto decorative e fiori dai colori pastello resi spettacolari non dai petali, assenti o piccoli e non appariscenti, ma dai sepali che formano corolle a coppa o a campana piatta che ricordano un po' quelle dei Solanum. Tra le più notevoli, T. purpurea che al momento della fioritura si ricopre letteralmente di racemi color malva; T. quercifolia, con foglie molto attraenti e fiori rosa-porpora; T. pygmaea, che forma cespugli bassi e compatti ed è adatta anche alla coltivazione in contenitori. Molto apprezzate dal giardinaggio australiano, anche perché molte sono piante da sottobosco che ben si adattano agli angoli ombrosi, sono praticamente sconosciute in Europa. Alcune specie erano commercializzate nei cataloghi ottocenteschi e risulta che nel giardino Ricasoli sul Monte Argentario verso la fine del secolo si coltivasse, insieme a moltissimi altri arbusti australiani, anche T. solanacea. A parte qualche vivaio californiano, oggi non sembra siano commercializzate al di fuori dell'Australia. Oggi il nome del medico e naturalista tedesco Paul Möhring è ricordato soprattutto come dedicatario del linneano Moehringia, ma ai suoi tempi fu uno studioso stimato e riconisciuto, membro della Leopoldina e dell'Accademia di San Pietroburgo, e corrispondente di molti di quelli che contavano, dallo stesso Linneo all'immancanbile Albrecht von Haller. Scriveva di medicina e anche di botanica, ma dedicò la sua opera principale Avium genera agli uccelli, di cui tentò una classificazione in quattro classi. Uscito appena un anno prima di Species plantarum e sei anni prima della decima edizione di Systema naturae (1758, punto di partenza della nomenclatura zoologica) sebbene di poco è un'opera prelinneana la cui nomenclatura non è considerata; più discusso è invce lo status dell'edizione olandese Geslachten der Vogelen, che seguì di poco l'opera di Linneo. In ogni caso, l'influenza dell'opera di Möhring è attestata dalla ripresa di vari generi da lui creati da parte di altri studosi, in particolare lo stesso Linneo e il francese Brisson. 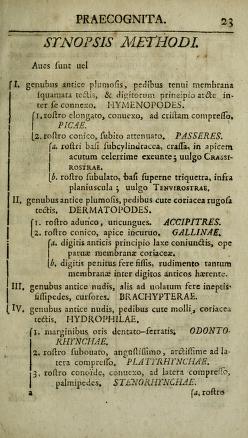 Un medico erudito, tra medicina, botanica e ornitologia Oggi la cittadina di Jever in Bassa Sassonia, capitale della Frisia tedesca, è celebre soprattutto per la sua ottima birra. Qui nacque e visse tutta la vita - se si esclude la parentesi degli studi universitari - il medico e naturalista tedesco Paul Möhring (1710-1792). Nonostante il relativo isolamento di questa località di provincia, all'estremo nord della Germania, riuscì a farsi un nome tra gli studiosi e almeno una delle sue opere, Avium genera, ebbe una certa influenza sui contemporanei, inclusolo stesso Linneo. Si tratta infatti di uno dei primi tentativi di stabilire una classificazione sistematica di tutte le specie di uccelli conosciuti. Con il senno di poi, nella sua Histoire des sciences naturelles (1831), Cuvier lo giudica assai severamente: "Brisson e Linneo adottarono diversi dei suoi generi, tuttavia la sua classificazione si basa su caratteristiche irrilevanti". Consideriamo tuttavia che la classificazione degli uccelli è tuttora una questione assai complessa, e quello di Möhring era uno dei primi tentativi moderni, dopo le anticipazioni rinascimentali di Aldrovandi e Gessner e il sistema di Ray e Willughby. Come ho anticipato, Paul Heinrich Gerhard Möhring (questo il suo nome competo) era nato a Jever, all'epoca un territorio del ducato di Anhalt-Zerbst. Il padre, il pastore Gottfried Victor Möhring, un colto teologo e pedagogo, era il rettore della scuola di Jever, dove anche Paul completò gli studi di base e liceali. Nel 1729 si iscrisse al Gymnasium Academicum di Danzica, forse con l'intenzione iniziale di seguire le orme paterne, ma presto passò allo studio della medicina. Nel 1732 si trasferì all'università di Wittenberg e qui l'anno successivo si laureò con una tesi sulla meccanica dell'infiammazione del sangue. Tornò quindi a Jever, vi si stabilì come medico, conquistando rapidamente la fiducia di una vasta clientela; fu successivamente nominato medico della guarnigione, medico cittadino e medico di corte. A questa vita professionale di successo, Möhring affiancò una vasta attività erudita; fin dal 1736 (lo stesso anno di Linneo), con l'appellativo Diocles secundus, fu ammesso all'Accademia leopoldina, ai cui atti avrebbe contribuito con diversi articoli , così come alla rivista di Norimberga Commercium litterarium. Il nome accademico fa riferimento a un medico ellenistico, Diocle di Caristo, cui si attribuisce la più antica spiegazione della differenza tra vene ed arterie, e ben si collega sia all'argomento della tesi di laurea di Möhring, sia alla sua professione, ma i suoi interessi scientifici non si limitavano alla medicina. La botanica dovette essere il primo amore se, sin dal suo ritorno a Jever, il giovane medico creò un giardino privato, oggetto della sua prima pubblicazione a stampa, Primae lineae horti privati in proprium et amicorum usum ("Prime linee di un giardino privato ad uso proprio e degli amici", Oldenburg 1736), un libretto d'un centinaio di pagine che da una parte ne è il catalogo, dall'altra si offre come modello a chi voglia impiantare un analogo giardino. Nel catalogo in ordine alfabetico troviamo sì le tradizionali piante officinali che ci attendiamo nell'hortus di un medico, ma anche piante orticole, ornamentali ed esotiche, nonché oiabte del territorio. Nell'identificazione delle specie, Möhring si rivela un attento conoscitore della letteratura botanica, con uno spiccato interesse per la tassonomia. Dovette essere orgoglioso dell'operina se si affrettò ad inviarne una copia al celebre Albrecht von Haller, che lo approvò ma contestò alcune identificazioni e gli suggerì di rivolgersi a Linneo. All'epoca lo svedese - di appena tre anni maggiore di Möhring - viveva ancora in Olanda, e, anche se aveva già pubblicato la prima edizione di Systema naturae e Bibliotheca botanica, era ancora soprattutto il curatore del giardino del magnate George Clifford. Möhring colse la palla al balzo per cercare di avviare uno scambio sia con lui sia con il suo datore di lavoro: inviò anche a Linneo il libretto e nella lettera di accompagnamento (datata 29 luglio 1737), senza mancare di citare l'approvazione di Haller e di porre alcuni quesiti tassonomici, offrì di inviare a Linneo semi ed esemplari di qualsiasi pianta del suo giardino in cambio di semi di Hartecamp. Finché Linneo visse in Olanda, lo scambio espistolare tra lui e Möhring dovette essere abbastanza fitto (si sono conservate sette lettere del tedesco, tutte scritte tra il 1737 e il 1738, tranne l'ultima, del 1748, ma nessuna delle risposte dello svedese); l'auspicato scambio di semi in effetti si avviò, su richiesta di Möhring Linneo coinvolse anche il direttore dell'orto botanico di Leida Adriaan van Royen e semi e libri provenienti da Hartecamp e Leida presero la via di Jever. Möhring lesse con avidità le opere del nuovo amico e si dichiarò entusiasta del sistema sessuale (se lo avesse conosciuto prima, si sarebbe risparmiato molti dubbi ed errori). Le lettere contengono anche parti squisitamente botaniche, con la minuta descrizione di varie piante, incluso il genere Corrigiola, al quale forse Möhring pensava di dedicare una monografia. Negli anni successivi, tuttavia, forse anche a causa dei gravosi impegni come medico, a prendere il sopravvento negli interessi di Möhring fu dapprima la stessa medicina e la sua storia, poi l'ornitologia. Sono dedicati rispettivamente a questi argomenti i suoi due libri maggiori, Historiae medicinales, pubblicato nel 1739, e Avium genera, pubblicato a Brema nel 1752. Quest'ultimo, al di là del giudizio liquidatorio di Cuvier, ha guadagnato a Möhring qualche riga nelle storie della zoologia come autore di una classificazione che ai suoi tempi ebbe una certa rinomanza e influenzò lo stesso Linneo. Per fare una facile battuta, potremmo definirla "fatta con i piedi". Furono infatti le caratteristiche degli arti il principale criterio adottato da Mohring per dividere gli uccelli in quattro classi. La prima è quella degli imenopodi, gli uccelli con piedi coperti da una sottile membrana; ne fanno parte i due ordini delle Picae (ovvero gazze e corvi) e Passeres (grosso modo, l'attuale Passeriformes). La seconda classe è quella dei dermatopodi, gli uccelli con piedi ricoperti da una membrana più spessa, ugualmente divisa in due ordini, gli Accipitres, gli uccelli da preda, e le Gallinae, i gallinacei. Per la terza classe, più che dei piedi, si tiene conto delle ali: è infatti quella dei brachipteri, ovvero degli uccelli con ali ridotte e inadatte al volo. Infine l'ultima classe è quella degli idrofili, ovvero degli uccelli acquatici, inclusi i palmipedi. Möhring li divide in cinque ordini, sulla base della forma del becco. Insomma, una classificazione poco coerente e di gran lunga imperfetta, come sottolinea l'impietoso Cuvier. Il libro tuttavia suscitò un discreto interesse e nel 1758 venne tradotto in olandese con il titolo Geslachten der Vogelen da Cornelius Nozeman, che nel 1770 avrebbe iniziato a pubblicare il grande catalogo degli uccelli olandesi Nederlandsche Vogelen. Mentre l'edizione di Brema precede la decima edizione di Systema naturae ed è quindi non rilevante per la nomenclatura zoologica, la traduzione di Amsterdam lo segue di qualche mese. Poiché non si tratta di una mera traduzione, ma contiene aggiunte di varia natura, nel secolo scorso si aprì la questione se considerare valide le denominazioni di Möhring che in vari casi precedono quelle in uso. Come sottolineò il gruppo di lavoro sulla nomenclatura ornitologica in occasione del congresso internazionale di ornitologia del 1964, ciò avrebbe comportato "una confusione senza fine e il cambio del nome anche di uccelli tra i più comuni e universalmente diffusi". La conclusione fu dunque di rigettare Geslachten der Vogelen ai fini nomenclatori. Tuttavia, molte denominazioni create da Möhring erano state fatte proprie da altri autori, e sono quindi entrate nelle nomenclatura zoologica in modo indiretto. Tra gli esempi più significativi, due nomi di Möhring ripresi dallo zoologo francese Brisson: Spheniscus, il genere cui appartengono i cosiddetti pinguini fasciati, e Rhea, il nandù (in inglese rhea è anche il loro nome comune). Möhring visse una lunga vita, ed oltre ad essere onorato dai concittadini, era stimato dagli studiosi. Tra i suoi corrispondenti, oltre a von Haller e Linneo, troviamo il celebre medico erudito di Hannover Paul Gootlieb Werlhof, il rettore dell'Università di Leida Gualtherus van Doeveren, e Hans Sloane. Quando aveva già compiuto ottant'anni, accettò con gioia l'elezione all'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo. Aveva ormai perso quasi completamente la vista, ma continuò ad esercitare la professione fino alla morte nel 1792, a 82 anni.  Minuscole piante rupicole Si deve certamente all'amicizia giovanile con Linneo la dedica del generre linneano Moehringia. Già il Philosophia botanica, Linneo annovera Moehering tra i principali botanici del suo tempo e anticipa questo genere, poi ufficializzato in Species plantarum. Abbiamo visto che Möhring aveva studiato Corrigiola, un genere della famiglia Cariophyllaceae. A questa famiglia appartiene anche Moehringia, separato da Linneo dall'affine Alsine. Ne fanno parte poco meno di trenta specie di erbacee annuali o perenni, diffuse esclusivamente nelle aree temperate dell'emisfero boreale, prevalentemente in Europa; poche specie si estendono al nord Africa e all'Asia sudoccidentale; una (M. lateriflora) è circumboreale; tre sono esclusive del nord America. Sono piccole piante dai fusti esili, che formano cuscinetti o piccoli cespugli; le foglie, di forma variabile, ma per lo più da filiformi a lineari, sono opposte. I fiori, solitari o riuniti in piccole cime, possono essere tetrameri o pentameri; i petali bianchi sono liberi, ben separati tra loro, ovoidali e con apici interi. La vera caretteristica distintiva è tuttavia data dai semi, muniti di un'escrescenza più o meno accentuata (strofiolo) che è anche un elemento decisivo per distinguere una specie dall'altra. Le poche specie di ampia diffusione sono prevalentemente piante boschive, mentre il grosso del genere è rappresentato da specie calcofile che vivono nelle fessure delle pareti rocciose e hanno una diffusione endemica a livello locale o regionale. Questa particolare distribuzione è evidente anche nella flora italiana nella quale, con sedici specie, è rappresentato oltre il 50% dell'intero genere: tre sono specie mediterranee ed europee di ampia diffusione, due sono presenti nell'intero arco alpino, cinque sono endemismi di particolari settori delle Alpi condivisi con le nazioni confinanti (alcuni dei quali rari, come M. argenteria, esclusiva del massiccio dell'Argentera a cavallo tra Francia e Italia, o M. tommasini, esclusivo della penisola istriana), sei sono esclusivi dell'Italia. Per un elenco completo delle specie italiane e la loro distribuzione si rimanda alla scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

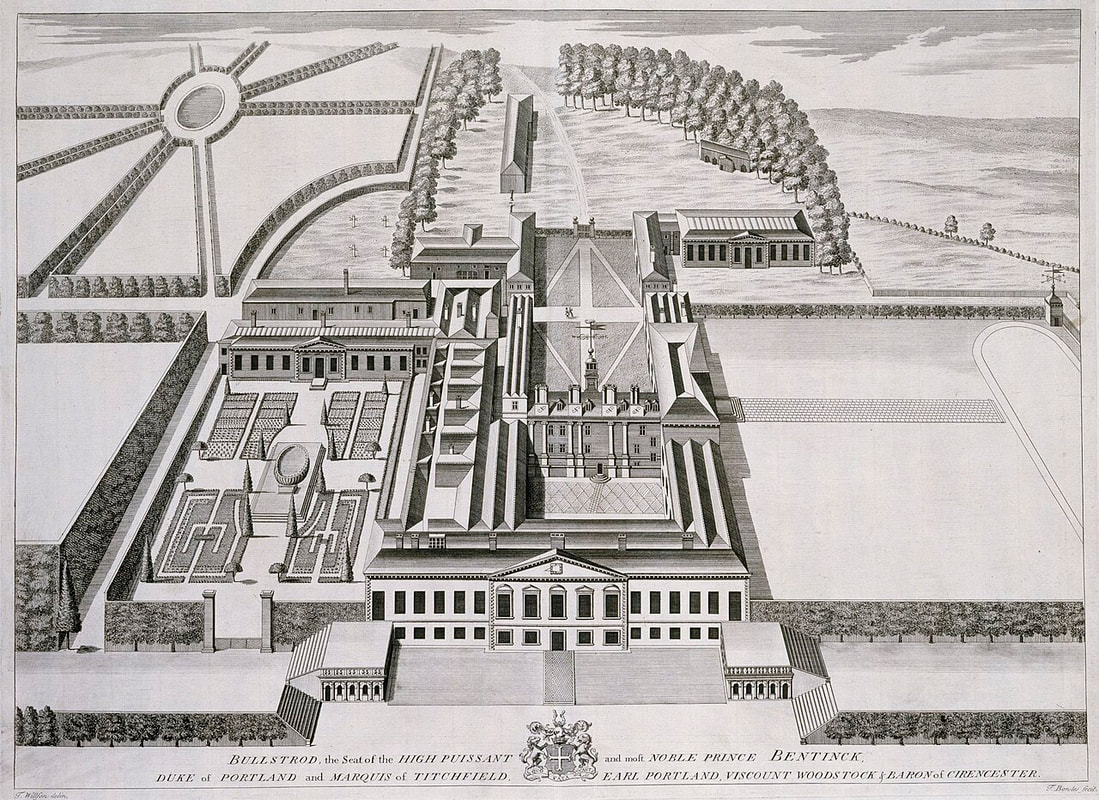

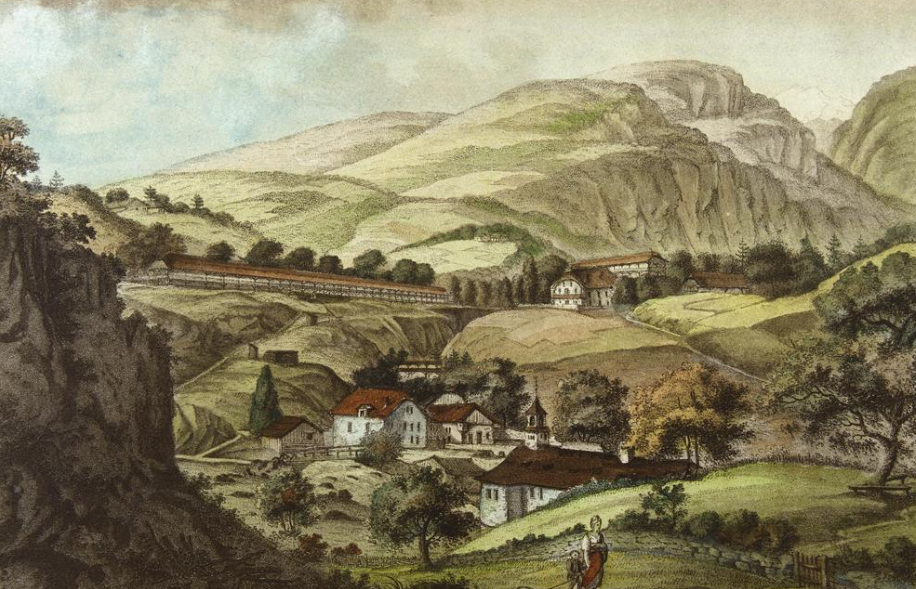

 RSS Feed
RSS Feed