|
Firenze è la sede dell'Erbario centrale italiano, il più grande del nostro paese e uno dei primi dieci al mondo. L'importante collezione di briofite risale al lascito di un medico svizzero appassionato di botanica che si traferì in Italia e si fece fiorentino: Émile Levier. Raccoglitore meticoloso ed entusiasta, erborizzò non solo in Toscana, ma anche in Campania, in Abruzzo, nelle Alpi e, al di fuori dei nostri confini, partecipò a quattro spedizioni in aree all'epoca poco conosciute. Quando le briofite (muschi ed epatiche) occuparono il centro dei suoi interessi, con raccolte proprie e con l'apporto di una gigantesca rete internazionale, creò un vastissimo erbario briologico che dopo la sua morte passò appunto all'Erbario centrale. Lo ricorda l'esotico genere Levieria.  Piante montane e briofite Il 21 agosto 1875 due escursionisti affrontano l'impegnativa scalata del Corno grande del Gran Sasso. Sono il medico Émile Levier e sua moglie Mathilde. A motivarli, più della passione sportiva, è l'amore per le piante. Émile (ma da quando dalla nativa Svizzera si è trasferito a Firenze non gli spiace essere chiamato Emilio) è infatti un appassionato botanico e da quando vive in Italia dedica l'estate e tutto il tempo lasciato libero dalla professione medica all'esplorazione della flora e da qualche tempo l'Abruzzo è diventato la sua area di caccia preferita. Sui ghiaioni e nelle fessure delle rocce attorno ai 2700-2900 metri, vivono numerose specie rupicole: Levier riconosce Papaver alpinum (oggi Oreomecon alpina), Draba cuspidata e l'endemismo appenninico Cerastium thomasii. È Mathilde la prima a notare una piccola specie a pulvino con fiori ormai secchi. I due Levier ne raccolgono pochi esemplari per l'erbario. Nel luglio dell'anno successivo la pianticella viene rinvenuta in piena fioritura al di sopra del Campo di Giove sulla Majella da due dei numerosi corrispondenti botanici di Émile, Pierre Edmond Boissier e Louis Leresche, anch'essi svizzeri e appassionati raccoglitori. Gli esemplari prontamente e generosamente condivisi con Levier gli confermano che si tratta di una specie inedita di Androsace; la battezza doverosamente A. mathildae, in onore della "coraggiosa moglie che per prima vide la rara pianticella durante l' ascensione del Gran Sasso [...] e con me ne raccolse pochi esemplari". Segnalata solo in Abruzzo, appunto sulle pendici del Gran Sasso e della Majella, questa deliziosa piccola pianta è forse il più prezioso rinvenimento di Émile Levier (1839-1911). Nato a Berna, dove si laureò in medicina e per tre anni prestò servizio negli ospedali cittadini, dopo un anno trascorso a Parigi come medico interno, nel 1865 si trasferì a Firenze aprendo uno studio di medico-chirurgo. Apprezzato per le capacità professionali, l'affabilità e la conoscenza delle lingue, era ricercato soprattutto dalla folta colonia di stranieri che viveva nella capitale toscana. Per diversi anni, nel periodo estivo prestò servizio come medico termale ai Bagni di Bormio in Valtellina e per qualche estate a Boscolungo nel Pistoiese (oggi è la nota stazione sciistica dell'Abetone). Amava questi soggiorni in montagna perché gli offrivano molte occasioni per coltivare la sua passione per la botanica, nata nell'adolescenza grazie all'amicizia con Charles-Henri Godet. Dotato di "memoria ferrea, occhio sicuro e acuto" (come scrisse Sommier nel suo elogio funebre) era un raccoglitore nato. Dopo il trasferimento a Firenze, iniziò ad esplorare dapprima la flora dei dintorni, per poi allargare sempre più il raggio delle sue esplorazioni. Infatti nella capitale toscana trovò un ambiente assai stimolante; le sue ricerche furono incoraggiate da Filippo Parlatore, impegnato nella pubblicazione della sua Flora d'Italia, e da Teodoro Caruel che si avvalse di molti suoi materiali per i supplementi al Prodromo della flora toscana. Strinse poi una fervida amicizia con Stefano Sommier che, come vedremo, fu suo compagno nella sua più impegnativa avventura botanica. In Italia erborizzò, oltre che in Toscana, nelle Alpi Retiche, nella penisola sorrentina, a Capri, ad Ischia e ripetutamente in Abruzzo dove, oltre al Gran Sasso e alla Majella, esplorò il Monte Velino, Scanno e l'Altopiano delle Cinquemiglia, sempre riportando copiose raccolte che condivise generosamente con il Museo botanico fiorentino, pur andando a costituire anche un ricco erbario personale, accresciuto da scambi con i numerosissimi corrispondenti. Fuori d'Italia, partecipò a quattro spedizioni. Nel 1878 e poi nuovamente nel 1879 visitò il nord della Spagna e del Portogallo con Boissier e Leresche, come lui membri della Société botanique de Genève ; il capo incontestato della spedizione era il più esperto e noto Boissier, mentre a Levier, il solo medico, spettava il compito di "curare i suoi colleghi se si fossero ammalati, senza per questo perdere il suo diritto ad erborizzare". Inoltre, si contava sulla sua energia, visto che era "più giovane della metà e perciò più agile". Il momento culminante della spedizione fu l'esplorazione del Pico de Europa, all'epoca largamente inesplorato, dove i tre botanici poterono raccogliere molte piante alpine, tra cui una nuova specie di Pimpinella pubblicata da Leresche come P. siifolia (oggi Parapimpinella siifolia). Ma Levier poté anche approfittare del "diritto ad erborizzare" per fare un'ampia raccolta di muschi (oltre cento specie e varietà). Ne leggiamo l'elenco in Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et le Portugal en 1878 et 1879, scritto a quattro mani da Levier e Leresche. Nel 1880 esplorò la Corsica con Charles Forsyth Major, studiando in particolare le piante montane e le affinità e le differenze con la flora sarda; infine nel 1887 fu la volta di un viaggio di quattro mesi nel Caucaso con Sommier, nel corso della quale i due esaminarono la vegetazione di 85 località diverse, raccogliendo più di diecimila esemplari che poi descrissero in Enumeratio plantarum anno 1890 lectarum. Inizialmente, Levier si occupò di angiosperme, pubblicando una serie di rilevanti lavori sull'origine e la diffusione dei tulipani in Italia e in Europa, ma poi il centro del suo interesse si spostò sempre più verso le crittogame, in particolare i muschi e le epatiche (secondo Sommier "materia adattattissima [sic] al Levier, così oculato indagatore delle cose minute"). L'assidua ricerca di briofite lo portò in Toscana, in Valtellina, nell'alto Novarese e in Valle d'Aosta. Per procurarsi esemplari esotici creò una rete di corrispondenti - così vasta da essere stata definita "universo" - che includeva amici, viaggiatori, missionari, funzionari coloniali. Forse per eccessivo perfezionismo, pubblicò poco, ma diede un enorme contributo ai lavori altrui riorganizzando materiali, determinando esemplari, abbozzando studi che poi altri avrebbero completato. Per anni scrisse contributi e accumulò materiali per una monografia sul genere Riccia, per la quale preparò anche perfette tavole a colori (era un eccellente illustratore botanico), ma la morte gli impedì di completarla, così come uno studio sulla distribuzione altimetrica dei muschi. Forte fumatore, incominciò ad accusare problemi cardiaci che nel 1911 lo portarono alla morte. Una parte dell'erbario fu donato dalla vedova (Mathilde Levier, assidua compagna di escursioni botaniche) all'Erbario centrale di Firenze, il resto fu venduto dagli eredi ed acquistato sempre dalla stessa istituzione. La parte più preziosa è costituita dell'erbario briologico, creato da Levier sia con raccolte dirette sia con gli apporti dei suoi corrispondenti, fino a diventare il più vasto d'Italia. Lo è probabilmente ancora oggi, tanto da essere stato utilizzato ancora all'inizio di questo secolo come base di partenza della Flora dei Muschi d’Italia.  Un omaggio dalla foresta pluviale Levier, finché la malattia non glielo impedì, fu un medico e, anche se collaborò al Museo botanico fiorentino e all'erbario, non ebbe mai alcun ruolo accademico o istituzionale (tranne che, a partire dal 1889, come membro della Società botanica italiana di cui fu più volte consigliere). Forse per questo andava a genio anche a quel bastian contrario che fu Odoardo Beccari che nel 1877 volle dedicargli il genere Levieria con parole affettuose: "È all'amico Dr. E. Levier, distinto ed appassionato cultore della botanica, che dedico questo nuovo genere". Con Levieria (famiglia Monimiaceae), dalla Toscana e dai monti d'Italia ci trasferiamo nelle foreste pluviali delle Molucche, della Nuova Guinea e dell'Australia settentrionale. Sono questi l'areale di diffusione e l'habitat delle sue sette specie, costituite da alberi o arbusti, raramente rampicanti, che vivono soprattutto nelle foreste pluviali di bassa montagna, tra 1200 e 3000 metri. Sono dioiche, con piante maschili distinguibili per i tepali separati ed arrotondati portati su un piccolissimo ricettacolo piatto e piante femminili caratterizzate da un ricettacolo a coppa usualmente quadrilobato; in fase di sviluppo le drupe rimangono esposte dall'arricciatura del ricettacolo, con i tepali al margine. Il centro di diversità è la Nuova Guinea, dove sono presenti tutte e sette le specie; una si estende alle Molucche e una al Queensland.
0 Comments
Nel 1696, il frate francescano Francesco Cupani pubblica lo straordinario Hortus Catholicus: è il catalogo delle circa 3000 tra specie e varietà che crescevano nello splendido giardino di Misilmeri, voluto da Giuseppe del Bosco principe di Cattolica. Accanto alle officinali di prammatica, c'erano le specie sicule, molte delle quali raccolte di persona da Cupani, assiduo esploratore della flora dell'isola, e le esotiche più rare, giunte in Sicilia grazie alla rete di corrispondenti italiani e europei abilmente coltivata dal botanico francescano. Rimase invece incompleta e inedita l'ultima opera di Cupani, l'ancor più grandioso Panphyton siculum. Il confratello Plumier volle ricordarlo con il genere Cupania, cui più tardi si affiancò Cupaniopsis. Al suo allievo Bonanno, che tentò di completarne l'opera inedita, è invece toccato il monotipico Bonannia. 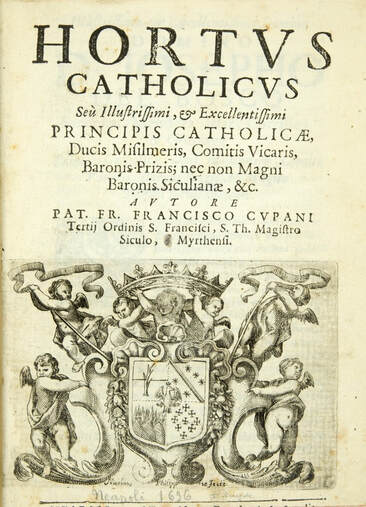 Un giardino straordinario e il suo catalogo Intorno al 1690, Giuseppe del Bosco, principe di Cattolica, decise di trasformare in orto botanico il Giardino Grande del suo palazzo di Misilmeri, a una quindicina di km da Palermo; già esistente almeno dal XV secolo, godeva di acque abbondanti grazie a una vicina sorgente. Non conosciamo nei particolari la genesi del progetto, che voleva anzitutto venire in soccorso delle genti bisognose del feudo attraverso la coltivazione di piante medicinali utili, ma è probabile che sia stato determinante l'incontro con il frate francescano Francesco Cupani (1657-1710), che da qualche anno si stava dedicando all'assidua esplorazione della flora siciliana. Nato a Mirto in provincia di Messina, come riferisce egli stesso nel prologo di Hortus Catholicus, Cupani inizialmente studiò medicina a Palermo, appassionandosi soprattutto di botanica; tuttavia a 24 anni entrò nel terzo ordine francescano, e lasciò lo studio della natura per la filosofia e la teologia, che in seguito insegnò prima a Verona poi a Palermo. La passione per le piante, relegata a svago marginale, si riaccese con forza al ritorno in Sicilia, alimentata dalla frequentazione di medici e speziali come Ignazio Arceri, medico del Regio nosocomio palermitano, e l'aromataro Nicola Gervasi (1632-1681), console del Collegio dei farmacisti e autore dell'Antidotarium Panormitanum Pharmaco-Chimico; di quest'ultimo, che Cupani definisce affettuosamente praceptor meus, "mio maestro", egli loda il giardino palermitano ricchissimo di piante rare. Ma la spinta determinante venne dall'esempio di Paolo Silvio Boccone, suo modello e assiduo corrispondente, che lo incoraggiò a proseguire le ricerche sulla flora indigena. Frutto di quattro anni di erborizzazioni, sfidando il caldo estremo dell'estate e i geli dell'inverno, è la prima opera edita di Cupani, Catalogus plantarum sicularum noviter adinventarum, pubblicata a Palermo nel 1692. Sono appena quattro pagine, con una lista di circa 150 piante in ordine alfabetico; secondo l'uso del tempo Cupani si avvale di nomi-descrizione polinomiali; ad esempio, l'attuale Euphorbia pithyusa subsp. cupanii figura come Tithymalus exiguus, pumilus, saxatilis, Portulaceae foliolis, flosculis rubentibus. A conclusione della lista, in una breve nota il francescano esprime la speranza di poter presto pubblicare le immagini delle piante, a meno che non lo faccia per lui il reverendo Silvio Boccone "famosissimo per la competenza erboristica", al quale ha inviato generosamente tutti gli exsiccata "mosso dall'onore della patria". Al momento dell'uscita del catalogo, il principe di Cattolica gli aveva già affidato la realizzazione del giardino di Misilmeri, in cui alle piante medicinali tanto native quanto esotiche si sarebbero affiancate ornamentali, piante esotiche rare, alberi da frutto e orticole. Per le piante medicinali e autoctone, il frate si avvalse della collaborazione di farmacisti ed erboristi come Pietro Citraro e Francesco Scaglione, nonché degli invii di numerosi corrispondenti che vivevano in parti dell'isola non esplorate di persona; ma continuò anche il lavoro sul campo, tanto che già nel 1694 fu in grado di stampare una seconda lista di piante siciliane, Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum, pubblicata sempre a Palermo, in cui le specie e varietà elencate sono salite a 300. Intanto il giardino cresceva grazie alla munificenza del principe, che lo trasformò in un luogo fatato con statue, fontane e addirittura uno zoo con animali esotici; lo circondava un muro coronato da oltre 600 vasi di piante esotiche, quasi un'anticipazione della ricchissima collezione di piante che racchiudevano. A farle arrivare in Sicilia fu una vasta rete di corrispondenti italiani ed europei che Cupani mise insieme forse con la mediazione iniziale di Boccone. Tra i corrispondenti più assidui troviamo infatti uno dei contatti di Padre Silvio, William Sherard, che a sua volta fece da tramite con botanici, appassionati e collezionisti britannici, gli inviò piante esotiche in cambio di semi siciliani, gli procurò libri (tra gli altri, Historia plantarum di John Ray). Determinante per la crescita del giardino fu poi Giovanni Battista Trionfetti, il curatore dell'orto botanico della Sapienza a Roma, che poté far giungere a Misilmeri le novità che affluivano a Roma grazie a gesuiti e sacerdoti viaggiatori. Tra i corrispondenti di Cupani troviamo molti altri grandi nomi della botanica del tempo: lo stesso Ray, Pitton de Tournefort, Caspar Commelin, i tedeschi Johann Georg Volkamer e Johannes Böhm. Questi scambi epistolari, oltre ad arricchire il giardino, consentirono al botanico siciliano di superare l'isolamento di una località periferica e di tenersi aggiornato sui progressi della botanica e sui grandi dibattiti del suo tempo, procurandosi i testi di riferimento indispensabili per catalogare le piante del giardino; nella nota di autorità premessa a Hortus Catholicus, egli elenca ben 90 titoli, tra i quali, oltre a testi già classici della botanica rinascimentale o del primo Seicento, troviamo libri di pubblicazione recente o recentissima, come il catalogo delle piante canadesi di Cornut (1635), Flora sinica di Boym (1656), la Centuria e il Prodromus di Breyne (rispettivamente 1678 e 1680), il catalogo delle piante olandesi di Jan Commelin (1683), i primi sei volumi di Hortus Malabaricus (1678-1686), il catalogo dell'orto botanico di Montpellier di Magnol (citato nella seconda edizione di Hortus Catholicus, e uscito lo stesso anno 1697). Come si vede, si tratta principalmente di cataloghi di orti botanici e di rassegne di flore esotiche: il problema principale che si poneva Cupani, come si evince anche dalla corrispondenza con Sherard, era infatti la corretta identificazione, per evitare di presentare come nuove piante già pubblicate in precedenza. Nonostante la grande mole di piante da identificare e descrivere, già nel 1696 Cupani fu in grado di dare alle stampe la prima edizione di Hortus Catholicus, accompagnata da un primo supplemento e seguita l'anno dopo da un secondo. E' un'opera imponente, che elenca circa 3000 tra specie e varietà; per le identificazioni e le denominazioni, Cupani rimase fedele all'insegnamento di Boccone, scegliendo una soluzione un po' datata: come punto di riferimento principale per l'identificazione dei generi (il concetto, anche se in modo ancora impreciso, si andava ormai affermando) si affidò all'autorità di Robert Morison, e al suo sistema basato sulla fruttificazione (che in qualche modo poteva essergli familiare, visto che anche Castelli, maestro del suo praeceptor Gervasi, si era basato sui frutti); per le specie e le denominazioni, oltre a Morison stesso, all'ancora più datato Pinax di Caspar Bauhin e all'Historia plantarum di Jean Bauhin. Come nelle liste precedenti, anche in Hortus Catholicus le piante si susseguono in ordine alfabetico, da Abies alba a Yucca. Per quelle già note, tipicamente Cupani parte dalla denominazione del Pinax, seguita, se differenti, da quelle di Jean Bauhin e di Morison; la voce si conclude (e questa invece è una novità) con il nome vernacolo siciliano, nel desiderio di allargare la conoscenza delle piante anche a chi non leggeva il latino. A mo' di esempio, ecco la voce iniziale (corrispondente a Abies alba Mill): Abies alba, seu foemina CBP [ovvero Caspar Bauhin Pinax], sive elate Thilia IB [ovvero Jean Bauhin], vulgo Erva di S. Filippu, o Arvulu cruci, Arvulu caccia diavuli. Ovviamente, se la pianta nel Pinax non compare, Cupani ricorre ad una o più altre autorità, ad esempio per l'attuale Hibiscus mutabilis L. a Paul Hermann, Morison e Ferrari: Althaea arborea, Rosea, Sinensis, flore multiplici HLB [Hermann, Hortus logduno-batavus], Althaea arborea, Sinensis Moris. Hist. 2 [Morison, Historia universalis Oxoniensis vol. 2], Rosa sinensis Ferrari Florae cult. vulgo Rosa Indiana. Per le piante non descritte in precedenza, Cupani usa una denominazione polinomiale, costituita dal nome generico seguito da uno o più epiteti. A tale proposito, si è spesso detto che egli abbia anticipato Linneo, facendo largo uso di nomi binomiali. Lasciando da parte i binomi ripresi da Bauhin (che a sua volta è ritenuto l'inventore dei nomi binomiali, ma non li usò in modo sistematico), vediamo se è vero con un esempio, tratto ancora dalla lettera A. Oltre a sei specie di Acetosa già descritte dai Bauhin e/o da Morison, Cupani ne descrive cinque nuove: "Acetosa Nebroides Arisari pallido-virenti folio", "Acetosa peregrina, lanceolata, vesiculis trigonis, venis sanguineis inscriptis", "Acetosa alienigena caule carens, sterilis, radice nimio reptatu, foecunda", "Acetosa lanceolato folio, e basi lata polyfido, Etnensis", "Acetosa montana angusto folio sagittae". Si tratta, evidentemente, di nomi descrizione polinomiali; anzi, nella secondo supplemento, Cupani esprime la sua perplessità di fronte a nomi troppo brevi che, egli teme, impedirebbero il riconoscimento proprio delle specie nuove. Per dirlo in altri termini, la separazione tra denominazione e descrizione, che Linneo stesso raggiungerà solo in Species plantarum, non è ancora avvenuta. Infatti, in Bibliotheca botanica, lo svedese collocò Cupani non certo tra gli innovatori o i sistematici, ma tra i curiosi, ovvero "coloro che raccolsero piante prima del tutto ignote o mal conosciute e le illustrarono con descrizioni e immagini". Il merito maggiore di Cupani sta ovviamente nell'esplorazione della flora siciliana, di cui fu instancabile raccoglitore e descrittore, segnando un passo avanti notevolissimo anche rispetto a Boccone. Da segnalare è anche l'attenzione alle produzioni agricole locali e soprattutto alle varietà delle piante fruttifere, che ne fanno un antesignano della pomologia: ad esempio, sono elencate e puntigliosamente descritte 35 varietà di mandorli, 48 di fichi, 45 di meli, 73 di peri, 48 di viti, 20 di limoni, 21 di aranci, 5 di cedri. Mentre scriveva Hortus Catholicus, Cupani già pensava a un progetto ancora più ambizioso: una vasta opera illustrata che avrebbe fatto conoscere al mondo la natura siciliana, descrivendo non solo le piante, ma anche gli animali, le conchiglie, i fossili, i minerali. Secondo quanto scrive nel prologo della prima edizione di Hortus Catholicus, intorno al 1696 il lavoro era già abbastanza avanzato: erano state incise 600 delle 800 lastre di rame previste (a pagarle fu evidentemente il generoso principe di Cattolica, che contava di trarre gloria europea dal munifico investimento); per quanto riguarda le piante era sua intenzione specificarne la denominazione secondo le indicazioni dei Bauhin e di Morison, il luogo di origine, le proprietà officinali, l'etimologia, i sinonimi in latino, il nome volgare, il segno celestiale, l'astro dominante e l'epoca più indicata di raccolta. Nel supplemento dell'anno successo, ci informa che ormai le lastre erano tutte pronte e il manoscritto a buon punto, tanto che contava, Dio volendo, di completarlo in pochi mesi. Ma, evidentemente, Dio non volle: il lavoro di raccolta e verifica si prolungò più del previsto e nel 1710 Cupani morì prematuramente, a poco più di cinquant'anni, lasciando l'opera incompleta. Torneremo più avanti sulla sorte di quell'opera sfortunata, per soffermarci sulle vicende successive del giardino di Misilmeri. Morto Cupani, che lo aveva fondato e diretto per quasi vent'anni, la direzione passò successivamente a due suoi collaboratori, Pietro Citraro e Francesco Scaglione. Nel 1714 ricevette la visita di Vittorio Amedeo II, appena divenuto re di Sicilia. Tuttavia nel 1721 Giuseppe del Bosco morì senza lasciare eredi diretti, e le proprietà e i feudi passarono al figlio di una sorella, Francesco Bonanno del Bosco. Nel corso del Settecento, i Bonanno sperperarono il patrimonio familiare. A risentirne fu anche lo splendido ma dispendioso giardino, via via sempre più trascurato. Intorno alla metà del secolo, ebbe ancora un sussulto, grazie all'arrivo da Padova dell'abile capo giardiniere Giovanni Maria Lattini, ma quando questi lasciò l'incarico, insoddisfatto del salario, il declino divenne inarrestabile. Nel 1785, all'atto della fondazione dell'orto botanico di Palermo, con il benestare del principe in carica, 2000 piante tra le più rare furono espiantate e traslate nel nuovo giardino, insieme a vasche di marmo, sedili di pietra e altro materiale. Da quel momento dell'antico Hortus Catholicus del principe Giuseppe del Bosco e di Francesco Cupani rimase solo il ricordo.  Da Cupania a Cupaniopsis A testimoniare il ruolo di Cupani nella scoperta delle piante sicule sono le diverse specie che lo ricordano nell'epiteto, come Colchicum cupanii, Genista cupanii, Aira cupaniana e la già citata Euphorbia pithyusa subsp. cupanii. Tributo alla fama europea del giardino e del suo creatore è invece la dedica del genere Cupania da parte di Plumier, che cita il giardino "ricchissimo di piante fatte venire dalle più remote contrade del mondo" nonché il suo "ordinatissimo catalogo". Poi validato da Linneo, il genere Cupania, della famiglia Sapindaceae, esclusivo dell'America tropicale, dal Messico all'Argentina, con centro di diversità in Brasile, comprende circa 60 specie di alberi e arbusti, che vivono in vari habitat, dalle foreste stagionalmente aride alle foreste pluviali. Benché presentino sia fiori femminili sia fiori maschili sulla stessa pianta, sono funzionalmente dioiche e poligame, poiché i fiori staminati (maschili) e quelli nettariferi (femminili) si aprono in momenti diversi. Hanno foglie composte alternate, con nervature molto evidenti, generalmente coriacee, spesso con faccia superiore glabra e inferiore tomentosa; i fiori, piccoli, con cinque petali e cinque sepali, sono raccolti in grandi infiorescenze spesso molto ramificate e sono seguiti da capsule che contengono semi arillati. Tra le specie di maggiore diffusione, citiamo C. cinerea, originaria delle foreste umide dalla Costa Rica al Brasile, a volte coltivata come ornamentale; particolarmente notevoli i frutti, che a maturazione si aprono formano una stella coriacea con al centro semi neri avvolti in un arillo aranciato. Per la sua chioma elegante, è spesso utilizzata nelle alberature anche C. vernalis, diffusa dalla Bolivia al Brasile e all'Argentina settentrionale. A celebrare indirettamente Cupani, si è aggiunto il genere Cupaniopsis ("simile a Cupania"), stabilito da L.A.T. Radlkofer nel 1879. Anch'esso appartenente alla famiglia Sapindaceae, raggruppa una quarantina di specie di alberi e arbusti diffusi in Nuova Guinea, in Australia e nelle isole del Pacifico; ricorda Cupania per le foglie composte e i frutti a capsula. Purtroppo molte piante di questo genere, endemiche di piccole aree, sono minacciate, in pericolo di estinzione o addirittura già estinte, come C. crassivalvis della Nuova Caledonia, dichiarata estinta nel 1998. La specie più nota è l'australiana C. anacardioides, nota con il nome vernacolare tuckeroo. E' un piccolo albero originario delle foreste litoranee dell'Australia orientale e settentrionale. Più che al momento della fioritura, diventa spettacolare al momento della fruttificazione, quando produce grandi grappoli di capsule aranciate che si aprono in tre lobi, rivelando i semi scuri ricoperti da un arillo arancio brillante; sono appetiti da numerose specie di uccelli. Per la sua bellezza, anche questa specie è spesso utilizzata nelle alberature stradali, soprattutto nelle zone costiere vista la sua tolleranza alla salinità.  Un'opera maledetta e una pianta tossica Per concludere, resta ancora da raccontare della sorte dell'ultima opera inedita di Cupani. Nel 1713, probabilmente per volontà del principe, sotto il titolo Panphyton siculum vennero stampate le sole immagini, con una tiratura di poche copie (se ne conoscono in tutto sette), per altro diverse tra loro, tanto da fare pensare a prove di stampa. I manoscritti furono invece affidati, perché li completasse e li preparasse per la stampa, al farmacista Antonio Bonanno, nei testi d'epoca spesso chiamato Antonino, figlio di Vincenzo, uno dei collaboratori di Cupani, e di una figlia di Nicola Gervasi (per questo motivo, è anche noto come Bonanno Gervasi). Bonanno riuscì a rivedere e predisporre un primo volume, con 187 tavole, che fu stampato nel 1719, ma lo stesso anno morì. Come abbiamo già visto, nel 1721 morì anche il principe, e con la sua morte ebbe fine ogni tentativo di pubblicare quell'opera sfortunata. I manoscritti furono ereditati da un'altra famiglia di farmacisti imparentata con i Bonanno, i Chiarelli, che custodirono gelosamente una copia di Panphyton Siculum in quattro volumi, appartenuta a Antono Bonanno con le sue annotazioni manoscritte, e 16 volumi di note manoscritte di Cupani. Desideravano pubblicarli, ma mancavano le risorse finanziarie. Il momento giusto sembrò arrivare quando entrarono in contatto con il botanico statunitense Rafinesque, che visse in Sicilia dal 1805 al 1815. Deciso a far risorgere il Panphyton, da lui ribattezzato Panphysis sicula, fece approntare copie delle incisioni e cercò di coordinare i suoi sforzi con quelli dei Chiarelli, ma poi anche lui dovette rinunciare. Nel 1815, quando ripartì dall'America, portò con sé le 121 tavole di incisioni che era riuscito a far preparare; al largo del Connecticut si inabissarono nelle acque dell'oceano, insieme alla biblioteca di Rafinesque e circa 60 casse di collezioni; il botanico salvò la vita, ma dovette ricominciare dal nulla. Non stupisce che egli abbia voluto ricordare il tentativo dell'altrettanto sfortunato Bonanno; nel 1814 pubblicò su un giornale siciliano, Specchio delle scienze, il genere Bonannia (Sapindaceae) con queste parole "Questo genere ha gran somiglianza con Cupania [...]; gli ho perciò dato il nome di Bonannia in onore di Antonino Bonanni Gervasi, discepolo ed illustratore del P. Cupani, e del P. Filippo Bonanni gesuita, autore di una conchilogia". Pubblicato su una rivista locale, il nuovo genere passò inosservato. Come nomen rejicendum, è oggi sinonimo di Blighia. Nel 1826, fu la volta del boemo Presl che in Flora Sicula creò un secondo genere Bonannia (Brassicaceae), in onore tanto di Vincenzo quanto di Antonio Bonanno "coetanei e discepoli del reverendo Cupani". Oggi è sinonimo di Brassica. Infine, nel 1843 Gussani in Florae Siculae Synopsis creò un terzo genere Bonannia (Apiaceae); anche se non lo cita esplicitamente, il riferimento a una tavola del volume curato da Bonanni, fa presumere che il dedicatario sia sempre lui; benché sia l'ultimo arrivato, fu accettato dalla comunità scientifica ed è tuttora valido come nomen conservandum. Si tratta di un genere monotipico, rappresentato dalla sola B. graeca, una rara erbacea dei pascoli montani aridi, presente in Sicilia dal Messinese al Palermitano, in Calabria nella Sila e nel Pollino e in poche località sparse in Grecia e nell'Egeo. E' un'erbacea perenne, alta fino a 30 cm, con foglie basali lanceolate e foglie cauline ridotte a guaine, e fiori gialli riuniti in ombrelle. Tutta la pianta emana una resina giallastra tossica, che può causare la morte degli agnelli. Paolo Boccone, che prese il nome di Silvio quando entrò nell'ordine cistercense, è uno dei più importanti botanici italiani del Seicento, certo il più noto a livello interazionale, grazie ai suoi viaggi, ai molti contatti, all'erudizione delle sue opere. Lo testimoniano i luoghi di pubblicazione, che vanno da Parigi a Oxford, da Amsterdam a Venezia, e i molti erbari che confezionò per i suoi protettori e mecenati, conservati a Lione, Parigi, Leida, Oxford, Innsbruck, Vienna, Breslavia. Il suo maggior merito fu attirare l'attenzione degli studiosi europei sulla peculiare flora siciliana, che fu uno dei primi ad esplorare. Plumier, che fu suo allievo a Roma, volle onorarlo con il genere Bocconia, poi validato da Linneo. 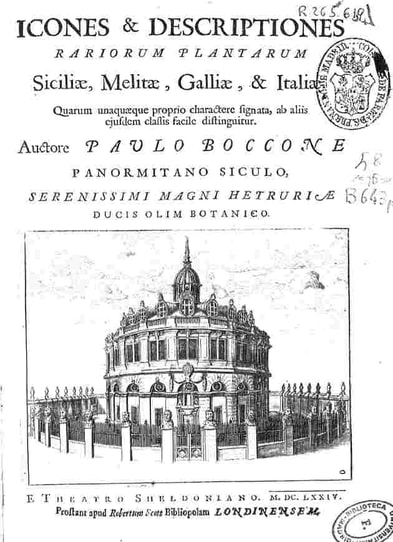 Da Palermo a Parigi Il palermitano Paolo Boccone (1633-1704) fu una figura di caratura internazionale per le sue ricerche che, oltre alla botanica, toccarono la chimica, la mineralogia, la natura dei fossili, le eruzioni dell'Etna e molti altri argomenti. Eppure, la sua biografia è tutt'altro che chiara, e molte delle notizie che si ripetono su di lui mancano di prove: ad esempio, non è affatto provato che la sua famiglia fosse di nobili origini, né che si sia laureato a Padova, né tanto meno che abbia insegnato in quell'ateneo. Molto incerta è la cronologia della sua vita, in particolare dei viaggi che lo portarono a visitare molti paesi europei. Nacque a Palermo da una famiglia oriunda di Savona e si ritiene si sia avvicinato alla botanica, alla chimica e alla scienze naturali grazie alla frequentazione di Pietro Castelli e dell'orto botanico di Messina, ma neppure di questa notizia spesso ripetuta abbiamo alcuna evidenza; fu invece con certezza allievo del matematico Giovanni Alfonso Borelli, che conobbe a Messina e di cui intorno al 1655 seguì le lezioni a Pisa. Lasciata la Sicilia, continuò infatti gli studi a Perugia, a Padova e nella città toscana. Nella seconda metà degli anni '50 dovette fare la spola tra la Sicilia e la Toscana, dove sperava di inserirsi stabilmente alla corte del granduca. In effetti per qualche tempo divenne uno dei semplicisti di Ferdinando II; nel frontespizio di gran parte delle sue opere, non manca di ostentare questo titolo, usando formule diverse: "botanico del serenissimo duca di Toscana", "serenissimi magni Hetruriæ ducis Phylliatra", "Herboriste de Ferdinand II de glorieuse mémoire Grand-Duc de Toscane"; il suo compito principale doveva essere quella di raccogliere piante e semi per arricchire i giardini granducali, nonché gli orti dei semplici di Pisa e Firenze. Era però una posizione subordinata e poco soddisfacente (nella dedicatoria a Cosimo III di Recherches et observations naturelles del 1674 scrive più realisticamente "per qualche tempo ho avuto l'onore di essere uno degli erboristi del fu Monsignore vostro padre"); Boccone dunque si rassegnò a tornare in Sicilia, dove si fissò almeno dal 1663. Si sposò e cercò di conciliare gli impegni familiari (che egli definisce "noiosi", ovvero penosi e difficili) con le ricerche naturalistiche, specialmente con il "diletto di osservar piante", che lo portò a percorrere molte contrade dell'isola. Erano un oggetto di studio, ma anche un cespite d'entrate; nel 1668 a Catania pubblicò l'elenco di piante siciliane Manifestum botanicum de plantis Siculis, il cui scopo commerciale è palese nella riedizione dello stesso anno, Elegantissimarum plantarum cultoribus, nec non obseruatoribus perdoctis, quibus forte desunt infrascripta semina nunc recentia offeruntur, & communicantur honesto pretio per Paulum Boccone Panormitanum, ovvero un catalogo di semi offerti a studiosi e appassionati a giusto prezzo. Importante fu la frequentazione del pittore messinese Agostino Scilla, con il quale condivideva l'interesse per i fossili, la geologia, le specie marine e quelle strane forme che paiono al confine tra i regni della natura: coralli, madrepore, fossili marini, pietre a forma di conchiglia o di lingua. In questi anni risiedeva nella Sicilia orientale, tra Leontini, Messina e Catania, dove pubblicò i suoi cataloghi e il suo primo saggio naturalistico, Della pietra belzuar minerale Siciliana, dedicato a Giacomo Ruffo visconte di Francavilla e scritto sotto forma di lettera al farmacista bolognese Giacomo Zannone, uno dei suoi clienti e corrispondenti. Nel 1668 visitò Malta, dove stabilì qualche utile contatto, raccolse poche piante (nel libro sulla flora siciliana e maltese che pubblicherà qualche anno dopo a Oxford ne figurano solo tre e un fungo), ma molti fossili tra cui le ricercatissime glossopietre. Rientrò poi a Messina, dove fece escursioni e ricerche congiunte con Scilla. Ebbe anche modo di assistere all'eruzione dell'Etna, la più importante dell'epoca. Si trovava nell'isola ancora nel marzo 1669, come risulta da una lettera a Redi in cui accenna all'acquisto di semi per l'orto botanico di Pisa su incarico del granduca. La morte della moglie, avvenuta quell'anno, e la speranza di reinserirsi nell'ambiente toscano lo spinsero a lasciare l'isola. Nella seconda metà del 1669 era a Firenze, dove mostrò le sue collezioni al granduca, ma la morte di quest'ultimo nel maggio 1670 lo convinse a cercare fortuna altrove. Munito di lettere di presentazione dell'archiatra Giovanbattista Gornia, di altri medici toscani e del Gran Priore dell'ordine di Malta Valencé, si imbarcò per la Francia. Dalle raccolte botaniche, risulta che erborizzò nei dintorni di Marsiglia ed Aix e nell'Isola Ste Marguerite, di fronte a Cannes. Fu poi a Lione, dove è conservato uno dei suoi erbari e per tre mesi insegnò la bella arte della botanica a due distinte dame (come aveva già fatto in Italia con "gentiluomini di prima qualità"). Era sicuramente a Parigi all'inizio del 1671; infatti, secondo quanto egli stesso scrive nel curioso dialogo "Entretien d'un Seigneur de la Cour de France avec M. Boccone" che conclude Recherches et observations naturelles sur la production de plusieurs pierres, nell'aprile di quell'anno aveva iniziato a tenere nella sua casa parigina quelli che potremmo definire dei seminari in cui presentava le curiosità che aveva portato con sé dall'Italia e determinava le piante proposte dai partecipanti: ognuno era invitato a portarne con sé "fino a mezza dozzina, fresche o essiccate, per essere esaminate, scegliendole tra le più curiose e le più rare"; gli incontri si tenevano il giovedì all'una, ogni due settimane, e Boccone vi parlava “di piante, di animali, di pietre, di metalli, e di tutto ciò che di più raro e prezioso la natura racchiude nel suo seno”. Dal dialogo scopriamo anche che il botanico siciliano aveva portato con sé i semi di piante da offrire al Re cristianissimo per arricchire il Jardin du Roi, e a tal fine aveva preso contatto con il sovrintendente Vallot, che li aveva rifiutati, sostenendo che erano vecchi e non più vitali, anche se Boccone chiedeva di essere ricompensato solo per quelli che avrebbero germinato. Non era dunque un dono, ma una transazione commerciale. Il trattatello, stampato a Parigi appunto nel 1671, oltre al dialogo fittizio, contiene cinque saggi in forma di lettera su pietre dalle forme curiose, la pietrificazione di parti di animali e l'eruzione dell'Etna, che riproducevano in forma scritta le conferenze tenute da Boccone all'Accademia privata fondata dal medico del principe di Condé, l'abate Pierre Bourdelot. Seguì una seconda serie, intitolata Recherches et observations curieuses sur la nature du corail, con ulteriori cinque lettere sul corallo e alcuni pesci; nell'introduzione dell'editore si preannuncia la prossima uscita di un'opera illustrata totalmente dedicata alle piante. Rispetto a un opuscolo con poche immagini, si trattava di un'operazione editoriale decisamente costosa, che Boccone non poteva affrontare senza un mecenate. In realtà, proprio grazie a Bourdelot, ne aveva incontrato uno dal nome altisonante, appunto il gran Condé; ma il principe, in disgrazia per la sua partecipazione alla Fronda, era privo di ogni influenza politica e viveva lontano dalla corte, nella sua tenuta di Chantilly; Boccone dovette frequentarla con una certa assiduità e una sua erborizzazione è testimoniata dal Cahier de Chantilly, un quaderno di piccolo formato probabilmente di sua mano in cui le piante raccolte sono elencate utilizzando per lo più la nomenclatura del Pinax di Caspar Bauhin; la seconda parte del manoscritto è un erbario, non costituito da exsiccata, ma da impressioni ottenute inchiostrando esemplari secchi, una tecnica impiegata qualche anno primo anche da Fabio Colonna e perfezionata dallo stesso Boccone. Era invece un più tradizionale erbario di piante essiccate quello che Boccone avrebbe approntato per un altro principe reale in odore di Fronda, il botanofilo Gastone d'Orlèans, ugualmente conservato a Parigi; visto che il principe morì nel 1660, quando Boccone viveva ancora in Toscana ed era del tutto sconosciuto, è escluso che gli sia mai appartenuto, tanto più che contiene piante sicuramente raccolte da Boccone nelle Fiandre nel 1672; moltissimi esemplari sono invece comuni all'erbario del Principe di Condé, anche se non sappiamo quando e per chi il botanico siciliano preparò il cosiddetto "erbario di Gastone d'Orlèans". 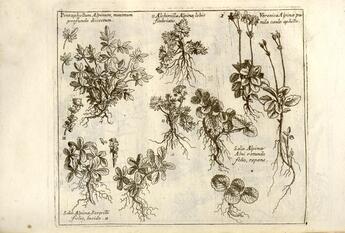 Un naturalista di fama europea Nel 1672 Luigi XIV si decise a riabilitare il gran Condé per servirsi del suo genio militare nella campagna contro l'Olanda. Una buona notizia per lui, ma non necessariamente per Boccone, che vide il suo principale protettore partire per il campo di battaglia. Forse il suo manoscritto, con le descrizioni delle piante raccolte in Sicilia, a Malta, in altre regioni italiane e in Francia e le illustrazioni a stampa diretta, era pronto, ma mancava chi lo finanziasse. Ma la cronologia si imbroglia di nuovo; non sappiamo quando abbia lasciato la Francia né se abbia visitato altri paesi, a parte una visita ad Anversa nel 1672. Di certo invece si trovava a Londra il 5 maggio 1673, giorno in cui presentò alla Royal Society, alla quale aveva donato un gabinetto di curiosità e una piccola natura morta di Agostino Scilla, una memoria su alcune pietrificazioni siciliane. Fu presumibilmente in questo ambiente che conobbe un gentiluomo appassionato di botanica e giardinaggio, Charles Hatton, che era stato allievo di Robert Morison e decise di inviare il manoscritto al suo maestro. L'arrogante Morison per una volta comprese pienamente il valore di quel materiale, e si diede da fare per prepararlo per la pubblicazione. Hatton, benché non fosse un nababbo, non fece mancare il sostegno finanziario, così nel 1674, per i tipi dell'Università di Oxford, uscì Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae, con la descrizione di un centinaio di piante (ci sono anche alcuni funghi), più della metà delle quali siciliane, e incisioni ricavate dalle immagini a stampa diretta; saltando i passaggi del dipinto e del disegno al tratto, i costi si riducevano di molto, ma i risultati, tranne che nei casi di piante minute o dalle forme lineari, lasciano spesso a desiderare; diverse immagini erano di qualità così bassa che Morrison le scartò e le sostituì con sette incisioni calcografiche, che furono pagate da Hatton così come la stampa. Con il libro fresco di stampa, Boccone ripartì alla volta dell'Olanda, deciso a farlo conoscere e cercare nuovi sponsor per stampare le sue opere erudite sulle curiosità naturali; sappiamo che pensò a Hieronymus van Beverningh, il protettore di Paul Hermann, visitò diversi gabinetti di curiosità, donò uno dei suoi erbari a Arnold Seyen, professore di botanica a Leida. Tra gli altri, incontrò il microscopista Johannes Swammerdam, perfezionando l'uso del microscopio che fu il primo ad applicare allo studio dei fossili. Incontrò anche il farmacista Johann Breyne, ma mancò il nipote Jacob, il collezionista e botanico di Danzica. Nel 1674 ad Amsterdam uscì Recherches et observations naturelles, che riprende ed amplia le pubblicazioni parigine e le comunicazioni alla Royal Society; le lettere, indirizzate ad eminenti esponenti della scienza italiana, francese, inglese e olandese, sono ora 29, e toccano argomenti disparati. In ogni caso, assicurarono la fama europea di Boccone. Sulle vicende successive e sulla data del rientro in Italia di nuovo la cronologia e i percorsi (ricavabili per lo più dai luoghi di raccolta delle piante citate in Museo di piante rare e da notizie sparse in varie opere) si fanno incerti e intricati. Forse tornò per qualche tempo in Francia, e certo sulla via del ritorno visitò il Delfinato e la Savoia (raccolse alla Grande Chartreuse e a Chambéry), varcò le Alpi al passo del Moncenisio, dove fece notevoli raccolte, quindi visitò il giardino reale di Torino. Fu poi la volta della Liguria, da dove passò in Corsica, visitata nel 1677. Nel 1678 era a Roma, dove ritrovò Agostino Scilla e frequentò l'accademia fisico-matematica fondata da Giovanni Giustino Ciampini, di cui condivideva il metodo sperimentale e lo spirito di ricerca. Lo si vedeva anche alle riunioni dell'Accademia reale voluta da Cristina di Svezia, cui donò l'ennesimo erbario. Passato per donazioni successive all'Istituto botanico di Genova, è probabilmente andato perduto durante la seconda guerra mondiale. Forse Boccone anche a Roma teneva lezioni ed accademie come quelle parigine; certo tra i suoi discepoli vi fu Charles Plumier, che in quegli anni studiava presso il convento dei minimi di Trinità dei monti. In questo stesso torno di anni, incominciò a corrispondere con Francesco Cupani, incoraggiandolo ad esplorare la flora siciliana. Non sappiamo come maturò la decisione, alla vigilia dei cinquant'anni, di abbracciare lo stato ecclesiastico. Nel 1682 entrò nell'ordine cistercense, assumendo il nome di Silvio (Sylvius) e svolgendo il noviziato a Firenze. Non per questo cessò di studiare e di viaggiare per raccogliere piante e oggetti naturali. Nel 1684 pubblicò a Bologna Osservazioni naturali, sempre sotto forma di lettere a medici e dotti soprattutto bolognesi e veneti, dedicate ad argomenti disparati, in cui sembrano prevalere gli aspetti più curiosi della natura, dai "fuochi naturali" di cui i contadini modenesi si servono per cucinare alle formiche o mosche odorose della campagne pisane. Delle piante si parla soprattutto per le proprietà farmacologico-terapeutiche, ma nella lettera 21 si disquisisce "delle cause della viridità perpetua di alcune piante in tutte le stagioni". Bologna non fu certo l'ultima tappa della sua vita errabonda. Nella biblioteca nazionale di Vienna sono conservati due piccoli erbari di Boccone, da lui dedicati "alla sacra maestà cesarea di Leopoldo Primo", in cui probabilmente sperava di trovare l'ennesimo mecenate. Il primo è intitolato "Piante originali e rare ostensive", è firmato Paolo Boccone ed è relativo alle piante di Icones et descriptiones; il nome secolare e il contenuto ci rimandano a una data precedente il 1682, forse addirittura agli anni francesi. Il secondo, intitolato "Piante dell'Austria", è invece firmato Silvio; sul recto di ciascun foglio sono incollate piante piuttosto comuni dei dintorni di Vienna, sul verso sintetiche indicazioni sul loro uso terapeutico, certamente di mano del botanico siciliano, di cui documentano il passaggio in Austria probabilmente negli anni '90. Sono gli anni in cui Boccone, con il nome onorifico di Plinius II, è ammesso all'Accademia curiosorum naturae di Halle, posta sotto l'alto patronato di Leopoldo I e ribattezzata Accademia cesarea leopoldina. Come risulta da Museo di piante rare, da Vienna si spostò a Brno, Bratislava, quindi potrebbe aver raggiunto Wroclaw, dove è conservato un altro erbario. Secondo una serie di documenti in gran parte inediti ritrovati dalla studiosa palermitana Floriana Giallombardo, i viaggi in Europa centrale si collocano tra il 1694 e il 1697. Ma era soprattutto di casa in Veneto. Nel 1694 fece raccolte in Dalmazia e nel 1697 pubblicò a Venezia Museo di fisica e di esperienze, l'ultima delle grandi opere miscellanee su svariati argomenti di scienze naturali, e Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, la più ampia delle sue opere botaniche. L'impostazione è assai diversa rispetto alla sintetica opera oxoniense: le descrizioni delle piante, che rimangono brevi o brevissime, sono riunite in gruppi o decadi affini per qualche ragione (ad esempio, le analoghe proprietà medicinali, l'origine alpina, il profumo simile delle foglie) e si alternano a trattati più ampi, sotto forma di lettere aperte ad altrettanti dotti e mecenati. Le tavole, di buona qualità, non sono più alternate al testo, ma riunite nella seconda parte del volume; ne risulta un'opera corposa, di quasi 200 pagine di testo e 130 tavole calcografiche con 319 figure. È dedicato "ad alcuni nobili patritii Veneti protettori della botanica, e delle buone lettere", ovvero agli sponsor che aprirono la borsa per finanziare il bello e certamente costoso volume. Alle piante già pubblicate in Icones et descriptiones si sono aggiunte quasi duecento nuove specie; i nuclei principali di raccolta, il cui luogo è quasi sempre puntigliosamente indicato, sono il Moncenisio, le Alpi Apuane, la Corsica, l'Appennino modenese e la zona di Norcia/Monti Sibillini; frequenti pure le raccolte dei territori di Bologna, Roma e Padova. Se il grosso Boccone lo raccolse personalmente, qualche specie si deve a doni e invii di amici e corrispondenti; il gruppo più cospicuo gli fu donato dal domenicano francese Jacques Barrelier, che probabilmente Boccone conobbe a Parigi (e non a Roma, come scrivono alcuni). Nella prefazione, Boccone racconta che fu incoraggiato a pubblicarlo da William Sherard, che nel 1697 come lui si trovava a Venezia; quando gli mostrò le sue raccolte, l'inglese confermò che molte piante erano inedite. L'anno successivo, il volume fu recensito da John Ray sulle Transactions della Royal Society, che ne riconosce l'importanza ("ci offre una vasta collezione di piante rare, la maggioranza delle quali sono nuove e mai descritte"), ma rimarca tre difetti: le piante sono collocate senza alcun ordine o connessione; le descrizioni si limitano a pochi elementi, senza una sufficiente descrizione delle parti principali; mancano i sinonimi delle piante descritte da altri botanici; prosegue poi facendo le pulci a diversi passi specifici. Questa recensione agrodolce è comunque una carezza in confronto alla reazione di Antoine de Jussieu che accusò Boccone di plagio per aver pubblicato alcune piante raccolte da Barrelier (di cui per altri riconosce sempre apertamente la paternità). Dopo il grande exploit dei due Musei, Boccone dovette ritornare a Palermo; visse gli ultimi anni nella Abbazia di Santa Maria di Altofonte in Parco, a 5 km dalla città, divenendone anche priore; qui morì nel 1704. Come pioniere dello studio della flora siciliana, e più in generale mediterranea, gli è stata dedicata la rivista Bocconea, edita dalla fondazione internazionale Pro Herbario Mediterraneo.  Una bella invadente Come scopritore di decine di specie inedite (intorno a 120), Boccone è ricordato dall'epiteto di numerose specie, dallo splendido Eryngium bocconei a Limonium bocconei, da Seseli bocconei a Hieracium bocconei. Il genere Bocconia si deve a Plumier che in Nova plantarum americanarum genera riserva a Boccone termini assai elogiativi: "Il reverendo padre Dom Silvio Boccone, in precedenza Paolo Boccone, nobile gentiluomo palermitano, celeberrimo in tutto il mondo letterario per le sue opere sia botaniche sia naturalistiche, che dopo aver contemplato molte parti del mondo terrestre, si accinge a meditare su quello celeste, essendo stato accolto nell'ordine cistercense a Firenze". Non fa cenno di esserne stato allievo, ma confermò la circostanza all'amico Garidel. Fatto proprio da Linneo, il genere Bocconia (Papaveraceae) riunisce una decina di specie di arbusti e piccoli alberi, diffusi nei Caraibi, in Messico e in Sud America. Hanno rami sottili, grandi foglie lobate o dentate, piccoli fiori apetali raccolti in pannocchie terminali; i rami spezzati emanano un latice giallastro o arancio, con proprietà antidolorifiche; dalla corteccia di alcune specie si ricava invece una tintura gialla. La specie più nota e diffusa è B. frutescens, nativa del Messico, delle Antille e di parti del centro e del Sud America, dove si trovi in habitat diversi, dalle foreste aride a quelle umide, incluse quelle nebulose, nonché in terreni disturbati. E' un grande arbusto o piccolo albero, alto fino a sei metri, molto ramificato, con rami sottili e intricati, che portano all'apice gruppi di grandi foglie profondamente lobate. Benché i fiori siano privi di petali, le grandi infiorescenze a pennacchio risultano piuttosto decorative. Per questo, intorno al 1920 è stata introdotta come pianta da giardino nelle Hawaii, dove si è rivelata una pericolosa infestante. Produce infatti una grande quantità di piccoli frutti, mangiati e dispersi dai semi, e cresce in fretta, sottraendo luce e nutrienti alle piante native. Non fa invece più parte del genere B. cordata, trasferita al genere Macleaya come M. cordata. Grazie alla grande variabilità morfologica e geologica del territorio, la flora sarda è particolarmente varia; inoltre, come avviene spesso nelle isole, è ricca di endemismi (circa 340 su un totale di 2410 entità, ovvero il 15% del totale). La Sardegna è dunque di grande interesse per i botanici anche oggi; tanto più lo era all'inizio dell'Ottocento quando era un territorio pressoché inesplorato per la scienza. Niente da stupirsi dunque se il giovane medico Giuseppe Giacinto Moris, appassionato botanico formatosi all'Orto di Torino, quando il governo piemontese lo spedì a Cagliari ad insegnare chirurgia, fece di tutto per non farsi sfuggire l'occasione di essere il primo a scrivere una Flora Sardoa. Fu l'impresa della sua vita: prima sette anni di ricerca sul campo in cui visitò quasi ogni angolo dell'isola, poi la pubblicazione di tre volumi (un quarto rimase inedito) protrattasi per oltre un ventennio. Capace e intraprendente direttore dell'Orto botanico di Torino per quasi quarant'anni, Moris fu anche senatore del Regno. A ricordarlo, oltre ai nomi specifici di diverse delle piante, la rara Morisia monanthos, endemica di Corsica e Sardegna. 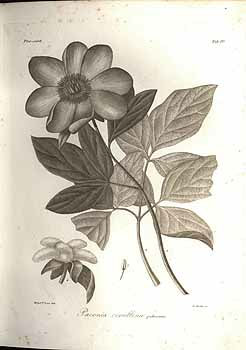 Un territorio tutto da scoprire Nei primi decenni dell'Ottocento, per un botanico entusiasta c'era ancora molto da scoprire anche nella vecchia Europa. Una delle aree pressoché inesplorate era la Sardegna che, al contrario delle regioni continentali degli stati sabaudi, era stata toccata solo marginalmente dalla grande ricognizione botanica promossa da Allioni e dai suoi allievi. Unica eccezione, le ricerche del medico Michele Antonio Plazza (1720-1791), titolare della prima cattedra di Chirurgia all'Università di Cagliari, che erborizzò nel Cagliaritano e nel sud dell'isola e fu in corrispondenza con Allioni; quest'ultimo, sulla base delle sue raccolte, nel 1759 pubblicò Fasciculus stirpium Sardiniae in Diocesi Calaris lectarum, il primo vero studio sulla flora sarda, in cui esaminò 136 specie (tutte abbastanza comuni). Plazza probabilmente intendeva scrivere egli stesso una flora sarda, ma il suo manoscritto, in cui le specie descritte sono 818, rimase inedito fino all'inizio del Novecento. Agli inizi degli anni '80, nel corso del suo viaggio mediterraneo, anche il celebre botanico norvegese Martin Vahl toccò rapidamente l'isola, dove scoprì una nuova specie di sparto o ginestra, di cui inviò un campione a L'Héritier de Brutelle (si tratta di Genista ephedroides DC, un endemismo sardo). Dunque, nel 1822, quando arrivò a Cagliari per assumere la cattedra di clinica medica, il ventiseienne medico Giuseppe Giacinto Moris, aveva un'intera flora da esplorare e da scoprire. Allievo prima di Balbis, che aveva acceso in lui l'entusiasmo per la botanica, poi di Capelli (direttore dell'orto torinese dal 1817 al 1831) probabilmente iniziò i suoi viaggi botanici fin da subito, e sicuramente dal 1823. Non era un compito facile: quasi non esistevano strade (la costruzione della Carlo Felice, che per la prima volta collegò il nord e il sud dell'isola era appena iniziata, e sarebbe stata terminata solo nel 1830), non c'erano alberghi, imperversavano il tifo e la malaria, non mancavano banditi e briganti. Bisognava dunque muoversi a cavallo, dormire all'aperto o chiedere ospitalità ai maggiorenti locali. Nelle sue prime spedizioni, Moris ebbe il sostegno di alcuni membri della Reale Società Agraria Economica di Cagliari, in particolare il canonico Murcas, Preside del Collegio dei Nobili e l'Intendente generale Greyffier, entrambi appassionati di botanica. Ma soprattutto trovò un compagno e un amico in Alberto La Marmora (1779-1863). Militare di carriera, quest'ultimo, sospettato di aver preso parte ai moti del 1821, era stato costretto alle dimissioni e esiliato in Sardegna, di cui cominciò a studiare la geologia, l'archeologia, la storia e a tracciare nuove carte, divenendo in breve il fondatore degli studi sardi in tutti questi campi. 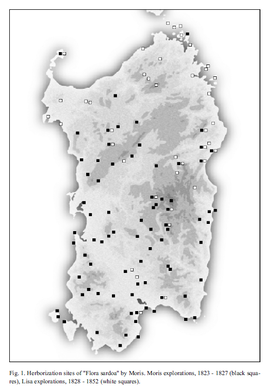 Un'esplorazione in profondità e un'opera fondamentale La prima spedizione documentata di Moris è del maggio 1823, quando insieme a Greyffier e La Marmora, muovendo da Cagliari visitò Aritzo e il Gennargentu. A giugno, ancora con La Marmora, era la volta di Domusnovas e del Sulcis. L'anno successivo, come riferisce in una lettera a Capelli, fu nelle zone più insalubri dell'isola (non sappiamo esattamente dove), forse in compagnia di Philippe Thomas, membro di una famiglia di botanici svizzeri, che in quel periodo viveva a Cagliari. Fino a quel momento, Moris, che era in Sardegna a insegnare chirurgia, non aveva alcun incarico ufficiale come botanico. Deciso a continuare le sue ricerche con l'obiettivo di scrivere una flora della Sardegna, attraverso Capelli incominciò a fare pressioni sul governo di Torino per essere esonerato dall'insegnamento e essere ufficialmente incaricato di esplorare la flora sarda; chiedeva anche finanziamenti, testi scientifici aggiornati e personale di supporto. La dispensa dall'insegnamento giunse nell'agosto del 1824 e all'inizio del 1825 da Torino arrivò Carlo Giuseppe Bertero, però non nelle vesti di aiutante, come credeva Moris, ma come direttore della missione; sebbene i rapporti personali tra i due fossero eccellenti e basati sulla stima reciproca, si generò una situazione equivoca cui mise fine lo stesso Bertero che preferì rientrare a Torino dopo pochi mesi. In ogni caso i due botanici piemontesi, sempre in compagnia di La Marmora, tra maggio e giugno avevano visitato il Sulcis e Iglesias. Partito Bertero, Moris continuò l'esplorazione con La Marmora, visitando Ogliastra, Fonni e nuovamente il Gennargentu. Fu durante una di queste escursioni che capitò un gustoso incidente riferito da La Marmora: Moris aveva raccolto numerose Malvaceae e le aveva disposte con cura in mezzo a fogli di carta in una cartella che portava sul dorso; avendo visto una pianta interessante, scese da cavallo, e, passandosi una briglia sotto il braccio per evitare che l'animale si allontanasse, si inginocchiò per raccogliere l'esemplare; nello sforzo, la cartella si aprì e venne a trovarsi proprio sotto il muso del cavallo che ne approfittò per farsi una bella scorpacciata. Il materiale raccolto incominciava ad essere ingente e, nonostante l'aiuto di Thomas, Moris si trovò in difficoltà. Fortunatamente, da Torino giunse l'incarico ufficiale e anche il sospirato assistente, nella persona di Domenico Lisa, giardiniere dell'Orto torinese, che sarebbe stato suo compagno nelle campagne del 1826-1827. Quella del 1826, con Lisa e La Marmora, fu un lungo giro di due mesi (maggio-luglio) nella Sardegna centrale, toccando tra le altre località Carloforte, Monte Arcuentu, Capo Frasca, Uras, Morgongiori, Flumentorgiu, Laconi, Gennargentu, Aritzo, Tonara, Desulo. Ancora più ampia fu la spedizione del 1827. Partiti da Cagliari l'ultima settimana di aprile, i tre compagni attraversarono l'intera isola, visitando Arbus, Ales, Santu Lussurgiu, Planargia, Bosa, Sindia, Bonorva, Monte Santo, Ozieri, Monte Rasu. Qui Moris e Lisa si separarono da La Marmora, continuando verso nord con un itinerario che non conosciamo con precisione. Del resto, oltre a quelle citate negli itinerari, molte altre località furono visitate da Moris, come risulta dalle note dell'erbario (nella cartina, sono indicate con un quadretto scuro). Malato, nella primavera del 1828 Moris rientrò a Torino, affidando a Lisa la continuazione del lavoro sul campo. Ancora a Cagliari, nell'aprile 1827 aveva in parte anticipato i risultati delle sue ricerche, pubblicando in contemporanea nella capitale sarda e a Torino Stirpium sardoarum elenchus, che contiene la descrizione di 1246 piante vascolari e la diagnosi di 26 specie nuove, seguito a giugno da un'Addenda e a dicembre da una seconda serie, con ulteriori 157 specie e la diagnosi di 17 specie nuove. A Torino nel 1829 diede poi alle stampe una terza serie, con altre 76 specie vascolari e un'ampia lista di crittogame. In tutto le specie descritte sono 1482. Moris non sarebbe più tornato in Sardegna, anche se le ricerche nelle zone che aveva dovuto tralasciare continuarono grazie a Lisa (ne parlerò in un altro post) e al sardo Simone Masala, che negli anni '60 raccolse molti esemplari nel Sarcidano e nell'area di Cagliari. Nel 1829 Moris fu nominato professore di medicina presso l'Università di Torino e nel 1831 succedette a Capelli come direttore dell'orto botanico torinese. Membro di molte istituzioni, senatore del Regno dal 1848, fu sempre più coinvolto in impegni accademici e amministrativi che rallentarono quella che riteneva la vera missione della sua vita: la stesura della Flora sardoa. Uscita nell'arco di un ventennio (nel 1837 il primo volume, tra il 1840 e il 1843 il secondo, tra il 1858 e il 1859 il terzo) è un'opera imponente, estremamente accurata nelle descrizioni e nelle determinazioni (a tal fine, Moris visitò importanti erbari a Parigi e Ginevra) e di grande pregio estetico, grazie alle 111 tavole che la illustrano, preparate sotto la sua stretta supervisione. La maggior parte è dovuta a Maria Maddalena Lisa Mussino, disegnatrice dell'orto torinese e moglie di Domenico Lisa. L'autore delle altre è John C. Heyland, disegnatore botanico che collaborò con celebri botanici dell'epoca, tra cui de Candolle. In tutto le specie descritte sono 1141, Benché incompleta (si limita alle fanerogame), Flora sardoa è un'opera fondamentale che divenne un punto di riferimento per tutti gli studi successivi, avendo anche il merito di stimolare l'interesse per la peculiare flora dell'isola e i suoi numerosi endemismi.  Morisia, la pianta che si semina da sé Nelle opere maggiori e nei numerosi contributi usciti in diverse riviste, Moris pubblicò circa un centinaio di nuove specie. Sono numerose quelle che lo ricordano nel nome specifico, tra cui la bellissima Paeonia morisii Cesca, Bernardo & N.G. Passal. (anche se questa denominazione non è universalmente riconosciuta) e la rara Genista morisii Colla, limitata alla Sardegna sud-occidentale. Tra le specie più rare della nostra flora, inserite nella lista rossa, si fregiano del suo nome Borago morisiana e Dianthus morisianus. Nel 1832 lo svizzero Jacques Etienne Gay gli dedicò un nuovo genere endemico dell'area sardo-corsa, Morisia, famiglia Brassicaceae, anticipando di due anni l'omonimo Morisia, famiglia Cyperaceae, creato da Nees von Esembeck. A essere valido è dunque il primo, anche se nel 1838 de Candolle propose di cambiarlo in Morisea o Morisina per evitare confusioni con Morysia (genere oggi disusato, dedicato al collezionista francese Charles de Saint Morys). Morisia è un genere monospecifico rappresentato unicamente da M. monanthos, una specie endemica della Sardegna e della Corsica, che cresce in luoghi preferibilmente umidi e freschi, formando localmente colonie anche estese. E' un'erbacea perenne bassa, con rosette di foglie pennate con foglioline più o meno triangolari e fiori eretti a quattro petali giallo oro. La sua particolarità sta nel metodo di disseminazione; dopo la fioritura, i peduncoli si ripiegano verso il basso spingendo i frutti nel suolo, dove avverrà la maturazione e quindi la germinazione dei semi. E' considerata un paleo endemismo di origine nordafricana. Altre informazioni nella scheda. Arrivano dalle foreste pluviali dell'Asia e dalle praterie del Mediterraneo Molineria e Molineriella, i due generi dedicati a Ignazio Molineri, giardiniere dell'orto botanico di Torino, appassionato ricercatore di piante che contribuì forse più di ogni altro alla conoscenza della flora piemontese. Gli resero omaggio botanici del calibro di Allioni - che assistette per decenni, prestandogli i suoi occhi acuti -, Balbis e Parlatore.  Una dinasty dell'orto botanico di Torino Tra i dedicatari dei nomi botanici, sono relativamente rari gli esponenti di una categoria senza la quale nessun giardino, tanto meno un orto botanico, potrebbe prosperare e addirittura sopravvivere: quella dei giardinieri. Tra le fortunate eccezioni, Ignazio Molineri che a cavallo tra Settecento e Ottocento lavorò all'orto botanico di Torino per un quarantennio, percorrendo tutte le tappe della carriera da apprendista a giardiniere capo. Approfittiamone per conoscere più da vicino lui e i suoi compagni di lavoro in un giardino di fama europea, ma di dimensioni modeste e soprattutto di scarsi mezzi finanziari (ancora nell'Ottocento, i curatori lamentavano che i finanziamenti non erano neppure sufficienti per un adeguato riscaldamento delle serre, per non parlare dell'acquisto di piante esotiche). Intorno al 1730 (l'orto era stato istituito nel 1729) il personale era costituito da Sante Andreoli o Andreola, "giardiniere di botanica o erbolaio", Pietro Cornaglia, aiuto giardiniere e erbolaio in seconda, e due garzoni, Francesco Peyroleri e un altro di cui non conosciamo il nome, cui potevano aggiungersi all'occasione avventizi e lavoratori a giornata. Accanto alle competenze orticole necessarie per dirigere il lavoro di assistenti e garzoni, all'erbolaio era richiesta una perfetta conoscenza pratica e teorica delle piante, soprattutto officinali; tra i suoi compiti infatti rientrava la raccolta in natura di piante, sia per accrescere le collezioni, sia per fornire i semplici destinati allo studio e alla coltivazione; inoltre doveva assistere il professore di botanica e direttore dell'orto supportandolo durante le lezioni di materia medica. Non a caso, Bartolomeo Caccia (1695-1746, il primo direttore dell'orto di Torino), in assenza di personale già formato nella capitale sabauda, fece venire Andreoli dall'orto botanico di Padova; appartenente a una famiglia di giardinieri dell'istituzione patavina, egli era già in età avanzata e quindi Caccia ritenne opportuno affiancargli Pietro Cornaglia, che poi alla morte di Andreoli, di cui non conosciamo con precisione la data, gli succedette come primo erbolaio. Cornaglia accompagnò Donati in diversi viaggi; in particolare nel 1751 fu con lui ad erborizzare in val di Susa, sul Moncenisio, in Moriana, in Tarantasia, sul Gran San Bernardo e in Val d'Aosta. Quanto a Francesco Peyroleri, che intorno al 1750 fu nominato secondo erbolaio, avendo dimostrato un notevole talento per il disegno, la sua attività principale divenne quella di "disegnatore delle piante botaniche". Autore di centinaia di tavole dell'Iconographia taurinensis, d'altra parte Peyroleri partecipò attivamente all'esplorazione botanica del territorio sabaudo, anche per procurarsi le piante vive da ritrarre; ancora nel 1764 (all'epoca si avvicinava ai sessant'anni) lo troviamo come compagno di viaggio di Bellardi tra Val d'Aosta e Savoia (ne ho parlato in questo post). Ma sulla figura del disegnatore, che andava ormai differenziandosi da quella di giardiniere, avremo occasione di tornare in un'altra occasione. E' ora infatti che entri in scena il nostro protagonista. Cornaglia era originario di Montaldo di Mondovì, un paesino di montagna descritto dai contemporaneo come "selvaggio e alpestre"; com'era uso all'epoca, scelse come collaboratori alcuni parenti. Il primo fu un nipote, Paolo Cornaglia, che nel 1759 fu aggregato come giardiniere alla spedizione di Donati in Oriente; purtroppo, come ho raccontato in questo post, non andò più lontano di Venezia, dove giunse già malato e morì. Ben più fortunate furono le vicende dei fratelli Molineri, che di Cornaglia erano cugini. Il primo ad arrivare a Torino dalla nativa Montaldo fu Pietro (nato nel 1736), che percorse una dopo l'altra le tappe ormai istituzionalizzate della carriera di giardiniere dell'orto torinese: nel 1758 fu assunto come garzone straordinario; nel 1761 divenne allievo; nel 1777 aiutante erbolaio; nel 1781 (e fino alla morte, 1800) giardiniere capo o custode. Qualche anno dopo lo raggiunse il fratello minore Ignazio, che nel 1767 risulta in forza come allievo giardiniere. Le opere di Allioni (direttore dal 1763 al 1781) sono prodighe di elogi per i due fratelli, definiti "giovani assai pazienti alle fatiche, dotati di ingegno e di corpo robusto, abili orticultori". Allioni stesso li istruì nel sistema di Linneo e i due divennero naturalisti compiuti. Il contributo di entrambi all'esplorazione del territorio piemontese fu inestimabile, tanto che in Flora pedemontana e in Auctarium ad floram pedemontanam sono citati come raccoglitori quasi ad ogni pagina. La predilezione di Pietro andava all'entomologia e numerosissimi sono gli insetti che fornì ad Allioni (la cui collezione pare si aggirasse sui 4000 esemplari); egli scoprì anche alcune nuove specie che poi furono pubblicate da Fabricius. La passione di Ignazio era invece la botanica; raccoglitore entusiasta, percorse molte contrade del Piemonte, raccogliendo ben 127 specie diverse. Tra le sue scoperte più notevoli, Saxifraga florulenta, la rara sassifraga dell'Argentera. Tra i suoi compiti, anche l'allestimento e la cura degli esemplari essiccati che andarono a costituire il primo nucleo dell'Erbario dell'orto torinese. Quando l'avanzare dell'età e l'affaticamento causato dal continuo uso del microscopio danneggiarono la vista di Allioni, fu Ignazio - di cui ancora una volta il professore loda la perizia e la diligenza nella raccolta e nello studio delle piante - a prestargli i suoi occhi, consentendogli di completare le sue opere. Non ultimo merito di Ignazio fu aver preservato le raccolte stesse dell'orto negli anni di trascuratezza dovuti alla malattia di Dana e alla guerra. Nel 1801, morto il fratello, gli succedette come giardiniere capo iniziando una fervida collaborazione con il nuovo direttore, Giovanni Battista Balbis. Fu anzi proprio lui, con il suo entusiasmo, il suo aiuto e il suo sostegno a incoraggiare Balbis - desolato di fronte allo spettacolo di tanta rovina - a intraprendere l'impresa di fare rivivere e restituire ai passati fasti l'orto torinese. Benché fosse ormai sulla sessantina, lo accompagnò anche in diverse escursioni tutt'altro che agevoli sulle montagne piemontesi; Balbis volle preservarne la memoria dedicandogli Poa molinerii e Iberis molinerii. Nel suo catalogo dell'orto (1810) ne scrisse una lode che è anche il più ampio ritratto del valente giardiniere. Oltre a riconoscere apertamente che, senza di lui e il suo paziente lavoro di raccoglitore, non ci sarebbero state né le opere di Allioni né le sue, ricorda come questo autodidatta, nato in un villaggio di montagna, oltre ad essere un botanico di eccezionale valore, dominasse il francese e il latino; avesse imparato del greco almeno quanto era necessario per comprendere l'etimologia dei termini botanici; padroneggiasse la geografia, tanto importante per la raccolta delle piante legate a determinati habitat; avesse voluto completare le sue conoscenze con lo studio di geometria e astronomia. In tanta stima lo aveva Balbis che lo propose come membro della Commissione di scienze ed arti incaricata di stendere un progetto generale di istruzione pubblica. Nel 1802, quando venne creata la scuola di veterinaria presso il Valentino, la commissione esecutiva lo nominò dimostratore delle piante, ovvero insegnante di botanica. Morì in tarda età circondato dalla stima generale nel 1818. Una sintesi di questa vita contemporaneamente semplice ed eccezionale nella sezione biografie.  Molineria, foglie dal fascino tropicale Qualche anno dopo la sua morte, nel 1826, un nuovo omaggio giunse da Colla. Nel suo giardino di Rivoli egli coltivava Curculigo sumatrana, un'erbacea orientale procuratagli da un corrispondente. Poiché non gli risultava che nessuno l'avesse pubblicata fino a quello momento e le sue caratteristiche differivano a suo parere da quelle delle altre Curculigo, egli ritenne appartenesse a un nuovo genere, che dedicò a Molineri "già custode dell'Orto botanico, i cui grandi meriti per la botanica patria sono attestati dalla celeberrima Flora pedemontana di Allioni e dalle aggiunte dell'insigne Balbis". Anche se Colla si sbagliava (Curculigo sumatrana Roxb. continua a chiamarsi così), il genere fu adottato da botanici successivi ed è tuttora valido. Appartenente alla famiglia Hypoxidaceae, comprende sette specie di monocotiledoni erbacee native del subcontinente indiano, della Cina, del Sud est asiatico e dell'Oceania, con centro di diversità in India dove sono presenti tutte le specie. Sono piante rizomatose con grandi foglie che ricordano quelle dell'Aspidistra e fiori a stella assai decorativi, ma poco visibili perché crescono raso terra e sono nascosti dal fogliame. La specie più diffusa e nota è M. capitulata, detta in inglese palm grass per le grandi foglie lanceolate (lunghe anche un metro), fibrose e con marcate venature parallele, che possono ricordare quelle di una giovane palma; originaria del sottobosco delle foreste umide di gran parte dell'Asia orientale e della Nuova Guinea, è stata introdotta in altri paesi tropicali, dove si è dimostrata fin troppo volenterosa. Nei giardini a clima mite può essere utilizzata come notevole tappezzante per la capacità di colonizzare rapidamente il terreno. Nei paesi d'origine, le foglie vengono utilizzate per creare cesti e altri manufatti. Qualche informazione in più nella scheda.  La minuscola Molineriella Nel 1850, anche Parlatore si ricordò di Molineri, creando un secondo genere Molineria per M. minuta, una minuscola Poacaea. La motivazione è davvero interessante: "Ho voluto con questo ricordar nella scienza il nome d'Ignazio Molineri, già custode del R. Giardino botanico di Torino, il quale arricchì di numerose scoperte la flora italiana con i suoi frequenti viaggi nelle Alpi e nella Liguria. Ho prescelto una pianta piccola con l'epiteto minuta per indicare l'acutezza del suo occhio osservatore, a cui nulla sfuggiva per quanto piccolo e minuto". Poiché nel frattempo la denominazione di Colla, benché applicata ad altre specie, si era affermata, quella proposta da Parlatore risultava illegittima. Ma a risolvere la questione a favore del nostro bravissimo giardiniere-botanico dalla vista acuta fu il francese Georges Rouy che nel 1913 ne mutò la denominazione in Molineriella. Questo genere della famiglia Poaceae comprende tre specie di erbe annuali dell'area mediterranea, con centro di diversità in Spagna dove sono presenti tutte. Nel nostro paese cresce la sola M. minuta, nota con il nome volgare di "nebbia di Molineri" per le aeree infiorescenze, un'erba che raramente supera i 20 cm, presente in tutte le regioni del centro e del sud, dove cresce negli incolti e nei prati di annuali. Qualche approfondimento nella scheda. Esponente di spicco della scuola botanica di Allioni, di cui fu il principale allievo e collaboratore, Lodovico Bellardi in decine di escursioni botaniche percorse ogni angolo dello stato sabaudo, dalla pianura alle contrade più remote delle Alpi, dando un contributo inestimabile alla conoscenza della flora pedemontana. Celebre tra i botanici del suo tempo - di molti dei quali fu stimato corrispondente - per la profonda conoscenza delle piante, grande raccoglitore di piante locali, scrisse poco e non uscì quasi dai confini dello stato dove era nato. Viaggiatore immobile nello spazio, lo è anche nel tempo: al contrario di quanto accadde ad altri botanici subalpini, attraversò senza esserne toccato le tempeste della storia nel periodo che va dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione. Lo ricordano due piccoli generi, presenti anche nel nostro paese: Bellardia (Orobanchaceae) e Bellardiochloa (Poaceae). Per una volta, entrambe le dediche si riferiscono a specie che il dedicatario raccolse e contribuì a fare conoscere. 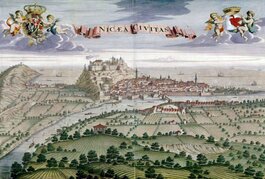 Tra piane, montagnose e alpestri regioni Nella prefazione alla Flora pedemontana (1785), la sua grande opera dedicata alla flora del Piemonte, Carlo Ludovico Allioni sottolinea l'importanza del contributo dell'allievo Lodovico Bellardi, che, spinto da ardente amore per la scienza, percorse ed esplorò in modo accuratissimo molte contrade dello Stato sabaudo alla ricerca di piante. I luoghi citati da Allioni ci danno la misura dell'ampiezza di questi viaggi: la pianura vercellese; le colline, le montagne, i laghi del Canavese; la Valle d'Aosta e le sue montagne; buona parte della Savoia; la contea di Nizza, senza tralasciare le cime più aspre e le valli più remote. Allioni ricorda poi l'estrema generosità del solerte allievo che, invece di pubblicare le sue scoperte in un'opera propria, come inizialmente aveva progettato, le mise a disposizione del maestro che le pubblicò appunto in Flora pedemontana. Per capire il peso di questo contributo, basti pensare che su 2813 specie qui descritte, per circa 250 Bellardi è citato come raccoglitore; tra di esse almeno una ventina erano inedite. Allievo prima di Donati, poi di Allioni, Bellardi era venuto a Torino a studiare medicina dalla nativa Cigliano, nel Vercellese, e grazie ai suoi maestri si era innamorato della botanica. Benché avesse scelto la professione di medico e non avesse alcun incarico ufficiale né all'Università né all'orto botanico, divenne il principale collaboratore di Allioni grazie ai suoi viaggi e alle sue ricerche. Tra il 1759 (appena diciottenne) e il 1790 percorse in lungo e in largo il Piemonte in tutte le "piane, montagnose e alpestri regioni", per citare il suo primo biografo, G. Carena. Il viaggio che conosciamo meglio, essendocene pervenuto il diario, è quello che nell'estate del 1784 lo portò a percorrere Valle d’Aosta, Vallese, Alta Savoia e Savoia in compagnia di Francesco Peyrolery, giardiniere e disegnatore dell'orto botanico di Torino. Partiti da Torino all'inizio di luglio, i due raggiunsero l'imbocco della Valle d'Aosta, quindi risalirono la Valle di Gressoney, per poi tornare nella Valle centrale a Saint-Vincent e dirigersi ad Aosta. Attraverso il Valico del Gran S. Bernardo raggiunsero Martigny e da qui Roche nel Vaud, dove incontrarono il celebre scienziato Albrecht von Haller; ritornati a Martigny raggiunsero Chamonix attraverso il Col de la Forclaz. Passando per Mégéve e Ugine, toccarono l'attuale Albertville, proseguendo nella Vanoise fino a Termignon (dove il diario si interrompe), da dove forse rientrarono a Torino attraverso il valico del Moncenisio. Questa escursione, della durata di poco più di un mese, fruttò la raccolta di circa 430 piante. Come ho già detto, non si tratta che di uno dei tanti viaggi che nell'arco di 30 anni portarono Bellardi a percorrere ed esplorare gran parte degli stati sabaudi (esclusa la Sardegna). Oltre a offrire un eccezionale contributo alla conoscenza della flora del Piemonte e delle zone limitrofe, le sue ricerche arricchirono anche l'orto botanico di Torino di numerose specie, che egli coltivava pure in suo piccolo orto sperimentale, che aveva potuto creare grazie al sostegno dell'ambasciatore portoghese a Torino, Roderigo Countinho de Souza. Qui Bellardi sperimentava anche la coltivazione di piante officinali adatte al clima subalpino, in sostituzione dei costosi semplici importati: così coltivò due specie di rabarbaro (Rheum compactum L. e R. undulatum L.) e una Cassia diversa dalla senna descritta da Linneo, che però ne aveva le stesse proprietà medicinali, tanto che avrebbe potuto perfettamente sostituirla; la chiamò perciò Cassia succedana (nome ancora oggi valido). Dopo il 1790, i viaggi si diradarono, ma nel frattempo Bellardi era riuscito a creare una rete di allievi, amici e corrispondenti che, da ogni angolo del Piemonte, raccoglievano per lui le piante locali nei diversi momenti della loro vita vegetativa. Tra di essi il frate certosino Cumino, Biroli, de Suffren, Viale. Intratteneva anche una fitta corrispondenza con molti eminenti botanici europei, presso i quali godeva di una fama quasi leggendaria di enciclopedia vivente delle piante subalpine. Così Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, ebbe a definirlo viro de re botanica celeberrimo, cuius laudatum nomen rei herbariae cultoribus est notissimum, "uomo celeberrimo per la botanica, il cui nome lodato è notissimo ai cultori della botanica". Tra i suoi corrispondenti più assidui, James Edward Smith, presidente della Linnean Society, una delle numerose istituzioni scientifiche straniere che lo accolsero tra i loro membri (oltre alle torinesi Reale Società Agraria e Reale Accademia delle Scienze, di cui fu anche Tesoriere dal 1804 al 1825). Rispetto all'imponente attività di raccoglitore, limitati furono invece i contributi scritti: Osservazioni botaniche con un saggio d'appendice alla Flora Pedemontana (1788), in cui polemizzò con il maldestro autore di una flora di Chambery, chiarendo il concetto di pianta autoctona; Appendix ad Floram Pedemontanam, (1792) e Stirpes novae vel minus notae Pedemontii descriptae et iconibus illustratae (1803), che costituiscono un'integrazione della Flora di Allioni con nuove specie o correzioni tassonomiche. In totale, si ritiene siano circa una sessantina le nuove specie da lui raccolte e segnalate. Di notevole importanza anche l'erbario, con oltre 5000 essiccati (che egli chiamava "scheletri"), notevole anche per la precisione delle note che lo corredano, oggi conservato presso l'orto botanico di Torino. Una sintesi della sua lunga, serena e produttiva vita nella sezione biografie.  Poa o Festuca? no, Bellardiochloa Contrariamente a quello che siamo portati a pensare, è abbastanza raro che un botanico sia celebrato dal nome di una pianta che raccolse, studiò o denominò. Bellardi è l'eccezione che conferma la regola: gli sono stati dedicati ben due generi validi e in entrambi i casi la specie tipo fu raccolta e descritta da lui. L'interesse per le piante di questo grande raccoglitore della flora alpina era a 360 gradi; circa metà delle piante nuove da lui segnalate sono crittogame; si interessò anche ai licheni e ai funghi; tra le angiosperme, studiò piante solitamente trascurate, vere e proprie "erbacce", tra cui numerose Poaceae. Così in Flora Pedemontana, Allioni segnalò una nuova specie di Poa raccolta da Bellardi nel suo paese natale, in onore del quale la denominò Poa cilianensis All.; oggi è passata a un'altro genere, ma mantiene il nome specifico voluto dai due botanici piemontesi: Eragrostis cilianensis (All.) Janch. Un'altra specie di Poa, che Bellardi raccolse presso Limone Piemonte, fu da lui pubblicata nell'appendice alla Flora pedemontana (1792) sotto il nome di Poa violacea. Questa denominazione fu trascurata dai botanici successivi, che in genere attribuirono la pianta (variamente denominata) al genere Festuca, finché nel 1874, sulla base di alcune caratteristiche della cariosside, Balansa lo restituì al genere Poa ripristinando la denominazione di Bellardi. Nel 1929 il botanico di origini piemontesi Emilio Chiovenda, in un saggio pubblicato in un volume miscellaneo celebrativo del bicentenario dell'orto botanico torinese, rilevò che questa specie presenta caratteristiche intermedie tra Poa e Festuca, tanto da farla attribuire a un genere proprio, che chiamò Bellardiochloa, cioè "erba di Bellardi", "in omaggio allo scopritore della specie, che fu tanto benemerito della flora piemontese". Nei decenni successivi, a dire il vero, il genere creato da Chiovenda non godette certo del consenso generale, venendo per lo più attribuito a Poa. Solo in anni recenti, ulteriori studi hanno dimostrato che Bellardiochloa è un genere a sé, ben differenziato tanto da Poa quanto da Festuca dal punto di vista sia morfologico sia molecolare. Oggi gli sono assegnate cinque specie di erbe dei pascoli e delle rocce delle aree subalpine, soprattutto su suoli silicei. Una specie, B. variegata (sinonimo B. violacea, ovvero proprio la specie descritta da Bellardi) ha un ampio areale che comprende le montagne dell'Europa meridionale, dai Pirenei ai Balcani passando per le Alpi; in Italia, dove è nota con il nome comune di fienarola violacea, è presente in tutte le regioni eccetto Campania e Puglia. In Sicilia sono presenti due rare sottospecie, B. v. subsp. nebrodensis e B. v. subsp. aetnensis. Il centro di diversità del genere è considerato la Turchia, dove sono presenti quattro delle cinque specie, tre delle quali endemiche. Qualche approfondimento nella scheda.  Un genere quasi parassita Anche l'altro genere che celebra Bellardi, ovvero Bellardia (Orobanchaceae) ha una storia travagliata. Oltre ad avere riconosciuto i meriti dell'allievo prediletto nella prefazione, in Flora Pedemontana Allioni volle anche onorarlo dedicandogli una delle piante da lui raccolte, Bellardia trixago, "in segno di riconoscenza e stima". Non validi sono ovviamente i generi Bellardia creati più tardi, rispettivamente nel 1791 da Schreber e nel 1835 da Colla. Bellardi raccolse questa pianta nei pressi del faro di Nizza. In precedenza, era già stata studiata da altri botanici, che l'aveano assegnata ad altri generi, in particolare Bartsia. Successivamente, il genere stabilito da Allioni ebbe vita controversa, ora riconosciuto come indipendente, ora incluso appunto in Bartsia. E' molto recente (2016) una revisione filogenetica di quest'ultimo genere che ha dimostrato l'indipendenza di Bellardia, cui ha attribuito due specie, B. trixago e B. viscosa (prima Parentucellia viscosa). Entrambe sono mediterranee e presenti nel nostro paese, in pascoli e incolti. Nota con il nome di perlina minore, B. trixago è un'erbacea annuale emiparassita, diffusa nell'Italia centro meridionale, con un'infiorescenza eretta e piramidale dai vistosi fiori bianchi o violacei che emergono da file di brattee. Nota come perlina maggiore, B. viscosa ha dimensioni maggiori, ma fiori più piccoli gialli e presenta ghiandole che la rendono vischiosa al tatto. La sua appartenenza al genere Bellardia è comunque controversa; POWO considera nome valido Parentucellia viscosa, B. viscosa sinonimo. Qualche informazione in più nella scheda. Per dare lustro al titolo regale appena conquistato, Vittorio Amedeo II fonda l'Orto botanico di Torino. Qualche anno dopo Carlo Allioni ne farà un'istituzione scientifica di prestigio europeo, guadagnandosi la stima di Linneo. A lui - tra i primi ad adottare la denominazione binomiale e più tardi autore di un'opera fondamentale della botanica illuminista - lo svedese dedicherà il genere Allionia.  Un nuovo orto botanico per un nuovo re Nel 1703, allo scoppio della guerra di successione spagnola, Vittorio Amedeo II di Savoia, infido alleato di Luigi XIV, decide di cambiare campo e si schiera con l'Impero e l'Inghilterra. La vendetta del Re Sole non si fa aspettare: lo stato sabaudo è devastato, la capitale Torino subisce un terribile assedio. Ma la "volpe sabauda" dimostra di aver visto giusto: non solo i francesi sono disfatti nella battaglia di Torino (7 settembre 1706), ma alla fine della guerra, con la pace di Utrecht, i Savoia entrano finalmente nel salotto buono della storia, accedendo al sospirato titolo reale. Adesso che Torino è la capitale di un regno (dal 1713 al 1714 di Sicilia, quindi di Sardegna) deve dotarsi di tutte le strutture che danno lustro a una monarchia degna di questo nome, comprese le istituzioni scientifiche. Immancabile tra queste un Orto botanico, dove studiare e coltivare le piante utili, ma anche collezionare le nuove specie esotiche, vanto dei Giardini reali di Parigi o di Londra. D'altra parte l'esplorazione e la conoscenza delle risorse del territorio per ogni stato nazionale è sempre più importante dal punto di vista economico, demografico e strategico. Così nel 1729 nasce l'Orto botanico di Torino, diretto dapprima dal medico Bartolomeo Caccia (morto nel 1747) quindi da Vitaliano Donati (1717-1762), eclettico scienziato, viaggiatore ed esploratore che fu anche all'origine del Museo Egizio. Il terzo direttore sarà Carlo Allioni (1728-1804), che lo gestì per un quarantennio e lo inserì nel circuito dei maggiori orti botanici europei, trasformandolo in una reputata istituzione di ricerca e incrementando enormemente le raccolte (sotto la sua gestione le specie coltivate salgono da 317 a 4500). Una visita all'eccellente sito dell'Orto botanico di Torino offre un panorama delle collezioni coltivate nei suoi spazi (giardino, boschetto, alpineto e tre serre) e molte informazioni di approfondimento sulla storia e le attività dell'istituzione piemontese. 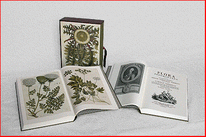 Caro Carlo, ti scrivo.... Quando diventa direttore dell'orto botanico, Allioni ha già al suo attivo un'opera importante, Rariorum Pedemontium Stirpium. Specimen primum, del 1755, in cui le specie, ancora indicate con il nome polinomiale, sono accompagnate da dodici splendide tavole disegnate da Francesco Peyrolery. Il libro è anche all'origine della corrispondenza e si può dire dell'amicizia con Linneo. Infatti, dopo qualche esitazione, Allioni, incoraggiato dal danese Peter Ascanius in visita a Torino, ne invia un esemplare all'illustre collega, che gli risponde con una lettera colma da gentilezza ed apprezzamento scientifico. Per un ventennio le lettere dei due Carli viaggeranno da Torino a Uppsala e da Uppsala a Torino, accompagnando libri, pacchetti di semi, fogli di erbario, campioni di minerali e esemplari essiccati. Il Carlo svedese apprezza la flora alpina, il Carlo piemontese le piante esotiche che potranno arricchire le aiuole dell'Orto botanico. I due discutono dell'identificazione delle piante, ma si scambiano osservazioni anche sui minerali e gli animali, essendo entrambi naturalisti dai vasti interessi. Linneo non lesina le lodi al più giovane amico: a proposito di Auctarium Horti Tauriniensis (lettera dell'8 novembre 1774) giunge a dire che le descrizioni della flora italiana di Allioni superano ciò che è stato scritto prima di lui quanto nella notte la luce della luna supera quella delle piccole stelle. A sua volta, Allioni farà proprie le tesi di Linneo, adottando tra i primi la nomenclatura binomiale, tanto da essere soprannominato il Linneo piemontese. I curiosi possono ora leggere questa corrispondenza nel sito The linnean Corrispondence nell'originale latino, accompagnato da una sintesi in inglese. E ovviamente non poteva mancare la dedica di un nuovo genere: Linneo provvide nel 1759, nella decima edizione del Systema naturae, intitolando all'amico Allionia, una deliziosa Nyctaginacea del Nord America. Il capolavoro di Allioni è Flora Pedemontana, sive enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii, frutto di 25 anni di lavoro, pubblicata nel 1785 (due volumi di testo e un volume di tavole), in cui vengono descritte 2813 piante delle Alpi occidentali. Questo trattato - notevole anche per la cura editoriale - è considerato uno delle opere botaniche più significative dell'Illuminismo. Altre notizie su Carlo Allioni nella biografia.  Allionia, allionii Allionia è un'annuale o perenne di breve vita dal portamento strisciante, originaria del Sud degli Stati Uniti (dalla California al Texas dal Nevada all'Oklaoma), dai graziosi fiori rosa vivo. Non sappiamo perché Linneo abbia scelto proprio questa pianta per onorare l'amico piemontese, ma possiamo proporre qualche ipotesi. Intanto ha proprietà medicinali, e Allioni era un medico insigne. Inoltre ha un fiore davvero particolare: in realtà si tratta di tre fiori separati che sembrano formarne uno solo. Un'allusione alla poliedrica attività del naturalista subalpino, botanico, zoologo, geologo? Infine il piemontese è descritto dai contemporanei come un uomo di grande modestia, che univa all'immensa scienza la semplicità di cuore: la bella ma modesta Allionia non potrebbe essere il suo ritratto vegetale? Nella scheda qualche approfondimento sul genere Allionia e sulle sue due specie. Nato e morto a Torino, Allioni non può essere considerato un botanico sedentario. Mentre i suoi contemporanei esploravano le Americhe, l'Asia, l'Africa, le isole del Pacifico e l'Australia, percorreva instancabilmente il piccolo stato sabaudo, esplorandone palmo a palmo le montagne. Così raccolse un erbario composto da 11.000 esemplari e descrisse circa 400 nuove specie. Forse memore della morte del suo predecessore Vitaliano Donati - perito in mare mentre si dirigeva a Goa - non attraversò il mare neppure per esplorare la flora sarda, delegando la raccolta al collaboratore Michele Plazza. Diverse tra le nuove specie descritte da Allioni lo ricordano nel nome specifico: Arabis allionii, Veronica allionii, Campanula allionii, Sempervivum globiferum subsp. allionii (già Jovibarba allionii), ecc. Tra di esse una perla per rarità e bellezza, la Primula allionii, un endemismo delle Alpi Marittime. Per goderne la bellezza, si può dare un'occhiata alla gallery dedicata alla specie e alle sue cultivar orticole sul sito dell'American Primrose Society. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed