|
Furono tre i continenti (se non contiamo qualche mese in un quarto e un breve scalo nel quinto) a fare da sfondo alla vita di Hans Hermann Behr, dottore in medicina e poliedrico naturalista e scrittore. Nato e formatosi in Germania, una prima visita lo portò per un po' più di un anno in Australia ad esplorare l'area di Adelaide, all'epoca meta di molti coloni tedeschi. Ritornò poi a casa, ma la rivoluzione del '48 - a suo dire - lo trasformò in esule, prima di nuovo in Australia, poi per breve tempo nelle Filippine, infine per più di mezzo secolo in California. Arrivò a San Francisco proprio in coincidenza con l'inizio della febbre dell'oro (l'unico prodotto della natura che non lo interessò mai) e fu testimone della tumultuosa crescita della città e della distruzione di un ambiente naturale che aveva potuto vedere ancora intatto. Prolifico cacciatore di piante e insetti in Australia, nonché autore di interessanti articoli antropologici, in California ebbe un ruolo di primo piano nell'Accademia delle scienze e fu soprattutto entomologo (era uno specialista e grande collezionista di lepidotteri); ritornò però alla botanica quando venne chiamato a insegnarla alla facoltà di farmacia. Fin qui lo scienziato, ma Behr, noto per il suo umorismo sferzante, fu anche scrittore, con all'attivo due romanzi in tedesco e scritti umoristici che spesso sfociano nel non sense. Lo ricordano gli eponimi di numerose piante e insetti e il monotipico genere Behria, endemico dell'estremità meridionale della Baja California. 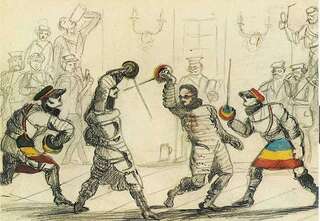 Una fruttuosa prima spedizione in Australia Quando morì, a quasi 86 anni, il San Francisco Chroniclelo lo definì "un'autorità di rilevanza mondiale" in molti campi della scienza, da annoverare tra "i giganti della mente". Eppure oggi il medico tedesco naturalizzato statunitense Hans Hermann Behr (1818-1904) è quasi dimenticato, non fosse per una località australiana (Behr Creek), una strada di San Francisco (Behr Avenue), una manciata di nomi di piante e un romanzo che ogni tanto viene ripescato e ristampato. Fu infatti molte cose durante la sua lunga vita: medico per professione e necessità, naturalista, raccoglitore e collezionista di insetti e piante per passione, insegnante e divulgatore, scrittore di romanzi e sketch comici che me lo fanno immaginare come un Mark Twain (o un O. Henry) della botanica. Come loro era un umorista, non di rado pungente e più spesso surreale. Behr nacque a Köthen, la capitale del principato di Anhalt, in una famiglia che da generazioni forniva all'amministrazione alti funzionari. Fin dagli anni del ginnasio rivelò uno spiccato talento per le lingue - nel suo necrologio Alice Eastwood, esagerando, scrisse che parlava tutte le lingue europee - e studiò, oltre al latino e al greco, persino l'ebraico. Amava già la natura ed era già un accanito collezionista; all'epoca collezionava uova di uccelli e si racconta abbia rubato un nido di cigni reali per procurarsi le loro uova. Nel 1837 si iscrisse all'università di Halle, poi alla facoltà di medicina a Würzburg dove si innamorò della botanica; era un attivo membro della confraternita studentesca Corps Moenania, per sostenere i colori della quale partecipò a 27 duelli. Si tratta dello sport alquanto cruento del Mensur, nel quale i contendenti si affrontavano con la spada per dimostrare il proprio coraggio, riportandone frequentemente ferite e cicatrici al volto, poi esibite con orgoglio. E' il caso anche di Behr che ne aveva più di una. Completò poi gli studi all'università di Berlino, dove nel marzo del 1843 ottenne la laurea in medicina. A Berlino forte era l'influenza sia di Humboldt sia del geografo Karl Ritter. Entrambi lo incoraggiarono a visitare paesi lontani per approfondire sul campo lo studio di botanica e entomologia. Behr scelse l'Australia sudorientale, che proprio in quegli anni stava attirando ondate di immigrati tedeschi. A partire dal 1838, gruppi di coloni tedeschi avevano cominciato a stabilirsi nell'area di Adelaide, in quella che all'epoca era la colonia dell'Australia del Sud. Tra di loro c'erano vignaioli del Reno reclutati per avviare la coltivazione industriale della vite, contadini poveri della Slesia e della Sassonia, ma i nuclei più consistenti provenivano dalla Prussia ed erano guidati da missionari luterani. Nel 1842 27 famiglie si stabilirono nella valle di Barossa e battezzarono il loro villaggio Bethanien in ricordo della città biblica, rinomata per la sua fertilità. Il 27 maggio 1844 Behr si imbarcò a Brema sulla George Washington e il 12 settembre sbarcò ad Adelaide. Da una lettera diretta alla Società entomologica di Stettino, risulta che a novembre si trovava a Bethanien ed aveva già iniziato ad esplorare attivamente la zona, la cui fauna e flora all'epoca erano quasi completamente ignote alla scienza europea. Dapprima esplorò la valle del Barossa, poi si spinse sempre più lontano, con escursioni che coprono un raggio di 100 km a nord e ad est di Adelaide, tra il Golfo di St. Vincent e il fiume Murray. A più riprese tra l'autunno del 1844 e l'inverno del 1845 visitò il Light River, nella primavera del 1845 esplorò le pinete nei pressi di Gawler, tra la primavera e l'inizio dell'estate la Barossa Range, a maggio i fiumi Murray e Onkaparinga, ad agosto i Murray Flats. Non sappiamo in quale data scalò il Monte Barker a sudest di Adelaide. Oltre a raccogliere grandi quantità di piante ed insetti (era particolarmente interessato a coleotteri e lepidotteri) non mancò di osservare i costumi degli aborigeni, dedicando particolare attenzione al linguaggio e ai corroboree, le cerimonie rituali, che in due scritti che avrebbe presentato alla Società geografica di Berlino non avrebbe esitato a paragonare alle cerimonie religiose cristiane. Dopo 13 mesi, ripartì per l'Europa, imbarcandosi il 9 ottobre 1845 ad Adelaide su una piccola nave, la Heerjeebhoy Rustomjee Patel, di cui era l'unico passeggero oltre alla moglie del comandante. Nello stretto di Lombok, essa fu attaccata dia pirati e dovette rifugiarsi a Bali. Poi il viaggio proseguì senza altri incidenti via Città del Capo per Amsterdam, dove Behr sbarcò il 19 maggio 1846. Da qui dovette raggiungere Köthen, dove sarebbe vissuto fino al 1848. Ora si trattava di pubblicare l'ingente materiale raccolto. Anche se egli stesso presentò le sue raccolte in articoli comparsi nel 1847 su Entomologische Zeitung e Linnaea, si affidò soprattutto alla collaborazione di alcuni amici ed esperti: per i lepidotteri Johann Christoph Friedrich Klug, per i coleotteri Ernst Friedrich Germar, per le piante Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Preceduta da un importante saggio introduttivo di Behr sulla flora dell'Australia meridionale, la descrizione delle circa 200 specie di piante da lui raccolte fu pubblicata da Schlechtendal nel numero 20 di Linnaea (1847). Egli ne considerò nuove per la scienza una settantina, e molte le nominò in onore dell'scopritore; tra di esse, per limitarci alle denominazioni tuttora accettate, Prostanthera behriana e Glischrocaryon behrii. 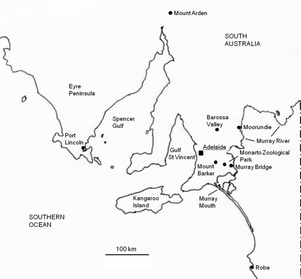 Ritorno in Australia A Köthen Behr non si occupava solo delle sue raccolte australiane e della propria carriera di medico; si interessava attivamente di politica. Come tanti giovani tedeschi in quegli anni agitati, aspirava a un mutamento politico in senso democratico e progressista, e si avvicinò a posizioni socialiste, causando sconcerto e preoccupazione nella sua conservatrice famiglia. Tanti anni dopo, in un romanzo autobiografico, egli l'avrebbe raccontato spiritosamente così: "Ero giovane, ero un socialista e fanatico dell' emancipazione in differenti direzioni [...]. Nel glorioso 1848 mi resi colpevole di ogni sorta di misfatti e mi consideravo una persona pericolosa perché ero impegnato a rompere le finestre del ministro della mia patria". Non ebbe certamente un ruolo di primo piano negli eventi rivoluzionari, del resto pacifici, che toccarono anche la periferica Köthen, ma era abbastanza coinvolto da spingere il padre, il cancelliere municipale Carl Ludwig, a finanziargli un secondo viaggio in Australia, prima che si compromettesse definitivamente. Tuttavia, anche se nei suoi anni americani gli piacque presentarsi come un esule politico, forse dietro la sua partenza c'erano anche altre ragioni. Con il favore del duca Friedrich Ferdinand, Köthen era diventato il maggior centro di diffusione dell'omeopatia: qui visse e lavorò a lungo il fondatore Samuel Hahnemann, qui nel 1845 Arthur Lutze aprì uno studio che attirava frotte di clienti (nel 1855 si sarebbe trasformato nel primo, celebre e redditizio, ospedale omeopatico). La concorrenza di Lutze, ai suoi occhi nient'altro che un ciarlatano, riduceva le già scarse prospettive di carriera di Behr e fu questo, presumibilmente, più che la situazione politica e le pressioni familiari, a deciderlo a lasciare per sempre l'Europa per cercare fortuna in Australia. Almeno stando al sarcastico proclama con il quale annunciò la sua decisione ad amici e colleghi: "Convinto che il dottor Lutze resterà qui e che gli altri medici dovranno lasciare il paese, ho l'onore di informare i miei amici e mecenati che lascio la mia patria [...] e con la presente chiedo ai miei colleghi di fare lo stesso". Quale che fosse la motivazione reale, il 15 giugno 1848 Behr si imbarcò come medico di bordo sul Victoria, diretto a Adelaide via Rio de Janeiro. Rallentato da una squadra navale danese nel Mare del Nord, il vascello arrivò in Australia solo a novembre. Pochi giorni dopo lo sbarco, Behr era di nuovo a Bethanien, dove forse aveva pensato di stabilirsi come medico. Invece come due anni prima il desiderio di avventura e l'amore per le scienze naturali presero il sopravvento: a novembre esplorò il Salt Creek, tra novembre e gennaio 1849 il Barossa Range e il versante orientale del Mount Lofty Range, nel marzo 1849 il fiume Murray. Più o meno nello stesso periodo erano arrivati in Australia diversi altri naturalisti tedeschi le cui strade dovettero incrociarsi con quella di Behr; citiamo i due più famosi: Ferdinand von Mueller (all'epoca ancora un oscuro farmacista senza von), futuro botanico coloniale del Victoria e direttore dell'orto botanico di Melbourne, e William Hillebrand, futuro esploratore della flora hawaiana. Le etichette degli erbari dimostrano che nel novembre 1848 Mueller e Behr dovettero erborizzare insieme nel Barossa Range e lungo il Salt Creek; più tardi Mueller gli dedicò Lasiopetalum behrii che Behr era stato il primo ad osservare. Quanto a Hillebrand, arrivato ad Adelaide nel marzo 1849, la sua amicizia con Behr dovette essere piuttosto stretta se i due, in una data che purtroppo non conosciamo (forse settembre 1849) lasciarono insieme l'Australia per trasferirsi a Manila, con l'intenzione di aprire ciascuno uno studio medico. Secondo una nota pubblicata su un giornale dell'epoca, prima di partire Behr avrebbe inviato le sue recenti raccolte a William Jackson Hooker, ma di questo invio si sono perdute le tracce. Tanto Behr quanto Hillebrand nel dicembre 1849 ottennero la licenza per esercitare la medicina nelle Filippine, ma vi rimasero pochi mesi, durante i quali nessuno dei due risulta aver fatto raccolte; alla fine di settembre 1850 Behr si trovava sicuramente a San Francisco, dove alla fine di novembre sarebbe stato raggiunto da Hillebrand. Ma mentre questi ripartiva quasi immediatamente per Honolulu, Behr fece di San Francisco la sua nuova casa: vi sarebbe rimasto per più di mezzo secolo, fino alla morte, allontanandosene solo per un breve viaggio in Europa nel 1853, allo scopo di recuperare e condurre con sé la fidanzata Agnes Omylska.  Mezzo secolo in California Nella California che si andava tumultuosamente popolando per la corsa all'oro (uno dei pochi prodotti della natura che mai lo interessò, stando alle sue dichiarazioni), Behr divenne presto uno figura riconosciuta dell'ambiente intellettuale e scientifico. Aveva uno studio medico, che cambiò spesso indirizzo, e come a Köthen si trovò ad affrontare la concorrenza dell'omeopata Lutze, qui si vide rubare i clienti da sedicenti medici che in realtà erano barbieri intraprendenti, infermieri o studenti che non erano riusciti a superare gli esami di medicina. Dato che non aveva peli sulla lingua e non esitava a mettere in ridicolo questi ciarlatani, Behr si fece così molti nemici; uno di loro, che scriveva gratuitamente per un giornale locale in lingua tedesca, inscenò un'accanita campagna di stampa contro di lui, accusandolo di essere un gesuita, anzi il peggiore dei gesuiti. Il motivo? Behr era cattolico e insolitamente religioso per un uomo di scienza. Anche se ridicola, l'accusa gli fece perdere molti clienti luterani. Behr non divenne mai ricco con il suo lavoro di medico, cui del resto continuava ad affiancare molteplici interessi scientifici e, come scopriremo, artistici. Era impegnato in mille altre attività, per lo più volontarie e non remunerative. Non molto dopo il suo arrivo, una banda di ex deportati australiani, noti come Sydney Ducks, si rese responsabile di furti, estorsioni e incendi; nel 1851 appiccarono il fuoco a un negozio del centro, causando un incendio che arse quasi 2000 edifici. I cittadini esasperati risposero varando un comitato di vigilanza che non esitava a farsi giustizia da sé, con metodi come processi sommari, espulsioni forzate e linciaggi. Tra questi spicciativi giustizieri fai da te troviamo anche Behr. Un ruolo non molto coerente con il rivoluzionario del '48, così come non lo fu la supplica che rivolse al duca nel 1853, in occasione del suo ultimo viaggio in patria: "Sarebbe molto gradito e vantaggioso per la mia pratica medica a San Francisco se potessi ricevere uno dei titoli ducali dell'Anhalt - magari come consigliere di corte - in riconoscimento dei miei trattati di botanica". Ottenne quanto chiedeva, tornando in California con il titolo sospirato e l'incarico - del tutto onorifico - di console dell'Anhalt in California. Quel titolo pomposo non cambiò in nulla la sua situazione reale e continuò ad essere il medico povero in canna di sempre, ma intanto incominciò a farsi conoscere negli ambienti scientifici. Nel 1854 fu ammesso all'Accademia delle scienze californiana, fondata l'anno prima, di cui divenne uno degli animatori: all'epoca, gran parte dei naturalisti che operavano in California erano degli amatori, e Behr, che invece aveva una solida formazione accademica e una vasta esperienza sul campo, diede un contributo importante in termini di rigore scientifico. Dal 1864 al 1904, anno della sua morte, ne fu il vicepresidente, stringendo un duraturo sodalizio con George Davidson, presidente dal 1871 al 1887; a partire dal 1862, occupò a più riprese il ruolo di curatore del dipartimento di entomologia. In effetti, in California il suo interesse preminente divennero le farfalle, di cui esplorò anche le potenzialità economiche. Nel 1855 nel primo volume dei Proceedings dell'Accademia comparve una sua memoria dedicata a Saturnia rubra (oggi Hyalophora euryalus), ospite di Ceanothus thyrsiflorus, a suo parere altamente promettente come sostituto del baco da seta. I suoi tentativi di lanciare un'industria sericola a partire da questa farfalla autoctona fallirono, ma fu l'inizio di una estesa raccolta di bachi, fatti venire anche dall'estero, che andò ad aggiungersi alla sempre più vasta collezione di lepidotteri, in parte raccolti da lui, in parte ottenuti con scambi internazionali con altri naturalisti. Intorno al 1882, gli esemplari erano ormai 20,000. Tra il 1863 e il 1870 Behr dedicò ai lepidotteri almeno una decina di articoli pubblicati su riviste scientifiche come Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia,Transactions of the American Entomological Society e Entomologische Zeitung. La botanica non era mai stata dimenticata, ma tornò al centro a partire dal 1872, quando Behr fu nominato professore di botanica della Facoltà di farmacia della California. Faceva lezione due volte la settimana e ogni quindici giorni guidava i suoi studenti in escursioni botaniche nei dintorni; per loro scrisse Synopsis of the genera of vascular plants in the vicinity of San Francisco, with an attempt to arrange them according to evolutionary principles (1884), in cui conciliò la fedeltà al sistema linneano con l'apertura all'evoluzionismo. L'attenzione alle piante native è palese in Flora of the Vicinity of San Francisco, una guida da campo rivolta a un ampio pubblico. Alla rapida trasformazione dell'ambiente naturale in seguito all'esplosiva urbanizzazione della città (tra il 1850 e il 1885 la popolazione decuplicò, passando da 25.000 a oltre 250,000 abitanti), di cui era stato attento e consapevole testimone, dedicò Botanical Reminiscences, pubblicati nel 1891 e nel 1896, un documento straordinario su ambienti e piante oggi scomparsi e sull'introduzione di piante esotiche. A quest'ultima contribuì - e non sempre in modo felice: in questo sì, pericoloso - lo stesso Behr che si era mantenuto in contatto epistolare con Mueller e per suo tramite introdusse in California diverse piante australiane, tra cui l'invasiva Avicennia marina subsp. australasica e vari eucalipti. Ma non è finita: oltre che antropologo, entomologo e botanico, il poliedrico personaggio fu anche un dotato scrittore. A indirizzarlo alla scrittura fu il viaggiatore e narratore tedesco Friedrich Gerstäcker che durante il suo viaggio attorno al mondo fece tappa nella California della febbre dell'oro; era diretto in Australia e a San Francisco incontrò Behr; i suoi coloriti racconti sull'emigrazione tedesca in Australia lo colpirono talmente che gli suggerì di ricavarne un romanzo. Nacque così Auf fremder Erde ("Nella terra straniera"), pubblicato nel 1864 in Germania dalla casa editrice di Gerstäcker con la prefazione di quest'ultimo; Behr lo firmò con la pseudonimo Ati Kambang ("carattere allegro", "indole gaia") e vi descrisse in tono spesso umoristico i comportamenti e le interazioni tra i vari gruppi etnici di immigrati e gli aborigeni. L'editore invece rifiutò il secondo romanzo di Behr, Dritte Söhne ("I terzi figli") che si svolgeva in California e fu poi pubblicato a puntate su una rivista americana in lingua tedesca. Con queste credenziali, nel 1873 Behr fu tra i primi aderenti al Bohemian Club. Fondato l'anno prima e diversissimo ai suoi esordi dal club attuale, ritrovo di miliardari e politici di primo piano, era un'associazione informale di giornalisti, artisti e scrittori che si incontravano periodicamente nel retro di un locale, il Jolly Corks. Qui, tra una bevuta e l'altra, i membri del Club presero l'abitudine di allestire spettacoli interni detti Jinks, che tipicamente sviluppavano un tema in forma di poesie, canzoni, scene teatrali. Behr vi trovò il palcoscenico ideale per il suo spirito ironico; le scenette, i monologhi e i non sense da lui creati per i jinks furono pubblicati poco dopo la sua morte da un gruppo di amici sotto il titolo The Hoot of the Owl ("Il grido della civetta") La civetta era il simbolo del club e Behr ne teneva una come animale da compagnia. Il suo carattere è stato descritto in vari modi, abbastanza contraddittori; aveva fama di eccentrico, di persona cordiale con gli amici ma sferzantemente ironica con chi incorreva nella sua disapprovazione. Rimase celebre uno scontro con il micologo Harvey Willson Harkness che nel 1887 era stato elettopresidente dell'Accademia delle scienze, battendo Davidson. Durante un'accesa discussione del comitato direttivo, non riuscendo a smontare la serrata argomentazione di Behr , Harkness sbottò "Vada al diavolo!", al che Behr rispose in tono cortese: "Dopo di lei, mio caro signore". Oltre a scrivere per riviste scientifiche sia statunitensi sia tedesche, Behr era in relazione epistolare con molti studiosi in entrambi i continenti. Nel 1898 la sua alma mater, l'università di Berlino, volle festeggiarlo conferendogli la laurea honoris causa con una solenne cerimonia. Behr morì a quasi 86 anni, nel 1904, lasciando all'Accademia delle scienze californiana libri, manoscritti e l'inestimabile collezione di insetti. Purtroppo tutto andò in fumo nell'incendio che distrusse la sede dell'accademia in conseguenza del devastante terremoto del 1906.  Riservato ai colibrì! Abbiamo già visto che Behr è ricordato dall'eponimo di diverse specie della flora australiana (e ovviamente di numerosi lepidotteri, tanto australiani come Etiella behrii quanto americani come Parnassius behrii ). E' invece endemica della Baja California Behria tenuiflora, unica specie del genere Behria, dedica dell'amico e collega Edward Lee Greene, curatore dell'erbario dell'Accademia delle scienze californiane fino al 1885, quindi primo professore di botanica all'università di Berkley. Con lui (come con Alice Eastwood che ne scrisse un commosso necrologio) doveva avere rapporti cordiali, se nella dedica Greene scisse: "Il genere è dedicato al nostro eccellente amico, il dr. H. Hermann Behr, professore di botanica della Facoltà di Farmacia dell'Università di California". Come ho accennato in questo post, la status del genere Behria, appartenente alla sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae, è discusso. Secondo alcuni studiosi va incluso nell'affine Bessera, ma i botanici dell'Università della Baja California, che studiano questo gruppo di piante da anni, ne sostengono l'indipendenza sulla base della distribuzione, della morfologia e dei dati molecolari. Infatti, mentre le quattro specie di Bessera si distribuiscono nel versante pacifico del Messico lungo la faglia vulcanica trans messicana, Behria è esclusiva dell'estremità meridionale della Baja California, dove è relativamente comune, crescendo dal livello del mare alla cima della catena montuosa, a circa 2200 metri d'altezza. Come le altre specie di questa sottofamiglia, è dotata di cormi, da cui emergono una o più foglie lineari e uno scapo che termina in un'infiorescenza a ombrella; tuttavia i fiori sono alquanto diversi: quelli di Bessera sono campanulati, con il tubo del perianzio che racchiude parzialmente l'ovario, quelli di Behria sono tubulari e il perianzio racchiude totalmente l'ovario. Come quelli di Bessera, anche i fiori di Behria sono vivacemente colorati, con tubo arancio vivo striato di giallo, e sono impollinati dal colibrì di Xantus Basilinna xantusii. In natura, fiorisce da settembre a febbraio, quando la temperatura si è fatta più fresca e può godere di un minimo di umidità. Piuttosto capricciosa e imprevedibile (può andare in dormienza anche per anni se non trova le condizioni giuste), è raramente coltivata nonostante la sua bellezza. Thad M. Howard in Bulbs for Warm Climates sostiene che in coltivazione tende a morire dopo un anno o due e conclude: "Forse è meglio lasciare questa specie al godimento dei colibrì della Baja California".
0 Comments
Per Robert Brown, la partecipazione alla spedizione Flinders segnò l'inizio di una lunga e operosa carriera scientifica. Dopo il viaggio e le raccolte, venne il momento dello studio e delle pubblicazioni, la più ceelebre delle quali è Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van-Diemen che ne fa il padre della botanica australiana. Successivamente bibliotecario e curatore delle collezioni della Linnean Society, ultimo bibliotecario di Banks, curatore delle collezioni banksiane del British Museum, capo del Dipartimento di botanica dello stesso, presidente della Linnean Society, fu una figura di spicco della botanica britannica, anche se il suo carattere schivo e la meticolosa lentezza del suo lavoro tesero a isolarlo dalle nuove generazioni. Di grande importanza i suoi contributi alla tassonomia e gli studi sul polline, il nucleo cellulare, la differenza tra gimnosperme e angiosperme. Mentre studiava il polline al microscopi, le sue osservazioni sconfinarono nella fisica, con la scoperta di quello che più tardi verrà chiamato "moto browniano". A ricordarlo, oltre a diverse località, australiane o meno, e moltissimi eponimi, i generi australiani Brunonia e Brunoniella. 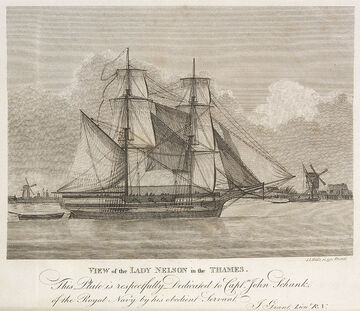 L'ultimo viaggio: Tasmania Quando Robert Brown accettò la proposta di Banks di unirsi alla spedizione Flinders, anche se il suo nome era già piuttosto noto nei circoli botanici britannici, soprattutto come esperto di crittogame (varie felci e muschi da lui raccolti furono pubblicati in Fasciculi plantarum cryptogamaticarum Britanniae da Dickson, con il suo permesso, ma senza citarlo), come aiuto chirurgo di un reggimento di stanza in Irlanda non aveva molte prospettive. La spedizione in Australia fu la grande occasione che attendeva. In tre anni e mezzo, con l'aiuto del giardiniere Good e del pittore Ferdinand Bauer, raccolse più di 3400 esemplari botanici (cui vanno aggiunti animali e minerali), anche se una parte considerevole di queste raccolte andò perduta durante il naufragio del Purpoise, Già prima di quella sventura, lui e Bauer avevano deciso di accettare l'invito del governatore King di continuare ad esplorare la flora della colonia. Per qualche mese, alternò l'esplorazione dei dintorni di Port Jackson con la sistemazione delle proprie raccolte, descrivendo molte piante, momentaneamente classificate secondo il sistema linneano, nel manoscritto intitolato Descriptorium plantarum Novae Hollandiae que in fasciculis parvis Continentur, finché il 28 novembre 1803 si imbarcò sulla Lady Nelson, inviata a Port Phillipp per trasferire in Tasmania i coloni di quell'insediamento che si era rivelato poco propizio. Non appena la nave raggiunse lo stretto di Bass, incontrò un tempo così ostile che fu costretta a rifugiarsi nelle isole del Kent Group, dove rimase bloccata per quasi un mese. Brown approfittò della sosta forzata per esplorare la flora della Deal Island, soprattutto le piante marine. Verso la fine del mese, sopraggiunse la Francis, diretta a Port Dalrymple sulla costa settentrionale della Tasmania. A bordo c'era un gruppo di esploratori incaricati di verificare se la zona era adatta a ospitare la nuova colonia. Poiché la nave era stata alquanto danneggiata dalla tempesta, fu deciso che sarebbe rientrata a Port Jackson per riparazioni, mentre la Lady Nelson l'avrebbe sostituita nella missione, dirigendosi a sua volta a Port Dalrymple, dove gettò l'ancora il giorno di Capodanno 1804. Sino al 18 gennaio, quando salpò per Port Phillipp, vennero esplorate la baia e il corso del fiume Tamar; Brown partecipò a varie spedizioni, ma la stagione già avanzata limitò le sue raccolte. Gli esploratori si trovarono alle prese con un incendio e ci furono anche diversi incontri non molto amichevoli con gruppi di indigeni. Quando infine la Lady Nelson arrivò a Port Phillipp, il governatore Collins aveva già deciso che il nuovo insediamento sarebbe sorto alla foce del fiume Derwent (si tratta dell'odierna Hobart). Così il 30 gennaio la nave ripartì per trasportarvi il primo contingente di coloni. A bordo c'era anche Robert Brown, che nei successivi sei mesi avrebbe esplorato il monte Wellington (che all'epoca era chiamato Table Mountain per la sua somiglianza con la montagna che domina Città del Capo), il fiume che ora porta il suo nome Brown River, la bassa valle del Derwent e l'estuario dell'Huon. Di ritorno a Port Jackson nell'agosto 1804, riprese a visitarne i dintorni, a volte insieme al botanico ufficiale della colonia George Caley, spingendosi a nord fino al fiume Hunter. Il 23 maggio 1805 si imbarcò alla volta dell'Inghilterra sul rabberciato Investigator insieme a Ferdinand Bauer, rientrato dalle isole Norfolk. Portava con se un erbario di 1200 piante, semi, minerali e collezioni zoologiche. 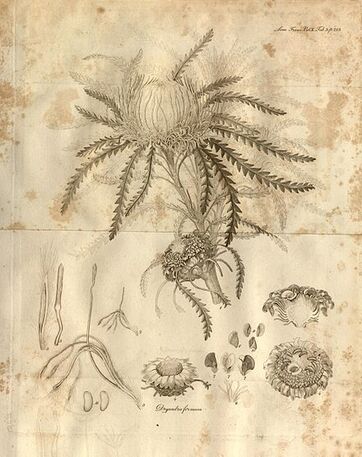 Prime pubblicazioni: uno scandalo e un disastro finanziario Ad ottobre i due amici erano di ritorno in Inghilterra. Per entrambi era giunto il momento di passare per uno dagli schizzi agli acquarelli, per l'altro dalla raccolta allo studio. Il progetto comune era la pubblicazione di una Flora complessiva dell'Australia, con i testi di Brown e le illustrazioni di Bauer. Il botanico poté dedicarsi quasi a tempo pieno al progetto grazie alla Linnean Society, che lo assunse come impiegato e bibliotecario. Era ancora ben lontano dalla meta quando, nel 1808, Dryander (il segretario e bibliotecario di Banks) gli chiese di scrivere una monografia sulle Proteaceae, in modo che egli potesse utilizzare le sue denominazioni nella nuova edizione di Hortus Kewensis che stava allestendo con il capo giardiniere Aiton. Brown accettò, studiando in modo molto accurato non solo le Proteaceae che aveva raccolto personalmente in Australia e in Sud Africa, ma anche le piante vive della collezione del mercante George Hibbert, gli erbari di Banks, Smith, Lambert e altri; poté anche esaminare brevemente le raccolte di Labillardière. Il saggio fu pronto all'inizio del 1809 e Brown lo lesse nel corso di quattro sedute della Linnean Society, tra gennaio e marzo. La pubblicazione però tardò fino al marzo 1810, quando apparve sia nella rivista della società con il titolo On the Proteaceae of Jussieu sia come volume a sé con il titolo On the natural order of plants called Proteaceae. Com'è chiaro da questi titoli, Brown non segue più la classificazione linneana (che già lo aveva lasciato insoddisfatto in Australia, ma che aveva provvisoriamente conservato per comodità) ma quella "naturale" di Antoine Laurent de Jussieu. Egli propone una nuova classificazione della famiglia, servendosi per la prima volta anche dell'analisi del polline; ne discute la distribuzione geografica; stabilisce due sottofamiglie, basandosi sulla contrapposizione tra frutti deiscenti e indeiscenti; descrive 404 specie e 38 generi, 18 dei quali nuovi. Il saggio segnò il riconoscimento scientifico di Brown, ma fu anche seguito da aspre polemiche. Poco dopo le conferenze alla Linnean Society, quindi molti mesi prima della pubblicazione a stampa del saggio di Brown, uscì On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, dopo una breve parte iniziale realmente dedicata alla coltivazione di queste piante firmata da Joseph Knigth, il giardiniere di Hibbert, presentava un'ampia revisione tassonomica della famiglia. Non era firmata ma l'autore fu facilmente identificato in Richard Salisbury che già in Paradisus londinensis (1806) aveva trattato diverse Proteaceae. Egli aveva assistito alle conferenze di Brown e, secondo la ricostruzione corrente, aveva memorizzato il nomi dei suoi nuovi generi; ora ne anticipava la pubblicazione, "rubandoli" al vero autore. Accusato di plagio, fu di fatto ostracizzato dalla botanica britannica. Brown stesso fu profondamente scioccato e scrisse di Salisbury in questi termini: "Non so che cosa pensare di lui tranne che sia un briccone e un pazzo". Nel 1810 Brown finalmente terminò quella che riteneva la prima parte della sua flora australiana; la pubblicò a proprie spese, senza illustrazioni, come Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, vol. 1; la numerazione del testo iniziava a p. 145, perché egli prevedeva una prefazione da aggiungere in ristampa. Le vendite furono così scarse che il botanico ritirò il volume dal commercio e rinunciò a scrivere sia la prefazione sia i volumi successivi. Solo vent'anni dopo sarebbe uscito un supplemento, dedicato alle Proteaceae scoperte nel frattempo. Anche il volume con le illustrazioni di Bauer (1813) fu un fiasco totale. Nonostante il disastro finanziario, il libro di Brown è una pietra miliare della botanica che segna il vero inizio dello studio sistematico della flora australiana, con la pubblicazione di 2040 specie, oltre metà delle quali nuove, e importanti contributi anche metodologici alla sistematica; vengono stabilite nuove famiglie (all'epoca si chiamavano ordini), molte delle quali tuttora accettate, e definiti in modo più preciso i criteri di classificazione delle famiglie stesse, all'epoca ancora piuttosto fluidi, 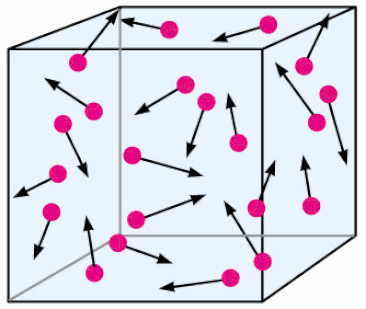 Brown diventa il Giove della botanica Il 1810 segnò per Brown anche un'importante svolta professionale. In seguito alla morte di Dryander, Banks lo assunse come segretario e bibliotecario, con uno stipendio annuo di 200 sterline e l'uso di un alloggio privato a Soho Square. Occuparsi di quella immensa biblioteca e di quel grandioso erbario, garantendone l'accesso ai numerosi visitatori, era tutt'altro che una sinecura. Per Brown, significò anche allargare i suoi interessi a nuove piante e nuove aree geografiche. Ad esempio, nel 1814 in appendice di A voyage to Abyssinia di Henry Salt pubblicò una lista di 146 piante abissine e nel 1818 l'erbario raccolto da Christian Smith in Congo. Nel 1820, alla morte di Banks, Brown ne ereditò la biblioteca e l'erbario con la clausola che, alla sua stessa morte, fossero trasferiti al British Museum. Nel 1827 egli anticipò la volontà del suo benefattore facendone dono al Museo, garantendosene però il controllo come Curatore delle collezioni banksiane; nel 1837, quando il dipartimento di Storia naturale venne diviso in tre sezioni, egli fu nominato primo curatore del dipartimento di botanica, incarico che mantenne fino alla morte. La sua posizione al British Museum ne faceva una delle figure più importanti della botanica britannica e gli permetteva di continuare a fare ciò che più amava: studiare meticolosamente le piante e le loro strutture microscopiche. Non a caso per ben due volte rifiutò una cattedra universitaria: non solo quella di Edimburgo, che implicava l'insegnamento della medicina, ma anche quella di botanica di Glasgow, per la quale caldeggiò la candidatura di William Jackson Hooker. Brown era un grande osservatore, uno sperimentatore metodico e rigoroso, uno scienziato aperto all'innovazione. Queste qualità emergono pienamente dalle sue scoperte degli anni '20 e '30. Nel 1827, in un saggio dedicato al nuovo genere Kingia, fu il primo a riconoscere le differenze fondamentali tra gimnosperme e angiosperme (anche se lui non le chiamava ancora così): mentre le ultime hanno semi racchiusi in un ovario (solitamente il frutto), le prime non hanno né fiori né frutti e i semi si presentano "nudi" e disposti sulle scaglie di un cono o pigna. E' sempre del 1827 la scoperta più celebre al di fuori della botanica. Mentre studiava al microscopio granuli di polline di Clarkia pulchella in sospensione acquosa, egli notò che essi erano in continuo movimento e che tale movimento avveniva in direzioni casuali. Dapprima pensò che i granuli fossero vivi, ma poi ripeté l'esperimento con moltissimi materiali diversi, organici e inorganici, verificando che il movimento avveniva sempre nello stesso modo. Egli non propose una spiegazione del fenomeno, tranne osservare che doveva essere un riflesso della struttura molecolare della materia. La spiegazione di quello che è noto come "moto browniano" arriverà molti anni dopo: nel 1905 da parte di Albert Einstein. Nel 1831, mentre studiava i meccanismi di impollinazione di piante delle famiglie Orchidaceae e Asclepiadeaceae, Brown notò nella cellule delle orchidee la presenza di un struttura che poi osservò anche in altre piante e la denominò "nucleo" della cellula. Il nucleo era già stato osservato in precedenza, forse fin dal Seicento dal microscopista olandese Leeuwnhoek; lo aveva notato e disegnato anche Franz Bauer a partire dal 1802, ma Brown fu il primo a dargli il nome. Sia lui sia Bauer però pensavano che fosse presente solo nelle monocotiledoni. Brown era altamente apprezzato dai suoi contemporanei; Humboldt lo definì "botanicorum facile princeps" e von Martius "Jupiter Botanicus", certo in riferimento anche al suo ruolo di padre padrone del dipartimento di botanica del British Museum. Come figura anche istituzionale, fu membro di molte società scientifiche come la Reale accademia svedese delle Scienza, la Reale accademia olandese delle Scienze e delle Arti, l'Accademia americana delle Arti e delle Scienze. Aveva un particolare legame con la Linnean Society: nel 1822 si era dimesso da impiegato, era stato immediatamente accolto come membro, poi entrò a far parte del Consiglio e nel 1828 fu nominato vicepresidente, presidente dal 1849 al 1853, quindi nuovamente vicepresidente fino alla morte. Brown era innegabilmente un grande scienziato, che qualcuno considera addirittura il maggiore botanico del suo tempo; ma la sua meticolosità e la sua dedizione al lavoro ebbero anche un risvolto negativo. Non amava delegare, con il risultato che molti esemplari raccolti da botanici e viaggiatori delle generazioni successive finivano di attendere il loro turno nei depositi del British Museum, in attesa che potesse occuparsene. Era il caso in particolare delle piante australiane, che egli tendeva a considerare la sua riserva di caccia. Il risultato fu che molte delle sue stesse raccolte rimasero inedite e che la prima opera importante sulla flora australiana dopo il Prodromus, Flora australiensis di George Bentham, iniziò ad uscire solo dopo la sua morte. Quale fosse l'atteggiamento dei naturalisti più giovani verso questo mostro sacro (anche fisicamente: era alto, imponente, severo, di poche parole e di spirito tagliente) ce lo racconta un aneddoto che ha per protagonista Charles Darwin. Nel corso del famoso viaggio attorno al mondo a bordo del Beagle, aveva visitato anche l'Australia e sapeva che il vecchio botanico era ansioso di aver da lui qualche esemplare stuzzicante. Ma lui, convinto che sarebbero finiti a prendere polvere nei magazzini del British, non aveva nessuna intenzione di accontentarlo. Così, quando alla fine lo incontrò, lo distrasse regalandogli un po' di legno fossile (i fossili erano una passione comune). In una lettera commentò: "Credo che il mio legno silicizzato abbia disselciato il cuore di Mr. Brown". 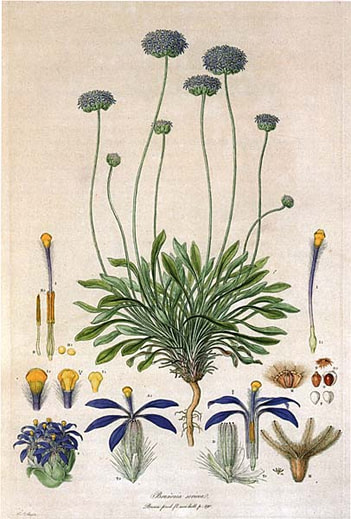 Omaggi floreali e no Robert Brown morì ottantacinquenne nel 1858 nell'alloggio di Soho Square dove abitava dal 1810. A ricordarlo vi è stata posta una targa, ma i luoghi a lui legati sono molti altri: nell'Australia meridionale il monte Brown che scalò durante la spedizione Flinders e oggi ospita un parco nazionale a lui dedicato e in Tasmania il fiume Brown; non mancano località che mai visitò, come il Capo Brown in Groenlandia, così denominato in suo onore da William Scoresby, o il monte Brown in Canada, omaggio di David Douglas, Le piante con eponimo brownii o brownianus si contano a centinaia; ci sono poi due generi, ovviamente australiani. A dedicargli il primo fu James Edward Smith che lo chiamò Brunonia; scopriamo perché grazie alle frasi iniziali del suo An Account of a new Genus of New Holland Plants named Brunonia, letto durante la seduta del 6 febbraio 1810 della Linnean Society, di cui Smith era fondatore e presidente: "Per la conoscenza della pianta che mi accingo a presentare, sono obbligato a Mr. Brown, bibliotecario della Società, che la scoprì nel corso delle sue ricerche botaniche in Nuova Olanda. Una parte assai interessante della sua ricca messe in quel paese occupa un'ampia porzione di questo volume delle nostre Transactions. Con una simile prova del suo genio e della sua abilità davanti ai nostri occhi, qualsiasi testimonianza in tal senso da parte mia sarebbe superflua, ma sono ansioso di cogliere l'opportunità, che egli ha accettato dietro mia ardente sollecitazione, di rendere giustizia ai suoi meriti dedicandogli questo genere nuovo e molto particolare. Poiché esiste già un genere Brownea in memoria dello studioso della storia naturale della Giamaica [Patrick Browne], per evitare ogni ambiguità e mantenere la massima somiglianza possibile con il suo nome, sono obbligato a ricorrere all'espediente, non eccezionale e autorizzato da precedenti, di chiamare il mio genere Brunonia". L'espediente usato da Smith consiste nell'usare l'equivalente latino di Brown, Bruno (gen, Brunonis). Qualche mese più tardi, Brown usò i nomi di Smith nel Prodromus; poiché la conferenza di Smith venne pubblicata solo nel 1811, la priorità di pubblicazione del genere spetta a lui stesso, e non a Smith. In tal modo involontariamente Brown ha violato un tabù della terminologia botanica, dedicando un genere a se stesso. Brunonia R.Br. (oppure Brunonia Smith ex R.Br.) è un genere curioso al di là di questo aneddoto. Smith lo aveva scelto perché costituiva un vero enigma tassonomico. Sembrava infatti in relazione con molte famiglie naturali, ma era difficile attribuirla con certezza all'una piuttosto che all'altra. L'incertezza non si è sciolta con il passare del tempo. In passato è stato attribuito a una famiglia propria, Brunoniaceae, ma a partire dal 2003 è stato trasferito nelle Goodeniaceae, dalle quali per altro differisce perché è l'unico con fiori a simmetria radiale, ovario supero e semi privi di endosperma. Oggi gli è attribuita un'unica specie, B. australis, un'erbacea annuale o perenne con foglie riunite in una rosetta basale, da cui emergono esili scapi che portano alla sommità una densa infiorescenza a capolino di numerosi piccoli fiori blu cielo o più raramente malva. Piuttosto diffusa, è presente in tutto il paese; predilige suoli sabbiosi o rocciosi e ambienti aridi e aperti, ma non ne è esclusiva. Si trova infatti anche in boscaglie e foreste aperte. Le infiorescenze ricordano quelle delle Scabiosa o della Knautia, da cui il nome comune blue pincushion. Un secondo omaggio è arrivato in tempi molto più recenti. Nel 1964 l'olandese Bremekamp decise di creare un nuovo genere per accogliere le specie australiane del genere soppresso Aporuellia (famiglia Acanthaceae). Poiché tre di queste specie erano state raccolte e descritte per la prima volte da Robert Brown (che le aveva assegnate al genere Ruellia) lo chiamò Brunoniella in suo onore. Comprende sei specie, cinque endemiche dell'Australia e una della Nuova Caledonia. Sono perenni tuberose, prostrate o erette, quasi tutte nane, con rami spesso scanalati longitudinalmente o appiattiti, foglie in coppie opposte ai nodi e fiori con corolla imbutiforme solitari o raccolti in spighe lasche. L'ambiente tipico è il sottobosco delle boscaglie e delle foreste umide dell'Australia settentrionale o nord-orientale. Anche se esistono anche altri colori, anche per questo genere il colore dominante dei fiori è l'azzurro, Il "Viaggio di scoperta alle Terre australi", più noto come "Spedizione Baudin", avrebbe dovuto assicurare la gloria scientifica della nuova Francia di Napoleone; invece, nonostante gli indubbi successi, con la ricognizione di ampi tratti delle coste australiane e la raccolta di migliaia di esemplari, è passato alla storia come una spedizione maledetta. Defezioni, malattie e morti ne falcidiarono l'imponente équipe scientifica: alla partenza da Le Havre, a bordo del Géographe e del Naturaliste, senza contare uno stato maggiore di una sessantina di eccellenti ufficiali, diversi dei quali recentemente diplomati dell'Ecole polytechnique, c'erano ventidue tra scienziati e artisti; alla partenza da Mauritius alla volta dell'Australia, il secondo gruppo si era ridotto a quattordici (contando anche due artisti reclutati nel frattempo); alla partenza da Port Jackson per la seconda parte della spedizione, erano diventati nove. In Francia ne tornarono solo sei, tre dei quali morirono nel giro di pochi anni in seguito alle malattie contratte durante il viaggio. Dunque, un vero disastro sul piano umano, non compensato dai risultati scientifici, imponenti ma in gran parte rimasti inediti. Occorreva un capro espiatorio, e fu facilmente trovato nel capitano Baudin: un outsider ammesso da pochissimo nella marina militare, dopo aver servito per anni una potenza nemica, per di più impossibilitato a difendersi, essendo morto lui stesso durante il viaggio. A costruire la leggenda nera provvidero solerti gli autori della relazione ufficiale, prima lo zoologo Péron poi l'ufficiale Louis de Freycinet, che per motivi diversi nutrivano astio nei confronti dello sventurato comandante. Solo in anni relativamente recenti, la pubblicazione del giornale di bordo di Baudin ha permesso di riequilibrare un poco quel quadro. Eppure, i risultati erano sotto gli occhi di tutti: nel parco della Mailmaison scorrazzavano canguri ed emù e cigni neri si dondolavano sul laghetto, mentre i giardini e i viali di Francia incominciavano a popolarsi di eucalipti e di mimose, germinate dai semi giunti dall'Australia. Tra ufficiali-cartografi e scienziati, contando sia quelli che rimasero fino alla fine sia quelli che lasciarono la spedizione, sono almeno una dozzina quelli che hanno ricevuto l'onore di un genere botanico; due soli sono validi, e per una strana coincidenza ricordano due dei salvati tornati a Le Havre a bordo del Géographe: l'ultimo comandante, Pierre Bernard Milius, colui che lo riportò in Francia dopo la morte di Baudin, e l'unico tra i giardinieri o botanici rimasto fino alla fine: il ragazzo giardiniere Antoine Guichenot, sedicenne quando lasciò Le Havre. La spedizione si sfilaccia: Le Havre-Ile de France Dopo il successo della spedizione della Belle Angelique e la trionfale partecipazione alla Festa della libertà, Nicolas Baudin, che ormai godeva della stima e dell'amicizia di Antoine Laurent de Jussieu, il direttore del Museum National, propose al Direttorio una missione scientifica più ambiziosa: niente meno che la circumnavigazione del globo, per rinnovare la gloria del viaggio di Bougainville in salsa repubblicana. Sempre a corto di quattrini, il Direttorio tergiversò, finché Baudin e i suoi sponsor del Museum tornarono alla carica con il nuovo padrone della Francia, Napoleone Bonaparte. Il primo console ricevette il capitano e una delegazione dell'Institut national des sciences et des arts, approvò il progetto, ma fissò una meta e un compito più circoscritti: l'esplorazione e la mappatura delle coste meridionali, occidentali e settentrionali della Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Non di meno, per il numero di persone coinvolte e l'ampiezza degli obiettivi scientifici, che oltre alla cartografia includevano mineralogia, astronomia, zoologia, botanica ed etnografia, si trattava di un'impresa grandiosa, che avrebbe dovuto sancire la preminenza scientifica della nuova Francia. Nulla fu lasciato al caso. Una commissione, che comprendeva molti dei più bei nomi del Museum, stilò precise istruzioni (quelle antropologico-etnografiche furono scritte da Cuvier), l'itinerario venne fissato nei minimi particolari, furono allestite due corvette di recente fabbricazione, la Galathée et la Menaçante, prontamente ribattezzate Géographe e Naturaliste, cui venne aggiunto un ponte per ricavare spazio per le provviste, le attrezzature e il personale scientifico, costituito da ben 22 tra scienziati, giardinieri e artisti. La attrezzature erano all'ultimo grido e comprendevano persino un alambicco per distillare e rendere potabile l'acqua marina. Si era in guerra, e fu necessario ottenere il beneplacito dell'Inghilterra, che fu concesso grazie alla mediazione di Joseph Banks, anche se lui stesso e la Royal Navy temevano che dietro quella facciata scientifica si nascondessero mire coloniali; ecco perché venne immediatamente allestita una contro-spedizione, quella del capitano Matthiew Flinders sull'Investigator, con la missione dichiarata di mappare le coste dell'Australia e quella segreta di sorvegliare i francesi. Il Géographe e il Naturaliste salparono da Le Havre il 19 ottobre 1800. A bordo del Géographe, comandato da Nicolas Baudin con l'assistenza del capitano di fregata Alexandre Le Bas de Sainte Croix, c'erano 118 uomini, tra ufficiali (tra i quali vale la pena di segnalare almeno il figlio di Bougainville Hyacinthe e Henri de Freycinet), marinai, personale di bordo, e un'équipe scientifica che comprendeva il geografo Charles-Pierre Boullanger, l'astronomo Frédéric Bissy, il mineralogista Louis Depuch, gli zoologi René Maugé, Stanislas Levillain e François Péron, il botanico Jean Baptiste Leschenault de La Tour, i giardinieri Anselme Riedlé, Antoine Sautier e Antoine Guichenot, gli artisti Louis Lebrun e Jacques Gerard Gilbert. Erano invece 120 le persone imbarcate sul Naturaliste, comandato dal capitano di corvetta Jacques Félix Hamelin des Essarts con l'assistenza del secondo Pierre Bernard Milius; tra gli ufficiali, il minore dei Freycinet, Louis; l'équipe scientifica comprendeva il geografo Pierre Ange Faure, il mineralogista Joseph Charles Bailly, l'astronomo Pierre-François Bernier, gli zoologi Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, i botanici Jacques Delisse e André Michaux, assistito dai giardinieri Jean François Cagnet e Merlot (un ex schiavo nero quattordicenne che Michaux aveva portato con sé dagli Stati Uniti), l'artista Michel Garnier. Sul Géographe, fin dall'inizio si creò un solco tra Baudin e i suoi ufficiali: quasi tutti di origine aristocratica, giovani, ambiziosi, diversi di loro da poco diplomati all'École polytechnique, mal tolleravano un comandante venuto dalla marina mercantile, che oltre tutto aveva servito per anni sono bandiera nemica; il carattere chiuso e autoritario di Baudin non aiutava. Il 2 novembre le navi gettarono l'ancora a Tenerife, dove si trattennero undici giorni. Michaux fu ospite di Broussonet, sull'isola in qualità di commissario delle relazioni commerciali del governo francese, che informò i compatrioti dell'imminente partenza per l'Europa di un battello con prigionieri inglesi; alcuni marinari ne approfittarono per disertare. Ma soprattutto nacquero le prime tensioni tra Baudin e i naturalisti: dopo qualche giorno passato a fare entusiasmanti raccolte, furono trattenuti a bordo in attesa di un'imminente partenza che però veniva rinviata di giorno in giorno. Eppure l'ordine non valeva per gli antichi compagni di Baudin sulla Belle Angélique, il giardiniere Riedlé e gli zoologi Maugé e Levillain. Le navi lasciarono Tenerife il 13 novembre, con qualche inconveniente dovuto alla maggiore lentezza del Naturaliste e alla difficoltà di allineamento tra le due navi. Al largo di Madera, il Géographe fu fatto segno di un colpo di cannone da un vascello spagnolo, che lo aveva scambiato per una nave britannica. Fu forse il rischio di altri incontri pericolosi a far optare Baudin per una rotta più prossima alla costa africana, anziché quella consueta più vicina alla costa brasiliana (alcuni però pensano a una scelta obbligata, dovuta alla caduta degli alisei); rallentata dalla bonaccia, la navigazione si allungò di un mese e mezzo. Con due conseguenze disastrose: il moltiplicarsi di casi di scorbuto e il crollo della fiducia nelle capacità marinare del comandante. Il Capo di Buona speranza venne avvistato solo a metà gennaio, senza farvi scalo. Dopo aver superato una tempesta, l'Ile de France fu raggiunta il 16 marzo 1801, con due mesi buoni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Qui le navi avrebbero dovuto esser rifornite di viveri e attrezzature, rifiutati però dalle autorità locali che avevano i magazzini sguarniti e temevano un attacco inglese. Baudin fu costretto a ricorrere a un prestito garantito dal console danese. Molti degli uomini erano malati, quasi tutti erano scontenti. A rompere gli indugi fu forse l'esempio di André Michaux. Il vecchio botanico, contrariato dalle regole d'ingaggio che stabilivano che le raccolte sarebbero appartenute esclusivamente allo Stato, diede le dimissioni, seguito dai suoi aiutanti Merlot e Cagnet. Dichiarandosi malati, lo imitarono l'astronomo Bissy, gli zoologi Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, il farmacista e botanico Jacques Delisse e tutti gli artisti. Baudin, che non credeva più di tanto a queste malattie più o meno diplomatiche, non li rimpianse, accontentandosi di trasferire Bernier sul Géographe e di sostituire gli artisti con due giovani di talento che si erano imbarcati come aiuto-cannonieri, Charles Alexandre Lesueur e Nicolas Martin Petit. Gli spiacque molto di più la diserzione di ventun marinai. 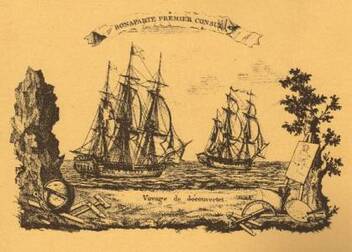 Malattia a bordo: Ile de France-Port Jackson È dunque con l'équipe scientifica dimezzata e gli effettivi ridotti che la spedizione riparte il 25 aprile 1801. Eccetto due giorni di tempesta, la navigazione è tranquilla e sospinta da venti favorevoli; la costa australiana è avvistata all'altezza del Capo Leuwen il 27 maggio. A causa del ritardo accumulato, Baudin ha infatti deciso di iniziare le ricognizioni non dalla Tasmania, secondo le istruzioni del Ministero della marina, ma dalla costa occidentale. Il primo contatto dei naturalisti con la terra australiana è nei pressi del capo che viene battezzato Naturaliste (31 maggio): i francesi si stupiscono nel vedere come una terra così arida ospiti una tale varietà di alberi e arbusti. Viene quindi esplorata la baia battezzata Géographe, dove va perduta una lancia e annega un marinaio. Il 10 giugno una tempesta separa le due navi. Avendo mancato i diversi punti d'incontro, non si riuniranno fino a Timor. Il Géographe esplora la costa tra Shark Bay e il North-West Cape, e in particolare l'isola Bernier dove l'attivissimo capo giardiniere Riedlé fa molte raccolte interessanti; poi, con diversi casi di scorbuto a bordo e provviste al lumicino, fa vela per Timor dopo getta l'ancora il 22 agosto. Il Naturaliste invece esplora a fondo la foce dello Swan river e le isole adiacenti, poi anch'esso si dirige a Timor, dove giunge un mese dopo l'ammiraglia. Lo scalo a Timor è necessario per rifornire la nave, ma notoriamente pericoloso. Molti si ammalano di dissenteria e muoiono sei uomini, tra cui il capo giardiniere Riedlé. Quando le navi lasciano Timor, il 13 novembre, i malati a bordo sono molti; tra di loro anche Leschenault, che è stato trasferito sul Naturaliste. Con grande gioia di Baudin, deve invece rimanere a terra il suo detestato secondo Le Bas de Sainte Croix, rimasto ferito in un duello contro l'ingegnere Ronsard. Lo sostituisce il maggiore dei Freycinet, Henri, Ora la spedizione fa rotta verso la Terra di van Diemen (ovvero la Tasmania). Prima di raggiungerla, sul Géographe si contano altri sette morti, tra cui il giardiniere Sautier (15 novembre) e lo zoologo Levillain (23 dicembre). Il 13 gennaio 1802 le due navi navigano lungo il Canale d’Entrecasteaux che separa la Tasmania dall'isola Bruny, dove gettano l'ancora. Il giorno dopo incontrano per la prima volta un gruppo di aborigeni. Iniziano a mappare accuratamente le coste sud-orientali dell'isola. Il 18 gennaio gettano l'ancora nella Great Oyster Bay, sulla costa occidentale di Maria Island. Qui muore e viene sepolto Maugé, che non si è mai ripreso; è un grave colpo per il comandante che con lui perde l'ultimo compagno della Belle Angelique e forse l'unico amico. Il 27 febbraio le due navi lasciano l'isola e fanno rotta a nord per continuare la ricognizione della costa orientale della Tasmania. Il 6 marzo un canotto con il geografo Boullanger, l'aspirante Maurouard e sei marinai è incaricato di rilievi più ravvicinati, ma a causa del cattivo tempo perde il contatto con il Géographe; tre giorni dopo, è recuperato dal brigantino inglese Harrington, che porta i francesi a bordo del Naturaliste, il quale a sua volta ha perso di vista l'altra nave. Come in precedenza, anche questa volta tutti i punti d'incontro verranno mancati, a partire da quello di Waterhouse, dove le due corvette passano il 19 marzo, a poche ore di distanza, senza riuscire a vedersi a causa della nebbia. Non si incontreranno più fino a Port Jackson (Sidney). Dopo qualche giorno di tempo tempestoso, Hamelin riprende i rilievi della costa orientale della Tasmania; ne parte il 7 aprile, e dopo aver fissato la posizione del Wilson Promontory e mappato la costa di Western Port, essendo a corto di viveri e acqua, fa rotta per Port Jackson dove getta l'ancora il 26 aprile. Ne riparte il 18 maggio, ma non avendo potuto doppiare la Tasmania a causa del cattivo tempo, vi rientra il 28 giugno. Invece Baudin, navigando verso nord, il 27 marzo ha raggiunto il Wilson Promontory e ha proseguito esplorando da est a ovest la costa meridionale dell'Australia. L'8 aprile si vede arrivare incontro un'altra nave: pensa si tratti del Naturaliste, invece è l'Investigator di Matthew Flinders: ovviamente, il capitano inglese sa benissimo che i francesi potrebbero essere da queste parti, e a ogni buon conto ordina di armare i cannoni, ma fa anche issare la bandiera bianca. I due capitani ignorano che pochi giorni prima (il 25 marzo) è stata firmata la pace d'Amiens; per quanto ne sanno, i loro paesi sono in guerra. Ma dopo tutto comandano una missione scientifica. L'Investigator affianca il Géographe e Flinders sale a bordo, i due capitani si salutano cordialmente e scambiano informazioni sulle loro rispettive scoperte. Un secondo incontro si avrà il mattino dopo. Il punto d'incontro (a 5 miglia dalla costa meridionale dell'Australia di fronte all'attuale Adelaide) sarà battezzato da Flinders Encounter Bay. Nonostante l'entusiasmo per aver incontrato un collega che stima e di cui conosce l'abilità di cartografo, Baudin è certo deluso per aver scoperto di non essere il primo ad aver mappato la costa meridionale dell'Australia, per altro solo per un breve tratto. Quindi la navigazione riprende. Poco dopo l'incontro con gli inglesi, nel golfo di St Vincent la nave è sballottata da onde così violente che Baudin lo ribattezza Golfe de la Mauvaise. Il 25 aprile il Géographe tocca le isole St Peter e St Francis, mappa la costa est della penisola Eyre, finché la scarsità di viveri e le malattie che continuano a imperversare a bordo convincono Baudin a raggiungere Port Jackson; il cattivo tempo lo costringe a prendere la rotta più lunga e difficile che contorna la Tasmania. Arriverà a Port Jackson il 20 giugno; il 28 le due corvette si riuniscono dopo quasi quattro mesi di separazione.  Ritorno: Port Jackson-Ile de France-Francia Accolti ospitalmente dagli inglesi (nonostante qualche tensione in occasione del decennale della Repubblica il 22 settembre 1802), i francesi si fermano a Port Jackson per quasi cinque mesi. A corto di uomini per le morti e le malattie, Baudin decide di acquistare una nave più piccola e più adatta ai rilievi oceanografici, la Casuarina (così chiamata dal legname usato per costruirla) e di rinviare in Francia il Naturaliste, con a bordo le carte, le memorie, le osservazioni scientifiche e le collezioni fatte nella prima parte del viaggio. A preparare le piante vive è il giovanissimo apprendista giardiniere Antoine Guichenot (sedicenne al momento della partenza, ora deve avere circa diciotto anni), l'unico rimasto dopo la defezione o la morte dei suoi quattro compagni. Nonostante i pochi anni, è solerte e capace, ed accompagna Baudin a bordo del Naturaliste per un'ultima ispezione quando il comandante vi sale per impartire a Hamelin dettagliate raccomandazioni su come trattare quel traporto tanto fragile quanto prezioso. Le tre navi lasciano insieme Port Jackson il 18 novembre; il 6 dicembre gettano l'ancora in una baia dell'isola King che appare letteralmente ricoperta di leoni marini, da cui il nome Sea Elephant Bay; agli occhi dei francesi, l'isola, con la sua vegetazione lussureggiante, la ricchezza di acqua e l'abbondanza di animali, è un vero paradiso terrestre. Péron, Lesueur, Guichenot e Leschenault, che si è riunito agli amici, sono ovviamente i più entusiasti, e vi si attardano alcuni giorni, mentre il Géographe è tenuto al largo dal cattivo tempo. Nel frattempo la Casuarina, comandata dal più giovane dei fratelli Freycinet, è stata inviata ad esplorare le isole Hunter. L'8 dicembre, mentre il Naturaliste si prepara alla partenza, arriva da Port Jackson la Cumberland, comandata dal capitano Charles Robbins, spedita dal governatore King per accertarsi che i francesi non abbiano l'intenzione di preparare un insediamento in Tasmania. Hamelin viene a sapere da uno degli uomini di Robbins che loro stessi hanno lo stesso compito, ma non ne informa Baudin. Poco dopo c'è l'addio definitivo. Il Naturaliste arriverà a le Havre il 7 giugno 1803, dopo essere stato trattenuto per breve tempo dagli inglesi a Portsmouth. Il 15 dicembre, nel corso delle manovre d'attracco nella Sea Elephant Bay, il Géographe perde una lancia. Riuscirà ad ancorarsi e a recuperare i naturalisti solo il 25 dicembre. Due giorni dopo si riunisce con la Casuarina e i due vascelli procedono insieme fino all'isola dei Canguri (scoperta l'anno prima da Flinders), di cui cartografano la costa meridionale. Quindi la Casuarina va ad esplorare i golfi St Vincent e Spencer, mentre il Géographe è all'ancora all'Eastern Cove, con gli uomini impegnati nella costrizione di una nuova lancia; ne parte il 1 febbraio 1803 e fa vela verso ovest; alle due è segnalata, in direzione opposta, la Casuarina: Freycinet non vira per seguire il comandante, e le due navi rimarranno separate per due settimane. Raggiunta la costa del continente nei pressi di Streaky Bay, il 7 febbraio il Géographe getta l'ancora a Denial Bay; durante la sosta di quattro giorni per i rilievi cartografici, i naturalisti hanno modo di incrementare le loro raccolte. Intanto la Casuarina ha visitato alcune delle isole Nuyts, per poi dirigersi verso il King George Sound, dove il 17 febbraio le due navi si riuniscono. L'area viene attentamente mappata, permettendo di nuovo ai naturalisti di scendere a terra. E' forse il luogo dove Guichenot e Leschenault fanno le raccolte più abbondonati. Il 20 febbraio, il sotto-luogotenente Ransonnet, che sta esplorando un tratto di costa, incontra la nave baleniera americana Union il cui comandante il giorno dopo fa visita a Baudin; in ricordo di questo incontro, la baia verrà denominata Two People Bay. Il 1 marzo la spedizione lascia il King George Sound, per doppiare il capo Leuwen e risalire la costa occidentale dell'Australia. Le due navi si perdono ancora una volta di vista, finché il 13 marzo si ritrovano alla Rottnest Island, fissata come punto d'incontro. Proseguono insieme fino a Shark Bay, dove Péron, Lesueur e Guichenot fanno notevoli raccolte, quindi esplorano la costa dal North-West Cape a un gruppo di isole, ribattezzato Bonaparte Archipelago. Alla fine di aprile, Baudin, già assai malato di tubercolosi, decide di dirigersi a Timor, per caricare acqua e rifornimenti. Vi arrivano il 6 maggio e ne ripartono il 3 giugno; Leschenault, anch'egli gravemente malato, viene lasciato a terra. Le due navi si dirigono a sud est, per iniziare la ricognizione della costa settentrionale dell'Australia, che esplorano fino all'altezza dell'isola Melville; il 5 giugno Bernier muore per una febbre contratta a Timor. L'equipaggio è sfinito, l'acqua sempre più scarsa, il comandante quasi in fin di vita: il 7 luglio, si rassegna a mettere fine alla spedizione e a tornare in Francia via Mauritius. Il Géographe vi arriva il 7 agosto, seguito il 12 dalla Casuarina, da cui era stato separato per l'ennesima volta da una tempesta. Il 16 settembre Baudin muore e viene sepolto con gli onori dovuti al suo rango, ma poco rimpianto dai suoi uomini. La Casuarina viene disarmata e venduta; uomini, attrezzature e raccolte vengono trasferite sul Géographe, che affronta l'ultimo tratto di viaggio sotto il comando di Pierre Bernard Milius. Nel maggio 1802 il secondo di Hamelin era stato lasciato malato a Port Jackson. Prima dell'arrivo del Géographe e del ritorno del Naturaliste, si era imbarcato per Canton e da qui nel febbraio 1803 aveva raggiunto l'Ile de France. Tra gli ufficiali della spedizione, è il più anziano, per questo viene preferito (con grande disappunto di quest'ultimo) al secondo di Baudin, Henri de Freycinet. Con un grande carico di collezioni portate da Timor e dalla Nuova Olanda o procurate in loco, il Géographe lascia il porto di Saint Louis il 16 dicembre, per terminare il suo viaggio a Lorient il 25 marzo 1804. Altre piante vengono aggiunte durante lo scalo al Capo di Buona Speranza.  Bilancio: disastro o successo? Il disastro umano, con la morte del comandante, di metà dei membri dell'équipe scientifica e di un decimo dell'equipaggio (una percentuale per altro non inconsueta nei viaggi oceanici dell'epoca) ha finito per eclissare i risultati geografici e scientifici della spedizione, che furono notevolissimi ma rimasero poco noti perché molto parzialmente pubblicati. Lo scopo principale della missione, rilevare le coste sud, ovest e nord dell'Australia, visitando le aree ancora ignote e rettificando le carte, era stato raggiunto almeno per la costa est della Tasmania, la costa ovest e ampi tratti della costa meridionale dell'Australia. A sancire questi risultati, la pubblicazione nel 1811 della cosiddetta "carta di Freycinet", inclusa nella seconda parte dell'Atlante storico che accompagna la relazione ufficiale del viaggio, scritta da Péron e Louis de Freycinet. Tuttavia, la spedizione di Baudin si intrecciò con quella di Flinders, con uno strascico di polemiche sulla priorità delle scoperte tra francesi e britannici che oscurò in parte anche questo successo. Per le scienze naturali, i contributi maggiori riguardano la zoologia e l'antropologia, e si devono alla stessa persona, François Péron. Con la defezione di Bory de Saint Vincent e Dumont e la morte di Levillain e Maugé, questo giovane allievo di Cuvier (aggregato alla spedizione soprattutto per le ricerche antropologiche), divenuto il solo zoologo della spedizione, dovette estendere il suo campo d'indagine alla biologia marina (il suo settore d'elezione), alle osservazioni metereologiche e all'intera fauna, Era un vero personaggio romantico (basti pensare che si era imbarcato in seguito a una delusione amorosa), con un carattere focoso e appassionato, ambizioso e ribelle che, spinto dal suo zelo di conoscenza, spesso si trovò in conflitto con Baudin. Preso dalla foga dell'esplorazione, tendeva a trascurare ogni prudenza e ad allontanarsi rischiando di perdersi e di ritornare ormai esausto e sulla soglia della disidratazione. Una di queste imprese (che ebbe come teatro la penisola della Shark Bay che oggi porta il suo nome e ospita il François Péron National Park) portò all'esasperazione il capitano Baudin che il 19 marzo 1803 scrisse sul giornale di bordo: "E' la terza scappata di questa natura che combina il nostro colto naturalista, ma sarà anche l'ultima, perché non gli permetterò più di scendere a terra, a meno che io stesso sia sulla stessa barca". Con l'aiuto dei disegnatori Lesueur e Petit, Péron mise insieme una collezione di 100.000 esemplari di 4000 specie diverse di cui 2500 nuove per la scienza. Impegnato nella stesura della relazione ufficiale della spedizione e morto pochi anni dopo il ritorno in Francia (durante la spedizione anche lui si era ammalato di tubercolosi), non poté catalogare e pubblicare le sue raccolte, che tuttavia diedero un contributo fondamentale alla conoscenza della fauna australiana, di cui poterono usufruire Lamarck e gli autori del Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle. Molto importanti anche le sue osservazioni antropologiche, soprattutto sui popoli aborigeni della Tasmania, che di lì a pochi anni sarebbero stati quasi totalmente sterminati dalle malattie e da una guerra genocida. Di fronte all'immensità delle collezioni del prorompente zoologo, quelle botaniche sembrano passare in secondo piano; anch'esse non furono pubblicate né dell'unico botanico sopravvissuto, Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (tornato in Francia solo nel 1807) né da La Billardière, cui furono affidate come esperto di flora australiana. In realtà, erano di notevole importanza e hanno lasciato una traccia tangibile nel paesaggio francese (e non solo). Secondo Antoine Laurent de Jussieu, l'erbario messo insieme da Riedlé, Sautier, Guichenot e Leschenault conteneva non meno di 1500 specie, in numerosi esemplari, preparati e conservati in modo eccellente. Come abbiamo visto, Riedlé morì durante il primo scalo a Timor e Sautier ebbe la stessa sorte durante la navigazione verso la Tasmania; così tutto il lavoro botanico ricadde sui due più giovani e inesperti, Guichenot sul Géographe e Leschenault sul Naturaliste. Si deve certamente a loro il grosso delle raccolte botaniche che riempivano le stive e il ponte del Naturaliste nel suo viaggio di ritorno e, secondo una testimonianza dell'epoca ammontavano, a più di mille pacchi di semi e cinquantacinque casse di piante; c'erano inoltre 3.560 esemplari d'erbario, raccolti da Riedlé, Leschenault e Maugé, ben impacchettati in 14 casse. Ancora maggiori le raccolte della seconda parte della spedizione, in cui i due poterono lavorare fianco a fianco; contando anche gli esemplari caricati all'Ile de France e al Capo di Buona Speranza, si trattava di 63 casse o mezzi barili con più di mille piante vive, cui vanno aggiunte due casse di semi e cinque casse di esemplari d'erbario. Durante il lunghissimo viaggio verso l'Europa, ovviamente le piante vive ebbero molto a soffrire. Thouin, che visitò il Naturaliste poco dopo l'arrivo della nave a Le Havre, dovette tristemente constatare che su circa 800 individui raccolti tra Timor e la Nuova Olanda, forse venti davano ancora segni di vita, e non più di 12 o 15 sembravano in buona salute; tutti gli altri erano morti per mancanza d'acqua o erano stati distrutti dai ratti che infestavano la nave. Un inventario redatto qualche mese dopo, cita tra le piante sopravvissute qualche albero da frutto cinese imbarcato all'Ile de France e sette piedi di Phormium tenax. Alcuni semi contenuti nelle balle di terra, fatte prudentemente trasportare al Museum, germinarono: erano graminacee e alcune specie dei generi Opercularia, Mimosa, Casuarina. Ventenat, nel suo splendido catalogo del giardino della Malmaison (cui, secondo le disposizioni di Napoleone, era destinato il meglio delle raccolte), cita espressamente quattro piante nate da semi trasportati dal Naturaliste: quella con cui volle incensare la neo-imperatrice Josephinia imperatricis (oggi Sesamum imperatricis), Apium prostratum, Hibiscus heterophyllus e Callistachys lanceolata. Il ricco carico del Géographe, che, anziché essere lasciato a se stesso, poté godere delle cure di Guichenot, ebbe sorte migliore, ma molte piante morirono per il freddo e le piogge incessanti in cui la nave incappò alla latitudine di Bordeaux. Ne sopravvissero circa 230; 98 tra le specie più sane furono scelte da Mirbel, il sovrintendente della Mailmaison, per le serre dell'imperatrice. Alcune furono poi moltiplicate per essere acclimatate nella Francia meridionale, soprattutto a Tolone e Nizza. Tra queste ultime, varie specie dei generi Ecalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, Acacia, tra cui la più nota di tutte, A. dealbata, ovvero la mimosa, che fiorì per la prima volta alla Malmaison nel 1811. Dunque, da molti punti di vista, un successo. Ma non quello che Napoleone avrebbe voluto: la gloria di aver mappato per primi le coste australiane era venuta meno e c'erano troppi morti e troppi errori da occultare. Farlo era semplice: attribuire tutto il buono a ufficiali, cartografi e scienziati, tutto il cattivo al capitano Baudin. Che essendo morto, non poteva difendersi. Un aneddoto vuole che, al rientro della spedizione, Napoleone abbia esclamato: "Baudin ha fatto bene a morire. Altrimenti l'avrei fatto fucilare". E' certamente apocrifo, ma rende bene l'idea. I primi a spargere maldicenze sul capitano erano stati ovviamente alcuni dei transfughi di Mauritius, desiderosi di attribuire la responsabilità della loro defezione a Baudin, raffigurato come incompetente, tirannico, vendicativo, nonché corrotto. Il colpo di grazia gli fu inferto dal resoconto ufficiale,Voyage de découvertes aux terres australes: exécuté par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goëlette le Casuarina, pendent les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, scritto da François Péron e completato da Louis de Freycinet. Come si vede fin dal titolo, Baudin è sparito. Infatti Péron evita di nominarlo se non in modo indiretto (notre commandant) e non esita a denigrarlo, spesso alterando i fatti; inoltre, per compiacere Napoleone, spesso e volentieri attribuisce nomi francesi a luoghi già scoperti dagli inglesi: così la costa sud-est dell'Australia diventa Terre Napoléon; in seguito alle proteste inglesi, queste denominazioni verranno cancellate nell'edizione definitiva del 1815, curata da Freycinet. Se le radici dell'astio dell'aristocratico Freycinet, che insieme al fratello maggiore più volte si era scontrato con Baudin, sono chiare, perché Péron si prestò? Alcuni parlano di vecchie ruggini, altri di ambizione, ma forse la spiegazione più convincente è che capitano e zoologo non potevano intendersi perché incarnavano due modi di concepire il sapere: Baudin (e i suoi raccoglitori Levillain, Maugé e Riedlé) quello dell'enciclopedismo settecentesco, Péron (e in qualche senso Leschenault) quello della specializzazione dei saperi. Purtroppo per Baudin, l'operazione riuscì perfettamente e la sua spedizione fu nota al mondo attraverso il resoconto alterato di Péron e Freycinet. Solo in tempi recenti, la pubblicazione dei diari di bordo, il confronto tra le testimonianze e le ricerche di archivio hanno cominciato a rendergli giustizia. Determinante è stata anche la mostra The Art of Science: Baudin’s Voyages 1800–1804, a cura del National Museum of Australia (30 marzo-24 giugno 2018), con molti materiali prestati dal Muséum d’histoire naturelle di Le Havre, tra cui i disegni e le splendide tavole di Lesueur per l'Atlas che accompagnava il resoconto ufficiale. Di notevole interesse anche il sito The Baudin Legacy project, a cura dell'Università di Sidney.  Epilogo: omaggi botanici La spedizione ha lasciato una notevole traccia nella nomenclatura botanica; tra i suoi membri, almeno una dozzina sono stati onorati dalla dedica di un genere botanico, anche se alcuni di loro lo hanno guadagnato in circostanze precedenti o successive. E' il caso ovviamente di André Michaux, che da tempo si era conquistato questo alloro con i suoi viaggi in Oriente e in America. Meriti successivi lo assicureranno agli altri transfughi di Mauritius Jean-Baptiste Bory de St Vincent e Jacques Delisse, che meritano un post a parte, così come Louis de Freycinet e Jean-Baptiste Leschenault de La Tour, per i quali il Viaggio nelle terre australi fu il preludio ad altre avventure. Generi oggi ridotti a sinonimi sono toccati sia a Baudin (ne ho già parlato qui) sia al comandante del Naturaliste Jacques Félix Hamelin des Essarts; ma forse quest'ultimo deve il genere Hamelinia (Asteliaceae, sinonimo di Astelia), dedicatogli nel 1832 da Achille Richard, soprattutto alle sue successive imprese militari, grazie alle quali divenne barone dell'impero; come eroe delle guerre napoleoniche, il suo nome figura sull'Arc de Triomphe, il solo di un ufficiale navale. Allo stesso modo, non fu solo la solerzia con cui trasportò in un porto francese le piante e gli animali della spedizione Baudin ad aver fatto guadagnare il genere Miliusa all'ultimo comandante del Géographe Pierre Bernard Milius (1773-1829). Egli fece infatti una notevole carriera amministrativa. Dal 1818 al 1821 fu governatore della Réunion (all'epoca ancora Ile Bourbon), dove intraprese molte iniziative come la costruzione di un canale e di strutture portuali e la fondazione del Collège Royal de Borbon e della Société philotechnique de Bourbon. Interessato alle arti e alle scienze, incoraggiò l'esplorazione botanica di Nicolas Bréon, il fondatore e primo direttore del Jardin du Roi dell'isola; in contatto epistolare con Leschenault de La Tour, che all'epoca si trovava in India, favorì e incoraggiò in ogni modo l'importazione di piante indiane a Bourbon. Al suo ritorno in Francia, portò con sé una pianta allora rara originaria del Madagascar, e ne donò tre esemplari all'orto botanico di Bordeaux, sua città natale. Si tratta dell'oggi notissima "spina di Cristo", ovvero Euphorbia milii, che lo celebra nell'epiteto (in cui il suo cognome francese è curiosamente declinato come se fosse una parola latina). Tra il 1823 e il 1825 fu governatore della Guaiana. Nel 1827, al comando del Scipion, si segnalò alla battaglia di Navarino, Il genere Miliusa gli fu dedicato a Alphonse de Candolle sulla base di un esemplare raccolto in India da Leschenault. Appartenente alla famiglia Annonaceae, comprende una sessantina di specie di alberi o arbusti eretti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e l'Australia settentrionale, con centri di diversità in India e in Tailandia. Diverse specie sono utilizzate nella medicina tradizionale: ad esempio M. balansae per le gastropatie, M. velutina come tonico e afrodisiaco, M. thorelii come analgesico. Veniamo ora ai naturalisti. A François Péron sono stati dedicati due generi Peronia, nessuno dei quali oggi accettato. Nel 1811, quindi poco dopo la sua morte, Delaroche, autore dei testi del celebre volume di Redouté Les liliacées, gli dedicò Peronia stricta, che era fiorita proprio quell'anno per la prima volta al Museum national da semi di origine ignota venuti dall'Inghilterra; la pianta fu poi identificato come Thalia dealbata. Nel 1832 volle ricordarlo anche Robert Brown, che era diventato buon amico di Péron e Leschenault durante lo scalo a Port Jackson; Peronia R.Br. è oggi sinonimo di Sarcosperma. Sono stati giustamente onorati tutti e tre i giardinieri che rimasero con Baudin, a cominciare dal capo giardiniere Anselme Riedlé (1765–1801); allievo di Thouin formato al Jardin des Plantes, aveva già preso parte alla spedizione della Belle Angélique. conquistandosi l'amicizia e la stima di Baudin. Durante la spedizione fu attivissimo, facendo raccolte sia a Tenerife sia negli scali lungo la costa occidentale dell'Australia, dove raccolse semi, esemplari d'erbario e piante vive. In questa fase, fu un maestro e un punto di riferimento non solo per i suoi due aiutanti, ma per lo stesso Leschenault che in precedenza non aveva quasi esperienza di raccolte sul campo. Purtroppo fu vittima della dissenteria che colpì la spedizione a Timor; fu sepolto con tutti gli onori nel cimitero di Kupang accanto alla tomba in cui riposava David Nelson, il botanico dello sventurato viaggio del Bounty. Baudin disegnò personalmente la sua tomba, ma non poté presenziare alle esequie, essendo a sua volta malato. Anche a lui furono dedicati due generi Riedlea oggi non riconosciuti: nel 1802 da Mirbel (sinonimo di Onoclea) e nel 1807 da Ventenat (sinonimo di Melochia). Ammalatosi anche lui a Timor come il suo capo, ben presto ne seguì la sorte l'assistente giardiniere Antoine Sautier (ca. 1771-1801); nato a Parigi, probabilmente lavorava anche lui al Museum e aveva 29 anni al momento della partenza. Decaisne, che nel 1834 gli dedicò Sautiera, oggi sinonimo di Dyscoriste, lo ricorda per "lo zelo, con il quale arricchì il Museo di un gran numero di oggetti nuovi". L'unico genere valido è toccato al solo sopravvissuto, il "garzone giardiniere" Antoine Guichenot (1783-1867). Figlio di un militare che prestava servizio alla Menagerie del Jardin des Plants e della responsabile delle sementi, era praticamente nato del giardino, ma al momento dell'ingaggio non aveva pressoché esperienza di erborizzazioni sul campo. Era quasi illetterato (le sue note d'erbario sono scritte con un'immaginifica ortografia fonetica), ma era un lavoratore instancabile e un grande osservatore, tanto che le sue note sono spesso più dettagliate di quelle dello stesso Leschenault. Va certamente a lui gran parte del merito della raccolta (per non parlare della conservazione in vita) delle piante vive del Géographe. Baudin, che ne apprezzava la dedizione e lo zelo, gli dedicò Guichenault Point, un promontorio della penisola Péron nella Shark Bay. Dopo il ritorno a Parigi, Guichenot tornò a lavorare come giardiniere al Museum; poco sappiamo sulla sua vita, eccetto alcuni aneddoti raccolti in un articolo comparso nel 1861 sul Bulletin de la Societé imperiale zoologique d'acclimatation. Dopo aver informato i lettori che all'epoca Guichenot si era stabilito a Couets nei pressi di Nantes, l'autore M. Pépin riferisce che, benché si trovasse in una situazione difficile, in seguito alla morte del padre e di due fratelli, lo scrupoloso giardiniere resistette "alle offerte più seducenti" rifiutando di vendere sottobanco i semi di una Banksia per cui un botanico inglese gli offriva 25 franchi il pezzo nonché una rara conchiglia di cui aveva raccolto numerosi esemplari. Nel 1814 fu decorato con l'ordine del giglio. Forse fu il padre dello zoologo del Museum Alphonse Antoine Guichenot, che risulta figlio di un giardiniere della stessa istituzione. E' invece infondata e dovuta alla confusione con Gaudichault, il botanico della spedizione, la notizia che abbia preso parte al viaggio dell'Uranie al comando di Freycinet. La dedica del genere Guichenotia da parte di Jacques Étienne Gay (1821) appare quanto mai azzeccata e opportuna. Si tratta infatti di un genere australiano, di cui il giovane giardiniere, insieme a Riedlé e Leschenault, raccolse la prima specie conosciuta, G. ledifolia, nel 1801 durante il primo passaggio della spedizione a Shark Bay. Oggi assegnato alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), è affine ai generi Thomasia, Lysiosepalum e Lasiopetalum, comprende 16-17 specie di arbusti endemici dell'Australia occidentali. Adattati all'estrema aridità di questa regione, hanno foglie lineari e coriacee e graziosi fiori a campanella. Quelli di G. macrantha, la specie più nota e coltivata, negli Stati Uniti sono commercializzati come Aussie Bells, "campanelle australiane". Nella storia australiana, Allan Cunningham è noto soprattutto come esploratore, per aver aperto nuove vie di comunicazione e scoperto diversi valichi, tra cui quello che porta il suo nome (Cunningam's Gap); tuttavia, anche dopo essere stato coinvolto dal governatore Brisbane nell'esplorazione del territorio della colonia, egli continuò a sentirsi in primo luogo un botanico che, come scrisse a Kew, aveva trovato il modo di "mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". Finite le spedizioni marittime guidate del capitano King, tra il 1822 e il 1829 Cunningham perlustrò gran parte del Nuovo Galles del sud, per poi essere incaricato di trovare vie di collegamento con il Queensland, e prese parte a più di venti spedizioni, almeno una delle quali diretta e organizzata da lui stesso. Un viaggio lo portò anche in Nuova Zelanda. Senza però mai smettere di raccogliere piante: secondo l'amico e primo biografo Robert Heward, durante i suoi quindici anni australiani furono oltre 3000 specie. Moltissime sono quelle che lo ricordano nel nome specifico, Alania cunninghamii anche in quello generico. Senza dimenticare il genere Cunninghamia, che divide con il quasi omonimo James Cunighame.  Tra fatiche e speranza Il 25 aprile 1822, con il rientro a Sydney della Bathurst, si concludeva la prima fase delle avventure australiane di Allan Cunnigham, quella marittima (l'ho raccontata in questo post). L'infaticabile botanico del re rivolgeva ora la sua attenzione all'interno del paese. Dopo aver dedicato qualche mese a preparare i materiali da spedire a Kew (fase a cui dedicava ogni attenzione e che sempre lo preoccupava sommamente, per il lunghissimo viaggio che attendeva i suoi campioni e le fragili piante vive), già a settembre era di partenza: superate le Blue Mountains, per tutto il mese fu impegnato ad erborizzare nell'area compresa tra Bathurst e il fiume Cudgegong, spingendosi anche a oriente di quest'ultimo. I risultati di questa spedizione attirarono l'attenzione del nuovo governatore del Nuovo Galles del Sud, sir Thomas Brisbane, che lo incaricò di cercare una via di collegamento tra Bathurst e le Liverpool Plains scoperte da Oxley nel 1818. Cunningham, che da tempo coltivava la passione per l'esplorazione, accettò di buon grado e scrisse a Kew: "'Ho scoperto di poter mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". L'appoggio logistico offerto dal governatore tornava per altro comodo, visto il magro salario e gli scarsi finanziamenti londinesi. Nel marzo 1823 Cunningham, accompagnato da cinque servitori e altrettanti robusti cavalli da soma, partì da Bathurst dirigendosi verso nord in direzione del Lawson's Goulburn River, poi a est fino alle sorgenti del fiume Hunter. Da qui risalì la Liverpool Range alla ricerca di un valico; dal Mount Macarthur (oggi Mount Moan) vide a est un punto in cui catena di abbassava e decise di muovere in questa direzione, ma il cammino si fece sempre più difficile, finché risultò bloccato da ogni parte da ripidi burroni. Non restava che tornare indietro fino al Mount Macarthur, per cercare un passaggio in direzione nord-ovest. L'infruttuosa deviazione era costata tre settimane e tre giorni. Dopo altri sei giorni di cammino lungo la catena, il 2 giugno Cunningham decise di salire nuovamente su una cima: guardandosi intorno, a non più di tre miglia scorse una notevole depressione, al di là della quale si intravvedevano pianure aperte. Cunningham aveva scoperto il Pandora's Pass: gli diede questo nome pensando, da una parte, alle privazioni e alle difficoltà del viaggio, dall'altra alla piccola speranza che aveva trovato alla fine, che gli facevano pensare al mito di Pandora che, quando apre il suo vaso, sparge nel mondo ogni male, ma in fondo le rimane la speranza. Raggiunto il valico il 9 giugno, ritornò infine a Bathrust il 27 giugno, dopo undici settimane di arduo cammino. Relazionò poi i due viaggi da Bathurst in A Specimen of the Indigenous Botany […] between Port Jackson and Bathurst, e in Journal of a Route from Bathurst to Liverpool Plains (1825); significativamente, il focus del primo sono le piante, del secondo l'esplorazione. Dopo questa epica spedizione, fu la volta di una serie escursioni più brevi, per lo più in distretti già esplorati, in cui la botanica tornava in primo piano: a novembre raccolse esemplari nelle Blue Mountains lungo la Bells Line; nel gennaio 1824 tornò a Bathrust a raccogliere semi maturi. Poco dopo il suo ritorno a Parramatta, attraccò a Port Jackson il battello francese Coquille, che stava circumnavigando il globo al comando di Louis Isidore Duperrey. Con grande gioia, Cunningham fece conoscenza con il naturalista ufficiale della spedizione René Primevère Lesson e il primo ufficiale e botanico Jules Dumont d'Urville e in marzo li accompagnò a erborizzare nelle contee di Camden e Argyle; visitarono i laghi George e Bathurst, le sorgenti del Murrumbidge, Brisbane Downs, la Marley Plain e Shoalhaven. Era una zona facile da percorrere e almeno in parte già battuta, che non offriva grandi novità botaniche, tranne intorno alle cave calcaree di Shoalhaven, ma fu senz'altro un splendido biglietto d'ingresso per i due naturalisti francesi, Rientrato con loro a Parramatta all'inizio di maggio, Cunningham trascorse i mesi di luglio e agosto a erborizzare a Illawarra, uno dei suoi luoghi preferiti, riportandone piante vive che piantò in piccole scatole o vasi, perché recuperassero prima di essere spedite in Inghilterra. Tra l'altro scoprì la terribile Dendrocnide excelsa (lui la chiamò Urtica gigas), un albero dalle foglie urticanti che provocano un dolore che può durare mesi, tanto inteso da resistere alla morfina. Si affrettò poi a rientrare a Parramatta, in modo da imbarcarsi sulla Amish diretta a Moreton Bay; questa spedizione, di nuovo guidata da Oxley, aveva lo scopo di esplorare il fiume Brisbane. Insieme a Oxley, Cunnigham risalì in battello il fiume finché fu navigabile; lungo le sue rive poté scoprire molte piante interessanti, tra cui Araucaria cunninghamii, e anche diverse specie di orchidee. A ottobre era di nuovo a Parramatta; per concludere l'anno, tornò nuovamente a Bathurst a fare incetta di semi. Ne riportò novità come Banksia cunninghamii, Grevillea anethifolia, Eucalyptus mannifera. Dal Nuovo Galles al Queensland Nell'inverno del 1825 (da aprile a giugno) fu la volta di una nuova spedizione verso nord, che nel prima tratto ripercorse la strada che egli stesso aveva aperto due anni prima. Passando da Richmond, Cunningham raggiunse la valle dell'Hunter, quindi superò il Pandora's Pass procedendo verso nord attraverso le Liverpool Plains, dove trovò un notevole ostacolo nella pioggia continua e nel terreno piatto e paludoso; proseguì alla ricerca di una strada più elevata, finché fu costretto a tornare indietro, trovando la piana completamente allagata. Rientrò a Parramatta il 17 giugno, avendo percorso un circuito di 700 miglia. Gli ultimi mesi dell'anno furono trascorsi ad esplorare le aree della Wellington valley e di Mudgee, alla ricerca di semi ed esemplari da inviare a Kew; il bottino più interessante furono diverse orchidee terrestri. Ma la sua salute cominciava a risentire di tante fatiche e tanti viaggi, e dovette fermarsi fino a febbraio, per poi accontentarsi di escursioni botaniche relativamente brevi lungo il Cox's River e ancora a Illawarra. Nell'agosto 1826 poté realizzare un sogno che accarezzava da molto tempo: imbarcatosi su una baleniera, raggiunse la Nuova Zelanda dove fu accolto calorosamente dai missionari della Baia delle isole. Si trattenne nell'isola del Nord per quattro mesi, visitando l'area compresa tra la Baia delle isole e Hokianga, la zona di Wangoroa e la baia di Plenty. Infine, il 29 dicembre si imbarcò sul piccolo vascello dei missionari diretto a Sydney, dove sbarcò il 20 gennaio 1827 dopo un viaggio reso lungo e penoso dai venti avversi. Risultato della breve visita fu Florae Insularum Novae Zelandiae Precursor (1837-39), considerato la prima sinossi della flora neozelandese. Lo attendeva la più impegnativa delle sue spedizioni. Essendogli giunta notizia che il governatore sir Ralph Darling desiderava si esplorassero le potenzialità economiche dell'area compresa tra la Grande Catena divisoria e Moreton Bay (l'odierna Brisbane), si offrì come capo della spedizione, per la quale propose un dettagliato itinerario. Ad accompagnarlo sarebbero stati sei uomini, parecchi cani e undici cavalli da soma con le provviste per quattordici settimane; i cavalli vennero inviati via terra fino all'alto corso del fiume Hunter, mentre Cunnigham raggiungeva in nave Newcastle; da qui risalì il fiume con le provviste fino a Dulwich, dove il gruppo si riunì. Proseguirono quindi insieme fino a Segenhoe, all'epoca la fattoria più estrema e punto di partenza della spedizione vera e propria. Gli esploratori ne partirono il 30 aprile e si diressero a nord, varcando la Liverpool Range all'altezza di Dartbrook Creek; spesso la strada era così ripida che bisognava alleggerire i cavalli, trasportando i bagagli a braccia. Quindi si diressero verso nord in direzione del fiume Peel, passando attraverso una boscaglia aperta di Eucalyptus sideroxylon. Il 21 maggio raggiunsero un vasto fiume che Cunningham chiamò Gwydir; proseguirono attraverso aride boscaglie interrotte da crinali e gole, fino a fiume Macintyre che era quasi asciutto per la siccità. Preoccupato dalla mancanza di pascolo per i cavalli e per le provviste, già consumate a metà, Cunningham decise di non proseguire verso nord come aveva progettato, ma di spostarsi più a est. Fu così che il gruppo si imbatté in un fiume largo e profondo che il botanico battezzò Dumaresq, in onore del segretario del governatore Henry Dumaresq. Dopo averlo attraversato, proseguirono per altri sei giorni; il 6 giugno Cunnigham salì sul monte Damaresq: di fronte a lui una vasta pianura feritile di ricchi pascoli. Era le terra promessa che era venuto a cercare: non a caso la battezzò Darling Downs in onore del governatore che aveva voluto quella spedizione. A una distanza di forse dieci km, vide anche un valico che prometteva di offrire un comodo passaggio verso Moreton Bay. Debilitato dall'epatite di cui soffriva periodicamente fin dai tempi dei viaggi della Mermaid, non lo esplorò personalmente, ma vi inviò due uomini che confermarono la sua supposizione. Cunningham lo chiamò Spicers Gap in onore di Peter B. Spicer, sovrintendente dei forzati. Attraverso un altro passo, che poi sarebbe stato chiamato Cunningham's Gap, il gruppo scese nei Darling Downs, seguendo per qualche giorno il corso del fiume che lo irrigava (Cunningham lo battezzò Condamine River, in onore di Thomas de la Condamine, ex aiuto di campo del governatore); quindi si accamparono in una valle ad est del fiume (Logan Valley, in onore del comandante dell'insediamento di Moreton Bay) per far recuperare uomini e cavalli. Era infatti ora di tornare indietro, cosa che fecero seguendo una via più occidentale rispetto a quella dell'andata, rientrando a Segenhoe dopo un viaggio di tredici settimane. Cunningham poté presto verificare di persona la praticabilità della via di collegamento che aveva intravvisto. Nel 1828 andò ad erborizzare a Moreton Bay con il botanico della colonia Charles Fraser; a luglio partivano in spedizione con il comandante Logan, un soldato, cinque forzati e molte provviste. Dirigendosi verso sud, raggiunsero il Logan River, scoperto dal capitano due anni prima, e il monte Barney, che Logan già aveva tentato inutilmente di scalare. Questa volta ci riuscì. Dopo aver esplorato per qualche giorno l'area intorno all'attuale Boonah, Fraser e Logan tornarono a Brisbane; Cunningham invece si addentò nelle montagne e varcò il passo che aveva scoperto nel 1827. La strada che egli percorse è oggi diventata un'autostrada, e ovviamente porta il suo nome: Cunningham Highway. Cunningham tornò a Moreton Bay ancora nel 1829, per esplorare l'alto corso del Brisbane River. Anche nel 1828 e nel 1829 non mancarono i consueti viaggi botanici a Bathurst e Illawarra. Tra maggio e settembre egli visitò anche l'isola Norfolk. Trattenuto nell'isola oltre il previsto dal cattivo tempo, poté fare un inventario molto ampio della sua flora (nel suo diario elenca 104 specie che ritiene native e 38 che considera introdotte). Visitò anche la vicina isola Phillip, dove fu derubato di gran parte dell'equipaggiamento e delle provviste da alcuni forzati. Fin nel 1828 aveva chiesto di poter tornare in Inghilterra (ricordo che l'aveva lasciata nell'ormai lontano 1814); il permesso gli fu finalmente accordato nel novembre 1830. Dopo un'ultima visita a Illawarra e alla Cox Walley e i saluti agli amici (erano tanti che richiesero non meno di una settimana), partì da Sydney il 25 febbraio e arrivò in Inghilterra a luglio. Qui si stabilì non lontano da Kew, dedicandosi alla sistemazione del suo erbario e alla stesura di vari articoli. Nel 1832 fu ammesso alla Linnean Society. Lo stesso anno morì Charles Fraser, e gli fu offerto di succedergli come botanico della colonia, ma egli rifiutò a favore del fratello minore Richard. Anche quest'ultimo era un ottimo botanico, entrato appena quindicenne a Kew. In Australia non mancò di partecipare a diverse spedizioni e visitò anche la Nuova Zelanda (dove tra l'altro scoprì l'orchidea che porta il suo nome Dendrobium cunninghamii), ma infine fu vittima di un tragico incidente. Nell'aprile 1835 si unì alla spedizione Mitchell, inviata ad esplorare il corso del fiume Darling. Nei pressi del Bogan River, si allontanò dal gruppo per erborizzare e non fece mai più ritorno. Più tardi si scoprì che, perdutosi e probabilmente in preda al delirio, si era unito ad alcuni indigeni che più tardi, terrorizzati dal suo strano comportamento notturno, lo avevano ucciso. Quando la notizia della morte di Richard giunse in Inghilterra, il posto di botanico della colonia fu nuovamente offerto a Allan Cunningham, che questa volta accettò e ritornò a Sidney nel febbraio 1837. Tra i suoi compiti, c'era anche la direzione del Giardino del governatore; Fraser aveva cominciato a trasformarlo in orto botanico (il futuro Sydney Royal Botanic Garden), ma era ancora soprattutto un parco pubblico e un orto per la coltivazione di verdure per la mensa del governatore; dopo qualche mese, Cunningham diede le dimissioni, proclamando che non "avrebbe più tollerato di essere un mero coltivatore di cavoli e rape". Nell'aprile 1838 si imbarcò sulla corvetta francese L'Héroine alla volta della Nuova Zelanda; trovò tempo pessimo e ritornò Sidney in ottobre gravemente malato. Nonostante la sua salute continuasse a peggiorare, progettava di accompagnare il capitano John Wickam della Beagle in una nuova ricognizione della costa nord-occidentale. Ormai stava così male che la nave partì senza di lui; il suo successore e amico James Anderson lo fece trasportare in un piccolo cottage situato nell'Orto botanico, dove Cunningham si spense il 27 giugno 1839. Nel 1844 in sua memoria venne eretto un obelisco commemorativo, alla cui base nel 1901 vennero traslate le sue ceneri. Si trova al centro di un piccolo stagno affiancato da boschetto di una delle tante piante da lui scoperte, la palma Archontophoenix cumminghamiana. Gli è intitolata anche la rivista scientifica dell'Orto botanico di Sydney "Cunninghamia".  Una piccola pianta per un grande raccoglitore Insieme a Robert Brown, Allan Cunningham è considerato il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento; ne esplorò le coste settentrionali, gran parte del Nuovo Galles del Sud, il Queensland meridionale, la Tasmania, nonché le isole Norfolk e Phillips e alcune aree della nuova Zelanda. Secondo il suo amico e primo biografo Robert Heward, le specie da lui raccolte ammontano a 3000. I suoi invii di semi, bulbi, piante vive a Kew furono così importanti che una serra, prima destinata alle piante africane, venne invece riservata alle sue australiane. Moltissime delle specie da lui raccolte erano ignote alla scienza, e non poche gli sono state dedicate. Ricordiamo almeno Casuarina cunninghamiana, Archotophoenix cunninghamiana, Araucaria cunninghamii, Crotalaria cunninghamii, Actinodium cunninghamii, Adenanthos cunninghamii, Alsophila cunninghamii, Angianthus cunninghamii, Banksia cunninghamii, Cassinia cunninghamii, Clematis cunninghamii, Eucalyptus cunninghamii, Nothofagus cunninghamii, Solanum cunninghamii. A una scelta di queste magnifiche piante è dedicata la gallery a fine post. Anche se i continui viaggi e la brevità del soggiorno in Inghilterra gli permisero di pubblicare solo una minima parte delle sue raccolte, gli si devono 139 denominazioni valide: 6 generi (Ackama, Alseuosmia, Corokia, Fieldia, Rabdothamnus, Hoheria), 133 specie (la più nota delle quali è probabilmente Grevillea rosmarinifolia) e una varietà. Si basano invece su raccolte di Cunningham più di 300 denominazioni di altri autori, tra cui 6 generi. A Cunningham sono stati dedicati due generi: Cunninghamia R.Br., che condivide con il quasi omonimo James Cuninghame (ne ho parlato in questo post) e Alania Endl., un genere monospecifico della famiglia Boryaceae, la cui unica rappresentante ha la ventura di ricordare il nostro protagonista sia nel nome generico sia nell'epiteto: è infatti Alania cunninghamii, un'erbacea rizomatosa del Nuovo Galles del Sud. Come ci ricorda Endlicher, Cunnigham la raccolse all'inizio del suo soggiorno australiano, nel 1818, "in campi aridi nei pressi delle Blue Mountains". E' una perenne cespitosa con foglie lineari, infiorescenze ascellari di piccoli fiori bianchi a stella con perianzio formato da sei tepali liberi, sei stami inseriti alla base con filamenti lunghi quanto i tepali. E' endemica delle Blue Mountains settentrionali; eliofila, tende a formare tappeti espandendosi con i rizomi. Qualche informazione in più nella scheda. Allan Cunningham, il secondo "raccoglitore del re per Kew", arriva in Australia alla fine dal 1816. E' l'inizio di una vera epopea che farà di lui il più prolifico cacciatore di piante australiane della prima metà dell'Ottocento, con la raccolta di non meno di 20.000 esemplari. Giovane ed entusiasta, tra il 1817 e il 1822 è il botanico di bordo delle cinque spedizioni guidate dal capitano Phillip Parker King. Per una volta, tra capitano e botanico, uniti dalla medesima sete di scoperta e dallo stesso amore per la natura, non c'è conflitto, ma collaborazione, stima, anzi amicizia. Non sono rare le occasioni in cui i due scendono insieme a terra per esplorare e fare raccolte di piante e animali. Meritatissima dunque la dedica da parte di Robert Brown del curioso genere Kingia (con il quale il botanico scozzese paga anche un debito con il padre del capitano, Philip Gidley King, governatore del Nuovo Galles del Sud all'epoca delle spedizioni Flinders). 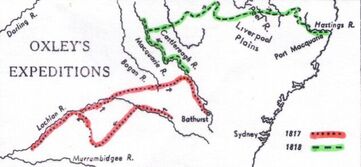 Primo contatto: una spedizione di 1200 miglia Il 20 dicembre 1816, dopo due anni trascorsi in Brasile (ne ho parlato in questo post) il raccoglitore del re Allan Cunningham (1791-1839) sbarcava finalmente nella baia di Sidney. In Brasile aveva perfezionato le tecniche di raccolta e acquisito il gusto dell'avventura, ma ora finalmente aveva raggiunto la meta per la quale si preparava da tempo. Dotato di una buona istruzione di base (la famiglia avrebbe voluto farne un avvocato), a 17 anni era entrato a Kew ed era stato assegnato all'erbario, come assistente di William T. Aiton che stava completando la seconda edizione di Hortus Kewensis; decisivo fu poi l'incontro con Robert Brown che tra il 1801 e il 1805 era stato il botanico delle spedizioni Flinders in Australia e ora era il bibliotecario di Joseph Banks. Fu Brown a iniziare Cunningham alla flora australiana e a spingerlo a proporsi per una missione sul campo nel nuovissimo continente. La sua candidatura fu caldeggiata da Aiton che ne aveva grandissima stima. Al suo arrivo a Port Jackson Cunningham aveva appena 25 anni; ne sarebbero trascorsi più di quindici prima che rivedesse la madre patria: quindici anni pieni di avventure, di spedizioni per mare e per terra, che ne avrebbero fatto il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento. Appena sbarcato, si presentò al governatore del Nuovo Galles del sud Lachlan Macquarie che lo accolse con grande gentilezza e gli suggerì di unirsi alla spedizione di John Oxley che si accingeva ad esplorare il territorio a ovest delle Blue Mountains; Cunningham accettò e, in attesa della partenza, affittò un cottage a Parramatta e iniziò a botanizzare nei dintorni. Fin dai tempi del primo viaggio di Cook, la baia di Sidney era la zona più battuta dagli europei ed egli ebbe l'impressione di essere quasi a casa, ritrovando molte piante coltivate nei giardini e nelle serre inglesi, che conosceva benissimo come assistente di Aiton e spesso non aveva difficoltà a riconoscere a colpo d'occhio. Nell'aprile 1817 Cunningham lasciò Parramatta e si unì alla spedizione Oxley il cui scopo principale era verificare se il fiume Lachlan (scoperto appena due anni prima e battezzato così in onore del governatore) si gettasse in mare o in qualche lago interno; venne così ad affiancarsi al botanico Charles Fraser, a un mineralogista e un disegnatore. Partiti da Bathurst il 28 aprile, gli esploratori seguirono il corso del fiume per circa due mesi, finché a giugno ogni ulteriore progresso fu bloccato da paludi impenetrabili. Allora si diressero a nord e raggiunsero il Macquarie River che discesero fino a Bathurst, dove rientrarono il 29 agosto. In circa 20 settimane, avevano percorso (a piedi, a cavallo, in barca) circa 1200 miglia, toccando ambienti ecologici molto diversificati; dal primo all'ultimo giorno, Cunningham non cessò mai di raccogliere piante, anche se all'inizio era un po' deluso perché "la botanica, con pochissime eccezioni, è la stessa che ho osservato in situazioni simili nei dintorni di Parramatta". Tra quelle poche eccezioni, una delle tante piante che portano il suo nome, Casuarina cunninghamiana. Alla fine, però, il bottino ammontò a circa 450 specie. L'8 settembre 1817, al tramonto, Cunningham rientrò a Parramatta con tutte le sue collezioni ben impacchettate. Il mattino dopo si presentò al governatore che lo invitò a cena e gli suggerì di unirsi a una nuova spedizione, questa volta per mare: il capitano Phillip Parker King si accingeva infatti a perlustrare le coste australiane non esplorate da Flinders. Cunningham ovviamente accettò. Scrisse a Banks e Aiton per comunicare che era rientrato sano e salvo e trascorse gli ultimi mesi dell'anno a preparare gli esemplari da inviare a Kew e a continuare l'esplorazione dei dintorni. Il 21 dicembre era a bordo del cutter Mermaid, la piccola nave scelta dall' ammiragliato per la missione di King. Costruita in India in legno di teak, era lunga 17 metri e a pieno carico aveva un pescaggio di appena tre metri, ideale per la ricognizione idrografica anche di strette insenature. Aveva dunque un carico limitato (uno degli obiettivi era anche individuare punti di rifornimento di acqua e cibo fresco) e un equipaggio di appena 19 uomini: oltre al capitano, il luogotenente Phillip Parker King, i suoi secondi Frederick Bedwell e John Septimius Roe (che poi sarebbe diventato il primo General Surveyor dell'Australia occidentale), il nostro Cunningham, 12 marinai, due mozzi e l'aborigeno Bungaree, che aveva già partecipato come guida, interprete e negoziatore con le popolazioni locali alla spedizione Flinders. 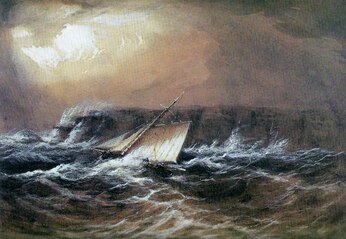 Alla scoperta della costa settentrionale dell'Australia Il compito principale di King era il rilevamento idrografico della costa settentrionale, in particolare del settore più occidentale non toccato da Flinders; l'ammiragliato sperava che egli individuasse qualche fiume che fosse possibile risalire per penetrare nell'interno. Ma la lista dei compiti che gli fu consegnata includeva anche la raccolta di informazioni sulle condizioni metereologiche, le montagne, la flora e la fauna, il legname, i minerali, le comunità locali, le loro lingue e costumi, la possibilità di commerciare con loro, nonché ogni prodotto che potesse essere esportato in Gran Bretagna. Obiettivi che per una volta mettevano d'accordo il capitano e il suo naturalista. Salpata da Port Jackson il 22 dicembre 1817, la Mermaid scese lungo la costa occidentale, per poi navigare lungo le coste meridionale e orientale fino a raggiungere il North West Cape dove sarebbe iniziato il rilevamento. Durante il tragitto, due soli scali significativi: il 26 dicembre a Twofold Bay, quando Cunningham per la prima volta scese a terra con il capitano, notando che la vegetazione poco differiva da quella di Port Jackson; il 20 gennaio 1818 a Oyster Bay, che fu perlustrata per quasi due settimane. Doppiato il North West Cape, intorno a metà febbraio venne scoperto un golfo battezzato Exmouth Gulf in onore di Lord Exmouth. Erano acque infide in cui vennero perse due delle tre ancore. Per circa due settimane la navigazione, in quasi totale assenza di vento, proseguì lenta, perlustrando il tratto di costa tra il golfo di Exmouth e Port Walcott. Cunningham ebbe parecchie opportunità di scendere a terra, spesso in compagnia del capitano che condivideva i suoi interessi naturalistici; tuttavia si era alla fine della stagione secca e il territorio appariva arido e desolato, le piante erbacee erano per lo più morte, mentre le rare specie arboree raramente portavano frutti. Finalmente l'8 marzo si levò il vento da sud e la Mermaid fece vela a nord, in direzione della Terra di Arnhem. Sospinta dal vento, dapprima carico di pioggia, non si sarebbe fermata fino al 27 marzo, quando gettò l'ancora in un'isola che poi sarebbe stata battezzata Goulburn Island; ora il paesaggio appariva del tutto diverso; così lo descrive un entusiasta capitano King: "Si era ormai al termine della stagione delle piogge, e ogni cosa aveva l'aspetto più rigoglioso; l'erba, che copriva il terreno dell'isola, era alta più di sei piedi, tanto che ci nascondeva l'un l'altro mentre camminavamo verso la sommità della collina, i cui lati erano fittamente boscosi. Ai margini della spiaggia crescevano il pandano e l'ibisco e una varietà di altri alberi e arbusti tropicali e la sabbia era variegata dai lunghi tralci del convolvolo in piena fioritura". Insomma un vero paradiso, come l'adiacente Sims Island (così nominata su richiesta di Cunningham in onore del primo curatore del Botanical Magazine John Sims) dove il nostro botanico poté fare incetta di piante, tra cui una profumatissima Asclepiadacea. Lasciata Goulburn Islands il 6 aprile, per tutto quel mese e quello successivo vennero esplorate la penisola di Cobourg, le isole Melville e Bathurst, le coste del golfo di Van Diemen fino al West Alligator River, il punto più orientale: King lo chiamò così per i coccodrilli che infestavano le sue rive paludose ed egli scambiò per alligatori. In più occasioni ci furono incontri con nativi, non sempre amichevoli nonostante la presenza mediatrice di Bungaree; il più drammatico si ebbe nella penisola di Cobourg, in un ancoraggio ribattezzato da King Knocker's Bay "Bay dei picchiatori" perché gli esploratori furono presi a sassate dai nativi mentre cercavano di disincagliare una lancia rimasta intrappolata tra le mangrovie. La stagione inoltrata e il tempo pessimo rendevano impossibile proseguire verso est; il capitano decise così di fare rotta per Timor; la breve sosta a Kupang (6-11 giugno) permise a King di rinnovare le provviste e a Cunningham di erborizzare nei dintorni della città, con l'aiuto di servo malese messogli a disposizione dall'amministrazione olandese. Il viaggio di ritorno, nuovamente lungo le coste occidentale e meridionale, fu funestato dalla dissenteria, con la morte di uno dei marinai; grazie ai venti favorevoli, fu tuttavia molto veloce: il 29 luglio 1818 la Mermaid gettava l'ancora nella baia di Sidney. Il comandante e i suoi ufficiali trascorsero la seconda metà del 1818 a riordinare le carte e a preparare la nave per la successiva spedizione; Cunningham, oltre a preparare i pacchi di semi e piante per Kew, ebbe anche il tempo di fare una breve escursione a sud di Sidney, visitando la regione di Illawarra; situata ad appena una cinquantina di miglia da Port Jackson, con il suo clima caldo-umido e una peculiare vegetazione tropicale, sarebbe divenuto uno dei suoi terreni di caccia favoriti dove sarebbe tornato molte volte negli anni successivi. Partito da Parramatta il 19 ottobre e rientrato esattamente un mese dopo, era pronto per una seconda avventura con l'amico King. La seconda spedizione della Mermaid fu però quasi un viaggio di routine: nel dicembre 1818 King salpò per la terra di van Diemen (l'odierna Tasmania) e ne perlustrò la costa fino al Macquarie Harbour; già il 14 febbraio era di ritorno nella baia di Sidney. Cunningham incrementò le sue raccolte erborizzando nei dintorni di Hobart e Launceston; la visita in Tasmania fu tuttavia abbastanza deludente per lui: erano le stesse zone già esplorate da Robert Brown e vi trovò poche novità. Il terzo viaggio della Mermaid (8 maggio 1819-12 gennaio 1820) seguì una rotta opposta rispetto al primo. Accompagnata da un altro vascello, la Lady Nelson, su cui viaggiava una nostra vecchia conoscenza, John Oxley, la Mermaid si diresse a nord, raggiungendo Port Maquaire e la foce del fiume Hastings. Dopo aver esplorato insieme quest'area, mentre la Lady Nelson e Oxley rientravano a Port Jackson, la Mermaid si inoltrava nel rischioso passaggio tra la costa del Queensland e la barriera corallina; era una navigazione lenta e difficile che moltiplicò gli scali, offrendo molteplici possibilità di raccolta a Cunnigham; sulla Fitz Roy Island poté raccogliere molti alberi tipici della foresta pluviale e addirittura due orchidee (una sarà poi dedicata al capitano come Dendrobium kingianum); all'Endeavour River, dove Cook era stato costretto a spiaggiare la sua nave gravemente danneggiata dalla barriera corallina, fu deliziato dalla raccolta di alcuni esemplari che andavano a sostituire quelli imperfetti raccolti da Banks in persona. Il 25 luglio la Mermaid doppiava Capo York ed entrava nel golfo di Carpentaria; partendo da Goulburn Island, King riprese il rilevamento della costa settentrionale, procedendo però da est a ovest; tra agosto e settembre furono esplorate le coste e le isole della Terra di Arnhem, per poi proseguire fino al Capo Londonderry e l'arcipelago Buonaparte. Si era ormai a metà ottobre. il tempo era di nuovo pessimo e molti uomini erano malati. Come due anni prima, King si diresse a Timor, per rinnovare le scorte e iniziare il viaggio di ritorno, che seguì la stessa rotta di quello precedente, concludendosi il 12 gennaio 1820. Il terzo viaggio, con i numerosi scali lungo le coste del Queensland e la lenta esplorazione della costa settentrionale fu particolarmente fruttuoso per Cunningham, che poté anche osservare (e raccogliere) in una stagione diversa varie piante che aveva già incontrato nel corso del primo viaggio; tuttavia egli si ammalò abbastanza gravemente (di itterizia, secondo King). Ciò non gli impedì di essere di nuovo della partita per la quarta spedizione della Mermaid (14 giugno-9 dicembre 1820). Nei mesi precedenti il vascello era stata carenato e bonificato (con scarso successo) degli scarafaggi e dei ratti che infestavano lo scafo. A giugno era pronto per la partenza, con gli stessi ufficiali ma un equipaggio rinnovato perché solo due marinai avevano confermato l'ingaggio; ora a bordo c'era anche un chirurgo. Fu un viaggio sfortunato fin dall'inizio. Poco dopo l'uscita dal porto, la nave incontrò un tempo così cattivo da perdere il bompresso; dovette così rientrare per essere riparata. Il viaggio riprese il 13 luglio, ma una settimana dopo, durante le manovre d'ancoraggio a Port Bowen, la nave rimase incagliata in un banco di sabbia, riportando danni gravi ma al momento non visibili, tanto che King ordinò di riprendere la navigazione. Il Capo York venne doppiato senza difficoltà e per la terza volta la Mermaid raggiunse Goulburn Island dove Roe, che si era imprudentemente allontanato da solo per cacciare, rischiò di essere catturato e ucciso dai nativi. Ma la preoccupazione maggiore era proprio la Mermaid: dall'ingresso nel golfo di Carpentaria lo scafo imbarcava sempre più acqua, tanto che King decise di portarla a terra per carenarla. Il 21 settembre fu trovato un ancoraggio adatto in una baia riparata e provvista di acqua dolce; i lavori di riparazione si protrassero fino al 30 settembre, ma non poterono che essere provvisori, in mancanza di sufficienti chiodi di rame. Non restava che intraprendere il forzato viaggio di ritorno, lungo le coste ovest e sud. Prima di rientrare a Sidney il 9 dicembre, a Botany Bay si rischiò il naufragio. Anche le raccolte di Cunningham erano state magre, a causa della stagione avanzata. All'arrivo a Port Jackson, lo attendeva una notizia dolorosa: quella della morte del suo protettore Joseph Banks, avvenuta il 20 giugno. Fu l'ultimo viaggio della Mermaid (la nave, non più adatta alla navigazione oceanica, fu destinata a usi meno logoranti), ma non l'ultimo di King, Cunningham e compagni. Il 26 maggio 1821 riprendevano il mare a bordo del brigantino Bathurst, un vascello di tonnellaggio doppio rispetto alla piccola e agile Mermaid, con un equipaggio di 33 persone. Ripercorrendo la rotta ormai consueta, ripresero l'esplorazione della costa settentrionale, completandone la ricognizione fino alla penisola Dampier e a Roebeck Bay. Tuttavia, dopo la brutta avventura della Mermaid, e tanto più con una nave con maggior pescaggio, il capitano temeva i banchi di sabbia e trascurò di esplorare la profonda insenatura che oggi porta il suo nome (King Sound). Da Roebeck Bay la nave fece rotta per Mauritius, dove Cunningham che non aveva raccolto molto durante l'ultima parte del viaggio, essendosi di nuovo ammalato, riuscì a scambiare alcune piante australiane con piante indiane, africane e malgasce. Quindi la Bathurst, nuovamente navigando lungo le coste occidentale e meridionale, rientrò a Sidney il 25 aprile 1822.  Un enigma botanico In cinque anni di viaggi e avventure comuni tra King e Cunningham si era cementata una sincera amicizia. Il capitano avrebbe descritto così il "suo" botanico: "Era un esemplare raro, direi un genere a sé: devoto alla sua scienza, la botanica; un caldo amico e un uomo onesto". Ma per i due amici era venuto il momento di separarsi. A King fu ordinato di rientrare in Inghilterra con la Bathurst; Cunningham rimase in Australia di cui continuò ad esplorare la flora per altri nove anni; e lì lo ritroveremo in un altro post. A Londra King fu accolto nella Royal Society e nel 1826 pubblicò la relazione dei suoi viaggi, che contiene anche un'appendice sulla flora della costa settentrionale dell'Australia scritta da Cunningham. Fu quindi incaricato dei rilevamenti idrografici della Terra del fuoco, missione che lo impegnò per ben cinque anni (1826-1830). Tornato in Inghilterra in cattiva salute, nel 1831 decise di lasciare il servizio attivo e di tornare in Australia, dove il padre gli aveva lasciato una vasta proprietà; vissuto fino al 1856, vi ricoprì una serie di incarichi politici; nel 1855 fu nominato retroammiraglio. Fu Robert Brown a rendere merito dei suoi servigi alla botanica dedicandogli un singolare endemismo australiano, Kingia australis; allo stesso tempo si sdebitò con il padre di lui, Philip Gidley King, governatore del Nuovo Galles del Sud ai tempi delle spedizioni Fliders. Così infatti scrive: "A questo nuovo genere ho dato il nome del mio amico il capitano King, che durante i suoi importanti rilevamenti delle coste della Nuova Olanda creò preziose collezioni in diversi campi delle scienze naturali, e in ogni occasione diede tutta l'assistenza in suo potere a Mr. Cunningham, l'infaticabile botanico che lo accompagnava. Il nome è anche inteso come segno di rispetto alla memoria del fu capitano Philip Gidley King che, come governatore del Nuovo Galles del Sud, organizzò materialmente il viaggio del Capitano Flinders; e verso la cui amicizia io e Ferdinand Bauer siamo in debito per l'assistenza che ci ha prestato finché siamo rimasti in quella colonia". Si rimanda alla sezione biografie per un profilo biografico di padre e figlio; qui basti dire che il capitano King, oltre ad essere un grande idrografo, era un naturalista più che dilettante, interessato soprattutto alla zoologia. Il suo amore per la natura traspare alla lettura di quasi ogni pagina di Narrative of a Survey of the Intertropical and Western Coasts of Australia, Performed Between the Years 1818 and 1822, dove spesso lo vediamo partecipare con entusiasmo alle raccolte di Cunningham; in Patagonia, raccolse un'importante collezione etnografica che poi donò al British museum e esemplari di uccelli, in alcuni casi inediti, che poi pubblicò sul Zoological Journal di Sidney. Era inoltre un dotato disegnatore e acquarellista. Oltre alla già ricordata orchidea, lo ricordano gli eponimi di sei rettili: Amphisbaena kingii, Chlamydosaurus kingii, Egernia kingii, Elgaria kingii, Hydrophis kingii e Liolaemus kingii. Kingia australis, l'unica specie del genere Kingia, è una pianta assai singolare. Si presenta come un tozzo pseudo tronco, formato dall'accumulo delle basi fogliari, sormontato da un ciuffo di foglie lunghe, sottili e piuttosto rigide. I fiori, minuscoli, da giallo verdastro a bruno, ma raggruppati in dense infiorescenze globose, sono portati all'apice di lunghi steli emessi tra il fogliame. Di crescita lentissima (circa 1 cm e mezzo l'anno), è però molto longeva; esemplari pluricentenari alti oltre sei metri non sono insoliti. Fin dalla sua scoperta, dovuta proprio a Robert Brown, che la raccolse nel 1801 sulla costa del King George Sound, costituisce un'enigma per i botanici. Quando non è in fioritura, ha un aspetto assai simile ad alcune specie del genere Xanthorrhoea, tanto che per molti anni si credette ne fosse la forma femminile. In realtà, i suoi fiori sono talmente diversi. Brown poté osservarla in fioritura, ma trovò solo frutti così rovinati e imperfetti che inizialmente non la pubblicò; tuttavia nel 1823 ottenne esemplari di fiori e frutti maturi raccolti da William Baxter, basandosi sui quali poté descriverla e discuterne la collocazione tassonomica in Character and description of Kingia, inizialmente pubblicato in appendice al resoconto dei viaggi di King. Con molti dubbi, egli assegnò il nuovo genere alle Liliaceae. A lungo è stato collocato nella famiglia Xanthorrhoeaceae; oggi, insieme a altri tre generi, tutti australiani, fa parte della famiglia Dasypoganaceae, stabilita nel 1998, molto più vicina alle Arecaceae (le palme) che non alle Xanthorrhoeaceae/Asparagaceae. La sua crescita lentissima è un adattamento a condizioni di estrema aridità, in terreno con pochi elementi nutritivi; la sua fioritura è evento raro, che si produce in condizioni particolarmente favorevoli, ma soprattutto dopo un incendio. Altre informazioni nella scheda. William Dampier è considerato il navigatore britannico più importante tra Francis Drake e James Cook. Vanta una lunga serie di primati: è stato il primo britannico a fare tre volte il giro del mondo, il primo a descrivere un uragano, le tartarughe delle Galapagos e l'albero del pane, il primo a guidare una spedizione scientifica ufficiale per conto della Royal Navy, il primo a raccogliere piante australiane... Le sue avventure hanno ispirato Swift e Defoe, le sue scoperte idrografiche hanno guidato Cook, le sue osservazioni sulle Galapagos sono state preziose per Darwin. Eppure Dampier non era né un ufficiale né un gentiluomo: a dirla tutta, era un pirata, o se preferite un bucaniere, un fratello della costa. Come naturalista, era autodidatta, ma non gli mancavano occhi acuti, attenzione ai particolari e capacità di collegare i fenomeni. A ricordare questo singolare personaggio è molto opportunamente il genere endemico australiano Dampiera. 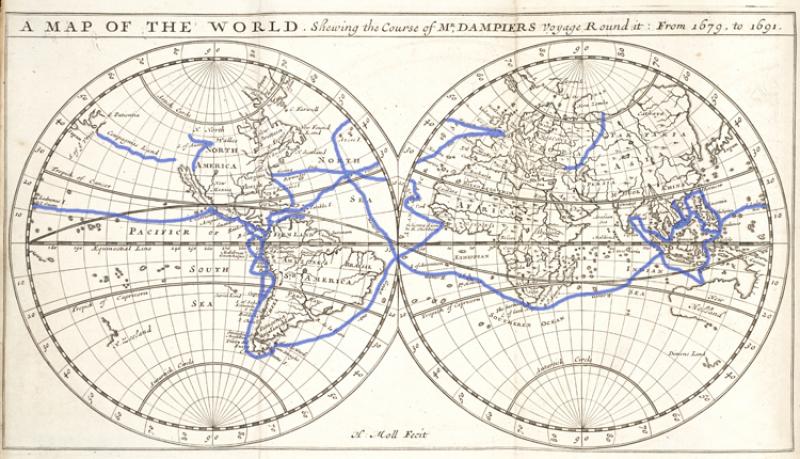 Avventure attraverso i sette mari Dopo tanti naturalisti vessati da un comandante più interessato alla navigazione che alle piante, ecco un capitano che rischia l'ammutinamento della ciurma per la sua passione per la botanica. Non è la maggiore stranezza di questo singolare personaggio. In diversi momenti della sua vita, William Dampier fu marinaio, mercante, piantatore, taglialegna, avventuriero, scrittore di successo, esploratore, navigatore e corsaro. Ovunque, e sotto ogni veste, fu un grande osservatore di ogni aspetto della natura, anche se il suo amore principale andava alle piante. Come scrive la giornalista M.S. Douglas: "Era un uomo con un gran naso, magro, tranquillo, dall'occhio acuto, un eccellente navigatore, uno scienziato attento ed accurato. Ed era anche un pirata". Non in senso metaforico: per almeno dieci anni fu un bucaniere, uno dei famigerati pirati dei Caraibi. Nato in un villaggio del Somerset in una famiglia contadina, alla scuola pubblica aveva acquisito almeno le basi del latino e della matematica, ma era rimasto orfano presto e si era innamorato del mare. A diciotto anni, la sua prima navigazione lo portò a Terranova, la seconda a Giava. Nel 1673 combatté brevemente nella terza guerra anglo-olandese. Nel 1674 arrivò nei Caraibi, come aiutante in una piantagione di zucchero in Giamaica. Dopo qualche mese lo ritroviamo a Port Royal, il principale porto dell'isola, all'epoca conosciuto come "la città più ricca e malfamata del mondo". Era anche una delle basi dei bucanieri, le cui incursioni contro le città e le navi spagnole erano più che tollerate dai britannici. Oltre alla pirateria, questi irregolari praticavano il contrabbando e altre attività più o meno legali, tra cui il taglio e il commercio del legno di campeggio, Haematoxylum campechianum, apprezzato materiale tintorio di cui gli spagnoli cercavano inutilmente di preservare il monopolio. Dampier sperò di fare fortuna con questa attività e si trasferì nella Baia di Campeche, ma, quando il campo dei boscaioli fu spazzato via da un uragano, si trasformò in pirata e probabilmente partecipò a incursioni ai danni degli spagnoli, abbastanza fruttuose da consentirgli nel 1678 di ritornare in Inghilterra, dove acquistò una piccola proprietà e si sposò. Già affascinato dalla esuberante natura tropicale in Giamaica, fu probabilmente in Campeche che Dampier iniziò a mettere per iscritto le sue osservazioni; le scriveva su fogli sparsi, che poi preservava dagli insetti e dall'umidità conservandoli in una canna di bambù chiusa alle due estremità con della cera. La permanenza in patria durò pochi mesi. Nel 1679 Dampier era di ritorno a Port Royal, dove entrò a far parte della ciurma del pirata Bartholomew Sharp. Da questo momento, divenne un pirata in servizio permanente effettivo e, a bordo di varie navi e sotto il comando di diversi famigerati comandanti, partecipò alla cattura di navi e alla devastazione di insediamenti spagnoli nei Caraibi, nello stretto di Panama, lunga la costa del Perù; durante un'incursione la nave su cui era imbarcato arrivò persino in Africa, per poi doppiare Capo Horn e passare dalle Galapagos, dove il nostro pirata-naturalista fu affascinato dallo strano aspetto ( e dall'ottimo gusto) delle tartarughe giganti. Anche se più tardi proclamerà che a spingerlo non era l'avidità di ricchezza, ma il desiderio di conoscere il mondo, in queste imprese non fu meno violento e sanguinario dei suoi compagni. Tuttavia, ovunque andasse, non mancava mai di esercitare il suo spirito di osservazione, e di prendere nota di ciò che osservava. Visse la sua avventura più lunga e straordinaria a bordo della Cygnet, comandata da Charles Swan. Nel 1684, nella speranza di catturare i galeoni che trasportavano oro e merci preziose dalle Filippine, quest'ultimo, a quanto pare spalleggiato da Dampier, decise di attraversare il Pacifico dal Messico alle Indie orientali, come era chiamato all'epoca l'arcipelago malese. Durante la traversata, la fame si fece sentire, tanto che i marinai erano sul punto di ammutinarsi e di cibarsi dei due colpevoli: il capitano e Dampier. Swan fece notare che, se da lui qualcosa si poteva ricavare, il magro Dampier era poco appetibile. Per fortuna, prima di mettere in atto i loro propositi cannibalici, approdarono a Guam, dove trovarono cibo abbondante, in particolare i frutti dell'albero del pane Atrocarpus spp. (Dampier sarà il primo europeo a descriverlo). Abbandonato Swan al suo destino a Mindanao, sotto il comando di John Reed la navigazione proseguì verso il mar della Cina, toccando il delta del Mekong e Canton. Qui decisero di invertire la rotta e di raggiungere l'India attraverso le Filippine e l'arcipelago malese. Dopo aver raggiunto Timor, deviarono verso sud e il 5 gennaio 1688 gettarono l'ancora a Karakatta Bay, nell'attuale Australia nord-occidentale (all'epoca si chiamava Nuova Olanda). Anche se diversi navigatori olandesi ne avevano variamente esplorato le coste, era un territorio largamente sconosciuto, tanto che si ignorava se fosse un insieme di isole o un continente a parte. La Cygnet doveva essere raddobbata e la sosta dei pirati si protrasse per diverse settimane; Dampier ne approfittò per esplorare l'interno di quella che, in suo onore, oggi si chiama penisola Dampier. Quindi la navigazione riprese attraverso l'Oceano indiano; insieme a due compagni, il pirata naturalista fu abbandonato in una delle isole Nicobare. I tre riuscirono a riadattare una canoa, con la quale realizzarono l'incredibile impresa di attraversare l'oceano indiano in tempesta, raggiungendo l'emporio inglese di Acieh nell'isola di Sumatra. Dopo altre avventure, che lo portarono anche in Vietnam e in Malacca, Dampier poté infine tornare in Inghilterra solo nel 1691. Aveva completato il suo primo giro del mondo. 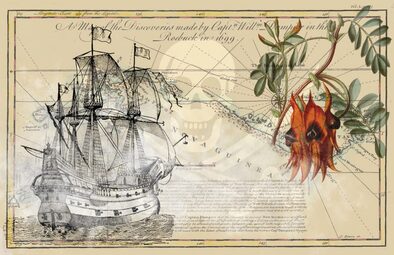 Un best seller e una spedizione scientifica Dampier era senza un soldo, ma aveva due risorse preziose: un schiavo tatuato filippino, che aveva acquistato a Sumatra, e il suo diario di viaggio. Dello sfortunato filippino, dopo averlo esibito come curiosità esotica, si disfece presto, rivendendolo al proprietario di una locanda; il diario si trasformò in uno fortunato bestseller, New Voyage Round the World , uscito nel 1697; nell'arco di due anni raggiunse quattro edizioni e nel 1699 fu seguito da un secondo volume. Se il largo pubblico era affascinato dalle avventure su sfondi esotici, furono invece le precise e oggettive informazioni di Dampier su popoli e risorse, idrografia e meteorologia, flora e fauna ad attirare l'attenzione di mercanti, politici e naturalisti. Dampier dedicò accortamente il libro a Charles Montague, presidente della Royal Society, che lo introdusse presso altri studiosi, in particolare Hans Sloane e John Woodward; inoltre lo presentò al primo lord dell'Ammiragliato, lord Oxford. Grazie a questi potenti sostegni, Dampier riuscì a far approvare quella che a tutti gli effetti possiamo considerare la prima spedizione scientifica finanziata dalla Royal Navy. Fu così che il 14 gennaio 1699 partì per il suo secondo giro del mondo, non più come marinaio semplice di una nave pirata, ma come capitano della nave di sua maestà Roebuck; il suo compito era raggiungere la Nuova Olanda, se possibile circumnavigarla ed esplorarne le potenzialità economiche e scientifiche. Era il comandante, ma anche il naturalista di bordo (un'accoppiata rara nella storia della scienza); l'amico Woodward, che nel 1796 aveva pubblicato per la Royal Society un opuscolo sull'argomento, lo aveva istruito sul corretto modo per raccogliere e conservare gli esemplari. Inoltre l'ammiragliato gli aveva messo a disposizione un abile artista (non tanto abile, a giudicare dai risultati) per disegnare piante e animali. Vista la stagione avanzata, la Roebuck avrebbe dovuto seguire la rotta del Capo di Buona Speranza, ma giunto all'arcipelago di Capo Verde, Dampier decise altrimenti. Si era reso conto che i marinai non avevano alcuna esperienza di navigazione oceanica e era ormai in aperto contrasto con il suo secondo George Fisher; lo fece vergare e mettere ai ferri, quindi puntò verso la costa brasiliana. Il 23 marzo raggiunse Bahia; Fisher fu sbarcato e incarcerato, in attesa di essere rimpatriato e processato. Mentre la nave veniva rifornita di viveri ed acqua, il comandante ne approfittò per andare ad erborizzare quasi ogni giorno in quella natura esuberante. Meno contenti erano i marinai, confinati a bordo; temendo un ammutinamento o una denuncia all'Inquisizione, il 23 aprile Dampier fece levare l'ancora. Ripresa la rotta iniziale, doppiò il Capo di Buona Speranza e raggiunse la costa australiana all'inizio di agosto, gettando l'ancora in una baia così ricca di squali che la battezzò Shark Bay (si chiama ancora così); prosegui poi verso nord visitando un'isola di quello che oggi si chiama Arcipelago Dampier, che chiamò Rosemary Island per l'abbondanza di una pianta dai fiori azzurri che gli ricordava il rosmarino (in realtà Olearia axillaris); in mezzo a piante di tanti colori, tra cui prevaleva l'azzurro, spiccava il rosso di una specie di fagiolo rampicante. Questa pianta davvero magnifica, dopo aver portato per qualche tempo il nome Clianthus dampieri, oggi si chiama Swainsonia formosa. Infine visitò per poche ore la Lagrange Bay dove raccolse esemplari di piante e conchiglie, mentre l'anonimo disegnatore ritraeva uccelli ed altri animali. Quel paese arido e privo di risorse, abitato da quella che Dampier giudicò "la popolazione più miserabile del mondo" era però deludente; le provviste scarseggiavano, la ciurma era sempre più incontrollabile e lo scafo in pessime condizioni. Anziché proseguire la navigazione verso est lungo la costa australiana, Dampier decise di tornare indietro e di dirigersi a Batavia, passando da Timor e dalla Nuova Guinea; a Batavia vennero effettuate alcune riparazioni che consentirono di riprendere il viaggio, doppiando il Capo di Buona Speranza alla fine di dicembre. Alla fine di febbraio la Roebuck naufragò al largo dell'isola di Ascension per una falla nella chiglia; l'equipaggio riuscì a salvarsi, recuperando pochi oggetti, tra cui il diario di Dampier e gli esemplari botanici raccolti in Brasile, Nuova Olanda e Nuova Guinea. Dopo un mese di stenti, i naufraghi furono raccolti da una nave della Compagnia delle Indie e rientrarono in Inghilterra ad agosto. Anche questa avventura divenne un libro, A Voyage to New Holland (1703). Dampier dovette affrontare la corte marziale, che lo assolse per il naufragio del Roebuck, ma lo condannò per abuso di potere e crudeltà nei confronti di Fisher, che fu invece totalmente scagionato. Nonostante ciò, Dampier rimaneva un personaggio così popolare da essere ricevuto dalla regina Anna e da ricevere il comando di una spedizione corsara ai danni del vicereame del Perù, con magri risultati. Di grande successo, ma non per merito suo, fu invece la spedizione corsara comandata da Woodes Rogers, durante la quale, nelle vesti di timoniere, Dampier fece il suo terzo giro del mondo. 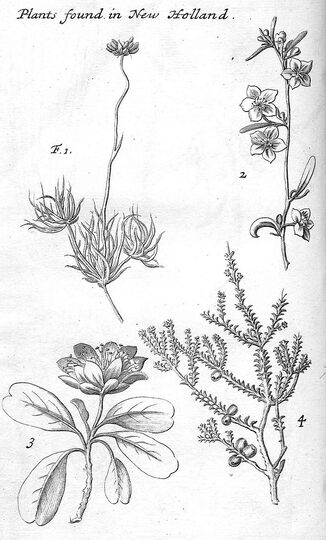 Alla scoperta della flora australiana Non basterebbe un romanzo per raccontare una vita tanto avventurosa (una sintesi nella sezione biografie); e infatti alle sue vicende si ispirarono tanto Swift, che nei Viaggi di Gulliver lo fa definire dal suo protagonista "mio cugino Dampier", quanto Defoe, che ha in parte modellato su di lui il giovane Robinson e il Capitano Singleton. Soffermiamoci qui sui suoi meriti scientifici. Dampier era un naturalista autodidatta, ma era dotato di una grande capacità di osservare e di confrontare i fenomeni, che descriveva con rara precisione e oggettività. Dalla brutta avventura in Campeche trasse la prima descrizione di un uragano tropicale, di cui poi rilevò le affinità con i tifoni del mar della Cina. Di estrema importanza il suo studio sugli alisei, le brezze, i venti stagionali, le maree e le correnti dei mari tropicali, pubblicato in appendice al secondo volume di New Voyage e divenuto un classico dell'idrografia e della meteorologia, apprezzatissimo tra gli altri da Cook e da Nelson. I suoi libri contengono osservazioni di prima mano e solitamente prive di pregiudizi sui popoli visitati (con la parziale eccezione degli aborigeni australiani, tratteggiati brevemente con poche frasi liquidatorie); di particolare interesse le pagine dedicate ai Chamorro, la popolazione indigena di Guam che ancora resisteva agli spagnoli che avevano occupato l'isola appena due anni prima. Dell'isola Dampier descrive anche con precisione le risorse naturali e i metodi di coltivazione, manifestando apprezzamento per i frutti dell'albero del pane. Osservò anche gli infiniti usi della palma da cocco presso i popoli del Pacifico, che a suo parere avrebbero dovuto essere imitati nelle Antille, dove la pianta era presente ma poco sfruttata. I due volumi di New Voyage Round the World contengono molte informazioni sulla flora e sulla fauna dell'America e del Pacifico. Contrariamente ai suoi contemporanei, che ritenevano la cocciniglia il seme di qualche pianta, la descrisse correttamente come un tipo di insetto, vari anni prima che Leewenhoek la identificasse come tale osservandola al microscopio. Le sue osservazioni sulle tartarughe e sulle iguana della Galapagos sono così attente e penetranti da fare da guida a Darwin, che aveva una copia di New Voyage nella sua biblioteca di bordo sul Beagle. Ovviamente, per i botanici le pagine più importanti sono quelle dedicate alla flora australiana. Durante il primo viaggio, Dampier ebbe modo di esplorare abbastanza a fondo la penisola che oggi porta il suo nome; anche se all'epoca non aveva ancora appreso le tecniche di raccolta e conservazione, le sue descrizioni sono così accurate da permettere quasi sempre di identificare piante ed animali. Le soste australiane del secondo viaggio, come abbiamo visto, furono molto brevi, ma Dampier questa volta raccolse un certo numero di esemplari botanici e poté giovarsi di un disegnatore, che ritrasse soprattutto uccelli e forse piante (quest'ultime potrebbero essere state disegnate più tardi sulla base degli exsiccata). Le piante raccolte e descritte sono circa una quarantina (cui vanno aggiunti esemplari raccolti in Brasile e Nuova Guinea); come gli aveva insegnato Woodwart, Dampier le pressò accuratamente tra le pagine di pesanti volumi e riuscì a salvarle dal naufragio. Al suo ritorno in Inghilterra, probabilmente le affidò a Woodward che a sua volta le passò all'amico John Ray; fu così che in appendice al terzo volume di Historia plantarum compare la descrizione di diciassette piante raccolte da Dampier (undici in Australia, quattro in Brasile, due in Nuova Guinea e una a Timor); probabilmente a scriverla fu Woodward. Altri esemplari furono prestati a Plukenet, che ne descrisse sette in Amaltheum botanicum. Più tardi Woodward cedette il piccolo erbario a Sherard; in tal modo entrò a fare parte dell'erbario dell'Università di Oxford, dove ancora si conservano 26 esemplari. Inoltre, in A Voyage to New Holland compaiono la descrizione e i disegni al tratto di 18 piante, nove delle quali australiane.  Piante azzurre dal nuovissimo mondo Oltre alle già citate Olearia axillaris e Swainsonia formosa, tra le piante australiane raccolte o descritte da Dampier figurano Solanum orbiculatum, Beaufortia sprengeliodes (precedentemente B. dampieri), Paractaenum novaehollandiae, Crotalaria cunninghamii, Canavalia rosea, Abrus precatorius. Una delle piante conservate nell'erbario di Oxford, un arbusto dai fiori azzurri presumibilmente raccolto a Rosemary Island, rimase inedito e fu pubblicata nel 1810 da Robert Brown in Prodromus florae Novae Hollandiae come Dampiera incana. La dedica testimonia della fama che Dampier conservava ancora a inizio Ottocento: "L'ho chiamata Dampiera in memoria di William Dampier, capitano di marina ed esploratore celeberrimo, in tutti i suoi vari viaggi sempre assiduo osservatore della natura senza trascurare la botanica; visitò due volte la costa occidentale della Nuova Olanda e ha lasciato la descrizione di alcune piante di questa regione nella sua relazione di viaggio". Dampiera, della famiglia Goodeniaceae, è un genere endemico dell'Australia dove è presente in tutti gli stati, con centro di diversità negli stati occidentali, dove vive circa la metà delle 66 specie riconosciute. Sono erbacee perenni o piccoli arbusti con fiori asimmetrici azzurri o viola con gola gialla. In alcune zone dell'Australia occidentale, insieme alle loro parenti Scaevola, sono piante dominanti delle brughiere costiere; altre specie vivono invece in montagna. Poiché, come molte piante australiane, le diverse specie si sono evolute adattandosi a specifiche caratteristiche di suolo, esposizione, drenaggio ed è difficile farle prosperare in condizioni differenti, solo alcune sono entrate in coltivazione, in particolare quelle a portamento tappezzante. Tra di esse, D. linearis, una coprisuolo pollonante che cresce abbastanza rapidamente in qualsiasi suolo ben drenato e produce meravigliosi fiori blu elettrico; D. diversifolia, una perenne prostrata tappezzante che tollera condizioni diverse e in estate produce fiori blu scuro; D. purpurea, originaria del sottobosco delle foreste di eucalipti dell'Australia orientale, con foglie tomentose e fiori da lavanda a viola scuro. Altre informazioni nella scheda. Sarà perché iniziano a fiorire già in inverno, sarà perché crescono in fretta e si arrampicano dappertutto, sarà per l'allegria dei loro grappoli viola: fatto sta che nel mondo anglosassone i rampicanti del genere Hardenbergia sono noti con il nome comune happy wanderer, "vagabondo felice". Anche l'uomo che suggerì il nome botanico, il barone Hügel, era un vagabondo, o almeno un viaggiatore, ma tutt'altro che felice; si era messo in viaggio per guarire dal mal d'amore. Per sua volontà, l'allegra vagabonda è stata dedicata a sua sorella, la contessa von Hardenberg, sulla quale - come capita troppo spesso alle donne - sappiamo davvero troppo poco. Un cuore infranto e un viaggio intorno al mondo Nel bel mondo della Vienna effervescente degli anni venti dell'Ottocento, che il congresso omonimo aveva trasformato nella capitale europea della diplomazia e del walzer, il barone Carl von Hügel era una figura molto nota. Come il fratello maggiore, direttore dell'Archivio di Stato, apparteneva al circolo del cancelliere Metternich. In gioventù, oltre a combattere con onore nelle campagne contro Napoleone, aveva molto viaggiato in Europa, sviluppando un raffinato gusto di collezionista e una grande passione per le piante. Dopo la morte del padre, nel 1826, venuto in possesso di un cospicuo patrimonio, acquistò una vasta proprietà nel sobborgo viennese di Hietzing; vi fece costruire una splendida villa e creò un giardino botanico privato, dove sperimentava la coltivazione di piante esotiche. Intorno al 1830, si fidanzò con una bella e volitiva contessa ungherese, Melanie Zichy-Ferraris. Ma la madre di lei mise gli occhi su un partito molto più promettente: niente meno che il principe Metternich, da poco rimasto vedovo per la seconda volta. Melanie riuscì a fare breccia nel suo cuore e ruppe il fidanzamento con Hügel per sposarsi con il cancelliere (che aveva trentadue anni più di lei). Tradito dalla donna amata e da un uomo che ammirava e considerava un amico, a Hügel non restava che partire. Non per l'Europa, che del resto conosceva già bene, ma per il Levante e oltre. Per prepararsi al viaggio, visitò brevemente l'Inghilterra e la Francia, e nel maggio 1831 si imbarcò a Tolone alla volta delle Grecia. Visitò poi Creta, Cipro, la valle del Nilo, la Palestina e la Siria. Nella primavera del 1832 era in India. Visitò Decca, Goa, Mysore, scalò le Blue Mountains, e percorse la costa del Malabar da Travancore a Capo Camorin. Passò poi a Ceylon, dove si trattenne quattro mesi. Seguendo la costa del Coromandel raggiunse Pondicherry e Madras, da dove si imbarcò per l'Indonesia e l'Australia. Nell'Australia occidentale Hügel intendeva raccogliere semi e piante per il suo giardino. Il primo impatto con il paesaggio australiano, allo sbarco nel porto di Fremantle nel novembre 1833, fu una cocente delusione: "Mi aspettavo fiduciosamente praterie verdi immacolate, alberi e arbusti coperti di fiori e frutti all'inizio dell'estate australe, tutto il paese un quadro della Natura non toccato dall'uomo". Invece ciò che vide era una terra "totalmente priva di vita", grigia, dove "tutto era immobile escluso il mare ribollente e minaccioso". Ma tutto cambiò quando si inoltrò nel bush: "A poche centinaia di passi dalla città inizia la vegetazione. La particolarità delle piante della Nuova Olanda è che la bellezza delle forme e i colori dei fiori si rivelano solo quando li si osserva attentamente a breve distanza. Dunque, la ricchezza e la varietà della flora in tutto il suo splendore colpisce l'occhio solo a uno sguardo ravvicinato. Il triste grigio-verde si trasforma nelle più varie sfumature di verde, dal più chiaro e luminoso al più scuro e lussureggiante, mescolati a fiori brillanti di ogni tipo, in numero indicibile. Mi aggiravo in quel mondo di colori come intossicato". Stranamente, è un mondo allo stesso tempo estraneo e familiare: estraneo per la sua inattesa varietà e bellezza, familiare perché il barone incontra ad ogni passo piante che già conosce, per averle coltivate nel suo giardino. Infatti, la bellezza delle flora dell'Australia occidentale non era sfuggita ai primi coloni, e diverse specie avevano incominciato a fare la loro comparsa nelle serre europee fin dalla fine del Settecento. Immerso in quella flora di sogno, il nostro viaggiatore infelice ritrova la felicità: "Per la prima volta dopo anni - lunghi anni penosi - vissi per un'ora nella piena delizia del momento. La mano sinistra stringeva un enorme mazzo di splendidi fiori, mentre la destra ancora si protendeva a raccogliere varietà sempre nuove". Il barone si trattenne circa un mese nell'area dello Swan River, esplorandone la foce, le isole all'imboccatura, i dintorni di Perth e spingendosi all'interno fino a Darlington e alle colline della Darling Scarp. Continuò poi per mare lungo il King George Sound, visitando l'area di Albany, incluse le valli inferiori del King River e del Kalgan River. Raccolse centinaia di specie, ma a colpire il suo cuore più di ogni cosa furono i grappoli rossi e viola di alcune leguminose rampicanti, su cui torneremo. Il suo viaggio australiano proseguì fino all'ottobre 1834, toccando la Terra di Van Demen (ovvero la Tasmania), l'Isola Norfolk e il Nuovo Galles del Sud. Seguirono la Nuova Zelanda, Manila e nuovamente l'India. Lo attendeva la parte più importante della spedizione: il lungo viaggio che da Calcutta lo portò ad attraversare l'India settentrionale, fino al Punjab, con un'ampia deviazione fino alle alte terre himalayane al confine tra Tibet e Kashmir. Sempre accumulando ricche collezioni di materiali di ogni genere, osservando usi e costumi, visitando personalità incluso il Maharaja Ranjit Singh, acquisì una profonda conoscenza, per molti aspetti inedita, della storia, della geografia fisica e umana, della natura, delle risorse economiche del Kasmir. Dalla terra dei Sikh, scese a Delhi, quindi a Bombay, dove nel 1836 iniziò il viaggio di ritorno. Attraverso il Capo di Buona Speranza e l'isola di Sant'Elena, nel 1837, dopo sei anni di assenza, era di nuovo a casa, dove poté riabbracciare la madre. 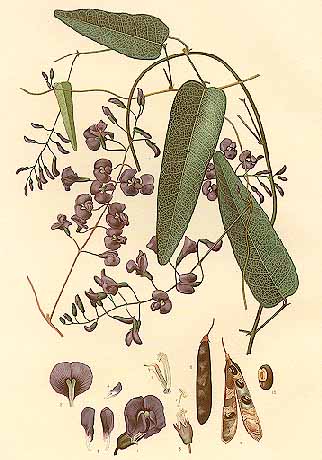 Piante australiane ed altre avventure Ora giungeva il tempo dello studio e del riordino della collezioni. Insieme a lui, a Vienna erano arrivate centinaia e centinaia di casse di opere d'arte, oggetti etnologici, animali impagliati, esemplari d'erbario. E finalmente entra in scena la dedicataria della nostra pianta. Per riordinare le collezioni botaniche, il barone si affidò alla sorella minore, Franziska detta Fanny, che durante la sua assenza si era sposata con il conte Anton August von Hardenberg, ed era ora la contessa von Hardenberg. Poco sappiamo di lei, tranne che assolse il compito con zelo e che dovette avere qualche conoscenza di botanica se Bentham (cui, come vedremo, si deve la dedica) dice di lei "con il suo ingegno orna la nostra scienza". Il barone divideva il suo tempo tra la stesura del suo capolavoro, Kaschmir und das Reich der Siek ("Il Kasmir e il regno dei Sikh"), in quattro volumi (1840-48), grazie al quale nel 1849 fu premiato dalla Royal Geographical Society come "intraprendente esploratore del Kashmir", gli impegni mondani, la cura del giardino e la promozione dell'orticultura austriaca. Ad occuparsi di pubblicare la sua collezione di piante australiane, riordinata con tanta cura da Fanny, fu un gruppo di botanici capeggiato da Stephan Endlicher: oltre allo stesso Enclicher, ne facevano parte l'inglese George Bentham e gli austriaci Eduard Fenzl e Heinrich Schott. Il risultato fu Enumeratio plantarum quas in Novae Hollandiæ ora austro-occidentali ad fluvium Cygnorum et in sinu Regis Georgii collegit Carolus Liber Baro de Hügel (1837), in cui vennero pubblicate quasi trecento specie raccolte dal Barone tra lo Swan River e il King George Sound. Tra di esse, le amate leguminose del Fiume dei Cigni. In realtà, non erano una novità assoluta in Europa, perché già da qualche anno alcune specie erano arrivate nelle serre europee, classificate come Glycine poi come Kennedia. Sulla base delle sue raccolte in Australia, Hügel suggerì a Bentham (che si occupò della pubblicazione delle Leguminose) di dividerle in quattro generi: oltre a Kennedia, Physolobium, Zichya e Hardenbergia. Due di questi nuovi generi dovevano ricordare le due donne più importanti della sua vita: la mai dimenticata ex fidanzata Melanie Zichy-Ferraris e la sorella Fanny, ora contessa Hardenberg. Provvide egli stesso a creare il genere Zichya sulla rivista della società botanica austriaca, mentre Hardenbergia venne pubblicata da Bentham appunto in Enumeratio plantarum. Per inciso, oggi sia Physolobium sia Zichya sono stati riassorbiti da Kennedia, mentre Hardenbergia continua da essere riconosciuto come un genere indipendente, come vedremo meglio tra poco. Ma prima di concludere, ancora due parole sul barone e sua sorella Fanny. Le cronache del tempo descrivono il giardino di Hietzing come uno dei più belli d'Europa, ricco di piante esotiche riportate dal viaggio intorno al mondo. All'ingresso, di fronte al soggiorno, circondata da pilastri con piante rampicanti, c'era una terrazza pavimentata, con una grande varietà di piante coltivate tra le lastre, e aiuole con bulbi, erbacee ed arbusti scelti con grande cura perché fiorissero quasi tutto l'anno, tra cui una notevole collezione di camelie; un prato con molti alberi e arbusti esotici; serre fredde e riscaldate con la collezione di piante australiane. Non mancava un orchidarium, che nel 1842 contava 83 generi e quasi 200 specie. Molto ammirato era il cosiddetto Giardino rococò, con aiuole formali bordate di tufo, parterre, fontane e statue. Il barone si dava da fare per diffondere il gusto per il giardinaggio e le piante esotiche non solo con l'esempio; riprendendo un progetto che già accarezzava prima di partire, nel 1837 fondò la Österreichische Gartenbau-Gesellschaft, la società di giardinaggio austriaca, di cui dettò lo statuto e fu il primo presidente. Le prime mostre organizzate dalla società si tennero proprio nel parco di Hietzing. Gli eventi del 1848 misero fine a un tranquillo decennio di studio e giardinaggio; Hügel riprese servizio nell'esercito e partecipò alla guerra in Italia (dal nostro punto di vista, la prima guerra d'Indipendenza); era però a Vienna nei giorni tumultuosi in cui Metternich rischiò di essere linciato dalla folla e, insieme all'amata Melanie, lo portò in salvo nascondendolo nella sua carrozza. Forse disgustato da questi eventi, abbracciò la carriera diplomatica, servendo per molti anni prima a Firenze, poi a Bruxelles. Quando si ritirò, preferì trasferirsi in Inghilterra insieme alla moglie, un'irlandese molto più giovane di lui che aveva conosciuto in India e sposato a Firenze, e ai figli. Il giardino e la villa, passati di mano in mano, fatalmente andarono in rovina e vennero dispersi dalla lottizzazione. Quanto a Fanny, la sua vita ha lasciato ben poche tracce nelle cronache del tempo. Sappiamo che, dopo il matrimonio con il conte von Hardenberg, un gentiluomo della corte di Hannover, lo accompagnò nelle varie sedi cui fu assegnato (le fonti dell'epoca citano Berlino e Dresda) e soggiornò spesso nella tenuta di campagna di Rettkau, in Slesia. Proprio qui si rifugiò e morì il fratello maggiore, Clemens Wenzel, collaboratore di Metternich, travolto dalla disgrazia del cancelliere. Nel 1849 Franziska rimase vedova e, presumibilmente senza figli, decise di raggiungere Carl, vivendo per qualche tempo nella sua casa di Vienna, per poi trasferirsi insieme a lui a Firenze. Qui morì nel 1852. Una sintesi di queste poche notizie nella sezione biografie.  Finalmente, Hardenbergia Ovviamente, anche il barone Hügel, come raccoglitore e collezionista, nonché promotore dell'orticoltura, ha avuto la sua parte nella nomenclatura botanica. Un genere Huegelia gli fu dedicato sia da Robert Brown, sia da Reichenbach, sia da Bentham; nessuno dei tre è oggi accettato. A resistere più a lungo è stato forse Huegelia Rchb., oggi confluito in Trachymene Rudge. La specie più nota è probabilmente Trachymene coerulea, spesso ancora indicata con il sinonimo Huegelia coerulea. Un manipoli di piante neppure troppo esiguo ricorda invece il barone nel nome specifico: sono per lo più australiane, come Alyogyne huegelii, il cosiddetto ibisco blu, oppure Melaleuca huegelii. Ed eccoci infine arrivati alla nostra protagonista verde, la felice vagabonda Hardenbergia. Appartenente alla sottotribù Kennediinae della famiglia Fabaceae, è in effetti molto affine a Kennedia; le piante di entrambi i generi sono liane originarie dell'Australia. Ad Hardenbergia sono assegnate tre specie: H. comptoniana, nativa dell'Australia sudoccidentale (che è la specie raccolta da Hügel lungo lo Swan River); H. perbrevidens, endemica del Queensland; H. violacea, nativa dell'Australia meridionale e orientale. Rampicanti, volubili o ricadenti, sono sempreverdi con foglie alterne, ovate ma anche palmate, piuttosto coriacee; a fine inverno e all'inizio della primavera producono copiose pannocchie di fiori papilionacei dai colori sgargianti: da malva a porpora con marcature bianche H. comptoniana; da malva a viola scuro con marcature gialle al centro la rara H. perbrevidens; da viola a porpora, ma anche rosa e bianchi H. violacea. Questa è la specie più coltivata e ne sono state selezionate molte cultivar, compresa una bicolore. Viene coltivata all'aperto dove non gela, come nella nostra riviera, altrove in serra temperata o in posizione protetta contro un muro. Qualche informazione in più nella scheda. Separata dall'Australia continentale da uno stretto di circa 250 km, la Tasmania è una grande isola con una straordinaria varietà di ambienti e una grande ricchezza di endemismi. Uniche sono le sue foreste pluviali fresche, relitti della flora del Gondwana altrove scomparsa in seguito ai cambiamenti climatici; tra i suoi record, alcuni degli alberi più antichi e longevi del pianeta, il pino della Tasmania, Lagaristrobos franklinii, che può vivere fino a 3000 anni. Quando Winifred Mary Curtis arrivò qui dall'Inghilterra nel 1939, questa flora singolare era stata oggetto di diversi studi, ma mancava un manuale di riferimento didatticamente fruibile. Fu per i suoi studenti che ella iniziò così a scrivere The student's flora of Tasmania, un'impresa che l'avrebbe vista impegnata per circa quarant'anni. Con la sua lunghissima vita (morì centenaria nel 2005) la botanica australiana è stata una straordinaria testimone del Novecento e una protagonista di quel cammino che lo ha fatto definire il "secolo delle donne". Tra i riconoscimenti che l'hanno onorata, anche la dedica dell'endemica Winifredia sola, appartenente alla singolare famiglia Restionaceae.  Una giovinezza inglese Nata nella Londra edoardiana nel 1905, la botanica Winifred Mary Curtis ha avuto la ventura di vivere esattamente cent'anni, percorrendo un secolo segnato da due guerre mondiali e da enormi trasformazioni che, tra l'altro, hanno mutato profondamente il ruolo delle donne. Al momento della sua nascita, con la sola eccezione della Nuova Zelanda, in nessun paese al mondo alle donne era riconosciuto il diritto di voto; non era assolutamente automatico che le ragazze avessero le stesse opportunità di accesso allo studio dei loro coetanei maschi. In Gran Bretagna, le donne erano accettate in una sola università, la London University. Dunque, per tutta la vita Winifred fu sempre grata ai genitori che la incoraggiarono a studiare e a sviluppare i suoi talenti e si batté perché a tutte le ragazze fossero garantite pari opportunità. Il primo evento che segnò profondamente la sua vita - e quella della sua generazione - fu la Prima guerra mondiale. Il padre, funzionario statale, fu infatti inviato in India e fu separato dalla famiglia per tutta la durata del conflitto. Winifred e sua madre dovettero trasferirsi in campagna (una buona opportunità per una futura botanica), mentre il destino delle donne subiva una profonda svolta. Con gli uomini al fronte, si aprivano al lavoro femminile campi prima impensati; nel 1918 arrivava finalmente anche in Gran Bretagna il sospirato diritto di voto. Ma un'intera generazione di giovani uomini aveva perso la vita, tanto che molti anni dopo, a chi le chiedeva perché non si fosse mai sposata, Winifred ebbe a rispondere, con una certa ironia: "Uomini non ce n'erano. Erano stati tutti uccisi in guerra". Finita la guerra, Winifred e sua madre si trasferirono in India, dove la ragazza frequentò un collegio americano, un ambiente molto aperto e cosmopolita. Nel 1921 tornò a Londra e nel 1924 si iscrisse all'University College, dove avrebbe studiato botanica, chimica, matematica e fisica. Studentessa brillante, ottenne varie borse di studio; nel 1929 conseguì il titolo di Bachelor of Science, con una ricerca su Spartina x townsendii, una Poacea invasiva che, originatasi nell'Inghilterra meridionale intorno al 1870 da un'ibridazione spontanea tra la nativa S. maritima e l'americana S. alternifolia, nell'arco di cinquant'anni aveva incominciato a diffondersi in modo sempre più incontrollato. Winifred avrebbe voluto rimanere a lavorare all'Università, ma incominciavano a farsi sentire gli effetti della crisi economica e molte donne venivano espulse dal mondo del lavoro. Per mantenersi cominciò così a insegnare scienze in varie scuole femminili; contemporaneamente, continuava il suo lavoro all'università come volontaria e, più tardi, anche come ricercatrice "onoraria" (leggasi non pagata) a Kew. Fu anche membro attivo della British Ecological Society, in quegli anni al suo esordio. Nel 1939 ottenne la laurea magistrale (Master of Science). Nel 1938 suo padre Herbert John Curtis andò in pensione; da tempo aveva deciso di cercare un paese del Commonwelt dal clima più mite dove trascorrere la vecchiaia. Le sue preferenze andavano a Nuova Zelanda, Tasmania e Vancouver; Winifred scrisse alle locali università, nella speranza di un impiego come botanica. L'offerta più promettente venne dall'Università della Tasmania con un posto part-time come Dimostratore. La decisione era presa e la famiglia Curtis si mise in viaggio per Hobart, la capitale della Tasmania, dove arrivò nel settembre 1939, dopo un viaggio di sei settimane, quasi in contemporanea con l'inizio della Seconda guerra mondiale.  Decana della botanica australiana Cominciava una nuova vita di intensa attività. All'incarico part-time all'università (era la seconda donna di sempre ad essere ammessa ai ranghi accademici, l'unica al momento in servizio) per mantenersi dovette affiancare l'insegnamento di scienze in una scuola superiore femminile. Winifred trovava assurdo insegnare biologia alle sue studentesse usando come libro di testo manuali basati sulla flora e la fauna britanniche; decise così di scrivere Biology for Australian Students, che sarà pubblicato nel 1948. Intanto, gli effetti della guerra si facevano sentire anche in quella remota isola; la travolgente avanzata giapponese faceva temere che la flotta nipponica tentasse di invadere la Tasmania per trasformarla in una base navale avanzata; nel 1942 le autorità decisero di evacuare la scuola dove insegnava Winifred, trasferendola a Interlaken nell'altopiano centrale. La nostra botanica fu così costretta a fare la spola tra la scuola e l'università, senza mancare di visitare periodicamente i genitori che abitavano nel Parco nazionale, muovendosi con una piccola auto poco adatta alle strade sterrate che doveva percorrere. Fortunatamente proprio quell'anno le fu offerto un incarico a tempo pieno come assistente di biologia. Iniziò le sue ricerche sulla flora della Tasmania studiando il numero di cromosomi di alcune piante; pubblicato nel 1944 fu il primo studio sulla poliploidia dedicato a piante native australiane. Nel 1945, quando le cattedre di zoologia e botanica vennero separate, divenne titolare della cattedra di botanica (Lecturer of Botany). Più tardi sarebbe diventata Senior Lecturer (1951) e Reader (1956), la prima donna australiana a raggiungere questo titolo. Ebbe spesso a ricoprire il ruolo di direttore del dipartimento, oltre a farsi la fama di insegnante formidabile e temibile, ma amata e rispettata dai suoi studenti. Ma intanto era iniziata anche un'altra avventura. Nel 1943 il Gouvernment Printer (l'equivalente del nostro poligrafico di Stato) le chiese di aggiornare Tasmanian Flora di Rodway, un testo ormai fuori stampa e assai datato, essendo uscito per la prima volta nel 1903. Winifred accettò, senza sapere che il lavoro le avrebbe richiesto quarant'anni. Con le giornate già occupate dall'insegnamento (e il sabato pomeriggio trascorso all'Erbario dell'Università), poteva dedicarsi alla scrittura solo di sera. Le vacanze erano destinate alla raccolta: infatti, a parte poche eccezioni, le descrizioni erano sempre condotte a partire da materiale fresco, raccolto durante escursioni in cui Winifred, accompagnata da alcune allieve, si spostava prima in autobus, poi a piedi, spesso lungo sentieri non segnati, pernottando in tenda o in capanne nei parchi nazionali. I cinque volumi di The Student's Flora of Tasmania con le piante classificate sulla base di sistema di Bentham e Hooker che Curtis aveva studiato negli anni londinesi, uscirono tra il 1956 e il 1994, a partire dal secondo volume con la collaborazione di Dennis Morris del Dipartimento di Stato di Agricoltura. Intanto nel 1962 era morta la madre e Winifred decise di andare in prepensionamento per assistere il padre e dedicarsi a tempo pieno alla stesura della Flora; così nel 1966 si ritirò dall'insegnamento (anche se la sua presenza all'Università continuò ad essere assidua). Tuttavia l'anno successivo non seppe dire di no quando le fu chiesto di scrivere i testi per una pubblicazione dedicata alla flora endemica della Tasmania. La proposta veniva da lord Talbot de Malahide, grande collezionista che coltivava molte piante originarie dell'isola nella sua tenuta in Irlanda. Inizialmente, egli aveva chiesto all'illustratrice botanica australiana Margaret Stones, un'artista affermata che lavorava per il Curtis Magazine e per i Kew Gardens, di disegnare 35 piante tasmane. Decise poi di ampliare il progetto, prevedendo una serie di volumi, per i quali chiese a Winifred Curtis di scrivere le descrizioni; il risultato fu The Endemic Flora of Tasmania (1967-1978), una splendida opera di sei volumi in folio per un totale di 254 illustrazioni. Poiché i disegni di Margaret si basavano su piante vive, molte furono procurate dallo stesso lord Talbolt traendone dai suoi giardini; ma altre, non reperibili in Europa, venivano raccolte da Winifred Curtis e spedite per per via aerea in Irlanda; i disegni di Margaret facevano poi il cammino inverso per essere verificati, eventualmente corretti e approvati da Winifred, Intanto l'instancabile botanica continuava ad occuparsi della sua opera maggiore, frequentando assiduamente l'erbario dell'Università che, anche grazie a lei, nel 1977 si trasformò nel Tasmanian Herbarium. Attiva e lucida fino a tardissima età, divenne uno vero "monumento vivente" della botanica australiana. Continuò a partecipare a congressi all'estero almeno fino agli anni '80, mantenne un'attiva corrispondenza con colleghi, dilettanti e studenti, che tendevano a considerarla un oracolo. Sui suoi libri si formarono generazioni di studenti (si dice che la sua The Student's Flora of Tasmania sia l'unica grande flora di riferimento leggibile da parte di uno studente, grazie alla lunga pratica didattica dell'autrice). E' stata onorata da innumerevoli riconoscimenti, tra cui la dedica di una riserva naturale, Winifred Curtis Scamander Reserve. Le sono state dedicate diverse piante endemiche della Tasmania: Epilobium curtisiae Raven, Richea curtisiae A. M. Gray, Viola hederacea spp. curtisiae L. Adams, Epacris curtisiae Jarman, nonché il genere Winifredia. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Una Winifredia... sola Il genere Winifredia, appartenente alla famiglia Restionaceae, fu creato nel 1986 da L.A.S. Johnson e B.G. Briggs. Comprende un'unica specie, W. sola. Fu proprio Winifred Curtis a raccoglierla per prima e a segnalarla ai due colleghi. E' un'erbacea dioica poco comune che si trova nei cariceti della Tasmania sudoccidentale. Similmente agli altri membri della famiglia, ha steli cilindrici con foglie più o meno secche ridotte a guaina e infiorescenze terminali di spighette. Una caratteristica distintiva sono gli steli eretti dal diametro di 2-3 mm ampiamente spaziati lungo il rizoma. L'epiteto sola indica sia il fatto che questa specie è l'unica del genere, sia i luoghi remoti e poco abitati in cui vive. Altre informazioni nella scheda. Le Restionaceae sono un gruppo di piante erbacee che a prima vista possono ricordare gli equiseti, mentre si tratta di monocotiledoni affini ai carici e ai giunchi. Sono tipiche dell'emisfero sud e con il loro aspetto preistorico stanno attirando anche da noi l'attenzione di giardinieri e vivaisti. Chi desiderasse saperne di più, troverà qualche informazioni e link di approfondimento in questa pagina. Alla vigilia della Rivoluzione francese, un piccolo gruppo di amici fonda una nuova società scientifica, caratterizzata dall'interdisciplinarietà, dall'indipendenza e dalla fedeltà al metodo sperimentale. E' la Societé Philomatique, destinata a un grande avvenire. Tra i soci fondatori, Claude-Antoine-Gaspard Riche, che dopo esserne stato il primo segretario, nel 1791 lascerà la Francia come naturalista dell'Espérance, una delle due navi della spedizione Entrecasteaux. A ricordarlo il singolare genere Richea, con nove specie endemiche della Tasmania che egli esplorò insieme all'amico La Billardière.  Studio e amicizia Il 10 dicembre 1788, a Parigi, sei amici fondano una nuova associazione scientifica. Tutti giovani o giovanissimi, sono Augustin-François de Silvestre; Charles de Broval, matematico e fisico; il dicottenne Alexandre Brongniart che diventerà un famoso geologo; e tre medici: Claude-Antoine-Gaspard Riche, Joseph Audirac e un certo Petit. I promotori dell'iniziativa sono senza dubbio Silvestre e Riche, entrambi ventiseienni e innamorati delle scienze naturali. Il primo per classificare i libri del suo patrono si è sentito in dovere di studiare matematica, fisica, chimica, scienze naturali; è diventato così uno studioso autodidatta, una figura familiare nei salotti letterari e scientifici del tempo, amico di molti eminenti scienziati. Il secondo si è laureato in medicina a Montpellier nel 1787, per poi spostarsi a Parigi dove, grazie anche al fratello maggiore, l'ingegnere Gaspard Riche de Prony, ha stretto amicizia con scienziati come Vicq d'Azyr e Cuvier. Di carattere ardente e entusiasta, è anche vicino alla Societé Linéenne, di cui condivide la battaglia per la diffusione del sistema di Linneo (che, per diverse ragioni, è invece avversato tanto dal vecchio Buffon quanto dai naturalisti del Jardin des Plantes). All'inizio l'associazione è solo un gruppo di amici che si incontrano settimanalmente, a turno, a casa di uno dei membri, per leggere i loro lavori, discutere delle ultime novità scientifiche, replicare esperimenti. Tre caratteristiche sono evidenti fin dall'inizio: l'indipendenza tanto dall'autorità politica quanto delle istituzioni scientifiche riconosciute; l'interdisciplinarità (gli interessi dei soci toccano matematica, fisica, chimica, scienze naturali, geologia, scienze della salute); la vocazione pedagogica e l'interesse per le applicazioni pratiche della scienza a beneficio della società. Nel nuovo clima di libertà dei primi mesi della Rivoluzione, la società si consolida e si espande: nell'autunno si dota di uno statuto, di un motto (Studio e amicizia), di un nuovo nome: Societé philomatique de Paris, ovvero società degli amanti della ricerca. Il suo programma è nobile e ambizioso: "diventare un luogo di incontro generale dove confluiranno le nuove conoscenze e da cui si espanderanno nel mondo degli studiosi, in una catena luminosa e ininterrotta di verità e insegnamenti". Per elezione e cooptazione entrano nuovi membri: il primo, sempre nell'autunno 1789, è il chimico Vauquelin, scopritore del berillo e del cromo. Tra il 1790 e il 1791 l'associazione continua ad allargarsi, raggiungendo 18 membri effettivi e 18 corrispondenti. Ma a farla decollare sono gli eventi del 1793: l'8 agosto la Convenzione sopprime le Accademie e le società scientifiche legate al vecchio regime; di conseguenza nell'autunno molti ex accademici chiedono di essere ammessi ai Philomathes, che ormai riuniscono il fior fiore della scienza francese: Berthollet, Fourcroy, Lavoisier, Lefebvre d'Hellancourt, Ventenat, Vicq d'Azyr, Lamarck, Monge, Prony, Laplace. Ma questa è ormai un'altra storia. Nel frattempo, ad eccezione di Silvestre (segretario fino al 1802) e Brongniart, i soci fondatori sono ormai usciti di scena: Audirac è morto nel 1790, Broval è emigrato nel 1792, di Petit si sono perse le tracce. Quanto a Riche, dal settembre 1791 è coinvolto nella grande avventura della spedizione Entrecasteaux alla ricerca di Laperouse, come naturalista dell'Espérance. Fino a quel momento è stato l'anima dell'associazione; come segretario, ne ha redatto i bollettini mensili (che fino al 1792 erano manoscritti, copiati in 18 copie, una per ciascun corrispondente).  Passione naturalistica, disavventure e disastri A convincerlo a partire, oltre all'amore per la scienza, una serie di considerazioni: quella principale è la salute; fin dagli anni di Montpellier il giovane naturalista soffre di tubercolosi, tanto che sono i suoi stessi amici a spingerlo a partire, nella speranza che il viaggio per mare e il mutamento di clima gli giovino; poi il desiderio di gloria, alimentato, secondo Cuvier (che di Riche ci ha lasciato un commosso elogio funebre) da una storia d'amore: temperamento appassionato e romantico, negli anni universitari Claude si innamorò perdutamente di una giovane, tanto appunto da ammalarsi; questo amore contrastato l'avrebbe spinto prima a venire a Parigi a cercare la gloria scientifica, per rendersi degno dell'amata, poi a partire per i mari del Sud, a trovare o la morte o la fama. Ho già raccontato delle vicende della spedizione in questo post. Riche si legò di amicizia soprattutto con La Billardièere, cui lo univano sia l'amore per la scienza sia la passione politica (sembra che a Parigi avesse fatto parte del club giacobino); inoltre come naturalisti erano per così dire complementari: La Billardillière era soprattutto un botanico, Riche soprattutto uno zoologo. Dunque collaborarono senza rivalità ciascuno alle ricerche dell'altro, scambiandosi esemplari, osservazioni e insegnamenti, in puro spirito di amicizia filomatica. Fedele allo spirito interdisciplinare della società, durante la spedizione Riche si occupò anche di meteorologia, geologia e chimica, nonché di misurare i venti, la salinità, la luminescenza delle acque; il suo interesse principale era tuttavia la fauna acquatica. Anche per lui, dopo gli entusiasmi iniziali, subentrò la frustrazione delle soste troppo brevi rispetto ai lunghi tratti di mare, che divenne rabbia per l'indifferenza quando non l'ostilità degli ufficiali. In una lettera a Entrecasteaux, scritta nell'agosto 1792, mentre veleggiavano verso le Molucche, Riche lamenta che non solo durante gli scali non gli è stato prestato alcun aiuto, ma che gli uomini dell'equipaggio si appropriano delle prede migliori per arricchire le proprie collezioni private. La risospota del comandante, come possiamo immaginare, fu negativa e alquanto minacciosa. L'avventura più pericolosa toccò a Riche durante la sosta a Esperance Bay, nell'Australia occidentale (14-16 dicembre 1792). Attratto da fumi intravisti in lontananza, si allontanò dagli altri, finendo per perdere l'orientamento; vagò poi per due giorni nei pressi di un lago interno, finché riuscì in qualche modo a raggiungere il mare. I compagni lo trovarono esausto su un piccolo capo ribattezzato in suo onore Cape Riche; a un certo punto aveva anche dovuto abbandonare le sue raccolte. In quelle ore disperate non aveva incontrato anima viva, eccetto tre canguri; si era sostentato solo con l'acqua di una fonte e le bacche di un'Ericacea, battezzata Leucopogon richei (oggi L. parviflorus) da La Billardière. Quest'ultimo, sollevato ma anche seccato per la sventatezza dell'amico, ne approfittò comunque per erborizzare, raccogliendo, oltre a questa pianta, Banksia repens e B. nivea, Chorizema ilicifolia, Eucalyptus cornuta e Anigozanthus rufa (la pianta nota come "zampa di canguro"). Quando la spedizione a Giava finì in catastrofe, Riche fu tra i naturalisti imprigionati come agitatori giacobini. Dopo mesi di prigionia, il 13 luglio 1794, insieme a Willaumes, Legrand, Laignel, Ventenat e 19 marinai, gli fu concesso di partire per Mauritus (Ile de France). Dopo aver deposto la sua testimonianza sul tradimento degli ufficiali, egli era tuttavia tormentato dall'angoscia di aver perso il risultato di anni di fatiche (anche le sue raccolte e le sue carte erano finite nella mani degli olandesi); chiese dunque all'assemblea coloniale il permesso di tornare a Batavia per cercare di recuperarle. Nel novembre 1794 poté infine imbarcarsi sulla Natalie, una nave che riportava a Giava dei prigionieri olandesi; a Batavia le autorità olandesi ignorarono le richieste, e, di nuovo a bordo della Natalie, il 29 marzo 1795 Riche ripartì per l'Ile de France senza i materiali, ma con la soddisfazione di aver ottenuto il riscatto di una cinquantina di altri compagni di sventura, tra cui La Billardière. Tornò poi in Francia nel giugno dell'anno seguente, ma in condizioni di tale prostrazione che si spense nel settembre del 1797, senza aver potuto riabbracciare la famiglia (avendo scoperto, anzi, che la donna amata era caduta vittima del Terrore). Una sintesi della sua vita breve ed intensa nella sezione biografie.  Nelle foreste e nelle praterie alpine della Tasmania Oltre a Leucopogon richei, La Billardière nella sua Relation du Voyage à la Recherche de la Pérouse (1800) volle dedicare all'amico perduto Richea glauca (oggi Craspedia glauca, dopo essersi chiamato C. richea). Per quanto la denominazione di La Billardière abbia la priorità, è stata soppiantata a favore (come nomen conservandum) del genere Richea creato da Robert Brown in Prodromus Florae Novae Hollandiae (1810). In tal modo Riche ha tenuto a battesimo un genere strettamente legato ai luoghi che esplorò, oltre che un'indubbia meraviglia della natura che non avrebbe mancato di affascnarlo. Il genere Richea R. Br. della famiglia Ericaceae (un tempo Epacridaceae) comprende 11 specie di alberi e arbusti, nove dei quali endemici della Tasmania. Molto variabili per dimensioni, dalla nana R. alpina all'arborea R. pandanifolia, sono accomunate dai rami segnate dalle cicatrici anulari delle foglie cadute; dalle foglie che avvolgono totalmente il fusto alla base, per poi incurvarsi e assottigliarsi all'apice; i fiori, raccolti in cime o pannocchie terminali, hanno corolla chiusa e petali fusi in un opercolo. Alcune specie sono piuttosto comuni in Tasmania, dove occupano ambienti soprattutto alpini e subalpini alquanto diversificati: aree aperte aride come R. acerosa, zone paludose come R. gunnii, macchie con suolo povero come R. procera, foreste umide come R. dracophylla. La specie più singolare è R. pandanifolia, un vero e proprio albero che può superare i dieci metri: in genere ha un solo fusto non ramificato, rivestito di foglie secche persistenti, coronato da un ciuffo di lunghissime foglie lanceolate, alle cui ascelle spuntano grappoli di fiori crema o bianchi: a prima vista, nessuno penserebbe che si tratta di un'Ericacea, anzi sarebbe facile scambiarla per una palma. Fiori a parte, è ingannevole anche R. dracophylla, un arbusto eretto dal portamento disordinato che sembra evocare una Draceana. Le specie arbustive di medie dimensioni, che formano ampie brughiere, si rivelano invece per quel che sono al primo sguardo: eriche dalle fioriture stupende, soprattutto la magnifica R. scoparia, con le sue pannocchie di un ricco rosa carico. Qualche informazione in più nella scheda. Nei due anni cruciali in cui in Francia cade la monarchia e si scatena il Terrore, la surreale spedizione Entrecasteaux, decretata dall'Assemblea nazionale e finanziata da Luigi XVI, ignara di quanto avviene in patria naviga nei mari australi in nome del re e della nazione alla ricerca di quanto resta della spedizione di La Pérouse. Fallita nel suo obettivo principale - le navi avvisteranno l'isola di Vanikoro, dove La Pérouse aveva fatto naufragio, ma inspiegabilmente la supereranno senza esplorarla - e risoltasi in una catastrofe umanitaria (quasi metà degli uomini morirà durante il viaggio) sarà tuttavia un grande successo scientifico: al suo attivo, la circumnavigazione di Australia e Tasmania, la scoperta o l'esplorazione di molte isole del Pacifico, la correzione delle carte nautiche, la nascita stessa dell'idrografia scientifica, con l'ingegner Beautemps-Beaupré. Eccezionali poi i risultati botanici, grazie soprattutto al combattivo Jacques Julien Houtou de La Billardière, che, gettati alle ortiche i nomi nobiliari, volle chiamarsi semplicemente cittadino Labillardière. A ricordarlo lo splendido genere australiano Billardiera.  Prologo; una spedizione di soccorso in nome del Re e della nazione Quei 219 uomini che il 28 settembre 1791 - due settimane prima il re ha giurato sulla nuova Costituzione e due giorni dopo l'Assemblea nazionale si scioglierà per lasciare il posto all'Assemblea legislativa - lasciano il porto di Brest al grido "Vive le Roi! Vive la Nation!" non sanno che il fragile compromesso tra re e nazione sta per spezzarsi, e presto non ci sarà più alcun re. Forse uno degli ultimi atti di concordia tra i due poteri è proprio la loro missione, voluta dall'Assemblea nazionale e finanziata dal sovrano: a bordo di due bagnarole, riaddobbate in tutta fretta e ribattezzate pomposamente La Recherche e L'Espérance, partono per i mari del sud alla ricerca della spedizione La Pérouse, di cui non si hanno notizie da tre anni. Sotto il comando dell'esperto ammiraglio Antoine de Bruni d'Entrecasteaux, dovranno battere palmo palmo il Pacifico, ripercorrendo l'ipotetica rotta dell'Astrolabe e della Boussole, le navi di La Pérouse. La loro sarà anche una missione scientifica, che dovrà proseguire gli obiettivi della spedizione perduta. Ecco perché a bordo c'è una quindicina di scienziati: tra gli altri, il geografo e astronomo Claude Bertrand, il mineralogista Jean Blavier, l'astronomo Ambroise Pierson, l'ingegnere idrografo Charles-François Beautemps-Beaupré. Particolarmente nutrito il drappello dei naturalisti; tutti giovani, hanno un'età media di ventisette anni. Il decano e capo in pectore è il trentunenne Jacques Julien Houtou de La Billardière, un botanico esperto che ha già all'attivo una spedizione in Siria e Libano; c'è poi il brillante naturalista e geologo Claude Riche, membro fondatore e segretario della Societé philomatique; Louis Ventenat, elemosiniere della Recherche, fratello del botanico Etienne Pierre, più interessato alla natura che al suo creatore; il chirurgo e naturalista Louis Auguste Deschamps. Li affiancano i pittori Jean Piron e Chailly-Ely e il giardiniere Félix Delahaye, scelto personalmente da André Thouin di cui è stato allievo e collaboratore. Sulle onde dell'Oceano, quegli uomini portano con sé tutte le lacerazioni e le passioni ideologiche della Francia rivoluzionaria: ci sono i bleus, gli ufficiali, nobili e monarchici; i sottoufficiali, di origini borghesi, cui è negata ogni speranza di carriera, sensibili alle parole d'ordine dei club rivoluzionari, di cui sono membri attivi più di uno degli scienziati: i più sfegatati sono i giacobini La Billardière e Riche; ai marinai tocca ovviamente il ruolo dei sanculotti. Ma tutto questo, nell'entusiasmo del viaggio, per ora non conta. Il primo scalo, a Tenerife (12-23 ottobre), offre ai naturalisti l'occasione di sfidarsi nella scalata del picco del Teide; a vincere la partita è il gruppo della Recherche, guidato da La Billardière, anche se Deschamps e Piron cedono e tornano indietro. Il destino di sventura che aleggia sulla spedizione incomincia a manifestarsi nel secondo scalo, la colonia del Capo (16 gennaio 1792). Scendendo dalla Table Mountain, Claude Bertrand scivola e fa un volo di 15 metri. Gravemente ferito, abbandona la spedizione insieme a Blavier e Chailly-Ely, provati dal viaggio. Decederà poco tempo dopo. In mare, due giorni dopo la partenza (18 febbraio), muore anche il quartiermastro; sulla base di alcune ambigue testimonianze raccolte al Capo, Entrecasteux ha deciso di dirigersi al più presto verso l'arcipelago dell'Ammiragliato, doppiando l'Australia meridionale e risalendola in direzione nord est. Non è la rotta più breve, ma è l'unica possibile con due imbarcazioni poco adatte ad affrontare i forti venti della rotta più settentrionale. 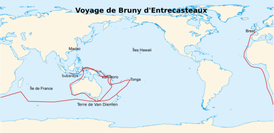 Un viaggio nei mari australi Attraversato l'Oceano Indiano, il 21 aprile le due navi raggiungono l'isola Van Diemen (ovvero la Tasmania) e gettano l'ancora nella baia - ribattezzata la Recherche - dove poi sorgerà la capitale Hoban. Mentre i vascelli vengono raddobbati, gli scienziati esplorano l'interno e scoprono cigni neri (Cygnus atratus) e due nuove specie di eucalipti (Eucaliptus globulus e E. resinifera). Non lontano dalla costa il giardiniere Félix Delahaye, secondo un'abitudine che si incontra anche in spedizioni precedenti, pianta un orto con semi portati dall'Europa, che dovrebbe costituire una risorsa per le navi europee che vi faranno scalo in futuro, oltre che uno strumento di civilizzazione degli indigeni. Ripartite il 17 maggio, le navi fanno rotta a nord ovest verso la Nuova Caledonia, che raggiungono un mese dopo. Dopo aver rischiato il naufragio sugli scogli dell'isola, ne esplorano la costa occidentale, all'epoca sconosciuta, quindi proseguono verso nord fino all'arcipelago dell'Ammiragliato (28 luglio). Nessuna traccia di La Perouse. Proseguendo verso nord, Entrecasteaux tocca diverse isole; l'unico scalo di una certa importanza è la Nuova Irlanda, dove La Billardiere e Riche fanno un abbondante bottino. Costeggiata la Nuova Guinea, mentre a bordo lo scorbuto miete diverse vittime, all'inizio di settembre le navi sono costrette a fare scalo a Ambon, principale colonia olandese delle Molucche. In questo angolo lontano dal mondo le notizie tardano mesi ad arrivare; nessuno sa che nel frattempo in Europa è scoppiata la guerra e Francia e Olanda sono nemiche. I francesi sono accolti generosamente, riforniti di vettovaglie, curati; i naturalisti - a cui tuttavia non è concesso di penetrare all'interno - devono accontentarsi dei lussureggianti giardini dei loro ospiti. La sosta dura oltre un mese e le tensioni latenti incominciano a emergere; La Billardière presenta all'ammiraglio una petizione, firmata dagli scienziati e da alcuni ufficiali,con la richiesta di essere parte in causa nella scelta della rotta e degli scali. Entrecasteaux rifiuta, minacciando di lasciare gli scienziati a Ambon; a sua volta La Billardière lo minaccia di sottoporre l'affare all'Assemblea nazionale... Il caso sembra chiuso, ma in realtà tra i due partiti - monarchici e repubblicani - si sta scavando un solco; gli scienziati mettono al bando Delahaye, che non aveva firmato la petizione, mentre per il motivo opposto gli ufficiali Willaumez, Gicquel e Legrand sono esclusi dallo stato maggiore. Partita da Ambon il 13 ottobre, la spedizione passa al largo di Timor, quindi si spinge in avanti nell'Oceano Indiano, per poi tornare verso est, a nord dell'attuale città di Perth. Dopo una tempesta che rischia di gettare i due vascelli sugli scogli, si salvano attraccando in una baia prontamente ribattezzata Espérance. Agli scienziati è concesso di scendere a terra, esclusi La Billardiere e Ventenat che sono agli arresti per aver protestato contro la decisione di Entrecasteux di non esplorare la costa occidentale dell'Australia. Preso dall'entusiasmo, Riche si spinge troppo all'interno e si perde; dopo cinque giorni di assenza, l'ammiraglio decide che, se non sarà ritrovato entro ventiquattro ore, le navi partiranno senza di lui. La Billadière riesce a strappare un rinvio di 48 ore: può così scendere a terra e cercare di salvare l'amico. Riche verrà ritrovato esausto sul piccolo capo che da quel momento porta il suo nome. Il 17 dicembre si riparte in direzione sud, completando il periplo dell'Australia, di cui Beautemps-Baupré rileva con precisione la costa meridionale. Il 20 gennaio 1793 sono di nuovo in Tasmania, dove Delahaye ritrova il suo orto in pessimo stato. Ignorando che il 21 gennaio Luigi XVI è stato ghigliottinato, i nostri naturalisti si danno alla pazza gioia; divisi in tre équipes, dirette rispettivamente da La Billardière, Ventenat e Riche esplorano a fondo il territorio, fanno ricche raccolte, entrano in contatto amichevole con gli aborigeni che Piron ritrae nei suoi disegni. Il mozzo dodicenne Gabriel Abelen dice a Ventenat di aver visto lungo il fiume Huon uno strano animale con il pelo di lontra, il becco d'anitra, la coda di castoro; nessuno gli crede: l'ornitorinco dovrà aspettare altri cinquant'anni per essere scoperto. Il 14 febbraio si riparte, in direzione Nuova Zelanda; La Billardière e Riche insistono per uno scalo che permetta di ritrovare Phormium tenax, una pianta descritta da Banks e Forster, che ritengono molto utile per fabbricare cordami. La risposta di Entrecasteuax già la immaginate: i due botanici giacobini finiscono un'altra volta ai ferri. Possono invece sbarcare a Tongatapu, l'isola principale delle Tonga. All'inizio sono accolti con danze e festini erotici, ma poi l'atmosfera si guasta, finché, temendo un agguato, i francesi lasciano l'isola dopo due settimane, non senza aver caricato duecento alberi del pane che La Billardière e Delahaye, secondo gli ordini ricevuti a Parigi, intendono importare a Mauritius. Di isola in isola continuano a risalire a nord, finché ad aprile toccano la Nuova Caledonia, dove sono favorevolmente accolti dagli indigeni antropofagi e La Billardière può arricchire la sua collezione di piante. Lo scorbuto fa una vittima illustre: Huon de Kermadec, comandante in seconda della spedizione e capitano dell'Espérance. Ripreso il viaggio, nell'isola Sainte-Croix un marinaio è ucciso con una freccia da un indigeno. L'area è pericolosa e, senza fermarsi, la flotta passa al largo dell'isola di Vanikoro, ignara che proprio lì aveva fatto naufragio La Pérouse. Nei mesi successivi, errano nel clima malsano delle isole della Melanesia. Le condizioni sanitarie diventano sempre più difficili. Il 20 luglio, al largo di alcuni isolotti detti degli Anacoreti, muore anche l'ammiraglio Entrecasteaux. Il comando è assunto da Alexandre d'Hesmivy d'Auribeau, che si ammala a sua volta; mentre diversi marinai muoiono di dissenteria, il giovane luogotenente Elisabeth Rossel fatica ad imporre la disciplina a un equipaggio sempre più recalcitrante. Guarito, Auribeau riprende il comando effettivo; dopo due scali nelle isole di Buru e Bouton, gettano infine l'ancora a Madura, all'entrata del canale che porta a Surabaya, nell'isola di Giava.  Epilogo: nostoi Passano giorni incerti. Un primo emissario inviato a terra non fa ritorno; un secondo torna con una scorta di soldati olandesi; dopo una breve riunione, Auribeau annuncia ai suoi uomini che sono in guerra con l'Olanda e devono considerarsi prigionieri. E' concesso di sbarcare solo ai malati e ai medici (dunque tra loro anche La Billardière, Riche e il medico capo Roussillon, a sua volta botanico) che organizzano un ospedale di fortuna. Solo in questo momento, scoprono che cosa è successo in Francia durante la loro assenza. Nella confusione generale, il governatore di Surabaya permette addirittura ai naturalisti (La Billardière, Riche, Ventenant, Deschamps, Delahaye) di continuare le loro ricerche, non sappiamo se da soli o in gruppo. Gli olandesi considerano le due navi preda di guerra; nonostante ciò, Auribeau cerca di venderle al miglior offerente; gli ufficiali repubblicani Du Portail, Willaumez e Gicquel progettano di fuggire con le navi alla volta di Mauritius. Presumbilmente in combutta con Auribeau, Chateauviux, un emigrato provenziale come lui che si è arruolato sotto bandiera olandese, prende d'assalto le navi; mentre gli ufficiali repubblicani e una parte dell'equipaggio cercano di resistere, Auribeau ammaina il tricolore e innalza la bandiera bianca con i gigli, consegnando i vascelli agli olandesi. Denunciati come sovversivi gli ufficiali Laignel, Legrand, Willaumez, i naturalisti Riche, Ventenat, La Billardière, il pittore Piron vengono posti agli arresti. I diari, le raccolte naturalistiche, le carte e i rilievi di Beautemps-Beaupré sono requisiti come preda di guerra. Tra i naturalisti due soli scampano: Louis Auguste Deschamps e il giardiniere Delahaye. Il primo lo incontreremo di nuovo in un altro post. Quanto al secondo, i suoi rapporti con La Billardière rimangono ambigui; nel suo giornale di viaggio, quest'ultimo afferma di avergli affidato parte dei suoi materiali e sicuramente la custodia dei dieci alberi del pane sopravvissuti al viaggio, che l'abile giardiniere riesce a mantenere in salute e a moltiplicare per margotta, portandoli poi con sé a Mauritius, dove li trapianterà con successo. Rientrato in Francia nel settembre 1797, diventerà giardiniere della Mailmaison, al servizio dell'Imperatrice Giuseppina. Ma torniamo ai nostri naturalisti prigionieri. Insieme a una trentina di marinai "sanculotti", con una marcia di venti giorni attraverso la giungla sono condotti sotto scorta a Samarang, dove sono rinchiusi nella fortezza. Ventenat, che è stato trasportato in barella dagli amici, è alloggiato presso un medico della città. Più tardi, quasi tutti saranno trasferiti a Batavia, mentre a Samarang rimangono solo Piron e La Billardière. Nel famigerato clima di Batavia, muoiono in molti (compreso l'ultra realista Auribeau). Nel luglio 1794, grazie a uno scambio di prigionieri, a un primo gruppo è concesso di imbarcarsi per Mauritius; tra di loro Riche (anche su di lui tornerò con un post apposito) e Ventenat, che muore poco dopo l'arrivo nell'isola. La Billardière dovrà invece attendere la libertà fino al marzo 1795. Oscura è la sorte di Piron, che in ogni caso non tornò mai in Francia; sicuramente fu al lungo insieme a La Billardière, che portò con sé in Francia alcuni dei suoi disegni. Al nostro eroe, più ancora della prigionia, pesa di essere stato privato del frutto di tante fatiche. La sua ricca collezione di piante, minerali, insetti a un certo punto viene consegnata dagli olandesi a Rossel, l'ultimo capo nominale della spedizione che le porta con sé nell'ottobre 1794 quando si imbarca su una nave olandese alla volta dell'Europa; a sua insaputa, nel frattempo in Olanda è stata instaurata la repubblica batava, alleata dei francesi, Nelle acque dell'Atlantico, la nave "nemica" è dunque abbordata e catturata dai britannici. Rossel e compagni finiscono agli arresti, mentre le casse di La Billardière, preda di guerra, vengono portate a Londra. Secondo Rossel, appartengono al legittimo re di Francia, ovvero Luigi XVIII, al momento in esilio in Inghilterra; quest'ultimo, diplomaticamente, le dona alla regina Carlotta. Ma nel frattempo La Billardière è tornato in Francia e non è disposto ad accettare il fatto compiuto. Con l'appoggio del direttorio, scrive a Banks, di cui era stato ospite in gioventù al tempo dei suoi studi londinesi, perché usi tutta la sua influenza per convincere il governo britannico che quel dono è illegittimo e l'unico proprietario di quelle collezioni è colui che per raccoglierle ha rischiato la vita. Per una volta, la ragioni della scienza hanno la meglio su quelle della politica, e le casse di La Billardière prendono la via di Parigi, mentre Banks giura che a quel materiale, pur desiderandolo, non ha dato neppure un'occhiata e non si è appropriato né di un fiore né di una foglia. Per La Billardière (anzi, per il cittadino Labillardière, come ora si firma), dopo il viaggi e la prigionia, è arrivata l'ora dello studio e della scrittura. Nel 1799 pubblica Relation du voyage à la recherche de La Pérouse che tradotto in più lingue diventa un best-seller internazionale. Illustrati con 26 tavole di ritratti e paesaggi di Piron, 3 tavole di uccelli di Audebert e 14 tavole botaniche di Redouté, i suoi due volumi hanno un valore pionieristico per la conoscenza dell'etnografia della Tasmania e della Nuova Caledonia, nonché della flora e della fauna della Tasmania e dell'Australia occidentale. Tra le piante pubblicate per la prima volta, Eucaluptus cornuta e E. globulus, Banksia nivea e B. repens, Anigoxanthus rufus e Chorizema ilicifolia. Tra il 1804 e il 1806 è la volta di Novae Hollandiae plantarum specimen, un'ampia descrizione della flora australiana, in cui La Billardière dà conto, oltre della propria collezione, anche delle raccolte di Riche e della spedizione Baudin (1800-2); include 256 disegni, alcuni dei quali ancora di Redouté. Si tratta dell'opera più ampia sulla flora australiana prima del Prodromus di Robert Brown (1810). Tra le piante descritte per la prima volta, la carnivora Cephalotus folicularis, Adenanthos obovatus, Cahnia trifida per la costa meridionale; Adenanthos, Calytrix, Astartea fascicularis, Hakea clavata, Taxandra marginata, Acacia saligna per l'Australia sudoccidentale; Eucryphia lucida e Phyllocladus aspeleniifolius per la Tasmania. Talvolta criticata per una certa confusione nelle localizzazioni e per aver incluso piante raccolte da altri botanici senza dichiararne la provenienza, l'opera fu tuttavia lodata per l'eleganza del latino e l'accuratezza delle descrizioni. Come sempre, una sintesi della vita di La Billardière nella sezione biografie.  Le campanelline e le bacche di Billardiera Quasi profetica del grande ruolo di La Billardière per la conoscenza della flora australiana fu la dedica del genere Billardiera da parte di James Edward Smith in A Specimen of the Botany of New Holland, pubblicato nel 1793, quando il nostro ancora navigava ignaro nelle acque australi. Altri generi omonimi, quindi non validi, gli furono dedicati da Moench nel 1794 e Vahl nel 1796. Molto opportunamente, questo genere della famiglia Pittosporacea è endemico dell'Australia, soprattutto delle zone esplorate da La Billardière. Comprende una ventina di arbusti e rampicanti legnosi diffusi in macchie e boschi aperti delle regioni temperate, in particolare in Tasmania e nell'Australia sudoccidentale. Molte specie sono di notevole valore ornamentale come rampicanti leggere, per i fiori a campanella aperta e le bacche solitamente eduli dai colori talvolta sgargianti; tra le più notevoli, la specie tipo, la comune B. scandens, che può essere coltivata come rampicante, tappezzante o alberello, con fiori verdastri, rosati o viola e frutti elissoidali verde oliva, quindi gialli a maturazione; B. longiflora, con fiori verdastri a campana lunga e stretta, seguiti da smaglianti bacche viola; curiosamente a descriverla per primo fu lo stesso dedicatario, che l'aveva raccolta in Tasmania e la pubblicò nella sua opera sulla flora australiana. Ma sicuramente la palma della bellezza va a B. heterophylla, che fino al 2004 - quando il genere Sollya è confluito in Billardiera - era nota come Sollya heterophylla, nome con cui fu descritta da John Lindley nel 1831. E' un arbusto rampicante le cui foglie cambiano aspetto dallo stadio giovanile a quello adulto, caratterizzato da aeree cime di fiorellini a campana blu profondo, un colore insolito nei giardini. Fu introdotta in coltivazione nei paesi a clima mite almeno dalla seconda metà dell'Ottocento. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|






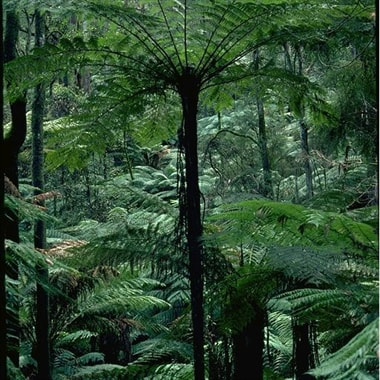



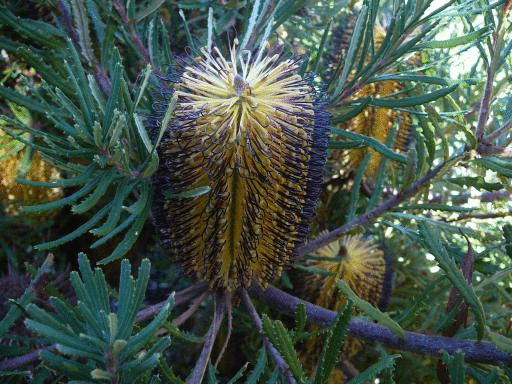





 RSS Feed
RSS Feed