|
Tra le migliaia di persone che, attratte dalla febbre dell'oro, attorno al 1850 si riversarono in California, c'era anche Hiram Green Bloomer. Della sua vita personale sappiamo poco, ma gli atti dell'Accademia delle scienze della California attestano che fu uno dei sette fondatori e poi me fu un membro molto attivo, rivestendo a lungo il ruolo di curatore del dipartimento di botanica. Fece raccolte sia in California sia in Nevada e, oltre a donare molti esemplari all'accademia, altri ne inviò per la determinazione ai botanici dell'East Cost. Diversi gli furono dedicati da Asa Gray e uno da Sereno Watson. Non amava scrivere, ma era un bibliofilo e collezionista di libri di botanica (non per sé, ma per la biblioteca dell'Accademia); amava invece coltivare le bulbose native, come quella bellissima dai fiori d'oro che l'amico Albert Kellogg vide per la prima volta fiorire nel suo giardino. Gliela dedicò e così nacque il genere Bloomeria (Asparagaceae). 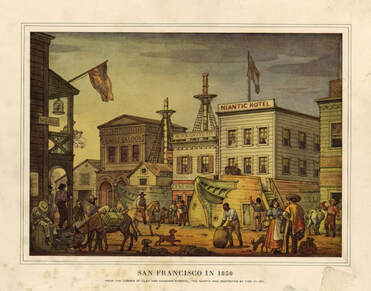 Dalla corsa dell'oro all'Accademia delle scienze Fino al 1846, là dove sarebbe sorta San Francisco, c'era un villaggio di meno di 300 abitanti chiamato Yerba buena (dal nome spagnolo di Clinopodium douglasii, abbondante in quest'area). Poi gli Stati Uniti strapparono al Messico la California (nel 1850 sarebbe diventata il 31 stato), Yerba buena divenne San Francisco, nel 1848 a Sutter's Mill venne scoperto l'oro; nell'arco di pochi anni 300.000 persone arrivarono qui da tutti gli Stati uniti e dall'estero in cerca di oro e fortuna. Tra di loro c'erano anche Hiram Green Bloomer (1821–1874) e la sua famiglia. Era nato a Marlborough nello stato di New York; non conosciamo molto della sua vita personale, ma sappiamo che aveva studiato al Newburgh College; era sposato e aveva già diversi figli. Nel 1849, all'età di 28 anni, tentò di raggiungere una prima volta la California ma a Panama, dove doveva imbarcarsi, si ammalò e fu costretto a tornare a casa. Arrivò a San Francisco probabilmente l'anno dopo e si inserì in fretta in quella città in tumultuosa crescita, divenendo un "cittadino a scartamento largo", come lo definisce Jepson, impegnato in molte attività civiche. Ad attrarlo in California non dovette essere solo l'oro, ma anche le piante, visto che già a Panama aveva fatto qualche raccolta. Entrò così in contatto con altri appassionati, tra cui il medico e farmacista Albert Kellogg. Nella serata del 4 aprile 1853, Kellogg e Bloomer si incontrarono con altre cinque persone in un ufficio di Montgmery Street: è l'atto di fondazione dell'Accademia delle Scienze della California, i cui scopi erano "una sistematica e accurata ricognizione di ogni porzione dello Stato e la raccolta di un gabinetto delle sue rare e ricche produzioni". Fino ad allora, ad interessarsi della ricca flora californiana erano stati da una parte i botanici delle spedizioni che vi fecero scalo tra il Settecento e la prima metà dell'Ottocento, come Menzies, il botanico della spedizione Vancouver che la visitò nel 1793, o raccoglitori venuti da lontano, come David Douglas che nel 1831 esplorò la California meridionale per incarico della Royal Horticultural Society. Kellogg e Bloomer furono tra i primi botanici residenti. Oltre alla passione per le piante, avevano in comune il talento artistico (del primo ci sono rimasti eccellenti disegni di piante, il secondo trasmise i primi rudimenti dell'arte al figlio Hiram Reynolds Bloomer, in seguito un noto pittore paesaggista) e la dedizione all'accademia, nella quale occuparono ruoli importanti. Kellogg fu il fondatore dell'erbario e il primo curatore del dipartimento di botanica, Bloomer, dopo essere stato segretario e redattore dei verbali dal 1854, fu curatore del dipartimento di botanica dal 1856 al 1866, infine direttore del museo, dal 1868 fino alla morte nel 1874. Kellogg e Bloomer erano amici e collaboratori, ma in una cosa si differenziavano totalmente: il primo era uno scrittore prolifico con all'attivo decine di articoli nei Proceedings dell'Accademia e in altre riviste, del secondo ci è noto sola un breve testo in cui difese la priorità degli studi di Kellogg sulla sequoia gigante di fronte alla pretese di Lindley di denominare quella gloria americana Wellingtonia gigantea. Jepson nel breve schizzo biografico che gli dedicò lo ha spiritosamente definito membro della "molto stimabile confraternita dei non-scrittori". Non scriveva, ma prendeva frequentemente la parola alle riunioni dell'accademia, spesso per presentare qualche libro o recenti pubblicazioni di botanica. Il non scrittore Bloomer era infatti un lettore e un bibliofilo: all'accademia donò in più occasioni non solo esemplari botanici da lui raccolti, ma anche libri; ci è rimasta una sua unica lettera a Torrey, in cui chiede informazioni sul prezzo e la reperibilità della sua Flora of New York e un aiuto per trovare testi botanici rari; quello che desiderava di più era Les Liliaceés di Redouté, anche di seconda mano. Le liliacee (ovvero le bulbose: ai suoi tempi ne facevano parte moltissime specie poi transitate in altre famiglie) erano la sua più grande passione e, come vedremo meglio tra poco, amava coltivare quelle native nel suo giardino. All'amore per le piante si deve anche la sua morte, a poco più di cinquant'anni: nel settembre 1874, con altri appassionati, partecipò a un viaggio di esplorazione nel Marin County; il gruppo si perdette e fu costretto a trascorrere la notte all'addiaccio. Per la fatica e l'esposizione agli elementi, Bloomer si ammalò e poco dopo morì.  Bloomeria, ovvero stelle d'oro Bloomer erborizzò in California e in Nevada; secondo la testimonianza del figlio Hiram Reynolds, creò un erbario di diverse migliaia di esemplari, accuratamente classificati ed etichettati, e circa un anno prima della morte lo donò all'Accademia; purtroppo è andato perduto, ma alcuni duplicati sono conservati in altre collezioni. La sua attività di raccoglitore è testimoniata da diverse dediche di botanici dell'East cost, che pure guardavano dall'alto in basso i "dilettanti" della California: da Sereno Watson, Ranunculus bloomeri (oggi Ranunculus orthorhynchus var. bloomeri), raccolto dal "Dr. J. (sic!) G. Bloomer in un fondo umido presso San Francisco", e da Asa Gray varie specie da lui raccolte a Virginia City e sul Monte Davidson in Nevada: Aster bloomeri (oggi Symphyotrichum campestre), Erigeron bloomeri, Haplopappus bloomeri (oggi Ericameria bloomeri), e Galium bloomeri (oggi Galium multiflorum), a proposito del quale Gray scrive:"[raccolto] nel territorio di Nevada presso Virginia City da Mr. H. G. Bloomer, al quale, come suo scopritore, ho il piacere di dedicare questa specie così ben caratterizzata". Fu invece un altro botanico attivo in California, Henry N. Bolander, a dedicargli Stipa bloomeri (oggi Eriocoma × bloomeri) per "commemorare i suoi servigi alla botanica di questa costa occidentale". Alla passione per le liliacee si deve una dedica in un certo senso "mancata" da parte dell'amico Kellogg. Prima del 1860 egli vide nel giardino di Bloomer "il giglio più magnifico della costa pacifica". Ne fu così impressionato che ne presentò un disegno (forse realizzato dallo stesso Bloomer) all'Accademia; tuttavia non lo pubblicò. Lo fece solo una dozzina di anni dopo, denominandolo Lilium bloomerianum. Troppo tardi: due anni prima la magnifica specie, raccolta in California da Benedikt Roezl e inviata in Europa, era stata validamente pubblicata come Lilium humboldtii, in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande esploratore-naturalista. Kellogg aveva comunque provveduto a immortalare l'amico con la dedica di una genere. Nella seduta del 18 luglio 1859 dell'Accademia delle scienze, egli presentò esemplari e disegni di due liliacee (sempre nel senso ampio impiegato all'epoca) raccolte a New Idria da John Allean Veatch e coltivate nel giardino di Bloomer. Non sappiamo se le avesse disegnate lo stesso Kellogg oppure Bloomer, entrambi eccellenti artisti. Ritenendole nuove per la scienza e non appartenenti ad alcun genere noto, Kellogg stabilì per lo loro due nuovi generi, battezzandole rispettivamente Veatchia crystallina e Bloomeria aurea. In realtà, la prima non era inedita: era stata pubblicata quasi trent'anni prima da Lindley come Hesperoscordum hyacinthinum; in seguito, fu riclassificata e oggi si chiama Triteleia hyacinthina; Veatchia è dunque sinonimo di Triteleia e la fama del perito, agrimensore e mineralogista Veatch rimane affidata alla scoperta di un vasto deposito di borace nel Lake County. Kellogg aveva invece visto giusto con Bloomeria: questo piccolo genere, di cui fu il primo a descrivere una specie, rimane valido e continua ad essere il più bell'omaggio al non-scrittore Hiram Green Bloomer. Come Brodiaea, Behria e Triteleia, fa parte della sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Le sue tre specie (Bloomeria clevelandii, B. crocea e B. humilis) sono native delle colline pedemontane aride della California e della Baja California, dove crescono in praterie, nei boschi aperti o nel chaparral. Come le loro sorelle, hanno cormi, foglie lineari e sottili steli culminanti con una infiorescenza a ombrella relativamente grande. Invece degli azzurri di Triteleia e Brodiaea e del rosso di Behria, i fiori di Bloomeria ostentano il più luminoso dei gialli. I singoli fiori sono piccoli, a stella (in inglese si chiamano Golden Stars), con lobi molti aperti, per lo più liberi (una caratteristica distintiva rispetto ai generi affini). Solitamente si coltiva la specie più diffusa, B. crocea. Si riproduce con facilità, è molto fiorifera e regala una lunga fioritura se coltivata al sole in terreno ben drenato. Dopo la fioritura, le foglie seccano e, poiché non è rustica e detesta l'umidità invernale, dove gli inverni sono freddi e umidi il modo migliore per coltivarla è ritirare i cormi d'autunno e conservarli in un luogo asciutto, ripiantandoli in primavera; si piantano invece in autunno dove gli inverni sono miti, a condizione da proteggerli tassativamente dalle piogge invernali.
0 Comments
Creato nel 1902, il Big Basin Redwoods State Park è il più antico della California. La sua nascita si deve alla battaglia di un gruppo di cittadini, con il sostegno dell'università di Stanford e del capo del suo dipartimento di botanica, William Russell Dudley, che ebbe un ruolo importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte di una delle meraviglie della natura, la sequoia della California (Sequoia sempervirens), che in meno di un secolo era stata portata alla soglia dell'estinzione dagli abbattimenti indiscriminati. Dudley era uno specialista di conifere e un appassionato raccoglitore; gli si deve la fondazione dell'erbario Dudley. A ricordarlo, il genere Dudleya, endemico dell'Oregon, della California e della Baja California. 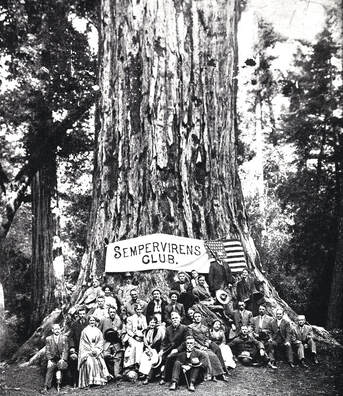 Salvare le sequoie Nell'ottobre 1899, un incendio scoppiò nei boschi delle Montagne di Santa Cruz presso Felton in California. Presto raggiunse le case di Wrights Station e l'azienda vinicola Mare Vista Winery; per scongiurare lo scoppio di un serbatoio di gas, il proprietario non esitò ad ordinare ai suoi dipendenti di estinguere le fiamme con 4000 galloni di vino rosé. Il fatto era abbastanza curioso da attirare l'attenzione della rivista inglese The Wide World Magazine che commissionò un articolo a C.F. Holder, presidente dell'accademia delle scienze della California, il quale chiese al noto fotografo e pittore californiano Andrew P. Hill di illustrarlo con le sue fotografie. Hill, oltre all'area devastata, per mostrare il contrasto, pensò di scattare qualche fotografia alle maestose sequoie (Sequoia sempervirens) secolari di un parco privato, il Welch’s Big Trees Grove (oggi parte dell'Henry Cowell State Park); aveva appena sistemato il suo cavalletto e scattato tre foto, quando arrivò l'infuriato proprietario che pretese i negativi, sostenendo che quelle foto avrebbero danneggiato la sua vendita di cartoline ai turisti. Hill ribatté che le fotografie erano per una rivista straniera e, anzi, sarebbero state un'ottima pubblicità. L'altro gli ripose piccato che la pubblicità non gli interessava, perché presto quegli alberi sarebbero diventati traversine ferroviarie e legna da ardere. La risposta sconvolse e indignò Hill: come, quella meraviglia della natura era destinata a perire? Da quel momento, salvare le sequoie della California divenne lo scopo della sua vita. Convinse due amici, l'avvocato e poeta di San Jose John E. Richard e la scrittrice Josephine Clifford McCrackin, che aveva perso la casa nell'incendio di Wrights Station, a denunciare la situazione sui giornali locali. Nel marzo 1900 McCrackin scrisse una lettera aperta al Sentinel di Santa Cruz intitolata "Salviamo gli alberi" che fu il primo atto pubblico della campagna. Il secondo fu una riunione convocata il 1 maggio 1900 da Hill e dal presidente dell'ateneo di Stanford David Starr Jordan nella biblioteca dell'Università, per discutere azioni concrete per salvare le sequoie. Durante la riunione emerse che i naturalisti dell'università avevano già individuato come area più adatta alla nascita di un parco naturale il Big Basin (molto più vasto e con alberi più grandi e antichi rispetto al bosco di Felton) e fu deciso di inviarvi in esplorazione un comitato, che includeva giornalisti, uomini d'affari e politici, presieduto da Hill e da Carrie Stevens Walter del San Jose Woman's Club. Due settimane dopo il gruppo visitò l'area e decise di costituirsi in associazione, denominata Sempervirens club dall'eponimo di Sequoia sempervirens, con un capitale iniziale di 32 dollari, raccolti facendo passare un cappello tra i presenti. Come presidente fu scelto l'avvocato di San Francisco Charles Wesley Reed, che contava diversi appoggi politici, affiancato da varie personalità più o meno eminenti come vicepresidenti onorari. A rappresentare la scienza, William Russell Dudley (1849-1911), capo del dipartimento di botanica sistematica di Stanford, che aveva partecipato al meeting del 1 maggio e da tempo denunciava i rischi di estinzione della sequoia della California. Dudley era cresciuto in una fattoria del Connecticut e fin da bambino si era innamorato della natura; ventunenne si iscrisse alla Cornell University, dove per qualche tempo si pagò gli studi mungendo le mucche della fattoria universitaria. Caso volle che suo compagno di stanza fosse David Starr Jordan che abbiamo già incontrato nelle vesti di presidente dell'università di Stanford; David divenne ittiologo, mentre Willie (come lo chiamavano in famiglia) scelse la botanica. Già prima di laurearsi fu lettore di botanica alla Cornell, che lo utilizzò anche come raccoglitore. Dopo essersi laureato nel 1876, si perfezionò per qualche tempo a Strasburgo e Berlino, dopo di che insegnò botanica alla Cornell fino al 1892, quando venne nominato a Stanford, dove prese servizio nell'autunno 1893, reclutato dall'amico Jordan che era appena stato scelto come presidente del neonato ateneo. Il dipartimento di botanica era tutto da inventare, non c'erano né strutture né laboratori, ma per Dudley, che fino ad allora si era occupato della flora degli Stati uniti orientali (i suoi principali lavori riguardavano le flore della contea di Cayuga, della contea di Lackawanna e del Wyoming) ogni fatica era ricompensata dalla ricchissima flora californiana. Il suo più grande amore divennero gli alberi, in particolare le conifere, di cui studiò le relazioni evolutive e la distribuzione geografica. Era facile incontrarlo con i suoi studenti in escursioni botaniche in varie parti dello stato, specialmente nella Sierra Nevada e nella Sierra Santa Lucia. Più conosceva la flora californiana, più crescevano le sue raccolte (oggi formano il nucleo principale del Dudley Herbarium dell'Università di Stanford) ma anche la consapevolezza della devastazione degli habitat naturali e la preoccupazione per gli alberi minacciati dalla speculazione. Nel 1892 fu uno dei primi membri del Sierra Club, una delle primissime associazioni ambientaliste, fondata da John Muir per proteggere la Sierra Nevada e i suoi boschi di sequoie giganti Sequoiodendron giganteum. Nel 1895, insieme allo stesso Muir e al geologo di Berkeley Joseph Le Conte, fu uno dei portavoce del club in un forum pubblico tenutosi a San Francisco sul tema "Parchi nazionali e riserve forestali", in cui sostenne che bisognava cessare di cedere a privati le terre demaniali, che andavano invece convertite in parchi nazionali. In un articolo pubblicato sul bollettino del Sierra club tra la fine del 1895 e l'inizio del 1896, riferì che le sue indagini sul campo dimostravano che i due milioni di acri di sequoie che un tempo si estendevano per cinquecento miglia lungo le colline costiere dell'Oregon e della California stavano scomparendo a un ritmo tale che l'antica specie rischiava l'estinzione. Insieme a un collega di Stanford, il docente di ingegneria civile Charles Wing, visitò e mappò l'area del Big Basin, scoprendo che i migliori boschi di sequoie erano stati venduti a compagnie di legname e decimati. L'unico modo per salvarli era acquistare i boschi e trasformarli in un parco statale, e l'area più adatta era proprio il Big Basin, che la distanza dalla ferrovia e le peculiarità topografiche avevano preservato pressoché intatto; tuttavia, i boscaioli avevano già iniziato il loro lavoro e, se non venivano fermati, scrisse in un articolo pubblicato nel marzo 1900, entro due anni "la regione, invece di un Eden, diventerà peggio del Sahara". Nella fatidica riunione del maggio 1900 nella biblioteca di Stanford, l'indignazione di Hill e la competenza di Dudley si incontrarono. Tra l'estate e l'autunno la campagna per salvare le sequoie del Big Basin prese il volo, con ogni membro del club impegnato a suo modo per smuovere l'opinione pubblica, coinvolgere altre associazioni, arruolare politici e convincere gli industriali che i turisti attirati dal parco avrebbero portato più soldi dello sfruttamento del legname. L'argomentazione fece breccia almeno su Henry L. Middleton che si dichiarò disposto a vendere i 14000 acri che la sua compagnia possedeva nel Big Basin offrendone al club l'opzione di acquisto per un anno. Dudley, che da tempo era membro dell'American Forestry Association, fece da tramite con il servizio forestale nazionale e ottenne l'appoggio del suo capo, Gifford Pinchot. Reed scrisse una proposta di legge per l'istituzione di un parco statale che nel gennaio 1901 fu presentata all'Assemblea dello Stato della California da un politico amico; respinta nella forma iniziale, che prevedeva lo stanziamento di 500.000 dollari per l'acquisto di 5000 acri, fu approvata quando venne ridotta a 250.000 dollari e a 2500 acri. Era una grandissima delusione per il Sempervirens club che puntava su un grande parco da 35.000 a 60.000 acri; anche Dudley riteneva che "per gli scopi scientifici, e anche per un buon parco pubblico" il minimo fossero 35.000 acri. L'istituzione del California Redwood Park (dal 1927 avrebbe mutato nome in Big Basin Redwoods State Park) venne approvata dal senato con voto quasi unanime nel marzo 1901. Per presiedere alla sua realizzazione, venne creata una commissione, formata dal governatore e da quattro membri di sua nomina, tra cui il professor Dudley, che ne fu il segretario fino allo scioglimento nel 1905. Finalmente, nel settembre 1902, con l'acquisto di 2500 acri di foresta, più 800 acri di chaparral e 500 acri di terreno da riforestare donati da Middleton, il parco divenne realtà. Molto più piccolo di quanto sperato, era comunque un inizio, nonché il primo dei circa 280 tra parchi statali e riserve naturali che oggi esistono in California. Il Sempervirens Club non si sciolse, ma continuò la sua battaglia per estenderne i limiti. Negli anni successivi arrivarono piccole donazioni di altri terreni e nel 1916 il parco incorporò quasi 4000 acri convertiti da terre federali, estendendosi così fino alla costa. Oggi la sua estensione è di 10,800 acri (44 Km2). Oltre ad ospitare il più grande gruppo di Sequoia sempervirens a sud di San Francisco, include una varietà di ambienti che vanno dalle foreste miste di sequoie, altre conifere e querce al chaparral, ai canyon umidi, alla vegetazione costiera, estendendosi dal livello del mare a circa 600 metri di altitudine. Purtroppo nell'agosto 2020 è stato catastroficamente investito dagli incendi che hanno devastato la California settentrionale; sono andate distrutte tutte le strutture del parco e almeno 15.000 alberi, principalmente abeti di Douglas. Anche alcune sequoie sono cadute, ma la maggior parte di quelle più antiche sono rimaste in piedi. Dopo essere rimasto chiuso per due anni, oggi il parco è di nuovo aperto, sebbene in modo limitato. Il paesaggio ha mutato volto ma, secondo gli esperti sta lentamente recuperando. La maggior parte delle sequoie è sopravvissuta, e dai tronchi anneriti dall'incendio stanno rispuntando ciuffi di fogliame. Non è certo la prima volta che questi antichi giganti affrontano il fuoco: si sono evoluti con gli incendi e si riprendono molto più facilmente di altre specie, grazie alla corteccia spessa più di 30 cm che protegge gli strati più interni dal fuoco, ai tannini che proteggono le eventuali ferite dagli attacchi di funghi e insetti, alle gemme dormienti sia alla base sia lungo il tronco e i rami che permettono loro sia di emettere germogli basali sia di rigermogliare dai rami e dallo stesso tronco.  Perché i botanici cambiano i nomi: il caso di Dudleya Ma è ora di ritornare al prof. Dudley che tanto fece per far nascere il parco. Anche negli anni successivi continuò ad impegnarsi nelle battaglie ambientaliste. Nel 1904, insieme all'amico Jordan e alla botanica Alice Eastwood, partecipò a una manifestazione indetta a San Francisco dal California Club per bloccare la vendita di 1000 acri di foresta contenenti antiche sequoie ai piedi del Monte Tamalpais. Era un insegnante innamorato della sua materia e amato dagli studenti e nei suoi 18 anni di insegnamento a Stanford formò intere generazioni di eccellenti botanici; era uno studioso coscienzioso, ma forse fin troppo autocritico e forse per questo le sue pubblicazioni californiane si limitano ai numerosi articoli, dedicati soprattutto alle foreste e agli alberi della California, che egli pubblicò tra il 1889 e il 1910 sul Bollettino del Sierra Club e su The Forester, la rivista dell'American Forestry Association. Progettò a lungo un lavoro complessivo sulle conifere degli Stati Uniti occidentali, ma il progetto non andò mai oltre lo stadio di manoscritto incompleto. Nel 1908 andò Persia per esplorarne le foreste; in Egitto contrasse una grave bronchite che degenerò in tubercolosi, che nel 1910 lo costrinse a lasciare l'insegnamento e nel 1911 lo portò alla morte. Grande esploratore della flora californiana, è ricordato dall'eponimo di vari funghi (fu anche micologo) e di piante come gli endemismi Triteleya dudleyi, Pedicularis dudleyi e Polystichum dudleyi. Nel 1903 Britton e Rose gli dedicarono il genere Dudleya, endemico di ambienti rocciosi lungo la costa pacifica, dall'Oregon meridionale alla Baja California settentrionale, con una laconica nota: "Nominato in onore del prof. William R. Dudley della Stanford University". Questo genere di una cinquantina di piante succulente della famiglia Crassulaceae è caratterizzato da una grande varietà morfologica (dalle piccole geofite decidue alte pochi cm alle grandi sempreverdi con rosette di 50 cm di diametro), con fiori a stella simili a quelli di Sedum, oppure tubolari o amcora pendenti e campanuliformi come quelli di Echeveria. Solo recentemente tanta varietà è stata ricondotta a un unico genere, mentre i primi botanici che si occuparono di queste piante le attribuirono variamente ai generi Echeveria, Cotyledon e Sedum. Queste incertezze sono perfettamente testimoniate da Dudleya cespitosa, una geofita tuberosa endemica della California meridionale, la prima ad essere descritta. Nel 1803 Haworth la pubblicò come Cotyledon cespitosum, mentre nel 1811 von Jacquin la classificò come Sedum cotyledon e Aiton come Cotyledon linguiformis. Altre due specie, Dudleya pulverulenta e D. lanceolata, furono invece pubblicate nel 1840 da Nuttall come Echeveria pulverulenta e E. lanceolata. All'inizio del Novecento una vera rivoluzione fu attuata da Nelson e Rose che sistemarono questo gruppo di piante in ben tre nuovi generi: Dudleya, cui attribuirono una sessantina di specie, 40 delle quali descritte da loro per la prima volta, Stylophyllum con 12 specie, e Hasseanthus con 4 specie. Negli anni '30, Alwin Berger li ritenne tutti e tre superflui, spostando Dudleya e Stylophyllum in Echeveria e Hasseanthus in Sedum, i due generi da cui riteneva si fossero rispettivamente evoluti. Le sue conclusioni furono largamente accettate dai botanici fino alla metà del Novecento, quando incominciarono ad apparire le prime analisi filogenetiche molecolari. Nel 1942, Reid Moran separò nuovamente Dudleya e Stylophyllum da Echeveria, riunendoli in Dudleya come sottogeneri; mantenne Hasseanthus come genere distinto, ma strettamente imparentato. Fu il punto di partenza delle ricerche successive che hanno dimostrato che Dudleya si è evoluto in epoca relativamente recente (5 milioni di anni fa) da Sedum, non da Echeveria, come si riteneva in precedenza, e va assegnato alla tribù Sedoideae. Anche se rimangono molti punti da chiarire, oggi al variabile genere Dudleya sono assegnate circa 50 specie, divise in tre sottogeneri: Dudleya (Eududleya secondo la terminologia di Moran), caratterizzato da rosette di foglie appiattite e fiori con petali saldati in un tubo; Stylophyllum, caratterizzato da foglie strette che assomigliano a dita o più raramente da foglie piatte, e petali non fusi che si allargano al centro; Hasseanthus, caratterizzato da cormi sotterranei, piccole foglie che cadono dopo la fioritura, fiori ampiamenti diffusi. Le Dudleya in genere si presentano come succulente da piccole a grandi con foglie carnose, in alcune specie appiattite, in altre tubolari, in altre ancora orbicolari, riunite a rosetta; in diverse specie sono ricoperte da un rivestimento ceroso, detto farina, generalmente bianco, gessoso o farinoso; in poche specie a proteggere le piante dal sole è un sottile strato oleoso e appiccicoso. Il colore del fogliame varia dal verde al grigio. Le rosette possono essere solitarie o cespitose, con diverse rosette che partono da un caudex centrale. Mentre, ad eccezione delle specie più grandi, nel resto dell'anno rimangono piuttosto nascoste nelle fessure delle rocce che sono il loro habitat tipico, al momento della fioritura al centro delle rosette emergono uno o più robusti gambi carnosi che in genere si dividono all'apice in divesri rami, ciascuno dei quali portano 10-15 piccoli fiori (o più) comunemente bianchi o gialli, ma anche rosa, arancio o rossi. Nelle specie di maggiori dimensioni, come D. brittonii (non ha caso nota come "giant Dudleya"), la rosetta raggiunge i 50 cm di diametro e l'infiorescenza può arrivare anche a un'ottantina di cm, mentre nelle minuscole specie del sottogenere Hasseanthus come D. brevifolia le foglie rimangono quasi sepolte nella terra e il peduncolo florale non supera i 4 cm. A differenza di Echeveria, con il quale è ancora spesso confuso, Dudleya non è ancora largamente coltivato, ma purtroppo ha attirato fin troppo l'attenzione dei collezionisti: uno dei pericoli maggiori per la sopravvivenza di molte specie, endemiche di aree piuttosto ristrette, è la raccolta indiscriminata in natura di quelle più rare, che vendono vendute a carissimo prezzo soprattutto sul mercato asiatico. Una recente legge ha introdotto una multa di 5000 dollari per ogni esemplare di Dudleya raccolto su suolo pubblico, che salgono a 40.000 alla seconda infrazione. A minacciare le Dudleya sono anche l'espansione degli ambienti urbani e sempre più i cambiamenti climatici, ed in particolare la siccità invernale: ad differenza di altre succulente, sono per lo più originarie di aree con piogge invernali, che è anche la stagione del loro massimo rigoglio, mentre l'estate, quando la temperatura supera i 30°, è la stagione del riposo. La dedica del piccolo genere Amsonia (famiglia Apocynaceae) è un vero rebus. Chi era il misterioso Mr. Amson al quale fu dedicato da uno dei primi raccoglitori e studiosi della flora della Virginia, John Clayton? Qual era il suo nome completo? Già se lo chiedeva Solander e da allora, anziché chiarirsi, da un botanico all'altro, da un'enciclopedia a un dizionario etimologico, il mistero non ha fatto che aggrovigliarsi sempre più, come nel gioco del telefono senza fili. 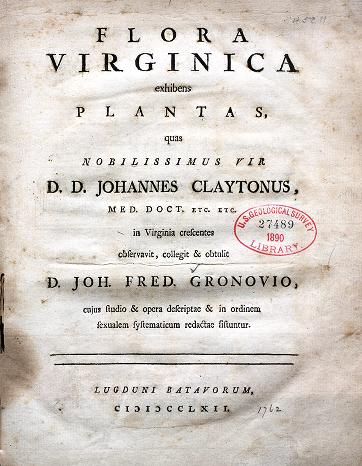 Viaggiatore, ammiraglio, medico? Amsonia tabernaemontana è una graziosa perenne dai fiori azzurri a stella piuttosto diffusa nel sottobosco delle foreste degli Stati Uniti sud-orientali, dove è nota come Eastern bluestar, "stella azzurra orientale". Il primo botanico a raccoglierla e descriverla fu probabilmente John Clayton che nel 1739 la incluse nella sua Flora virginica; all'epoca riteneva si trattasse di una specie di oleandro (in effetti appartengono alla stessa famiglia, le Apocynaceae) e la descrisse come "Anonymus suffrutex foliis Salicis alternis [...] Nerii species" (un suffrutice anonimo con foglie di salice alternate, una specie di oleandro). Più tardi capì che apparteneva a un genere a sé e nel manoscritto (purtroppo perduto) di un'ampliata Flora che aveva inviò a Peter Collinson nel 1757 lo chiamò Amsonia. Inviò in Inghilterra anche semi e la pianta divenne subito popolare tra i suoi amici: oltre a Collinson, la coltivavano Philip Miller al Chelsea Physic Garden e James Gordon nel suo vivaio di Mile End. In quei giardini la notò Solander, che ne scrisse a Linneo nel 1761, aggiungendo che Clayton l'aveva chiamata Amsonia, ma lui non sapeva a chi si riferisse, né lo sapeva nessun dei botanici che aveva interpellato; supponeva dunque che "Clayton l'avesse nominata per qualcuno in Nord America". L'anno dopo il pittore Dyonisius Ehret, che era stato incaricato di preparare le illustrazioni per l'opera di Clayton (purtroppo non si trovò mai un editore e rimase inedita) ne inviò uno schizzo a Linneo, che pubblicò la nuova specie nella seconda edizione di Species plantarum, assegnandola al genere Tabernaemontana con il nome T. amsonia. Infine, nel 1788 il botanico americano Thomas Walter in Flora Caroliniana istituì il genere Amsonia e ribattezzò questa specie A. tabernaemontana invertendo il binomio linneano, senza fornire indicazioni sull'origine dell'eponimo. A questo punto, come direbbe Snoopy, il mistero incomincia ad infittirsi. Nel 1782 in Supplementum plantarum il figlio di Linneo creò un genere dal nome molto simile, Amasonia (è tuttora valido e raggruppa sette specie di Lamiaceae neotropicali) "in memoria di Amason, un viaggiatore americano". Al quale nel 1810 Alexandre de Théis in Glossaire de botanique, regalò un nome di battesimo: "Thomas Amason, viaggiatore in America". La somiglianza tra le due denominazioni intrigò James Edward Smith che nell'articolo "Tabernaemontana" della Cyclopaedia di Rees (1819) ipotizzò che il dedicatario di entrambi fosse la stessa persona: forse il figlio di Linneo aveva aggiunto quella a suggestionato dal nome svedese del Rio delle Amazzoni, Amasona. Pur scrivendo prudentemente che era impossibile risalire all'origine del nome, tranne che si doveva a Clayton, avanzò comunque un'ipotesi: probabilmente il nome era stato scritto scorrettamente e il dedicatario era l'ammiraglio inglese George Anson, primo barone Anson. Ipotesi fatta propria da Rafinesque che in New flora of North America (1838) corresse senz'altro il nome in Ansonia. Nel frattempo il misterioso Amson aveva già assunto una terza identità, grazie al celebre architetto paesaggista Loudon che in Hortus britannicus (1830) scrisse che il genere prendeva il nome da "Charles Amason, un viaggiatore americano". Nel Pocket Botanical Dictionary Paxton (1840) recuperò il cognome originario Amson, fissando la vulgata che resisterà per un secolo e mezzo, arricchendosi via via di particolari. Nel 1856 nella seconda edizione del suo manuale, Asa Grey, scettico e prudente, scriveva: "si dice sia stato denominato per un certo Mr. Charles Amson". Nel 1861 in A class book of botany Wood aggiunse con tanto di punto interrogativo: "Dedicato a Charles Amson, del S. Carolina?", ipotesi forse suggerita dal fatto che le attività botaniche di Walter, l'autore del nome, si svolsero in questo stato. I dubbi scompaiono per Britton e Brown (An illustrated flora of United States [...], 1896): "per Charles Amson del South Carolina". Su questa strada li seguirono praticamente tutte le successive pubblicazioni statunitensi, I primi dubbi furono espressi nel 1928 da Woodson in una monografia sul genere Amsonia. Consultando enciclopedie, testi di riferimento e le società storiche delle Caroline e della Virginia, egli non trovò nessuna evidenza che un qualche Charles Amson fosse vissuto o avesse viaggiato in queste regioni nel periodo coloniale o avesse contribuito in qualche modo alla scienza botanica. In una lettera di Clayton a Bartram datata 1 settembre 1760 trovò invece un riferimento diretto all'eponimo; Clayton ricordava infatti di aver proposto il nome Amsonia "per un dottore di qui". Woodson ne inferì che il genere doveva essere stato dedicato a "un medico della Gloucester County, Virginia"; quanto al nome di battesimo, o anche all'esatta grafia del cognome, i dubbi rimanevano. I dubbi non vennero considerati, mentre i nuovi dati raccolti da Woodson andarono a combinarsi con i pezzi precedenti della storia. La biografia di Mr. Amson era ormai completa, così come la troviamo in innumerevoli pubblicazioni. Tanto per fare qualche esempio di testi autorevoli e recenti: Gledhill, The names of plants (2008): "per Charles Amson, medico della Virginia del XVIII secolo e viaggiatore in America"; Genaust, Etymologisches Wörterbuch der botanischen Planzennamen (2014): "Nome di Walter (1788) per Charles Amson, botanico americano, sul quale l'autore non dice nulla"; e ancora la seconda edizione dell'Indice dei nomi eponimici delle piante di Lotte Burkhardt (2018) : "Charles Amson (XVIII sec.) medico e botanico americano, visse nella contea di Gloucester in Virginia, viaggiò e potrebbe essere l'autore di una Flora del South Carolina, amico di John Clayton".  Mistero risolto? A dimostrare che questa biografia è fittizia e che l'identità del dottor Charles Amson è stato creata pezzo per pezzo come nel gioco del telefono senza fili combinando Linneo figlio, Alexandre de Théis, Loudon, Paxton, Wood e Woodson, è stato nel 2004 il botanico canadese James S. Pringle, nell'articolo History and eponimy of the genus name Amsonia (Apocynaceae), SIDA, n. 21. Potendo sfruttare gli strumenti della rete, ha confermato ciò che già aveva intuito Woodson: non si trova alcuna traccia né di un viaggiatore di nome Amson (o magari Amason) né del dottor Charles Amason della Contea di Gloucester. Invece, come avevano già scoperto i biografi di Clayton e John Bartram Edmund e Dorothy Berkeley, c'era un dottor John Amson che viveva sì in Virginia, ma a Williamsburg; già i Berkeley lo ritenevano il vero dedicatario di Amsonia: scrivendo a Bartram, che abitava nella lontana Pennsylania, con l'espressione "di qui" Clayton non intendeva strettamente la contea dove lui stesso viveva e lavorava, ma più in generale la regione, tanto più che Williamsburg ne distava poche miglia, vi era vissuto da giovane e aveva una parte della famiglia. Scavando nei documenti, Pringle è anche riuscito a ricostruire la biografia di John Amson; potrebbe essere nato a Londra nel 1698 (non c'è però certezza che non si tratti di un omonimo) e essersi laureato a Reims in Francia nel 1722. Non si sa quando sia giunto in America: certamente era in Virginia nel 1738, quando prese in prestito e restituì un volume della biblioteca di un certo Dr. Brown di Williamsburg. Nel 1746 acquistò da un parente del naturalista Mark Catesby (amico di Clayton) due lotti che includevano certamente un'abitazione dove stabilì la sua residenza. Intorno al 1751 acquistò un terreno fuori città dove presumibilmente aveva una fattoria o una piantagione, visto che da un altro documento sappiamo che possedeva degli schiavi. Almeno dal 1746 fu assessore e tra il 1750 e 1751 sindaco della città. Come medico era molto stimato. Nel 1758 George Washington, all'epoca colonnello della milizia, si ammalò; temeva di aver contratto la tisi e dalla sua casa di Mount Vernon si spostò a Williamsburg per consultare i migliori medici; tra di loro Amson che lo rassicurò: si trattava solo di un'infreddatura. Tra i pazienti di Amson c'era anche Daniel Parker Custis, il primo marito di Martha Washington. Sappiamo che il dottore possedeva un giardino, che fu visitato nel 1751 dal giurista John Blair. Non si conosce con esattezza la data della morte, che dovette intercorrere tra 1761 (data in cui risulta tra i creditori dell'erede di Custis) e il 1765 (data in cui una certa Anne Anderson, che potrebbe essere sua figlia o la sua vedova, risulta aver ereditato sei lotti a Williamsburg e una proprietà fuori città di 180 acri appartenuta al fu dr. Amson). Ci è rimasto anche uno scritto di sei pagine, pubblicato postumo (1766), che consiste nella prescrizione per la cura della pertosse e include una serie di ingredienti di origine vegetale. Come medico, ma anche come proprietario di un giardino e di una fattoria o una piantagione, avrà avuto conoscenza e interesse per le piante, ma non sappiamo di più; come non conosciamo quale fosse la sua relazione con Clayton e tanto meno le ragioni della dedica di Amsonia.  Azzurri fiori stellati Il piccolo genere Amsonia (Apocynaceae) raggruppa sedici specie di erbacee perenni o annuali con una distribuzione fortemente disgiunta; vivono tra gli Stati Uniti centrali e il Messico, ad eccezione di due specie: una europea, A. orientalis, presente in un'area ridotta della Turchia europea e della Grecia settentrionale; una dell'Asia orientale, A. elliptica. Caratteri distintivi del genere sono radici rizomatose legnose, fusti eretti che contengono un latice irritante e tossico, foglie alternate decidue da lanceolate a lineari, fiori azzurri o bianchi tinti d'azzurro raccolti in cime terminali tirsoidi o corimbose, con lungo tubo corollino e cinque lobi più o meno stretti, simili a petali disposti a stella, da cui il nome comune inglese bluestar. Come molti membri di questa famiglia, contengono alcaloidi e altri composti con proprietà soprattutto antimicrobiche. Sono però principalmente piante ornamentali molto apprezzate in giardino sia per il colore insolito dei fiori sia per la tendenza a formare ampi gruppi. La specie più coltivata è probabilmente proprio A. tabernaemontana; in natura vive nelle boscaglie aperte e nelle praterie dal Missouri al Texas e dal New Jersey alla Florida su suolo preferibilmente umido ma ben drenato. Il latice amaro e tossico la rende non appetibile agli erbivori, mentre i fiori attraggono molti tipi di insetti e anche colibrì. Di portamento compatto e cespuglioso, forma gruppi molto attraenti al momento della fioritura che avviene tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate; un secondo momento di interesse è l'autunno, quando le foglie prima di cadere si tingono di giallo. Simile è A. hubrichtii, che però ha fiori azzurro acciaio e foglie sottili e piumose con colori autunnali più vivi. A. tomentosa, originaria degli Stati Uniti sudoccidentali e del Messico settentrionale, si distingue per i fusti legnosi che possono raggiungere anche un metro d'altezza; se ne conoscono due forme: A. tomentosa var, stenophylla, con foglie glabre, e A. tomentosa var. tomentosa, con foglie ricoperte di un tomento lanoso; i fiori sono bianchi soffusi di verde, di blu o rosa. Presso il popolo Zuni le radici erano utilizzate contro il morso dei serpenti. L'unica specie europea, A. orientalis, molto rara e minacciata, vive in natura solo in un'area ristretta della Grecia nord-orientale e della Turchia europea; la comunità europea l'ha inclusa nelle lista delle specie da proteggere (dove compare con il sinonimo Rhazya orientalis ed è segnalata come "minacciata in modo critico"). E' anch'essa simile alle altre specie, ma ha foglie più grandi e fiorisce in piena estate; i fiori azzurri hanno tubo corollino più scuro e sepali più brevi e dal colore più vivido. L'unica specie asiatica, A. elliptica, meno rustica delle altre, è molto simile a A. tabernaemontana, ma ha portamento più aperto. Le foglie verde chiaro in autunno assumono tonalità dorate e rosate. E' una pianta medicinale con effetti antibatterici ed emolitici. Non è opportuno assumere una donna per questo scopo: Mary Agnes Chase ovvero una storia di genere31/3/2022 Ancora all'inizio del Novecento e anche negli Stati Uniti, sebbene le ragazze che si iscrivevano alle facoltà scientifiche fossero sempre più numerose, non era facile per loro fare ricerca; se riuscivano ad entrare in questa o quella istituzione, accedere ai finanziamenti era molto più difficile che per i colleghi maschi. Se poi non avevano neppure una laurea, le cose si complicavano ulteriormente. Per la botanica, la porta d'accesso più praticabile continuava a rimanere l'illustrazione, un settore in cui la presenza femminile era ormai sdoganata da tempo. Fu questa la strada percorsa dall'autodidatta Mary Agnes Chase che, grazie ad alcuni incontri fortunati, ma soprattutto a una tempra eccezionale riuscì a superare tutti gli ostacoli di genere e ad affermarsi come uno dei botanici più importanti del suo campo, l'agrostologia, ovvero lo studio delle graminacee. Animata da una forte coscienza sociale, non concepì la sua battaglia come una questione individuale, ma politica: ecco perché fu in prima fila nel movimento suffragista e non fece mancare il suo sostegno alle ragazze che intendevano seguire le sue orme. Esperta di graminacee di valore mondiale, è ricordata da ben tre piccoli generi di Poaceae: Agnesia, Chasechloa e Sinochasea.  Come un'illustratrice divenne botanica Tra i 27 milioni di visitatori della Fiera Colombiana di Chicago del 1893, organizzata per celebrare i 400 anni dalla scoperta dell'America, c'erano anche una giovane donna e un ragazzo: Mary Agnes Chase (1869-1963) e Virginius Heber Chase (1876-1966), rispettivamente zia e nipote. A stupirli ed emozionarli furono soprattutto le collezioni botaniche, tanto che decisero di iniziare ad esplorare la flora dei dintorni della città. Mary Agnes aveva solo ventiquattro anni, ma aveva già alle spalle una vita difficile. All'età di due anni perse il padre, Martin Meara, un fabbro di origini irlandesi che lavorava per le ferrovie, e andò ad abitare a Chicago dalla nonna materna con la madre e i quattro fratelli. La famiglia era molto povera, e finita la scuola di base, dovette lavorare per contribuire al bilancio familiare. Trovò lavoro come tipografa e correttrice di bozze allo School Herald , una modesta rivista destinata agli insegnanti rurali, diretta da Willam Ingraham Chase; nonostante la notevole differenza d'età (lei aveva diciotto anni, lui trentaquattro) i due si innamorarono e presto si sposarono. Ma William era ammalato di tubercolosi e entro un anno morì, lasciando Mary Agnes vedova e oberata di debiti. Per tirare avanti, di notte lavorava come correttrice di bozze per il Chicago Inter Ocean e di giorno dava una mano nell'emporio del cognato, dove strinse una grande amicizia con il nipote Virginius. Sempre più affascinato dalla botanica, il ragazzino leggeva tutto quello che poteva sull'argomento e cominciò a trascinare la zia nelle sue scorribande. Raccoglievano piante, prendevano note, essiccavano i soggetti e imparavano a classificarli. Per saperne di più, Mary Agnes decise di seguire corsi aperti di botanica all'Università e al Lewis Institute, dove imparò a disegnare le piante. La botanica per ora era solo un hobby, qualche ora di pausa in una difficile vita di lavoro e di fatica. Durante un'escursione, un primo incontro fortunato cominciò a cambiare la sua vita: quello con un altro appassionato, il pastore presbiteriano Ellsworth Jerome Hill, che, ormai in pensione, poteva dedicare parecchio tempo alla raccolta e allo studio delle sue piante preferite, i muschi e le epatiche. Hill incoraggiò Chase a perseverare, le insegnò le basi della tassonomia e l'uso del microscopio e le chiese di illustrare (gratis) i suoi numerosi articoli. Queste illustrazioni, molto classiche per impostazione e notevoli per la precisione dei dettagli, attirarono l'attenzione di Charles Frederick Millspaugh, curatore di botanica del Field Museum of Natural History, che le chiese di illustrare (sempre a titolo gratuito) due pubblicazioni dell'istituto: Plantae Utowanae (1900) e Plantae Yucatanae (1904). Nel frattempo, la pratica del microscopio aveva permesso a Chase di trovare un lavoro meglio pagato nei laboratori di controllo dell'industria conserviera. Ma per lei era ora che la botanica da hobby si trasformasse in professione; sempre su suggerimento di Hill, nel 1903 presentò la sua candidatura come illustratrice botanica al Dipartimento di agricoltura (USDA). Vinto il concorso, si trasferì a Washington e per due anni lavorò alla Divisione delle piante da foraggio. Nel 1905 un secondo incontro fortunato impresse la svolta definitiva alla sua vita: il suo capo divenne Albert Spear Hitchcock, un botanico specializzato in agrostologia (ovvero lo studio delle graminacee). Egli apprezzò il suo talento e decise di farne la propria allieva e la propria assistente (lo divenne ufficialmente nel 1907). Chase cominciò così ad abbandonare gradualmente l'illustrazione a favore dello studio scientifico delle piante, accompagnando Hill anche nelle sue spedizioni sul campo in varie parti degli Stati Uniti. Il primo frutto di questa collaborazione, che sarebbe durata trent'anni, furono due lavori a quattro mani sulle specie statunitensi del genere Panicum (1910 e 1915). Nel 1911 Hill partecipò alla ricognizione botanica di Panama finanziata dallo Smithsonian; al suo ritorno, chiese che i 54 $ che aveva risparmiato fossero assegnati a Mary Agnes Chase per continuare le ricerche. La risposta dello Smithsonian fu un netto rifiuto: "Spiace dire che non posso raccomandare di inviare la signora Chase nella Zona del Canale, sia perché dubito che la somma menzionata sia sufficiente sia perché dubito dell'opportunità di assumere una donna per questo scopo". Allo stesso modo, la stazione di Barro Colorado (che pure Chase aveva contribuito a installare) rifiutò l'accesso alle donne. Per Mary Agnes fu chiaro che non si trattava di una questione personale, ma politica. Fu così che, senza lasciarsi intimorire dalle conseguenze di questa scelta per la sua carriera, si impegnò attivamente nel movimento suffragista. Nel 1915 fu arrestata una prima volta mentre, insieme ad altre donne, manteneva acceso un falò dei discorsi di Wilson che contenevano le parole freedom e liberty (somma ipocrisia finché non c'era libertà per le donne). Nel 1918 fu tra le attiviste (le Silent Sentinels) che picchettarono la Casa bianca per ricordare al neoeletto Wilson la promessa di sostenere il suffragio femminile; arrestata e incarcerata, partecipò allo sciopero della fame che guadagnò al movimento il sostegno di parte dell'opinione pubblica e costrinse l'amministrazione a rilasciare le donne arrestate. Per le sue posizioni "incompatibili per un dipendente dello stato" rischiò anche il licenziamento; a salvarle il posto fu Hitchcock che dichiarò che gli era impossibile continuare le sue ricerche senza di lei.  Viaggi e pubblicazioni della "signora delle graminacee" Non era un'esagerazione. Il programma di ricerca dei due botanici era niente meno che la mappatura di tutte le graminacee delle Americhe e dopo gli Stati Uniti intendevano estendere le loro ricerche all'America latina. Non potendo attingere a finanziamenti pubblici, Chase (abituata fin da bambina a vivere frugalmente) finanziò autonomamente i suoi primi viaggi e anche più tardi si appoggiò su organizzazioni e missioni femminili, a proposito delle quali scrisse: "I missionari viaggiano ovunque e come i botanici lo fanno spendendo il meno possibile". A partire dal 1906, dedicò molto del suo tempo libero a viaggi negli Stati Uniti (ne visitò ben 19) e nel Messico. Tutti autofinanziati, benché il suo stipendio fosse nettamente inferiore a quello dei colleghi maschi. Nel 1913 poté trascorrere diversi mesi in Porto Rico dove tra l'altro scoprì una nuova specie di felce; le sue raccolte di graminacee confluirono nel 1917 in Grasses of the West Indies, scritto in collaborazione con Hitchcock. Nel 1922 pubblicò il suo primo libro, illustrato da lei stessa, First Book of Grasses: The Structure of Grasses Explained for Beginners. Come è evidente dal sottotitolo, si rivolge non a botanici professionisti bensì "a studiosi seri ma dilettanti". Lo stesso anno partì per il suo primo viaggio in Europa, nel corso del quale visitò diversi erbari, tra cui quelli di Pisa e Firenze e l'Hackel Herbarium del Museo nazionale di Vienna, dove poté collaborare con Hackel alla raccolta di graminacee alpine. Anche grazie al successo del suo libro, nel 1923 fu promossa botanica assistente e nel 1925 botanica associata. Nel 1924, con il finanziamento di diverse organizzazioni, tra cui l'USDA e il Field Museum di Chicago e l'appoggio logistico delle missioni femminili, Chase partì per il Brasile. Incontrò i colleghi dell'orto botanico di Rio de Janeiro Paulo de Campos Porto e María de Carmo Bandeira, quindi per sei mesi percorse il Brasile orientale in treno, in autobus, in automobile, a dorso d'asino, a piedi, raccogliendo più di 500 nuove specie di graminacee e 19.000 altri esemplari. Insieme a Maria Bandeira, scalò persino il monte Itatiaia (erano le prime donne a farlo), da cui discesero "con le gonne piene di esemplari". Nel 1929, tornò in Brasile per una seconda spedizione di un anno. Nel 1935 uscì il magnum opus di Hitchcock, Manual of the Grasses of the United States, a cui le ricerche di Chase avevano dato un contributo decisivo. Ma nel dicembre di quell'anno il botanico morì all'improvviso sulla nave che lo riportava negli Stati Uniti da un lungo viaggio attraverso gli orti botanici e gli erbari europei. Nel 1936 Chase (che ora aveva 67 anni) le succedette come botanico senior, responsabile del dipartimento di agrostologia sistematica dell'USDA. Nel 1937, fu nominata anche curatrice del settore delle graminacee dell'Erbario nazionale. Nel 1939, andò in pensione, ma mantenne l'incarico all'erbario e continuò a lavorare allo Smithsonian come volontaria. Era ormai riconosciuta come la più importante specialista di graminacee del mondo. Nel 1940 fu invitata in Venezuela dal governo come consulente per un programma di sviluppo; anche se ormai aveva superato la settantina, ne approfittò per continuare le ricerche, raccogliendo 400 taxa di graminacee in ambienti diversi: le Ande, la savana e la foresta pluviale. Come già in Brasile, in Venezuela incontrò molti studenti e studentesse di botanica; per molti di loro, divenne una consigliera, un'amica e non fece mancare loro il suo sostegno concreto, aiutando decine di giovani promettenti ma privi di mezzi a continuare gli studi negli Stati Uniti. Per le ragazze, l'ostacolo era duplice: incoraggiare le giovani donne ad abbracciare la carriera scientifica divenne uno dei principali scopi dei viaggi che nel dopoguerra la videro ancora in America latina, in Canada e nelle Filippine. La sua casa, che soprannominò affettuosamente in spagnolo "Casa contenta", era sempre aperta alle studentesse e alle botaniche che passavano da Washington. Tra di loro la venezuelana Zoraida Luces de Febres (1922–2015), che grazie a lei poté entrare allo Smithsonian; tradusse in spagnolo First Book of Grasses, fu la prima donna venezuelana a laurearsi in scienze naturali e divenne a sua volta un'importante agrostologa. E' solo un esempio dell'impegno personale e politico di Chase per le cause in cui credeva. Oltre ad essere impegnata nel movimento femminista, come membro del Women's Party e della Women's Christian Temperance Union, aderì al Socialist Party, si batté contro la discriminazione razziale aderendo alla National Association for the Advancement of Colored People. Attiva e lucida fino in tarda età, nel 1951 pubblicò la seconda edizione di Manual of the grasses of the United States di Hitchcock. E finalmente anche l'establishment botanico le tributò gli onori che meritava: nel 1956 la Botanical Society of America la premiò con un certificato di merito definendola "uno dei più importanti agrostologi del mondo e preminente tra gli studiosi americani in questo campo"; nel 1958 (aveva appena compiuto 89 anni) ricevette la laurea honoris causa dall'università dell'Illinois e fu nominata membro onorario dello Smithsonian; nel 1961 divenne membro della Linnean Society. Nel 1962, ultranovantenne, in collaborazione con un'altra botanica, Cornelia D. Niles, riuscì ancora a completare il monumentale Index to grass species, in tre volumi. Morì l'anno dopo all'età di 94 anni, poco dopo essersi ritirata in una casa di riposo. Le sue raccolte sono custodite in diversi erbari. L'Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburg ospita la Hitchcock-Chase Collection of Grass Drawings, una straordinaria collezione che comprende 2713 disegni - per lo più a china - di graminacee raccolti e in parte disegnati da Albert Spear Hitchcock e Mary Agnes Chase.  Un giro del mondo in tre graminacee Alla "signora delle graminacee" non potevano mancare gli omaggi botanici. Le sono stati dedicati ben quattro generi, tre dei quali tuttora validi; non stupisce che tutti appartengano alla famiglia Poaceae. In ordine di tempo (1911), la prima dedica giunse dal sacerdote, chimico e botanico Julius Nieuwland che, nell'ambito di una revisione del genere Panicum, creò Chasea, prendendo le mosse dallo studio su questo genere pubblicato l'anno precedente da Hitchcock e Chase; non valido, è considerato un doppione di Panicum. Con i tre generi validi facciamo un piccolo giro del mondo, segno della reputazione internazionale di Agnes Mary Chase. Iniziamo dal Madagascar, con il genere endemico Chasechloa (1949), omaggio di una delle tante colleghe con cui Chase era in corrispondenza, la francese Aimée Antoinette Camus (che a sua volta, prima di diventare specialista di orchidee, si era occupata di graminacee). Comprende due sole specie, C. egregia e C. madagscarensis, in precedenza assegnate anch'esse al genere Panicum, a cui sono molto affini; tuttavia, le analisi filogenetiche ne hanno confermato l'indipendenza. Sono grandi erbe piuttosto rare limitate alle regioni nord-occidentali dell'isola. La seconda tappa è la Cina, con il genere monotipico Sinochasea (1958), dedica di Yi-Li Keng, uno dei tanti studenti stranieri che poterono giovarsi dell'aiuto della generosa botanica statunitense. Keng, infatti, dopo essersi laureato a Nanchino, si spostò all'università di Washington per la laurea di secondo livello, per la quale scrisse una tesi sulle graminacee cinesi. Come ricorda nella dedica "il nome è una combinazione di Sino, Cina, e Chasea, in onore della sig.a Agnes Chase, la nota agrostologa degli Stati Uniti, che mi aiutò molto nello studio delle graminacee cinesi". L'unica specie, S. trygina, è un'erba dei pascoli alpini della Cina, del Tibet e dei piccoli stati himalayani adiacenti. Concludiamo il viaggio in Amazzonia con un altro genere monotipico, Agnesia (1993). I due autori, l'argentino Fernando Omar Zuloaga e lo statunitense Emmet Joseph Judziewicz, con questa dedica vollero sottolineare quanto utile e ancora attuale fosse (e sia ancora) il lavoro di questa grande botanica: "Il genere è dedicato all'eccezionale agrostologa statunitense Agnes Chase, autrice del monumentalmente completo e utilissimo indice delle specie pubblicate di graminacee. Ancora oggi le sue note manoscritte sugli esemplari e sulle cartelle dell'erbario nazionale statunitense spesso forniscono suggerimenti benvenuti e permettono di risparmiare molto tempo nell'identificazione e nelle relazioni reciproche di molte graminacee". L'unica specie di questo genere, A. lancifolia, è un raro bambù delle foreste umide dell'area amazzonica. La pubblicazione di The Cactaceae dei botanici statunitensi Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose segna una pietra miliare nella classificazione dei cactus e ne rivoluziona la tassonomia. I quattro volumi, editi tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution for Science, sono anche una sontuosa opera d'arte, grazie ai disegni in bianco e nero e alle tavole a colori, di impressionante precisione, della pittrice britannica Mary Emily Eaton e delle sue collaboratrici; centinaia di fotografie in bianco e nero ne arricchiscono l'apparato iconografico. Anche se da allora le Cactaceae hanno subito numerose revisioni, almeno 50 dei 79 generi stabiliti da Britton e Rose rimangono validi, e i volumi di The Cactaceae sono ricercati da ogni cactofilo. L'opera nasce dalla stretta collaborazione tra Nathaniel Britton, all'epoca direttore del New York Botanical Garden, e Joseph Nelson Rose, un grande e metodico tassonomista al cui il destino ha riservato il ruolo dell'eterno secondo. A ricordarlo i generi Rhodosciadium (Apiaceae) e Roseodendron (Bignoniaceae). 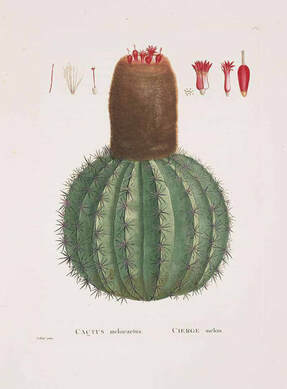 Una classificazione spinosa Come ben sanno gli appassionati di cactus, abituati a fare i conti con continue revisioni e cambi di nome, la classificazione delle Cactaceae è una faccenda spinosa; a ciò contribuiscono diversi fattori: citiamo soltanto la grande variabilità morfologica che spesso rende difficile distinguere specie da specie, specie da sottospecie, specie da varietà; l'alto grado di convergenza evolutiva di queste piante di habitat estremi che fa sì che piante lontane dal punto di vista genetico tendano ad assomigliarsi perché devono affrontare le stesse condizioni ambientali; la difficoltà di raccogliere, seccare e preservare esemplari d'erbario di queste piante spinose, con forme arrotondate e tessuti succulenti. Con la sola eccezione di Rhipsalis baccifera, si tratta di una famiglia esclusivamente americana, in cui gli europei si sono imbattuti con le scoperte geografiche. Probabilmente la prima specie ad arrivare in Europa, forse già con i viaggi di Colombo, fu il fico d'India (qui le Indie sono quelle occidentali) Opuntia ficus-indiae, ma la prima ad essere attestata è un Melocactus "cactus a melone" noto a Londra intorno al 1570. Qualche anno dopo nell'erbario di Tabaernemontanus vengono descritti sia cactus globosi, sia cactus colonnari, che il botanico tedesco chiama Cereus, ovvero "cero, candela". A cavallo tra Cinquecento e Seicento diverse specie sono descritte da altri botanici, come Clusius, L'Obel e Gerard. Pitton de Tournefort pubblica Melocactus e Opuntia, mentre Plumier riporta dai suoi viaggi nelle Antille Pereskia. Questa è la situazione prima di Linneo che nel 1753, in Species Plantarum, descrive 22 specie ma sorprendentemente le raggruppa nell'unico genere Cactus, nome che ricava dal gr. kaktos, una pianta spinosa di Teofrasto non meglio identificata. Più analitico di lui Philip Miller che nella quarta edizione di The Gardener's Dictionary (1754) descrive quattro generi: Cactus, Cereus, Opuntia e Pereskia. Tuttavia, nella nona edizione (1787) farà marcia indietro e si adeguerà alla posizione di Linneo. Poco dopo, nel 1789, Antoine Laurent de Jussieu crea la famiglia Cactaceae. A rimescolare le carte è Haworth che nel 1812 dichiara il genere linneano Cactus inutilizzabile, riservandolo al solo Cactus melocactus L., e lo smembra in Cactus, Cereus, Epiphyllum, Mammillaria, Opuntia, Pereskia e Rhipsalis (creato da Gaertner nel 1788). Nel terzo volume del Prodromus (1828) de Candolle opta per la prudenza, descrivendo sette generi e 174 specie, suddivisi nei grandi gruppi di cactus epifiti e cactus non epifiti. Il grande collezionista principe di Salm-Dyck, che nel suo castello nei pressi di Düsseldorf possedeva la più importante collezione di Cactaceae dell'epoca, in Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (1850) pubblica 20 generi, dividendo la famiglia in due gruppi: Cacteae Rotatae, con fiori a disco, e Cacteae Tubulosae, con fiori tubolari. Nel corso del secolo, mano a mano che gli ambienti aridi del Nuovo mondo vengono esplorati e sempre nuove specie vengono scoperte e inviate ai giardini botanici ma anche ai vivai europei, si aggiunge una grande quantità di specie che i botanici tendono a riunire in pochi grandi generi. Nel 1891 nella sua revisione di Genera Plantarum, Otto Kuntze torna addirittura all'antico, ovvero a Linneo, riconoscendo solo tre generi: i piccoli Pereskia e Pterocactus e un super genere Cactus con oltre 1000 specie. La sistematizzazione più influente a cavallo tra i due secoli è tuttavia la monumentale Gesamtbeschreibung der Kakteen, "Descrizione generale dei cactus", di Karl Moritz Schumann, in tredici volumi pubblicati tra il 1897 e il 1898, con un appendice nel 1903. Rifacendosi soprattutto a Salm-Dick, egli accetta 21 generi e 640 specie. Divide poi la famiglia in tre tribù: Rhipsaloideae, Mammillarieae, Echinocactaceae. Una posizione in parte più aperta è quella di Alwin Berger, curatore dei giardini Hambury, che accetta 41 generi e propone di dividere il vasto genere Cereus in 5 1sottogeneri. E' questa la situazione quando entrano in scena i nostri protagonisti, Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose. 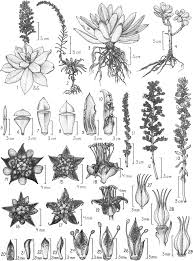 Un botanico taciturno, eterno secondo Britton e Rose incominciarono a studiare le Cactaceae nel 1904; entrambi conoscevano bene le flore degli Stati Uniti, dei Caraibi e del Messico e inizialmente il loro intento era pubblicare una revisione complessiva delle specie nordamericane. Solo più tardi, nel gennaio 1911, Daniel MacDougal, il direttore del Desert Laboratory di Tucson, suggerì loro di allargare le ricerche all'intera famiglia e di chiedere il sostegno finanziario della Carnegie Institution for Science. Di Britton ho già parlato in questo post; è ora di conoscere meglio Rose. Aaron M. Socha, un esperto di cactus che ha lavorato per il Giardino botanico di New York, lo ha definito "un individuo così spiccato che neppure Shakespeare avrebbe potuto renderlo universale". Era un uomo taciturno, riservato, modesto e disinteressato agli onori, ma allo stesso tempo determinato; come botanico, un ricercatore instancabile (qualcuno lo ha definito un "cavallo da tiro"), un descrittore minuzioso e un tassonomista di estremo rigore. Ripercorrendo la sua carriera, a me è sembrato un eterno secondo, un Bartali della botanica. E a Bartali assomiglia anche per la forza di volontà, la bontà d'animo, la generosità, la profonda religiosità. Nato nell'Indiana e rimasto presto orfano durante la guerra di Secessione, studiò nel piccolo college di Wabash; mentre seguiva i corsi post laurea di biologia, divenne assistente del suo professore di botanica, John Merle Coulter, che lo volle al suo fianco per studiare un'altra famiglia difficile, le Apiaceae (a quei tempi, si chiamavano ancora Umbellifere); la collaborazione tra professore e allievo iniziò con Revision of the North American Umbelliferae (1888) e, dopo una serie di articoli su vari generi, culminò con Monograph of the Umbelliferae (1900). Secondo i biografi, a fare il lavoro duro fu Rose, mentre Coulter ebbe piuttosto un ruolo di revisore. Nel frattempo, Rose si era sposato e si era trasferito a Washington per iniziare la sua carriera professionale nel Dipartimento di Agricoltura (USDA) come assistente di George Vasey, botanico capo dell'USDA e curatore dell'erbario nazionale. Rose lo affiancò nella pubblicazione delle raccolte di Edward Palmer in Messico e Centro America, con grande apprezzamento di quest'ultimo che nel 1897 lo invitò ad accompagnarlo in Messico; grazie a questa spedizione, Rose si familiarizzò con il lavoro sul campo e imparò le tecniche di raccolta e conservazione anche di piante difficili come le succulente messicane. Nel 1896 l'Erbario nazionale era passato sotto la giurisdizione dello Smithsonian, e Rose fu promosso assistente curatore di botanica, poi dal 1905 curatore associato. Fu questo il vertice della sua carriera, come notiamo anche dal ruolo di vice presidente - in armonia con il suo carattere e il suo destino - di associazioni attive nella capitale come Botanical Society, Washington Botanical Society, Washington Society, Washington Biological Society (di cui, a dire la verità, dopo essere stato il vicepresidente dal 1909 al 1917, divenne presidente nel 1918). Come assistente curatore dell'USDA, organizzò nove spedizioni in Messico e in Centro America, di cui pubblicò i risultati in Studies of Mexican and Central American Plants, 1897-1911. Intorno all'inizio del secolo, incominciò a corrispondere con Britton, cui inviò molti esemplari per il New York Botanical Garden; entrambi erano particolarmente interessati alle Crassulaecae e a partire dal 1903 incominciarono a scrivere vari articoli a quattro mani su questa famiglia, pubblicati per lo più sul Bollettino del New York Botanical Garden. I loro primi lavori comuni sulle Cacataceae risalgono al 1905. Il progetto suggerito da MacDougall fu presentato da Britton e Rose alla Carnegie all'inizio del 1911 e fu immediatamente approvato. Nel 1912 Rose prese un congedo non pagato dallo Smithsonian e fu nominato ricercatore associato della Carnegie, affiancato da due assistenti, W.R. Fitch e P.G. Russel. Britton, che continuava a dirigere l'orto botanico di New York, fu nominato ricercatore associato onorario (ovvero senza paga), mentre il suo collaboratore R.S. Williams fu incaricato di selezionare e preservare gli esemplari per le illustrazioni. 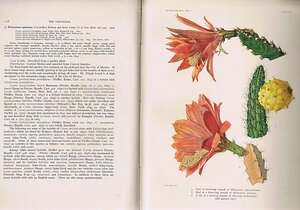 Una rivoluzione tassonomica Quando Britton e Rose incominciano il loro lavoro, la situazione è confusa al massimo grado. Nel corso di un secolo, le specie di cactus, spesso introdotte direttamente non da botanici, ma da raccoglitori di piante al servizio di collezionisti e vivai, si sono moltiplicate a dismisura; e insieme si sono moltiplicati gli errori. Un caos perfettamente descritto dai due botanici nella prefazione del I Volume di The Cactaceae: "descrizioni interpretate scorrettamente, piante identificate in modo sbagliato, errori perpetuati; così la distribuzione geografica di molte specie è stata pubblicata in modo erroneo e le conclusioni basate su dati di questo tipo risultano inaffidabili. Non solo ci sono nomi specifici attribuiti a piante cui non spettano, ma i nomi generici sono diventati interscambiabili e le leggi della priorità sono state ignorate". Quella che Britton e Rose decidono di operare è una rivoluzione; il botanico Lyman Benson ha osservato che, se gli stessi criteri fossero stati applicati a tutte le piante "almeno un milione di piante avrebbero dovuto cambiare nome". Nei quattro volumi di The Cactaceae, i 21 generi accettati da Schumann esplodono e diventano 124, mentre le specie classificate sono 1325. Insomma, per la tassonomia delle Cactaceae, dopo un secolo di prudenza e di enormi super generi, è arrivata l'ora dell'audacia e della suddivisione in molti generi più piccoli, basati sia sulle evidenze morfologiche, sia sulla distribuzione geografica. Anche se i due botanici ottimizzano il tempo, dividendosi il lavoro sia di ricerca sia di scrittura e sono affiancati da una dozzina di collaboratori, il compito è immenso e i cinque anni previsti inizialmente si dilatano a dieci. Bisogna reperire e leggere tutte le descrizioni originali e verificarle quanto più possibile sugli esemplari tipo custoditi negli erbari, quindi confrontarle con le piante vive in coltivazione e/o in natura. Senza dimenticare che il lavoro (1912-1923) verrà a cadere a cavallo della Prima Guerra Mondiale e anche il Messico si chiuderà alle ricerche a causa della rivoluzione messicana. Le Cactaceae vivono nei deserti delle Americhe, ma nell'Ottocento sono state prevalentemente studiate e classificate da studiosi europei, commercializzate da vivai europei e collezionate da collezionisti europei. Ecco perché le ricerche di Rose, già nei primi mesi del 1912, si spostano in Europa. A Londra visita gli erbari di Kew, del Natural History Museum e della Linnean Society e a Parigi l'Hérbier National. Passa poi in Italia dove visita piccole collezioni pubbliche e private di Roma, Napoli, Firenze e Venezia. La tappa principale è però la Riviera, dove Rose va a trovare Alwin Berger; i due botanici corrispondono fin dal 1905, quando Rose aveva scritto a Berger per complimentarsi per il suo studio sulle Cactaceae. E' poi la volta della Germania con gli erbari e gli orti botanici di Monaco e Berlino, la collezione privata di Leopold Quehl ad Halle, il vivaio Haage & Schmidt a Erfurt e l'orto botanico di Darmstadt. Prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, Rose fa ancora un salto ad Anversa per esaminare la collezione privata di Frans de Laet. Le spedizioni sul campo iniziano l'anno successivo. Insieme a sua moglie Elizabeth Knight Britton, all'amica Delia West Marble, membro del Botanical Club, pittrice e fotografa, e al raccoglitore dell'orto botanico di New York John Adolph Shafer, Nathaniel Britton visita le Isole vergini americane, Porto Rico e Curaçao; Rose e i suoi assistenti percorrono Saint Croix, St. Kitts, Antigua e Hispaniola. Nel 1914, mentre in Europa si accendono i fuochi di guerra, Britton torna a Porto Rico per esplorare le isole dell'arcipelago, mentre Rose, accompagnato dalla moglie Lou Beatrice Sims, parte per il suo lungo giro in Sud America. Dopo due brevi tappe in Giamaica e Panama, nel 1915 esplora le zone ricche di cactus di Perù, Bolivia centrale, Cile settentrionale e centrale; come aveva fatto in Europa, a Santiago del Cile esamina le specie tipo raccolte il secolo precedente da Rodolfo Amando Philippi e le specie rare dell'orto botanico. Passa in Brasile, dove studia soprattutto le aree di Bahia e Rio de Janeiro, quindi in Argentina, dove si concentrata sulle province di Mendoza e Cordoba. Come in Europa e in Cile, visita botanici e collezionisti da cui ottiene esemplari e informazioni di prima mano. Nel 1916 Britton è a Cuba insieme a Percy Wilson, mentre Rose e sua moglie concludono il viaggio sudamericano con Curaçao e Venezuela. Per i due botanici è arrivata l'ora del lavoro da scrivania, tanto più che la guerra ora rende difficile gli spostamenti anche in America. Nel 1918, per Rose c'è ancora un viaggio (ad accompagnarlo questa volta è suo figlio Thomas) in Ecuador. Inoltre sono stati coinvolti altri raccoglitori, come J.K. Small inviato nel 1916 in Florida alla ricerca di rare specie di Opuntia o Shafer che nell'inverno 1916-17 fa importanti raccolte in Bolivia, Argentina, Paraguay e Uruguay. Altri esemplari furono inviati da collezionisti, curatori di orti botanici e erbari, studiosi e appassionati. Il primo volume, dedicato alle tribù Pereskieae e Opuntieae, uscì infine nel 1919; il secondo, dedicato alle sottotribù Cereanae e Hylocereanae della tribù Cereae, nel 1920; il terzo, dedicato alle sottotrbù Echinocereanae, Echinocactanae e Cactanae, seguì nel 1922; il quarto, dedicato alle sottotribù Coryphanthanae, Epipyllanae y Rhipsalidanae, completò l'opera nel 1923. Nel 1922 Rose era tornato una seconda volta in Europa, per consultare nuovamente Berger, con il quale aveva continuato a corrispondere, almeno finché la guerra non lo aveva reso impossibile. Ma appena il conflitto era finito, si era affrettato a inviare dall'opulenta America un ricco pacco di cibo all'amico e alla sua famiglia, alle prese con la fame nella Germania postbellica. Pubblicati dalla Carnegie Institution of Science senza badare a spese, oltre ad essere una pietra miliare della botanica, i quattro volumi di The Cactaceae sono una raffinata opera d'arte grazie al ricchissimo apparato iconografico con tavole a colori, disegni e fotografie in bianco e nero nel corpo del testo. A dipingere tre quarti delle 800 tavole fu la pittrice inglese Mary Emily Eaton, che all'epoca lavorava per l'orto botanico di New York; per la precisione del tratto e la vivezza dei colori questa eccellente artista fu definita dai contemporanei "la più grande pittrice di piante dal vivo". A coadiuvarla, un team tutto al femminile: Deborah Griscom Passmore, Helen Adelaide Wood, Kako Morita. Britton e Rose partirono dalle revisioni di Schumann e di Berger, ma si spinsero molto più in là, creando molti generi più piccoli; oltre a correggere le denominazioni di molte specie, ne pubblicarono numerose per la prima volta. Anche se nel secolo che è intercorso da allora la storia tassonomica della Cactaceae ha continuato ad essere travagliata e molte sono state le revisioni, è significativo della qualità del loro lavoro il fatto che ben 50 dei 79 generi da loro creati continuato ad essere accettati, anche se spesso ne sono stati ridefiniti i confini. Inoltre, anche grazie alla splendida veste editoriale, The Cactaceae ebbe anche il merito di destare l'interesse del grande pubblico per una famiglia di piante che all'epoca era ancora poco di moda.  Modeste piante aromatiche e alberi d'oro Terminata l'impresa, Rose riprese il suo lavoro allo Smithsonian. Non cessò però la sua collaborazione con Britton; negli anni '20 i due botanici scrissero insieme la trattazione delle Mimosaceae e delle Caesalpinaceae per la North American Flora. Rose diede ancora prova delle sue grandi capacità di tassonomista ridefinendo il super genere Cassia, il cui status all'epoca era estremamente confuso. Egli morì nel 1928, sei anni prima dell'amico e compagno di avventura. Nella sezione biografie, una sintesi della vita di questo grande botanico, che il destino e l'ordine alfabetico collocano in seconda posizione anche come autore di The Cactaceae. Vorrei salutarlo con le parole di Alwin Berger che lo definì "uno degli uomini meno egoisti e di animo più gentile che io abbia mai incontrato". Come a Britton, anche a Rose furono dedicati numerosi generi (c'è anche una dedica comune, Brittonrosea Speg., oggi sinonimo di Echinocactus); a essere attualmente validi sono due: Rhodosciadium e Roseodendron. Come abbiamo visto, nella sua lunga carriera di tassonomista specializzato nel riportare ordine nella sistematica di famiglie complicate, i primi lavori di Rose furono dedicati alle Apiaceae. E proprio a questa famiglia appartiene Rhodosciadium, che nel 1889 gli fu dedicato dall'illustre botanico Sereno Watson. Il nome, un composto di rhodon, "rosa" e sciadeion "ombrello", si basa su un gioco di parole tra rose, "rosa" in inglese, e Rose, il cognome del nostro botanico e significa "ombrellifera dedicata a Rose". Il genere è distribuito tra Stati Uniti meridionali e Guatemala e gli sono attribuite da cinque a quindici specie. Sono erbacee perenni degli ambienti montani, con ombrelle rade con pochi fiori viola o giallo-verdastro. E' curioso che proprio Rose nel 1895 abbia separato dal genere dedicato a lui stesso alcune specie messicane, assegnandole al nuovo genere Deanea (oggi non accettato). In rete sono disponibili davvero poche informazioni su questo genere discusso; Rhodosciadium longipes (una specie pubblicata per la prima volta da Rose con il nome Deanea longipes) in Messico, dove è chiamata espico, è considerata una pianta medicinale. Una sintetica presentazione del genere nella scheda. Le ricerche di Rose prima in Messico e poi in Sud America ne hanno fatto una figura quasi leggendaria per i botanici dell'America latina. Non stupisce che Faustino Miranda, forse il più noto botanico messicano, nel separare da Tabebuia due specie abbia voluto dedicare a Rose il nuovo genere Roseodendron (1965), ovvero "albero di Rose". La denominazione di Miranda tuttavia fu presto respinta, e le piante furono assegnate a Cybistax, per poi ritornare a Tabebuia. Ricerche molecolari pubblicate nel 2007 hanno però dato ragione a Miranda, raccomandando di resuscitare Roseodendron. Appartenente alla famiglia Bignoniaceae, comprende due sole specie: R. donnell-smithii, e R. chryseum. R. donnell-smithii è la specie più diffusa; raccolta in Messico da Palmer, fu pubblicata proprio da Rose nel 1892 come Tabebuia donell-smithii. E' un albero magnifico che al momento della fioritura si ricopre di grandi fiori dorati; è nota con il nome colloquiale "primavera"; ha un areale abbastanza ampio (dal Messico meridionale al Guatemala) ma è anche frequentemente coltivata. R. chryseum è invece un endemismo delle foreste aride del Venezuela nordoccidentale e della Colombia settentrionale. Rispetto all'altra specie è di dimensioni minori e presenta infiorescenze meno compatte. Qualche approfondimento nella scheda. Il Giardino botanico di New York (New York Botanical Garden, NYBG) è uno dei più importanti orti botanici del mondo; situato nel quartiere del Bronx, oggi si estende per oltre 1 km², contiene 48 diversi giardini, ospita serre, laboratori, il maggiore erbario dell'emisfero settentrionale con 7.800.000 esemplari e la biblioteca botanica più importante del paese, ricca anche di manoscritti e testi storici. Eppure tutto è incominciato da un fazzoletto di terra e dal sogno di una coppia di botanici, Nathaniel L. Britton e Elizabeth G. Knight Britton. Lui, oltre ad aver diretto il NYBG per più di trent'anni, è stato un riconosciuto esperto della flora del centro America, ma è famoso soprattutto per il libro sulle Cactaceae che scrisse a quattro mani con J.N. Rose. Lei è stata una pioniera degli studi sui muschi degli Stati Uniti orientali e delle battaglie ecologiste. Entrambi sono ricordati da generi monotipici: Neobrittonia (Malvaceae) per Nathaniel, Bryobrittonia (Encalyptaceae) per Elizabeth.  Un giardino nato dal sogno di una coppia di botanici Anche se uno dei primi orti botanici statunitensi, l'Elgin Botanic Garden, sorse proprio qui, alla fine dell'Ottocento New York era priva di un orto botanico. Infatti, nel 1808 David Hosack, il fondatore, era stato costretto a vendere l'Elgin Botanical Garden alla città; trasferito al Columbia College, era stato lasciato all'abbandono fino a scomparire. Sopravvivevano soltanto i resti della biblioteca e dell'erbario. Se oggi la città vanta uno dei prestigiosi giardini botanici del mondo, New York Botanical Garden (NYBG), si deve a una coppia di straordinari botanici, Nathaniel Lord Britton e Elizabeth Gertrude Knight Britton. Nathaniel si era laureato in geologia e aveva partecipato alla ricognizione geologica del New Jersey, ma fin dagli anni universitari era appassionato di botanica ed era un membro attivo del Torrey Botanical Club. Verso la metà degli anni '80 divenne insegnante di geologia e botanica alla Columbia University. I suoi interessi si spostarono sempre più verso la botanica; al Torrey conobbe una giovane briologa, Elizabeth Gertrude Knight, che sposò nel 1885. Nel 1888 la coppia andò a Kew per condurre alcune ricerche e entrambi furono impressionati dai giardini, dall'erbario e dalla biblioteca. Sembra che sia stata Elizabeth ad esclamare: "Dobbiamo avere un'istituzione così a New York!". Di ritorno a casa, Elizabeth presentò una entusiastica relazione al Torrey Club e propose di fondare un Comitato per promuovere la creazione di un orto botanico, concepito allo stesso tempo come un giardino per il piacere della cittadinanza, un'istituzione educativa e un centro di ricerca e irradiazione della conoscenze botaniche sul modello di Kew. Entrambi i Britton erano energici e convincenti e seppero coinvolgere nel progetto le maggiori istituzioni scientifiche cittadine: oltre al Torrey Botanical Club, la Columbia University (dove Nathaniel insegnava e Elizabeth prestava servizio volontario come curatrice dell'erbario dei muschi), l'American Museum of Natural History. La campagna di raccolta fondi, di cui Elizabeth divenne l'anima, coinvolse quotidiani come il Sun e l'Herald Tribune e guadagnò il sostanzioso sostegno dei grandi magnati della città, da Morgan a Carnegie a Vanderbildt, che poi figurarono ai vertici del consiglio di amministrazione. Fondato ufficialmente con un atto del New York State Legislature il 28 aprile 1891, il nuovo orto botanico sorse nel Bronx Park, a nord della città; i lavori cominciarono tuttavia solo nel 1896 e richiesero diversi anni. La biblioteca fu completata nel 1900 e la grande serra nel 1909. Nominato segretario del consiglio di amministrazione fin dall'atto di fondazione, nel 1896 Britton lasciò la Columbia University, dove, oltre a insegnare geologia e botanica, era anche il curatore della biblioteca e dell'erbario, e divenne il primo direttore del NYGB. Con l'assenso della Columbia University, che continuò a collaborare strettamente con la nuova istituzione, le collezioni di cui era curatore si trasferirono con lui. In quegli anni, mentre Elizabeth si batteva anima e corpo per raccogliere i fondi per il nascente giardino, Nathaniel era anche impegnato nelle ricerche per la sua prima opera importante, An Illustrated Flora of the Northern United States and Canada, finanziata da Addison Brown e nota come Britton & Brown Illustrated Flora, la prima flora illustrata dell'America settentrionale. I Britton pensavano che come Kew era la "capitale botanica" dell'impero coloniale britannico, allo stesso modo il NYBG dovesse assumere la guida delle ricerche botaniche non solo nel territorio metropolitano, ma anche nelle aree di influenza statunitense in America centrale, a partire dal protettorato di Porto Rico. Fu così che il NYBG fu in prima linea nelle ricerche botaniche nell'area; nel 1902 la coppia iniziò una serie di viaggi nelle Antille e nei Caraibi. Tutti gli anni, quando l'inverno newyorchese si faceva più duro, i Britton si trasferivano a sud, non in vacanza, ma in spedizioni botaniche sul campo finanziate in parte da loro stessi, in parte da cordate tra diverse istituzioni scientifiche. Nathaniel partecipò di persona a una trentina di spedizioni; la più importante è senza dubbio la ricognizione scientifica di Porto Rico e delle Isole Vergini, condotta dall'Accademia delle Scienze di New York in collaborazione con il governo di Porto Rico e l'American Museum of Natural History che si protrasse per sette anni, dal 1919 al 1926 e coinvolse scienziati di molte discipline. Furono i viaggi in America centrale a destare l'interesse di Britton per le Cactaceae. Ne nacque il progetto che porterà alla stesura di The Cactaceae, il suo capolavoro, scritto a quattro mani con Joseph Nelson Rose. Un'opera così importante che merita un post a parte. Britton diresse il NYBG fino al pensionamento, nel 1929. Oltre ad essere uno scienziato di grande valore, aveva grandi capacità organizzative e sotto la sua direzione il giardino crebbe rapidamente; nel 1915, con l'acquisizione di un settore sottoutilizzato del Brox Park, passò da 250 a 400 acri. Britton curò l'arricchimento delle collezioni, varò programmi di conferenze e fece del giardino (il cui accesso rimase gratuito per mezzo secolo) uno spazio bello e piacevole per i suoi concittadini, un punto di incontro reso vivo da mostre e iniziative divulgative; ma soprattutto lo rese un'istituzione scientifica di primo piano. Si batté per centralizzare le collezioni di libri e erbari disperse tra le varie istituzioni newyorchesi; grazie a affidi, doni e acquisti, al termine del suo mandato la biblioteca contava 43.500 volumi e l'erbario 1.700.000 esemplari. Egli credeva nella collaborazione tra le varie istituzioni scientifiche, e fu tra gli animatori della Scientific Alliance of New York, purtroppo di breve durata. Era anche noto per il carattere imperioso e poco accomodante (scherzosamente, usando il suo secondo nome, lo chiamavano "il Lord"). In campo tassonomico si batté per la stretta osservanza della regola della priorità; ma lo fece in modo talmente rigido e poco diplomatico da provocare una rottura sia con molti colleghi statunitensi sia con i botanici europei. Britton scisse moltissimo; accanto e dopo il grande lavoro sulle Cactaceae, pubblicò numerosi volumi sulla flora delle Antille: Flora of Bermuda (1918), The flora of the American Virgin Islands (1918), Descriptions of Cuban plants new to science (1920), The Bahama flora (1920) in collaborazione con Charles Frederick Millspaugh. 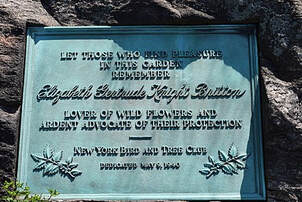 Dallo studio dei muschi alla battaglia per le piante native E' ora di conoscere più da vicino sua moglie Elisabeth Gertrude Knigth; proprio come il marito, era una figlia della città di New York, ma aveva trascorso lunghi periodi a Cuba, dove il nonno possedeva una piantagione di canna da zucchero. A soli 17 anni si diplomò e incominciò a insegnare come tutor di Scienze naturali alla Normal School (oggi Hunter College). Nel 1879, a ventun anni, si iscrisse al Torrey Botanical Club e fece il suo esordio nella carriera botanica scoprendo la fruttificazione del muschio Eustichium norvegicum e la presenza in Nuova Scozia della rara felce Schizaea pusilla. Aveva già deciso di specializzarsi nello studio delle piante di cui sarebbe diventata una dei massimi esperti: i muschi. Era un'appassionata escursionista e in questi anni visitò gli Adirondack e gli Appalachi. Fu al Torrey che conobbe Nathaniel Britton, che era il responsabile del bollettino dell'associazione, su cui Elizabeth pubblicò i suoi primi articoli; nel 1884 divenne curatrice dei muschi e nei 1886 redattrice del bollettino. Nel 1893, fu la sola donna tra i 25 membri fondatori della Botanical Society of America. Dopo il matrimonio, lasciò l'insegnamento e prestò servizio come volontaria alla Columbia University, dove era la responsabile non ufficiale dell'erbario dei muschi. Benché non avesse un titolo accademico, era una guida e punto di riferimento per studenti e specializzandi. Abbiamo già parlato del viaggio a Kew (dove era andata a studiare la collezione di muschi di Henry Hurd Rusby) e della battaglia per il NYBG. Quando l'erbario della Columbia fu trasferito nel neonato giardino, continuò nella nuova sede l'attività volontaria come curatrice dei muschi dal 1912 al 1929; grazie a lei, furono acquisite molte collezioni. Molto del suo tempo fu dedicato alla catalogazione dell'erbario di muschi di William Mitten, acquisito dal NYBG nel 1906. Insieme al marito, erborizzò in Porto Rico, Giamaica e Cuba. Durante la sua carriera, scrisse quasi 350 articoli, metà dei quali dedicati ai muschi. Il progetto di un grande Handbook of Mosses of Eastern America, fu abbandonato a favore di una serie di articoli più brevi, in parte confluiti nella North American Flora pubblicata dal NYBG. Dall'inizio del secolo, quando la battaglia per l'orto botanico era già stata vinta, Elizabeth Britton abbracciò con tutta la sua determinazione una seconda causa: quella della salvaguardia dei fiori selvatici. Nel 1902 fu tra i fondatori della Wild Flower Preservation Society che si batteva per proteggere le piante native anche attraverso provvedimenti legislativi; ne divenne segretaria e tesoriera e, oltre a pubblicare numerosi articoli sull'argomento nella rivista del NYBG, per sensibilizzare l'opinione pubblica partecipò letteralmente a migliaia di eventi in scuole e garden club. Nel 1925 come presidentessa del comitato per la conservazione dei Garden Club dello Stato di New York guidò una vittoriosa campagna di boicottaggio contro la pratica di utilizzare rami di agrifoglio selvatico come decorazione natalizia. Nel 1929, quando Nathaniel andò in pensione, la coppia, che abitava in una casa del Brox non lontana dall'orto botanico, alternò ai soggiorni in città quelli nel Cottage di Richmond, un edificio storico che apparteneva alla famiglia Britton fin dal 1695. Nathaniel lavorava a una flora di Porto Rico (Flora Borinquena) che rimase incompiuta. Entrambi morirono nel 1934, a quattro mesi di distanza, prima Elizabeth, poi Nathaniel, che non si era mai ripreso dalla perdita della moglie. Una sintesi delle loro vite nella sezione biografie.  Due piccoli generi per due grandi botanici Non sorprende che, come direttore di un'istituzione tanto prestigiosa, come ricercatore con all'attivo la scoperta di numerose specie e come autore di opere decisive come The Cactaceae, Nathaniel Lord Britton abbia collezionato la dedica di quasi settanta nomi di specie e di sei generi. Tuttavia uno solo rimane valido, Neobrittonia, che gli fu dedicato nel 1905 da Hochreutiner dell'Orto botanico di Ginevra, riclassificando una specie messicana precedentemente denominata Abutilon acerifolium Don. Neobrittonia acerifolia, l'unico rappresentante di questo genere della famiglia Malvaceae, è un arbusto diffuso dal Messico centrale a Panama in boschi misti, pinete e boschi mesofili di montagna tra 2100 e 2400 metri. Alto tra due e tre metri, ha rami ricoperti di lunghi peli e foglie che ricordano quelle dell'acero, profondamente lobate, con tre o cinque lobi; ha fiori attraenti, con cinque petali lilla violaceo, seguiti da frutti tondeggianti, formati da 8-12 segmenti ravvicinati e disposti a ruota, abbastanza simili a quelli del nostrano Abutilon theophrasti, ma irsuti e spinosi. Qualche dettaglio in più nella scheda. Anche Elizabeth Knight Britton ha ricevuto la sua parte di onori: a ricordarla i nomi specifici di una quindicina di piante, come la felce Thelypteris brittoniae, e il genere di muschi Bryobrittonia, che gli fu dedicato nel 1901 da R.S. Williams, soprattutto in riconoscimento del suo ruolo educativo quando era curatrice dei muschi alla Columbia University. Scrive infatti Williams: "Il genere è dedicato a Mrs. Elizabeth G. Britton, il cui aiuto ha incoraggiato molti studiosi americani dei nostri muschi". Appartenente alla famiglia Encalyptaceae, è anch'esso un genere monotipico, che comprende solo B. longipes, una specie dei climi rigidi che vive su substrati calcarei in Nord America, Europa e Asia centrale. Altre informazioni nella scheda. Quando scoprì la vocazione di naturalista, Ynés Mexía aveva superato la cinquantina, e usciva da un decennio di depressione e instabilità emotiva. Grazie alle piante, ritrovò l'amore per la vita e divenne una raccoglitrice formidabile. Nel breve arco di tredici anni - tanto durò la sua carriera - percorse le America dall'Alaska alla Terra del fuoco, raccolse oltre 145.000 esemplari, scoprì 500 nuove specie e un nuovo genere (che le è stato dedicato con il nome Mexianthus); coraggiosa, tenace, caparbia, preferiva mete non battute, viaggiando per lo più da sola in modo spartano. A chi dubitava che una donna potesse farlo, nell'America latina di quasi un secolo fa, rispondeva semplicemente "Perché no?" 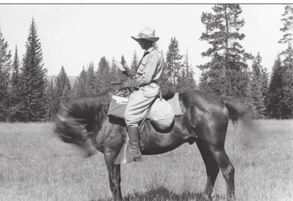 Dare senso alla vita raccogliendo piante La vita può ricominciare anche a cinquant'anni, quanti ne aveva Ynés Mexía quando scoprì la sua vera vocazione. Nata negli Stati Uniti da un diplomatico messicano e una statunitense, aveva avuto una vita abbastanza complicata a cavallo tra i due paesi. In crisi per la separazione dal secondo marito, che prima del divorzio l'aveva anche rovinata economicamente, si era trasferita a San Francisco. Per un decennio, fu afflitta da una grave forma di depressione. Quando aveva quasi cinquant'anni, decise di iscriversi al Sierra Club e, partecipando ad escursioni all'aria aperta insieme a persone innamorate della natura, incominciò a recuperare la salute del corpo e dello spirito. La natura californiana l'affascinò tanto che nel 1921, a cinquantun anni, decise di iscriversi al corso di Scienze naturali all'Università di Berkeley. Nel 1922, partecipando a una spedizione paleontologica, scoprì il fascino delle piante e della loro raccolta; si iscrisse a un corso sulle piante da fiore presso la Hopkins Marine Station e prese parte alle escursioni organizzate dal Calipso Club, il club degli studenti di botanica. Sicuramente determinante fu l'incoraggiamento di Alice Eastwood, curatrice dell'erbario dell'Accademia della Scienze californiana e capo del dipartimento di botanica, che le insegnò come raccogliere e preparare gli esemplari. La prima spedizione ufficiale arrivò nel luglio 1925; Mexía, che quell'anno compiva 55 anni, si unì a un viaggio botanico nello stato di Sinaloa in Messico organizzato dall'Università di Stanford e guidato da un'altra botanica, Roxanna Ferris. Come oriunda messicana, conosceva bene la lingua e il paese, ma soprattutto rivelò un vero talento come raccoglitrice: aveva un occhio acuto nel riconoscere le piante ed era molto meticolosa e abile nel preparare gli esemplari. Ne aveva già raccolti più di 500, quando cadde da una scogliera, ferendosi una mano e fratturandosi alcune costole. Dovette forzatamente abbandonare la spedizione, ma al suo ritorno negli Stati Uniti, impressionato dalla qualità delle sue raccolte, il capo dell'erbario dell'Università della California le commissionò un secondo viaggio, di nuovo in Messico. Strinse anche amicizia con un'assistente dell'Erbario dell'Accademia delle Scienze della California, Nina Floy Bracelin, che si offrì di aiutarla a catalogare le future raccolte. A questo punto, Ynés Mexía era ormai una raccoglitrice professionista, con un lavoro che dava senso alla sua vita: "Ho un lavoro che produce qualcosa, e qualcosa di duraturo". Nel settembre 1926 si imbarcò alla volta di Mazatlan sulla costa pacifica del Messico, da dove iniziò una spedizione di sei mesi in zone dell'interno poco conosciute; viaggiava sola, servendosi di guide locali, che erano anche ottimi informatori. Muovendosi ora a piedi ora a cavallo, alla fine del viaggio, nell'aprile 1927, aveva raccolto oltre 3000 esemplari, tra cui 50 specie non ancora descritte, e un genere sconosciuto, che in suo onore sarà denominato Mexianthus. Mexía, che non amava il lavoro di scrivania e definiva se stessa più un'avventuriera che una botanica, affidò la "post produzione" a Nina Floy Bracelin, che riordinava le collezioni, etichettava gli esemplari e li inviava ad esperti per l'identificazione; in tal modo divenne anche la sua agente e mantenne i rapporti con una vasta rete di botanici. Nell'estate del 1928, sempre per l'Università della California, si spostò in Alasaka, nel Mount Mc Kinley Park, dove raccolse oltre 6000 esemplari. Alla fine dello stesso anno, fu in Messico per la terza volta. Nell'autunno del 1929, si imbarcò per il Brasile, dove esplorò le terre alte per circa un anno e mezzo; per qualche tempo, si accompagnò con un'altra botanica autodidatta come lei, Mary Agnes Chase, un'esperta di graminacee; ma tutte e due erano troppo testarde per andare d'accordo, tanto più che Mary Agnes preferiva viaggiare in treno e dormire in un albergo decente, mentre Ynés era a suo agio viaggiando a cavallo e dormendo sotto una tenda. Ancora il Brasile fu la meta della spedizione del 1931, quella più celebre; l'obiettivo era risalire il corso del Rio delle Amazzoni. La prima parte della navigazione si svolse a bordo di un comodo piroscafo, un vero lusso rispetto alle abitudini di questa viaggiatrice spartana. Dopo 24 giorni, Mexía sbarcò a Iquitos in Perù, assunse tre guide e quattro rematori, per risalire il Maranon in canoa: era esattamente il percorso fatto da La Condamine nel Settecento, ma al contrario: non lasciarsi trasportare dalla corrente del grande fiume, ma risalirlo remando controcorrente: una scelta audace perfettamente in linea con il carattere di Ynès. Dopo aver superato il temibile Pongo de Manseriche , all'inizio della stagione delle piogge Mexía stabilì la sua base a Rio Santiago; esplorò il fiume e i suoi affluenti, scalò la Sierra del Pongo, senza farsi spaventare dalle pareti a strapiombo. E ovviamente, raccolse piante su piante. L'ingrossamento delle acque rendeva impossibile affrontare il viaggio di ritorno in canoa; Mexía convinse i rematori a costruire una grande zattera di legno di balsa. A bordo di questa imbarcazione scese il fiume fino a Iquitos, da dove spedì le raccolte in California. Lei prese un'altra strada: prima in aereo, poi a dorso di mulo, quindi in automobile, infine in treno, arrivò a Lima dove si imbarcò per San Francisco; era di ritorno nel marzo 1932. Questa spedizione, probabilmente la più importante tra quelle intraprese dall'indomita raccoglitrice, fruttò 65.000 esemplari. Non rimase a casa a lungo. Nel 1933 si accontentò di una breve spedizione casalinga in Nevada, Utah, Arizona e California con Alice Eastwood e il suo assistente, John Thomas Howell, a bordo di una Ford T. Tuttavia già nel 1934 tornò in Sud America per incarico dell'Ufficio per le piante industriali del Dipartimento di Agricoltura che aveva stabilito una stazione sperimentale in Ecuador; il suo compito era raccogliere le diverse specie di Cinchona e soprattutto cercare una rara palma della cera, Ceroxylum ventricusum, che vive a oltre 3000 metri d'altitudine nelle foreste pluviali d'altura tra Colombia e Ecuador. Con un assistente viaggiò in treno da Quito a Ibarra, poi in automobile fino a Tulcàn, dove assunse una guida locale e affittò dei cavalli per risalire le pendici del Chiles, un vulcano al confine tra i due paesi, dove era stata segnalata la pianta. La pioggia incessante li costrinse ad accamparsi in una torbiera, creando una tenda improvvisata con vestiti e bagagli; nel cuore della notte, furono risvegliati da un terremoto. Come se non bastasse, Ynés rischiò di morire per aver ingerito alcune bacche avvelenate. Per fortuna, uno degli accompagnatori riuscì a fargliele rigettare solleticandole la gola con una piuma di gallina. Tutti ormai volevano tornare indietro, tranne l'ostinata cacciatrice di piante, che convinse gli altri a continuare. E alla fine, trovò la sospirata palma. Il suo viaggio proseguì poi attraverso il Perù, la Bolivia, l'Argentina, il Cile fino allo Stretto di Magellano, con la raccolta di altri 15.000 esemplari. Nel 1938, l'ultima spedizione, di nuovo in Messico, questa volta negli Stati di Guerrero e Oaxaca. Ynés, che probabilmente era malata da tempo senza saperlo, incominciò a soffrire di dolori allo stomaco, che la costrinsero riluttante a rientrare negli Stati Uniti, dove le diagnosticarono un cancro ai polmoni; morì appena un mese dopo. Del resto, lei che nelle sue spedizioni preferiva dormire all'aperto anche quando era disponibile una sistemazione più comoda, non si sarebbe rassegnata a una lunga degenza in un ospedale. Nel suo testamento, lasciò un lascito all'Accademia delle Scienze, in modo che la fedele Nina fosse assunta come assistente di Alice Eastwood. Ynés Mexía fu sicuramente il più importante raccoglitore della flora sudamericana della sua epoca. Un risultato tanto più straordinario se si pensa che la sua carriera durò solo tredici anni, dal 1925 al 1938. Percorrendo il continente dall'Alaska alla Terra del fuoco, raccolse oltre 145,000 esemplari, incluse 500 nuove specie, 50 delle quali portano il suo nome. Anche se non si laureò mai, era spesso invitata a parlare dei suoi viaggi, di cui pubblicò resoconti in varie riviste, e il suo nome divenne molto conosciuto tra i botanici. Occasionalmente partecipò a spedizioni di gruppo, ma, come abbiamo già visto, preferiva viaggiare da sola (cosa inaudita per una donna a quei tempi), come spiegò essa stessa: "Un ben noto raccoglitore e esploratore ha asserito che era impossibile per una donna viaggiare da sola nell'America Latina. Io ho deciso che se volevo conoscere meglio il continente sud-americano il modo migliore era aprirmi la strada da me. Bene, perché no?". Una sintesi della sua vita avventurosa nella sezione biografie.  A caccia di piante rare: Mexianthus mexicanus Buona parte delle piante scoperte da Ynés Mexía sono rari endemismi, spesso minacciati. Del resto, come abbiamo visto, preferiva andarle a scovare in territori difficili da raggiungere, ancora inesplorati o almeno poco battuti. Non fa eccezione Mexianthus, il genere che raccolse nella sua prima spedizione solitaria, nel 1925, e che le fu dedicato nel 1928 da Benjamin Lincoln Robinson dell'Erbario di Harvard, con la seguente motivazione: "E' un piacere dedicare questa notevole pianta alla sua scopritrice, la sig.a Ynes Mexia, la cui coraggiosa esplorazione di parti poco note della Sierra Madre ha portato alla luce molte piante sconosciute alla scienza o altrimenti di speciale interesse". Nella flora messicana, che conta ben 30.000 specie, il dieci per cento è costituito da Asteraceae, con circa 3000 specie e ben 1300 endemismi. Tra di essi anche il raro Mexianthus mexicanus, l'unica specie di questo genere endemico dello stato di Jalisco, dove è stato raccolto solo in tre stazioni nei pressi di Puerto Villarta, a circa 500 metri d'altitudine, dove vive su substrato vulcanico nelle foreste subtropicali decidue. Purtroppo in rete sono disponibili solo fotografie di esemplari d'erbario. E' un'alta perenne suffruticosa, con foglie alternate da ovate a ellittiche, con punta acuminata e margini dentati. A renderla speciale sono le infiorescenze, con capolini con un singolo flosculo e corolla bianca, riuniti in sinfiorescenze globose, a loro volta portate in un'infiorescenza secondaria terminale a spiga sparsa. I frutti sono acheni con pappi scagliosi. Una breve presentazione nella scheda. Nei primi giorni di primavera, è in fioritura anche una vecchia ospite dei nostri giardini, la maonia, o meglio Mahonia aquifolium, una pianta che siamo talmente abitati a vedere che forse dimentichiamo che ben pochi altri arbusti sono così poco esigenti e capaci di rallegrare anche un giardino d'ombra durante tutto l'arco dell'anno; in primavera appunto con i fiori dorati e dolcemente profumati, in estate con le bacche blu profondo, in autunno con le foglie rossastre, in inverno con il fogliame sempreverde. Arrivò nei giardini europei nel 1822, pochissimi anni dopo che Lewis e Clark la scoprirono nelle Montagne rocciose; a darle il nome fu un altro esploratore della flora del Nord America, Thomas Nuttall, che volle così onorare un pioniere del giardinaggio americano, Bernhard McMahon. Vivaista a Filadelfia, egli produsse il primo catalogo di sementi del paese e scrisse il manuale di giardinaggio più letto negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento, un best seller il cui successo durò mezzo secolo. Tra i suoi clienti anche Jefferson, che lo stimava tanto da affidargli, perché li coltivasse e li moltiplicasse, i semi di numerose piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark.  Un vivaista intraprendente Per volontà del presidente Jefferson, che considerava la botanica la "più utile delle scienze", le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark non solo furono inviate alla American Philosophical Society e Benjamin S. Barton perché le studiasse (scelta infelice, come abbiamo visto in questo post), ma semi, radici e bulbi vennero affidati a abili giardinieri perché li coltivassero e moltiplicassero. Qualche specie rimase nelle aiuole di Monticello, la tenuta del presidente, ma il grosso venne distribuito tra il ricco piantatore William Hamilton, proprietario di un celebre orto botanico privato nei pressi di Filadelfia, e Bernhard McMahon, che nella stessa città gestiva un vivaio e una ditta di sementi. Emigrato dall'Irlanda nel 1796, McMahon fondò la sua impresa nel 1802; avendo lavorato per qualche tempo presso un giornale, era consapevole dell'importanza della stampa e decise di pubblicizzare i suoi prodotti con un catalogo, il primo del genere negli Stati uniti; Catalogue of Garden Grass, Herb, Flower, Tree & Shrub-Seeds, Flower Roots, &c, pubblicato nel 1802-03, comprende 720 specie e varietà di semi, nella maggioranza dei casi di piante di origine europee. Una maggiore attenzione alle piante native si nota già nella seconda edizione (1804). Uomo di notevole intraprendenza e intelligenza, McMahon cominciò anche a seguire le lezioni di Benjamin S. Barton, che, proprietario della prima serra della città, divenne uno dei suoi clienti. Appassionato raccoglitore oltre che coltivatore, spesso inviò al professore esemplari di piante interessanti trovate nei dintorni della città, che scambiava anche con altri botanici come Henry Muhlenberg. Intanto aveva incominciato a lavorare alla sua opera più nota, The American Gardener's Calendar: Adapted to the Climates and Seasons of the United States, la cui prima edizione uscì nel 1806; un testo di grande successo, come testimoniano le sue undici edizioni, l'ultima delle quali pubblicata quarantanni dopo la morte dell'autore. Modellato su analoghe opere britanniche, in particolare Gardener's Dictionary di P. Miller e Every Man his own Gardener di J. Abercrombie, segue la tradizionale presentazione dei lavori mese per mese, con indicazioni per la preparazione del suolo, le semine, gli impianti, le potature. Il capitolo "Ornamental Designs and Plantings", ritenuto il primo saggio sulla progettazione dei giardini paesaggistici pubblicato in America, contribuì largamente alla diffusione oltreoceano della nuova moda del giardino paesaggistico e naturalistico. Anche se la maggior parte delle piante illustrate nel calendario erano quelle tradizionalmente coltivate in Europa, McMahon incoraggiava i suoi lettori a imitare la natura e ad accogliere le specie americane, lodando in particolare la bellezza degli alberi, degli arbusti da fiore e dei fiori selvatici, di cui sottolineava la robustezza e la maggiore adattabilità alle roventi estati americane. In ciò incontrava le inclinazioni di Jefferson, che seguì le sue indicazioni quando creò la bordura fiorita e le aiuole ovali di Monticello; con il vivaista, divenuto anche il suo principale fornitore di piante e sementi, scambiò una cordiale corrispondenza e, come ho già anticipato, lo scelse per coltivare e custodire parte delle collezioni vive di Lewis e Clark. Tra i primi invii, giunti già nel 1805 da Fort Mandan, il "tabacco di Mandan", ovvero Nicotiana quadrivalvis, e Linum lewisii. Nel 1807, quando, in vista della pubblicazione del resoconto ufficiale della spedizione, si cercava un illustratore botanico, fu McMahon a suggerire il tedesco Frederick Pursh, che all'epoca lavorava per Barton come curatore dell'erbario e raccoglitore. Pursh si stabilì a casa sua, per poter ritrarre sia gli esemplari essiccati sia le piante coltivate nel vivaio, di cui scrisse anche le descrizioni; rimase ospite di McMahon fino alla fine del 1808, sempre più nervoso e impaziente mano a mano che capiva che probabilmente Barton non avrebbe mai scritto i capitoli sulla flora che Jefferson si attendeva da lui. Nella sua corrispondenza con il presidente, McMahon espresse grande entusiasmo per l'alta qualità dei semi ricevuti da Lewis; nel 1807 ne coltivava 20 nuove specie e 5 o 6 nuovi generi; particolarmente interessanti riteneva alcuni nuovi tipi di ribes e uva spina, tra cui il magnifico Ribes aureum, con fragranti fiori gialli. Nel 1808, acquistò 20 acri di terreno a Germantown Road per costruire un vivaio più ampio e un giardino botanico che, in onore di Linneo e della sua università, chiamò Upsal Botanic Garden; secondo la testimonianza di Muhlenberg, incominciò a impiantarlo l'anno successivo. Nel 1815, usciva una nuova edizione del catalogo di sementi. McMahon morì l'anno successivo, con un solo cruccio. Le piante che gli erano state affidate da Jefferson e coltivava con tanta dedizione erano di proprietà federale, non poteva né commercializzarle né pubblicarle; dopo la tragica morte di Lewis, non aveva esitato a restituire a Clark tutti gli esemplari essiccati depositati presso di lui, nella speranza che Barton, o qualche altro botanico americano, pubblicasse finalmente le piante raccolte durante la famosa spedizione; a farlo invece fu Frederick Pursh, che nel 1811 si era trasferito a Londra, portando con sé i disegni e le descrizioni, e nel 1813 vi pubblicò Flora America septentrionalis che contiene le immagini e le descrizioni di 130 delle specie raccolte da Lewis. Dopo la morte di McMahon (una sintesi della sua vita nella sezione biografie), il vivaio fu gestito dalla vedova Ann e più tardi dal figlio Thomas P., che continuò a rivedere e pubblicare il calendario (l'ultima edizione è del 1857). Berberis o Mahonia? Un dibattito secolare
Durante la spedizione nel nord-ovest erano stati raccolti tre arbusti che Pursh assegnò al genere Berberis, con i nomi B. aquifolium, B. nervosus e B. repens. Nel 1818 Thomas Nuttall in The genera of North America ne separò le prime due, creando per loro il genere Mahonia, in onore del nostro valente vivaista, con questa motivazione: "In memoria del fu Bernhard McMahon, la cui passione per la botanica e l'introduzione, coronata dal successo, di piante utili e ornamentali negli Stati Uniti rivendica la pubblica stima". Era l'inizio di un dibattito durato due secoli. Mentre le Mahoniae facevano la conquista dei nostri giardini, i botanici si combattevano a colpi di dotti articoli, assegnandole ora a un genere proprio ora includendole in Berberis. Le differenze tra i due generi sono sottili: i fiori sono identici, ma Berberis ha foglie semplici e fusti spinosi, Mahonia foglie composte e fusti privi di spine. Alla fine del XX secolo, la bilancia - con dolore di appassionati, vivaisti e giardinieri - sembrava propendere per un vastissimo genere Berberis, con circa 600 specie; i sostenitori di questa tesi, che non convinse l'intera comunità scientifica ma fu accolta dai maggiori repertori come Plant list o Plants of the World, sottolineavano come i due generi si incrociano tra loro, producendo gli ibridi x Mahoberberis (che però, va ricordato, sono tendenzialmente sterili). Tuttavia il dibattito continuava. Tra chi era meno convinto, i botanici cinesi - la Cina è il centro di diversità di Mahonia, con circa il 50% delle specie sul suo territorio; fu così che un'équipe dell'Università di Taiwan, diretta dal professor Yu, decise di studiare a fondo il gruppo di Mahoniae più problematico, quello che più si avvicina a Berberis, Mentre le altre Mahoniae vivono in aree boschive, l'habitat di questo gruppo sono i deserti tra Stati Uniti meridionali e Messico; hanno foglie composte ma sono dotate di spine. Dopo sette anni di lavoro sul campo e in laboratorio per le analisi del DNA, l'importante studio è stato pubblicato nel 2017, ribaltando la situazione. Mahonia viene ristabilito come genere indipendente, più antico di Berberis di cui è presumibilmente l'antenato; ma ne vengono separati due piccoli generi nuovi: Moranothamnus (prima Mahonia claireae) e Alloberberis (prima Mahonia sezione horridae). Dunque, finalmente Mahonia. Nei limiti in cui è stato ridefinito, diventa il secondo genere per numero di specie della famiglia Berberidaceae, con circa sessanta rappresentanti tra Asia orientale (31 specie in Cina, di cui 27 endemiche), Asia himalayana, America settentrionale e centrale. Sono arbusti, in genere alti e espansi, con foglie pinnate e fiori raccolti in racemi, solitamente gialli. Molti sono popolari piante da giardino, a cominciare da Mahonia aquifolium, la specie tipo, arrivata in Europa nei prima anni '20 dell'Ottocento, divenendo subito molto comune, tanto da spontaneizzarsi in diverse aree. Più recente, almeno da noi, il successo delle più imponenti specie asiatiche a fioritura invernale, come M. japonica e soprattutto l'ibrida M. x media, la cui cultivar più nota è probabilmente 'Charity'. Qualche approfondimento su queste e alcune altre specie nella scheda. Acquisita l'indipendenza politica, gli Stati Uniti incominciano ad emanciparsi dal passato coloniale anche sul piano culturale e scientifico. Nel campo delle scienze naturali, figura chiave di questo momento di passaggio tra una scienza ancora eurocentrica e una scienza autenticamente americana è Benjamin Smith Barton, titolare della prima cattedra statunitense di botanica e scienze naturali; autore del primo manuale di botanica, Elements of Botany; istruttore di Lewis in preparazione della grande spedizione nel Nord Ovest; finanziatore dei viaggi botanici di Pursh e Nuttall. Dunque un padre fondatore a tutti gli effetti; ma anche una figura controversa, con una biografia segnata da vicende poco chiare, promesse mancate, opere annunciate e mai finite, senza parlare del pessimo carattere. Ambizioso e desideroso di gloria, nei suoi ultimi giorni provò conforto nel pensare che la sua memoria sarebbe stata preservata dal nome di una delle più belle specie delle praterie americane; la regola della priorità l'ha invece legato per sempre a un'altra Bartonia, una pianta minuscola e insignificante, in una sorta di giustizia poetica. 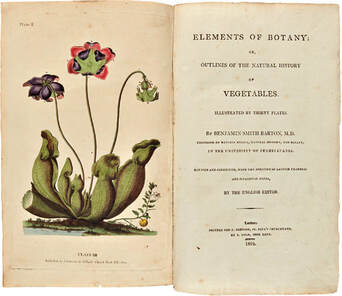 Un padre fondatore delle scienze naturali americane... I primi passi della scoperta della natura dei territori che diverranno gli Stati Uniti d'America si muovono in un'ottica ancora coloniale; europei sono i primi esploratori (come John Tradescant e John Clayton); quando John Bartram inizia i suoi viaggi, lo fa per soddisfare le esigenze di clienti britannici; ancora nei primi anni dell'indipendenza, il massimo protagonista dell'esplorazione botanica dell'America atlantica sarà il francese André Michaux. Europei erano anche i modelli teorici (prima quello di Linneo, poi quello di Jussieu) e i libri di testo, tutti regolarmente importati dal vecchio continente. Ma anche la scienza americana era desiderosa di emanciparsi e di acquistare la sua indipendenza; un processo di cui senza dubbio una delle figure chiave è Benjamin Smith Barton, titolare della prima cattedra universitaria di botanica degli Stati Uniti e autore del primo manuale di botanica, Elements of Botany, consulente di Jefferson che gli chiederà di istruire sulla natura e sui nativi il capitano Lewis, in preparazione della prima autentica spedizione naturalistica americana. Nel 1803, quando incontrò Lewis, Barton aveva appena pubblicato il suo manuale e, a soli trentasette anni, poteva già vantare una brillante carriera accademica. Gli inizi, tuttavia, era stati quanto meno imbarazzanti. Proveniente da una famiglia che vantava altri naturalisti (i più noti sono lo zio materno David Rittenhouse, eminente astronomo, e William P.C. Barton, anch'egli botanico e autore di Flora of North America), dopo aver seguito i corsi di medicina a Filadelfia, nel 1786, quando era appena ventenne, si spostò a Edimburgo con l'intenzione di laurearsi in quella prestigiosa università. Ambizioso e brillante, affascinante parlatore, con le sue conversazioni su popoli e piante native americane fu accolto con entusiasmo in quell'ambiente avido di esotismo; fu presto ammesso alla Royal Medical Society, di cui anzi divenne uno dei presidenti annuali, e ottenne un premio per un articolo sul giusquiamo nero (Hyosciamus niger); tuttavia dopo due anni, senza aver conseguito la laurea, lasciò precipitosamente la città. Secondo la vulgata familiare, era entrato in conflitto con alcuni insegnanti; visto il suo carattere ombroso, è più che possibile, ma a spingerlo alla fuga fu un prestito da parte della Medical Society che non poteva o non voleva onorare. Di lì passò in Germania. Quando nell'autunno del 1789 rientrò in patria senza alcun titolo universitario, si sparse la voce - che Barton non fece nulla per smentire, se non la diffuse egli stesso - che si fosse laureato presso la celebre Università di Gottinga. In ogni caso nei registri della Philosophical Society cui fu ammesso quello stesso anno il suo nome compare seguito dal titolo abusivo di "dottore in medicina". Sempre nel 1789 iniziò a praticare la professione medica e soprattutto gli venne assegnata la cattedra di storia naturale e botanica al Philadelphia College, due materie inedite nel curricolo universitario statunitense; incarico confermato due anni dopo, quando il Philadelphia College si fuse con l'Università di Pennsylvania. Nel 1790 fu ammesso al Collegio medico di Filadelfia; nel 1792 divenne membro dell'American Arts of Science; nel 1796, alla morte del precedente titolare, fu chiamato a reggere anche la cattedra di materia medica. A questo punto, essere privo di un titolo accademico poteva essere assai rischioso, tanto più che contava non pochi nemici; Barton cominciò così a sollecitare i suoi contatti europei per ottenere una laurea honoris causa; alla fine, pochi mesi prima che assumesse l'incarico, il sospirato titolo arrivò da una delle più oscure università tedesche, quella di Kiel. In ogni caso, Barton riuscì ad agire in modo così discreto che questa storia è stata scoperta solo intorno al 1970; fino ad allora, tutti - compresi gli storici - avevano presa per vera la laurea a Gottinga. Nonostante questo esordio fortunoso, Barton divenne presto una figura eminente del naturalismo americano. Come primo insegnante di storia naturale e botanica del suo paese, teneva affollate lezioni cui partecipavano non solo gli studenti di medicina, ma anche un pubblico di curiosi, comprese molte signore, che il professore sapeva affascinare toccando gli aspetti più diversi della natura americana. Divenne la figura centrale di un circolo di naturalisti che comprendeva anche il celebre raccoglitore William Bartram e il botanico Henry Muhlenberg. Anche grazie allo zio, David Rittenhouse, che era succeduto a Franklin come presidente della società, divenne il membro più giovane della American Philosophical Society, di cui poi fu vicepresidente dal 1802 al 1816; della società fu uno dei membri più attivi, pubblicando numerosi articoli che nel 1804 gli guadagnarono il Premio Magellano. Nel 1803 fondò la Philadelphia Linnean Society, di cui fu il primo presidente; dal 1809 alla morte fu anche presidente della Philadelphia Medical Society. Abile gestore della propria fama, seppe anche ingraziarsi i potenti in patria come all'estero. Era in corrispondenza con molti naturalisti europei, tra cui Banks (cui dedicò Elements of Botany); quanto a Jefferson, tra lui e il presidente esisteva un legame speciale da quanto gli aveva dedicato il genere Jeffersonia (come ho raccontato in questo post). Scrisse moltissimo (oltre che di medicina e botanica, di zoologia, mineralogia, geologia, antichità e lingue indiane, di cui fu un grande cultore), soprattutto articoli brevi che pubblicò dapprima nelle Transactions dell'American Philosophical Society, poi in Medical Physical Journal, la rivista medica che fondò e diresse per molti anni. Come ho anticipato all'inizio, nel 1803 uscì la prima edizione della sua opera più nota, Elements of Botany, il primo manuale di botanica scritto negli Stati Uniti, un testo di successo che raggiunse le sei edizioni, tre delle quali durante la vita dell'autore. Importante anche Collections for an Essay towards Materia Medica of the United States, che nella terza edizione (1810) descrive oltre un centinaio di piante officinali native e le loro proprietà mediche. Tra i suoi contributi più interessanti, vale anche la pena di citare A discourse on some of the principal desiderata in natural history: and on the best means of promoting the study of science in United States, letto da Barton nel giugno 1807 alla Linnean Sopciety, in cui tracciò un lucido programma di ricerca per gli scienziati della nuova nazione; per limitarci alla botanica, poneva tra i principali obiettivi lo studio delle crittogame, l'attenzione alla distribuzione geografica delle piante, gli studi comparativi, le acquisizioni dei nativi sulle piante medicinali e alimentari. E' dunque logico che Jefferson abbia inviato proprio a lui Lewis, perché gli aprisse le porte degli studiosi di Filadelfa (cosa che Barton non fece, o fece con riluttanza) e gli impartisse un corso accelerato di botanica e zoologica. Il professore non solo insegnò al capitano come raccogliere, conservare correttamente e etichettare gli esemplari, ma decise che doveva assolutamente partire anche lui, o almeno accompagnare la spedizione per un tratto. A questo punto va detto che egli, come riferisce a denti stretti il nipote e biografo William, soffriva di quello che oggi chiameremmo disturbo bipolare, sempre oscillante tra esaltazione e depressione; a ogni nuova occasione, a ogni nuovo soggetto di ricerca, si entusiasmava e si lanciava in vasti progetti, salvo poi abbandonarli per noia non appena dall'ideazione bisognava passare alla realizzazione concreta. L'idea di partire con Lewis sarà stato dunque un sogno, un fuoco fatuo tipico del suo carattere, che probabilmente egli stesso - un valetudinario cronico che soffriva di tubercolosi e di attacchi invalidanti di gotta - era il primo a non prendere sul serio. Dunque Lewis partì senza Barton, ma portando con sé come sostituito una copia fresca di stampa dei suoi Elements of Botany. Comunque Jefferson contava su di lui per pubblicare i risultati scientifici della spedizione, tanto che egli fu il destinatario del primo invio da Fort Maidan; ma la sospirata Storia naturale della spedizione di Lewis e Clark andò ad allungare la lista delle sue opere "fantasma". 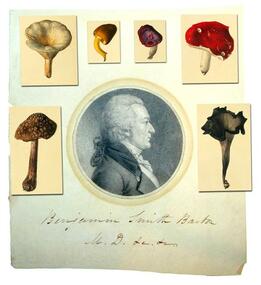 ... con un lato oscuro Dopo aver elencato i successi, il lato luminoso del nostro professore, è infatti venuto il momento di parlare del suo lato oscuro. Quella non fu l'unica opera promessa, ma mai scritta. Egli in effetti fu uno scrittore prolifico, ma farraginoso e prolisso, che dava il meglio di sé in testi brevi; la sua bibliografia è costellata di opere di più ampio respiro annunciate, progettate, a volte iniziate, poi abbandonate. Ma c'è di peggio. Ambizioso e avido di successo, non era sempre corretto verso gli altri ricercatori, tanto da essersi attirato l'accusa di plagio. L'ornitologo Charles Willson Peale lo accusò, probabilmente a torto, di essersi impadronito di alcuni esemplari destinati al suo museo e espresse la convinzione che "non si è mai fatto scrupolo di prendere le penne degli altri per arricchire il suo piumaggio". In effetti, gli studiosi hanno rilevato che non di rado fece passare per proprie idee altrui, senza citare la fonte né aver ottenuto l'autorizzazione dell'autore. A suscitare polemiche fu anche la pubblicazione di Jeffersonia diphylla, che non si basava su ricerche proprie, ma su raccolte di André Michaux e William Bartram. Ancora più criticato fu per la riluttanza a scambiare informazioni e materiali, secondo la secolare consuetudine dei naturalisti; ad esempio Henry Muhlenberg, che pure gli fu amico, lamentava che mentre lui gli aveva mostrato il suo erbario, Barton non aveva mai contraccambiato il favore. D'altra parte, bipolare anche in questo, sappiamo che a volte fu assai generoso con la sua preziosissima biblioteca, la più completa degli Stati Uniti per la storia naturale, prestando ad altri studiosi volumi altrimenti introvabili nel paese. Barton era più un teorico, un botanico da scrivania, che un ricercatore sul campo. Il suo erbario, conservato alla Natural Science Academy di Filadelfia, comprende 1674 esemplari, ma solo circa 200 furono raccolti da lui, per lo più nei pressi della città o della tenuta di famiglia. E' nota una sola spedizione di un certo impegno cui partecipò di persona, da New York fino alle Cascate del Niagara, ma anche in questo caso si dedicò più all'osservazione dei costumi dei nativi che alla raccolta di piante. L'erbario fu dunque messo insieme con acquisti e con il contributo di almeno una trentina di raccoglitori, molti dei quali suoi studenti. L'apporto maggiore (circa 1200 esemplari) tuttavia venne da Federick Pursh che egli assunse nel 1805 perché lo aiutasse a completare il suo maggiore progetto: una flora del Nord America, che avrebbe dovuto includere anche le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Probabilmente Barton aveva iniziato a lavorarci subito dopo la pubblicazione di Elements of Botany e nel 1806 ne pubblicò un'anticipazione dal titolo chilometrico: Prodromus of a Flora of the States of New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland and Virginia. Riccamente illustrata dal pittore francese Turpin, fu stampata in 500 copie, ma non se ne è conservata neppure una. Come mai? Fu l'autore stesso a ritirare tutta l'edizione e a farla distruggere. L'ipotesi più probabile è che, lavorando insieme a Pursh, un eccellente tassonomista formatosi in Germania, che catalogò con ammirevole e teutonica precisione il suo erbario, Barton si sia reso conto di aver commesso molti errori e abbia preferito eliminare un'opera che, più che la sua gloria, avrebbe sancito la sua mediocrità di sistematico e tassonomista. L'opera andava riscritta e ampliata. A tal fine finanziò i viaggi di ricerca di Pursh che al suo servizio nel 1805 esplorò le regioni montane della Carolina e della Georgia e nel 1806 le montagne della Pennsylvania e del Vermont. L'anno successivo, di ritorno da una spedizione che lo aveva portato nello stato di New York e ancora nel Vermont, Pursh preferì non rientrare a Filadelfia e accettare l'incarico di curatore dell'orto botanico di New York. In tal modo, recuperava la sua indipendenza scientifica, e si liberava di un "patrono" mai troppo generoso, collerico e probabilmente geloso della sua competenza. Barton, privato del suo principale collaboratore, si trovò impossibilitato a proseguire, finché la dea bendata fece arrivare alla sua porta un giovanotto entusiasta con una pianta da riconoscere. Era il ventiduenne Thomas Nuttall, un apprendista stampatore britannico con la passione per le scienze naturali. Barton, che, colpito dal suo entusiasmo e dalle sue buone maniere, ne fece il suo pupillo, gli insegnò il sistema di Linneo e lo spronò a studiare ed esplorare la natura americana, sull'esempio di William Bartram. Dopo averlo messo alla prova con alcuni brevi viaggi, nel 1810 finanziò la prima grande spedizione di Nuttall fino ai Grandi laghi, con una paga di 8 dollari al mese più le spese; le osservazioni e i quaderni di campo sarebbero stati di esclusiva proprietà di Barton, ma il raccoglitore poteva tenere per sé la propria copia degli esemplari; esattamente il contrario di ciò che avveniva di solito: il finanziatore/collezionista esigeva per sé una o più copia dei materiali, ma il ricercatore manteneva la proprietà intellettuale delle proprie scoperte. Tuttavia anche questa collaborazione finì bruscamente, quando l'imminente scoppio della guerra del 1812 con l'Inghilterra spinse Nuttall a tornare in patria. Del resto, anche le forze di Barton andavano declinando. Morì nel 1815, al rientro da un viaggio in Europa grazie al quale aveva sperato di recuperare la salute. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Termino con una curiosità: la prestigiosa rivista Bartonia, organo del Philadelphia Botanical Club, non è dedicata a lui, ma a suo nipote William Paul Crillon Barton, autore di Compedium Florae Philadelphicae (1818) e A Flora of North America (1821), che dello zio fu allievo, biografo e successore per la cattedra di materia medica.  Bartonia, ovvero botanica e giustizia poetica Tre giorni prima di morire, Barton aveva terminato il suo ultimo articolo, su un argomento che gli era molto caro: una pianta che nel 1812 Sims aveva denominato Bartonia decapetala, sulla base di materiali raccolti da Pursh e da Nuttall. Concordi sulla dedica al loro patrono, il primo, a quanto pare, avrebbe voluto chiamarla B. ornata, il secondo addirittura B. superba. In ogni caso, una pianta magnifica, con spettacolari fiori bianchi che si aprono di notte, che riempiva d'orgoglio il vecchio professore. Ma anche nella botanica c'è una giustizia poetica, che assume le petulanti vesti della legge della priorità. Molti anni prima, Henry Muhlenberg aveva già creato un genere Bartonia, pubblicato nel 1801 con tutti i crismi da Willdenow. Niente di cui andare orgogliosi, ahimè: si tratta di uno dei più insignificanti generi della famiglia Gentinaceae, minuscole annuali erbacee che passano quasi inosservate. Vivono nelle paludi, alcune specie in mezzo allo sfagno, da cui quasi non si distinguono se non durante la fioritura, e, come adattamento a un ambiente così povero di nutrienti, sono emiparassite che si nutrono a spese delle piante vicine, con foglie ridotte a scaglie insufficienti ad assicurare una sufficiente fotosintesi. Muhlenberg ovviamente di questo non poteva sapere nulla (dedicò a Barton B. verna, una specie che avevano raccolto insieme) ma non spiace che a ricordare il troppo vanaglorioso professore, accusato dai detrattori di adornarsi delle penne altrui, sia Bartonia Muhl. ex Willd. e non la più appariscente Bartonia Pursh ex Sims. Il piccolissimo genere comprende tre specie, endemiche degli Stati Uniti orientali. Legate ad ambienti fragili e sempre più ridotti, sono piuttosto rare: B. virginica è inclusa nella lista rossa delle specie a rischio mentre B. paniculata subsp. paniculata in Canada è oggetto di programmi di conservazione. Ancora non del tutto spiegati i meccanismi della sua nutrizione: secondo alcuni studiosi, sono saprofite mentre alcuni studi recenti mostrano evidenze di micorrize che permetterebbero di assorbire i nutrienti dall'apparato radicale delle piante circostanti. Un breve profilo delle tre specie nella scheda. Quella dell'americano Thomas Horsfield è la storia prima di un innamoramento, poi di un'amicizia: l'innamoramento per l'isola di Giava da cui nasce una vocazione di naturalista, così prorompente da farne il primo studioso della natura di quell'isola, che esplorò quasi palmo palmo per diciotto anni, dapprima senza il sostegno di alcuna istituzione, se non un gruppo di appassionati; l'amicizia con T. S. Raffles, che gli permetterà di continuare le sue ricerche in più grande stile e lo introdurrà negli ambienti scientifici londinesi. Botanico, zoologo, entomologo, vulcanologo, ha lasciato il suo nome a molte specie di animali e al genere Horsfieldia. 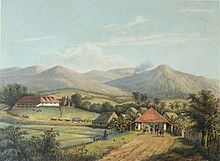 Un naturalista poliedrico e instancabile Nell'anno 1800, un giovane medico della Pennsylvania, Thomas Horsfield, si imbarcò come chirurgo di bordo sul mercantile "China"; il breve scalo a Batavia (la capitale delle Indie Olandesi, nell'isola di Giava) cambiò per sempre la sua vita: "Fui così deliziato - sono parole sue - dalla bellezza di quello scenario, dalla magnificenza e dall'abbondanza della vegetazione, dalla ricchezza delle sue risorse in tutti i campi delle scienze naturali, che nella mia mente sorse il desiderio di conoscerla meglio". Tornato a casa, si procurò tutti i libri possibili sull'argomento, gli strumenti indispensabili, i materiali necessari per la raccolta e la conservazione degli esemplari e di lì a un anno era di nuovo a Giava. Vi avrebbe trascorso 18 anni, esplorando ogni angolo dell'isola e divenendo il primo occidentale (se si eccettua Louis Auguste Deschamps, che però aveva potuto accedere solo alla regione limitrofa a Batavia) a studiarne estesamente la flora, la fauna, la geologia. La Compagnia olandese delle Indie Orientali era estremamente gelosa delle sue prerogative e sospettosa di ogni straniero, tanto più in quegli anni di guerra. Per rimanere a Giava e iniziare le sue ricerche, proprio come Deschamps qualche anno prima, Horsfield entrò al suo servizio come chirurgo. Gli era vietato esplorare l'interno, ma gli fu permesso di visitare i distretti di Buitenzorg (oggi Bogor) e Tijanjur, a sud di Batavia, per studiare le piante medicinali usate dai nativi. Frutto di circa un anno di lavoro fu una relazione presentata al Comitato della Società di Arti e Scienze di Batavia, che attrasse l'attenzione del Governo e guadagnò a Horsfield il permesso di estendere le sue ricerche, oltre che alle piante medicinali, ad altri campi della botanica, alla zoologia e alla geologia. La Società (un'associazione privata creata da alcuni appassionati) decise anche di finanziare, sia pure non copiosamente, le sue ricerche e di pubblicarne i risultati sul proprio bollettino. Dopo aver visitato i dintorni di Batavia e il Priangan, all'inizio del 1804 fu autorizzato ad esplorare le regioni orientali dell'isola. Poté così visitarne le principali catene vulcaniche, dove raccolse molti esemplari della peculiare vegetazione di alta quota. Visitò la capitale del principato di Yogyakarta e le rovine del tempio di Prambanan. In un'altra escursione, percorse la costa meridionale in tutta la sua lunghezza. La spedizione più impegnativa si estese dal 1805 al 1807, portandolo a Surakata, la capitale dell'altro principato indipendente, di cui esplorò a fondo i dintorni nel corso di diverse escursioni, quindi a Surabaya, da cui si mosse per un giro generale della provincia più orientale, che percorse in lungo e in largo in tutte le direzioni: visitò estese foreste di teak, vide un vulcano eruzione, scalò montagne, osservò la preparazione dell'upas, ovvero un potente veleno il cui ingrediente principale era il succo di Antiaris toxicaria. In quest'area ricca anche di fauna individuò un viverride ancora sconosciuto, che assegnò al genere Prionodon. Visitò anche brevemente l'isola di Bali. Impossibilitato a tornare a Batavia per lo stato delle strade, si stabilì a Surakata, dove gli fu concesso dal governatore di lasciare in deposito le sue collezioni (sempre più ricche di animali, piante, minerali, disegni e mappe) per continuare le sue ricerche nei distretti meridionali e occidentali; iniziò anche a studiare le metamorfosi dei lepidotteri. Mentre era impegnato in queste attività, nel 1811 l'isola di Giava fu occupata dagli inglesi. Dapprima Horsfield guardò con preoccupazione questi rivolgimenti, temendo di perdere il frutto di nove anni di lavoro, come dipendente dal governo olandese. Il maggiore Robinson, Commissario della Compagnia, gli concesse di continuare le sue ricerche anche se senza alcun sostegno finanziario, in attesa di ordini superiori. Tuttavia nel novembre 1811 il nuovo governatore inglese, Thomas Stamford Raffles, giunse a Surakata in visita ufficiale al sultano; esaminò le collezioni di Horsfield e, comprendendone l'eccezionale valore, gli propose di entrare al servizio della Compagnia delle Indie britannica, che da quel momento avrebbe finanziato le ricerche del naturalista statunitense molto più generosamente degli olandesi. L'anno successivo lo inviò a Bangka (un'isola lungo la costa orientale di Sumatra) come membro della commissione che doveva studiare l'opportunità di un insediamento commerciale britannico; nel corso di due soggiorni, il naturalista statunitense esplorò anche quest'isola (che, a paragone con Giava, gli pareva misera e incivile; corse anche il rischio di rimanere ucciso, in seguito a un banale incidente in cui il suo disegnatore perse la vita e lui buona parte delle sue raccolte). Tornato a Giava, dedicò l'estate del 1814 all'esplorazione delle regioni occidentali appartenenti ai principati indipendenti, visitando tra l'altro le grotte delle rondini salangane (Collocalia esculenta). Per impulso di Raffles, che lo mise anche in contatto con Banks e Robert Brown, gli interessi di Horsfield si stavano sempre più spostando verso la zoologia: mentre gli esemplari botanici di maggiore interesse venivano inviati a Kew, gli animali andavano ad arricchire il Museo della Compagnia delle Indie, fondato nel 1801. La Gran Bretagna restituì ufficialmente Giava agli Olandesi nel 1815; dopo la definitiva partenza di Raffles (trasferito a Bencoolen nell'isola di Sumatra, che Horsfield visitò brevemente), avendo ottime relazioni anche con le vecchie autorità, poté trattenersi a Giava ancora un anno. All'inizio del 1819, costretto anche da ragioni di salute, lasciò definitivamente l'amatissima isola, giungendo a Londra a luglio. 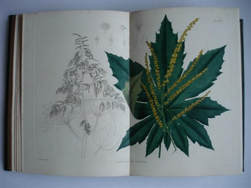 Una faticosa impresa editoriale a sei mani I molti anni che gli rimasero ancora da vivere (morì nel 1859, a 86 anni; una sintesi della sua vita nella sezione biografie) furono dedicati non più alla ricerca sul campo, ma alla sistemazione e alla pubblicazione delle raccolte proprie e altrui, con un interesse sempre più preponderante per la zoologia. Sicuramente grazie all'appoggio di Raffles, venne assunto come conservatore del Museo della Compagnia delle Indie, agli ordini del primo curatore, Charles Wilkins, cui più tardi succedette. Tra il 1821 e il 1824, pubblicò la sua opera più nota, Zoological Researches in Java and the neighbouring islands, che presenta una sintesi della fauna della grande isola indonesiana, con note sulla tassonomia, le caratteristiche morfologiche e il comportamento di primati, pipistrelli e uccelli, basandosi anche sulle osservazioni di altri studiosi, incluso Raffles. Quando quest'ultimo creò la Società zoologica di Londra (1826), lo volle accanto a sé come segretario; nel 1828 fu ammesso alla Royal Society. Come conservatore e poi curatore dell'India Museum, dove affluiva una crescente massa di esemplari di animali dal subcontinenti indiano, Horsfield fu impegnato a esaminarli, identificarli e catalogarli; ne risultò la descrizione di sei nuove specie di mammiferi dell'India e delle regioni limitrofe: i pipistrelli Rhinolophus affinis, Hipposideros larvatus, Kerivoula hardwickii, Scotophilus heathii, il gatto dorato Pardofelis temminckii e lo scoiattolo striato dell'Himalaya Tamiops mcclellandii. Culmine di questa attività fu nel 1851 la pubblicazione del Catalogue of the Mammalia in the Museum of the East India Company, in cui descrisse molto dettagliatamente gli animali del subcontinente, aggiungendo altre cinque specie nuove per la scienza. Collaborò anche con N.A. Vigors alla classificazione degli uccelli australiani e fu tra i promotori della Enthomological Society of London. La sua importanza come zoologo è anche testimoniata dai numerosi nomi specifici del regno animale che gli rendono omaggio (almeno una quindicina). Ma torniamo alla botanica. Quando giunse in Inghilterra, Horsfield portava con sé un voluminoso erbario di 2000 esemplari, cui si aggiungevano disegni e calchi in carta di riso (un ingegnoso metodo da lui elaborato per conservare almeno l'impronta delle piante, che nel clima tropicale era spesso molto difficile preservare); per organizzare questa massa di materiale secondo precisi criteri tassonomici, egli si rivolse a Robert Brown, che era allora il segretario di Banks (che sarebbe morto l'anno dopo, lasciandolo erede delle sua biblioteca e delle sue collezioni). L'esame degli esemplari e dei numerosi duplicati, l'identificazione delle specie e dei generi, il raggruppamento per famiglie richiesero un tempo molto lungo, rendendo impensabile una pubblicazione integrale; d'accordo con Horsfield, Brown selezionò le specie più interessanti o di per sé o per la loro novità. Ciascuna sarebbe stata corredata della descrizione in latino, delle osservazioni in inglese e illustrata da una tavola (le illustrazioni, giudicando Brown inadatte quelle eseguite a Giava da artisti locali, furono rifatte sulla base degli esemplari essiccati). Nonostante questa scelta drastica, a causa dei suoi mille impegni Brown non poté scrivere egli stesso le descrizioni, che alla fine dovette affidare a uno dei suoi collaboratori, John Joseph Bennett, assistente del dipartimento di botanica del British Museum. Dopo una lunghissima gestazione, con il titolo Plantae Javanicae Rariores, l'opera uscì infine tra il 1838 e il 1852 in quattro parti (ciascuna delle quali comprende 25 specie con altrettante tavole). Opera importante per la conoscenza della flora giavanese e magnifica per il corredo iconografico (i disegni sono di C. e J. Curtis, le incisioni di J. Curtis e E. Weddell), è tuttavia molto tardiva e certo non rende totalmente giustizia all'indefesso lavoro di Horsfield, che nel frontespizio risulta solo come raccoglitore, anche se il suo nome precede quelli di Bennett e Brown, scritti in corpo lievemente più piccolo. D'altra parte, corrispondeva a una scelta dello stesso Horsfield, che durante il soggiorno londinese aveva di fatto abbandonato la botanica per la zoologia.  Horsfieldia, dalle foreste del sudest asiatico Gli omaggi non sono mancati anche nella nomenclatura botanica. Oltre ad essere ricordato da alcuni nomi specifici (tra gli altri, Sauromatum horsfieldii, Miliusa horsfieldii, Edychium horsfieldii), tre diversi botanici in tempi successivi gli dedicarono un genere Horsfieldia: Willdenow già nel 1806, Blume nel 1830 e Chifflot nel 1909. Per la regola della priorità, l'unico valido è Horsfieldia Willd. (famiglia Myristicaceae). Questa dedica precoce dimostra che anche in tempi di guerra e nonostante le lunghe distanze, nell'ambiente dei naturalisti le notizie continuavano a circolare, magari con qualche imprecisione. Creando il nuovo genere sulla base di una specie segnalata da Horsfield a Giava (H. odorata, oggi H. iryaghedhi), nella quarta edizione di Species plantarum Willdenow infatti scrive: "Ho denominato questa pianta in memoria del dottore statunitense Thomas Horsfield che per amore delle piante esplorò le Indie orientali". Il termine "memoria" e il tempo verbale danno l'impressione che il botanico tedesco avesse ricevuto la falsa notizia della morte di Horsfield in Oriente. Molto appropriatamente per questo appassionato del Sudest asiatico, Horsfieldia è un genere di circa cento specie di alberi sempreverdi delle foreste umide tropicali di bassa quota, diffuso in un'area che va dall'India e alle isole Salomone, passando per la Cina meridionale, l'Indocina e l'Indonesia. Il maggiore centro di diversità è la Nuova Guinea (con una trentina di specie), seguita dal Borneo; a parte poche eccezioni, quasi tutte le specie sono diffuse in una piccola parte di questa vasta zona e molte sono endemiche o subendemiche. Proprio per questo, parecchie sono minacciate, soprattutto per la restrizione del loro habitat naturale. Appartenenti alla stessa famiglia della noce moscata (Myristica fragrans), sono in genere piccoli alberi molto decorativi sia per il bel fogliame sempreverde, sia per le grandi infiorescenze molto ramificate, seguite da piccole bacche tondeggianti; dioiche, portano i fiori femminili e quelli maschili su piante separate. Alcune specie, già note alla medicina tradizionale, contengono l'alcaloide horsfilina con effetti analgesici. Altre sono invece coltivate per i frutti, da cui si ricava una cera. Tra di esse proprio H. iryaghedhi, originaria di Sri Lanka (e si teme ormai estinta in natura), ma introdotta forse dagli olandesi in Malesia e a Giava, dove veniva coltivata appunto per la cera. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed