|
I due più antichi orti botanici della Lombardia nascono quasi contemporaneamente, nell'ultimo quarto del Settecento, nell'ambito delle grandi riforme teresiane che ebbero tra gli obiettivi anche lo svecchiamento dell'istruzione con una maggiore attenzione alla scienza. Erano infatti strettamente legati a due istituzioni didattiche: l'Università di Pavia e le scuole palatine di Brera. Anche se il personaggio è enigmatico e le decisioni in definitiva venivano prese a Vienna, nella loro nascita e primo sviluppo ebbe un qualche ruolo il conte Firmian, plenipotenziario per la Lombardia austriaca. Un merito che gli venne riconosciuto da Marsili con la dedica del notevole genere Firmiana (Malvaceae). 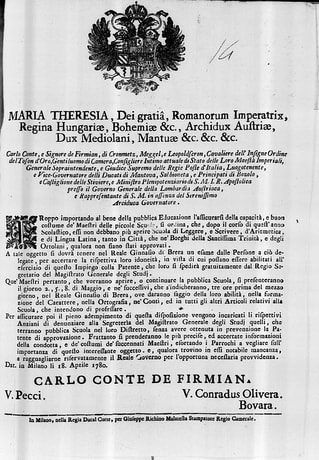 Mecenate delle arti e della scienza Intorno al 1760, all'abate Filippo Antonio Farsetti, proprietario del celebre giardino di Sala nel Padovano, giunsero "mandate non so da chi né da qual paese" sementi contrassegnate con la vaghissima etichetta Arbor excelsa ex China ("albero di grande altezza della Cina"). Seminate dall'abile giardiniere Francesco Pomai, produssero molte pianticelle che furono poi trapiantate tanto in serra quanto all'aperto; una, che "aveva perduto la cima e si era lateralmente divaricata in tre rami" fu donata da Sala a Giovanni Marsili, prefetto dell'Orto dei semplici di Padova. Allevata "diligentemente" e protetta d'inverno nella serra fredda, trapiantata in vasi via via più grandi, prosperò e "fu sì grata e cortese che in pochi anni volle a me dare il geniale e desiderato spettacolo de' primi suoi fiori coi primi suoi frutti condotti a perfetta maturità". Così Marsili racconta la prima fioritura in Europa della spettacolare Firmiana simplex, avvenuta nell'orto botanico padovano nel 1775. Diversi degli altri esemplari di Sala giunsero anch'essi a fioritura, ma solo qualche tempo dopo. La pianta, seppure sotto altri nomi, non era una novità assoluta. Sloane l'aveva vista in fioritura, ma in Giamaica (la pubblicò come Malva arborea), mentre Linneo, che ne possedeva un esemplare dal fusto non ramificato (per questo lo chiamò Hibiscus simplex) non lo aveva mai visto fiorire. Dunque Marsili fu il primo a poterne studiare fiori e frutti, capendo che andava assegnata a un genere proprio. Era un albero senz'altro di grande bellezza, dunque perfetto da dedicare a un potente. Marsili scelse il conte Carlo Firmian, ministro plenipotenziario della Lombardia austriaca, morto pochi anni prima, che poteva vantare qualche merito come mecenate della botanica: "E' a lui dovuto dai Botanici tributo di particolare riconoscenza per la recente fondazione del Regio Giardino di Pavia, portato in breve spazio d' anni, mercé le provide di Lui cure, la Sovrana munificenza, e la perizia, vigilanza e dottrina de' valenti suoi Presidi e Direttori, a tal grado di floridezza e di celebrità , che già gareggia co' più rinomati d'Europa". Come altre piante portano i nomi di Begon, Bignon, Eugenio di Savoia, Carlo di Braunschweig (dedicatario di Brunsvingia) o il patrizio veneto Morosini (dedicatario di Maurocenia), "la cui memoria anima l'industria, risveglia all' azione gl' ingegni e rincuora l' umanità - concludeva - passi a' posteri al pari d'esse nobilitato e fastoso con quello di FIRMIANA". Il conte Carlo Giuseppe Gottardo (Karl Joseph Gotthard) von Firmian (1716-1782) fu ministro plenipotenziario della Lombardia per 23 anni, dal 1758 alla morte. Gli storici sono divisi sul suo ruolo nella grande stagione delle riforme austriache in Lombardia: si va da chi vede in lui "il can da guardia dell'assolutismo" o almeno un mero esecutore, per altro indolente, delle direttive di Vienna, a chi al contrario ne sottolinea il ruolo propulsivo, soprattutto per quanto riguarda le riforme ecclesiastiche e l'applicazione delle dottrine giurisdizionaliste. Cadetto di una famiglia della nobiltà trentina che da secoli forniva funzionari tanto al principe vescovo di Trento quanto agli Asburgo e che nel Settecento ebbe un momento di gloria grazie all'arcivescovo di Salisburgo Leopold Anton Eleutherius von Firmian, zio del nostro, ebbe una formazione cosmopolita prima in Baviera e in Austria, poi nei Paesi Bassi dove studiò giurisprudenza, quindi a Parigi, dove frequentò gli ambienti giansenisti; un lungo viaggio di formazione lo portò in Italia, prima a Firenze poi a Roma, dove entrò in contatto con vari circoli intellettuali e iniziò a coltivare interessi filologici e antiquari. Tornato a Vienna, fu ammesso al Consiglio aulico; piuttosto attivo e impegnato nel suo ruolo, riunì attorno a sé una piccola accademia privata, in cui si discutevano e diffondevano le idee di Muratori, Genovesi, Montesquieu. Dal 1752 al 1758 fu ministro plenipotenziario, ovvero ambasciatore, a Napoli, quindi fu trasferito a Milano. In Lombardia la sua stella brillò soprattutto nel decennio 1760-1771: il suo stesso carattere indolente corrispondeva al prudente riformismo teresiano; spiacque invece a Giuseppe II, fin da quando visitò Milano nel 1769: lo giudicava titubante e inadeguato, così come riteneva datate e superate le sue idee. Per rispetto alla madre, che invece aveva grande stima del vecchio funzionario, lo mantenne al suo posto, ma lo affiancò con uno dei suoi fratelli, l'arciduca Ferdinando, nominato governatore di Milano nel 1771; dal 1778, fu costretto a coabitare con il suo successore designato, il conte Wilczek. Per altro, i suoi ultimi anni furono di estremo decadimento anche fisico. Al di là della difficoltà di separare quanto nelle sue azioni politiche si deve a lui e quanto alle direttive di Vienna, anche gli estimatori di Firmian ammettono che la sua presenza fu più incisiva come mecenate che come politico. Amava circondarsi di artisti e intellettuali; alla sua morte (oltre a una montagna di debiti) lasciò una collezione di quadri e di stampe e una biblioteca di oltre 40.000 volumi. Cesare Beccaria gli dedicò Dei delitti e delle pene, e sempre ne ebbe stima, al contrario di Pietro Verri che ne lasciò un giudizio impietoso sul piano tanto fisico (oggi si parlerebbe di body shaming) quanto morale. Talvolta suggerite da lui, talaltra da Vienna, troviamo lo zampino di Firmian in diverse iniziative collegate alla riforma scolastica, già iniziata in Austria intorno al 1757 e estesa alla Lombardia a partire dal 1765; sia pure con molte lentezze e contraddizioni, si ebbe un deciso avanzamento dell'accesso all'istruzione dei ceti popolari e uno svecchiamento dei metodi e dei contenuti didattici, con una forte valorizzazione delle materie scientifiche. In un suo memoriale del 1765, Firmian la collocò al primo posti tra le riforme più urgenti a necessarie. A giovarsi del vento di riforma fu in primo luogo l'Università di Pavia. Nel 1769, per interessamento di Firmian, ad insegnare scienze naturali venne chiamato Lazzaro Spallanzani; nel 1771, con l'arrivo da Vienna di sette casse di minerali e altri materiali naturalistici, che avrebbero permesso al professore "di dimostrare colla loro spiegazione le varie vie che tiene la Natura nel suo operare", prendeva avvio il Museo di Scienze naturali. Erano i primi atti del rilancio dell'ateneo patavino, a insegnare nel quale nel giro di pochi anni sarebbero stati chiamati altri scienziati di risonanza europea: il botanico Giovanni Antonio Scopoli, l'anatomista Antonio Scarpa, il fisico Alessandro Volta, che sarebbe diventato anche rettore. Nel 1772 fu aperta al pubblico la Biblioteca universitaria, dal 1779 ospitata dallo splendido Salone teresiano, e nel 1773 fu fondato l'orto botanico, la cui sede fu individuata dallo stesso Firmian nell'area della chiesa di S. Epifanio e del convento dei Canonici Lateranensi. La creazione di strutture scientifiche riguardò anche Milano. Nel 1773, il barnabita Ermenegildo Pini fu incaricato di creare un Museo di storia naturale presso le scuole Arcimboldi. Forse l'iniziativa fu presa a Vienna, ma certo fu Firmian a suggerire la trasformazione del complesso di Brera in una vera e propria cittadella della cultura. Il Palazzo di Brera era stato costruito nella seconda metà del Cinquecento per ospitare il Collegio della Compagnia di Gesù; intorno al 1760 vi venne realizzato un osservatorio astronomico, diretto da padri gesuiti che erano anche rinomati astronomi. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia, il palazzo e le aree adiacenti divennero di proprietà dello stato, che veniva così a disporre in pieno centro di un luogo ideale per riunirvi tutte le istituzioni culturali che la città aspettava da tempo. Firmian ne fu entusiasta e così scrisse a Kaunitz: "Brera dovrebbe servire per il Ginnasio ed Istituto di scienze di questa città di Milano[…] Si dovrebbero riunire in Brera le scuole Palatine, l’Aula per le dimostrazioni di Fisica sperimentale, la Camera ottica, il Laboratorio per la fusione dei metalli, il Museo delle antichità sacre e civili ed il Museo di storia naturale […] Al detto Istituto di Scienze si potrà trasportare la Biblioteca Pertusati, e formare una sala con quella di Brera […] Resterà in Brera la Specola e l’abate Lagrange […] In Brera vi sono poi le scuole inferiori […] Finalmente si potrebbe formare in Brera l’Accademia delle Arti e delle Scienze combinandola con tutti”. Il progetto trovò quasi completa attuazione negli anni successivi: già a partire dal 1774 vennero trasferite a Brera le scuole palatine, destinate all'istruzione superiore; nel 1776 venne aperta l'Accademia di Belle Arti; nel 1786, la Biblioteca Braidense, che oltre ad accogliere le biblioteche degli stessi gesuiti e quella del conte Pertusati, acquistata nel 1763 dalla Congregazione dello Stato di Milano, ricca di oltre 24.000 volumi, si divise con Pavia quella del celebre scienziato elvetico Albrecht von Haller, acquisita nel 1778 da Giuseppe II insieme al suo importantissimo erbario. Dei lavori di riallestimento del palazzo fu incaricato l'architetto Piermarini, che, oltre a predisporre le aule e ridisegnare la biblioteca, elevò nuove torri per l'osservatorio astronomico e fu coinvolto nella progettazione dell'orto botanico. Quest'ultimo fu sistemato in un terreno adiacente al lato meridionale del palazzo, che già al tempo dei Gesuiti ospitava un boschetto e un giardino, allo stesso tempo luogo di passeggio e meditazione e orto per le necessità di cucina. Al contrario di quello di Pavia, concepito come un grande orto botanico chiamato, oltre che a servire le esigenze didattiche della cattedra di chimica e botanica, a dare lustro all'Università con collezioni ricche di piante esotiche, Firmian pensava a un piccolo orto dei semplici didattico, dove coltivare le piante da utilizzare durante le lezioni pratiche (dimostrazioni) impartite agli studenti di botanica delle scuole palatine; sempre su sua proposta, nel 1774 la cattedra fu assegnata all'abate villambrosiano Fulgenzio Vitman (o Withman), che era stato il primo prefetto del giardino di Pavia. Secondo le intenzioni iniziali di Firmian, egli avrebbe dovuto provvedere anche al riadattamento del vecchio giardino dei gesuiti che, si illudeva, sarebbe avvenuto "senza spese alcuna"; per rifornirlo delle piante necessarie alle lezioni da avviare nella primavera successiva egli riteneva sufficienti due viaggi che Vitman compì tra l'estate e l'autunno del 1774, uno negli Appennini fino a Villombrosa, l'altro all'orto botanico di Torino. La realizzazione di un vero orto botanico e la coltivazione di piante esotiche dovevano aspettare tempi futuri. Vitman giunse a Milano all'inizio del 1775 e si recò ad ispezionare il giardino insieme a Piermarini, tecnici ed amministratori, scoprendo che erano necessarie opere ben più impegnative e costose; venne predisposto un progetto, che includeva anche una serra disegnata da Piermarini. Il governo approvò, ma lesinò il denaro, con la conseguenza che la serra non fu mai costruita. Vitman, tra mille difficoltà, riuscì comunque ad accrescere le collezioni, grazie a contatti con altri orti botanici, tanto in Italia quando all'estero: in primo luogo quello di Torino, ma anche Firenze e Parma, Vienna, Zurigo, Parigi e Madrid, tanto che nel 1778 il poligrafo Carlo Amoretti poté scrivere che il professore di botanica "ha un giardino sufficientemente ben fornito per le sue dimostrazioni". Un pochino lo aiutò anche Firmian che nel 1782 scrisse a Londra e a Zurigo per ordinare semi di alberi esotici per il boschetto.  Le grandi foglie dell'albero parasole Insomma, sono ben due gli orti botanici che, più o meno direttamente, devono la loro nascita e il primo sviluppo a Firmian. Dunque, d'accordo con Marsili, possiamo concludere che si sia meritata la fastosa dedica di Firmiana. Il genere, appartenente alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), comprende circa 18 specie di alberi o più raramente arbusti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e il Pacifico, con centro di diversità in Cina. Decidui, sono caratterizzati da grandi foglie palmate e da fiori unisessuali riuniti in grandi infiorescenze panicolate o più raramente racemose; la stessa pianta porta sia fiori staminati sia fiori pistillati; uno dei tipo prevale, con pochi fiori dell'altro tipo. Per favorire l'impollinazione incrociata, i fiori maschili tendono ad aprirsi prima di quelli femminili. I frutti sono follicoli con endocarpo membranoso che rimangono a lungo sulla pianta prima di aprirsi. La specie più nota e coltivata è senza dubbio F. simplex, anche nota come parasole cinese. Di medie dimensioni (10-15 metri), si fa notare soprattutto per le grandissime foglie lobate dal diametro fino a 30 cm; a maturità ha una chioma arrotondata che offre una densa ombra. Di crescita rapida, è relativamente rustica, ma per fiorire ha bisogno di sole e di un'estate calda; i fiori giallo-verdastri, raccolti in appariscenti pannocchie pendule, sono seguiti da frutti piuttosto decorativi, a volte usati in composizioni di fiori e frutti secchi. Non invasiva alle nostre latitudini, lo è invece negli Stati Uniti meridionali, dove è stata introdotta come albero da legname a crescita rapida. In Cina era tradizionalmente piantata nei giardini di letterati e poeti, di cui è dunque diventata emblema. In Cina e Corea corteccia, foglie e semi hanno diversi usi medicinali. Ad attirare gli sguardi su F. colorata sono invece i fiori, campanelle pendule ricoperte di una soffice peluria rosso-aranciata, tanto più che la fioritura si produce quando l'albero è ancora spoglio. Piuttosto comune nelle foreste umide dei Ghati occidentali e del Deccan, è presente anche nello Yunnan meridionale e in Indocina. Ha anch'essa belle foglie palmate e, poiché il fusto tende ad ingrossarsi alla base, è talvolta commercializzata come caudiciforme da vaso.
0 Comments
Studiare la natura per sollievo dell'animo, ovvero le vicissitudini di Giovanni Antonio Scopoli23/2/2023 Autore di cinquantasette pubblicazioni che spaziano dalla medicina alla zoologia, alla botanica, alla chimica, alla mineralogia, Giovanni Antonio Scopoli fu salutato dai contemporanei come "Linneo dell'impero austriaco". Il suo biografo Otto Guglia lo ha definito "il primo europeo anazionale", visto che nacque in Trentino, ma fu suddito austriaco, studiò in Italia e in Austria, lavorò e fece le sue ricerche in Slovenia, Slovacchia, Lombardia. Come botanico, è soprattutto l'iniziatore dello studio della flora slovena, grazie alla sua Flora carniolica. Come la sua gemella Entomologia carniolica, non sarebbe mai nata se il destino fosse stato più generoso con lui e non lo avesse relegato nel "carcere" di Idria, una cittadina mineraria della Slovenia, e soprattutto non l'avesse privato di tutti gli affetti più cari. Egli cominciò a battere campagne e montagne alla ricerca di insetti e piante proprio per trovare sollievo a tante disgrazie. Sebbene meno tragiche, anche le sue vicende successive furono segnate da continue contrarietà personali e professionali, tanto che egli intitolò la sua autobiografia Vitae meae vices, "Le vicissitudini della mia vita". L'ultima, beffarda e allo stesso tempo patetica, lo attendeva a Pavia, dove pensava di aver finalmente trovato il meritato riconoscimento. Grazie all'illustre von Jacquin che prima gli fu amico e poi (a sentir lui) ostile, lo ricorda la tossica Scopolia, da cui fu inizialmente estratta la scopolamina, a lungo uno dei principali anestetici. Né lo dimentica il Museo di scienze di Lubiana che ha ugualmente intitolato "Scopolia" la sua rivista ufficiale. 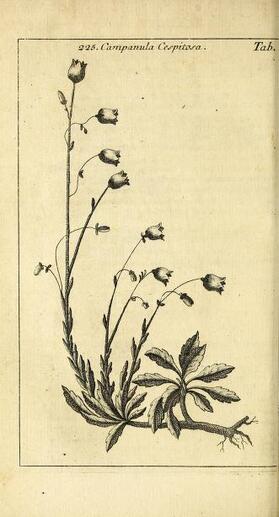 Insetti e piante della Carniola Nella prefazione della sua Entomologia Carniolica, Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) ebbe a scrivere: «ricordatevi sempre che non coltivo il teatro della Natura per amore dello studio, ma per sollievo dell’animo, in verità per alleviare i tristissimi dolori della mia esistenza». Pensava certo alla tragica moglie della moglie e dei figlioletti, periti in un incendio, ma anche alle difficoltà della sua carriera, che per sedici anni lo relegò nella periferica Idria, che nella sua autobiografia definirà senza mezzi termini "carcere". Quando vi era arrivato poco più che trentenne, aveva ben altre aspirazioni, e alla sola vista di quel villaggio montano costituito solo dalle "miserrime casette inedificate dei minatori" avvertì un presago di sventura. Scopoli era nato a Cavalese in Val di Fiemme, figlio del commissario militare del principe vescovo di Trento e di una nobildonna trentina che era anche pittrice. Dopo aver iniziato gli studi a Trento, si laureò in medicina a Innsbruck, quindi esercitò la professione per qualche tempo in Val di Fiemme e a Trento. Importante fu il soggiorno a Venezia del 1745, che gli permise di approfondire le conoscenze mediche con Lotario Giuseppe Lotti, di frequentare i giardini veneziani, in particolare quello di Lionardo Sesler, e di conoscere il sistema linneano, di cui sarebbe diventato un convinto sostenitore. Tornato a Trento, si sposò e, grazie alla protezione del protomedico Borsieri, fu assunto come segretario privato del principe vescovo Leopoldo Ernesto Firmian, che accompagnò a Graz e a Passau. Approfittò dei due anni trascorsi in Stiria per preparare l'esame di abilitazione che gli avrebbe consentito di esercitare in tutto il territorio soggetto agli Asburgo; lo superò in modo brillante nel 1753, alla presenza dello stesso van Swieten; impressionato dalla sua tesi su un nuovo metodo di classificazione botanica (Methodus plantarum enumerandis stirpibus ab eo hucusque repertis destinata), questi gli promise il primo posto vacante in una condotta medica. Scopoli sperava in Linz, invece fu Idria. A fare la fortuna - o anche la sfortuna, vista la pericolosità di questo materiale - di questa cittadina annidata nelle Prealpi della Carniola fu il mercurio, scoperto negli ultimi anni del 1400; pochi anni dopo vi fu aperta una miniera e Idria si trasformò nel centro più importante della Slovenia dopo Lubiana. La vita dei minatori era precaria; vivevano stipati nelle "casone", e la loro speranza di vita non andava oltre i 40 anni. Quando vi giunse Scopoli, con le loro famiglie costituivano una comunità di 2000 persone. Già il viaggio non aveva fatti presagire nulla di buono; dopo la nomina, Scopoli era tornato in patria a prendere la moglie Albina de’ Miorini, figlia del presidente della Magnifica Comunità di Fiemme, e la figlioletta; quindi a Hall nel Tirolo la famigliola si era imbarcata per un viaggio fluviale sull'Inn, gonfio di pioggia; il giorno dopo, l'imbarcazione fu colpita da un tronco e fece naufragio; Scopoli e i suoi furono tratti in salvo, ma tutti i bagagli, compresi i libri e gli strumenti medici, andarono perduti. Ospitato a Salisburgo e poi tornato a Vienna, Scopoli sperava che l'infortunio suscitasse la benevolenza reale, e che gli fosse assegnata la condotta di Linz, che sapeva ancora vacante. Ottenne invece un dono personale di 500 fiorini da parte dell''imperatrice, informata dell'incidente, poi dovette rassegnarsi a raggiungere Idria. Anche prima della tragica morte di moglie e figli, vi si trovò malissimo. Veniva pagato attraverso i proventi del monopolio sul vino, una beffa se si pensa che l'alcolismo era uno dei problemi sanitari che affliggevano i minatori e le loro famiglie, aggiungendosi agli effetti deleteri dei vapori del mercurio. Non conoscendo la lingua del paese, poco capiva i suoi pazienti; pessimi poi erano i suoi rapporti con il direttore della miniera, interessato solo al guadagno e per nulla sollecito della salute dei lavoratori. Il lavoro era pesante, e per nulla remunerativo; dopo nove anni di tormenti, Scopoli si rassegnò a chiedere il trasferimento con una supplica. Non lo ottenne, ma nel 1763 gli fu assegnata la cattedra di metallurgia chimica alla neoistituita scuola superiore di Idria con uno stipendio annuo di 400 fiorini. A consolarlo dalle vicissitudini personali e professionali c'era solo l'ambiente naturale, con una flora e una fauna ancora del tutto inesplorate. Secondo quanto egli stesso scrive nella prefazione alla seconda edizione di Flora carniolica, le sue escursioni iniziarono intorno al 1755 con l'esplorazione dei monti e dei boschi del distretto di Idria; nel 1756 percorse le paludi e le campagne di Lubiana; nel 1757 il monte Nanos; nel 1758 i territori di Škofja Loka e di Kranj, il monte Storžič e la catena montuosa che si estende fino al fiume Kokra; nel 1759 l'area tra Lubiana e Kočevje e i monti Grintovec, Kočna e Kalški Greben; nel 1760 i pascoli alpini e i dintorni del lago di Cerknica; nel 1761 nuovamente il monte Nanos e il Senožeče, il Carso e Trieste; nel 1762 gran parte della Carniola superiore e i monti di Bohinjska Bistrica; nel 1764 i circondari di Gorizia e Duino e la costa adriatica. Il primo risultato di queste ricerche fu la prima edizione di Flora carniolica (1760), della cui pubblicazione Scopoli informò il suo idolo Linneo con una lettera datata 1 settembre 1760. Fu l'inizio di una corrispondenza che sarebbe stata interrotta solo dalla malattia e poi dalla morte dello scienziato svedese. Nel 1763 seguì l'ancor più importante Entolomologia carniolica in cui vengono descritte 1153 specie di insetti (o meglio di artropodi), più della metà delle quali nuove per la scienza, classificati in sette classi sulla base di un sistema proprio; più olistico rispetto a quello di Linneo (basato sulle ali) o di Fabricius (basato sull'apparato boccale), tenta di tenere conto di più caratteristiche possibili per giungere a una classificazione naturale. Come medico, Scopoli fu anche il primo a rendersi conto dei nefasti effetti del mercurio, illustrati in De Hydroargyro Idriensi Tentamina (1761), che fa parte della più complessivo Tentamina physicochymico-medica, un'opera che, con i suoi suggerimenti sulla sicurezza dei lavoratori, fa di Scopoli uno di padri della medicina del lavoro. Tradotta (e piratata) in Germania, insieme alla successiva Introductio ad diagnosim et usum fossilium (1763), legata all'insegnamento di metallurgia chimica, incominciò a farlo conoscere a livello internazionale. Dalla Slovacchia all'Insubria Fu certamente questa fama crescente a liberarlo finalmente dalla "prigione" di Idria. Nel 1766 gli fu proposta la cattedra di mineralogia all'Accademia di San Pietroburgo, ma egli la rifiutò, così come l'incarico di medico personale del vescovo di Passau, preferendo rimanere al servizio degli Asburgo, tanto più che contava che l'arrivo di un altro medico, Balthasar Hacquet, lo sollevasse dai compiti più ingrati. Nel 1769, accettò invece di succedere a von Jacquin alla cattedra di mineralogia e metallurgia all’Accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica in Slovacchia). Il periodo slovacco fu molto fruttuoso sul piano professionale, con la pubblicazione di molte opere che spaziano sui tre regni della natura: Anni historico-naturales (1769-1772), scritti vari di mineralogia, cristallografia, micologia e zoologia, che contengono tra l'altro la descrizione di diverse specie di uccelli provenienti da varie collezioni; Dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes (1772), di argomento prevalentemente mineralogico; Principia mineralogiae systematice et praticae (1772), scritto come manuale per i suoi studenti; la seconda edizione di Flora carniolica (1772); Crystallographia hungarica (1776); Introductio ad historiam naturalem (1777), un tentativo di sintetizzare i "caratteri essenziali" dei generi dei tre regni della natura. Anche se continuava a interessarsi di zoologia e botanica, in questi anni, a occupare il centro dei suoi studi erano soprattutto la chimica e la mineralogia, un altro campo in cui diede contributi originali. La seconda edizione di Flora carniolica non è un semplice ampliamento della prima, ma un'opera di impostazione del tutto diversa. Nella Flora del 1760, Scopoli aveva descritto 756 specie di fanerogame e 256 di crittogame, in gran parte autoctone, dedicando anche una notevole attenzione ai funghi. Fu in effetti uno dei primi a studiare la flora e la fauna della grotte (incluso il famoso proteo Proteus anguinus); anche se apprezzava già Linneo, definito nella prefazione Princeps botanicorum, utilizzò le tradizionali denominazioni polinomiali, costituite da brevi diagnosi, e una propria classificazione "naturale" in 33 classi, una rielaborazione di quella di Tournefort. E' ancora l'opera di un medico-farmacista, e come tale Scopoli si preoccupò di integrare le descrizioni con note più o meno ampie sulle proprietà medicinali e gli eventuali altri usi. Non ci sono illustrazioni. La Flora del 1672 è quella di un linneano ortodosso, ed è esclusivamente botanica; le note farmacologiche scompaiono; di Linneo vengono adottati tanto le denominazioni binomiali quanto il sistema. Le specie lievitano a 384 crittogame, 1251 fanerogame, 141 tra funghi, licheni, alghe. Molte quelle descritte per la prima volta, e molte anche quelle che conservano ancora oggi il nome dato loro da Scopoli: tra i generi Ostrya, Rorippa, Sesleria, tra le specie Cotinus coggygria, Centaurea kartschiana, Cirsium carniolicum, Tragopogon dubius, Ostrya carpinifolia, Cakile maritima, Campanula cespitosa, Euonymus verrucosus, Genista sylvestris, Onobrychis viciifolia, Vicia grandiflora, Gentiana pannonica, Tilia platyphyllos, Sanguisorba minor, Salix alpina. Tra i funghi, ricordiamo almeno che si deve a Scopoli l'eponimo dell'ovolo reale Amanita caesarea (per lui, Agaricus caesareus), calco del nome volgare tedesco della Carniola Kaiserling. In due volumi, l'opera è illustrata da 66 tavole incise da F. Rein a partire da disegni dello stesso Scopoli. Anche negli anni slovacchi, così ricchi di pubblicazioni, non mancarono pene e contrarietà. Scopoli subì la perdita della seconda moglie Caterina de' Franchenfeldt; fu costretto a lavorare in un laboratorio umido e angusto che, oltre a mettere a dura prova la sua salute, era del tutto inadatto alle lezioni; la commissione di corte per i minerali gli proibì di pubblicare senza uno specifico permesso. Ma soprattutto la sua carriera era di nuovo bloccata; in una lettera a Linneo del 1773, lamenta che von Jacquin, che in precedenza gli era tanto amico, ora non vuole più avere nulla a che fare con lui e lo ostacola in tutto. Quando all'Università di Vienna venne istituita una seconda cattedra di storia naturale, accanto a quella di chimica e botanica tenuta appunto da von Jacquin, fece domanda per ottenerla, ma gli fu preferito l'oscuro farmacista viennese Jacob Well. Nel 1776 si risolse così ad accettare la cattedra di botanica e chimica all'Università di Pavia, dove incominciò ad insegnare nel 1777. Tra i suoi compiti la direzione dell'orto botanico, che era stato istituito nel 1773 nell'ambito delle riforme dell'insegnamento universitario promosse in Lombardia dal plenipotenziario degli Asburgo conte Firmian. Scopoli ne fece regolarizzare la superficie, creò due arboreti, rispettivamente ad est dell'edificio che ospitava il laboratorio di chimica e a nord delle serre in legno fatte costruire dal suo predecessore Valentino Brusati. Lo spazio centrale fu diviso in aiuole regolari separate da viali. La tradizione vuole che nel 1778, per commemorare l'amato Linneo, abbia fatto piantare l'esemplare di platano (Platanus x hispanica) che oggi costituisce l'albero più venerabile del giardino. Grazie ai suoi molti corrispondenti (all'epoca era membro di innumerevoli società scientifiche) inserì il nuovo giardino nel circuito internazionale degli orti botanici, accrescendone notevolmente le collezioni attraverso scambi. La sistemazione dell'orto botanico e del laboratorio di chimica lo distolsero per qualche tempo da nuove pubblicazioni, tanto più che era impegnato nella traduzione del Dizionario di chimica di Macquer. Ambiva però a pubblicare una grande opera illustrata, con la descrizione di specie rare e inedite; il progetto si tradusse nella raffinata e costosa ultima opera di Scopoli, Deliciae florae et faunae insubricae, in tre parti (1786-1788), una rassegna illustrata di animali, piante e minerali, in parte raccolti da lui stesso durante le sue escursioni naturalistiche in Lombardia o da allievi e corrispondenti, in parte coltivati nell'orto botanico o conservati nelle collezioni museali; vi pubblicò anche mammiferi e uccelli esotici raccolti da Pierre Sonnerat durante i suoi viaggi. Nel terzo e ultimo volume incluse un'autobiografia (Vitae meae vices, ovvero "Le vicissitudini della mia vita"). Deliciae florae et faunae insubricae, per altri aspetti pregevole, segnò la fine di Scopoli, che, nella smania di pubblicare, di tenere alta la propria fama internazionale, magari con uno scoop naturalistico, incappò in un madornale errore; nel 1785, mentre era alla ricerca di materiali curiosi e soprattutto inediti per la prima serie, fu avvicinato da un sedicente medico di campagna che gli offrì uno " singolarissimo verme" conservato sott'alcool; a suo dire, lo aveva vomitato una donna piemontese poco prima del parto. Con la bocca aperta e due tubi divergenti, era davvero mai visto e entusiasmò Scopoli che si affrettò a farlo disegnare e lo pubblicò nel primo fascicolo come Physis intestinalis, con tanto di dedica a Joseph Banks. Il povero Scopoli era stato vittima di un truffatore (o forse di una beffa): non si trattava di un verme, ma di un artefatto, la trachea e l'esofago di una gallina con la parte inferiore cucita. La verità sarebbe venuta a galla tre anni dopo, in seguito a uno squallido episodio in cui, purtroppo, il nostro protagonista fece una pessima figura. Fin dal suo arrivo a Pavia, si era delineata una forte tensione con un altro scienziato universale, Lazzaro Spallanzani, titolare della cattedra di scienze naturali e creatore del Museo di scienza naturale dell'Università, al quale lo stesso Scopoli vendette una parte delle sue collezioni; Spallanzani ne aveva controllato il catalogo, rilevando diverse mancanze, con grande disappunto del nostro, che in tal modo passava per ladro o imbroglione. C'era poi una rivalità scientifica: Scopoli era un sistematico, un catalogatore linneano, per il quale il compito principale della scienza era catalogare la natura, e la massima aspirazione era aggiungere un nuovo tassello alla lista; Spallanzani era un fisiologo, attento soprattutto alle funzioni e ai meccanismi fisiologici. Si aggiunga l'antipatia personale, alimentata dal dileggio dell'emiliano Spallanzani per il "dialetto germanico-italico" del trentino Scopoli. Fu certamente quest'astio a spingere quest'ultimo a divenire parte attiva di una vera e propria congiura ordita dal custode del Museo naturale, Giovanni Serafino Volta (omonimo e non parente di Alessandro, all'epoca rettore dell'Università), il quale, approfittando dell'assenza di Spallanzani, che era andato a Costantinopoli in viaggio di studio, lo accusò di essersi impadronito di diversi esemplari del Museo per arricchire la propria collezione privata. Rivelò la sua presunta scoperta, oltre che a Scopoli, al medico e anatomista Antonio Scarpa, titolare della cattedra di anatomia, e al matematico Gregorio Fontana, direttore della biblioteca universitaria; nell'estate del 1786 i quattro inviarono una denuncia sia al governo imperiale della Lombardia sia alla Commissione ecclesiastica degli studi (Spallanzani era infatti abate). Scopoli si incaricò di informare del fattaccio urbi et orbi, scrivendo una lettera circolare che fu inviata ai membri delle università italiane e a personalità della scienza e della cultura europea: certamente in buona fede, ma accecato dal rancore vide nella vicenda la "mano di Dio", che aveva ritorto la stessa accusa infamante contro colui che l'aveva ingiustamente accusato di furto. All'epoca Pavia era la più quotata università italiana; l'accusato era illustre, e lo erano altrettanto almeno due degli accusatori, Scarpa e Scopoli. Lo scandalo era dunque clamoroso. Le autorità austriache si affrettarono ad ordinare un'inchiesta, diretta del plenipotenziario Wilczeck; Spallanzani fu del tutto scagionato con tanto di editto imperiale, che allontanò Volta e ammonì i tre professori per "per il danno arrecato alla reputazione di Spallanzani, accusandolo senza prove sufficienti", per essersi fidati ciecamente delle false affermazioni di Volta. Ma, purtroppo per Scopoli, anche se conservò la cattedra, la storia non finì lì. Nel 1788, vennero pubblicate due lettere al "signor Dottore Scopoli", datate da Zoopoli, a firma di una certo dottor Francesco Lombardini bolognese. Anche se egli lo negò sempre, l'autore era Spallanzani che, nel tono più beffardo, coprì Scopoli di ridicolo per aver scambiato le viscere di un pollo per un inedito verme intestinale. Il vaso con il "verme singolarissimo" sparì prontamente dal Museo, ma ormai il danno era fatto. Travolto dal discredito, l'8 maggio 1788, mentre si celebrava la festa di san Pio, in onore di papa Pio V, fondatore del Collegio Ghislieri, il povero Scopoli si accasciò per un ictus sotto il portico dell'Istituto.  Dediche botaniche Insomma, il destino giocò con Scopoli fino alla fine, preparandogli una morte al tempo stesso tragica e grottesca, di cui si spiacque ormai troppo tardi anche lo stesso Spallanzani. La sgradevole vicenda non intaccò per altro la stima per una luminosa carriera scientifica, costellata di più di cinquanta pubblicazioni con contributi originali in tutti i campi che aveva toccato. Per limitarci alla botanica, Flora carniolica è ancora oggi una pietra miliare, per aver avviato lo studio della flora della Slovenia e più in generale delle Alpi orientali. Nella tassonomia botanica, celebrano Scopoli l'eponimo di due specie soprattutto balcaniche, Arabis scopoliana e Senecio scopolii, una centro europea ma presente anche in Italia, Scrophularia scopolii; recentissima è la dedica di Hieracium scopolii, endemismo del monte Lesima tra Piacenza e Pavia. A dedicare al naturalista trentino un genere Scopolia furono in parecchi; ad aprire le danze fu Adanson (che tra l'altro Scopoli ammirava moltissimo: entrambi aspiravano a un sistema naturale); seguirono von Jacquin, i Forster, il figlio di Linneo, James Edward Smith. Tutti nomi di peso che attestano la sua fama europea. Poiché la denominazione di von Jacquin era più nota di quella di Adanson, tanto da essere fatta propria da Linneo, è quella conservata (nomen conservandum); e non si tratta di una dedica da poco. Nella prima edizione di Flora carniolica Scopoli descrisse una pianta che "vive in tutti i boschi ombrosi nei pressi di Idria" con la seguente diagnosi: "Atropa caule herbaceo, foliis ovatis interis, calycibus erectis, fructu capsulari" (belladonna con fusto erbaceo, foglie ovate intere, calici eretti, frutto a capsula). La mise poi a confronto con Atropa belladonna, chiarendone con grande precisione caratteristiche comuni e differenti. Tre anni dopo von Jacquin, che da poco si era trasferito a Banská Štiavnica ad occupare la cattedra che poi sarebbe stata di Scopoli, individuò in questa specie un nuovo genere, che dedicò opportunamente allo scopritore: "Scopola carniolica. Questa pianta che nasce spontaneamente nei boschi ombrosi di Idria, se non erro, fu scoperta e descritta per primo da Giovanni Antonio Scopoli, medico di Idria e indefesso cultore della storia naturale; poiché mi pare richieda assolutamente un nuovo genere, l'ho chiamata Scopola dal suo scopritore". Come si vede, von Jacquin chiamò il nuovo genere, scorrettamente, Scopola, senza i. Sembra che il nome spiacesse a Scopoli, visto che in veneziano una scopola è uno schiaffone. Nel 1767 Linneo aggiustò le cose, modificando la denominazione in Scopolia, anche se come eponimo, visto che attribuì la specie al genere Hyoscyamus come H. scopolia. Velenosissima, è una delle tre specie di questo genere delle Solanaceae, che sembra in effetti collocarsi a metà tra i generi Atropa, che ricorda per il rizoma, le foglie e i fiori, e Hyoscyamus, che ricorda per i frutti. E' probabile che ben prima che Scopoli la "scoprisse", fosse ben nota a guaritrici e fattucchiere; secondo alcune fonti, fin dal tardo Medioevo era utilizzato come narcotico, anestetico e ingrediente di filtri amorosi, oltre che per scopi criminali; contiene infatti diversi alcaloidi (iosciamina, atropina, scopolamina), con proprietà simili a quelle della belladonna. Del resto, nel 1554 era già stata descritta da Mattioli che l'aveva raccolta sul monte Sabotino quando viveva a Gorizia e la pubblicò come Solanum somnificum alterum. Nel 1824, Ernst A. Schmidt dell'università di Marburg estrasse dal rizoma di Scopolia carniolica il principio attivo chiamato scopolamina, un alcaloide con effetti narcotici ed allucinogeni, estremamente tossico anche in piccole dosi. Nell'Ottocento, ebbe un certo uso come anestetico, tanto che la società slovena di anestesiologia ha scelto Scopolia carniolica come proprio simbolo, anche se il suo uso è stato abbandonato da tempo. Nella seconda metà del Novecento la scopolamina venne usata come componente del siero della verità dalla CIA e da altre agenzie, finché si capì che altera talmente la percezione della realtà da dare risultati inaffidabili. Scopolia carniolica è diffusa in modo discontinuo nell'Europa centro-meridionale e sud-orientale, in particolare nei Carpazi e nella penisola balcanica; è presente anche altrove (Germania, Danimarca, Ucraina, Russia), ma potrebbe essere stata introdotta come pianta medicinale, importante nell'Ottocento per l'estrazione di atropina e scopolamina. Anche la sua distribuzione in Italia è disgiunta: la si trova infatti nel Biellese e in poste stazione delle Prealpi Giulie lungo il confine con la Slovenia. Endemica di quest'ultima è la rara S. carniolica var, hladnikiana. Le altre specie sono S. caucasica, nativa del Caucaso settentrionale, e S. japonica, presente in Corea e Giappone. Per finire, un ultimo omaggio... cartaceo. Per celebrare colui che è indubbiamente il fondatore dello studio della flora slovena, l'organo del Museo di scienze naturali di Lubiana è stato battezzata "Scopolia". Due belle piante alpine, Favratia zoysii (sin. Campanula zoysii) e Viola calcarata subsp. zoysii (sin. Viola zoysii), entrambe endemiche delle Alpi Giulie, e il genere orientale di graminacee Zoysia, molto popolare per creare tappeti erbosi resistenti al calpestio e alla siccità, celebrano il barone sloveno Karel Zois, che si fece conoscere nell'ambiente botanico austriaco e tedesco con i suoi invii di piante alpine. Vissuto all'ombra del molto più celebre fratello maggiore Žiga Zois, figura chiave dell'illuminismo sloveno, insieme a lui creò un parco ricco di piante esotiche che comprendeva anche un giardino alpino, il più antico della Slovenia (nonché uno dei primissimi al mondo).  Un fratello famoso e brillante Nei primi anni del Settecento, i fratelli Francesco e Michelangelo Zois, nati a Berbenno in Valle Imagna (Bergamo), andarono a cercare fortuna a Venezia. Mentre il primo rimaneva nella città lagunare, il secondo intorno al 1720 si trasferì a Lubiana per lavorare nella bottega di un conterraneo che aveva fatto fortuna, Peter Anton Codelli, un mercante che commerciava in telerie e materiali ferrosi. Nel 1727, ottenne la cittadinanza e insieme a un socio rilevò la ditta. Era l'inizio di una straordinaria ascesa economica e sociale: già nel 1730 era membro del consiglio municipale, nel 1735 acquistò l'intera ditta e ne espanse gli affari; vedeva in Italia il ferro e l'acciaio della Carniola, importava attraverso Venezia prodotti orientali (uvetta, mandorle, fichi, allume, mastice, candele, incenso) che esportava in Germania e in Austria. Negli anni '40 e '50, grazie all'acquisto di diverse miniere e fonderie, controllava quasi l'intero settore siderurgico della Carniola ed era ormai una delle persone più ricche del paese. Nel 1737 fu insignito della nobiltà ereditaria, nel 1747 sposò in seconde nozze una nobildonna slovena e dal 1760 si fregiò del titolo di barone (Freyherr zu Edelstein). Era anche un grosso proprietario terriero; tra le sue tante proprietà, spicca il castello rinascimentale di Brdo, acquistato intorno a 1755. Situato nei pressi Kranj, al centro di una tenuta di 500 ettari, oggi è la principale sede di rappresentanza della Repubblica di Slovenia; qui visse per gran parte della sua non lunga vita il botanico Karel Zois (Karel Filip Evgen, in tedesco Carl Filipp Eugen Zois Freiherr von Edelstein, 1756-1799). Era uno dei più giovani dei numerosi figli (almeno otto) nati dal secondo matrimonio di Michelangelo Zois; sulla sua vita personale non sappiamo molto, forse perché è stato oscurato dal ben più famoso fratello maggiore Žiga (Sigismondo o Sigmund, 1747-1819), il principale esponente dell'illuminismo sloveno. Oltre a far prosperare gli affari di famiglia con l'aiuto del cugino Bernardin (figlio di un fratello di Michelangelo), Žiga Zois fece del suo palazzo di Lubiana il punto d'incontro degli artisti e degli intellettuali della Carniola; incoraggiò la codificazione dello sloveno, fino ad allora considerato un semplice dialetto, promuovendo anche la pubblicazione del primo giornale in lingua slovena, Lublanske novice. Mecenate di artisti e scienziati, si interessò egli stesso di geologia, mineralogia, zoologia (inviando tra l'altro alcuni esemplari di proteo Proteus anguinus a Schreiber perché ne studiasse l'anatomia), nonché botanica, probabilmente per influsso del fratello. Da buon proprietario di miniere e ferriere, era soprattutto un geologo e come tale è ricordato dal minerale zoisite, che gli fu dedicato nel 1805 da Abraham Gottlob Werner cui ne aveva inviato un campione raccolto sulla Svinška planina. Tra i maggiori esponenti del suo circolo, per il suo ruolo pionieristico nello studio della geologia e della flora delle Alpi Giulie, va citato il chirurgo di origini francesi Belsazar Hacquet (1739-1815); dopo una vita avventurosa, egli lavorò dapprima a Idria come chirurgo minerario e ostetrico. Qui conobbe il lavoro di Scopoli, che attirò la sua attenzione sulla flora della Carniola; ne continuò le ricerche esplorando le Alpi Retiche, Noriche, Carniche e Giulie. Nel 1773 si trasferì a Lubiana come docente del Liceo medico e chirurgico e della scuola di ostetricia e divenne segretario dell'Associazione agricola della Carniola, di cui Žiga Zois era membro eminente; divenuto suo stretto amico e collaboratore, lo aiutò a creare un gabinetto di scienze naturali e una notevole biblioteca e lo assistette nelle sue ricerche mineralogiche e geologiche. Una passione condivisa (anche da Karel, come vedremo più avanti) era quella per le montagne: già nel 1777 Hacquet aveva tentato di raggiungere la vetta del Triglav, la maggiore della Slovenia (2864 m.), ma aveva dovuto accontentarsi del Mali Triglav (2725 m). Certamente su suo suggerimento, nel 1778 il barone Zois finanziò la prima scalata coronata da successo, cui parteciparono il chirurgo Lovrenc Willomitzer (che era stato allievo di Hacquet a Idria), un cacciatore di camosci e due minatori che lavoravano per Zois. Uno di loro, Matevž Kos, è anche il più noto dei raccoglitori di Karel. Proprio la natura del Triglav trascinò Zois nella grande disputa che nel Settecento divideva i geologi; secondo i nettunisti e il loro caposcuola Werner, tutte le rocce avevano un'origine marina; sulla scia dello scozzese James Hatton, i plutonisti sottolineavano invece il ruolo del magma e delle eruzioni vulcaniche nei processi di formazione delle rocce. Un convinto seguace di questa posizione era Johann Ehrenreich von Fichtel di Sibiu in Transilvania, cui Zois aveva inviato campioni di rocce raccolte ai piedi di monti Vršac e Triglav. Nel suo Mineralogische Aufsätze (1794) Fichtel sostenne che questi fossili provavano che le parti basse del massiccio erano costituite da sedimenti di origine marina (calcari secondari), mentre le parti più alte erano costituite da rocce calcaree primarie di origine magmatica. Zois, che tra l'altro corrispondeva con Dolomieu, che fu suo ospite nel 1784, non era d'accordo: era convito che anche le rocce calcaree della sommità fossero di origine marina; se i suoi campioni di fossili venivano dalle parti basse, era perché non aveva chiesto ai suoi uomini di raccoglierne ad altezze maggiori. Urgeva una spedizione geologica in piena regola. Zois la affidò a due sacerdoti, Valentin Vodnik e Jožef Pinhak, accompagnati dal conte Franz Hohenwart e da alcune guide, tra cui Matevž Kos e un altro dei raccoglitori di Karel Zois, Andrej Legat. Nell'agosto il gruppo esplorò il Vršac, a settembre il Triglav, raccogliendo abbastanza fossili da dimostrare le origini marine anche delle parti alte del massiccio. Valentin Vodnik era anche un poeta, e quella scalata ispirò uno dei suoi poemi più celebri, intitolato appunto Vršac. Fu poi uno dei principali redattori di Lublanske novice, riunendo nella sua persona i diversi aspetti del mecenatismo di Žiga Zois: gli interessi letterari, la promozione della lingua e della cultura slovena, la ricerca scientifica e l'amore per la montagna. Della generosità di Zois si giovarono anche i cittadini di Lubiana, cui aprì il giardino che fece costruire su un tratto delle antiche mura; la sua collezione di oltre 5000 minerali andò a costituire il primo nucleo del Museo di scienze naturali di Lubiana.  Un botanico rispettato, ma oscuro Rispetto a questa brillante e poliedrica figura, il fratello minore Karel appare decisamente in ombra. Non faceva parte del "circolo di Zois", e neppure viveva a Lubiana, ma per lo più a Brdo o anche a Javornik nell'Alta Carniola, dove gli Zois, oltre alla loro maggiore fonderia, possedevano una casa padronale. Questa scelta contro corrente e la relativa carenza di informazioni su di lui hanno dato origine a qualche malignità. Uno dei suoi primi biografi, Karel Dežman, ipotizzò che fosse "un po' eccentrico"; Voss raccolse la voce che non fosse in buoni rapporti con il fratello maggiore e che, dopo la sua morte, questi avesse fatto sparire tutti i documenti più o meno compromettenti. Nada Praprotnik, che ha dedicato molti studi a questi precursore della botanica slovena, ritrovando anche documenti inediti, contesta almeno la seconda affermazione; fino al 1795, quando la gravissima gotta di cui soffriva relegò Žiga nella casa di Lubiana e lo costrinse su una sedia a rotelle da lui stesso progettata, il barone trascorreva lunghi periodi a Brdo e Javornik e visitava spesso le ferriere. Condivideva la passione per la botanica del fratello, era orgogliosissimo delle piante che gli furono dedicate, e incoraggiò in ogni modo le sue ricerche. Illuminante a tale proposito è una sua lettera a Hacquet: "La sua passione botanica mi sta già influenzando. Ho avuto la fortuna di potergli inviare il tuo Leontodon terglouense con altri materiali che ho riconosciuto dai tuoi disegni. Sulle nostre montagne ci sono molte piante che tu e il signor Scopoli avete ignorato; i miei numerosi lavoratori delle miniere e delle foreste più alte mi permettono di cercarle. Ho fatto ristrutturare una piccola casa colonica a due terzi dell'altezza di Belščica in modo che l'anno prossimo io vi possa trascorrere il mese di luglio per dedicarmi alla botanica sulle cime e lungo la valle. Successivamente partiremo per Bohinj. Ho trovato modo di far portare mio fratello a cavallo a Vele Polje sul Triglav a basso costo, e spero di arrivarci io stesso". Forse, semplicemente Karel era di salute cagionevole (morì a poco più di quarant'anni), oppure non amava la città e la vita di società. Secondo Wulfen, a iniziarlo alla botanica fu un suo ex allievo del collegio gesuitico di Lubiana, un certo Weber; sicuramente determinante fu l'esempio di Hacquet, autore fra l'altro di una Flora carniolica, che lo stimava al punto che, quando partì da Lubiana alla volta di Leopoli, gli lasciò il suo erbario. Il vero mentore di Karel Zois fu però Franz Xaver Wulfen, al quale il barone sloveno inviò diverse piante che il gesuita pubblicò a partire dal 1788. Nada Praprotnik ne ha individuate una dozzina, a cominciare dalle due che portano il suo nome: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), raccolta da Zois nelle montagne di Bohinj e sullo Storžič; Viola zoysii (oggi Viola calcarata subsp. zoysii) che gli spedì a Klagenfurt intorno al 1785 "dalle Alpi della Carniola al confine con la Carinzia, viva, ancora con la terra". Altri endemismi delle Alpi Giulie e Carniche segnalate da Zois e pubblicate da Wulfen sono Saxifraga tenella e Moehringia villosa. Zois era anche in contatto con altri botanici: a Willdenow inviò Senecio carniolicus (oggi Jacobaea carniolica), a Sternberg piante vive di Saxifraga atropurpurea (oggi Saxifraga exarata subsp. ampullacea) raccolte a Konjska Planina. Invece Thomas Host lo cita per Stemmacantha rhapontica (oggi Leuzea rhapontica subsp. rhapontica) raccolta sulle montagne di Bohinj. Sappiamo da diverse testimonianze che i fratelli Zois possedevano almeno due capanne o rifugi montani, da cui Karel partiva per le sue escursioni. Abbiamo già incontrato quella che sorgeva sotto Belščica sulle Caravanche; non esiste più ma è rimasto il nome Gospodova koča ("capanna del signore") perche la usava "un signore che era solito raccogliere piante". L'altra si trovava sul Dvojno jezero nella valle dei laghi del Triglav, o forse più in alto presso il lago Ledvice (a meno che le capanne fossero tre). Nel 1795 vi fecero sosta i membri della spedizione al Triglav; secondo la testimonianza di Franz Hohenwart, era costruita in legno di larice, comprendeva un'ampia cucina, dove dormivano anche i servitori, un magazzino per le provviste e le raccolte, camere per gli ospiti, una stanza da letto e un salotto per il barone. Arrivato poco prima del tramonto, il gruppo fu accolto molto ospitalmente e poté ammirare l'opera di Karel Zois che, sebbene si trovasse nel rifugio da solo una settimana, aveva raccolto già più di mille piante, molte delle quali destinate ai suoi corrispondenti; prima che potessero disimpegnarsi, ci vollero due ore! Chiaramente le piante venivano raccolte in più esemplari; alcune venivano essiccate per l'erbario (alla sua morte, Karel Zois lasciò un erbario di 2100 esemplari, per lo più costituito da piante alpine) o per essere spedite ad amici e corrispondenti; altre venivano portate vive a valle. Oltre a quelle raccolte di persona, Zois si serviva di una serie di raccoglitori professionisti; erano fittavoli o dipendenti della famiglia in qualità di boscaioli, cacciatori o minatori; tra i primi scalatori del Triglav, abbiamo già incontrato Matevž Kos e Andrej Legat. Secondo Wulfen, fu Kos a raccogliere Malaxis monophyllos sulle pendici del Vršac. Le piante vive, insieme a ceste di terra di montagna, andavano ad arricchire il giardino alpino che, con molta spesa e grande impegno, Karel Zois volle sul lato sud-est del parco di Brdo. Il castello era circondato da una vasta tenuta, con foreste, stagni, frutteti. Molto probabilmente già all'inizio del Settecento a sud dell'edificio c'era un parterre in stile barocco, con un asse principale lungo 600 metri, percorso da un ampio viale, con aiuole a ramages delimitate da siepi di bosso su entrambi i lati. Questa parte venne mantenute, ma già all'epoca di Michelangelo venne creato un giardino recintato che combinava il giardino di piacere con la tenuta agricola; progettato su due livelli, con un dislivello di 60 cm, era diviso in 24 parcelle rettangolari uniformi e simmetriche, piantate in vario modo e delimitate da alberi da frutto e siepi di agrifoglio. A partire dal 1784 o 1785, i fratelli Zois, pur rispettando la sostanzialmente l'impianto preesistente, intervennero aggiungendo diversi elementi: un nuovo viale con tigli posti su sei file e prati e campi su entrambi i lati; due stagni, ciascuno dei quali dotato di un padiglione estivo a pagoda e collegato al castello da un viale di carpini; diversi edifici, tra cui cottage rustici con il tetto di paglia, una gloriette, una ghiacciaia, una rimessa per barche e una pista da bowling; per le piante esotiche c'erano sia una serra sia un'orangerie, dove venivano ricoverate le piante in vaso che nella bella stagione era esposte all'esterno. Poiché utilizzavano il medesimo impianto di riscaldamento, forse erano due settori dello stesso edificio. Tra il 1785 e il 1796, a Brdo vennero piantati 6.398 alberi e 1.063 arbusti autoctoni ed esotici; le ornamentali esotiche furono fatte venire per lo più dall'Olanda ma anche dall'Inghilterra (tra i fornitori, il celebre vivaio Loddiges); per moltiplicarli, sul lato est venne creato un vivaio (Novina). A Karel le specie esotiche interessavano soprattutto come oggetto di studio; era lui a occuparsi della loro scelta e a tenere i contatti con i fornitori. Alcuni li ottenne anche dai suoi corrispondenti, in particolare da Thomas Host che, in cambio delle piante alpine, gli procurò diverse piante esotiche, probabilmente coltivate a Schönbrunn. La pupilla degli occhi di Karel Zois era però il giardino botanico alpino, che venne creato sul lato più assolato del giardino. Qui egli fece trapiantare le piante alpine che raccoglieva durante le sue escursioni o gli venivano portate dai suoi raccoglitori. Fare crescere e sopravvivere a Brdo, a circa 420 m sul livello del mare, piante che crescono molto più in alto e hanno esigenze particolari e diversificate non dovette essere un'impresa facile. Il giardino fu certamente preparato con grande accuratezza, provvedendo a fornire ad ogni pianta l'esposizione e il terreno giusto. Lo fa pensare il fatto che vi fossero coltivate con successo piante notoriamente difficili come l'orchidea Cypripedium calceolus, le emiparassite Pedicularis o la calcifila Tozzia alpina. Tra i manoscritti di Žiga Zois, ci è giunto un "Elenco principale dei semi delle piante alpine" che però fu certamente scritto da Karel Zois, come si deduce dal fatto che Campanula zoysii è chiamata "campanula mea"; è citata più volte, mentre non sembra che egli coltivasse la "sua" viola: forse era troppo difficile farla prosperare in pianura, o si accontentava di goderla nel suo cottage sulle Caravanche, dove ancora oggi cresce in abbondanza. Molte delle piante alpine coltivate a Brdo erano piuttosto comuni, ma non mancavano le specie più rare come un'altra campanula, Campanula cespitosa, un endemismo delle Alpi orientali scoperto da Scopoli; Lilium carniolicum, di distribuzione strettamente carsica; Primula carniolica, un raro endemismo sloveno che cresce solo nel settore settentrionale della Selva di Trnovo nelle Alpi Giulie; Drypis spinosa, una specie tipica dei ghiaioni calcarei, un endemismo illirico con stazioni disgiunte nelle Alpi di Kamnik; Geranium argenteum, che in Slovenia cresce solo in poche stazioni e probabilmente fu raccolto sul Črna prst, che già Wulfen considerava un vero e proprio giardino naturale per la sua ricchezza di specie. Oltre alle piante dei monti della Slovenia, Karel Zois coltivava anche specie montane ottenute dai suoi corrispondenti: ad esempio, non crescono in Slovenia Lomatogonium carinthiacum e Wulfenia carinthiaca, i cui semi gli vennero inviati dal direttore dell'orto botanico di Vienna von Jacquin. Alcune specie venivano da molto più lontano: nell'elenco e nei quaderni di Zois sono citate piante asiatiche provenienti dalla Siberia, dalla Kamčatka o dal lago Baikal. Probabilmente a procurargliele fu un altro illustre corrispondente, Peter Simon Pallas. Il giardino botanico alpino di Karel Zois è di grande importanza storica: non solo fu il primo orto botanico della Slovenia, ma è in assoluto uno dei primissimi giardini alpini. Basti pensare che l'Alpengarten del Belvedere a Vienna, che vanta la primogenitura, fu fondato successivamente, nel 1803. Tuttavia fu di brevissima durata: Karel Zois morì a soli 43 anni nella casa di famiglia a Trieste. Il fratello, ormai prigioniero della gotta, non visitava da tempo la proprietà, e alla sua morte, nel 1819, la lasciò a un nipote (anch'egli si chiamava Karel Zois) che trascurò del tutto sia il giardino alpino sia il vivaio. Nel catasto del 1826, mentre compare ancora il giardino barocco, non esistono più né l'uno né l'altro.  Erbe per prati indistruttibili Oltre che dall'eponimo delle due specie che gli furono dedicate da Wulfen, Karel Zois è ricordato dal genere Zoysia, omaggio di Willdenow con questa motivazione: "In memoria del barone Karl Zois di Lubiana, che ha studiato con grande zelo la flora del suo paese e attraverso un'attenta ricerca ha scoperto diverse nuove specie". Questo genere della famiglia Poaceae comprende otto specie di erbe originarie di una vasta area che va dall'Oceano indiano al Pacifico, con centro di diversità nell'Asia sud-orientale; sono erbacee perenni rizomatose tappezzanti con lamina fogliare breve, stretta e piatta che formano tappeti erbosi bassi e densi. Originarie di paesi caldi, fanno parte delle cosiddette "essenze macroterme", ovvero di quelle specie di graminacee per prati erbosi che prediligano climi caldi, hanno una notevole resistenza alla siccità, posseggono apparati radicali profondi e aggressivi che consentono loro di riprendersi rapidamente dopo la pausa invernale, durante la quale tendono a ingiallire o a perdere la parte aerea. Sono anche fortemente resistenti al calpestio, per cui trovano largo impiego, oltre che nei prati ornamentali, negli impianti sportivi come campi da golf, da calcio o da rugby, Le Zoysia formano un tappeto erboso molto fitto e compatto, che tende naturalmente a non permettere la crescita delle infestanti (tranne che nel periodo di dormienza, che è uno dei loro talloni d'Achille); la crescita è poi molto lenta, richiedendo quindi tagli meno frequenti delle classiche erbe da prato all'inglese. Ma soprattutto sono estremamente resistenti sia alle alte temperature sia alla siccità. In commercio si trovano essenzialmente due specie, Z. japonica e Z. matrella. Z. japonica, più settentrionale, è presente in Cina, Manciuria, Corea, Giappone; negli Stati Uniti fu introdotta dalla Cina nel 1895 e presto divenne la specie più utilizzata nei due terzi meridionali del paese. Rispetto alle altre specie, ha una tessitura più grossolana, cresce più rapidamente e necessita di almeno quattro ore di sole al giorno. Soprattutto negli Stati Uniti, ne sono state sviluppate numerose cultivar tra le quali 'Zenith' si segnala per la maggiore resistenza alle basse temperature (fino a -10). Z. matrella è diffusa in un'area vastissima che va dal Madagascar e dalle Mascarene a occidente fino alle isole Salomone a oriente; se ne distinguono due varietà: la più occidentale Z. matrella var. matrella, spesso commercializzata con il vecchio nome Z. tenuifolia, anche nota come "erba delle Mascarene" (dal Madagascar all'Australia settentrionale) e la più orientale, Z, matrella var. pacifica (dall'Indocina al Pacifico nord-occidentale), nota come "erba di Manila". Si distingue da Z. japonica per la lamina fogliare più fine (strettissima in Z. matrella var. matrella), i ciuffi più fitti, la predilezione per i terreni sabbiosi anche poveri e la resistenza alla salinità, essendo una specie prevalentemente costiera. La varietà occidentale con il nome Z. tenuifolia è stata fatta conoscere in Europa da Elie Bonaut, floricoltore di Antibes, che ne ha diffuso la coltivazione nella riviera francese. La sua principale caratteristica è la versatilità; inoltre ha un periodo di dormienza più breve (1-2 mesi). Anche di questa specie esistono molte cultivar, come 'BRF Zoysia' (la sigla sta per Blade Runner Farm), una delle più utilizzate per i campi da golf. Esistono anche ibridi tra le due specie, il cui nome botanico è Zoysia x forbesiana, dall'agronomo statunitense che per primo tentò questo incrocio. In epoca di riscaldamento globale e di precipitazioni ridotte, un prato di Zoysia può essere una soluzione particolarmente sostenibile, adatta anche a giardinieri pigri, anche se non sarà davvero "indistruttibile" come vanta la pubblicità. Ma così come c'è uno Zois famoso e uno più defilato, oltre a questa regina del green, abbiamo anche un'altra, più oscura Zoysia, anzi... falsa Zoysia. Nel 1924 in Somalia venne raccolta un'erba che a prima vista assomigliava a una Zoysia, ma non lo era. Nel 1928 il botanico italiano Chiovenda la pubblicò, denominandola Pseudozoysia sessilis. Unica specie di questo genere, è una piccola erbacea perenne, alta meno di 15 cm; anch'essa forma densi ciuffi di foglie con lamina stretta e lineare e ha infiorescenze a falsa spiga con spighette su assi contratti; è un'alofita che cresce sulle dune costiere. Forse nel vostro giardino coltivate la bella e robusta Euphorbia characias subsp. wulfenii, oppure, se amate le piante alpine, conoscete Primula wulfeniana o Androsace wulfeniana, o addirittura la rara e bellissima Wulfenia carinthiaca. Tutte ricordano il sacerdote austriaco Franz Xaver von Wulfen, ex gesuita di santa vita, che nella seconda metà del Settecento fu tra i pionieri dello studio delle piante alpine, che andava a cercare nel loro ambiente naturale, tra malghe e crode; nella sua lunga carriera di naturalista delle grandi cime, fece più di 60 scalate, scalando tra gli altri il Grintovec in Slovenia, la Croda Rossa di Braies nelle Dolomiti, l'Eisenhut e lo Schleinitz nelle Alpi austriache. Ultra settantenne, partecipò addirittura all'epica sfida che portò alla conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria, anche se non fu tra quelli che raggiunsero la vetta. A ricordarlo non può che essere una pianta che egli stesso raccolse sulle sue montagne, appunto Wulfenia carinthiaca, specie tipo di un genere che non cessa di intrigare i botanici per la sua curiosa distribuzione disgiunta. Su montagne ancora più alte e lontane ci porta il secondo genere che lo celebra indirettamente, Wulfeniopsis. Entrambi appartengono alla famiglia Plantaginaceae.  Sacerdote e scienziato A Klagenfurt, la capitale della Carinzia, in una piazza affacciata su un giardino, sorge un modesto monumento, un cippo piramidale su base quadrata sormontato da una sfera; su una delle facce, la scritta: "Franz X. barone von Wulfen, ugualmente grande come sacerdote, studioso ed essere umano 1728-1805". Eretto inizialmente come cippo funerario, il monumento riflette la gratitudine e l'affetto dei cittadini di Klagenfurt per questo gesuita che visse nella città carinziana per quarant'anni distinguendosi per il suo spirito di carità. Ripercorriamone la vita, soffermandoci per ora sulla sua figura di sacerdote. Wulfen nacque a Belgrado, dove il padre, un militare tedesco al servizio dell'impero, era di stanza in quegli anni; la madre era invece una nobildonna ungherese. Secondogenito, dopo aver completato gli studi presso il liceo classico di Kaschau (oggi Košice, Slovacchia), a diciassette anni entrò nella compagnia di Gesù; seguì i due anni di noviziato a Vienna e completò gli studi umanistici a Györ (attuale Ungheria). Gli studi superiori lo riportarono a Vienna, dove studiò per tre anni filosofia e per due matematica superiore; quindi lo troviamo a Graz dove studiò teologia per quattro anni e completò i primi due anni di prova. Il terzo e ultimo lo trascorse a Banska Bystrica (nell'odierna Slovacchia) dove pronunciò i voti solenni nel 1763. Intanto aveva incominciato ad insegnare nei collegi gesuitici di diverse città: grammatica (ovvero le materie umanistiche dei primi tre anni del ginnasio) nel 1755 al Collegio di Gorizia e nel 1756 al Theresianum di Vienna; matematica nuovamente a Gorizia nel 1761; logica e metafisica a Lubiana nel 1762 e fisica newtoniana sempre a Lubiana nel 1763. Infine nel 1764 fu trasferito a Klagenfurt, dove insegnò dapprima matematica poi tutte le materie degli studi filosofici (studia superiora) fino alla fine del 1768. Nel 1769 lasciò l'insegnamento per dedicarsi esclusivamente alla cura pastorale. Dal 1769 al 1773 fu confessore e catechista presso le Suore Orsoline. La sua più profonda aspirazione era essere inviato come missionario in Cina o nelle Indie, ma nel 1773 lo scioglimento della Compagnia dei Gesù mise fine a questa speranza. Gli fu assegnata una piccola pensione e un alloggio in una casa sulla Burggasse; disponeva così di un modesto reddito che devolveva in gran parte ai poveri, così come dedicava molto del suo tempo all'assistenza spirituale dei poveri, dei malati e di chiunque cercasse in lui consolazione e consiglio. Non c'è da stupirsi se alla sua morte fu salutato dai concittadini d'adozione come santo. Ma era anche uno stimato scienziato, membro di numerose società scientifiche e corrispondente di naturalisti di fama, compreso lo stesso Linneo. Su questo secondo aspetto della sua personalità ci illumina la lapide posta sulla casa della Burggasse: "In questa casa visse e studiò fino alla fine della sua vita Franz Xavier v. Wulfen 1728-1805. Prendono il nome da lui la wulfenia e la wulfenite". La wulfenite è un minerale (molibdato di piombo), la wulfenia una rara pianta montana (Wulfenia carinthiaca); è il simbolo vegetale della Carinzia ed è ritratta nella parte bassa della lapide. Entrambi sono strettamente collegati all'attività scientifica di questo sacerdote-naturalista. 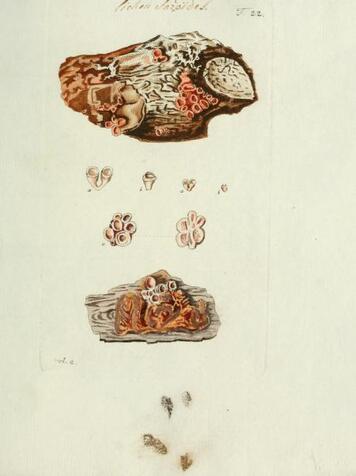 Alla scoperta della flora alpina Coltissimo, versato tanto nelle scienze umane quanto nelle matematiche, poliglotta che parlava e scriveva in quattro lingue (latino, tedesco, francese e italiano), come naturalista Wulfen era autodidatta; scoprì le scienze naturali, e in particolare la botanica, quando era novizio a Vienna, grazie a un amico medico Cominciò a tenere un erbario e ad esplorare le campagne in cerca di piante; come raccontò più tardi, per molto tempo il suo unico manuale fu Systema naturae di Linneo. Il primo terreno di ricerca furono ovviamente i dintorni di Vienna. Poi i continui spostamenti imposti dalla Compagnia di Gesù gli permisero di esplorare molte parti del variegato territorio asburgico, a cominciare dai paesaggi carsici dei dintorni di Gorizia, dove incominciò ad interessarsi anche di insetti e altri animali. Nel 1754 con un amico fece un viaggio a Venezia ed esplorò il Lido e Caorle. A Gratz ritrovò un amico d'infanzia, Leopold Biwald, che era entrato nella Compagnia qualche anno dopo di lui; gli diede lezioni di botanica e insieme batterono assiduamente le campagne. Forse durante il secondo soggiorno a Gorizia entrò in contatto con Scopoli, cui inviò esemplari sia per Entomologia Carniolica (1763) sia per la seconda edizione di Flora Carniolica (1772), in cui compaiono una sessantina di specie da lui raccolte; Scopoli così lo loda: "Grandissimi per la nostra flora sono i meriti del padre Francesco Saverio Wulfen della Compagnia di Gesù che benevolmente mi ha comunicato molte piante raccolte con indefessa industria nei dintorni di Gorizia". La passione per le ricerche naturalistiche si rinvigorì nei due anni trascorsi a Lubiana. Wulfen strinse amicizia con un confratello, padre Janez Jožef Erberg, anch'egli appassionato di botanica, che gli fece conoscere i dintorni della città; poiché nel mese di luglio le lezioni erano sospese e i professori erano in vacanza, Wulfen ne approfittò per esplorare i monti della Carniola; nacque probabilmente in questo periodo un'altra delle sue grandi passioni: l'alpinismo. Fu sul monte Nevoso nei pressi di Trieste e scalò il Grintovec, la cima maggiore della Carniola. Trasmise la sua passione per la montagna e la natura a uno dei suoi allievi, Sigmund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che fu suo compagno in alcune escursioni nelle Alpi di Kamnik e della Savinja, grazie alle quali incominciò a interessarsi anche di mineralogia. Situata sul lago Wörthersee tra verdi colline, in una zona ricca di stazioni termali, al centro di uno splendido scenario alpino, benché periferica e lontana dalle grandi biblioteche, Klagenfurt si offrì a Wulfen come un perfetto terreno di studio; presto si propose di scrivere una Flora norica, progetto a cui si sarebbe assiduamente dedicato fino alla fine dei suoi giorni. A tale scopo esplorò a fondo non solo i dintorni della città, ma gran parte delle valli e delle catene montuose della Carinzia, estendendo le sue raccolte alle crittogame e ai licheni, che egli classificava tra le alghe e che divennero il suo soggetto preferito. D'estate non perdeva occasione per percorrere le montagne per cercare minerali e piante alpine; durante i 40 anni in cui visse a Klagenfurt, fece più di sessanta scalate (ma su questo aspetto torneremo più avanti). Anche se finora non aveva pubblicato nulla, il suo nome incominciava ad essere conosciuto. Nel 1772 iniziò a collaborare con von Jacquin per Florae austriacae [...] icones; la loro era una tipica relazione patrono-cliente: grazie a corrieri, amici comuni, viaggiatori, commercianti, librai, da Klagenfurt partivano per Vienna esemplari d'erbario, semi, piante alpine vive e descrizioni, mentre da Vienna arrivavano libri e pubblicazioni difficili da reperire nella periferica Klagenfurt, nonché contatti con altri studiosi, come il padre della briologia Johannes Hedwig, che in quegli anni stava lavorando al suo trattato sui muschi. Jacquin utilizzò materiali comunicati da Wulfen sia per il quinto volume di Florae austriacae icones sia per Icones plantarum rariorum; inoltre pubblicò la prima opera a stampa di Wulfen, Plantae rariores carinthiacae, in sei puntate: nel primo e nel secondo volume della sua Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia (rispettivamente 1778 e 1781); nei primi quattro volumi di Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem (1786, 1788, 1789, 1790). Le specie più nuove ed interessanti erano anche corredate di immagini di eccellente qualità, eseguite dal valente pittore Joseph Menning e pagate di tasca propria da Wulfen; di particolare importanza storica le descrizioni e le immagini dei licheni, che per le prima volta ricevevano un'attenzione privilegiata. Le 364 specie di piante, funghi e licheni descritte in Plantae rariores carinthiacae erano il frutto di diversi viaggi nelle montagne della Carinzia e del Tirolo che Wulfen poté intraprendere grazie al finanziamento del consigliere imperiale Franz von Mygind. corrispondente di Linneo e amico di Jacquin. Nel 1781, con la dedica da parte di Jacquin del genere Wulfenia nel secondo volume di Miscellanea austriaca, si ebbe la sua consacrazione simbolica nell'empireo della botanica, anche se, nella sua infinita modestia, il buon sacerdote si schermì, scrivendo di non essere degno di tanto onore. Eppure la collaborazione con von Jacquin lo lasciava insoddisfatto. Era uno studioso scrupolosissimo e perfezionista. Le sue descrizioni erano un capolavoro di precisione: già sul posto, per ogni specie osservata dal vivo stendeva su un foglio a parte una prima versione, che poi inseriva nel quaderno che portava sempre con sé; a casa, consultava la bibliografia botanica e ricopiava ogni nota in bella copia, corredandola di sinonimi e note d'autorità, per poi inserirla al suo posto nell'erbario, classificato secondo il sistema linneano. In tal modo le sue descrizioni risultavano allo stesso tempo precise, fedeli e vivaci. Quanto alle identificazioni, aveva spesso dubbi, e avrebbe desiderato confrontarsi alla pari con altri botanici. A von Jacquin invece premeva pubblicare, ed era molto più sbrigativo; almeno tale pareva all'ipercritico e perfezionista Wulfen. Fu questo a provocare la rottura: quando espresse le sue perplessità a Thomas Host, che, in viaggio per la Dalmazia, gli aveva fatto visita nella sua casa di Klagenfurt, questi le prese come una critica personale e le riferì a von Jacquin; da quel momento ogni collaborazione si interruppe. Ma Wulfen nel frattempo aveva trovato altri mecenati. Come membro della Società di agricoltura di Klagenfurt, aveva stretto amicizia con l'imprenditore Johann (Jan) von Thys, di origine olandese, che aveva fondato una manifattura di tessuti a Klagenfurt ed era uno degli animatori della modernizzazione agricola della Carinzia; Thys e dopo la sua morte il figlio Rainer Franz finanziarono alcune spedizioni di Wulfen, che nel 1781 accompagnò Thys figlio in un memorabile viaggio in Olanda, nel corso del quale visitò tra l'altro gli orti botanici di Leida e Amsterdam e ne incontrò i prefetti David van Royen e Nicolaas Laurens Burman; la moglie di quest'ultimo gli donò una collezione di insetti sudafricani, che egli tre anni dopo pubblicò a Erlangen sotto il titolo Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum. Durante il viaggio, si era fermato a Erlangen per incontrare di persona Johann Christian von Schreber, con il quale già corrispondeva grazie a un altro naturalista ex gesuita, Franz von Paula Schrank. Allievo di Linneo e traduttore delle opere linneane in tedesco, professore di materia medica e direttore dell'orto botanico di Erlangen, dal 1791 presidente dell'Accademia leopoldina, Schreber, oltre che uno dei più importanti zoologi del suo tempo, era una figura di primo piano del mondo accademico tedesco; anche grazie alla sua amicizia, Wulfen fu via via ammesso a molte società scientifiche (oltre alla stessa Leopoldina, quelle di Erlangen, Jena, Berlino, Göttingen, nonché l'Accademia delle scienze di Stoccolma). Inoltre Schreber sostituì von Jacquin come curatore editoriale di Wulfen, che a partire dal 1786 pubblicò tutte le sue opere a Erlangen. In precedenza, fu ancora pubblicata a Vienna Abhandlung vom Kärntner Bleispate (1785), una monografia sui minerali di piombo di Bleiburg in Carinzia, magnificamente illustrata da Joseph Menning; tra di essi il minerale originariamente battezzato da Ignaz von Born che lo descrisse per primo nel 1772 plumbum spatosum flavo-rubrum, poi denominato da von Jacquin Kärntherischer bleispath, "spato di piombo di Carinzia"; nel 1845 venne infine ribattezzato wulfenite in onore del nostro. Oltre a Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum (1786), le opere uscite a Erlangen sono Plantae rariores descriptae (1803) e Cryptogama aquatica (1803). Di particolare interesse l'ultima, dedicata ad alghe e piante acquatiche, con la descrizione di oltre settanta specie; anch'essa fu resa possibile dal mecenatismo di Thys, che gli procurò un'amichevole accoglienza presso la filiale triestina della sua ditta; nel corso di due lunghi soggiorni, Wulfen poté così esplorare la fauna e la flora della costa adriatica, visitando anche l'Istria e le isole di Veglia, Cherso e Arbe. Gli si deve tra l'altro la prima descrizione di Ulva stellata, Fucus musciformis, Fucus filamentosus e Fucus simplex. 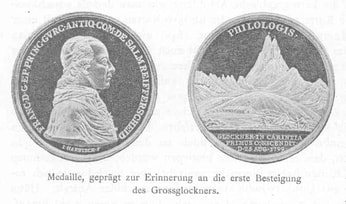 Scalate e piante alpine A Klangefurt, Wulfen riunì attorno a sé un piccolo circolo di più giovani studiosi, molti dei quali ecclesiastici, cui trasmise la sua passione per le scienze naturali e la montagna. Tra di loro spicca l'antico allievo di Lubiana Sigismund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che dal 1787 era vicario generale del principe-vescovo di Klangenfurt. Come il suo maestro era un grande appassionato di montagna e lo accompagnò in diversi viaggi ed escursioni. Insieme al barone Joseph von Seenus (che nel 1805 avrebbe pubblicato il resoconto di un viaggio botanico in Istria e Dalmazia), fu compagno di Wulfen in un secondo viaggio a Venezia; sulla via del ritorno visitarono varie località del Friuli e a Tolmezzo non mancarono di scalare La Mariana (Monte Amariana, 1906 s.l.m). In compagnia di un terzo ecclesiastico, il domenicano Ignaz von Eisentratten, scalarono l'Eisenhut (2441 m), la cima maggiore delle Alpi della Gurtal, e nel 1790 lo Schleinitz (2904 m) nel Gruppo dello Schober. Nel 1791, quando il botanico dilettante Carl von Zois venne apposta da Lubiana per incontrare Wulfen, venne organizzata per lui una grande escursione attraverso le catene della Carinzia superiore e del Tirolo, alla quale partecipò, oltre a Wulfen e Hohenwart, anche il goriziano Joseph Reiner, archivista e cappellano di corte prima a Gorizia poi a Klangenfurt. L'anno dopo Reiner e Hohenwarth raccontarono l'impresa in Botanische Reisen nach einigen Oberkärntnerischen und benachbarten Alpen unternommen [...], che contribuì grandemente a diffondere l'interesse per le montagne e l'alpinismo. Le testimonianze del tempo descrivono Wulfen come un uomo di alta statura, eretto anche in tarda età, forte ed agile, capace di camminare per mezza giornata senza stancarsi alla ricerca di una pianta rara e di lasciare indietro guide ed accompagnatori più giovani. Quando aveva superato la sessantina, tra il 1791 e il 1794, di passaggio da uno dei suoi viaggia a Trieste, esplorò le Dolomiti di Braies. scalando il Monte Lungo, il Picco di Vallandro e addirittura la Croda Rossa, la cima maggiore con i suoi 3.148 m. Vista la sua età, c'è chi ha messo in dubbio questa impresa; ma aveva più settant'anni quando prese parte alla più celebre impresa alpinistica austriaca dell'epoca, la conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria (3718 metri). La spedizione fu organizzata dal principe-vescovo della Carinzia Xaver von Salm-Reifferscheidt-Krautheim, sull'onda della prima ascensione del monte Bianco del 1786. Wulfen e Hohenwart conoscevano benissimo la catena del Grossglockner, frequente terreno delle loro esplorazioni botaniche, ne furono gli ispiratori e nel 1795 furono incaricati di una prima ricognizione; nel 1798 l'area fu ispezionata dall'arcivescovo in persona, che non badò a spese per la spedizione dell'anno successivo. Furono ingaggiati due montanari (le relazioni li ricordano come "i Glokner" e ci sono incertezze sui loro nomi esatti), che predisposero sentieri e all'altezza di 2620 m costruirono un rifugio, chiamato Salmhütte in onore del principe-vescovo, sufficientemente grande da ospitare i 30 membri della spedizione, tra cui Wulfen e Hohenwart. Il 23 luglio 1799 le due guide giunsero poco sotto la vetta del Kleinglochner, ma il maltempo rallentò a lungo la spedizione dei "signori"; solo il 24 agosto Hohenwart e quattro guide riuscirono a raggiungere il Kleinglochner, una cima un poco più bassa divisa dalla vetta principale da una forcella molto esposta, ma dovettero rinunciare a scalare la cima maggiore. Si diffuse però la voce che l'impresa fosse riuscita, e che i cinque avessero addirittura eretto una croce sulla cima, avvalorata da una medaglia commemorativa fatta coniare dal vescovo, con il suo ritratto sul recto, e il profilo del Grossglockner sul verso, con la croce sulla cima e la data dell'ascesa 25 agosto 1799. In realtà fin da settembre fu pianificata una seconda spedizione per l'estate successiva. Era ancora più imponente della precedente, con ben 62 partecipanti, tra i quali di nuovo Hohenwart, Wulfen, il botanico David Heinrich Hoppe, il geologo Ulrich Schiegg e il suo allievo Valentin Stanič . Fu costruito un secondo rifugio più in alto del precedente sull'Adlesruhe (3454 m). La spedizione si servì di scale, corde e rudimentali ramponi e fu guidata dai quattro montanari che avevano già partecipato alla spedizione precedente. Furono proprio loro a raggiungere la cima maggiore il 28 luglio, mentre Hoppe, Hohenwart e il parroco Orrasch li attendevano sulla cima del Kleinglocker; quindi, ridiscesero e raggiunsero nuovamente la vetta insieme a un altro parroco, Mathias Hautzendorfer, l'unico dei primi scalatori di cui conosciamo con esattezza il nome. Il giorno successivo anche Schiegg e Stanič raggiunsero la vetta; fecero misurazioni della pressione barometrica dell'aria e misurarono l'altezza della cima, mentre le guide vi fissavano una croce. Nel 1802 e nel 1806 il vescovo finanziò altre due spedizioni; in quella del 1802, finalmente anche Hohenwart raggiunse la vetta principale. Invece, sia nel 1799 sia nel 1800, l'ormai anziano Wulfen dovette accontentarsi di assistere alla scalata insieme all'arcivescovo dal rifugio dell'Adlesruhe. Erano anni tempestosi e stupisce che il principe-vescovo avesse profuso tanto impegno (e tanto denaro) in questa impresa alpinistica e scientifica. Nel 1797 Klagenfurt era stata occupata dai francesi, che rubarono gran parte delle raccolte di Wulfen. Nonostante questo il vecchio sacerdote continuava a lavorare alla sua Flora norica, un work in progress che nel suo maniacale perfezionismo non gli pareva mai pronta per la pubblicazione, per la quale del resto gli mancavano i soldi. Rimase sano e attivo fino alla fine, quando una polmonite lo stroncò nell'arco di tre giorni nell'aprile 1805. Contava che avrebbe provveduto alla pubblicazione Schreber, al quale lasciò il manoscritto ormai completato, con le illustrazioni relative e esemplari d'erbario. Il resto delle collezioni passò invece a Hohenwart, che nel 1809 sarebbe diventato arcivescovo di Linz. Purtroppo Schreber non poté esaudire l'ultima volontà di Wulfen, sia per la situazione di guerra sia perché morì egli stesso pochi anni dopo, nel 1810. Così Flora norica rimase inedita fino al 1858, quando la Società botanico-zoologica di Vienna decise di finanziarne la pubblicazione, affidandola a Eduard Fenzl, professore di botanica dell'Università di Vienna, con l'assistenza di Rainer Graf, spiritualmente vicino a Wulfen come sacerdote originario di Lubiana; l'opera contiene anche una delle prime biografie di Wulfen. In mezzo secolo gli studi sulla flora austriaca avevano fatto molti progressi e l'opera conservava un valore quasi solo storico; in particolare, Fenzl e Graf considerarono obsoleta la parte dedicata alle crittogame e limitarono la pubblicazione alle angiosperme, sotto il titolo Flora Norica Phanerogama; benché tardiva, con le sue vivide descrizioni di 717 specie dell'Austria e delle Alpi orientali rimane una pietra miliare per la conoscenza soprattutto della flora alpina.  Wulfenia, Wulfeniopsis e altre rarità montane A Wulfen si deve la prima pubblicazione di circa 120 taxa di vegetali. Tra di essi spiccano ovviamente molte piante alpine: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), endemica dei monti della Carinzia e della Slovenia e dedicata al discepolo "a distanza" Karl von Zois che ne fu il primo raccoglitore; Primula glutinosa, un endemismo delle Alpi orientali presente anche in Italia tra Lombardia e Trentino; Saxifraga moschata, diffusa invece dai Pirenei al Caucaso; Androsace chamaejasme, presente oltre che sui monti europei, nella catena dell'Atlante in Marocco; la genzianella nana Gentiana nana (oggi Comastoma nanum), una specie di alta quota delle Alpi orientali. Lo ricordano nell'eponimo specie endemiche delle Alpi orientali di cui fu il primo raccoglitore: Primula wulfeniana, Alyssum wulfenianum, Sempervivum wulfenii, Androsace wulfeniana. E' invece originaria dei litorali mediterranei Euphorbia characias subsp. wulfenii, oggi molto coltivata nei giardini e ampiamente naturalizzata. Torniamo in montagna con Wulfenia carinthiaca, la specie tipo del genere Wulfenia (Plantaginaceae), scoperta da Wulfen nel luglio 1779 alla malga Kuehweger (1625 m.) sulle pendici del Gartnerkofel nelle alpi Carniche; von Jacquin gliela dedicò con queste parole: "Ho nominato questa bellissima pianta dal suo scopritore, uomo di grande merito botanico, cui dobbiamo tante belle e rarissime piante della Carinzia". Oltre che bellissima (speciosa, scrive von Jacquin) è anch'essa assai rara, come tutte le consorelle del genere Wulfenia, caratterizzato da una singolare distribuzione disgiunta in tre aree non contigue: le Alpi Carniche tra Austria e Italia, le Alpi Dinariche in Albania, i monti Nur nella Turchia meridionale. La stessa W. carinthiaca ha distribuzione disgiunta: nelle Alpi Carniche è presente in una ristretta area di appena 10 km² attorno al Passo Pramollo-Nassfeld Pass sia sul versante italiano sia su quello austriaco; più ampie le popolazioni dinariche, a cavallo tra Albania, Montenegro e Kosovo. Ha foglie a rosetta obovate, crenate e carnose dalle quali a metà estate, per pochi giorni, emergono alti racemi fitti di fiori campanulati blu-viola. Cresce su pietraie umide, nel sottobosco degli ontaneti e delle pinete di Pinus mugo (Alpi Carniche) e Pinus peuce (Alpi Dinariche) o nei pascoli ricchi di azoto nei pressi delle malghe appena al di sopra del limite degli alberi. W. baldaccii, simile alla specie precedente, ma di dimensioni minori, fu segnalata per la prima volta negli anni '30 del Novecento dal botanico italiano Antonio Baldacci. E' un endemismo dei Monti Prokletje nell'Albania settentrionale, dove cresce nelle fessure tra le rocce nei boschi di betulla o ai margini di essi. Le altre due specie, W. glanduligera e W. orientalis, crescono su monti più bassi e mesofili della Turchia sud-orientale, entrambe nelle fessure delle rocce, la prima nei boschi di Fagus orientalis, la seconda nelle foreste sempreverdi submediterranee. In passato erano assegnate al genere Wulfenia anche due specie himalayane. La distribuzione fortemente discontinua tra Mediterraneo e Himalaya, benché non unica, è piuttosto rara e negli anni '80 del Novecento ha spinto gli studiosi ad approfondire la questione. Paragonando esemplari di tutte le specie e i loro pollini, essi sono giunti alla conclusioni che le differenze sono tali da far assegnare quelle himalayane a un genere proprio, che è stato denominato Wulfeniopsis (simile a Wulfenia); si distingue da Wulfenia per il numero dei cromosomi, le caratteristiche del polline e i racemi molto più radi, con i fiori portati da un solo lato dell'asse, con corolla non bilabiata con quattro lobi anziché cinque. Gli sono assegnate due specie, W. amherstiana (Himalaya occidentale, dal Pakistan al Nepal centrale, da 1500 a 3000 metri di altitudine) e W. nepalensis (talvolta considerata una varietà della precedente, endemica del Nepal, tra 1500 e 2700 m). Dunque, di nuovo piante di alta montagna che non sarebbero spiaciute a padre Wulfen. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
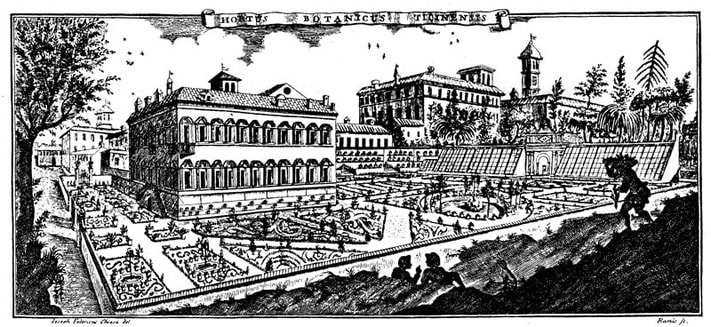

 RSS Feed
RSS Feed