|
Tra le migliaia di persone che, attratte dalla febbre dell'oro, attorno al 1850 si riversarono in California, c'era anche Hiram Green Bloomer. Della sua vita personale sappiamo poco, ma gli atti dell'Accademia delle scienze della California attestano che fu uno dei sette fondatori e poi me fu un membro molto attivo, rivestendo a lungo il ruolo di curatore del dipartimento di botanica. Fece raccolte sia in California sia in Nevada e, oltre a donare molti esemplari all'accademia, altri ne inviò per la determinazione ai botanici dell'East Cost. Diversi gli furono dedicati da Asa Gray e uno da Sereno Watson. Non amava scrivere, ma era un bibliofilo e collezionista di libri di botanica (non per sé, ma per la biblioteca dell'Accademia); amava invece coltivare le bulbose native, come quella bellissima dai fiori d'oro che l'amico Albert Kellogg vide per la prima volta fiorire nel suo giardino. Gliela dedicò e così nacque il genere Bloomeria (Asparagaceae). 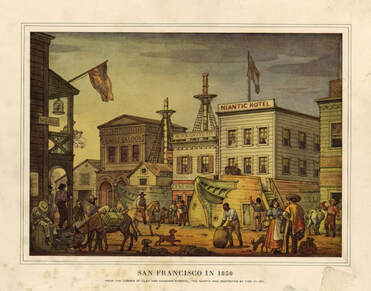 Dalla corsa dell'oro all'Accademia delle scienze Fino al 1846, là dove sarebbe sorta San Francisco, c'era un villaggio di meno di 300 abitanti chiamato Yerba buena (dal nome spagnolo di Clinopodium douglasii, abbondante in quest'area). Poi gli Stati Uniti strapparono al Messico la California (nel 1850 sarebbe diventata il 31 stato), Yerba buena divenne San Francisco, nel 1848 a Sutter's Mill venne scoperto l'oro; nell'arco di pochi anni 300.000 persone arrivarono qui da tutti gli Stati uniti e dall'estero in cerca di oro e fortuna. Tra di loro c'erano anche Hiram Green Bloomer (1821–1874) e la sua famiglia. Era nato a Marlborough nello stato di New York; non conosciamo molto della sua vita personale, ma sappiamo che aveva studiato al Newburgh College; era sposato e aveva già diversi figli. Nel 1849, all'età di 28 anni, tentò di raggiungere una prima volta la California ma a Panama, dove doveva imbarcarsi, si ammalò e fu costretto a tornare a casa. Arrivò a San Francisco probabilmente l'anno dopo e si inserì in fretta in quella città in tumultuosa crescita, divenendo un "cittadino a scartamento largo", come lo definisce Jepson, impegnato in molte attività civiche. Ad attrarlo in California non dovette essere solo l'oro, ma anche le piante, visto che già a Panama aveva fatto qualche raccolta. Entrò così in contatto con altri appassionati, tra cui il medico e farmacista Albert Kellogg. Nella serata del 4 aprile 1853, Kellogg e Bloomer si incontrarono con altre cinque persone in un ufficio di Montgmery Street: è l'atto di fondazione dell'Accademia delle Scienze della California, i cui scopi erano "una sistematica e accurata ricognizione di ogni porzione dello Stato e la raccolta di un gabinetto delle sue rare e ricche produzioni". Fino ad allora, ad interessarsi della ricca flora californiana erano stati da una parte i botanici delle spedizioni che vi fecero scalo tra il Settecento e la prima metà dell'Ottocento, come Menzies, il botanico della spedizione Vancouver che la visitò nel 1793, o raccoglitori venuti da lontano, come David Douglas che nel 1831 esplorò la California meridionale per incarico della Royal Horticultural Society. Kellogg e Bloomer furono tra i primi botanici residenti. Oltre alla passione per le piante, avevano in comune il talento artistico (del primo ci sono rimasti eccellenti disegni di piante, il secondo trasmise i primi rudimenti dell'arte al figlio Hiram Reynolds Bloomer, in seguito un noto pittore paesaggista) e la dedizione all'accademia, nella quale occuparono ruoli importanti. Kellogg fu il fondatore dell'erbario e il primo curatore del dipartimento di botanica, Bloomer, dopo essere stato segretario e redattore dei verbali dal 1854, fu curatore del dipartimento di botanica dal 1856 al 1866, infine direttore del museo, dal 1868 fino alla morte nel 1874. Kellogg e Bloomer erano amici e collaboratori, ma in una cosa si differenziavano totalmente: il primo era uno scrittore prolifico con all'attivo decine di articoli nei Proceedings dell'Accademia e in altre riviste, del secondo ci è noto sola un breve testo in cui difese la priorità degli studi di Kellogg sulla sequoia gigante di fronte alla pretese di Lindley di denominare quella gloria americana Wellingtonia gigantea. Jepson nel breve schizzo biografico che gli dedicò lo ha spiritosamente definito membro della "molto stimabile confraternita dei non-scrittori". Non scriveva, ma prendeva frequentemente la parola alle riunioni dell'accademia, spesso per presentare qualche libro o recenti pubblicazioni di botanica. Il non scrittore Bloomer era infatti un lettore e un bibliofilo: all'accademia donò in più occasioni non solo esemplari botanici da lui raccolti, ma anche libri; ci è rimasta una sua unica lettera a Torrey, in cui chiede informazioni sul prezzo e la reperibilità della sua Flora of New York e un aiuto per trovare testi botanici rari; quello che desiderava di più era Les Liliaceés di Redouté, anche di seconda mano. Le liliacee (ovvero le bulbose: ai suoi tempi ne facevano parte moltissime specie poi transitate in altre famiglie) erano la sua più grande passione e, come vedremo meglio tra poco, amava coltivare quelle native nel suo giardino. All'amore per le piante si deve anche la sua morte, a poco più di cinquant'anni: nel settembre 1874, con altri appassionati, partecipò a un viaggio di esplorazione nel Marin County; il gruppo si perdette e fu costretto a trascorrere la notte all'addiaccio. Per la fatica e l'esposizione agli elementi, Bloomer si ammalò e poco dopo morì.  Bloomeria, ovvero stelle d'oro Bloomer erborizzò in California e in Nevada; secondo la testimonianza del figlio Hiram Reynolds, creò un erbario di diverse migliaia di esemplari, accuratamente classificati ed etichettati, e circa un anno prima della morte lo donò all'Accademia; purtroppo è andato perduto, ma alcuni duplicati sono conservati in altre collezioni. La sua attività di raccoglitore è testimoniata da diverse dediche di botanici dell'East cost, che pure guardavano dall'alto in basso i "dilettanti" della California: da Sereno Watson, Ranunculus bloomeri (oggi Ranunculus orthorhynchus var. bloomeri), raccolto dal "Dr. J. (sic!) G. Bloomer in un fondo umido presso San Francisco", e da Asa Gray varie specie da lui raccolte a Virginia City e sul Monte Davidson in Nevada: Aster bloomeri (oggi Symphyotrichum campestre), Erigeron bloomeri, Haplopappus bloomeri (oggi Ericameria bloomeri), e Galium bloomeri (oggi Galium multiflorum), a proposito del quale Gray scrive:"[raccolto] nel territorio di Nevada presso Virginia City da Mr. H. G. Bloomer, al quale, come suo scopritore, ho il piacere di dedicare questa specie così ben caratterizzata". Fu invece un altro botanico attivo in California, Henry N. Bolander, a dedicargli Stipa bloomeri (oggi Eriocoma × bloomeri) per "commemorare i suoi servigi alla botanica di questa costa occidentale". Alla passione per le liliacee si deve una dedica in un certo senso "mancata" da parte dell'amico Kellogg. Prima del 1860 egli vide nel giardino di Bloomer "il giglio più magnifico della costa pacifica". Ne fu così impressionato che ne presentò un disegno (forse realizzato dallo stesso Bloomer) all'Accademia; tuttavia non lo pubblicò. Lo fece solo una dozzina di anni dopo, denominandolo Lilium bloomerianum. Troppo tardi: due anni prima la magnifica specie, raccolta in California da Benedikt Roezl e inviata in Europa, era stata validamente pubblicata come Lilium humboldtii, in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande esploratore-naturalista. Kellogg aveva comunque provveduto a immortalare l'amico con la dedica di una genere. Nella seduta del 18 luglio 1859 dell'Accademia delle scienze, egli presentò esemplari e disegni di due liliacee (sempre nel senso ampio impiegato all'epoca) raccolte a New Idria da John Allean Veatch e coltivate nel giardino di Bloomer. Non sappiamo se le avesse disegnate lo stesso Kellogg oppure Bloomer, entrambi eccellenti artisti. Ritenendole nuove per la scienza e non appartenenti ad alcun genere noto, Kellogg stabilì per lo loro due nuovi generi, battezzandole rispettivamente Veatchia crystallina e Bloomeria aurea. In realtà, la prima non era inedita: era stata pubblicata quasi trent'anni prima da Lindley come Hesperoscordum hyacinthinum; in seguito, fu riclassificata e oggi si chiama Triteleia hyacinthina; Veatchia è dunque sinonimo di Triteleia e la fama del perito, agrimensore e mineralogista Veatch rimane affidata alla scoperta di un vasto deposito di borace nel Lake County. Kellogg aveva invece visto giusto con Bloomeria: questo piccolo genere, di cui fu il primo a descrivere una specie, rimane valido e continua ad essere il più bell'omaggio al non-scrittore Hiram Green Bloomer. Come Brodiaea, Behria e Triteleia, fa parte della sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Le sue tre specie (Bloomeria clevelandii, B. crocea e B. humilis) sono native delle colline pedemontane aride della California e della Baja California, dove crescono in praterie, nei boschi aperti o nel chaparral. Come le loro sorelle, hanno cormi, foglie lineari e sottili steli culminanti con una infiorescenza a ombrella relativamente grande. Invece degli azzurri di Triteleia e Brodiaea e del rosso di Behria, i fiori di Bloomeria ostentano il più luminoso dei gialli. I singoli fiori sono piccoli, a stella (in inglese si chiamano Golden Stars), con lobi molti aperti, per lo più liberi (una caratteristica distintiva rispetto ai generi affini). Solitamente si coltiva la specie più diffusa, B. crocea. Si riproduce con facilità, è molto fiorifera e regala una lunga fioritura se coltivata al sole in terreno ben drenato. Dopo la fioritura, le foglie seccano e, poiché non è rustica e detesta l'umidità invernale, dove gli inverni sono freddi e umidi il modo migliore per coltivarla è ritirare i cormi d'autunno e conservarli in un luogo asciutto, ripiantandoli in primavera; si piantano invece in autunno dove gli inverni sono miti, a condizione da proteggerli tassativamente dalle piogge invernali.
0 Comments
Furono tre i continenti (se non contiamo qualche mese in un quarto e un breve scalo nel quinto) a fare da sfondo alla vita di Hans Hermann Behr, dottore in medicina e poliedrico naturalista e scrittore. Nato e formatosi in Germania, una prima visita lo portò per un po' più di un anno in Australia ad esplorare l'area di Adelaide, all'epoca meta di molti coloni tedeschi. Ritornò poi a casa, ma la rivoluzione del '48 - a suo dire - lo trasformò in esule, prima di nuovo in Australia, poi per breve tempo nelle Filippine, infine per più di mezzo secolo in California. Arrivò a San Francisco proprio in coincidenza con l'inizio della febbre dell'oro (l'unico prodotto della natura che non lo interessò mai) e fu testimone della tumultuosa crescita della città e della distruzione di un ambiente naturale che aveva potuto vedere ancora intatto. Prolifico cacciatore di piante e insetti in Australia, nonché autore di interessanti articoli antropologici, in California ebbe un ruolo di primo piano nell'Accademia delle scienze e fu soprattutto entomologo (era uno specialista e grande collezionista di lepidotteri); ritornò però alla botanica quando venne chiamato a insegnarla alla facoltà di farmacia. Fin qui lo scienziato, ma Behr, noto per il suo umorismo sferzante, fu anche scrittore, con all'attivo due romanzi in tedesco e scritti umoristici che spesso sfociano nel non sense. Lo ricordano gli eponimi di numerose piante e insetti e il monotipico genere Behria, endemico dell'estremità meridionale della Baja California. 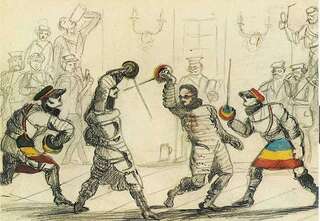 Una fruttuosa prima spedizione in Australia Quando morì, a quasi 86 anni, il San Francisco Chroniclelo lo definì "un'autorità di rilevanza mondiale" in molti campi della scienza, da annoverare tra "i giganti della mente". Eppure oggi il medico tedesco naturalizzato statunitense Hans Hermann Behr (1818-1904) è quasi dimenticato, non fosse per una località australiana (Behr Creek), una strada di San Francisco (Behr Avenue), una manciata di nomi di piante e un romanzo che ogni tanto viene ripescato e ristampato. Fu infatti molte cose durante la sua lunga vita: medico per professione e necessità, naturalista, raccoglitore e collezionista di insetti e piante per passione, insegnante e divulgatore, scrittore di romanzi e sketch comici che me lo fanno immaginare come un Mark Twain (o un O. Henry) della botanica. Come loro era un umorista, non di rado pungente e più spesso surreale. Behr nacque a Köthen, la capitale del principato di Anhalt, in una famiglia che da generazioni forniva all'amministrazione alti funzionari. Fin dagli anni del ginnasio rivelò uno spiccato talento per le lingue - nel suo necrologio Alice Eastwood, esagerando, scrisse che parlava tutte le lingue europee - e studiò, oltre al latino e al greco, persino l'ebraico. Amava già la natura ed era già un accanito collezionista; all'epoca collezionava uova di uccelli e si racconta abbia rubato un nido di cigni reali per procurarsi le loro uova. Nel 1837 si iscrisse all'università di Halle, poi alla facoltà di medicina a Würzburg dove si innamorò della botanica; era un attivo membro della confraternita studentesca Corps Moenania, per sostenere i colori della quale partecipò a 27 duelli. Si tratta dello sport alquanto cruento del Mensur, nel quale i contendenti si affrontavano con la spada per dimostrare il proprio coraggio, riportandone frequentemente ferite e cicatrici al volto, poi esibite con orgoglio. E' il caso anche di Behr che ne aveva più di una. Completò poi gli studi all'università di Berlino, dove nel marzo del 1843 ottenne la laurea in medicina. A Berlino forte era l'influenza sia di Humboldt sia del geografo Karl Ritter. Entrambi lo incoraggiarono a visitare paesi lontani per approfondire sul campo lo studio di botanica e entomologia. Behr scelse l'Australia sudorientale, che proprio in quegli anni stava attirando ondate di immigrati tedeschi. A partire dal 1838, gruppi di coloni tedeschi avevano cominciato a stabilirsi nell'area di Adelaide, in quella che all'epoca era la colonia dell'Australia del Sud. Tra di loro c'erano vignaioli del Reno reclutati per avviare la coltivazione industriale della vite, contadini poveri della Slesia e della Sassonia, ma i nuclei più consistenti provenivano dalla Prussia ed erano guidati da missionari luterani. Nel 1842 27 famiglie si stabilirono nella valle di Barossa e battezzarono il loro villaggio Bethanien in ricordo della città biblica, rinomata per la sua fertilità. Il 27 maggio 1844 Behr si imbarcò a Brema sulla George Washington e il 12 settembre sbarcò ad Adelaide. Da una lettera diretta alla Società entomologica di Stettino, risulta che a novembre si trovava a Bethanien ed aveva già iniziato ad esplorare attivamente la zona, la cui fauna e flora all'epoca erano quasi completamente ignote alla scienza europea. Dapprima esplorò la valle del Barossa, poi si spinse sempre più lontano, con escursioni che coprono un raggio di 100 km a nord e ad est di Adelaide, tra il Golfo di St. Vincent e il fiume Murray. A più riprese tra l'autunno del 1844 e l'inverno del 1845 visitò il Light River, nella primavera del 1845 esplorò le pinete nei pressi di Gawler, tra la primavera e l'inizio dell'estate la Barossa Range, a maggio i fiumi Murray e Onkaparinga, ad agosto i Murray Flats. Non sappiamo in quale data scalò il Monte Barker a sudest di Adelaide. Oltre a raccogliere grandi quantità di piante ed insetti (era particolarmente interessato a coleotteri e lepidotteri) non mancò di osservare i costumi degli aborigeni, dedicando particolare attenzione al linguaggio e ai corroboree, le cerimonie rituali, che in due scritti che avrebbe presentato alla Società geografica di Berlino non avrebbe esitato a paragonare alle cerimonie religiose cristiane. Dopo 13 mesi, ripartì per l'Europa, imbarcandosi il 9 ottobre 1845 ad Adelaide su una piccola nave, la Heerjeebhoy Rustomjee Patel, di cui era l'unico passeggero oltre alla moglie del comandante. Nello stretto di Lombok, essa fu attaccata dia pirati e dovette rifugiarsi a Bali. Poi il viaggio proseguì senza altri incidenti via Città del Capo per Amsterdam, dove Behr sbarcò il 19 maggio 1846. Da qui dovette raggiungere Köthen, dove sarebbe vissuto fino al 1848. Ora si trattava di pubblicare l'ingente materiale raccolto. Anche se egli stesso presentò le sue raccolte in articoli comparsi nel 1847 su Entomologische Zeitung e Linnaea, si affidò soprattutto alla collaborazione di alcuni amici ed esperti: per i lepidotteri Johann Christoph Friedrich Klug, per i coleotteri Ernst Friedrich Germar, per le piante Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Preceduta da un importante saggio introduttivo di Behr sulla flora dell'Australia meridionale, la descrizione delle circa 200 specie di piante da lui raccolte fu pubblicata da Schlechtendal nel numero 20 di Linnaea (1847). Egli ne considerò nuove per la scienza una settantina, e molte le nominò in onore dell'scopritore; tra di esse, per limitarci alle denominazioni tuttora accettate, Prostanthera behriana e Glischrocaryon behrii. 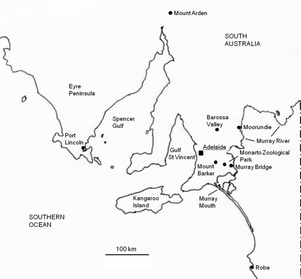 Ritorno in Australia A Köthen Behr non si occupava solo delle sue raccolte australiane e della propria carriera di medico; si interessava attivamente di politica. Come tanti giovani tedeschi in quegli anni agitati, aspirava a un mutamento politico in senso democratico e progressista, e si avvicinò a posizioni socialiste, causando sconcerto e preoccupazione nella sua conservatrice famiglia. Tanti anni dopo, in un romanzo autobiografico, egli l'avrebbe raccontato spiritosamente così: "Ero giovane, ero un socialista e fanatico dell' emancipazione in differenti direzioni [...]. Nel glorioso 1848 mi resi colpevole di ogni sorta di misfatti e mi consideravo una persona pericolosa perché ero impegnato a rompere le finestre del ministro della mia patria". Non ebbe certamente un ruolo di primo piano negli eventi rivoluzionari, del resto pacifici, che toccarono anche la periferica Köthen, ma era abbastanza coinvolto da spingere il padre, il cancelliere municipale Carl Ludwig, a finanziargli un secondo viaggio in Australia, prima che si compromettesse definitivamente. Tuttavia, anche se nei suoi anni americani gli piacque presentarsi come un esule politico, forse dietro la sua partenza c'erano anche altre ragioni. Con il favore del duca Friedrich Ferdinand, Köthen era diventato il maggior centro di diffusione dell'omeopatia: qui visse e lavorò a lungo il fondatore Samuel Hahnemann, qui nel 1845 Arthur Lutze aprì uno studio che attirava frotte di clienti (nel 1855 si sarebbe trasformato nel primo, celebre e redditizio, ospedale omeopatico). La concorrenza di Lutze, ai suoi occhi nient'altro che un ciarlatano, riduceva le già scarse prospettive di carriera di Behr e fu questo, presumibilmente, più che la situazione politica e le pressioni familiari, a deciderlo a lasciare per sempre l'Europa per cercare fortuna in Australia. Almeno stando al sarcastico proclama con il quale annunciò la sua decisione ad amici e colleghi: "Convinto che il dottor Lutze resterà qui e che gli altri medici dovranno lasciare il paese, ho l'onore di informare i miei amici e mecenati che lascio la mia patria [...] e con la presente chiedo ai miei colleghi di fare lo stesso". Quale che fosse la motivazione reale, il 15 giugno 1848 Behr si imbarcò come medico di bordo sul Victoria, diretto a Adelaide via Rio de Janeiro. Rallentato da una squadra navale danese nel Mare del Nord, il vascello arrivò in Australia solo a novembre. Pochi giorni dopo lo sbarco, Behr era di nuovo a Bethanien, dove forse aveva pensato di stabilirsi come medico. Invece come due anni prima il desiderio di avventura e l'amore per le scienze naturali presero il sopravvento: a novembre esplorò il Salt Creek, tra novembre e gennaio 1849 il Barossa Range e il versante orientale del Mount Lofty Range, nel marzo 1849 il fiume Murray. Più o meno nello stesso periodo erano arrivati in Australia diversi altri naturalisti tedeschi le cui strade dovettero incrociarsi con quella di Behr; citiamo i due più famosi: Ferdinand von Mueller (all'epoca ancora un oscuro farmacista senza von), futuro botanico coloniale del Victoria e direttore dell'orto botanico di Melbourne, e William Hillebrand, futuro esploratore della flora hawaiana. Le etichette degli erbari dimostrano che nel novembre 1848 Mueller e Behr dovettero erborizzare insieme nel Barossa Range e lungo il Salt Creek; più tardi Mueller gli dedicò Lasiopetalum behrii che Behr era stato il primo ad osservare. Quanto a Hillebrand, arrivato ad Adelaide nel marzo 1849, la sua amicizia con Behr dovette essere piuttosto stretta se i due, in una data che purtroppo non conosciamo (forse settembre 1849) lasciarono insieme l'Australia per trasferirsi a Manila, con l'intenzione di aprire ciascuno uno studio medico. Secondo una nota pubblicata su un giornale dell'epoca, prima di partire Behr avrebbe inviato le sue recenti raccolte a William Jackson Hooker, ma di questo invio si sono perdute le tracce. Tanto Behr quanto Hillebrand nel dicembre 1849 ottennero la licenza per esercitare la medicina nelle Filippine, ma vi rimasero pochi mesi, durante i quali nessuno dei due risulta aver fatto raccolte; alla fine di settembre 1850 Behr si trovava sicuramente a San Francisco, dove alla fine di novembre sarebbe stato raggiunto da Hillebrand. Ma mentre questi ripartiva quasi immediatamente per Honolulu, Behr fece di San Francisco la sua nuova casa: vi sarebbe rimasto per più di mezzo secolo, fino alla morte, allontanandosene solo per un breve viaggio in Europa nel 1853, allo scopo di recuperare e condurre con sé la fidanzata Agnes Omylska.  Mezzo secolo in California Nella California che si andava tumultuosamente popolando per la corsa all'oro (uno dei pochi prodotti della natura che mai lo interessò, stando alle sue dichiarazioni), Behr divenne presto uno figura riconosciuta dell'ambiente intellettuale e scientifico. Aveva uno studio medico, che cambiò spesso indirizzo, e come a Köthen si trovò ad affrontare la concorrenza dell'omeopata Lutze, qui si vide rubare i clienti da sedicenti medici che in realtà erano barbieri intraprendenti, infermieri o studenti che non erano riusciti a superare gli esami di medicina. Dato che non aveva peli sulla lingua e non esitava a mettere in ridicolo questi ciarlatani, Behr si fece così molti nemici; uno di loro, che scriveva gratuitamente per un giornale locale in lingua tedesca, inscenò un'accanita campagna di stampa contro di lui, accusandolo di essere un gesuita, anzi il peggiore dei gesuiti. Il motivo? Behr era cattolico e insolitamente religioso per un uomo di scienza. Anche se ridicola, l'accusa gli fece perdere molti clienti luterani. Behr non divenne mai ricco con il suo lavoro di medico, cui del resto continuava ad affiancare molteplici interessi scientifici e, come scopriremo, artistici. Era impegnato in mille altre attività, per lo più volontarie e non remunerative. Non molto dopo il suo arrivo, una banda di ex deportati australiani, noti come Sydney Ducks, si rese responsabile di furti, estorsioni e incendi; nel 1851 appiccarono il fuoco a un negozio del centro, causando un incendio che arse quasi 2000 edifici. I cittadini esasperati risposero varando un comitato di vigilanza che non esitava a farsi giustizia da sé, con metodi come processi sommari, espulsioni forzate e linciaggi. Tra questi spicciativi giustizieri fai da te troviamo anche Behr. Un ruolo non molto coerente con il rivoluzionario del '48, così come non lo fu la supplica che rivolse al duca nel 1853, in occasione del suo ultimo viaggio in patria: "Sarebbe molto gradito e vantaggioso per la mia pratica medica a San Francisco se potessi ricevere uno dei titoli ducali dell'Anhalt - magari come consigliere di corte - in riconoscimento dei miei trattati di botanica". Ottenne quanto chiedeva, tornando in California con il titolo sospirato e l'incarico - del tutto onorifico - di console dell'Anhalt in California. Quel titolo pomposo non cambiò in nulla la sua situazione reale e continuò ad essere il medico povero in canna di sempre, ma intanto incominciò a farsi conoscere negli ambienti scientifici. Nel 1854 fu ammesso all'Accademia delle scienze californiana, fondata l'anno prima, di cui divenne uno degli animatori: all'epoca, gran parte dei naturalisti che operavano in California erano degli amatori, e Behr, che invece aveva una solida formazione accademica e una vasta esperienza sul campo, diede un contributo importante in termini di rigore scientifico. Dal 1864 al 1904, anno della sua morte, ne fu il vicepresidente, stringendo un duraturo sodalizio con George Davidson, presidente dal 1871 al 1887; a partire dal 1862, occupò a più riprese il ruolo di curatore del dipartimento di entomologia. In effetti, in California il suo interesse preminente divennero le farfalle, di cui esplorò anche le potenzialità economiche. Nel 1855 nel primo volume dei Proceedings dell'Accademia comparve una sua memoria dedicata a Saturnia rubra (oggi Hyalophora euryalus), ospite di Ceanothus thyrsiflorus, a suo parere altamente promettente come sostituto del baco da seta. I suoi tentativi di lanciare un'industria sericola a partire da questa farfalla autoctona fallirono, ma fu l'inizio di una estesa raccolta di bachi, fatti venire anche dall'estero, che andò ad aggiungersi alla sempre più vasta collezione di lepidotteri, in parte raccolti da lui, in parte ottenuti con scambi internazionali con altri naturalisti. Intorno al 1882, gli esemplari erano ormai 20,000. Tra il 1863 e il 1870 Behr dedicò ai lepidotteri almeno una decina di articoli pubblicati su riviste scientifiche come Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia,Transactions of the American Entomological Society e Entomologische Zeitung. La botanica non era mai stata dimenticata, ma tornò al centro a partire dal 1872, quando Behr fu nominato professore di botanica della Facoltà di farmacia della California. Faceva lezione due volte la settimana e ogni quindici giorni guidava i suoi studenti in escursioni botaniche nei dintorni; per loro scrisse Synopsis of the genera of vascular plants in the vicinity of San Francisco, with an attempt to arrange them according to evolutionary principles (1884), in cui conciliò la fedeltà al sistema linneano con l'apertura all'evoluzionismo. L'attenzione alle piante native è palese in Flora of the Vicinity of San Francisco, una guida da campo rivolta a un ampio pubblico. Alla rapida trasformazione dell'ambiente naturale in seguito all'esplosiva urbanizzazione della città (tra il 1850 e il 1885 la popolazione decuplicò, passando da 25.000 a oltre 250,000 abitanti), di cui era stato attento e consapevole testimone, dedicò Botanical Reminiscences, pubblicati nel 1891 e nel 1896, un documento straordinario su ambienti e piante oggi scomparsi e sull'introduzione di piante esotiche. A quest'ultima contribuì - e non sempre in modo felice: in questo sì, pericoloso - lo stesso Behr che si era mantenuto in contatto epistolare con Mueller e per suo tramite introdusse in California diverse piante australiane, tra cui l'invasiva Avicennia marina subsp. australasica e vari eucalipti. Ma non è finita: oltre che antropologo, entomologo e botanico, il poliedrico personaggio fu anche un dotato scrittore. A indirizzarlo alla scrittura fu il viaggiatore e narratore tedesco Friedrich Gerstäcker che durante il suo viaggio attorno al mondo fece tappa nella California della febbre dell'oro; era diretto in Australia e a San Francisco incontrò Behr; i suoi coloriti racconti sull'emigrazione tedesca in Australia lo colpirono talmente che gli suggerì di ricavarne un romanzo. Nacque così Auf fremder Erde ("Nella terra straniera"), pubblicato nel 1864 in Germania dalla casa editrice di Gerstäcker con la prefazione di quest'ultimo; Behr lo firmò con la pseudonimo Ati Kambang ("carattere allegro", "indole gaia") e vi descrisse in tono spesso umoristico i comportamenti e le interazioni tra i vari gruppi etnici di immigrati e gli aborigeni. L'editore invece rifiutò il secondo romanzo di Behr, Dritte Söhne ("I terzi figli") che si svolgeva in California e fu poi pubblicato a puntate su una rivista americana in lingua tedesca. Con queste credenziali, nel 1873 Behr fu tra i primi aderenti al Bohemian Club. Fondato l'anno prima e diversissimo ai suoi esordi dal club attuale, ritrovo di miliardari e politici di primo piano, era un'associazione informale di giornalisti, artisti e scrittori che si incontravano periodicamente nel retro di un locale, il Jolly Corks. Qui, tra una bevuta e l'altra, i membri del Club presero l'abitudine di allestire spettacoli interni detti Jinks, che tipicamente sviluppavano un tema in forma di poesie, canzoni, scene teatrali. Behr vi trovò il palcoscenico ideale per il suo spirito ironico; le scenette, i monologhi e i non sense da lui creati per i jinks furono pubblicati poco dopo la sua morte da un gruppo di amici sotto il titolo The Hoot of the Owl ("Il grido della civetta") La civetta era il simbolo del club e Behr ne teneva una come animale da compagnia. Il suo carattere è stato descritto in vari modi, abbastanza contraddittori; aveva fama di eccentrico, di persona cordiale con gli amici ma sferzantemente ironica con chi incorreva nella sua disapprovazione. Rimase celebre uno scontro con il micologo Harvey Willson Harkness che nel 1887 era stato elettopresidente dell'Accademia delle scienze, battendo Davidson. Durante un'accesa discussione del comitato direttivo, non riuscendo a smontare la serrata argomentazione di Behr , Harkness sbottò "Vada al diavolo!", al che Behr rispose in tono cortese: "Dopo di lei, mio caro signore". Oltre a scrivere per riviste scientifiche sia statunitensi sia tedesche, Behr era in relazione epistolare con molti studiosi in entrambi i continenti. Nel 1898 la sua alma mater, l'università di Berlino, volle festeggiarlo conferendogli la laurea honoris causa con una solenne cerimonia. Behr morì a quasi 86 anni, nel 1904, lasciando all'Accademia delle scienze californiana libri, manoscritti e l'inestimabile collezione di insetti. Purtroppo tutto andò in fumo nell'incendio che distrusse la sede dell'accademia in conseguenza del devastante terremoto del 1906.  Riservato ai colibrì! Abbiamo già visto che Behr è ricordato dall'eponimo di diverse specie della flora australiana (e ovviamente di numerosi lepidotteri, tanto australiani come Etiella behrii quanto americani come Parnassius behrii ). E' invece endemica della Baja California Behria tenuiflora, unica specie del genere Behria, dedica dell'amico e collega Edward Lee Greene, curatore dell'erbario dell'Accademia delle scienze californiane fino al 1885, quindi primo professore di botanica all'università di Berkley. Con lui (come con Alice Eastwood che ne scrisse un commosso necrologio) doveva avere rapporti cordiali, se nella dedica Greene scisse: "Il genere è dedicato al nostro eccellente amico, il dr. H. Hermann Behr, professore di botanica della Facoltà di Farmacia dell'Università di California". Come ho accennato in questo post, la status del genere Behria, appartenente alla sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae, è discusso. Secondo alcuni studiosi va incluso nell'affine Bessera, ma i botanici dell'Università della Baja California, che studiano questo gruppo di piante da anni, ne sostengono l'indipendenza sulla base della distribuzione, della morfologia e dei dati molecolari. Infatti, mentre le quattro specie di Bessera si distribuiscono nel versante pacifico del Messico lungo la faglia vulcanica trans messicana, Behria è esclusiva dell'estremità meridionale della Baja California, dove è relativamente comune, crescendo dal livello del mare alla cima della catena montuosa, a circa 2200 metri d'altezza. Come le altre specie di questa sottofamiglia, è dotata di cormi, da cui emergono una o più foglie lineari e uno scapo che termina in un'infiorescenza a ombrella; tuttavia i fiori sono alquanto diversi: quelli di Bessera sono campanulati, con il tubo del perianzio che racchiude parzialmente l'ovario, quelli di Behria sono tubulari e il perianzio racchiude totalmente l'ovario. Come quelli di Bessera, anche i fiori di Behria sono vivacemente colorati, con tubo arancio vivo striato di giallo, e sono impollinati dal colibrì di Xantus Basilinna xantusii. In natura, fiorisce da settembre a febbraio, quando la temperatura si è fatta più fresca e può godere di un minimo di umidità. Piuttosto capricciosa e imprevedibile (può andare in dormienza anche per anni se non trova le condizioni giuste), è raramente coltivata nonostante la sua bellezza. Thad M. Howard in Bulbs for Warm Climates sostiene che in coltivazione tende a morire dopo un anno o due e conclude: "Forse è meglio lasciare questa specie al godimento dei colibrì della Baja California". A differenza della vicina Virginia, la cui flora aveva destato l'interesse di botanici e appassionati fin dall'inizio del Seicento, perché iniziassero le ricerche naturalistiche in Maryland si dovette attendere la fine del secolo e la trasformazione in colonia reale. Evento decisivo fu la nomina a governatore di Francis Nicholson, patrono delle arti e delle scienze e deciso sostenitore della chiesa anglicana. Il vescovo Compton ne approfittò per inviare nella colonia il giovane pastore gallese Hugh Jones, nella speranza che, come Banister in Virginia, riuscisse a unire con successo l'attività pastorale alle raccolte botaniche. Ma, al contrario di Banister, Jones non sapeva nulla di piante e, nonostante la buona volontà e l'insegnamento a distanza di Petiver, ebbe molta difficoltà a conciliare i due compiti. A supportarlo nel 1698 giunsero da Londra ben due naturalisti: William Vernon, designato dalla Royal Society, e David Krieg, amico e agente di Petiver. Anche se il loro soggiorno nella colonia fu breve, segnò il vero inizio dell'esplorazione della flora del Maryland, con la raccolta di diverse centinaia di specie, in parte pubblicate da Ray nel terzo volume di Historia Plantarum. Sia Krieg sia Vernon sono celebrati da generi validi della famiglia Asteraceae: Krieg dal piccolo Krigia e Vernon dal grande Vernonia e, indirettamente, da Vernoniopsis e Vernonanthura.  Un pastore e apprendista botanico La tragica morte di John Banister fu un duro colpo per il vescovo Compton e per i botanofili londinesi che si riunivano nel Temple Coffee House Botanical Club; con essa si interrompeva il flusso di nuove piante americane garantito dalle raccolte del solerte pastore. Due anni dopo, nel 1694, la nomina a governatore del Maryland di Francis Nicholson, che durante il suo mandato in Virginia aveva favorito l'attività di Banister e più in generale l'esplorazione delle risorse naturali, riaccendeva le speranze. Si cercò un ecclesiastico che, come il defunto, potesse unire all'attività pastorale le raccolte naturalistiche. Su segnalazione di Edward Lhwyd, curatore dell'Ashmolean Museum di Oxford, un candidato non ideale ma passabile fu individuato nel gallese Hugh Jones (ca. 1671-1701), assistente di Lhwyd nella raccolta di fossili. Di piante non sapeva nulla e aveva seguito i corsi di teologia per non più di un anno, eppure il vescovo Compton, ritenendo imminente la partenza della flotta del tabacco diretta in Virginia, si affrettò ad ordinarlo pastore. Invece, a causa della guerra con la Francia, la partenza fu rinviata di mesi, permettendo al neo-reverendo di frequentare il Club e ricevere almeno un'infarinatura di zoologia e di botanica. Doody, Petiver e James Ayrey (un mercante e collezionista il cui negozio era vicino a quello di Petiver) lo accompagnarono a cercare fossili nella cava di calce di Charlton presso Greenwich e ad erborizzare nel Kent. Doody gli procurò un termometro e forse un densimetro, Petiver gli impartì istruzioni su come raccogliere e conservare ogni sorta di "collezione filosofica" e gli diede una copia della sue centurie e forse altri libri, nonché materiali come la carta necessaria per essiccare gli esemplari e bottiglie per conservare gli animali sotto spirito. Jones giunse in Maryland solo nel giugno 1696. La situazione, da ogni punto di vista, era più complessa rispetto alla Virginia. Il Maryland, la cui economia si basava principalmente sulla coltivazione del tabacco, era molto meno florido della colonia gemella; la popolazione era costituita principalmente da servi bianchi a contratto, in gran parte maschi, frequentemente falcidiati da malattie ed epidemie; l'importazione di schiavi neri era appena agli inizi ma in crescita. Le piantagioni erano per lo più piccoli appezzamenti circondati da foreste e gli spostamenti rimanevano difficili. Fino al 1689 la colonia era stata amministrato da un governatore-proprietario cattolico della famiglia Calvert, che aveva favorito una certa tolleranza religiosa; oltre a cattolici, c'erano quaccheri, non conformisti, e anche anglicani, ma senza una chiesa organizzata. Questa fu stabilita solo nel 1691, quando il Maryland divenne un colonia reale; così, quando Jones arrivò ad Annapolis, la capitale, per presentarsi al governatore Nicholson, scoprì che i suoi doveri ecclesiastici sarebbero stati tutt'altro che una sinecura. Gli fu affidata la grande Christ Church Parish, ancora scarsamente abitata ma geograficamente vasta, con due sedi che lo costringevano a faticosi spostamenti. I doveri ecclesiastici assorbirono gran parte del suo tempo, lasciandone ben poco alle "collezioni filosofiche", già di per sé problematiche per un novellino immerso in un ambiente pressoché sconosciuto e in gran parte selvaggio. I suoi sponsor londinesi furono delusi: decisamente, Jones non era un nuovo Banister: nell'autunno e nell'inverno del suo primo anno in Maryland inviò pochi esemplari, imperfettamente conservati, per lo più già noti e non accompagnati dalle dettagliate note naturalistiche e dai disegni a cui li aveva abitati il compianto pastore-naturalista. Petiver cercò di ovviare con una specie di corso per corrispondenza, inviando a Jones liste di esemplari, doppioni della sua collezione, istruzioni pratiche e libri di botanica tra cui, oltre ai suoi Musei petiveriani, Historia plantarum di Ray e Paradisus batavus di Hermann. Oltre a doni come formaggi e generi di prima necessità, nei suoi pacchi c'erano anche medicinali, visto che un pastore in quella colonia ancora in via di formazione doveva occuparsi della cura non solo delle anime, ma anche dei corpi. Due nuovi invii di Jones raggiunsero l'Inghilterra alla fine del 1697 e nel 1698, per lo più in cattive condizioni a causa del lungo viaggio; finalmente nell'autunno del 1698 Petiver ricevette una collezione ben preparata e ben conservata, anche se lamentò che si trattasse essenzialmente di fiori, senza frutti e semi, "dai quali si ricavano le caratteristiche più essenziali o la denominazione". Preoccupato di perdere la priorità rispetto al rivale Plukenet, che in Almagestum botanicum (1696) aveva già pubblicato diverse specie virginiane raccolte da Banister, sollecitò Jones a intensificare le raccolte; gli chiese anche di inviargli il maggior numero possibile di esemplari della medesima pianta, in modo che egli potesse restituirgli i doppioni con le sue osservazioni. Qualche invio giunse ancora, ma a quel punto alle difficoltà che già conosciamo si era aggiunto il declino fisico: il giovane ecclesiastico gallese si ammalò di tisi e ne morì all'inizio del 1701. 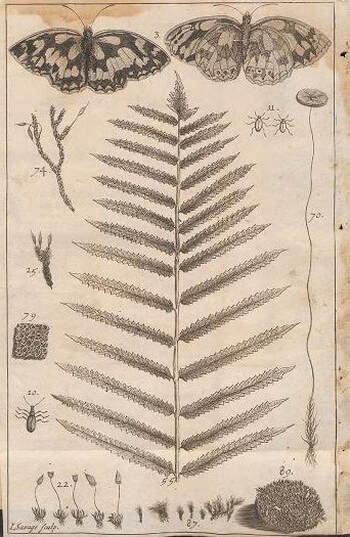 Due raccoglitori sono meglio di uno Già prima di questo infausto esito, Petiver e i suoi amici-rivali del Botanical Club e della Royal Society avevano deciso di affiancare al troppo indaffarato e troppo inesperto Jones un naturalista più preparato, ma soprattutto impegnato a tempo pieno. Nella seduta del 10 novembre 1697 della Royal Society, William Byrd II (figlio di William Byrd I, il piantatore virginiano che era stato amico, ospite ed esecutore testamentario di Banister) riferì che il governatore Nicholson intendeva offrire 25 sterline annue a un naturalista per "fare osservazioni e descrizioni di tutti i prodotti naturali di queste parti, e scriverne la storia" e chiedeva alla Royal Society di individuare la persona adatta. La scelta cadde su William Vernon (ca. 1667-ca. 1715), membro del St Peter's College di Cambridge, noto soprattutto come raccoglitore e studioso di muschi e già lodato da Ray per la profonda conoscenza della flora britannica. Ottenuti due o tre anni di congedo dall'Università, Vernon accettò l'incarico e si preparò a partire al più presto per l'America, dove contava di rimanere almeno due anni. La sua missione era sponsorizzata dalla Royal Society, quindi indirettamente dal Temple Coffee House Botanical Club; ma come sappiamo i suoi membri (in particolare Hans Sloane e James Petiver) erano divisi da una forte rivalità. Fu così che Petiver decise di giocare una seconda carta, inviando in Maryland un altro naturalista a lui legato: il medico tedesco David Krieg (1667-1713). Nato in Sassonia, quest'ultimo, dopo aver studiato all'Università di Lipsia, si era trasferito a Riga, diventando uno dei corrispondenti di Petiver, che lo aveva ospitato a casa sua quando nel 1696 egli si era spostato a Londra; inoltre lo aveva introdotto al Botanical Club e gli aveva fornito lettere di presentazione per Jacob Bobart, il prefetto dell'orto di Oxford, e per John Ray, che viveva nel suo rifugio di Black Nottley. Sicuramente nel novembre 1697, poco prima della partenza di entrambi per il Maryland, incontrò anche Vernon, ma i due viaggiarono separatamente e anche più tardi non raccolsero insieme, divisi da una presumibile rivalità; l'inglese arrivò in colonia nel marzo 1698, il tedesco (accompagnato dal "cacciatore di farfalle" di Petiver, un ragazzo chiamato Isaac) vi giunse due settimane dopo. Si era pagato il viaggio servendo come chirurgo di bordo, mentre il giovane Isaac forse viaggiò come ragazzo di cabina. Krieg dovette mettersi immediatamente all'opera, mentre Vernon, che dipendeva dal governatore e era tenuto a concordare le sue mosse con lui, dovette iniziare le raccolte solo a maggio. Non conosciamo nei particolari gli itinerari di nessuno dei due. Certamente visitarono Annapolis e i suoi dintorni ed esplorarono la costa orientale della baia di Chesapeake. L'unica lettera superstite di Krieg, scritta a maggio, ne attesta la presenza nel basso corso del Choptank River, mentre da una lettera inviata a luglio da Vernon a Sloane sappiamo che egli al momento si trovava ad Annapolis ed aveva già deciso di tornare in Inghilterra alla fine dell'estate. Non conosciamo le ragioni di questo rientro anticipato: alcuni hanno parlato di dissapori con il governatore Nicholson, altri al contrario ritengono che Vernon abbia preferito rinunciare piuttosto che rimanere in quella difficile colonia dopo la partenza del suo protettore; Nicholson infatti si accingeva a lasciare il Maryland per assumere nuovamente il governo della Virginia. Dunque, dopo circa cinque mesi di raccolte, lasciata l'America forse a settembre o a ottobre, tra novembre e dicembre sia Vernon sia Krieg erano nuovamente a Londra. Vernon presentò alcuni esemplari in una delle sedute del venerdì del Temple Coffee House Botany Club e gli sponsor si spartirono il bottino: Petiver fece la parte del leone, ricevendo da Krieg piante, insetti e conchiglie e molti esemplari anche da Vernon; altri li ottenne Sloane, altri ancora il vescovo Compton (che però lamentò che ci fossero pochi semi) e l'arcivescovo di Canterbury Tenison. Attraverso Sloane e Petiver, diverse centinaia di nuove specie furono inviate per l'identificazione a Ray, che incontrò molte difficoltà sia per l'incompletezza degli esemplari sia per la mancanza di note di accompagnamento; in ogni caso, nel terzo volume di Historia plantarum (uscito nel 1704) poté elencare 450 specie originarie del Maryland e determinarne 225. Tra il 1698 e il 1702 diverse specie furono inoltre pubblicate sulle Transactions della Royal Society da Petiver. Né Ray né Petiver (né Plukenet, che a sua volta pubblicò alcune specie del Maryland in Almatheum Botanicum, uscito nel 1705) indicano il nome dei raccoglitori, quindi non sappiamo che cosa fu raccolto rispettivamente da Jones, Vernon e Krieg. Nonostante il cambiamento di programma e le difficoltà incontrate da Ray, le raccolte dei due "inviati speciali" dovettero soddisfare a sufficienza le aspettative della Royal Society: nella seduta dell'11 gennaio 1699 fu deliberata sia l'ammissione di Krieg sia lo stanziamento di 20 sterline per inviare Vernon a caccia di piante nelle Canarie. Quasi immediatamente, egli si recò a Deale per imbarcarsi, ma mancò la partenza della flotta. Quando scoprì che non erano previste altre partenze prima di novembre, decise di rimanere a fare raccolte nel Kent e nei dintorni di Canterbury fino all'autunno. Ma ormai aveva perso la voglia di viaggiare. La missione alle Canarie sfumò, Vernon continuò per qualche anno a raccogliere in Inghilterra, specializzandosi in briofite e nel 1702 ritornò a Cambridge. Poco alla volta anche i suoi contatti con l'ambiente dei botanici e dei botanofili vennero meno, tanto che non sappiamo praticamente nulla dei suoi ultimi anni, neppure dove e quando morì. Il destino di Krieg dopo l'avventura americana fu amaro. Rimase a Londra ancora qualche mese, occupato a riordinare le sue raccolte e forse a fare disegni per Petiver; a maggio si imbarcò per Riga, dove era di ritorno il 14 giugno 1699. Per due anni esercitò la medicina nella città baltica, che offriva ben poche opportunità a un naturalista, come lamenta nelle lettere all'amico Petiver. Nel 1701 fu assunto come medico personale da Louis de Guiscard-Magny, ambasciatore della Francia in Svezia; lo raggiunse a Stoccolma e lo accompagnò a Parigi, dove ebbe modo di frequentare il Jardin des Plantes e conoscere Plumier e Vaillant. Quando scoprì che l'ambasciatore lo voleva al suo fianco come medico militare nella campagna prevista per l'anno successivo, decise di tornare a Riga. Lo faceva con riluttanza; avrebbe preferito un clima più caldo, magari un viaggio nelle Antille al servizio dell'amico Petiver. Lasciata Parigi nella primavera del 1702, dopo una breve visita a Strasburgo, dove viveva un fratello chirurgo, e alla famiglia a Schwarzeburg, nel gennaio 1703 era di ritorno a Riga. Anche se erano anni difficili per la città baltica a causa della Grande guerra del Nord tra Russia e Svezia, continuò a fare raccolte naturalistiche, nella speranza di scrivere una storia naturale della Livonia; si mantenne in contatto con gli amici inglesi, inviando loro curiosità, insetti e minerali, e ricevendo in cambio libri e strumenti. Il suo sogno era lasciare quella città provinciale dove nessuno condivideva i suoi interessi e tornare in America, o per lo meno a Londra. Ma rimase appunto un sogno. Nel 1710 Riga fu posta sotto assedio dai Russi; in città scoppiò una pestilenza che, insieme alla fame, fece 22.000 vittime. Una di loro era Krieg.  Asteraceae grandi e piccole Nessun botanico ha pensato di rendere omaggio a Jones, mentre sia Krieg sia Vernon sono onorati da almeno un genere di Asteraceae. Krigia e Vernonia, ben diversi per grandezza e distribuzione, si devono al botanico tedesco Johann Christian Daniel von Schreber, che li pubblicò nel 1791 nella sua riedizione del linneano Genera Plantarum, purtroppo senza alcuna dedica esplicita. Krigia è un piccolo genere di 7 specie, distribuite tra il Canada sud-orientale, gli Stati Uniti centrali e orientali e il Messico nord-orientale. Sono erbacee perenni o annuali, con una radice fibrosa o a fittone da cui emergono gambi eretti e solitamente non ramificate, con foglie lanceolate, dentate o lobate a rosetta e capolini per lo più solitari, gialli o arancione, molto simile a quelli dei generi Hieracium e Pilosella. Vernonia è invece un grande genere cosmopolita cui sono attribuite quasi 350 specie, ma inteso in senso lato è giunto a comprenderne anche 1000; va inoltre considerato che le specie in aree in contatto tendono ad ibridarsi con facilità. Gli studi hanno identificato due centri di biodiversità: uno in America, l'altro in Africa e nell'Asia sud-orientale. Possono essere erbacee annuali o perenni, spesso di grandi dimensioni, arbusti da piccoli a grandi, rampicanti o piccoli alberi, con foglie alternate semplici, da lanceolate a strettamente lineari. I capolini, raccolti in cime o corimbi terminali o ascellari, sono composti da un involucro a coppa o cilindrico formato da 5-6 serie di brattee embricate che proteggono il ricettacolo sul quale si inseriscono i flosculi tubolosi, usualmente bisessuali e fertili. La corolla tubolare e lobata può essere viola, blu o anche bianco-crema. I frutti sono acheni dotati di pappo. Diverse specie nordamericane sono coltivate nei giardini. Tra di esse V. arkansana (spesso commercializzata come V. crinita), originaria degli Stati Uniti centrali, un'alta perenne che tra agosto e settembre produce grandi capolini viola dall'aspetto un po' scompigliato; la rusticissima V. fasciculata, nativa di una fascia che va dal Manitoba in Canada agli Stati Uniti centro-settentrionali, che produce alti steli non ramificati che culminano in un denso corimbo di fiori magenta; V. lettermannii, originaria dell'Arkansas e dell'Oklahoma, con foglie filiformi e centinaia di piccoli fiori viola scuro; simile è V. noveboracensis, che tende ad espandersi con stoloni sotterranei, con fiori viola, ma anche lilla e bianchi. Diverse specie africane, come V. colorata, sono utilizzate come verdura da foglia; dato che crescono rapidamente e si rigenerano dopo i tagli, producendo una grande massa di foraggio che resiste molto bene alla siccità, sono note, oltre che con diversi nomi locali, con il nome inglese ironweed, erba di ferro, dovuto ai fusti rigidi e talvolta color ruggine, ma anche alla veloce crescita e alla robustezza. La specie più importante di questo gruppo, la più consumata nonché ingrediente dello Ndolé, il piatto nazionale del Cameroon, V. amygdalina, è stata trasferita al genere Gymnanthemum come G. amygdalinum; è anche una importante pianta medicinale. Secondo Plants of the World on line (ma l'accordo non è universale) va ricondotta a questa specie come sinonimo anche Vernonia condensata, poi Vernonanthura condensata, in precedenza ritenuta un endemismo brasiliano, mentre si tratta appunto di una specie africana, introdotta all'epoca della tratta degli schiavi. Dai semi di V. galamensis viene invece ricavato un olio con un alto contenuto di acido vernolico, utilizzato nell'industria delle vernici e come plastificante. Oltre ad essere il patrono dell'importantissimo genere Vernonia, William Vernon è celebrato indirettamente anche da due dei tanti generi che ne sono stati separati, Vernoniopsis e Vernonanthura. Il primo ("simile a Vernonia") è un genere endemico del Madagascar, con una o due specie di arbusti o piccoli alberi con corimbi terminali di numerosi capolini con lungo ricettacolo e corolla biancastra. Il secondo (da Vernonia + anthura, da anthera e oura "coda", in riferimento alle antere con base frequentemente caudata) è un grande genere separato nel 1995 da Vernonia, da cui differisce per la distribuzione più meridionale (dal Messico all'Argentina, passando per le Antille), le infiorescenze piramidali o tirsoidi anziché corimbose, l'habitus tipicamente arbustivo con steli legnosi fin dalla base anziché erbacei, e appunto le antere con code prominenti alla base. Il genere comprende una sessantina di specie; la più nota era probabilmente Vernonanthura condensata che, come abbiamo visto è stata trasferita a Gymnanthemum ed è per lo più ritenuta sinonimo di G. amygdalinum. Anche in questo genere troviamo piante interessanti per i nostri giardini, come V. nudiflora (in precedenza Vernonia angustifolia), un arbusto originario del Brasile e dell'Argentina, con foglie lineari e bei fiori viola. V. polyanthes ci ricorda invece quanto è pericoloso introdurre specie aliene in ambienti fragili: nativa del Brasile, all'inizio degli anni '90 del Novecento è stata introdotta in Mozambico come pianta nettarifera per le api; da qui si è diffusa nel vicino Zimbabwe e in diversi ambienti è rapidamente diventata una specie dominante ai danni della vegetazione nativa. Nella primavera del 1788, il botanico francese André Michaux e suo figlio François André visitano la Florida occidentale dove sono accolti con squisita cortesia dal governatore Vicente Manuel de Céspedes. Memore di quell'accoglienza, qualche anno dopo Michaux gli dedica uno dei suoi nuovi generi americani, ma un errore di lettura o una svista del tipografo trasformano il buon governatore in Lespedez e il genere in Lespedeza. 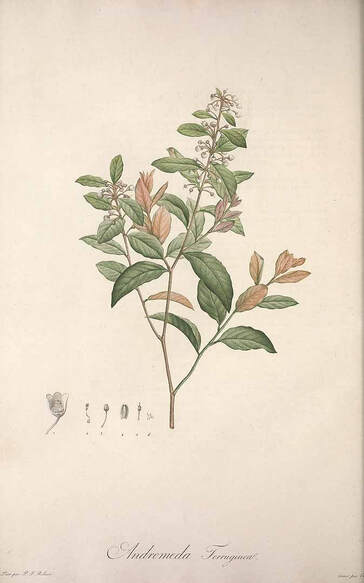 Un memorabile viaggio in Florida Inviato negli Stati Uniti come botanico reale alla ricerca di piante utili per ripopolare le foreste francesi, André Michaux era invece intenzionato ad andare oltre questo mandato: voleva scrivere una flora del Nord America, e per questo desiderava visitare tutte le zone accessibili, incluse la Florida spagnola e le Bahamas, nonostante la loro flora tropicale o subtropicale poco si adattasse all'introduzione in terra francese. Già nel 1787 aveva comunicato al Conte d'Angevilliers, direttore generale dei Bâtiments du Roi (da cui dipendeva la sua missione) la sua intenzione di visitare la Georgia e la Florida. Tensioni di frontiera bloccarono per qualche mese il progetto, finché alla fine del febbraio 1788, accompagnato dal figlio François André e da un servitore, egli salpò da Charleston alla volta di St. Augustine, la capitale della Florida occidentale. Agli ufficiali di porto dichiarò di essere stato autorizzato a studiare la storia naturale della provincia dal governatore, Vicente Manuel de Céspedes (o Zéspedes), al quale evidentemente aveva scritto, anche se il carteggio non ci è pervenuto. Condotto alla presenza del governatore, fu ricevuto con grande calore e cortesia. Solo qualche giorno dopo scrisse nuovamente a d'Angevilliers per ottenere il permesso ufficiale di fare raccolte botaniche in Florida. Di fatto, si era già messo al lavoro. Oltre a esplorare i dintorni della città, dove scoprì una nuova specie di Ericacea, Lyonia ferruginea, si era procurato un terreno dove creare un vivaio temporaneo e aveva affittato una canoa e due rematori. Il 12 marzo partì alla volta dell'Anastasia Island, dove fu ospite del mercante Jesse Fish che nella sua residenza, chiamata El Verge, aveva creato un giardino ricco di olivi, palme da dattero, limoni e aranci; Michaux nelle sue memorie lo definisce un paradiso. Era la prima tappa di un viaggio, parte in canoa, parte a piedi, parte a cavallo, che li portò in direzione sud, sempre erborizzando, ad esplorare la costa orientale della Florida lungo il Northwest River e l'Indian River fino all'altezza dell'attuale Bonaventure, dove giunsero all'inizio di aprile; oltre non era possibile andare, essendo ormai penetrati in territorio indiano. Durante il viaggio di ritorno affittarono dei cavalli per riportare le raccolte a St. Augustine e osservarono un incendio: sia gli indiani sia gli europei usavano applicare incendi per facilitare la caccia o per liberare terreni per il bestiame, una pratica altamente disapprovata da Michaux. Rientrato a St. Augustine il 17 aprile, Michaux fece subito visita al governatore, che nei giorni successivi volle visitare di persona le collezioni e invitò il botanico a pranzo. Quest'ultimo era impegnato a riordinare le raccolte (stando al suo diario, fino a quel momento ammontavano a 105 specie), a scrivere lettere in Francia e ai rappresentanti diplomatici francesi, anche per battere cassa, e a preparare la prossima escursione. Il 29 aprile era infatti di nuovo in partenza con gli stessi compagni, questa volta a cavallo, alla volta della residenza di Job Wiggins, che aveva accompagnato William Barton nella spedizione del 1774. Situata sulla riva orientale del St. Johns River, era un buon punto di partenza per esplorare il bacino del fiume, il maggiore della colonia; nei dintorni, Michaux trovò una nuova specie di graminacea, Stenopholis obtusata. Da quel momento il viaggio proseguì in canoa, toccando Mount Royal, una collina sabbiosa visitata e così denominata da John Bartram nel 1765, e Drayton Island sul lago George; quindi continuò lungo il St Johns River e nella strettoia oggi chiamata Salt Springs Run fino alla sorgente dove Michaux raccolse Illicium parviflorum, già osservato nei lori viaggi dai due Bartram ma ancora non descritto. Quindi il gruppo esplorò Silver Gleb Spring e proseguì fino alla confluenza tra il lago George e il St. Johns River, quindi lungo il fiume dove dopo qualche giorno si imbatté in correnti contrarie e grandi masse di alligatori; giunto all'altezza dell'attuale High Bank, avendo trovato poche specie nuove, Michaux decise di rientrare a St. Augustine. Il viaggio volgeva al termine. Dopo un'ulteriore visita al governatore e ad alcune famiglie influenti, i Michaux si imbarcarono con loro raccolte alla volta di Charleston; qui le talee prese in Florida furono trapiantate nel vivaio, mentre i semi di molte piante venivano spediti in Francia; tra le altre, Guilandina bonduc, Sophora tomentosa, Chiococca alba, Ceanothus microphyllus, Conocarpus erectus, Psychoria nervosa, Amyris eleifera, Zamia integrifolia, Tillandsia utriculata, Modiola caroliniana.  Ripopolare la Florida E' ora di sapere qualcosa di più dell'ospitale governatore Vicente Manuel de Céspedes (1721?-1794); appartenente a una famiglia di militari e militare egli stesso, prima di arrivare in Florida per circa un anno era stato governatore facente funzione a Santiago de Cuba; nel 1783 fu nominato primo governatore della Florida orientale che, dopo vent'anni di occupazione britannica, tornava sotto sovranità spagnola in forza del trattato di Parigi. Céspedes si trovò così a gestire una difficile transizione. Il problema principale era quello del popolamento. La popolazione era molto mista: c'erano spagnoli provenienti dalla madre patria, cubani, minorchini (Minorca nel Settecento era passata più volte dalla sovranità spagnola a quella britannica e viceversa, e molti erano di lingua inglese), francesi, italiani, greci, britannici che durante l'occupazione inglese erano subentrati agli spagnoli che avevano preferito lasciare la colonia. Il timore era che con il tempo gli anglofoni potessero prendere il sopravvento o che gli Stati Uniti decidessero di invadere il paese; venne così fissato l'obiettivo di aumentare la popolazione, fino a eguagliare nell'arco di 25 anni quella della Georgia. La corona fissò regole molto stringenti per i nuovi immigrati, la principale delle quali era che dovevano essere di religione cattolica; anche gli stranieri erano ben accetti, purché fossero appunto cattolici e imparassero la lingua spagnola. Céspedes, da parte sua, cercò di favorire i nuovi arrivi, garantendo dieci anni di esenzione dalle tasse, terre, aiuti come bestiame, sementi, attrezzi. Buona parte del territorio era disabitato, e le terre non mancavano, ma la questione del ripopolamento si incrociava con quella delle proprietà. Alcune, i cui proprietari ispanici avevano preferito lasciare la Florida, erano rimaste vacanti al momento dell'occupazione inglese, altre erano state abbandonate dagli inglesi al ritorno degli spagnoli. Céspedes propose che tutte le proprietà vacanti e non rivendicate entro una certa data fossero confiscate dalla corona, per essere ridistribuite ai nuovi immigrati, in particolare i cosiddetti floridanos, ovvero quelle persone che si erano stabilite a Cuba dopo l'occupazione inglese della Florida, di cui voleva incoraggiare il ritorno nella penisola. Un'ultima questione riguardava gli schiavi neri. Poiché nella Florida spagnola non c'erano né piantagioni né miniere, erano pochi; inoltre, nel 1693, il re Carlo II aveva emanato un decreto che concedeva la libertà agli schiavi fuggiti dall'America britannica, purché accettassero la religione cattolica. Così si era formato un notevole insediamento di neri liberi a nord di S. Augustine; godevano della libertà personale, non erano discriminati e formarono persino un reggimento di milizia. Altri schiavi fuggiti si erano rifugiati presso gli indigeni Creek e Seminole. Durante il ventennio di occupazione, i coloni britannici avevano introdotto l'economia di piantagione (si coltivavano cotone, indaco, canna da zucchero) e con essa schiavi neri portati dall'Africa. Al ritorno degli Spagnoli, essi chiesero di essere liberati in osservanza alla legge di Carlo II, mentre i loro proprietari, che ora si era stabiliti in Georgia o nelle Caroline, ne chiedevano la restituzione; Céspedes, anche se temeva che molte conversioni fossero di comodo, li trattenne in Florida. Buona parte del territorio era inesplorato; gli abitati si concentravano lungo la costa, con centro principale a St. Augustine (Jacsksonville e Miami non esistevano ancora) e non si spingevano oltre il Río de Mosquitos, forse a sud dell'attuale Cape Canaveral. Gli inglesi avevano poi creato una serie di piantagioni lungo il St Johns River, il più lungo e importante della regione anche per i commerci, anche se, per le sue acque basse e paludose, era navigabile solo in canoa. Si capisce dunque perché il governatore si sia mostrato così amichevole verso Michaux e abbia incoraggiato la sua esplorazione. Nel 1784, ordinò un censimento, seguito nel 1786 da un secondo più dettagliato. La conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche geografiche e umane, delle sue risorse, erano per lui un dovere d'ufficio, come dimostra il suo unico scritto noto, Descripción de la Florida Oriental: su clima, terreno, productos, ríos, barras, bahías, puertos, números y calidades de la gente que la habitan, un manoscritto inedito oggi conservato nell'Audiencia de Santo Domingo dell'Archivio General de Indias, da lui inteso come una vera e propria guida per indirizzare la politica immigratoria. Il documento inizia con una una descrizione geografica della Florida orientale, soffermandosi sull'estensione, il clima, le forme del territorio; si trattano poi i fiumi principali, i laghi, le lagune costiere, sempre indicando gli eventuali popolamenti e la loro consistenza, i pochi nuclei urbani. Dopo aver trattato in modo abbastanza generico le risorse naturali (che sono comunque abbondanti e promettenti), Céspedes conclude con la parte più politica: le sue indicazioni per incrementare il commercio (che a suo parere deve avvenire soprattutto da e verso Cuba) e per favorire l'immigrazione, terminando con le Reglas y condiciones para pobladores tanto extranjeros como naturales di cui abbiamo già parlato. L'incarico di Céspedes terminò nel 1790; dovette quindi ritornare a Cuba, dove sappiamo che morì nel 1794 e fu sepolto nella cattedrale dell'Avana.  Un errore... di sbaglio Michaux non dimenticò mai la cortesia con la quale era stato accolto dal governatore Céspedes, che la sua lotta con l'avara e poco sollecita amministrazione francese prima e dopo la rivoluzione gli facevano apprezzare anche più. Così nella sua Flora boreali-americana non poteva mancare di rendergli omaggio, dedicandogli uno dei suoi nuovi generi. Il libro fu pubblicato postumo nel 1803 a cura del figlio François André e questo forse spiega il fattaccio: tanto il nome del genere quanto quello del dedicatario sono infatti sbagliati. Il genere si chiama Lespedeza, non Cespdeza o Zespedeza (le due forme sotto le quali conosciamo il nome del governatore) e del dedicatario si dice "Per il sig. Lespedez, governatore della Florida, cortesissimo nei confronti dei miei viaggi". Eppure anche François André era della partita... ma, come si dice in questi casi, la colpa è del proto che avrà scambiato la lettera iniziale C con L. Lespedeza Mich. è un genere di una quarantina di specie della famiglia Fabaceae, con una distribuzione nettamente disgiunta: una trentina vivono nelle zone temperate e subtropicali dell'Asia orientale e in Australia, mentre le altre sono originarie del Nord America orientale. Il numero delle specie e la loro corretta individuazione hanno dato filo da torcere ai botanici a causa sia dell'estrema variabilità delle specie, sia della tendenza a produrre con facilità ibridi naturali. Il genere, caratterizzato dai fiori papilionacei (ma molte specie hanno anche fiori cleistogami, cioè autofecondanti, privi di petali) e da baccelli tipici di questa famiglia, è piuttosto vario: comprende infatti erbacee perenni, arbusti e rampicanti. La specie più nota e coltivata nei giardini è senza dubbio L. thunbergii, uno splendido arbusto originario della Cina e del Giappone con eleganti rami arcuati che alla fine dell'estate si trasformano in una cascata di fiori rosa-porpora. L'americana L. capitata è invece famosa per altre ragioni: già gli indiani ne usavano le foglie per preparare tisane medicamentose; oggi è usata in fitoterapia per le sue proprietà drenanti, diuretiche e antiossidanti, che la rendono particolarmente indicata per migliorare le funzioni renali. Come molte leguminose, anche le piante di questo genere hanno radici dotate di noduli che ospitano batteri in grado di fissare l'azoto, arricchendo così il terreno. In Asia diverse specie sono usate come foraggere e appunto per il sovescio. Le loro forti radici sono utili anche per arginare il terreno, contenendo gli smottamenti. Ma queste belle qualità possono anche presentare un rovescio della medaglia, come dimostra la storia dell'asiatica L. cuneata. Questa pianta è stata introdotta in diversi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti dove venne piantata per la prima volta nel 1896 nel Nord Carolina per bonificare i terreni di miniere abbandonate, e anche come foraggiera; grazie alle radici molto profonde, non solo trattiene il terreno, ma riesce a sopravvivere a lunghi periodi di siccità. Ne sono anche state sviluppate diverse varietà. Eppure tanto vigore ha un rovescio della medaglia: una singola pianta può produrre 1000 semi all'anno, dove si insedia invade gli spazi delle piante native, inibisce la crescita dei semenzali degli alberi, produce sostanze chimiche che inibiscono la crescita di altre piante. Negli Stati Uniti è già un problema, in Europa non ancora, ma l'Unione europea l'ha inserita nella lista delle piante invasive e ne ha vietato la commercializzazione. Negli anni che precedono immediatamente la rivoluzione francese, si intrecciano due storie che sembrerebbero non avere nulla in comune. Da una parte c'è il marinaio francese Nicolas Baudin, che l'origine borghese esclude da una carriera di comando nella marina reale; sceglie allora la marina mercantile, tanto più che è nipote di un armatore di Nantes dai traffici non sempre limpidi. Dall'altra parte, c'è una spedizione di botanici austriaci, che fallisce per la defezione di metà dei suoi membri. Finché, nell'isola di Haiti, dove forse è venuto a contrattare un carico di schiavi, il marinaio incontra il capo dei botanici e ne riceve una soffiata che cambierà per sempre la sua vita. Perché le piante non basta raccoglierle, bisogna anche che qualcuno le porti a casa. E magari le faccia arrivare vive. Questa diventa la specialità del capitano Baudin, che comanda una dopo l'altra ben tre Jardinière (ovvero serre viaggianti). Tutte, puntualmente, finite male. Su queste e altre navi navighiamo su e giù per l'Atlantico e l'Oceano Indiano, mentre i botanici erborizzano nelle Americhe, in Sud Africa e a Mauritius. Alla fine, a portare a casa un genere valido sono un austriaco e un francese: il giardiniere viennese Franz Bredemeyer, dedicatario di Bredemeyera (Polygalaceae), e il botanico Pierre André Ledru, dedicatario di Drusa (Apiaceae).  Come un capitano di marina si appassionò di botanica Il 9 termidoro dell'anno VI (27 luglio 1798) la folla parigina assiste a un grandioso spettacolo: muovendo dalla sede del Museo di storia naturale, un corteo di carri ornati di ghirlande raggiunge il Campo di Marte, dove verranno pronunciati numerosi discorsi e i musicisti del conservatorio offriranno un concerto. E' questo il modo scelto dal Direttorio per esporre coram populo i tesori trafugati durante la campagna d'Italia, in un'operazione propagandistica che trasforma un saccheggio in un atto di libertà: quei tesori, anziché essere gelosamente nascosti nei palazzi e nei conventi per il godimento di pochi privilegiati - si proclama - sono ora messi a disposizione di tutti nei musei della Repubblica, per il progresso delle scienze e delle arti. Il corteo è strutturato in tre divisioni: la prima è riservata alla storia naturale, con sei carri carichi di piante e animali esotici; la seconda alla scienza e alla tecnica, con altri sei carri ricolmi di libri, manoscritti, medaglie, spartiti; la terza, il clou dell'intera manifestazione, ai capolavori dell'arte: tra gli altri sfilano la quadriga di san Marco, la Venere capitolina, lo Spinario, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, quadri di Raffaello, Tiziano, Domenichino, Giulio Romano, per un totale di 300 tra statue e dipinti. Se questi ultimi sono stati strappati ai palazzi italiani, non è certo così per molta parte degli oggetti naturali: qualcosa arriva dall'Egitto, dove in quel momento si trova Napoleone, ma il grosso proviene dalle Antille, ed è stato aggiunto al corteo all'ultimo momento, su suggerimento di Antoine-Laurent de Jussieu. In un certo senso, sono anche quelli prede di guerra: è il bottino del viaggio di Nicolas Baudin ai Caraibi, un successo che di lì a un anno garantirà a questo marinaio di lungo corso il comando della più importante missione scientifica della Repubblica: la "spedizione Baudin" nelle Terre Australi. In attesa di raccontarla in un prossimo post, facciamo conoscenza con questo personaggio, le cui vicende si sono curiosamente intrecciate con quelle della "spedizione Märter", promossa dall'Austria di Giuseppe II. Nicolas Baudin (1754-1803) era nato nell'isola di Ré in una famiglia relativamente agiata; prese il mare a quindici anni, a bordo di uno dei vascelli dello zio materno Jean Peltier Dudoyer, un armatore che aveva iniziato la sua carriera armando navi negriere e aveva interessi sia in America sia nell'Oceano indiano; per molti anni Baudin navigò sulle navi sia dello zio sia della Compagnia delle Indie; quando scoppiò la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, Peltier Dudoyer fu uno degli armatori che fornirono navi e rifornimenti alle colonie ribelli; il nipote si trovò coinvolto in prima persona e si comportò con onore, tanto da essere promosso capitano. Nel 1780 gli fu assegnato il comando della fregata Apollon incaricata di trasportare truppe al Capo di Buona Speranza per sostenere gli olandesi contro i britannici; un compito squisitamente militare, tanto che il comandante del porto di Brest gli ritirò il comando per assegnarlo a un nobile (solo questi ultimi potevano diventare ufficiali della marina militare). Baudin per il momento abbandonò ogni speranza di farne parte e continuò a comandare navi mercantili. Nel 1785 come capitano della Caroline, anch'essa armata da Peltier Dudoyer, trasportò in Louisiana l'ultimo gruppo di Acadiani di Nantes; a New Orleans (all'epoca ancora francese, e ancora Nouvelle Orlèans) alcuni mercanti lo incaricarono di trasportare varie merci a Mauritius (all'epoca ancora francese e ancora Ile del France) a bordo della Joséphine (detta anche Pepita o Josepha). Forse per contrattare un trasporto di schiavi dal Madagascar nel viaggio di ritorno, egli fece scalo a Haiti, dove incontrò il botanico austriaco di origine tedesca Franz Joseph Märter (1753-1827). Facciamo un passo indietro per raccogliere questo secondo filone della nostra storia. Nel 1783 il direttore dell'orto botanico di Vienna Nikolaus von Jacquin convinse l'imperatore Giuseppe II ad inviare in America una spedizione alla ricerca di piante esotiche per i giardini di Schönbrunn. La capeggiava appunto Märter, professore di storia naturale al Theresianum, accompagnato da un altro botanico, Matthias Leopold Stupicz, dal pittore Adam Moll e dai giardinieri Franz Boos e Franz Bredemeyer. Imbarcatosi a Le Havre ad agosto, insieme al nuovo console imperiale negli Stati Uniti, il gruppo raggiunse Filadelfia dopo un viaggio di quaranta giorni, in cui sperimentò tre tempeste e Märter scoprì il proprio tallone d'Achille: un irrimediabile mal di mare. A Filadelfia egli incontrò William Bartram e avrebbe voluto senz'altro iniziare le raccolte prima dell'inverno, ma gli mancavano i libri e le attrezzature, che viaggiavano su un'altra nave. Poté così mettersi all'opera solo a novembre. Mentre tutti gli altri raggiungevano Charleston in nave, egli attraversò a cavallo Pennsylvania, Maryland, Virginia e le due Caroline, accompagnato dal medico e zoologo Johann David Schöpf, che aveva partecipato come volontario alla guerra d'indipendenza da parte britannica e aveva deciso di fermarsi nel paese per studiarne la fauna. Arrivato a Charleston nel gennaio 1784, Märter inizialmente pensò di inviare nelle Bahamas Stupicz e un giardiniere, mentre lui con gli altri esplorava le due Caroline e la Florida, ma, rendendosi conto che Stupicz non parlava quasi l'inglese, lo mandò nella Carolina del Nord, dove vivevano numerosi tedeschi. Mentre Moll e Bredemeyer rimanevano a Charleston, egli si imbarcò con Schöpf e Boos per le Bahamas, soffrendo di nuovo atrocemente il mal di mare. Fu così costretto a ritornare a Charleston, mentre nei mesi seguenti Boos, spesso in condizioni difficili, esplorò diverse isole, rientrando a Charleston verso la fine dell'anno. Nel frattempo Bredemeyer era stato inviato a Vienna con un primo trasporto; il viaggio, iniziato nel giugno 1784, si protrasse per cinque mesi con la perdita di molte piante. Poco dopo il suo arrivo, insieme all'aiuto giardiniere Schücht, egli fu rimandato in America per ricongiungersi alla spedizione, la cui situazione si era fatta piuttosto critica. All'inizio del 1785, Boos era a Charleston gravemente ammalato; Moll e Supicz, che in realtà si erano imbarcati proprio nella speranza di emigrare negli Stati Uniti, diedero le dimissioni uno dopo l'altro, per stabilirsi a Charleston, il primo come insegnante di disegno e incisore, il secondo come medico. A sua volta Märter aveva contratto la malaria. A maggio lo lasciò anche Boos, che partì per Europa con una parte delle collezioni: più fortunato di Bredemeyer, ebbe un viaggio breve e senza contrattempi, consegnando piante e animali in perfette condizioni. Poco dopo la sua partenza, Märter si imbarcò per la Martinica, fissata come punto d'incontro con Bredemeyer e Schücht. Ma il mal di mare lo tradì ancora una volta e dovette sbarcare a Guadalupa. Riuscì poi a raggiungere Haiti, dove nell'agosto 1785 finalmente arrivarono anche i due giardinieri. Tutti e tre erano malati; il più grave era proprio Märter, che fu bloccato per sei mesi e a lungo dovette anche essere ricoverato nell'Hôpital de la Charité a Cap-Français. Fu in queste circostanze che conobbe Baudin. Lo sfortunato botanico (che probabilmente lo aveva saputo da Bredemeyer) lo informò che il suo antico compagno Boos era stato inviato ad erborizzare al Capo di Buona Speranza ed era in attesa di un imbarco per Mauritius. Proprio la meta del nostro intraprendente capitano che non perse l'occasione, dirigendosi immediatamente al Capo. Almeno, questa è la storia vulgata: le date non coincidono perfettamente. Comunque, prendiamola per buona. Le collezioni americane di Franz Boos avevano fatto una tale impressione all'imperatore, che aveva deciso che, anziché tornare in America a dare supporto all'inconcludente Märter, era meglio andasse direttamente in Sud Africa, per poi passare a Mauritius. Boos partì da Vienna nell'ottobre 1785 insieme all'aiuto giardiniere Georg Scholl. Dopo un lungo e penoso viaggio, funestato dallo scoppio a bordo di un'epidemia che aveva fatto più di trenta morti, erano arrivati al Capo solo nel giugno 1786; furono generosamente ospitati dal colonnello Gordon, che comandava la guarnigione della Compagnia delle Indie olandesi; egli fece loro conoscere Francis Masson, con il quale esplorarono Swartand e il Karoo, fino ad allora non molto battuto dai botanici europei, raccogliendo non poche novità. Baudin arrivò al Capo nel febbraio 1787 e imbarcò Boos e una parte delle sue collezioni, mentre Scholl, secondo le istruzioni ricevute, rimaneva in Sud Africa. A marzo erano a Mauritius, dove Boos incontrò il governatore Ceré, che era già in corrispondenza con Vienna cui nel 1783 aveva inviato piante e semi. Boos gli consegnò i doni dell'imperatore e si trattenne a lungo a Pamplemousses, stringendo ottime relazioni con i botanici e gli appassionati che ruotavano attorno a quel magnifico orto botanico, ricevendo molte piante provenienti non solo a Mauritius, ma dall'intera Asia. Poté anche visitare l'Île Bourbon (ovvero La Réunion) ed esplorare le montagne dell'interno con il botanico Joseph Hubert. Intanto si era accordato con Baudin per noleggiare la Joséphine per trasportare a Vienna le sue collezioni, rese preziose dai contributi dei nuovi amici delle Mascarene. Nel dicembre 1787 la Joséphine-Pepita (che, tanto per aumentare la confusione, Boos aveva ribattezzato Pepinière, "vivaio") riprese il mare. Come ci informano i giornali dell'epoca, raggiunse il porto austriaco di Trieste il 18 giugno 1788. Il suo carico, che comprendeva anche qualche zebra viva, fece sensazione. Gli animali e le piante presero la via di Vienna, dove rientrò anche Boos. Durante quei lunghi mesi di viaggio, capitano e botanico avevano fatto amicizia. Boos illustrò a Baudin le tecniche migliori per preservare le piante e gli animali durante i lunghi viaggi oceanici; per Baudin fu la scoperta di una nuova vocazione: quella di raccoglitore-naturalista.  Avventure quasi corsare Il riuscito trasporto delle collezioni di Boos era senz'altro un ottimo biglietto da visita; Baudin sperava gli assicurasse il comando di una nuova spedizione di cui si andava vociferando: niente meno che la prima circumnavigazione austriaca del globo. Nel frattempo, al comando della nave commerciale Jardinière (ovvero "serra viaggiante", un nome non scelto a caso, visto che nel vaiggio di ritorno avrebbe dovuto imbarcare Scholl e le sue piante) partì per Canton, non è troppo chiaro se per conto proprio o della Compagnia imperiale delle Indie. Forse temendo guai con l'amministrazione cinese, viaggiava infatti sotto bandiera statunitense. Giunto a Canton, spedì il suo secondo in America per un traffico di pellicce, ma la Jardinière naufragò nelle Marianne settentrionali, di fronte all'isola di Asuncion. E' l'inizio di una serie di vicende rocambolesche: Baudin andò a Mauritius a procurarsi un'altra nave, che battezzò Jardinière II; il nome non portò fortuna: il 15 dicembre 1789 un ciclone colpì l'isola e la nave andò distrutta in porto. Allora Baudin si imbarcò come passeggero su una nave della Compagnia reale delle Filippine; di passaggio al Capo, poté prendere con sé solo una piccola parte delle collezioni di Georg Scholl. La nave era diretta a Cadice, ma non vi giunse mai. Lo scafo era in uno stato così deplorevole che si dovette fare rotta per le Antille e fare scalo a Trinidad, dove la collezione venne sbarcata. Baudin si imbarcò su un'altra nave e arrivò in Martinica, dove scrisse a Vienna per spiegare la situazione e riproporsi come comandante della progettata spedizione in Estremo oriente. Forse era giunta la volta buona. Nel gennaio 1792 la corte di Vienna gli concesse il titolo di capitano della Marina imperiale e gli affidò il comando di una nuova Jardinière che, oltre a prelevare Scholl e le sue collezioni, avrebbe dovuto esplorare le Indie Orientali e la Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Per accompagnarlo furono designati Franz Bredemeyer e l'aiuto giardiniere Joseph van der Schot che ad aprile si imbarcarono a Genova alla volta di Malaga. Ma i tempi erano cambiati: in Francia la monarchia era crollata, e pochi giorni dopo la loro partenza, il 20 aprile 1792, la Convenzione dichiarò guerra alla Prussia e all'Impero. Baudin all'improvviso diventava un nemico; raggiunta anch'egli Malaga, dapprima pensò di abbandonare la spedizione e cercò di negoziare il suo rientro nella marina francese; avendo avuto un rifiuto, continuò i preparativi, mentre Austria e Gran Bretagna chiedevano alle autorità spagnole il suo arresto e il sequestro della nave. Nella confusa situazione politica di quei mesi, in cui la Spagna tentava la difficile strada della neutralità, dopo una breve detenzione fu rilasciato e riprese possesso della nave. Lasciati i botanici a terra, il 1 ottobre la Jardinière salpò; ma Baudin, anziché tornare in Francia, cercò di realizzare da solo il programma scientifico inziale. Eccolo al Capo di Buona Speranza, dove caricò una parte delle collezioni di Scholl (che si accorse troppo tardi che ora la nave batteva bandiera francese); quindi si diresse verso la Nuova Olanda ma incappò in due cicloni successivi che la costrinsero ad attraccare a Bombay per riparazioni. La navigazione volse ora verso occidente, toccando il Golfo persico, il mar Rosso, la costa orientale dell'Africa, dove vennero raccolti esemplari di animali e piante, e terminò di fronte a Table Bay, dove la terza Jardinière si arenò durante una tempesta. Baudin si salvò e, a quanto pare, riuscì a recuperare almeno qualcosa delle sue raccolte, visto che anche queste finirono a Trinidad, dove passò durante il viaggio di ritorno, passeggero di una nave americana. Rientrato in Francia, nel marzo 1796 Baudin incontrò Antoine Laurent de Jussieu e gli suggerì di organizzare per conto del Museo nazionale una spedizione a Trinidad per recuperare le collezioni (sue o austriache, ormai poco importava...). Il direttorio accettò la proposta e il 30 settembre 1796 Baudin partì alla volta delle Antille al comando della Belle-Angelique. Lo accompagnava una piccola équipe scientifica: il botanico André Pierre Ledru, il giardiniere Anselme Riedlé, gli zoologhi René Maugé e Stanislas Levillain. Ma la nave era così inadatta a tenere il mare che alle Canarie Baudin dovette abbandonarla e sostituirla con una nuova nave, la Fanny, con la quale nell'aprile 1797 raggiunse Trinidad. Qui scoprì che l'isola era da poco passata nelle mani degli inglesi, che rifiutarono di consegnargli le collezioni. Baudin non era tipo da tornare in Francia a mani vuote. Nelle Antille c'erano diverse isole neutrali, come la portoghese São Tomé e la danese Saint Croix. Baudin e i suoi naturalisti le esplorarono e fecero buone raccolte di piante e animali; quindi a Saint Croix la Fanny venne sostituita con un vascello più agile, ribattezzato Belle-Angelique, a bordo della quale visitarono Porto Rico, quindi proseguirono per la Francia, dove giunsero nel giugno 1797, pochi giorni prima del grande corteo da cui abbiamo preso le mosse, giusto in tempo per esibire i loro trofei nella divisione di storia naturale. Quello stesso giorno, anche grazie ai buoni uffici del cugino Marie-Etienne Peltier - che dal 1794 batteva i mari come "corsaro della Repubblica - Baudin ricevette il comando della nave corsara Virginie; il 4 agosto fu reintegrato nella marina militare con il grado di capitano di vascello, e partecipò ad alcuni episodi della guerra contro l'Inghilterra. Ma la vera rivincita se la sarebbe presa nell'ottobre 1800, quando gli venne affidato il comando della grandiosa spedizione nelle Terre australi, più nota come "spedizione Baudin". In queste vesti lo ritroveremo in un prossimo post. E con lui tre dei naturalisti della Belle Angélique che lo seguirono nella nuova avventura, per perdervi la vita.  Epilogo: e vissero felici e contenti Molti sono i personaggi di questa storia affollata ad aver ricevuto l'onore della dedica di un genere botanico, anche se ne rimane valido uno solo. Ad aprire le danze è lo stesso capitano Baudin. Per ben due volte, De Candolle gli dedicò un genere Baudinia, ma entrambi sono ridotti a sinonimi: Baudinia (Myrtaceae) di Melaleuca e Baudinia (Goodeniaceae) di Scaevola. Si consola con l'eponimo di Limonium baudinii, una specie della Tasmania raccolta durante la sua celebre spedizione. Veniamo ora ai suoi compagni austriaci, raccontando ancora qualcosa delle loro vite dopo il turbinoso incontro con il capitano francese. L'ottimo Franz Boos (1753 - 1832) dopo il ritorno a Vienna fece carriera. Nel 1787, quando von Jacquin lasciò l'incarico, fu nominato direttore dei giardini e dell'orto botanico di Schönbrunn, cui nel 1790 si aggiunse la direzione del serraglio imperiale e del cosiddetto "Giardino olandese". Fino al ritiro nel 1827, continuò anche ad essere capo giardiniere e nel 1816 insieme al figlio Joseph Boos, anch'egli un valente professionista, pubblicò un catalogo delle piante selvatiche e coltivate di Schönbrunn. Nel 2001 il botanico austriaco Speta ha voluto ricordarlo con il genere Boosia, generalmente non accettato (è sinonimo di Drimia). Gli è stata anche dedicata una via nel quartiere di Hietzing. Dopo aver visto involarsi una parte delle sue collezioni per l'inganno di Baudin, Georg Scholl (1751-1831) rimase ancora in Sudafrica per diversi anni (il suo soggiorno ne durò in tutto dodici), ancora ospite del colonello Gordon. Le sue raccolte diventavano sempre più imponenti e sempre più difficili da trasportare, come ci informa Francis Masson nelle sue lettere a Joseph Banks. Di tanto in tanto, riusciva a spedire a Vienna bulbi e semi, tra cui quattro spedizioni tra il 1790 e il 1792 che, attraverso il console austriaco in Olanda, raggiunsero Vienna via Amsterdam. Solo nel 1799 gli fu possibile lasciare il paese, ritornando a Vienna con la collezione di piante vive sudafricane più importante d'Europa (ora capiamo meglio perché Banks, appena tornata la pace, si sia affrettato ad inviare al Capo il suo raccoglitore James Bowie). L'esemplare più sensazionale era una Fockea capensis, una specie così rara che a lungo si credette fosse estinta in natura. E' tuttora possibile ammirarla nella serra di Schöbrunn, grazie alla previdenza di un giardiniere che, durante la seconda guerra mondiale, lo salvò portandoselo a casa. Con i suoi 600 anni valutati, è considerata la più vecchia pianta in vaso del mondo. Quanto a Scholl, tornò a lavorare a Schönbrunn, quindi dal 1802 divenne capo giardiniere al Belvedere. Nel 1811 il figlio di von Jacquin gli dedicò Schollia (sinonimo di Hoya) e sempre nel 2001 Speta Geschollia (ugualmente sinonimo di Drimia). Lo ricorda l'eponimo dell'Aizoacea sudafricana Ruschia schollii. Nonostante la grande ricchezza e l'importanza storica delle collezioni di Boos e Scholl, la maggior gloria botanica è però riservata a Franz Bredemeyer (1758-1839), ricordato da un genere valido e da una decina di eponimi. Lo abbiamo lasciato ad Haiti al momento del ricongiungimento con Märter. Nel febbraio 1786 questi inviò lui e Schücht in Venezuela, dove contava di raggiungerli appena recuperata la salute. I due passarono da Porto Rico, che furono i primi botanici a visitare, quindi visitarono Caracas e il porto di La Guaira, dove avrebbe dovuto raggiungerli Märter. Nel frattempo questi aveva di nuovo cambiato idea e li richiamò, ma i due giardinieri ormai agivano in modo indipendente (e molto più efficace). Pur dovendo fare i conti con difficoltà economiche, carte sbagliate e i sospetti delle autorità spagnole, che temevano fossero spie, decisero di esplorare il più possibile quel paese tanto affascinante quanto quasi inedito per la botanica. Acquistarono dei muli e assunsero un assistente; a settembre viaggiarono a est di Caracas, visitando Guatire, Caucagua e la foresta pluviale nei pressi di Capaya (nell'attuale stato di Miranda); da marzo a maggio dell'anno successivo si spostarono verso ovest nell'attuale stato di Aragua e nei Llanos. Nell'aprile del 1788 si imbarcarono a La Guaira alla volta di Curaçao, dove noleggiarono la goletta americana The Commerce che li avrebbe riportati in Europa insieme a molte piante che fecero sensazione per l'aspetto decisamente esotico e tropicale. Li aveva preceduti di circa un anno lo stesso Märter. Invece di raggiungere i due giardinieri in Venezuela, era passato in Giamaica; qui aveva visitato le Blue Mountains, dove lo incontrò il botanico svedese Olof Schartz; secondo la testimonianza di quest'ultimo, era di nuovo malato, nonché depresso per la disgrazia in cui era caduto presso la corte di Vienna, che gli attributiva tutta la colpa del fallimento della spedizione. Nel maggio 1787 imbarcò totalmente a sue spese una collezione che secondo le sue dichiarazioni ammontava a non meno di 3000 esemplari, tra cui 1800 piante vive. Giunto a Londra, le fece svernare in serra; qui e in Olanda acquistò anche molti uccelli impagliati. Poté così presentarsi a testa alta all'imperatore che dovette perdonarlo, se lo nominò professore di botanica e storia naturale all'Università dei Paesi Bassi austriaci, fondata l'anno prima. Su sua raccomandazione, Bredemeyer venne nominato direttore dell'annesso orto botanico. Per entrambi, un incarico di brevissima durata. La rivoluzione del Brabante dell'ottobre 1789 li costrinse alla fuga. Una nuova occasione si presentò per Bredemeyer quando, come abbiamo anticipato, venne nominato naturalista della missione della terza Jardinière. Già sappiamo che l'avventura sfumò e il povero giardiniere rimase a terra, mentre Baudin partiva senza di lui. Non gli restava che tornare a Vienna. Nel 1793 divenne supervisore dei frutteti e dei parchi di Schönbrunn; in seguito si occupò dei giardini degli arciduchi, che nel 1802 accompagnò ad erborizzare in montagna. Al pensionamento di Boos, divenne a sua volta direttore dei giardini e del serraglio di corte. Sotto la sua direzione, furono allestite la "Casa delle giraffe" e una collezione di piante parassite. Divenuto consigliere imperiale e membro di molte società orticole, inclusa la Horticultural Society di Londra, morì ottantenne nel 1839. Le specie tropicali raccolte in Venezuela divennero una delle maggiori glorie delle serre di Schönbrunn, destando l'ammirazione di Humboldt, che fu spinto anche da quello spettacolo al suo viaggio in Sud America, dove non avrebbe mancato di ripercorrere le orme di Bredemeyer e Schücht. Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, conosceva bene Bredemeyer, delle cui note si servì ad esempio per descrivere le piantagioni di cacao del Venezuela, ombreggiate da alberi di bucaré (Erythrina poeppigiana) dagli smaglianti fiori rossi tra cui volavano eserciti di pappagalli dalle piume multicolori. Fu sicuramente lui a suggerire l'acquisto dell'erbario di Bredemeyer, 180 fogli del quale si trovano ora al Museo botanico di Berlino-Dahlem. Non stupisce dunque che sia stato proprio Willdenow a dedicargli il genere Bredemeyera, sulla base di una pianta raccolta da Franz Bredemeyer nei pressi di Caracas. Oggi a questo genere della famiglia Polygalaceae sono attribuite 18 specie, distribuite dal Messico al Paraguay settentrionale. Sono liane legnose o piccoli arbusti con foglie semplici, fiori con cinque sepali, due esterni e tre interni, con ali petaloidi; la corolla ha cinque petali (due laterali, la carena, e due rudimentali): i frutti sono capsule con semi protetti da un arillo con peli più lunghi dei semi stessi. La specie tipo descritta di Willdenow B. floribunda, diffusa dal Venezuela al Paraguay, presenta cospicui grappoli di fiori bianchi; è una specie officinale, con proprietà disintossicanti, cui la medicina tradizionale attribuisce efficacia contro i morsi dei serpenti. Tra le diverse specie che si fregiano dell'eponimo bredemeyeri o bredemeyerianus, vorrei ricordare almeno la spettacolare Bomarea bredemeyeriana: con i suoi grappoli di fiori a campana aranciati fu probabilmente una delle piante la cui vista colpì al cuore Humboldt. E Märter? forse qualcuno si domanderà. Sappiamo che la collezione d'uccelli fu da lui donata alla loggia massonica Zur true Eintracht (frequentata anche da Mozart e Schikaneder che ne avrebbero tratto ispirazione per l'uccellatore Papageno del Flauto magico) e andò dispersa quando il cattolicissimo imperatore Francesco bandì la massoneria nel 1794. Non ci è noto il destino della collezione botanica, forse meno favolosa di quanto Märter pretendesse. In condizione di professore "giubilato", ovvero in pensione, nel 1796 egli pubblicò una seconda edizione assai accresciuta di un libro sugli alberi austriaci che aveva pubblicato prima della spedizione (Verzeichniß der östreichischen Bäume, Stauden und Buschgewächse); l'anno successivo fu la volta di una monografia sulla batata dolce. Nel 1797, quando venne riaperta l'Accademia dei cavalieri teresiani, gli fu assegnata la cattedra di silvicoltura. La coltivazione di alberi da frutta e da legname era infatti ormai il suo interesse principale, tanto che nel 1799 aprì un vivaio con 300 piante da frutto; l'avrebbe venduto nel 1806 per motivi di salute, così come nel 1803 per la stessa ragione aveva dato le dimissioni dal Theresianum. Per altro morì più di vent'anni dopo, nel 1827, a 73 anni. Giuseppe II lo considerava streitsüchtig, ovvero polemico. A me pare piuttosto inconcludente. Sta di fatto che nessun botanico ha mai pensato di dedicargli, nonché un genere, neppure una specie. Fu invece nientemeno che de Candolle a dedicare un genere al solo botanico francese di questa storia, André Pierre Ledru (1761-1825), uno dei naturalisti della Belle Angélique. Sappiamo che era un sacerdote, da poco consacrato quando scoppiò la rivoluzione, cui aderì senza esitare, prestando giuramento alla Costituzione civile del clero. Nella fase più convulsa della controrivoluzione vandeana, come prete giurato si trovò in pericolo di vita; si trasferì così a Parigi, dove presumibilmente entrò in contatto con gli ambienti del Museum national e in particolare con Antoine Laurent de Jussieu (nel suo erbario si trovano esemplari donatogli da lui, comprese alcune piante coltivate al Trianon da suo zio Bernard de Jussieu). Grazie a queste frequentazioni, fu scelto come botanico della spedizione nelle Antille, durante la quale fece notevoli raccolte a Tenerife, Porto Rico e in diverse isole. Al suo rientro, tornò in provincia, divenendo insegnante, anche se non abbandonò mai del tutto la botanica, visto che allestì un orto botanico privato e possedeva un notevole erbario, ora conservato al Museo di Le Mans. De Candolle, che all'epoca lavorava ancora al Museum national, gli dedicò Drusa (Apiaceae), sulla base di un esemplare raccolto da Ledru (che egli definisce "ragguardevole botanico") a Tenerife, lungo la strada che conduce a La Orotava. La sua unica specie D. glandulosa è una piccola rampicante pelosa e appiccicosa, con fiori minuscoli e curiosi frutti dotati di ali dentate. Singolare la sua distribuzione: oltre che nelle Canarie e in Marocco (dove si ritiene introdotta), si trova in alcune stazioni della catena Cal Madow in Somalia. Nella primavera del 1679 arriva in Virginia come pastore il reverendo John Banister; formatosi a Oxford, dove ha seguito i corsi di Robert Morison, è il primo naturalista con una formazione scientifica universitaria a stabilirsi nelle colonie inglesi del Nord America; all'impegno pastorale affianca infatti l'esplorazione della flora (e della fauna), incoraggiato da committenti inglesi, tra cui il suo diretto superiore, il vescovo Compton, cui invia molte primizie americane per il giardino di Fulham. Progetta di scrivere una storia naturale della Virginia, ma perde la vita in un incidente assurdo. A ricordarlo il genere Banisteriopsis (famiglia Malpighiaceae). 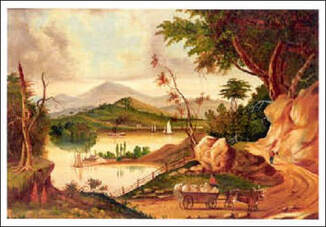 Un pastore naturalista A fine Seicento, la Virginia, la prima delle tredici colonie del Nord America, incominciava ad assestarsi dopo un avvio tutt'altro che facile. I coloni, che l'avevano fondata nel 1609, avevano dovuto affrontare la fame, ripetute guerre contro le popolazioni native, due massacri (nel 1622 e nel 1644). Durante la guerra civile erano rimasti sostanzialmente fedeli alla monarchia (tanto che Carlo II, recuperando il trono, la soprannominò The Old Dominion, l'antica colonia). Malattie, uragani, alluvioni, l'ostilità dei nativi, le tensioni con il governo centrale non mancavano, ma la Virginia aveva ormai trovato la risorsa che ne avrebbe fatto la più ricca delle colonie: la coltivazione del tabacco. Non era però una situazione né tranquilla né pacificata. Nel 1676 il piantatore Nathaniel Bacon guidò una rivolta armata (la prima nelle tredici colonie) contro il governatore William Berkeley, biasimato da una parte per i suoi metodi autocratici, dall'altro per la sua politica di pacificazione con i nativi, che impediva ai coloni poveri di installarsi oltre i confini della colonia. Alla ribellione, che assunse carattere molto violento, con il genocidio degli indiani Susquehanock e l'incendio della capitale Jamestown, aderirono i medi e piccoli proprietari e molti degli immigrati più poveri arrivati in Virginia come "servi a contratto", mentre i grandi proprietari rimanevano fedeli al governatore. Repressa con ferocia da Berkeley, la ribellione si esaurì con la morte di Bacon, ma lasciò un'eredità pesante: da quel momento, a lavorare nelle piantagioni furono sempre meno europei semi-liberi e sempre più schiavi neri. La Virginia si avviava a trasformarsi in una società razzista, basata sul sistema di piantagione e lo schiavismo. Il protagonista della nostra storia vi arrivò a ridosso di questi eventi. John Banister (1650-1692), nato in una famiglia modesta, a diciassette anni fu ammesso come corista al Madgdalen College di Oxford; benché destinato al sacerdozio, incominciò a frequentare l'Orto botanico, facendo amicizia con Jacob Bobart il Giovane e seguendo le lezioni di Robert Morison, a quel tempo impegnato nella mastodontica Plantarum historia universalis oxoniensis. Allestì un erbario e un catalogo di piante; ad affascinarlo erano soprattutto quelle americane. A sua volta Morison fu colpito dal suo talento e lo segnalò al vescovo di Londra Henry Compton, che stava cercando missionari interessati alle scienze naturali da inviare nelle colonie. Fu così che Banister, dopo essersi laureato nel 1674 e aver servito per un biennio come cappellano, nel 1678 si imbarcò alla volta dell'America, ufficialmente come ministro anglicano, ufficiosamente come naturalista e cacciatore di piante per i suoi patroni Morison e Compton. Dopo due scali alle Barbados e a Grenada, raggiunse la Virginia nella primavera del 1679. Il 7 aprile 1679 (data della prima lettera a Morison a noi pervenuta) era ospite del piantatore e commerciante William Byrd I. Di poco più vecchio di lui, Byrd era emigrato in Virginia per prendere possesso di una proprietà di alcuni acri lasciatagli da uno zio e aveva cominciato ad arricchirsi trafficando con gli indiani rum, fucili, ferramenta e lana in cambio di pellicce; era stato uno dei primi seguaci di Bacon, prendendo anche parte ad alcune azioni armate, ma poi era passato dalla parte del governatore. Col tempo sarebbe diventato un ricchissimo piantatore, proprietario della Westover Plantation che si estendeva per 1200 acri (equivalenti a quasi 5 km quadrati). Byrd era interessato alle piante da un punto di vista pratico: fece venire semi di nuove varietà di tabacco e importò piante orticole e agricole dall'Inghilterra. Incoraggiò Banister nelle sue ricerche, coinvolgendolo nelle sue spedizioni lungo la frontiera, e più tardi mantenne per lui i rapporti con l'Inghilterra, curando i suoi invii di piante, semi e animali e procurandogli materiali da disegno, carta e libri. Nella lettera a Morison, dopo aver descritto in termini coloriti i conflitti con gli indiani "nemici barbari", Banister descrive la Virginia come una terra fertile e ricca di acque che può offrire ogni bene necessario per la vita e per il piacere. Riferisce con meraviglia della grande ricchezza di alberi, che potrebbero ripopolare gli impoveriti boschi inglesi: ogni tipo di quercia, castagno, salice. Biasima la ristrettezza di vedute dei piantatori, unicamente interessati al tabacco e ai soldi che ne possono ricavare, mentre è affascinato dalla grande varietà di piante coltivate dai barbari indiani: mais con chicchi di tutti i colori, patate in innumerevoli varietà, fagioli, angurie e meloni. A lui il tabacco interessava soprattutto dal punto di vista scientifico e più tardi raccolse i semi delle diverse varietà coltivate dagli Indiani, creando una specie di banca del seme ante litteram. In una data ignota, Banister divenne ministro della Parrocchia di Bristol, la cui chiesa parrocchiale si trovava nei pressi dell'attuale città di Hopewell, lungo il fiume Appomattox. Cercava di conciliare i doveri pastorali con le ricerche naturalistiche, ma dovette constatare che era impossibile vivere con i magri proventi della parrocchia e dei pochi acri di terra che gli erano stati concessi, tanto più che nel 1687 mise su famiglia, sposando una giovane vedova. Qualche aiuto gli sarà venuto dai suoi amici londinesi, ma alla fine si rassegnò a trasformarsi anche lui in piantatore; nel 1689 acquistò 1735 acri nella Charles City County. A quel punto doveva ormai essere uno dei maggiorenti locali: l'anno successivo lo ritroviamo tra i membri del comitato fondatore del College of William and Mary che, tuttavia, a causa di difficoltà finanziarie, nascerà ufficialmente solo dopo la sua morte. Banister cominciò ad esplorare la natura della Virginia fin dal suo arrivo nella colonia. Dato che muoversi da solo in quel territorio ancora di frontiera era estremamente pericoloso, approfittava il più possibile delle spedizioni di Byrd, anche se difficilmente si sarà allontanato da casa più un centinaio di km. Le spedizioni, che comprendevano cacciatori, boscaioli per aprirsi la strada, guide e interpreti, si muovevano lungo le piste commerciali, per lo più ai piedi delle colline, e più raramente si spingevano sulle montagne (contro l'immagine eroica che Linneo darà delle esplorazioni di Banister). Il primo invio del missionario-naturalista raggiunge l'Inghilterra nel 1680: ci sono insetti, aracnidi e molluschi per il medico Martin Lister e circa 150 tra disegni, esemplari di piante e semi per Morison e il vescovo Compton. A destare la maggior sensazione è il disegno di una pianta "dalla forma così strana e mostruosa che ne provo paura": è Sarracenia purpurea. Il vescovo e i suoi amici del Temple Coffee House Club ne sono elettrizzati e chiedono a Banister (si spera in cambio di qualche sussidio economico) di inviare disegni di piante, esemplari di erbario, piante vive, semi, tutto quello che potrà raccogliere. L'invio del 1682 comprende una lista di piante per John Ray, una serie di disegni per Leonard Plukenet (che li pubblicherà nella sua Pytographia), altre piante per il giardino di Fulham: la più notevole è Magnolia virginiana, la prima magnolia a toccare il suolo europeo. Seguiranno Lindera benzoin, Liquidamber styraciflua, Cornus amomum, Gleditsia triacanthos, Chionanthus virginicus, Acer negundo, Rhus copallina, Aralia spinosa, Merispermum canadense, Quercus rubra, Ostrya virginiana, Abies balsamea, Nyssa aquatica. Tra tanti alberi e arbusti c'è anche qualche erbacea, come il Dracunculus Virginianus latifolius di cui il vecchio amico Bobart pubblica un'immagine nel 1699: è la prima riproduzione di Echinacea purpurea. Banister si interessa anche di altri campi della storia naturale. In una lettera al vescovo Compton del 1689, descrive e riconosce la funzione dei bilancieri delle mosche, che erano stati descritti qualche anno prima da Robert Hooke, senza però individuarne la funzione; in un contributo poi inviato alla Royal Society studia la conchiglia e i disegni dorsali e ventrali del curioso granchio Limulus polyphemus; è il primo a descrivere l'anatomia interna di una lumaca. La lettera in cui descrive Mutinus elegans è considerata il primo articolo dedicato a un fungo del Nord America. Rimane però principalmente un botanico e il suo sogno è scrivere una storia naturale della Virginia; a tale scopo, raccoglie esemplari d'erbario, redige liste, prende note. Ma a soli 42 anni la sua vita viene spezzata da un incidente assurdo e crudele. All'inizio di maggio 1692, ancora una volta accompagna Byrd e i suoi uomini in una spedizione che seguendo la pista commerciale nota come Occaneechee Trading Path si dirige verso il Roanoke River; forse proprio per cercare qualche pianta, si addentra nella boscaglia. Uno dei dipendenti di Byrd, Jacob Colson, lo scambia per un animale e gli spara. Almeno, questa è la versione ufficiale, registrata nel Henrico County Court order book in data 16 maggio 1692. L'incidente, avvenuto lontano da occhi indiscreti, resta avvolto dal mistero: la famiglia venne informata che il pastore era stato ucciso dalla caduta di un albero, mentre Ray credeva fosse morto cadendo da una roccia. Lasciava una vedova, un bimbo di due anni e un'opera mai scritta. Il suo nome è ricordato da Banisteria, la rivista della Virginia Natural History Society, dedicata alla storia naturale della Virginia, con articoli che coprono la botanica, la zoologia, l'ecologia e la geologia.  Botanici allucinati, piante allucinogene Dopo la sua morte, le collezioni di Banister furono riunite da Byrd e inviate a Londra insieme a una copia dei cataloghi. Le osservazioni sugli insetti della Virginia furono pubblicate nel 1701 nelle Transactions della Royal Society, mentre le raccolte botaniche, i disegni, le lettere e i cataloghi di piante influenzarono in vario modo la conoscenza della flora nordamericana e le opere di molti altri autori. In primo luogo, attraverso il giardino del vescovo Compton a Fulham, e in misura minore l'orto botanico di Oxford, furono dozzine le specie da lui introdotte in Inghilterra, in particolare quegli alberi e arbusti che sono alla base del passaggio dal giardino formale alla francese al giardino paesaggistico all'inglese. In secondo luogo, molti autori recuperarono le sue osservazioni sulla flora, la fauna e gli abitanti della Virginia, a volte senza citarlo. Così fece Robert Beverly, che in History and Present State of Virginia (1705) trascrisse verbatim intere pagine delle note di Banister. Molto ampia è la presenza delle sue raccolte nelle opere dei botanici britannici a cavallo tra Seicento e Settecento, a cominciare da John Ray che nel secondo volume di Historia Plantarum (1693) pubblicò un catalogo di piante americane, basato su una lista ricevuta nel 1682 da Banister, da lui salutato come "uomo eruditissimo e completissimo botanico". James Petiver in Museum Petiverianum cita 65 denominazioni di Banister per piante americane coltivate nel giardino di Fulham dal vescovo Compton e utilizza le sue note sui funghi nelle edizioni della sua Gazophylacii Naturae & Artis (1702–1709). Lister pubblica gli insetti, molluschi, aracnidi e animali primitivi da lui raccolti in Historia Sive Symposis Methodica Conchyliorum (1685–1692). Plukenet utilizza alcuni dei suoi disegni in Phytographia (1691–1705). Dillenius include i suoi muschi in Historia Muscorum (1741). Sono tutte opere ben note a Linneo, che durante la sua visita a Londra e a Oxford poté anche ammirare esemplari di erbario raccolti da Banister. E' dunque naturale che accogliesse la proposta di Houstoun di dedicargli un genere di piante. Houstoun aveva unito sotto il nome Banisteria un'intera famiglia di piante rampicanti tropicali, una delle quale era stata raccolta da Banister nelle Barbados. Forse attraverso racconti orali raccolti durante il soggiorno inglese, Linneo si era anche formata un'immagine romantica della figura di Banister, che ritroviamo nella dedica strappalacrime del genere Bannisteria (con due enne) in Hortus Cliffortuanus: "Houstoun ha destinato questa santa famiglia di piante alla memoria dell'inglese John Bannister [sic!] che prima di lui diede persino la carissima vita per le piante. Egli infatti penetrando i recessi della Virginia, scalando monti e rupi, affinché nulla rimanesse nascosto al suo zelo, per un caso sventurato inciampò, cade, si sfracellò e perì miseramente. Gli fu dunque dedicata una pianta americana rampicante con frutto spaccato color del sangue". Come si vede, egli segue la versione divulgata da Ray; la pianta in questione, qui Bannisteria foliis ovatis, ramis dichotomis [ecc.], ribattezzata in Species plantarum Banisteria (con una enne) fulgens, oggi si chiama Stigmaphyllon emarginatum. In effetti è un rampicante che ha per frutto uno schizocarpo che a maturità si divide in tre samare con ali rosso vivo. Linneo ufficializza il genere in Species Plantarum (1753), questa volta con la grafia corretta Banisteria. E' l'inizio di un nodo gordiano tassonomico. Egli distribuisce le specie che più tardi saranno assegnate alla famiglia Malpighiaceae in tre generi, distinti sulla base dei frutti: Malpighia, con frutto carnoso; Banisteria, con frutto che si divide in tre samare ciascuna con una grande ala dorsale trilobata; Thryallis con il frutto che si divide in tre cocci. Oggi, l'unico accettato rimane Malpighia. Il suo genere Banisteria, con il senno di poi, risulta un gruppo eterogeneo, che riunisce sette specie che oggi appartengono a quattro generi diversi (uno dei quali di un'altra famiglia). Dal resto, questo gruppo di Malpighiaceae è particolarmente difficile da classificare, e non possiamo prendercela con il vecchio Linneo, tanto più che i botanici che verranno dopo faranno di peggio. Nel corso dell'Ottocento, infatti, mentre cresceva il numero delle specie note e venivano creati nuovi generi, il nome linneano fu mantenuto e allargato a molte nuove specie. Particolarmente influente fu la trattazione di Banisteria di Adrien de Jussieu, seguita da molti autorevoli colleghi; ma il suo genere non aveva nulla a che fare con quello di Linneo, di cui non includeva neppure una specie. Infatti le specie linneane erano state tutte via via assegnate a nuovi generi; il gruppo più consistente era costituito da tre specie che ora facevano parte di Heteropterys, creato da Kunth nel 1821. Il primo ad accorgersi di questa incongruenza fu il botanico americano Charles Budd Robinson che nel 1910 propose di ripristinare il nome linneano per sostituire Heteropterys e ribattezzare Banisteriopsis "simile a Banisteria" il genere Banisteria nel senso di Jussieu. La proposta fu accettata solo in parte, generando ulteriore confusione; come capita in questi casi, a tagliare il nodo gordiano provò il Congresso Botanico Internazionale di Cambridge (1930) che decise di considerare legittimi Heteropterys e Banisteriopsis e di cassare Banisteria (nome reijcendum). La saga non finì lì, ci fu ancora qualche botanico che difese Banisteria, per non parlare di vivaisti e appassionati, finché negli anni '60 del Novecento il nome linneano fu definitivamente mandato in pensione e Banisteriopsis universalmente accettato. Banisteriopsis C.B.Rob. è un vasto genere della famiglia Malpighiaceae che riunisce una sessantina di specie di arbusti, piccoli alberi e liane rampicanti diffusi dal Messico al Sud America tropicale, con centro di diversità in Brasile, in due diversi ambienti: le savane tropicali, dove sono soprattutto arbusti, e la foresta pluviale, dove sono liane, a volte di dimensioni enormi. Dopo aver letto l'intricata storia della loro denominazione, forse non vi stupirete di scoprire che la specie più nota B. caapi è un potente allucinogeno. Tanto è vero che lo stato della Louisiana ha proibito la detenzione e la coltivazione di tutte le specie di questo genere, salvo per usi ornamentali. Qualche informazione in più nella scheda. Nel Giurassico (da 180 a 135 milioni di anni fa) foreste di conifere della sottofamiglia Sequoioideae delle Cupressaceae ricoprivano vaste aree dell'emisfero boreale, come testimoniano i fossili trovati in Nord America, Groenlandia, Europa ed Asia. Oggi ne rimangono solo tre specie viventi, ciascuna delle quali è l'unica rappresentante di un genere monospecifico: le americane (o meglio californiane) Sequoia sempervirens e Sequoiadendron giganteum e la cinese Metasequoia glyptostroboides. Le due californiane sono rispettivamente il più alto e il più grande albero del mondo: la prima può raggiungere un'altezza di 100 metri, la seconda la stessa circonferenza e un volume di quasi 1500 metri cubi. Niente di più appropriato, di più "giusto", che questi maestosi giganti delle foreste americane prendano il nome da un nativo americano, il cherokee Sequoyah. Giusto, appropriato finché volete, ma non necessariamente vero. Il botanico austriaco Stephen Endlicher che creò il nome nel 1847 non ne spiegò l'etimologia; il collegamento con Sequoyah venne proposto per la prima volta nel 1856 in un articolo anonimo; benché presto messo in dubbio, si impose e nel secolo scorso divenne opinione comune. Nel 2018 un rigorosissimo saggio l'ho ridotto a mito, o se volete a fake news. Ma per noi è l'occasione di parlare di un grande linguista nativo e di tre meraviglie della natura. Ognuna con una storia speciale. 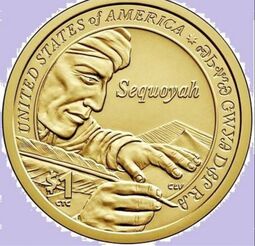 Da Sequoyah a Sequoia Nel 1831, il grande cacciatore di piante David Douglas scrive a William Jackson Hooker: "Ma la grande bellezza della vegetazione californiana è una specie di Taxodium, che dà alla montagna un aspetto peculiare, stavo per dire terribile, qualcosa che dice chiaramente che non siamo in Europa. Ho ripetutamente misurato esemplari di questo albero alti 270 piedi (= 82 metri circa) e con un diametro di 32 piedi (= 10 metri circa) a tre piedi dal suolo. Più in alto ne ho visti anche alti 300 piedi (= oltre 90 metri)". Gli alberi giganti che fanno provare a Douglas il terrore del sublime erano esemplari di Sequoia sempervirens, detta anche sequoia della California o sequoia costiera, in inglese redwood; appartiene proprio a questa specie Hyperion, l'albero più alto del mondo, un esemplare di 115,66 metri del Parco nazionale di Redwood. Il più alto, ma non il più massiccio. Questo secondo record spetta a Generale Sherman, un esemplare di un'altra specie di sequoie californiane, la sequoia gigante Sequoiadendron giganteum: alta "solo" 82,8 metri, ha un diametro massimo di 11 metri, un volume stimato di 1486,6 metri cubi e un peso stimato di 1910 tonnellate, che ne fanno il maggior essere vivente del pianeta per volume. A queste glorie della foreste americane l'intuizione di uno studioso o forse il caso sembrerebbe aver assegnato il più adatto dei nomi: il genere Sequoia - e di riflesso Sequoiadendron "albero sequoia" - prenderebbe il nome da un illustre nativo, il cherokee Sequoyah. Come scriverà il giornalista John D. Ross in un articolo comparso in The Los Angeles Times nel 1908, "Quale nome potrebbe essere più appropriato per il più grande degli alberi americani che quello di un esponente della prima razza americana?" Incominciamo dunque da lui, dal cherokee Sequoyah (trascritto anche Ssiquoya, Sikwayi, Se-quo-yah, See-quah-ya). Nato forse intorno al 1770 nella città cherokee di Tuckasegee (all'epoca in North Carolina, oggi in Tennessee), era figlio di una donna cherokee chiamata Wut-teh, figlia, nipote o sorella di un capo indiano; discussa è l'identità del padre (un mercante di pellicce meticcio, un venditore ambulante tedesco o un ufficiale dell'Armata continentale di origine scozzese?), che in ogni caso abbandonò moglie e figlio e non ebbe alcun ruolo nella sua vita. Più tardi, quando servì tra i cherokee alleati con l'esercito federale, egli si faceva chiamare George Guess, ma sappiamo che non parlava inglese, fu allevato dalla madre nelle tradizioni del suo popolo e non frequentò alcuna scuola. Le poche cose certe che sappiamo su di lui - molteplici sono le leggende poi fiorite attorno alla sua persona - si devono all'avvocato, scrittore e editore Samuel Lorenzo Knapp che lo intervistò nel 1828 con l'aiuto di due interpreti, mentre Sequoyah si trovava a Washington come membro di una delegazione del suo popolo. Spiccava in mezzo agli altri sia per il carisma, sia perché era l'unico a non indossare abiti europei, ma i tradizionali abiti cherokee. In gioventù dovette spostarsi in molti luoghi, fu cacciatore e guerriero, gestì una stazione commerciale, servì nel Reggimento di cherokee sotto il comando di Gideon Morgan; quando una malattia o una ferita lo privò dell'uso di un ginocchio, impedendogli di cacciare e combattere, divenne argentiere e fabbro di grandissima abilità e dedicò il suo tempo a risolvere un mistero su cui si interrogava da molti anni: come facessero i bianchi a comunicare con i "fogli volanti". Come egli stesso riferì a Knapp, fu forse intorno al 1810 che incominciò ad elaborare un sistema di scrittura per trascrivere la sua lingua. Dapprima pensò a immagini di uccelli e altri animali da associare a ciascuna parola o idea (si trattava dunque di pittogrammi o ideogrammi), ma presto capì che era un'idea poco pratica. Pensò allora di associare a ogni sillaba un simbolo arbitrario, inventando un sistema di 200 segni, poi ridotto a 86 caratteri; molti furono ripresi da un libro di ortografia, quindi riprendono la forma di lettere latine o greche, ma corrispondono a suoni affatto diversi. Il sistema, perfezionato intorno al 1821, è così efficace che sua figlia, una bimba di cinque anni, lo apprese con facilità; gli adulti invece rimanevano scettici. Sequoyah, convinto che la diffusione del suo sillabario fosse indispensabile per la sopravvivenza stessa del suo popolo, prese a viaggiare nelle riserve dell'Alabama dove vivevano i Cherokee per convincere i capi dell'utilità del suo sistema: a ciascuno di loro chiedeva di dire una parola, la trascriveva, poi chiamava la bambina perché la leggesse. Il successo dell'esperimento gli procurò un numero crescente di allievi, anche se molti non mancarono le diffidenze e i sospetti di stregoneria. Superate le ostilità iniziali, il sistema si diffuse rapidamente. Nel 1824 il Consiglio della Nazione Cherokee lo premiò con una medaglia d'argento. Lo stesso anno Sequoyah si trasferì in Arkansas e nel 1828 a Washington fu tra i firmatari del trattato che istituisce il territorio indiano (corrispondente all'attuale Oklahoma). E' in questa occasione che fu intervistato da Knapp. Nel 1829, Sequoyah si stabilì con la moglie e la figlia nell'attuale Sallisaw, in Oklahoma, dove ancora si conserva la sua capanna; cercò di svolgere un ruolo di paciere tra i Cherokee che si erano trasferiti qui all'inizio del secolo (gli Old Settlers) e i Cherokee occidentali, guidati dal capo John Ross; nel 1839 fu tra i firmatari dell'Atto di Unione tra le due frazioni che portò alla creazione di una nuova costituzione. Nel 1842, insieme a un figlio e a un compagno, andò in Messico per cercare di convincere i Cherokee che vi erano migrati a stabilirsi nel Territorio Indiano, ma nel corso di questo viaggio (tra il 1843 e il 1845) morì presso San Fernando de Rosas nello stato di Coahuila (Messico). Intanto il suo sistema era stato adottato ufficialmente dal suo popolo (1825). I Cherokee furono il primo gruppo indigeno ad avere una lingua scritta e a un alto numero di alfabetizzati (in proporzione molto maggiore rispetto agli statunitensi anglofoni). Alla fine dello stesso anno, la Bibbia e molti inni sacri vennero trascritti in cherokee. Nel 1826 per incarico del Consiglio della nazione Cherokee, George Lowrey e David Brown tradussero e stamparono otto copie delle leggi della Nazione. Nel 1828 incominciò ad essere stampato il Cherokee Phoenix, un quotidiano bilingue in inglese e cherokee. La notizia che un nativo aveva inventato dal nulla un alfabeto (o meglio un sillabario, trattandosi di una scrittura sillabica) si sparse presto in tutto gli Stati Uniti e trovò eco anche all'estero, dove fu d'esempio soprattutto ai missionari che dovevano affrontare il compito di creare sistemi di trascrizione di lingue fino ad allora prive di scrittura. Così, il missionario James Ewans si ispirò al sillabario cherokee per creare il Cree syllabics, il sistema usato per trascrivere le lingue degli indiani Cree del Manitoba e dell'Ontario; a sua volta, il Cree syllabics ispirò un sistema per trascrivere una lingua locale in Cina. Si calcola che il sillabario di Sequoyah sia all'origine di non meno di 21 sistemi usati per trascrivere oltre 60 lingue.  Puntando in alto: Sequoia Delle tre specie viventi della sottofamiglia Sequoioideae della famiglia Cupressaceae, quella con areale più vasto, e anche la prima ad essere nota agli europei è Sequoia sempervirens, la sequoia costiera o redwood, presente unicamente nelle montagne costiere sotto i 900 metri in una striscia lunga approssimativamente 750 km e larga 8-75 lungo la costa pacifica del Nord America, dall'Oregon meridionale alla Monterey Country in California. La prima "scoperta" sembra si debba alla Spedizione Portolá (14 luglio 1769-24 gennaio 1770) che esplorò l'Alta California; il cappellano e diarista della spedizione, il frate Juan Crespi, l'11 ottobre 1769 annota che il giorno prima, a cinque miglia dalla costa, a tre miglia nord dell'attuale Watsonville, gli spagnoli percorsero "basse colline ammantate di altissimi alberi di colore rosso, che ci erano ignoti". Perciò li chiamarono palo colorado, ovvero alberi rossi. Il primo a raccogliere campioni e semi del maestoso albero fu però Thaddäus Haenke, il botanico della spedizione Malaspina, che esplorò l'area intorno a Monterey nel 1791. Fu sicuramente dai semi da lui raccolti e presumibilmente inviati in Spagna dal suo collega Luis Née che nacquero i più antichi alberi di Sequoia sempervirens sul suolo europeo: un esemplare, oggi morto, identificato nel 1926 dal botanico californiano Jepson a Granada, e un boschetto ancora esistente presso la Casita del Principe all'Escorial. Durante la spedizione Vancouver (1791-1795), anche Archibald Menzies raccolse un campione in un luogo imprecisato della costa dell'America occidentale; fu su di esso che David Don si basò per la prima descrizione, pubblicata in A Description of the Genus Pinus di Aylmer Bourke Lambert (1824) con il nome Taxodium sempervirens. E qui entra in scena il secondo protagonista di questa storia, il botanico austriaco Stephen Endlicher, professore di botanica all'Università di Vienna tra il 1830 e il 1849 e rinomato tassonomista. Nel 1847 in Synopsis Coniferarum incluse la riclassificazione di varie specie trattate da Lambert, tra cui appunto Taxodium sempervirens, che assegnò al nuovo genere Sequoia, insieme a una seconda specie S. gigantea, sulla base delle descrizioni di Douglas e Hooker (che oggi sappiamo non riferirsi all'attuale Sequoiadendron giganteum, ma ugualmente a Sequoia sempervirens). Purtroppo Endlicher (morto nel 1849) non spiegò l'etimologia del nuovo genere. Il primo collegamento tra il genere Sequoia e il cherokee Sequoyah compare nel 1856, in un articolo anonimo pubblicato in The Country Gentleman’s, una rivista di agricoltura fondata nel 1852; l'autore anonimo scrive: "Da dove viene questo nome? E' un fatto intenzionale o una coincidenza che questo albero americano porti il nome di un americano che merita tanto onore? L'onore deve essere intenzionale; ma se non lo fosse, la coincidenza è assai gratificante". La congettura dell'anonimo viene ripresa nel 1868 dal geologo Josiah Dwight Whitney nel capitolo della ricognizione geologica della California dedicato alle sequoie del Yosemite Book , e diventa un fatto accertato: "Il genere è stato nominato in onore di Sequoia o Sequoyah, un indiano cherokee [...] meglio noto con il nome inglese George Guess, noto al mondo per la sua invenzione di un alfabeto e della lingua scritta per la sua tribù". E aggiunge che Endlicher avrebbe conosciuto l'attività di Sequoyah proprio grazie all'articolo pubblicato su The Country Gentleman (il che è impossibile, visto che, come sappiamo, uscì sette anni dopo la sua morte). L'opinione di Whitney, ripresa dall'autorevole botanico Engelmann, nel corso dell'Ottocento era tutt'altro che universalmente condivisa. Dopo averne discusso con Asa Gray, che aveva lungamente studiato questa specie, nel 1879 John Gill Lemmon conclude: "Il nome generico Sequoia è stato dato da Endlicher perché questo genere è un solitario seguace (dal latino sequi, "seguire") di vaste foreste colossali. Altri hanno detto che deriva da Sequoyah, il celebre indiano Cherokee; ma si tratta senza dubbio un'idea tardiva, indegna di essere mantenuta". Nonostante queste obiezioni, l'idea invece rimase in voga nell'intero ventesimo secolo, ormai accreditata come versione ufficiale, ripresa senza discussione in fonti di ogni tipo. Il dibattito si riaccese verso la fine del secolo ed è diventato assai vivace solo di recente, grazie a un articolo di Gary D. Lowe che nel 2012 ha rilanciato su nuove basi il collegamento con il latino sequi; nel 2017 gli ha risposto Nancy E. Muleady-Mecham, con un'articolata argomentazione che riafferma l'etimologia tradizionale e la sostiene con una ricca serie di collegamenti indiretti. La risposta di Lowe è stata un ampio saggio, pubblicato nel 2018 con l'eloquente titolo Debunking the Sequoia honoring Sequoyah myth, "Sfatare il mito che Sequoia onori Sequoyah", in cui letteralmente demolisce l'argomentazione di Muleady-Mecham pezzo per pezzo, dimostrando l'inconsistenza e/o la fallacia logica di tutti i suoi argomenti a sostegno; la conclusione è perentoria: "L'attribuzione del nome del genere Sequoia in onore dell'uomo Sequoyah è una tradizione inventata; un contributo silenzioso alla autorappresentazione dell'America come nazione della natura". Ho letto puntigliosamente entrambi i contributi e, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che le argomentazioni di Lowe sono più fondate e convincenti di quelle di Muleady-Mecham; il punto più debole rimane forse proprio il collegamento con il latino sequo-r, spiegato in base a un'ipotetica sequenza (ovvero serie di Fibonacci) del numero di semi, in cui Sequoia segue Taxodium, e precede altre specie (che però nel 1847 erano ipotetiche). Ma che Endlicher sapesse di Sequoyah e gli abbia dedicato il genere è davvero più che improbabile.  Una questione di volume: Sequoiadendron Il secondo tipo di sequoia, la sequoia gigante Sequoiadendron giganteum, ha un'areale estremamente ristretto: vive unicamente sulle pendici occidentali della Sierra Nevada in California, in 68 popolazioni in tutto, in un'area totale di 144,16 km2. Le popolazioni variano per dimensioni e numero di alberi: si va dal Redwood Mountain Grove, con 20.000 alberi adulti su un'estensione di 1240 ettari, a piccoli boschi di non più di sei esemplari. E sono proprio questi rari giganti le sequoie per antonomasia, quelle che probabilmente associamo a questo nome. Ovviamente gli indigeni le conoscevano da sempre, ma gli europei e la scienza le scoprirono molto dopo la specie più costiera, proprio per la loro maggiore rarità e per la posizione più interna. La prima menzione, del 1833, si trova nel diario dell'esploratore J. K. Leonard, che non cita alcuna località precisa ma che probabilmente passò attraverso il Calaveras Grove. Più preciso il racconto del cacciatore Augustus T. Dowd che nella primavera del 1852 inseguendo un orso capitò nei boschi ora noti come North Grove nel Calaveras State Park. Vedendo quegli alberi monumentali non credeva ai suoi occhi, e nessuno dei suoi compagni inizialmente volle credergli finché non li portò a vederli di persona; ma ben presto la notizia si diffuse, e purtroppo iniziarono subito anche gli abbattimenti: il primo albero visto da Dowd, ribattezzato Discovery Tree, fu abbattuto già nel 1853. Lo stesso anno la specie entrava nella letteratura scientifica grazie al botanico inglese John Lindley, che la descrisse per primo e la battezzò Wellingtonia gigantea, in onore del duca di Wellington (il vincitore di Waterloo), morto l'anno precedente. Per gli americani, uno scandalo: quel gigante americano doveva celebrare un altrettanto grande eroe d'America, e l'unico nome adatto era Washingtonia. Questo almeno sostenne l'anno dopo un certo Andreas Peter Winslow che proposte di ribattezzarla Washingtonia californica. Ma la botanica segue altre vie e altre regole: Wellingtonia è un nome illegittimo, perché era già stato usato per un'altra specie (W. arnottiana, oggi Meliosoma arnottiana, famiglia Sabiaceae) e pure Washingtonia è inaccettabile perché Winslow, che non era un botanico, nel pubblicarlo non si attenne alle regole appropriate. A superare il problema, per altro, aveva già pensato il francese Joseph Decaisne che assegnò anche questa specie al genere Sequioia, recuperando il nome di Endlicher S. gigantea (che come abbiamo visto in realtà era un sinonimo di S. sempervirens). Le differenze tra le due specie erano però tali da far ritenere andassero assegnate a generi diversi. Nel 1907 Carl Ernst Otto Kuntze la attribuì al genere fossile Steinhauera, per altro dubbio, dato che ne è noto solo il polline; la soluzione definitiva venne nel 1939 da John Theodore Buchholz, che separò le due specie creando per la sequoia gigante il nuovo genere Sequoiadendron, come S. giganteum. Approfittiamone anche noi per sintetizzare le principali differenze tra di due generi (e le due specie, che è la stessa cosa, trattandosi di due generi monospecifici). Oltre alle differenze di altezza e volume di cui abbiamo già parlato, notiamo che Sequoia sempervirens ha tronco dritto e snello, con corteccia marrone cioccolata più opaca, Sequoiadendron giganteum tronco conico e massiccio con corteccia marrone rossastro più luminosa. Molto diverso il fogliame, in entrambi i casi sempreverde: quello di Sequoia sempervirens è costituito da aghi piatti e duri, disposti lungo i rami, in un modo che ricorda quello del tasso, mentre Sequoiadendron gigeanteum ha aghi corti, appuntiti che si dispongono a spirale attorno ai rami, richiamando piuttosto il ginepro. Quanto alle pigne, quelle della gigantessa hanno dimensioni triple rispetto a quelle della sequoia costiera; hanno forma ovale, richiedono due anni per maturare, quindi persistono sui rami almeno sei mesi; quelli della specie costiera sono arrotondati, si formano in primavera e maturano in autunno per poi cadere. Entrambe le specie sono presto diventate ricercatissime piante da giardino. Esemplari notevoli (anche se molto più piccoli delle millenarie piante americane) si trovano anche nel nostro paese. I più antichi sono ovviamente di Sequoia sempervirens e risalgono agli anni '40 dell'Ottocento, quando arrivarono nel Parco della Burcina nel Biellese (Piemonte) e all'Arboreto Siemoni in Casentino (Toscana). Conosciamo con precisione la data d'impianto dei due esemplari della Burcina, che furono piantati nella primavera del 1848 per celebrare la promulgazione dello statuto albertino. Venne piantata presumibilmente intorno al 1853 la più alta d'Italia (54 metri), che si trova nel parco di Sammezzano nel comune di Reggello (Firenze) e ha due tronchi gemelli. I primi esemplari di Sequoiadendron giganteum, commercializzati attraverso l'Inghilterra ovviamente come Wellingtonia gigantea, sembra siano siano arrivati quasi subito dopo la scoperta, o più probabilmente verso la fine degli anni '50 o i primi anni '60 dell'Ottocento. Due dei più imponenti si trovano a Roccavione (Cuneo), superano abbondantemente i cinquanta metri d'altezza e hanno raggiunto un diametro di 11 metri. Presumibilmente furono piantati intorno al 1902, data di costruzione della Villa dei Conti Salazar. E' degno di menzione per la sua storia tragica e commovente anche l'esemplare di Longarone: ha un'età stimata di 170 anni (sarebbe dunque stato introdotto a ridosso della scoperta) e in una ferita longitudinale di 5 metri reca le tracce del disastro del Vajont che il 9 ottobre 1963 devastò la valle e distrusse più di 1900 vite.  Un fossile vivente: Metasequoia Non è finita; ci sono ancora un genere e una storia da raccontare. E dall'America ci spostiamo in Cina. Fin dall'Ottocento erano note specie fossili imparentate con le sequoie, che nel Giurassico dovettero formare vaste foreste in Europa e in Asia. Una di queste specie fossili fu scoperta nel 1939 dal botanico e paleontologo giapponese Shigeru Miki dall'Università di Kyoto che due anni dopo la pubblicò con il nome Metasequoia ("simile a Sequoia); risalente ad almeno 150 milioni di anni fa, doveva essersi estinta con i dinosauri, che un tempo scorrazzavano sotto le sue chiome. Per una coincidenza quasi incredibile, nell'inverno dello stesso 1941 il botanico cinese Gan Duo (noto anche come Toh Kan) durante una spedizione nelle province del Sichuan e dell'Hubei nel villaggio di Moudao nella contea di Lichuan (Hubei) osservò un'enorme conifera; faceva parte di un santuario e i locali lo chiamavano Shuǐshān, ovvero "abete d'acqua". Vista la stagione, era senza foglie, e Gan non raccolse alcun esemplare. Nel 1942, un altro botanico, Zhan Wang, visitò il villaggio e raccolse dei campioni; pensò che appartenessero a una specie già nota, Glyptostrobus pensilis (un'altra rara Cupressacea della Cina subtropicale). Orami si era nel pieno della guerra e solo nel 1945 egli poté mostrare le sue raccolte a un terzo botanico, Wan-Chun Cheng, una delle maggiori autorità mondiali della tassonomia delle Gimnosperme. Cheng capi subito che si trattava di una nuova specie, e inviò un campione a H.H. Hu, il direttore dell'istituto Fan di Pechino (il maggiore istituto botanico della Cina). Nonostante il caos della guerra e l'ostilità tra Cina e Giappone, Hu conosceva il lavoro di Miki e capì che la pianta viva apparteneva allo stesso genere che il collega giapponese aveva battezzato Metasequoia. Dopo altri studi e verifiche, nel 1948 Hu e Cheng pubblicarono insieme la nuova specie sul Bollettino dell'istituto Fan, battezzandola Metasequoia glyptostroboides. Chiesero poi l'aiuto dell'Arnold Arboretum dell'Università di Harvard, che lo stesso anno organizzò una spedizione di raccolta di semi, che, raccolti a migliaia, furono poi distribuiti a università, orti botanici e arboreti di tutto il mondo, Forse senza questi eventi provvidenziali, il fossile vivente sarebbe andato perduto. In natura è infatti rarissimo. Nel 2007 ne sono stati recensiti 5,371 esemplari, principalmente nella contea di Lichuan, con popolazioni minori nelle contee di Shizhu nel Chongqing e di Longshan nello Hunan. Molti esemplari erano già andati perduti per la trasformazione della piana alluvionale in risaie, ma dopo la scoperta l'albero ritrovato è diventato oggetto di venerazione e orgoglio nazionale. Sono state varate leggi per proteggerlo ed è stato largamente piantato in giardini e parchi e lungo le strade cinesi; ma i fragili ecosistemi dove viveva ormai quasi non esistono più e in natura è sempre più raro e minacciato. Spogliante e di dimensioni più contenute rispetto alle cugine di California, la metasequoia può comunque raggiungere un'altezza di circa 37 metri. Ha foglie aghiformi piatte, dritte o leggermente incurvate, opposte lungo i rami. Molto decorativa e di crescita rapida (anche un metro all'anno nei primi anni di vita), è anch'essa molto ricercata come pianta ornamentale ed è utilizzata anche come bonsai. Anche in Italia è giunta nel secondo dopoguerra; esemplari storici sono presenti nel Giardino Botanico Borromeo, nell'Isola Madre del Lago Maggiore e a Borghetto di Valeggio sul Mincio, che furono tra i beneficiari dei semi inviati dall'Arnold Arboretum. Moglie di un alto funzionario civile e militare, la contessa scozzese Christian Dalhousie seguì il marito prima in Canada poi in India. Forse per lei, come per molte dame del suo ceto, all'inizio la botanica fu solo un piacevole passatempo, ma presto divenne una missione, il suo modo di contribuire al progresso scientifico e alla diffusione della cultura. Corrispondente di William Jackson Hooker, fece parte di un singolare gruppo di signore che collaborarono attivamente alla raccolta di piante canadesi per la sua Flora boreali-americana; al contrario delle sue amiche, per lei però non fu un episodio. Le sue raccolte indiane furono così importanti da guadagnarle l'ingresso nella Società botanica di Edimburgo, unica donna del tempo a farne parte. La ricordano varie piante indiane e malesi e il genere Dalhousiea.  Quattro signore a caccia di piante Tra il 1829 e il 1840 William Jackson Hooker, all'epoca direttore dell'orto botanico di Glasgow, pubblicò la monumentale Flora boreali-americana, un'opera capitale per la conoscenza delle piante dell'America settentrionale. Si basò soprattutto sulle piante raccolte durante la seconda spedizione Franklin (1825-26), ma si servì anche degli esemplari e delle informazioni forniti da circa 120 raccoglitori e collaboratori: naturalisti e cacciatori di piante, ma anche militari, funzionari coloniali, persone comuni. Per preparare al compito quelli tra loro che non avevano una formazione come naturalisti (ed erano la maggior parte), predispose addirittura delle istruzioni su come raccogliere ed essiccare correttamente gli esemplari (Directions for Collecting and Preserving Plants in Foreign Countries: On Preserving Plants for a Hortus Siccus, 1828). Tra i più entusiasti raccoglitori canadesi di Hooker spiccano i nomi di quattro signore: Christian Broun Ramsay (più nota come Lady Dalhousie), Anne Mary Perceval, Harriet Sheppard e Mary Brenton. Tre di loro erano amiche intime e vivevano a Quebec City, all'epoca il centro amministrativo delle province orientali del Nord America britannico: Christian Ramsay (1786-1839) era la moglie di lord Dalhousie, prima vice governatore della Nuova Scozia, poi governatore generale del Nord America britannico; Anne Mary Flowers Perceval (1790-1876) era la moglie del direttore delle dogane del porto di Quebec; Harriet Sheppard (1786-1858) era la moglie di un facoltoso mercante di legname appassionato di scienze naturali. La quarta, Mary Brenton (1792-1884), viveva a Terranova, dove il padre era giudice della Corte Suprema; era l'unica a non far parte del gruppo di amiche, ma apparteneva alla stessa classe sociale, l'élite costituita dagli alti funzionari e dai facoltosi mercanti britannici. Come vedremo meglio tra poco, Hooker corrispondeva già con lady Dalhousie, ma la prima ad essere reclutata formalmente fu Anne Mary Flower Perceval. Non solo è citata in Flora boreali-americana non meno di 150 volte, ma fu lei a coinvolgere nell'avventura le due amiche e altri conoscenti. I coniugi Perceval erano bel noti nella vita mondana e culturale della colonia; il marito Michael Henry era figlio dell'ex primo ministro britannico Spencer Perceval, mentre la moglie era nata in una ricca famiglia di mercanti londinesi; molto apprezzati erano i pranzi e le serate danzanti che si tenevano nella loro bella casa, Spencer Wood, al centro di una grande tenuta. Anne Mary era una "castellana elegante", una dama dalle maniere squisite, ma anche una madre di famiglia con dieci figli che cercava di educare secondo i metodi più all'avanguardia. Fu probabilmente pensando alla loro educazione che incominciò ad interessarsi di botanica, approfittando della ricchezza di piante che poteva raccogliere nella sua stessa tenuta. Avviò un erbario, appassionandosi soprattutto di crittogame, e incominciò a corrispondere con vari botanici americani, tra cui John Torrey. Fu proprio quest'ultimo nel 1824 a raccomandarla a Hooker: la signora Perceval - scrisse - era un'eccellente botanica, che avrebbe potuto essergli utile spedendogli piante essiccate; ma era anche una dama dell'alta società con vasti contatti che poteva aiutarlo coinvolgendo altre persone. Tra Hooker e Perceval iniziò un scambio epistolare; la donna accettò con entusiasmo di contribuire al progresso dell'amabile scienza delle piante, coinvolgendo anche i suoi bambini di varie età. Per venire incontro alle sue esigenze pedagogiche Hooker le inviò una copia delle sue Botanical Illustrations (1822), un manuale che aveva scritto per la classe iniziale dei suoi studenti di botanica all'università di Glasgow. Perceval, che già utilizzava come punto di riferimento Flora Americae septentrionalis di Pursh, di cui apprezzava la chiarezza didattica, ne fu deliziata. Già nel giugno 1825 fu in grado di spedire a Hooker un primo invio, assicurandogli che presto ne sarebbe seguito un altro, grazie al coinvolgimento di diversi amici. A ottobre dello stesso anni gli scriveva: "Ho sguinzagliato i miei amici in tutte le direzioni. I signori Sheppard si occuperanno del Quebec, lady Dalhousie di Sorel e Montreal, e io di quello che resta". Tra il 1825 e il 1826 la signora Perceval, insieme ai figli, trascorse l'inverno a Filadelfia, dove incontrò il botanico Lewis von Schweinitz, cui diede vari esemplari tra cui Pterospora andromedea, un'ericacea rara che cresceva nel sottobosco di pini di Spencer Wood, e il medico e botanico William Darlington cui donò un album di piante canadesi. Avrebbe continuato a collaborare attivamente con Hooker fino al 1828, quando rimase improvvisamente vedova e lasciò il Canada. Non risultano sue raccolte dopo questa data. Delle amiche reclutate da Anne Mary Perceval, l'acquisto più produttivo fu indubbiamente Harriet Campbell Sheppard, anche perché, al contrario di Perceval e Ramsay, rimase in Canada fino alla fine dei suoi giorni. Le sue raccolte si estendono per tutti gli anni '20 e '30 e in Flora boreali-americana è citata 144 volte; molte delle piante da lei raccolte appartengono a generi "difficili", ovvero di classificazione problematica. Anche suo marito era interessato alla botanica e la coppia inviò esemplari non solo a Hooker, ma anche a Torrey e Asa Grey. Anche i loro bambini furono coinvolti nelle raccolte, con gli stessi intenti pedagogici di Anne Mary Perceval, che del resto era un'amica intima della coppia e loro vicina di casa. Sappiamo che non di rado erborizzavano insieme. Negli anni '20, William e Harriet Sheppard furono in prima fila nelle istituzioni che promuovevano la diffusione della cultura e della conoscenza scientifica in Canada, come la Literary and Historical Society of Quebec; sorta nel 1824 sotto il patronato di lord Dalhousie, divenne anche una tribuna dove comunicare le loro ricerche. Tuttavia, contrari all'esclusivismo della LHSQ, che accettava solo membri della ricca élite anglofona, nel 1827 furono tra i fondatori della più democratica Society for the Encouragement of Sciences and the Arts, che era aperta a anglofoni e francofoni e incoraggiava la partecipazione femminile. Harriet Sheppard pubblicò anche diversi contributi, tra cui una memoria sulle conchiglie. Già anziana, nel 1864 fu invitata a parlare alla conferenza annuale della Montreal Natural History Society come "una dei pionieri della storia naturale in questo paese". Ne approfittò per fare l'elogio della sua vecchia amica lady Dalhousie. Prima di occuparci di lei (la vera protagonista di questo post), ancora due parole sulla quarta raccoglitrice di Hooker, Mary Brenton. Alla fine del 1829, il botanico scrisse a lady Dalhousie lamentando che rimaneva scoperta la flora dell'estremità orientale dall'America britannica. Lady Dalhousie chiese al marito di coinvolgere ufficialmente i governatori del New Brunswick e di Terranova. Fu così che fu individuata Mary Brenton, le cui raccolte si estendono dal 1830 al 1838 circa. In Flora Boreali-Americana è citata 102 volte per piante sia native sia introdotte. Accompagnando il padre nei suoi doveri d'ufficio, poté viaggiare parecchio. Un'alta percentuale delle sue raccolte è costituita da piante boreali, molte delle quali provengono da stagni e paludi. Alcune sono rare, come Halenia brentoniana (oggi H. deflexa subsp. brentoniana), così denominata da Hooker in suo onore. Alla ricerca di piante "nuove e rare" in Canada e in India Ma è ora di parlare di lady Dalhousie. Nata Christian Broun, discendeva da una nobile famiglia scozzese tradizionalmente impegnata in campo legale. Diciannovenne si sposò con George Ramsay, ottavo conte di Dalhousie, un militare che aveva combattuto sotto Wellington nelle guerre napoleoniche. Tornata la pace, anche per far fronte alle ingenti spese della ristrutturazione dell'amato Dalhousie Castle, egli accettò di entrare nell'amministrazione civile e nel 1816 fu nominato vicegovernatore della Nuova Scozia. La moglie e i tre figli lo accompagnarono in Canada, stabilendosi ad Halifax. Entrambi i coniugi coltivavano interessi culturali e promossero il progresso della cultura scientifica. Lord Dalhousie fondò il Dalhousie College di Halifax, ora Dalhousie University; inoltre acquistò una vasta proprietà dove introdusse miglioramenti agricoli. Lady Dalhousie faceva da padrona di casa, presiedeva alle occasioni mondane e accompagnava il marito nei frequenti viaggi imposti dai suoi doveri. Era una grande lettrice, di vasta cultura, molto spiritosa (come si evince sia dalle sue lettere, piene di humor, sia dalle divertenti caricature della buona società di Halifax che disegnò in quegli anni), ma anche seria e determinata. Una serietà e una metodicità ben riconoscibili nell'erbario che iniziò in questi anni, in cui luogo e data di raccolta sono indicati con precisione, le piante sono accompagnate da indicazioni sull'habitat e spesso da schizzi ad acquarello e le specie sono identificate con notevole precisione sulla scorta di Flora Americae septentrionalis di Pursh. Ben presto le sue preferite divennero le felci. Iniziò anche a spedire in Scozia semi e piante vive per il giardino di Dalhousie Castle. Nel 1820 lord Dalhousie fu promosso Governatore generale dell'America britannica e la famiglia si trasferì a Quebec City. La sede ufficiale era Chateau St. Louis, nella città alta, ma la residenza preferita divenne la tenuta di Sorel, una cittadina situata a sud-est di Montreal. Era una zona ricca di piante che permise a lady Dalhousie di raffinare le sue conoscenze botaniche. L'erbario crebbe rapidamente. Nel 1823, tra Sorel e Montreal, raccolse 328 piante, alcune delle quali rare. Nell'estate del 1826, tra Sorel, Quebec City, l'Ottawa River e il Gaspé, ne raccolse circa 300. Lady Dalhousie entrò in contatto con Hooker ancora prima che questi lanciasse il suo appello per Flora boreali-americana. Nel 1823 gli inviò alcune scatole con varie rarità raccolte nelle vicinanze di Montreal, soprattutto orchidee. Lo stesso anno egli la raccomandò all'esploratore artico John Richardson come "una botanica molto zelante" e nel suo saggio On the Botany of America del 1825 la collocò in prima fila tra coloro che maggiormente stavano contribuendo alla conoscenza della flora canadese. Dunque accolse volentieri l'invito dell'amica Anne Mary Perceval. Tuttavia, rispetto a lei e alle altre due raccoglitrici di Hooker, il suo contributo quantitativo a Flora boreali-americana si riduce a una cinquantina di specie, soprattutto orchidee e felci: infatti era sua ambizione contribuire con piante nuove o rare. Insieme al marito, progettava anche di creare un orto botanico in un'isola del San Lorenzo, ma ostacoli politici ne impedirono la realizzazione. Nel 1824 la famiglia tornò momentaneamente in patria e lady Dalhouisie diede mano alla ristrutturazione del giardino di Dalhousie Castle; lord Dalhousie era intenzionato a dare le dimissioni e ad occuparsi della sua proprietà in Scozia, ma le finanze familiari furono rovinate dal fallimento del suo agente. I Dalhousie dunque tornarono in Canada, rimanendovi fino al 1828. Nel 1827 lady Dalhousie presentò alla Literary and Historical Society of Quebec (di cui era cofondatrice con il marito) circa 400 piante canadesi; il catalogo fu pubblicato nel 1829 nel primo volume delle Transactions della società. Nel frattempo, lord Dalhousie era stato nominato comandante in capo dell'esercito britannico in India. Nel luglio 1829 marito e moglie partirono per la nuova destinazione; durante il viaggio, lady Dalhousie approfittò degli scali a Madeira, Sant'Elena e al capo di Buona Speranza per incrementare le sue raccolte. Lo stesso fece durante il soggiorno indiano, che si protrasse fino al 1834. Anche se si definiva a tyro "una tirocinante, una principiante", e all'inizio fu sconcertata da una flora che appariva tanto diversa da quella scozzese o canadese, era ormai una botanica ben più che dilettante. Le raccolte del periodo indiano ammontano a non meno di 1200 esemplari; quelle più significative le fece a Simla e a Penang. In una spiritosa lettera del febbraio 1833 a Hooker riassume i suoi viaggi, scusandosi della scarsa qualità e quantità delle piante raccolte in Malesia: il loro soggiorno è durato solo sei settimane ed è coinciso con la stagione delle piogge, rendendo impossibile seccare le piante a regola d'arte. Racconta poi del viaggio a Simla: dopo aver risalito il Gange per 700 miglia, hanno percorso le pianure indiane per 800 miglia a dorso d'elefante: viaggiare a tanti piedi d'altezza non è molto pratico per botanizzare! A Simla si sono fermati sette mesi, e lì davvero ha trovato un paradiso botanico, ma - aggiunge modestamente - non c'era nessuno ad aiutarla e potrebbe aver identificato scorrettamente molte piante. In realtà, era un'abile raccoglitrice con occhi esercitati per individuare piante nuove e rare. Grazie a lei molte andarono ad arricchire l'orto botanico di Calcutta. Del suo vasto ed eccellente erbario poté giovarsi ancora il figlio di Hooker Joseph Dalton per la sua Flora Indica. Hooker padre volle manifestare la sua gratitudine dedicandole il volume del 1833 del Curtis Botanical Magazine "per gli essenziali servizi che, nonostante i suoi vari doveri in Canada e in Bengala, ha reso alla botanica con le sue estese collezioni e l'introduzione di molte specie interessanti nei giardini di questo paese". Tornata definitivamente in Scozia nel 1834, donò le sue collezioni all'orto botanico di Edimburgo e divenne membro onorario della Società botanica della città, la sola donna ad esservi ammessa. Fu presto una figura riconosciuta della società cittadina e dedicò i suoi ultimi anni soprattutto al giardino di Dalhousie Castle, dove aveva creato un felceto con le piante raccolte durante i suoi viaggi. Era sua intenzione descriverle in un volume, come annuncia in una lettera a Hooker; la morte improvvisa nel 1839 le impedì di realizzare il progetto. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Omaggi floreali Diverse piante ricordano la nostra raccoglitrice "ai quattro angoli del mondo" (l'espressione è sua). La maggior parte delle piante che portano o hanno portato il suo nome nell'eponimo furono raccolte durante il "piovoso" soggiorno a Penang: le felci Asplenium dalhousiae e Pteris dalhousiae, la licopodiacea Huperzia dalhousieana, la spettacolare orchidea Dendrobium dalhousieanum (oggi D. pulchellum). Fu raccolta invece a Simla la bella Acantacea Strobilanthes dalhousiana. Le è stato dedicato anche il coloratissimo beccolargo codalunga, un passeriforme dell'Himalaya, Psarisomus dalhousiae; ne vediamo un esemplare impagliato nell'unico ritratto ufficiale della contessa: austeramente vestita di nero, ostenta un cipiglio severo che non ci aspetteremmo leggendo le sue lettere piene di ironia. Lo splendido Rhododendron dalhousiae non è invece dedicato a lei, ma a sua nuora Susan, moglie dell'unico figlio sopravvissuto, James Broun-Ramsay, marchese di Dalhousie. Quest'ultimo alla fine del 1847 fu nominato governatore generale dell'India e, insieme alla moglie, raggiunse la sua sede viaggiando sulla stessa nave che portò in India Joseph Dalton Hooker. Il botanico divenne buon amico della coppia e, grato dei molti aiuti ricevuti dal governatore durante la sua spedizione indiana, dedicò la bella pianta a lady Susan. Lady Christien è infine ricordata dal genere Dalhousiea (famiglia Fabaceae). Roxburgh nelle foreste del Bengala aveva raccolto un rampicante che denominò Podalyria bracteata, ma Robert Brown osservò che non poteva appartenere a quel genere. Robert Graham, professore di botanica di Edimburgo e membro eminente della Edinbourgh Botanical Society, la attribuì a un genere proprio che denominò appunto Dalhousiea. Si tratta di un piccolo genere con areale disgiunto, che comprende due sole specie: D. africana, che vive nell'Africa occidentale tropicale, e D. bracteata, diffusa nell'Himalaya orientale, in Bengala, in Assam e in Myanmar. Entrambe vivono nelle foreste tropicali umide. D. africana è una liana, mentre D. bracteata è un arbusto sarmentoso o una rampicante, con infiorescenze terminali di fiori bianco neve. Le foglie fresche sono usate in impiastri, mentre nella comunità Tagin dell'Arunachal Pradesh pezzi di corteccia trovano uso in rituali divinatori. A metà Settecento, dopo quasi un secolo di confronti armati con l'Inghilterra, in Francia i grandi alberi, indispensabili per le costrizioni navali, incominciano a scarseggiare. Ne è assai preoccupato l'abate Nolin, il direttore dei vivai reali, tanto più che la perdita del Canada ha chiuso anche quella fonte di rifornimento. E' necessario ripopolare in fretta le foreste francesi con alberi dalla crescita veloce ma dal legno inattaccabile, come hanno dimostrato essere diverse specie nordamericane. I rivali inglesi lo fanno da almeno un secolo, ma adesso che le loro 13 colonie - con l'aiuto determinante degli amici francesi - hanno conquistato l'indipendenza, perché non approfittarne per mandare nei neonati Stati Uniti un esperto di silvicoltura a fare incetta di semi e alberi? E, guarda caso, c'è la classica persona giusta al momento giusto: il "botanico del re" André Michaux ha una grande pratica di coltivazione di alberi esotici ed è appena tornato da un viaggio in Persia in cui ha dimostrato di non avere paura di nulla e di essere un instancabile cacciatore di piante dall'occhio di falco. E così nel 1785 André Michaux e il figlio quindicenne François André partono per gli Stati Uniti, dove rimarranno dieci anni, prima al servizio del re, poi di una repubblica di cui condividono gli ideali di libertà, eguaglianza e fratellanza, ma da cui presto non riceveranno più un franco. Michaux padre fonda due vivai e percorre instancabile gran parte degli Stati Uniti, spingendosi anche in Canada e nella Florida ancora spagnola. La fa quasi sempre da solo, per lo più a piedi, in modo spartano. Sulle piante americane, e in particolare sugli amati alberi, presto ne sa più di tutti. Vivaista dei due mondi, manda in Francia una stupefacente quantità di piante, ma arricchisce anche i giardini americani di tante specie esotiche. Il suo libro sulla flora dell'America nord orientale farà testo per molti anni, così come quello di suo figlio sugli alberi americani. La pianta che lo celebra però non viene dall'America, ma dal Medio Oriente.  Da Versailles al mar Caspio André Michaux (1746-1801) è nato nel parco di Versailles e se un evento tragico non avesse sconvolto la sua vita forse sarebbe rimasto per tutta la vita fattore reale, come lo era suo padre prima di lui. La famiglia gestisce la fattoria di Sautory e André, che ha potuto frequentare la scuola solo quel tanto che basta a imparare a leggere, scrivere e far di conto, lavora al fianco del padre fin da bambino. Alla sua morte, gli subentra come fattore insieme al fratello, ma nel 1770 sua moglie muore di parto dando alla luce l’unico figlio François André. Per André la vita non ha più senso. A sollevarlo dalla depressione è uno dei suoi vicini, Louis Le Monnier, professore di botanica del Jardin du roi, che gli fa scoprire la coltivazione di piante esotiche. Michaux fa esperimenti di acclimatazione a Sautory e incomincia a frequentare le lezioni di Antoine-Laurent de Jussieu al Trianon. Ha trovato la sua strada; si trasferisce a Parigi a studiare al Jardin du roi e nel 1779 ottiene il brevetto di «botanico reale». Il suo desiderio più ardente è viaggiare. Quell'anno, viene inviato ai Kew Gardens a studiarne le serre, quindi partecipa insieme ad André Thouin a una spedizione in Alvernia organizzata e finanziata da Lamarck. Nel 1780, da solo, va a caccia di piante nei Pirenei francesi e spagnoli. Sogna viaggi più esotici e quando viene a sapere che il nuovo console a Bassora, Jean-François Rousseau, cugino del filosofo, sta per partire per la Persia si unisce al suo seguito con la missione di raccogliere piante belle, utili e interessanti per i giardini di Maria Antonietta al Trianon e il Jardin du roi. Lasciata la Francia nel febbraio 1782, sbarcano ad Alessandretta e, dopo un soggiorno di qualche mese ad Aleppo, si uniscono a una carovana che a ottobre li porta a Bagdad, dove trascorrono l’inverno. Quindi Michaux saluta il console con l’intenzione di raggiungere l’impero persiano; sulla strada per Bassora è fatto prigioniero da una tribù in rivolta. Liberato, può finalmente continuare il suo viaggio visitando metodicamente la Persia, da Shiraz a Persepoli, da Isfahan a Julfa e fino alle rive del Caspio. Dopo un viaggio di tre anni, rientra in Francia nel giugno 1785 con più di quattrocento specie di piante. Tra di esse, Rosa persica, raccolta su un’alta montagna tra Shiraz e Isfahan, l’olmo del Caucaso Zelkova carpinifolia, il noce del Caucaso Pterocarya fraxinifolia e la pianta che oggi porta il suo nome, Michauxia campanuloides, trovata sulle montagne della Siria occidentale. Riporta anche manoscritti, medaglie, reperti archeologici, tra cui un kudurru babilonese, oggi conservato al Cabinet des medailles della Biblioteca nazionale e noto come "sasso di Michaux". Appena tornato, vorrebbe ripartire, magari di nuovo per l'Oriente, ma il ministero gli propone una meta totalmente diversa: gli Stati Uniti. Il direttore dei vivai reali, l'abate Nolin, preoccupato per il depauperamento delle foreste francesi, ha chiesto di inviare in America una missione a caccia di piante e Michaux è il candidato ideale. Così, appena tre mesi dopo il suo ritorno, riparte. La Francia è il principale alleato dei neonati Stati Uniti, che ha sostenuto attivamente nella guerra d’indipendenza da poco ufficialmente conclusa con la pace di Parigi (settembre 1783). Dunque in America Michaux può contare su buoni amici. Benjamin Franklin era vissuto molti anni tra Parigi e Versailles, diventando una figura di primo piano della società parigina; Thomas Jefferson, che lo aveva sostituito come ambasciatore, era di casa nel Jardin du roi, era spesso ospite di Buffon e aveva stretto una duratura amicizia con il capo giardiniere André Thouin.  Alberi d'America Dunque il viaggio può essere organizzato con la massima rapidità. L’abate Nolin consulta i cataloghi degli orticultori americani e redige una lista delle piante più desiderabili. Michaux si imbarca con il figlio quindicenne François André, il giardiniere Paul Saunier (un altro allievo di Thouin) e un servitore e a novembre sbarca a New York. Nonostante il tempo pessimo e una lingua poco familiare, riesce quasi subito a mettere insieme un primo invio di piante e semi, che si è procurato nei vivai cittadini. Nel corso dell’inverno crea un vivaio di 30 acri a Hackensack (New Jersey) e incomincia ad esplorare i dintorni di New York. Su invito di Benjamin Frankilin, va a Filadelfia a conoscere William Bartram e a visitare il suo celebre vivaio. Poi è la volta di Mount Vernon, il magnifico parco di piante native creato dal presidente Washington; quindi, prima di rientrare in New Jersey, scende a sud fino a Fredericksburg in Virginia. L’incontro con Bartram, a sua volta un grande esploratore che tra il 1773 e il 1777 ha raccolto piante in otto colonie, dalla Pennsylvania alla Florida, è determinante; i due si scrivono, scambiano semi e informazioni, ma soprattutto è Bartram a suggerirgli di spostare il centro delle sue ricerche in South Carolina, una zona particolarmente ricca di nuove piante. Nel settembre 1786, Michaux affida il vivaio di Hackensack a Saunier e insieme a suo figlio si imbarca per Charleston. Qui, a poche miglia dalla città, crea un secondo vivaio di 111 acri che sarà la sua base operativa per i prossimi dieci anni. A Charleston c’è una grossa comunità di ugonotti di origine francese e Michaux si ambienta benissimo. Il suo giardino si sviluppa in fretta e presto può funzionare da centro di interscambio nelle due direzioni: oltre a coltivare le piante americane da spedire in Francia, si fa mandare semi dalla madrepatria e arricchisce i giardini dei suoi ricchi e influenti clienti americani di piante ancora sconosciute su questa riva dell’Oceano: tra quelle di cui gli si attribuisce l’introduzione negli Stati Uniti, Albizia julibrissin, Melia azedarach, Osmanthus fragrans, Lagerstroemia indica, Ginkgo biloba e la pianta del tè, Camellia sinensis. È chiaro che uno come Michaux non è venuto in America a fare il vivaista e non vede l’ora di riprendere a viaggiare. Appena il giardino è ben avviato, ricominciano le spedizioni. Nella primavera del 1787, dapprima in compagnia del botanico scozzese John Fraser, segue il percorso di Bartram lungo il fiume Savannah, poi si addentra da solo in territorio Cherokee fino alle sue sorgenti, scoprendo la rara Shortia galacifolia. Negli anni successivi visiterà gran parte del nord America orientale, spingendosi anche nella provincia canadese del Quebec, nella Florida spagnola e nelle Bahamas. Esplorò con particolare intensità la Georgia e le Caroline, in particolate la regione del Piedmont che visitò ben sette volte. Amava viaggiare da solo, a piedi o a cavallo, e con un bagaglio minimo. Se trovava ospitalità per la notte, bene; altrimenti, si poteva dormire benissimo anche sotto le stelle. Aveva un occhio d’aquila, si fermava ad osservare ogni pianta ed era abilissimo a scovare nuove specie anche in zone già battute, come notò l’amico Bartram. Nel 1792 fece un lungo viaggio fino alla baia di Hudson; al ritorno, ebbe un colloquio con Jefferson, all’epoca segretario di stato, a cui propose di esplorare la sorgente del Missouri, individuare la linea di spartiacque e scendere fino al Pacifico. Jefferson era tentato, ma per opportunità politica rinunciò, tanto più che Michaux si trovò coinvolto in un incidente diplomatico; l’ambasciatore francese Genêt, che stava cercando di organizzare gruppi di volontari e una sommossa per strappare New Orléans agli spagnoli, approfittò dei suoi viaggi botanici per affidargli vari messaggi segreti. Le trame di Genêt indignarono il generale Washington che difendeva l’assoluta neutralità degli Stati Uniti nel conflitto tra Francia e Spagna; quando il coinvolgimento del botanico emerse, egli venne a trovarsi in una situazione difficile. Da lontano, aveva seguito con trepidazione le vicende francesi, divenendo un ardente rivoluzionario. Eppure proprio la rivoluzione finì per rovinarlo. Con la ripresa della guerra, divenne sempre più difficile fare giungere i suoi invii in Francia. Il governo rivoluzionario cessò di pagargli lo stipendio e di rimborsargli le spese. Nel 1795, dopo un ultimo viaggio, si decise a tornare casa. In dieci anni, aveva inviato in patria 90 casse di semi e 60.000 pianticelle. Tra le piante da lui introdotte in Europa molte nuove specie di querce, aceri, noccioli, lo spettacolare Rhododendron catawbiense, Magnolia micahuxii (oggi M. tripetala), la sfolgorante Cladrastis lutea, che d’autunno si tinge d’oro. Durante il viaggio di ritorno, sulle coste olandesi fu vittima di un naufragio in cui perse tutti i suoi effetti personali ma riuscì a salvare gran parte delle collezioni. Tornato a Parigi, non riuscì a ottenere se non in minima parte il pagamento degli arretrati. Nel 1800, accompagnato dall’aiuto giardiniere Jean-François Cagnet, si imbarcò con la spedizione Baudin, ma non andava d’accordo con il comandante e non accettava le nuove direttive che imponevano di consegnare tutte le raccolte al governo; a Mauritius sbarcò, vi rimase un anno, poi, sulle orme di Commerson, andò in Madagascar. Anche qui creò subito un giardino d’acclimatazione, ma, dopo appena tre mesi morì di una febbre tropicale. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Prima di partire per l’ultimo viaggio era riuscito a scrivere una monografia sulle querce americane e soprattutto Flora boreali-americana , pubblicata postuma a cura del figlio François-André e di Louis-Claude Richard, con le illustrazioni di Redouté. Quest’opera, che descrive 1700 piante, 40 delle quali inedite, fu a lungo la più completa flora del nord America orientale. Dopo la sua morte, il governo francese inviò in America François André Michaux a liquidare i due vivai. Al suo rientro, egli scrisse Mémoire sur la naturalisation des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale. Nel 1806, incaricato di individuare le specie arboree più adatte all'acclimatazione in Francia, ripartì per Charleston, ma durante la traversata fu catturato da una nave inglese e imprigionato alle Bermuda: una prigionia per modo di dire, che gli permise di esplorare la flora dell'isola St George. Tornato in patria, pubblicò l'importante Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale. Vero continuatore dell'opera paterna, visse fino a tarda età e per un trentennio fu l'amministratore della Société centrale d’agriculture per la quale creò l'arboretum di Harcourt, ricchissimo di specie americane.  Campanelle levantine Numerose sono le specie che in ricordo di André Michaux portano l’eponimo michauxii: tra gli alberi, che erano i suoi preferiti, Quercus michauxii, Betula michauxii oppure Pyrus michauxii; ma ci sono anche arbusti, come il raro sommacco nano Rhus michauxii, bulbose come Lilium michauxii o erbacee come la piccolissima Minuartia michauxii. Il genere Michauxia gli fu dedicato nel 1788 da un altro botanico francese, Charles Louis L'Héritier de Brutelle. Appartenente alla famiglia Campanulaceae, comprende sette specie di piante erbacee diffuse dal Mediterraneo orientale al Caucaso e all’Iran; la più nota è proprio la specie riportata da Michaux dal suo viaggio in Persia, M. campanuloides, un’alta erbacea annuale o perenne di breve vita con curiosi fiori bianchi a campana rovesciata con petali retroflessi e stilo verdastro protruso. Simile è M. tchihatchewii, che conquista la palma di una delle più impronunciabili tra le denominazioni botaniche. Tutto per la colpa della trascrizione francese del nome russo Čjačev (forse un diplomatico che operava nella Francia dell'Ottocento). Altre informazioni nella scheda. Negli anni a cavallo tra Seicento e Settecento, la Francia del re Sole lancia una serie di spedizioni scientifiche: i viaggi di Plumier nelle Antille, il viaggio in Levante di Tournefort, la tragica spedizione di Lippi in Sudan. Di tre viaggi è protagonista padre Feuillée, frate minimo come Plumier, e provenzale come quest'ultimo e Tournefort. E' un astronomo e un cartografo e le sue spedizioni si muovono sempre sul sottile confine che separa l'esplorazione scientifica dallo spionaggio: prima è in Levante a disegnare carte e fare il punto su installazioni strategiche come porti, poi nelle Antille, infine, nel viaggio più importante, in Cile, mai esplorato da nessun studioso prima di lui. All'astronomia alterna la botanica: alle piante dedica il giorno, agli astri la notte. In appendice al suo Journal pubblica la prima rassegna della flora cilena e peruviana, con un occhio di riguardo alle specie officinali. Linneo si ricordò di lui dedicandogli il genere Fevillea, con semi ricchissimi di oli da secoli utilizzati nella farmacopea indigena e oggi forse una fonte alternativa di combustibili e preziosi grassi alimentari.  Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei? I tre viaggi di Plumier nelle Antille avevano dimostrato le grandi potenzialità botaniche di quell'area; così nel 1703, quando si offrì la possibilità di inviare in Martinica un astronomo e cartografo, Fagon, l'archiatra del re Sole e intendente del Jardin royal, insistette perché la missione avesse anche risvolti botanici. La scelta cadde su un altro frate minimo, forse allievo di Plumier: Louis Feuillée. Anche lui era provenzale e fin da ragazzo aveva dimostrato grande attitudine per la fisica e la matematica. Nel 1680, a vent’anni, prese i voti, l'unico modo per continuare gli studi per un giovane senza mezzi; nel convento di Marsiglia ebbe modo di studiare astronomia e cartografia e forse incontrò Plumier che lo avrebbe iniziato alla botanica. Tuttavia il campo in cui si fece notare fu l'astronomia: due saggi pubblicati nel 1697 e nel 1699 nelle Memorie dell’Accademia delle scienze attirarono l’attenzione dell’astronomo reale Giovanni Domenico Cassini che nel 1700 lo inviò nel Mediterraneo orientale a determinare la posizione geografica di vari porti. L’elogiativo rapporto di Cassini spinge il ministro Pontchartrain e Fagon ad affidargli la missione nelle Antille, dove dovrà fare rilievi cartografici e e osservazioni astronomiche ma anche, auspice Fagon, proseguire le ricerche botaniche di Plumier. Il 5 febbraio 1703 il frate si imbarca a Marsiglia sulla nave Grand Saint Paul diretta in Martinica con un carico di deportati. Sbarcato l’11 aprile, viene accolto nel convento dei domenicani di Saint-Pierre, ma poco dopo si ammala di febbre gialla. La sua robusta costituzione gli permette di recuperare; nei quattrodici mesi che trascorre nell’isola, come racconterà lui stesso, divide il suo tempo osservando le piante di giorno, gli astri di notte. Arrivato in Martinica su una nave di galeotti, ne riparte su un vascello corsaro. Il 4 luglio 1704 si imbarca sull’Ambitieuse, un veliero armato con sessanta cannoni, inviato nel mare dei Caraibi a insidiare le navi mercantili spagnole. Alla ricerca di prede, la nave corsara fa scalo a La Guaira in Venezuela, poi risale verso l’attuale Colombia, toccando Porto Cabello, Santa Maria (dove c’è uno scontro a fuoco con gli spagnoli), Porto Bello. Il 5 dicembre raggiunge Cartagena, dove il nostro frate sbarca salutando l’onorevole compagnia. Ha intenzione di raggiungere il Pacifico, ma il progetto si rivela irrealizzabile; dopo due mesi trascorsi ancora a fare osservazioni cartografiche e astronomiche, trova un passaggio su un piccolo vascello di filibustieri che, passando per San Domingo e Saint Thomas, lo riporta in Martinica. Vi trascorre ancora un anno, prima di poter rientrare in Francia il 21 giugno 1706. Da questo primo viaggio riporta una messe di dati astronomici, rilievi cartografici, disegni e numerose piante. Ridisegna la carta della Martinica e si guadagna il titolo di «matematico del re». Ma già Ponchartrain e Fagon progettano una nuova missione per questo frate che ha dimostrato di sapersi muovere abilmente in situazioni difficili: dovrà recarsi in Sud America per rilevare le esatte posizioni geografiche delle coste del Cile e del Perù. In piena guerra di successione spagnola, siamo a metà tra la spedizione scientifica e lo spionaggio. Infatti il buon padre Fueillée è costretto nuovamente ad accompagnarsi a corsari; ma adesso (insediatosi Filippo V a Madrid) i nemici non sono più spagnoli, ma inglesi e olandesi. Dato che molte navi nemiche incrociano nel Mediterraneo, la Saint-Jean-Baptiste su cui si è imbarcato a Marsiglia, raggiunge Tolone per unirsi a una flotta protetta dal vascello corsaro l’Heureux retours, comandato da Nicolas Lambert. Per evitare incontri pericolosi, seguono una rotta contorta e, partiti da Tolone il 14 dicembre 1707, solo il 9 maggio 1708 sono a Gibilterra. Il passaggio è sorvegliato da due fregate inglesi. Pur sapendo che l’esito è scontato, Lambert affronta la battaglia e si lascia catturare: ma con il suo sacrificio permette agli altri vascelli francesi di sfuggire e continuare il viaggio. Il primo scalo della Saint-Jean-Baptiste è Tenerife, dove sosta circa un mese. Il frate si immerge con gioia nella ricca flora canaria. L’11 luglio ripartono e 14 agosto raggiungono Buenos Aires; il comandante decide di attendere l’estate australe prima di affrontare il difficile passaggio del Capo Horn. Fueillée ne approfitta per fare i rilievi necessari a disegnare una nuova carta dell’estuario del Rio de la Plata. Ripartiti il 9 ottobre, negli ultimi giorni dell’anno superano senza troppe difficoltà Capo Horn e il 21 gennaio gettano l’ancora a Concepcion in Cile. 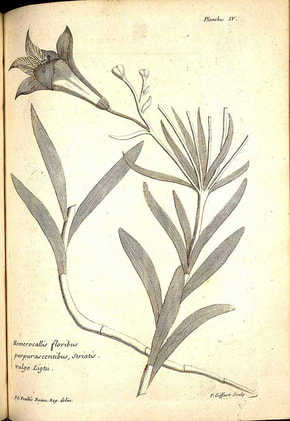 Ah, Sud America Sud America! La vera missione di padre Feuillé è solo all’inizio: rimane circa un mese a Conception, dove fa osservazioni astronomiche e raccoglie campioni di piante e animali; poi si sposta verso nord, toccando Valparaiso, Pisco, Callao e infine Lima, dove soggiorna per circa nove mesi. Nel gennaio 1710 riscende verso sud e, prima di tornare a Concepcion a cercare un imbarco, visita ancora Coquimbo e Arica. Il viaggio si protrae per un altro anno, con una lunga sosta a Conception, finché il 6 gennaio 1711 si imbarca sul Philipeaux e il 27 agosto è a Brest, dopo un’assenza di tre anni e otto mesi. Durante il lungo viaggio, come scrive uno dei suoi biografi, Paul Autran, «si dedicò a fissare la posizione e disegnare le mappe di tutti i porti, a correggere gli errori dei geografi precedenti in vari punti del suo itinerario, e raccolse un’infinità di piante, oggetti e osservazioni di storia naturale» ; fu tra l’altro uno dei primi astronomi a misurare la longitudine utilizzando segnali astronomici. Al ritorno, presentò personalmente i suoi disegni al re, che gli concesse una pensione e lo premiò con un dono graditissimo: la costruzione di un osservatorio tutto per lui nel convento dei minimi di Marsiglia, dove sarebbe vissuto quasi stabilmente fino alla morte, nel 1732. Già anziano, nel 1724, parteciperà ancora a una spedizione scientifica nelle isole Canarie, anche se dovrà rinunciare a scalare il picco del Teide insieme ai suoi più giovani accompagnatori. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Feuillé ha documentato il viaggio in Sud America nei tre volumi del suo Journal, pubblicato tra il 1712 e il 1725; in appendice al secondo e terzo volume vengono trattate le piante cilene e peruviane, sotto il titolo Histoire des plantes médicinales qui poussent sur les côtes du Chili et du Pérou. Le piante trattate sono un centinaio, molte delle quali mai descritte in precedenza. Di ciascuna viene dato un nome-descrizione in latino, seguito dal nome indigeno; seguono la descrizione in francese, solitamente molto dettagliata, indicazioni sull’habitat e gli eventuali usi terapeutici. Di eccellente qualità le tavole, ricavate da disegni e acquerelli eseguiti dal vivo dallo stesso Feuillée, che insieme alle precise descrizioni ci permettono di riconoscere facilmente, tra le altre, Alstroemeria ligtu e A. pelegrina, Lapageria rosea, Nicandra physaloides, Argylia radiata, Lobelia tupa, Mimulus luteus, Brugmansia arborea, Tropaeolum majus e T. minus. Tra le specie alimentari troviamo il pepino (Solanum muricatum), due specie di Passiflora, il lulo o naranjilla (Solanum quitoense), l’alchechengi peruviano (Physalis peruviana), la quinoa (Chenopodium quinoa), l’annona (Annona cherimolia), la caigua (Cyclanthera pedata).  Una liana dai semi oleosi L’opera botanica di Feuillé ha grande importanza storica, soprattutto per la flora cilena, mai studiata in precedenza, ed è anche di buon livello, nonostante l’autore fosse un astronomo prestato alla botanica. Ne aveva stima anche Linneo che gli rese omaggio ribattezzando Fevillea due specie alle quali Plumier aveva conservato la denominazione indigena Nhandiroba . Il genere Fevillea L. (famiglia Cucurbitaceae) comprende otto specie di liane rampicanti che vivono nelle foreste umide, dal Messico meridionale e dai Caraibi all’Argentina settentrionale. Una scelta opportuna, trattandosi di zone esplorate dal solerte frate-astronomo. La loro caratteristica più notevole sono i semi, i più grandi della famiglia (un seme secco può pesare anche 9 grammi) e i più ricchi di grassi tra le dicotiledoni. Le specie più nota e più diffusa è F. cordifolia, una liana che si aggrappa alle piante circostanti per mezzo di viticci e può allungarsi anche per 30 metri. Dioica, ha fiori maschili campanulati, piatti, con cinque lobi giallo aranciato, e fiori femminili con lobi brunastri tomentosi. L'ovario globoso si trasforma in un frutto tondeggiante, che contiene numerosi semi oleosi, da cui viene estratto un olio dal sapore simile a quello di arachide, utilizzato sia come alimento sia come combustile. Inoltre nella medicina tradizionale trova impiego come purgante, rimedio per affezioni di varia natura, emetico e antiveleno, come ricorda il nome inglese antidote vine. Un'altra specie da cui si ricava un olio alimentare è la brasiliana F. triloba. Recenti studi hanno sottolineato le potenzialità di queste piante, che potrebbero essere una buona fonte di combustibili e grassi alimentari a basso impatto ecologico. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed