|
I due concetti di base della classificazione scientifica, genere e specie, come oggi li intendiamo vennero formulati nella seconda metà del Settecento, rispettivamente da John Ray e Joseph Pitton de Tournefort, e poi definitivamente consacrati a metà Settecento da Linneo. Ma a ben guardare, arrivano da molto lontano: a stabilirli, non nelle scienze biologiche, ma come categorie universali del pensiero, fu il filosofo greco Aristotele, il "maestro di color che sanno" per Dante, ma per noi anche il maestro di color che classificano. Tutt'altro che sostenitore dell'ipse dixit, lo stagirita fu un genio universale, interessato ad ogni campo del sapere, compresa ovviamente la natura, che indagò con occhio di scienziato sperimentale ante litteram. Delegò all'allievo e amico Teofrasto lo studio delle piante, concentrandosi sugli animali; ma in passato gli fu attribuita anche un'opera di botanica, nota con il titolo latino De plantis. Ma fu certamente come padre nobile della cultura occidentale che L'Héritier de Brutelle gli rese omaggio con il genere Aristotelia (Elaeocarpaceae). 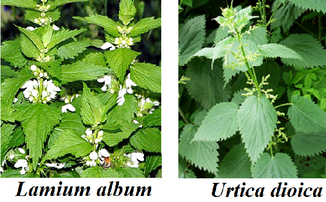 Tassonomie popolari, tassonomie scientifiche Da secoli, si può dire da quando è nata la botanica, i botanici si sono dati due compiti fondamentali, che in realtà sono strettamente connessi tra loro: identificare le piante, dando loro un nome, e raggrupparle, classificarle, sulla base di somiglianze e differenze. A dire il vero, classificazioni “ingenue” o “popolari” delle piante (anzi, più in generale degli esseri viventi) esistono in tutte le culture; ma la tassonomia popolare identifica e nomina solo le specie utili in qualche modo alla comunità oppure che è bene saper riconoscere perché nocive o pericolose. Le altre, quelle che non servono, spesso ricadono in categorie molto generali: “pianta”, “albero”, “felce”, “erbaccia”. D’altra parte, per designare le specie degne di essere riconosciute ed etichettate con un nome distintivo, già nelle designazioni popolari possiamo ritrovare in modo assai approssimativo, e con una portata molto diversa, i due concetti base della tassonomia scientifica, il genere e la specie. Ad esempio, in quasi tutti i dialetti italiani l’ortica comune (Urtica dioica) è designata con una singola parola, derivata dal latino urtīca, che corrisponde grosso modo al genere: ardicula (Sicilia), lurdicula (Calabria), ortiga (Liguria, Lombardia, Sardegna), urtia (Piemonte). Meno frequenti nomi descrittivi “polinomi”, come il piemontese erba ca foura “erba che punge”. Da questa ortica, che è quella vera e propria, potremmo dire l'ortica per antonomasia, la tassonomia popolare ne distingue un’altra, designata con un nome “binomiale”, formato cioè da due parole, analogamente al nome scientifico di specie: ortiga bianca (Brescia), ortiga falsa (Veneto), urtia morta o muta (Piemonte), urtiga gianca (Liguria). Sono alcuni esempi di denominazioni popolari di quello che per la scienza è Lamium album. Il fatto che tra Urtica dioica (Urticaceae) e Lamium album (Lamiaceae) non ci sia alcuna parentela ci chiarisce molto bene la differenza tra la tassonomia popolare e quella scientifica: la prima procede sulla base di somiglianze più o meno evidenti (in questo caso, la forma delle foglie), ma soprattutto le preme impedire confusioni tra due piante con usi pratici molto diversi, una delle quali potenzialmente pericolosa; la seconda cerca di cogliere affinità più profonde, intrinseche, nella convinzione che le somiglianze e le differenze tra le piante siano dovute a una “parentela”, ovvero alla loro storia evolutiva. Per arrivare a questa conclusione, la scienza ha compiuto un lunghissimo cammino, che è iniziato, almeno per la cultura occidentale, con il “maestro di coloro che sanno”, ovvero con Aristotele (384/383 a.C. – 322 a.C.). Fu proprio lui a fissare i concetti di genere e specie, non nell'ambito delle scienze naturali, ma in quello della logica: secondo il filosofo greco, ogni concetto può essere classificato secondo la sua maggiore o minore universalità, in un rapporto di genere (γένος, ghènos, concetto più universale) e specie (εἶδος, eidos, concetto più particolare). Il genere indica un gruppo di oggetti che condividono una serie di caratteristiche sostanziali, ma differiscono per caratteristiche particolari e contingenti e si applica a un numero maggiore di individui; la specie indica una gruppo di oggetti che condividono una serie di caratteri distintivi e riguarda un numero minore di individui. E' la specie, e non il genere, a definire con chiarezza l'essenza, la "sostanza prima" di qualcosa: ad esempio, "Socrate è un uomo" è una proposizione che chiarisce meglio che cos'è Socrate rispetto a "Socrate è un animale". 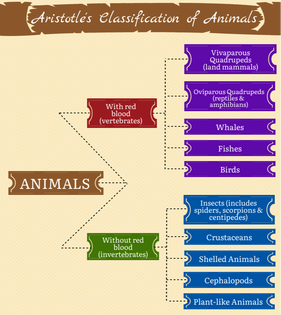 Una classificazione bestiale Come si è detto, si tratta di concetti generali, nati nell'ambito della logica, non specificamente dell'indagine sulla natura. Ma anche da questo punto di vista Aristotele si guadagna senz'altro il titolo di "maestro di color che classificano". Figlio di un medico, era profondamente interessato all'anatomia e alla biologia. In tutti gli svariati ambiti di cui si occupò (dalla metafisica all'etica, dalla logica alla retorica, dalla poetica alla teoria della letteratura, dalla psicologia alla politica e appunto alle scienze della natura), animato da un'insaziabile sete di conoscenza, fu sempre profondamente interessato alle questioni metodologiche. Egli fu anche il primo a tentare una classificazione degli esseri viventi, giungendo a delineare un sistema basato su una logica binaria e gerarchica. Nel De anima classificò in modo molto generale gli animali basandosi sul loro ambiente di vita e il loro sistema di locomozione e individuando tre insiemi di animali: acquatici, volatili e terrestri. Divise poi questi ultimi sulla base degli arti implicati nella locomozione in quadrupedi e bipedi; a quest’ultima categoria appartiene anche l’uomo, definito “animale (genere) terrestre bipede (specie)”. Agli animali dedicò poi tre opere più specifiche, Ricerche sugli animali (Historia animalium), Le parti degli animali (De partibus animalium) e Sulla generazione degli animali (De generatione animalium). Nella prima descrive 581 specie che aveva potuto osservare direttamente, distinguendole in due grandi gruppi: Enaima “animali dotati di sangue rosso” e Anaima “animali privi di sangue rosso”, corrispondenti grosso modo ai nostri Vertebrati e Invertebrati. Individuò poi nove “grandissimi generi”, quattro tra gli Enaima: Ornithes (uccelli), Ichthues (pesci), Tetrapoda (quadrupedi, ovvero mammiferi, rettili e anfibi), Ketoi (cetacei); cinque tra gli Anaima: Cephalòpoda (molluschi cefalopodi), Màlaka (molluschi senza conchiglia), Ostrakoderma (molluschi con conchiglia), Malakòstraka (Crostacei), Entoma (animali con il corpo diviso in segmenti, en-tomos, ovvero artropodi). Nell’ambito di ciascun “grande genere” distinse poi generi più specifici, che non corrispondono al genere in senso moderno, ma piuttosto alle famiglie, quando non agli ordini. Intermedia tra il singolo individuo e il genere, si colloca la specie (in greco eidos, ovvero “immagine”), che Aristotele usa con una portata abbastanza analoga a quella che assumerà nella scienza moderna. Nel corpus aristotelico ci è giunta anche un’opera sulle piante (il secondo “regno” dei viventi, per usare una terminologia che però non appartiene al filosofo greco), De plantis. Tuttavia gli studiosi ritengono si tratti di un testo apocrifo, da attribuirsi forse a Nicola di Damasco, un filosofo vissuto all’epoca di Augusto. Infatti, Aristotele divise il lavoro con il discepolo prediletto e successore alla direzione della scuola peripatetica Teofrasto. Mentre il maestro approfondiva lo studio degli animali, ad occuparsi delle piante fu quest'ultimo, il vero padre della botanica.  Dolci bacche dal Cile Anche se non si occupò direttamente di piante, Aristotele non mancò di esercitare una profonda influenza non solo sugli studiosi della natura del Medioevo, come il suo commentatore Alberto Magno, ma anche sui botanici del Rinascimento e della prima età moderna, alla ricerca di un metodo per classificare le piante che sempre più numerose affluivano grazie ai viaggi di scoperta, e che ormai era irrealistico pensare semplicemente di catalogare. Questo influsso è particolarmente evidente in Cesalpino, che basò il suo tentativo di classificazione delle piante sui concetti aristotelici di "sostanza" e "accidente"; fu sempre Cesalpino, sempre sulla scorta di Aristotele, a giungere a una prima definizione di specie che va già nel senso moderno. Ma, per una volta, non furono né Plumier né Linneo a rendergli omaggio con un genere botanico, ma alla fine del Settecento (1785) L'Héritier de Brutelle; l'idea era venuta in precedenza anche a Commerson (un botanico che sembrerebbe ben poco "aristotelico"), ma come si sa le sue opere rimasero a lungo inedite. Dunque la priorità va al genere di L'Hériter, che senza dubbio volle colmare una lacuna ma anche fare sfoggia di erudizione: “In memoria di Aristotele, filosofo principe dei peripatetici, che scrisse di storia naturale e di altro, come attestano Columella, lui stesso e altri autori di botanica, cui sono attributi due libri sulle piante”. L'Héritier creò il genere sulla base di una pianta raccolta in Cile da Dombey, Aristotelia maqui, che, riprodotta da seme, nell'inverno 1783 fiorì nelle serre del parco Monceau, di proprietà del duca di Chartres, il futuro Filippo Egalité. Il genere Aristotelia, della famiglia Elaeocarpaceae, comprende diciotto specie di alberi con una interessante distribuzione transpacifica: oltre che in Sud America (dal Cile all’Argentina) sono presenti infatti nell’arcipelago delle Vanuatu, nell’Australia sudorientale, in Nuova Zelanda e in Nuova Guinea. La specie più nota è probabilmente quella descritta da L’Héritier: oggi si chiama Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz. Nativo delle foreste del Cile meridionale e delle aree adiacenti dell’Argentina, questo piccolo albero, noto con il nome comune maqui, era considerato sacro dai Mapuche che ne usavano le foglie per curare le ferite infette e le dolci bacche per preparare la chicha, una bevanda alcoolica e inebriante. Noto anche come "mirtillo della Patagonia", è coltivato talvolta anche dai noi per i frutti ricchi di proprietà antiossidanti. Altre informazioni nella scheda. Nel regno degli animali, a ricordare lo Stagirita è anche un secondo Aristotelia: è un ampio genere di falene (farfalle notturne) della famiglia Gelechiidae, con rappresentanti anche nel bacino del Mediterraneo e in Grecia.
0 Comments
Circa due mila anni fa, in una data imprecisata tra il 17 e il 18 d.C., a Tomi, sulle sponde del mar Nero, moriva in esilio il poeta Publio Ovidio Nasone. Come egli stesso aveva auspicato, i suoi versi da due millenni continuano ad essere letti e le storie che aveva intrecciato nel suo capolavoro, Le metamorfosi, si sono impresse profondamente nel nostro immaginario collettivo. Il tema principale del grande poema è appunto la trasformazione, la metamorfosi da una natura all'altra: i suoi giovinetti, le sue ninfe, le sue donne innamorate, le sue madri dolorose si trasformano in pietre, in fiumi, in fontane, nell'aerea eco, in animali, in vegetali. Le metamorfosi vegetali sono appena una dozzina, ma alcune sono tra le più celebri, soggetto ricorrente di centinaia di opere d'arte: basti citare il mito di Apollo e Dafne e quello di Narciso. Anche le denominazioni delle piante devono qualcosa ad Ovidio: raccontando storie affascinanti sull'origine di alberi e fiori, il poeta latino ha tramandato alle generazioni successive anche i loro antichi nomi (anche se spesso non li usiamo per le stesse piante): narciso, cipresso, giacinto, loto... Inoltre, ha offerto ai botanici un deposito di nomi suggestivi, cui attingere per le loro denominazioni classicheggianti. Dunque non stupiamoci se anche lui è celebrato da un genere botanico, Ovidia, molto affine a un altro dei "suoi" generi: Daphne. Dal mito di Dafne a quello di Narciso Nel suo grande poema epico-mitologico Le metamorfosi, il poeta latino Ovidio (43 a.C.-17/18 d.C.) raccoglie e rielabora circa 250 miti greci, molti dei quali raccontano la trasformazione di esseri umani in elementi naturali di varia natura. Egli non fu certo l'inventore del genere: probabilmente esisteva già una tradizione in tal senso nella letteratura ellenistica; sappiamo, ad esempio, che il medico e poeta Nicandro di Colofone scrisse delle Metamorfosi in cinque libri che trattavano di esseri umani trasformati dagli dei in animali e in piante. Le origini di queste storie erano antichissime; molte erano miti eziologici (dal gr. aitia, "causa" e logos, "discorso", "racconto sulle cause") intesi a spiegare l'origine di un nome, di un'usanza, di un rito. Ma mai prima di Ovidio questi racconti ancestrali avevano assunto una veste tanto viva, e allo stesso tempo tanto profondamente umana. Anche se molti di questi miti ci sono giunti anche attraverso altre fonti (e altre varianti, visto che anche i miti sono soggetti a continue metamorfosi) la versione delle Metamorfosi è spesso quella che si maggiormente impressa nella memoria, e ha contribuito a consegnarli alla cultura occidentale, all'immaginario collettivo e alla storia dell'arte. All'interno del grande poema, le storie in cui i protagonisti lasciano l'aspetto umano per trasformarsi in alberi o fiori sono appena una dozzina, ma alcune sono tra le più indimenticabili. Talvolta (ma è l'eccezione, non la regola) il nome con cui Ovidio designa la persona e la pianta corrispondente è entrato direttamente nella nomenclatura botanica, ma più spesso ha seguito vie traverse. E' il caso della prima dendromorfosi (ovvero "trasformazione in albero") che ci viene incontro nel primo libro, forse la storia più famosa di tutte: il mito di Apollo e Dafne (I, 452-567). Colpito dalla freccia d'oro di Cupido, che ha irriso, Apollo si innamora perdutamente della ninfa Dafne, che, al contrario, colpita da una freccia di piombo, lo detesta. Dunque, alle sue profferte, fugge, finché, quando il dio sta per sopraffarla (è un tentato stupro, uno dei tanti di questo libro) prega il padre, il fiume Peneo, di sottrarla all'oltraggio con una metamorfosi. Non ha finito di parlare che "il petto morbido si fascia di fibre sottili, i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami; i piedi, così veloci un tempo, s'inchiodano in pigre radici, il volto svanisce in una chioma: solo il suo splendore conserva". Dafne (o meglio Daphne) è anche il nome greco dell'alloro, Laurus nobilis, e il mito (lasciando da parte significati simbolici e metaforici) ha la funzione di spiegare il sacro legame tra la pianta ed Apollo. In Ovidio, però, che scrive in latino, questo legame etimologico si perde. A recuperare Daphne penseranno, molti anni dopo, i botanici. Nella Naturalis Historia di Plinio si parla di un arbusto "alessandrino" detto Chamaedaphne, "alloro nano". Nel Cinquecento, incomincia ad essere identificata con un arbusto con foglie persistenti che ricordano in qualche modo l'alloro; Mattioli la chiama alla latina Laureola, ma aggiunge che i greci la chiamano Daphnoide. E' questa la situazione fino a Linneo che, prima in Flora lapponica, poi in Hortus Cliffortianus, quindi definitivamente in Species Plantarum, crea il genere Daphne, separandolo da Thymelaea. In Hortus Cliffortianus (dopo, purtroppo per me, perderà questa abitudine) spiega anche chiaramente perché: "Dato che il nome Thymelaea è ambiguo, la chiamo Daphne, come sinonimo superfluo di Laurus". Insomma, la parola c'era (grazie anche ad Ovidio) e tanto valeva usarla. E così la bella ninfa amata da Apollo in botanica ha subito un'altra inattesa trasformazione, dando il suo nome a questo genere bellissimo, ma super tossico. Più avanti nel I libro (689-712) troviamo un mito molto simile; cambiano solo i nomi dei protagonisti (e l'atmosfera): l'inseguitore è Pan, l'inseguita è la ninfa Siringa (in greco Syrinx). Quando sta per essere raggiunta, invoca le ninfe, che la trasformano in canne palustri. Il dio si consola, traendone uno strumento musicale, il flauto di Pan o siringa. Nessun pianta porterebbe il suo nome, se non fosse per un'alzata d'ingegno di Clusius, che decide di battezzare Syringa due piante portate da Costantinopoli dal suo amico Ogier Ghislain de Busbecq, diversissime tra loro ma accomunate da fusti cavi (l'ho raccontato qui). Il botanici successivi, dai Bauhin a Tournefort, perpetueranno l'equivoco, fino a Linneo che riserverà Syringa al lillà. Altro mito famosissimo nel libro III (339-510), probabilmente l'unico caso in cui Ovidio sta parlando della stessa pianta a cui pensiamo anche noi (o almeno, a una delle sue specie), con un nome conservato per tradizione ininterrotta. E' il narciso (narcissus), metamorfosi di Narciso, che come tutti sappiamo si innamora della propria immagine, e, nella versione di Ovidio, si lascia morire di languore per quell'amore impossibile. Quando le sue sorelle vanno a seppellirne il corpo, non lo trovano: "al posto suo scorsero un fiore, giallo nel mezzo e tutto circondato di petali bianchi". La versione greca del mito è più cruenta: Narciso si trafigge con la stessa spada con la quale si era dato la morte un innamorato respinto. Quanto al narciso (senza cercare di identificare la specie, forse N. poeticus), si tratta di una pianta mediterranea, che orna i nostri giardini fin dall'antichità, quando probabilmente iniziò anche ad essere coltivata per l'industria profumiera. Il nome greco è narkissos, in cui riconosciamo la radice narko-, "che dà sopore", in riferimento al profumo greve e lievemente ipnotico. Il primo a parlarne in tal senso è Teofrasto, nel suo trattato sugli odori. Dioscoride riferisce di alcuni usi medici, mentre Plinio ne descrive tre specie, una dai fiori purpurei, una con corolla bianca e coppa aranciata, l'altra identica ma con coppa verdastra. Grazie a Plinio, ma probabilmente anche alla popolarità di Ovidio, il nome Narcissus entra di gran carriera negli erbari medievali e rinascimentali, dove viene usato con grande liberalità per designare svariate bulbose; ad esempio, nei commentari di Mattioli, oltre a diverse specie di narcisi, sotto il nome Narcissus sfilano Pancratium maritimum, Hyacinthoides italica, un tulipano, un bucaneve e un Leucojum. Il genere come lo conosciamo noi è istituito da Tournefort e validato da Linneo. Per inciso, anche se non è protagonista di alcuna metamorfosi, anche un altro personaggio di questo episodio è entrato nella terminologia botanica: si tratta di Liriope, la madre di Narciso. Ovidio la definisce "l'azzurra Liriope" e tanto bastò al buon padre Loureiro per attribuire il suo nome a un genere che comprende specie con fiori (e talvolta bacche) azzurri.  Metamorfosi e piante misteriose Nel libro IV (190-270) il mito di Leucotoe e Clizia ci riserva una doppia metamorfosi. La storia è un po' meno nota, e vale la pena di sintetizzarla. Un tempo il Sole amava Clizia, ma ora nel suo cuore c'è posto solo per Leucotoe. Assunte le sembianze della madre di lei, si introduce nella stanza dell'amata e la violenta. Clizia lo riferisce al padre della fanciulla, che la fa seppellire viva in una profonda buca. Il Sole non può soccorrerla, ma dalla terra che egli irrora con nettare profumato "un virgulto d'incenso, allungando nel suolo le radici, si erse e ruppe il tumulo con la cima". Ovviamente, ora il dio detesta profondamente Clizia, che non può darsi pace: senza prendere cibo, non si alza più da terra, intenta solo a seguire con lo sguardo il percorso del Sole. Finché, dopo nove giorni, anche lei si trasforma: "Si dice che il suo corpo aderisse al suolo e che un livido colore trasformasse parte del suo incarnato in quello esangue dell'erba; un'altra parte è rossa e un fiore simile alla viola le ricopre il volto. Malgrado una radice la trattenga, sempre si volge lei verso il suo Sole, e pur così mutata gli riserba amore". Come abbiamo già visto in questo post, il termine incensum può indicare qualsiasi sostanza che, quando viene bruciata, emette fumo aromatico; dunque è davvero impossibile capire a quale pianta si riferisse Ovidio parlando di "virgulto d'incenso". Di sicuro, non apparteneva al genere Leucothoe, creato a inizio Ottocento da David Don; provenienti dal Nord America e dall'Asia orientali, questi arbusti erano ignoti a greci e romani, e non hanno neppure foglie aromatiche. Quanto a Clizia (in greco Clytie) non ha lasciato traccia nelle denominazioni botaniche. Resta da capire in quale pianta si sia trasformata: certo non nel girasole, come nel quadro di Evelyn De Morgan (e come molti pensano, compreso Montale), ovvero Helianthus annuus, una pianta di origine nordamericana. Un'ipotesi più verosimile potrebbe essere una specie di eliotropio: Heliotropium significa per l'appunto "che si rivolge al sole". Anche se la corrispondenza con la descrizione di Ovidio non è perfetta, gli eliotropi vivono in luoghi aridi, hanno foglie grigiastre e talvolta fiori violacei. La prossima metamorfosi vegetale si trova nel libro VIII (611-724): i buoni vecchi Filemone e Bauci ottengono dagli dei di morire insieme, e dopo la morte sono trasformati in una quercia e un tiglio con i tronchi uniti. Un mito commovente di cui si ricordò il botanico cileno di origine tedesca Rodolfo Armando Philippi che, in onore di sua moglie, nel 1894 battezzò Baucis lavandulifolia una graziosa Asteracea cilena. Purtroppo il nome non è valido, essendo già stata pubblicata proprio da David Don come Brachyclados lycioides. Nel libro IX (324-393) di nuovo una doppia metamorfosi con il mito di Driope: giovane madre, con il bimbo lattante in braccio va ad offrire una corona alle ninfe che vivono nei pressi di uno stagno. Per fare giocare il piccolo, raccoglie un fiore purpureo di "loto d'acqua", ma orrore! dallo stelo spezzato sgorgano gocce di sangue, e la malcapitata incomincia a trasformarsi in albero. Ha capito troppo tardi che il loto altri non è che la ninfa Lotide, che ha assunto quell'aspetto per sfuggire a Priapo. Prima di essere del tutto avvolta nella corteccia, raccomanda di insegnare al bimbo a diffidare dagli stagni e a non raccogliere fiori: bisogna rispettare gli alberi, perché in ogni arbusto può nascondersi una dea. Non è chiaro in quale albero si trasformi Driope (divenuta un'Amadriade, una ninfa degli alberi), e tanto meno che cosa sia il "loto d'acqua". Certo non è quello che noi chiamiamo loto, ovvero Nelumbo nucifera, una pianta acquatica indiana forse non nota agli antichi, tanto più che Lotide si è trasformata in un albero o in un arbusto. Con la parola loton / lotus gli antichi designavano in effetti tante piante diverse. La prima in ordine di apparizione, e anche la più celebre, compare nell'Odissea: è il loto dei lotofagi, certamente un albero o un arbusto con frutti eduli. Teofrasto conosce due gruppi di loti, quelli erbacei e quelli da fiore, ciascuno con diverse specie. Plinio ne distingue tre categorie: arboree (tra cui una specie con fiori purpurei detta anche Celtis), erbacee, acquatiche; Dioscoride si occupa essenzialmente dei loti erbacei. I grandi commentatori del Rinascimento cercano di fare chiarezza e si accapigliano sulle identificazioni. Il risultato è che la terminologia botanica pullula di loti veri o presunti: lo portano come epiteto l'acquatica Nymphaea lotus, forse il loto sacro degli Egizi; l'africano Ziziphus lotus, il giuggiolo comune, un buon candidato per il loto dei Lotofagi; l'improbabile Dyospirus lotus, parente dei kaki da frutto, che arriva dalla Cina, e in Europa non è attestato prima del 1597. Ma c'è anche un genere Lotus, istituito e validato dalla solita coppia Tournefort / Linneo, che corrisponde (forse) ad alcuni dei loti erbacei di Teofrasto e Dioscoride.  Gran finale: le metamorfosi del libro X Siamo giunti al gran finale, ovvero al libro X: non l'ultimo delle Metamorfosi, ma l'ultimo in cui compaiono dendromorfosi, ben quattro. Si inizia con il mito di Ciparisso (X,106-141), un altro amato di Apollo; il giovane è affezionatissimo ad un cervo di belle forme e mansueto carattere, che un giorno uccide per errore. E' così disperato che chiede al dio di trasformarlo in modo tale che il suo pianto duri in eterno. Ecco dunque come nacque il cipresso (in greco Kyparissos), l'albero del lutto. Come nel caso di Dafne, la lingua latina in cui scrive Ovidio spezza il legame etimologico tra eroe e pianta e il mito non lascia tracce nella terminologia botanica, dove il cipresso entra con il suo nome latino Cupressus, mentre il termine greco è presente solo nell'eponimo cyparissias "simile al cipresso", per piante con foglie lineari come quelle del cipresso, ad esempio l'euforbia cipressina Euphorbia cyparissias. Pochi versi dopo, un altro mito celeberrimo, quello del giovinetto Giacinto (X, 162-219), in greco Hyakinthos, vittima involontaria di Apollo durante una gara di lancio del disco. Come per il mito di Narciso, la versione di Ovidio è edulcorata: il ragazzo viene colpito accidentalmente da un rimbalzo del disco, mentre nel mito originale il lancio di Apollo viene deviato per gelosia da Zefiro. L'esito è lo stesso: nonostante le sue conoscenze mediche, il dio non riesce ad fermare l'emorragia e Giacinto muore dissanguato. Subito dopo però rinasce come fiore: "il sangue, che sparso al suolo aveva rigato il prato, ecco che sangue più non è, e un fiore splendente della porpora di Tiro spunta, della forma che hanno i gigli, solo che purpureo è il suo colore". Per rendere eterno il suo dolore, il dio scrive di sua mano sui petali il lamento AI AI. Il mito di Giacinto è stato variamente interpretato, per lo più come metafora della morte e della rinascita primaverile della natura; probabilmente è antichissimo, visto che il nome dell'eroe è pregreco. La pianta è citata già da Omero ed è stata variamente identificata (tra l'altro, come Scilla bifolia); è descritta da Dioscoride come una bulbosa con fiori disposti in un racemo inclinato e citata da Plinio, che però probabilmente non l'ha mai vista. Quale pianta fosse il giacinto di Ovidio non lo sapremo mai: il giglio martagone, il gladiolo, o ancora Delphinium ajacis, le identificazioni si sprecano. Di certo i giacinti come li intendiamo noi arrivano dal Mediterraneo orientale, e infatti a recuperare il nome, proprio sulla scorta di Ovidio, sono i botanici rinascimentali; secondo quanto racconta Mattioli, che è anche il primo a descriverlo, Hyacinthus orientalis, importato dall'Asia occidentale, fiorì per la prima volta nell'orto botanico di Padova nel 1590. A istituire e a convalidare il genere Hyacinthus sono nuovamente Tournefort e Linneo. Più avanti nello stesso libro, introdotto da effetti speciali ("Cose orrende canterò. Allontanatevi, figlie, e voi, padri") ecco il mito di Mirra (X, 298-502), ben noto anche per aver fornito il soggetto a uno dei capolavori di Alfieri; ed è anche uno dei vertici poetici delle Metamorfosi per pathos e penetrazione psicologica. Ma sintetizziamo al massimo: la sventurata principessa Mirra, dopo essersi congiunta con l'inganno al padre Cinira, gravida, fugge fino a raggiungere la terra di Saba. Giudicandosi indegna dell'uno e dell'altro, invoca gli dei perché la bandiscano sia dal mondo dei vivi sia da quello dei morti. In lacrime, viene trasformata in un albero che stilla gocce aromatiche: "Benché col corpo abbia perduto la sensibilità di un tempo, continua a piangere e dall'albero trasudano tiepide gocce. Lacrime che le rendono onore: la mirra, che stilla dal tronco, da lei ha nome, un nome che mai il tempo potrà dimenticare". Dunque Mirra, più che all'albero, dà il nome alla sua resina aromatica, proprio la stessa che i re Magi portano in dono a Gesù bambino insieme all'oro e all'incenso. Già conosciuta nell'antico Egitto, dove entrava nei riti dell'imbalsamazione, è citata nella Bibbia ed era molto apprezzata da Greci e Romani, che lo usavano come profumo, aromatizzante, medicinale. Il termine greco myrrha (e il suo equivalente latino) sono un prestito dall'ebraico mor, da una radice che significa "amaro". La resina è ricavata da vari alberi o arbusti del genere Commiphora, il più importante dei quali è C. myrrha. Ed eccoci all'ultimo mito (X, 503-559; 681-739), strettamente collegato a quello precedente: sotto la scorza arborea, la gravidanza di Mirra prosegue, e giunto il momento, l'albero è scosso dai dolori del parto, finché, impietosita, Giunone Lucina crea una fenditura da cui fuoriesce un neonato bellissimo: è Adone, in latino Adonis. Frutto di un incesto, è già segnato dal destino avverso, che durante una partita di caccia si manifesterà sotto le spoglie di un feroce cinghiale. All'innamorata Venere, che aveva tentato inutilmente di tenerlo lontano dai pericoli, non resta che tramutarlo in fiore: "Dal sangue spuntò un fiore del suo stesso colore [...]. Ma è un fiore di vita breve, fissato male al suolo, e fragile per troppa leggerezza; deve il suo nome al vento, e proprio il vento ne disperde i petali". Di origine orientale, il mito di Adone come quello di Giacinto allude alla morte e alla rinascita della natura. Il fiore in cui si tramuta non porta il suo nome: è l'anemone, dal gr. anemos, "vento". Ma anche in questo caso l'identificazione non è pacifica; potrebbe essere Anemone coronaria, ma non si tratta dell'unico fiore primaverile di breve durata dalla corolla color sangue. Clusius ipotizza che il fiore di Adone (in Rariorum plantarum historia lo chiama proprio così, flos Adonis) sia un bellissimo fiore con otto petali rosso sangue che ha raccolto nei suoi viaggi in Ungheria; Linneo raccoglie il suggerimento, lo battezza Adonis annua e crea il genere Adonis. E' l'ultima metamorfosi vegetale, ma non l'ultimo mito a suggestionare i botanici. Nel libro XV e ultimo, Ovidio racconta dell'etrusco Tagete (XV, 552-558). Dopo tante storie di uomini trasformati in pietre, animali, piante, è una metamorfosi al contrario: un contadino che sta arando, vede emergere dal terreno una "zolla portentosa", che rapidamente assume forma umana e inizia a parlare, insegnando agli Etruschi l'arte della divinazione. Del mito si ricordò Fuchs (in De historia stirpium commentarii insignes, 1542) per battezzare un'Asteracea messicana che si stava ambientando rapidamente nei giardini europei. Probabilmente il nome è una battuta di spirito, un'allusione alla velocità di germinazione dei tageti che sembrano emergere dal nulla dal terreno come il dio etrusco.  Un riconoscimento per il divino poeta Con tanti intrecci con il mondo vegetale, non stupisce che anche ad Ovidio (qui una sintesi biografica) sia stato dedicato un genere di piante. Il primo a pensarci fu Rafinesque, che nel 1836 separò da Commelina una specie che assegnò al nuovo genere Ovidia; oggi è considerato un sinonimo di Commelina. E' invece valido il genere Ovidia creato dallo svizzero Carl Meissner nel 1857. Il botanico, allievo di de Candolle, nell'ambito della revisione della famiglia Thymelaeceae per il XV volume del Prodromus, lo istituì staccando da Daphne due specie sudamericane. La dedica è raffinata e la motivazione esplicita: "Questo genere, diverso da Daphne, Wikstroemia e Daphnopsis per lo stilo allungato, e da Edgewortia per i fiori superiormente ricurvi, è dedicato al divino poeta che in versi bellissimi raccontò la metamorfosi di Dafne nell'alloro". Questo piccolo genere comprende due sole specie, assai affini all'europea Daphne, con areale disgiunto. La prima, Ovidia sericea, scoperta solo nel 2004, vive nelle Ande centrali boliviane e si distingue per le foglie persistenti fittamente ricoperte di indumento bianco; la seconda, O. andina, è un endemismo del Cile centrale, una specie piuttosto polimorfa che ad alta quota vive nel sottobosco delle foreste subalpine di Nothofagus. E' un bell'arbusto dalla chioma arrotondata da giovane, ma poi piuttosto sparso, con foglie persistenti, ellittiche, molto simili a quelle delle nostre Daphne, e fiori crema, profumati, raggruppati in cime terminali, seguiti da bacche bianche o rosse. Come le sorelle europee, è tossica e viene evitata dal bestiame. Una breve presentazione nella scheda. Quando l'autore di un nome botanico celebrativo non indica in modo esplicito chi intendesse onorare, può essere difficile ricostruire le sue intenzioni. E' il caso delle bellissime orchidee Laelia, che si riferiscono sicuramente all'antica gens romana omonima, senza che riusciamo tuttavia a sapere con certezza a quale dei suoi membri. L'ipotesi più gettonata identifica la dedicataria in una vestale vissuta all'epoca di Nerone, di cui non conosciamo nulla oltre la data di morte. E' d'altra parte più che probabile che la scelta sia stata dettata soprattutto dal suono: Laelia è un nome armonico, eufonico, evocativo, come piacevano al suo creatore, il padre dell'orchidologia John Lindley. 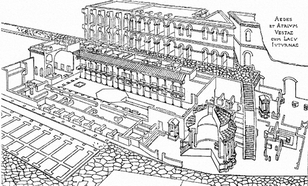 Un'evanescente figura femminile Nella sua lunga e instancabile carriera di studioso di orchidee, John Lindley diede il nome a oltre 120 generi validi di questa famiglia, e a molte centinaia di specie. Ricavò la maggior parte dei nomi generici da caratteristiche morfologiche distintive, ma agli altisonanti (e spesso cacofonici) composti greci prediletti dai suoi colleghi (come Odonthoglossum, creato da Kunth, oppure Phalaenopsis, creato da Blume) preferiva nomi brevi, se possibile dal suono armonioso, simili a epiteti femminili: Eria, "la villosa", Stenia, "la stretta", Coelia "la cava", Sophronitis "la casta". Gli piacevano i nomi di dee e ninfe, come Lycaste o Herycina, o di figure a metà tra storia e leggenda, come Aspasia o Ada. Di questo gruppo fa parte anche l'amatissimo genere Laelia. Sicuramente il botanico inglese aveva in mente un membro della gens romana omonima, ma quale? Impossibile saperlo con certezza, dal momento che egli non ha esplicitato il motivo della sua scelta. In realtà, la denominazione era già stata usata in precedenza da Adanson, che aveva dedicato un genere Laelia (Brassicaceae) al più noto esponente della famiglia, Gaio Lelio Sapiente (188-125 a.C.), celebre soprattutto per la sua amicizia con Scipione Emiliano, nonché protagonista del dialogo ciceroniano De amicitia. Ma proprio per la diffusione della denominazione di Lindley, quella di Adanson, benché precedente, è stata abbandonata. Sebbene questa ipotesi sia accettata da qualche studioso, è improbabile che Lindley avesse anch'egli in mente questo illustre personaggio: per le sue denominazioni "storiche" egli preferiva evocare donne sospese tra mito e storia, come appunto Aspasia e Ada. La dedicataria sarà dunque più probabilmente una donna della gens Laelia. Ne conosciamo essenzialmente tre, vissute rispettivamente tra il II e il I sec. a.C. e nel primo secolo d.C. Le prime due erano le due figlie del Sapiente, Laelia Major, moglie di Quinto Mucio Scevola, e Laelia Minor, moglie di Gaio Fannio Strabone; la maggiore fu elogiata da Cicerone per l'abilità retorica e la purezza del linguaggio, che trasmise alle figlie, una delle quali sposò Lucio Licinio Crasso, il più celebre oratore del suo tempo. Della terza, conosciamo quanto ne dice Tacito in una riga degli annali: "[Nel 64] morì la vergine vestale Laelia, e fu sostituita da Cornelia, della famiglia dei Cossi". Insomma, nacque, visse, morì. E' possibile che fosse figlia di D. Lelio Balbo che fu console nel 46 sotto Claudio. Ed è proprio questa Lelia vestale la più gettonata dedicataria dell'orchidea Laelia, benché a prima vista possa stupire che in mezzo a varie dediche a Afrodite (evocata come Doritis, Erycina e Paphinia) Lindley abbia associato a un'orchidea una casta sacerdotessa di Vesta. Tuttavia in Messico la simbologia legata alle Laelia non ha nulla di erotico: con i nomi di "flor de las almas", "lirio de todos los santos", "flor de muertos", o addirittura "calaverita", sono associate ai defunti, sia per il periodo di fioritura (è il caso di L. autumnalis), sia perché dai loro pseudobulbi è tradizionalmente ricavato un collante utilizzato nella confezione degli alfeniques, le figurine di zucchero della festa dei morti. Inoltre, c'è un parallelo con il genere Promeneia, dedicato da Lindley a un'altra sacerdotessa, la più anziana delle tre che servivano l'oracolo di Dodona. Proviamo dunque a immaginare la nostra vestale massima Lelia (tale sarà stata, se Tacito ne registrò la morte) nella Roma dei tempi di Nerone, magari sulla scorta del romanziere tardo vittoriano Frederick W. Farrar che in Darkness and Dawn (1891) la descrive come "una dama bella e signorile" e la mette in scena nell'atto di salvare dalla morte un condannato, su richiesta del giovane Tito, il futuro imperatore. Le vestali, infatti, l'unico collegio di sacerdotesse dell'antica Roma, godevano di grandi privilegi, tra cui il diritto di chiedere la grazia per un condannato a morte; vivevano a spese dello Stato, potevano testimoniare senza giuramento ed erano le uniche donne romane a poter fare testamento; i magistrati cedevano loro il passo e facevano abbassare i fasci littori in loro presenza. La loro persona era inviolabile e così sacra e pura che avevano il diritto di essere sepolte nel pomerio, mentre nessun altro poteva essere né sepolto né cremato in città. Vivevano nella casa delle vestali, che insieme al tempio della dea costituiva l'Atrium Vestae. Scelte tra fanciulle di ottima famiglia perfette nel corpo, con i genitori entrambi viventi, tra i sei e i dieci anni lasciavano la famiglia e entravano a far parte del collegio come novizie. Dopo dieci anni di noviziato, diventavano effettive e si occupavano dei doveri del culto, ovvero di mantenere acceso il fuoco sacro e di preparare la mola salsa, una focaccia sacra usata nei riti religiosi e nei sacrifici; dopo dieci anni di servizio, diventavano maestre e istruivano le novizie per un altro decennio. Infine, erano libere di tornare nella propria famiglia e di sposarsi. Nei trent'anni di servizio, potevano uscire liberamente, ma dovevano mantenersi in assoluta castità, pena la morte, L'Atrium Vestae si trova a ridosso del Foro. Anticamente, era attiguo a un bosco sacro, Lucus Vestae, che si estendeva fino alle pendici del Palatino, ma fu progressivamente ridotto per fare spazio agli edifici. Al centro della casa c'era però un grande cortile, simile a un peristilio, con tre bacini e presumibilmente aiuole fiorite, magari una pergola e piante in vaso. Forse esisteva anche un giardino sul retro dell'edificio. Tuttavia proprio nell'anno della morte della nostra Lelia, il complesso andò distrutto nell'incendio di Roma e le vestigia che possiamo vedere oggi risalgono a periodi successivi. Dopo un lungo restauro, sono state riaperte al pubblico nel 2010; nelle vasche è tornata a scorrere l'acqua e intorno sono state piantate aiuole di rose "antiche".  Laelia, un'orchidea che non teme l'aridità In definitiva, chiunque fosse la Lelia cui pensava Lindley, il suo intento - perfettamente raggiunto - era dare a queste orchidee un nome evocativo, nobile, dal suono armonioso, perfettamente adatto alla loro bellezza. Egli istituì il genere in The Genera and Species of Orchidaceous Plants (1831), sulla base di due specie messicane: Laelia grandiflora (oggi L. speciosa) e L. autumnalis. Ed è infatti proprio il Messico il centro di diversità di questo bellissimo genere, che oggi conta circa venticinque specie, dopo aver subito una profonda revisione tassonomica. Laelia è molto affine a Cattleya (con la quale infatti forma bellissimi ibridi), da cui venne distinta in base al numero dei pollinii (ne ha otto, anziché quattro). Fino alla fine del secolo scorso, gli era assegnata una cinquantina di specie, divise in due gruppi geograficamente distanti, nonché molto diversi per habitat e caratteristiche ecologiche; da una parte le Laelia del Messico e del Centro America, che vivono in aree aride prevalentemente montane con clima da temperato a freddo; dall'altra quelle brasiliane, diffuse in una varietà di ambienti tropicali o subtropicali dal livello del mare alle montagne. Come hanno dimostrato le ricerche basate sul DNA, si trattava di un raggruppamento artificiale, che è stato risolto dapprima trasferendo in Sophronitis quasi tutte le Laelia brasiliane, passate poi a Cattleya quando Sophronitis è confluito in quest'ultimo. Il risultato è che diverse tra le specie più note hanno cambiato nome, tra le altre Laelia purpurata, il fiore nazionale del Brasile, oggi Cattleya purpurata. Nella nuova circoscrizione più ristretta, le Laelia ci portano in un ambiente che non tendiamo ad associare alle orchidee: le foreste stagionali aride, soprattutto querceti-lecceti, dove per molti mesi all'anno non piove e in inverno le temperature possono scendere anche di vari gradi sotto zero. Per superare i periodi di aridità sono dotate di organi di riserva, gli pseudobulbi, che permettono di superare l'assenza di precipitazioni e il gelo; alcune di esse in inverno vanno in riposo. Inoltre, come adattamento all'aridità, adottano la fotosintesi CAM (metabolismo acido delle crassulacee) che permette di ridurre la traspirazione chiudendo gli stomi durante il giorno e assorbendo di notte l'anidride carbonica che verrà usata il giorno successivo per la fotosintesi. Hanno in genere fiori dai colori molto brillanti che si presume siano impollinati da colibrì. La bellissima Laelia speciosa (che è anche la specie tipo) è un endemismo del Messico centrale; è un'epifita che ama annidarsi sui rami dalla corteccia corrugata di diverse specie di querce delle montagne del centro del paese (Sierra madre occidentale e orientale, settore meridionale dell'altopiano messicano, fascia vulcanica trasversale). Di dimensioni compatte, ma con fiori enormi relativamente alle sue dimensioni, è stata raccolta e associata a riti sacri fin dai tempi degli aztechi. La raccolta indiscriminata dei fiori recisi e soprattutto degli pseudobulbi, usati per la confezione dei dolci dei morti, ne hanno ridotto molto il numero; oggi è protetta. Ne esistono molte varietà che si differenziano per il colore dei fiori, da lilla rosato a magenta. Importante come specie coltivata è anche L. anceps; anch'essa originaria del Messico centrale, di dimensioni molto maggiori della precedente, è tra le più usate nella produzioni di ibridi, soprattutto con generi affini come Cattleya e Brassavola. Come la precedente, L. autumnalis fiorisce dal tardo autunno all'inverno; è la specie abitualmente associata ai morti, con nomi come fiore dei morti, fiore di Ognissanti, fiore dei teschi, fiore delle anime; anch'essa cresce nei querceti e negli arbusteti di alta quota, con temperature notturne molto basse ed estati fredde; oltre alle querce, non disdegna cactacee e yucche. Qualche approfondimento nella scheda. La più antica testimonianza su quanto sapessero gli antichi dei veleni (e dei loro rimedi) non è costituita da un trattato, ma da una coppia di poemi del poeta ellenistico Nicandro di Colofone (II sec. a.C.): Theriaca, dedicato agli animali dal morso velenoso, e Alexipharmaca, dedicato ai veleni di varia natura assunti per ingestione. Proprio la forma in versi, che ne favoriva la memorizzazione, potrebbe aver contribuito a farli giungere fino a noi, mentre sono andate perdute le opere in prosa che li precedettero, cui probabilmente Nicandro attinse. Forse senza troppa fantasia, Adanson gli dedicò il genere Nicandra, la cui specie più nota gode fama di tossicità.  Due poemi... tossici L'epoca ellenistica fu caratterizzata da una ricca produzione scientifica; dovette farne parte anche il più antico trattato greco sui veleni di cui abbiamo memoria, Perì therion ("Sugli animali venefici") di Apollodoro d'Alessandria (III sec. a.C.) che probabilmente poté attingere alla secolare tradizione egizia. Perduta quest'opera, la prima testimonianza della scienza tossicologica antica è costituita da due poemi didascalici del poeta Nicandro di Colofone (II sec. a.C.): Theriaca, "Gli animali venefici", e Alexipharmaca, "Gli antidoti". Nella sezione biografie, una sintesi delle poche notizie che abbiamo di lui. Oggi può apparire curioso che un argomento scientifico venga esposto sotto forma di poema; eppure, poemi didascalici sui più vari argomenti furono assai in voga fino a un passato relativamente recente. I poeti ellenistici erano degli sperimentatori, che si rivolgevano a un selezionato pubblico di élite e miravano a rinnovare la poesia nelle forme, nel linguaggio, negli argomenti. Una delle modalità per perseguire questo rinnovamento fu mettere in versi temi scientifici, apparentemente aridi e lontani dal poetabile, ma proprio per questo una sfida eccitante per quei poeti innovatori; il più famoso dei poeti didascalici ellenistici è Arato di Soli che espose l'astronomia nei suoi Fenomeni. E' la strada percorsa anche dal nostro Nicandro che forse, oltre che poeta e sacerdote di Apollo, fu anche medico. La sua è una poesia ricercatissima anche nelle scelte lessicali: scritta in esametri epici (il verso dei poemi omerici), abbonda da una parte di arcaismi attinti appunto da Omero, dall'altra di termini tecnici della farmacologia e della medicina. Ma l'idea più innovativa sta proprio nel soggetto: invece di offrire ai suoi lettori cittadini quadretti di amena e nostalgica vita agreste, come aveva fatto Teocrito nei suoi Idilli, Nicandro vuole attirarli con il piacere della paura e del mostruoso. E ciò che più terrorizzava e faceva orrore all'uomo antico erano i serpenti, grandi protagonisti del primo dei due poemi. Ecco che in Theriaca sfilano serpenti velenosi e innocui, ragni, scorpioni, seguiti da insetti e altri invertebrati; del morso di ciascuno Nicandro descrive gli effetti con precisione di medico e compiacimento di scrittore dell'orrore; ad innalzare il tono, la narrazione di miti (come quello stesso della nascita dei serpenti) e le similitudini epiche. In questo primo trattato le piante entrano nella composizione dei rimedi. In primo luogo i repellenti, da spalmare sul corpo per tenere lontane le immonde bestiacce, come quello gradevolissimo composto da una dozzina di erbe aromatiche o quello inquietante che prevede la carne di una coppia di serpenti in amore raccolti in un crocicchio, midollo di cervo, olio di rose, olio illuminante e cera, Poi gli antidoti per il morso di un animale specifico, soprattutto cataplasmi; infine un antidoto di efficacia universale, composto da moltissimi ingredienti. E' l'antenato di quella panacea di tutti i mali che qualche secolo dopo assumerà il nome di teriaca o triaca. Le piante tossiche sono invece le protagoniste della prima parte di Alexipharmaca, seguite da animali e sostanze minerali che causano avvelenamento per ingestione. Nicandro tratta nell'ordine aconito, coriandolo (che oggi non consideriamo affatto tossico, mentre egli lo accusa di provocare la follia), cicuta, colchico, stramonio, giusquiamo, papavero da oppio; di ciascuno descrive puntigliosamente i sintomi dell'avvelenamento, per poi passare a lunghe liste di rimedi specifici. Tra gli ingredienti il più comune è il latte (considerato fino ad epoca recente il più potente degli antiveleni); seguono il vino e l'olio, usati sia come eccipienti sia come emetici. Moltissime sono poi le sostanze vegetali che entrano nelle ricette; e qualcuna per noi è tossica essa stessa: ad esempio, per soccorrere chi ha ingerito lumache di mare vengono prescritti elleboro e resina di scammonia (Convolvolus scammonia), un violento irritante gastro-intestinale; in alternativa, si suggerisce un più mite infuso di malva e latte d'asina. Presso gli antichi, l'opera di Nicandro godette di vasta fama; Plinio la cita molte volte e Dioscoride, pur senza citarla espressamente, ne dipende senza dubbio; poeta prolifico, Nicandro scrisse anche molte altre opere, tutte perdute, tra cui delle Georgiche che potrebbero aver influenzato Virgilio. Le due opere di tossicologia forse si conservarono proprio grazie alla forma in versi, che facilitava la memorizzazione rendendoli popolari tra medici e terapeuti; è possibile che già in epoca antica ne circolassero versioni illustrate, cui potrebbe risalire il magnifico manoscritto bizantino che ce ne ha trasmesso il testo. In epoca moderna, Nicandro non ha goduto di molta fama al di fuori degli ambienti specialistici. Nell'Ottocento, si mise in dubbio che fosse un medico, considerandolo un puro (e incompetente) versificatore dell'opera di Apollodoro; nel Novecento ne è stato rivalutato il valore scientifico, ma per lo più l'attenzione si è spostata sullo sperimentalismo e la qualità poetica.  Fiori azzurri e tossine Nicandro entra nella nostra galleria di dedicatari di generi botanici grazie a Michel Andanson, che nel 1763 crea Nicandra; egli non spiega le ragioni della dedica, ma probabilmente pensava alla tossicità di queste piante, una caratteristica piuttosto comune nella loro famiglia, le Solanaceae. A lungo, Nicandra è stato considerato un genere monotipico, limitato alla sudamericana Nicandra physalodes. Si tratta di un'erbacea annuale di origine peruviana che tuttavia è stata introdotta come ornamentale nei giardini, per diffondersi largamente come avventizia nei terreni disturbati di molti paesi, incluso il nostro. E' una bella pianta dalla crescita vigorosa, con grandi foglie lucide dai margini ondulati, fiori campanulati azzurro-lilla con gola bianca, seguiti da frutti anch'essi ornamentali; sono bacche globose ricoperte da una membrana cartacea, simili a quelle degli alchechengi, ma angolate, che persistono a lungo e possono essere usate come decorazioni invernali. La pianta contiene nicandrenoni, composti chimici steroidei del gruppo dei witanolidi (tipici della famiglia Solaneaceae, presenti ad esempio in Solanum belladonna). La sua ingestione provoca lievi intossicazioni e può essere psicotropa; in Australia si sono registrati alcuni casi sospetti di morte di ovini che ne avevano ingerito grandi quantità. Recentissima è la scoperta di due nuove specie: N. john-taykeriana, endemica del Perù settentrionale, pubblicata nel 2007; N. yacheriana, originaria del sud del Perù, pubblicata nel 2010. Qualche approfondimento nella scheda. Tra le poche testimonianze che ci sono rimaste della scienza antica, la "Storia naturale" (Naturalis historia) di Plinio il Vecchio nell'Occidente medievale fu l'opera più nota, più trascritta, più letta. Non tanto per il suo valore intrinseco (contiene molte contraddizioni e manca palesemente di spirito critico), né tanto meno per sua originalità (è una compilazione erudita che accosta 20.000 citazioni tratte da oltre 400 fonti), ma proprio perché, resi inaccessibili o perduti i testi originali, in particolare quelli greci, era quasi tutto quello che rimaneva. Ancora venerata all'inizio del Rinascimento (fu tra le primissime opere a stampa, pochi anni dopo la Bibbia di Gutenberg), ben presto perse sempre più il suo appeal, mano a mano che gli studiosi ne denunciavano gli errori, il contenuto libresco non suffragato dall'osservazione diretta, l'assenza di metodo scientifico. Gli studiosi di oggi sono divisi tra chi considera la grande enciclopedia di Plinio una specie di Reader's digest dell'antichità, e chi lo legge come un ambizioso e coerente progetto culturale, apprezzandone anche l'eleganza formale. Per Plumier, che gli dedicò uno dei suoi generi americani, Plinia, Plinio il Vecchio era semplicemente uno dei padri fondatori della botanica, degno di essere ricordato e celebrato.  Un martire della scienza Il 24 agosto del 79 d.C. (o il 24 ottobre, se la data tradizionale si deve a un errore), nella sua casa di Capo Miseno l'ammiraglio Gaio Plinio, com'era sua abitudine, stava studiando in un momento di relax, quando la sorella lo avvertì di uno strano fenomeno: in cielo era comparsa una grande nuvola dalla forma simile alla chioma di un pino marittimo. Plinio, oltre che comandante della flotta, era anche uno studioso e pensò che valesse la pena di saperne di più: ordinò immediatamente di approntare una nave per andare a vedere di persona. Ma proprio mentre usciva di casa gli fu consegnata la lettera di un'amica, Rectina, che lo avvisava che la sua villa era minacciata da un'eruzione del Vesuvio e lo scongiurava di accorrere in suo aiuto dal mare, visto che da terra non c'era via di scampo. A questo punto, la passione di studioso cedette al dovere civico; Plinio ordinò di mettere in mare tutte le quadriremi per cercare di mettere in salvo più persone possibile, e si imbarcò egli stesso. Mano a mano che le navi si avvicinavano alla costa Flegrea, erano investite da un pioggia sempre più fitta di ceneri e lapilli, ma, imperturbabile, l'ammiraglio continuava a dettare a uno schiavo le sue osservazioni sull'eruzione. Quando raggiunsero Ercolano, egli dovette constatare che il mare agitato e le pietre incandescenti che si erano riversate sulla costa rendevano impossibile sbarcare. Dopo un attimo d'incertezza, ordinò di fare rotta per Stabia, all'altro capo del golfo, dove si trovava la villa di un altro amico, Pomponiano. Sospinta dal vento, che spirava dal mare verso terra, la flotta raggiunse rapidamente Stabia, dove poté gettare l'ancora. Plinio trovò l'amico al colmo dell'agitazione, con i bagagli già pronti, in attesa che il vento girasse per potersi imbarcare. Egli cercò di tranquillizzarlo anche con l'esempio: prese un bagno, cenò e poi andò tranquillamente a dormire. Era l'unico a riuscirci: la situazione si stava rapidamente deteriorando, la casa traballava per le ripetute scosse di terremoto e il cortile andava riempiendosi di cenere e lapilli. Prima che il vecchio studioso rimanesse imprigionato dallo strato crescente di cenere, fu risvegliato e raggiunse gli altri. Il gruppo era incerto se fosse più sicuro rimanere in casa o uscire, proteggendosi il capo con coperte e cuscini; Plinio consigliò la seconda alternativa e si decise di avvicinarsi alla spiaggia, per verificare se fosse ora possibile mettersi in mare. Era l'alba, ma il cielo era così nero che sembrava ancora notte. Il mare squassato dalla tempesta imponeva di attendere ancora. Sempre imperturbabile, Plinio fece stendere a terra un lenzuolo e si sdraiò. Le fiamme che cadevano e un pronunciato odore di zolfo convinsero tutti che era meglio fuggire; due schiavi aiutarono ad alzarsi Plinio che quasi subito ricadde a terra. Era morto soffocato da vapori tossici. Questa fu, secondo il racconto del nipote e figlio adottivo Plinio il Giovane, la morte di Gaio Plinio Secondo, detto Plinio il Vecchio, uomo politico e scrittore romano. Tragica e improvvisa, gli impedì di rivedere il suo capolavoro, Naturalis historia, ovvero la Storia naturale.  Una enciclopedia della natura Non solo le sue ultime ore, ma tutta la vita di Plinio il Vecchio fu divisa tra l'impegno pubblico e lo studio. Come militare servì in Germania, in Gallia, in Spagna. Sotto Vespasiano, di cui era amico, fu procuratore in Gallia e in Spagna e esercitò vari incarichi a Roma; al momento della morte, come abbiamo visto, era prefectus classis Misenensis, ovvero ammiraglio della flotta di Miseno, il cui compito principale era combattere la pirateria. Per un profilo biografico, si rimanda alla sezione biografie. A questi incarichi ufficiali dedicava il giorno; ma ogni momento di riposo e la notte erano occupati dallo studio. Uomo dalle conoscenze enciclopedie, Plinio il vecchio scrisse di argomenti tanto vari come l'arte di lanciare un giavellotto da cavallo, la storia delle guerre romane in Germania, l'oratoria, i dubbi grammaticali, la storia contemporanea. Tutte queste opere sono andate perdute, ci rimane solo l'ultima, appunto Naturalis historia, una vastissima enciclopedia sul mondo della natura che, basandosi sugli appunti che andava prendendo da tempo, l'infaticabile erudito scrisse negli ultimi tre anni di vita. Così come si è giunta, comprende 37 libri, suddivisi in dieci volumi, ed è una delle opere più vaste dell'antichità classica a noi pervenute. L'obiettivo di Plinio era tracciare un quadro onnicomprensivo "della natura, ovvero, in altre parole, della vita". Il suo lavoro non si basò su un'indagine diretta e indipendente del mondo naturale (anche se in qualche raro caso si avvalse di osservazioni personali), ma sulle notizie attinte da una miriade di fonti; nella prefazione egli vanta di avervi inserito 20.000 citazioni, tratte da 2000 libri di 100 autori selezionati. Gli studiosi moderni ne hanno individuati circa 400, 146 romani e 327 greci. Dopo un primo libro occupato dalla prefazione, Plinio inizia la sua trattazione del mondo naturale dal cielo, con l'astronomia e la meteorologia (libro 2); passa alla terra, con la geografia e i suoi popoli (3-6); è quindi la volta della vita animale, a cominciare dall'uomo, vertice della creazione, di cui tratta l'antropologia e la fisiologia (7); poi gli animali: mammiferi, serpenti, animali marini, uccelli e insetti (7-11); a occupare il centro, le piante con la botanica, l'agricoltura, l'orticultura (12-27); a cavallo tra il mondo organico e quello inorganico, la farmacologia, la magia, le acque e la vita acquatica (28-32); infine i minerali, con un ampio excursus sul loro uso nella pittura e la scultura e sulle pietre preziose (33-37). Alieno da ogni speculazione, l'atteggiamento di Plinio è quello di un uomo pratico, che guarda alla natura essenzialmente dal punto di vista dell'utilità per gli esseri umani; egli è però anche un erudito, un curiosus, sempre pronto a farsi affascinare dal multiforme mondo naturale, fino a dare credito a miti e leggende (Cuvier lo accusò di avere una particolare propensione per le storie fantastiche). Ho già detto che la botanica ha grande spazio nella Naturalis historia. Anche se la sua fonte principale è Teofrasto (seguito da Giuba di Mauretania), Plinio non ha nessun interesse per una "botanica generale" come quella delineata dal filosofo greco; guarda alle piante da una parte con spirito pratico, per l'uso che se ne può fare per ricavarne alimenti, fibre tessili, tinture, medicamenti, spezie, ornamenti, dall'altro con ammirato stupore per la loro infinita varietà. La sua esposizione è ricca di indicazioni concrete, ma anche di aneddoti più o meno curiosi, spesso introdotti dalla formula "molti dicono che...". In Naturalis historia sono descritte circa 800 piante. La trattazione inizia con gli alberi esotici e le spezie (libri 12-13), da una parte affascinanti per l'alone di mistero che li circonda e la preziosità, dall'altra prova tangibile della grandezza dell'Impero romano che domina su molte lontanissime terre. E' poi la volta delle principali colture mediterranee: la vite e la produzione del vino (14), l'olivo e gli alberi da frutto (15). Seguono gli alberi selvatici (16) e l'arboricoltura (17). La trattazione delle piante erbacee inizia con i cereali (17), seguiti dal calendario agricolo (18) e dagli ortaggi (19), i cui usi medicinali sono trattati nel libro successivo (20). Si passa poi alle piante ornamentali, in particolare quelle usate per fare ghirlande (21; l'argomento era stato trattato anche da Teofrasto, ed era importante per gli antichi, che usavano ghirlande nelle cerimonie pubbliche, nei templi, ma anche in banchetti e ogni occasione festosa o luttuosa). Il focus dell'ultima sezione è l'uso medicinale delle piante: le medicine tratte da vite, olivo e alberi da frutto (23) e dagli alberi spontanei (24), quindi l'ampia trattazione delle erbe officinali (25-27), esposte in ordine alfabetico. Sappiamo dalle sue lettere che Plinio era anche un appassionato di giardini, e infatti le piante ornamentali ricevono nella sua opera un'attenzione che non trova riscontro in nessun altro autore antico. Nella villa di Laurentum aveva fatto piantare in cerchio dei platani, sui cui tronchi si arrampicava l'edera, che poi formava dei festoni che collegavano un albero all'altro. Dietro c'era una siepe di allori e al centro un prato con bossi e diversi arbusti potati alcuni a formare il nome del proprietario, altri a obelisco; c'erano anche piante da frutto e acanti. Non mancava una pergola di vite.  Storia di un longseller Perdute o inaccessibili quasi tutte le fonti originarie cui Plinio aveva attinto, la Naturalis historia nei secoli del Medioevo assurse a quasi unica testimonianza della scienza naturale degli antichi. Lo dimostra il numero eccezionale di manoscritti (anche se molti sono parziali e spesso corrotti) che ce ne tramandano il testo: circa 200. Il migliore tra i più antichi è il codice di Bamberg, che però contiene solo i libri 32-37 (che, con il loro excursus sull'arte, sono ritenuti da molti studiosi i più significativi). Inoltre, già a partire dal III secolo incominciarono a circolare diversi, più maneggevoli, compendi. Nei secoli dell'età di mezzo Plinio è un autore di riferimento, un'auctoritas, consultato, copiato, venerato. Vi attingono tra tanti altri Isidoro di Siviglia (560 ca-636) per le sue etimologie, il venerabile Beda (673 ca-735) per la meteorologia e le gemme, Vincenzo di Beauvais (1190-1264), che prende a modello il testo pliniano per il suo Speculum maius, Boccaccio le sue opere erudite. Del resto, il Medioevo ritrova in Plinio due tratti del proprio modello culturale: l'enciclopedismo e l'attrazione per il fantastico. Nel Quattrocento gli umanisti sono impegnati nell'immane compito di emendare il testo dagli errori dei copisti. Riscontrano molti errori, ma sono inclini ad attribuirli ai copisti. Nel 1469, appena tredici anni dopo la Bibbia di Gunteberg, viene impressa a Venezia dai fratelli Giovanni e Vindelino da Spira la prima edizione a stampa. Entro il 1500 se ne contano 15 edizioni. Arrivano prestissimo anche le traduzioni in lingua moderna: la prima si deve a Cristoforo Landino ed esce sempre a Venezia nel 1489. Ma i tempi stanno cambiando e gli studiosi iniziano a guardare al testo pliniano in modo sempre più critico. Il primo attacco arriva dal medico Niccolò Leoniceno in una lettera a Poliziano del 1492, poi ampliato nel 1509 in De Erroribus Plinii ("Sugli errori di Plinio"), in cui contrappone Plinio a Teofrasto e Dioscoride e ne denuncia la mancanza di metodo scientifico e di conoscenze mediche; giunge addirittura a raccomandare ai propri colleghi di non fidarsi troppo di quel testo, pena gravissimi danni per i pazienti. Anche se a difendere Plinio si fanno immediatamente sentire molti dotti umanisti, tra cui spicca Pandolfo Collenuccio con la sua Defensa Plini, l'attacco di Leoniceno è significativo di una nuova mentalità che al sapere libresco e al prestigio degli auctores contrappone la costruzione del sapere attraverso l'indagine, l'esperienza e la verifica dei fatti. Ovviamente l'influenza di Plinio non cessa dall'oggi al domani. Così, Gessner si ispira all'impianto di Naturalis historia per le sue altrettanto enciclopediche Historia plantarum e Historia animalium; nei Discorsi Mattioli lo cita quasi ad ogni pagina; Filippo Melantone lo preferisce a Aristotele per le sue lezioni di storia naturale; Francisco Hernandez lo traduce in spagnolo con scrupolo di filologo e sapienza di medico. Ma le critiche di Leoniceno hanno lasciato il segno: il suo allievo Euricius Cordus esorta i suoi studenti a cercare la verità nella natura piuttosto che nei libri; sulla stessa linea si schierano Melchiorre Guilandino e Jacques Dalechamps (1513-88) che nella prefazione al suo importante commento a Naturalis historia, contro la tradizione filologica, difende il suo approccio che mette in primo piano la comprensione dei fatti: "Io penso che la conoscenza del significato interiore delle cose è molto più importante per i sapienti che il vigore dell'espressione e la bellezza eloquente". Nell'età dei lumi la mancanza di spirito critico di Plinio attira gli strali degli studiosi, ma allo stesso tempo l'ambizione enciclopedica non manca di esercitare il suo fascino, tanto che Buffon lo prende a modello fin dal titolo per la sua opera principale, l’Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy; si guadagnerà così il soprannome di "Plinio di Montbard". Nell'Ottocento uno dei giudizi più drastici si deve a Cuvier che lo definisce "un autore senza spirito critico che, dopo aver passato molto tempo a fare estratti, li ha allineati insieme a riflessioni che non hanno nulla a che fare con la scienza propriamente detta, ma alternano le credenze più superstiziose alle lamentazioni di una filosofia pessimistica che non smette di accusare l'uomo, la natura e gli stessi dei". Il Novecento ha cercato di restituire a Plinio soprattutto la sua dimensione storica, valorizzandone l'importanza documentaria e leggendolo come monumento alla grandezza imperiale di Roma. Tra gli estimatori, troviamo Italo Calvino, che ne ammira soprattutto le pagine sull'astronomia nelle quali a suo parere "Plinio dimostra di poter essere qualcosa di più del compilatore dal gusto immaginoso che si dice di solito, e si rivela uno scrittore che possiede quella che sarà la principale dote della grande prosa scientifica: rendere con nitida evidenza il ragionamento più complesso traendone un senso d’armonia e di bellezza".  Una scorpacciata di frutti di Plinia Lontano dall'ammirazione senza riserve quanto dalle critiche demolitrici è il giudizio di padre Plumier, che dedicò a Plinio uno dei suoi nuovi generi americani, con queste equilibrate parole: "Caio Plinio Secondo veronese [in realtà, era comasco] ebbe tanto a cuore la botanica che nella sua Storia del mondo, dedicata all'imperatore Vespasiano o Tito, come altri preferiscono, nei libri da dodici a ventisette (secondo la divisione di Gessner) trattò le piante sotto ogni punto di vista: filosofico, storico, medico, agricolo, ecc. Morì durante l'eruzione del Vesuvio, quando era ammiraglio della flotta di Miseno". Istituito da Plumier nel 1703, il genere Plinia fu confermato da Linneo in Species Plantarum (1753); appartenente alla famiglia Myrtaceae, comprende alberi e arbusti diffusi dalle Antille e dall'America centrale al Brasile. Come altri esponenti neotropicali di questa famiglia, pone notevoli problemi di classificazione. Appartenente alla sottotribù Myrtinae della sottofamiglia Myrtoideae, forma un gruppo con gli affini Siphoneugena e Myrciaria in cui i confini tra generi e specie non sono sempre facili da determinare. Dunque, studiosi diversi gli assegnano un numero variabile di specie, da 40 a 75. Le principali caratteristiche distintive sono l'embrione con i due cotiledoni omogenei e totalmente separati, le foglie intere con nervatura centrale e nervature secondarie a spina di pesce profondamente incise, il calice deciduo che lascia una cicatrice simile a un ombelico sul frutto; in alcune specie, a colpire l'osservatore sono soprattutto i fiori che nascono direttamente sul tronco, seguiti dai frutti, così numerosi che talvolta possono coprirlo quasi interamente. La specie più nota è P. cauliflora, un albero nativo degli stati brasiliani di Minas Gerais, Goiás e São Paulo, dove è nota come jabuticaba (nome che condivide con altre specie, oggi assegnate al genere Myrciaria). In natura, fiorisce e fruttifica una o due volte l'anno, ma in coltivazione, con l'irrigazione adeguata, può produrre frutti freschi in continuazione. Simili nell'aspetto e nel gusto a acini d'uva nera, i frutti di jabuticaba sono estremamente apprezzati in Brasile (dove questo albero è considerato un simbolo nazionale, tanto che scherzosamente si dice "Se esiste solo in Brasile e non è jabuticaba, attento: non è buono"). Dolci ma con bassa acidità, vanno consumati rapidamente; si prestano alla preparazione di gelatine, marmellate e bevande fermentate. Poiché si deteriorano in fretta e non sono facili da coltivare in altri climi, sono poco noti al di fuori del Brasile; tuttavia ne esiste una piccola produzione in Sicilia. Eduli sono anche i frutti di P. edulis, un albero delle foreste costiere del Brasile, anch'essi prodotti , direttamente sul tronco; anziché neri, sono giallo-aranciati, con un gusto dolce-acido a metà tra quello della papaia e quello del mango sono noti come cambucà, mentre l'albero è detto cambucabeiro. Qualche approfondimento nella scheda. Fioriscono insieme nei nostri giardini, a maggio, e insieme sono arrivati dall'Oriente nei bagagli di un ambasciatore: sono il lillà e il filadelfo, o fior d'angelo, che a lungo hanno persino condiviso il nome latino syringa. Ne è nato un equivoco che perdura nelle denominazioni del filadelfo in alcune lingue europee (ad esempio il francese seringa, seringat) o regionali (siringa, serenga, serena, in Piemonte, Toscana, Emilia Romagna). Ma gli equivoci devono essere iscritti nel destino del profumatissimo arbusto: altrove è assimilato al gelsomino (il toscano gelsomino della Madonna, il siciliano gesminu di Portugallu, i tedeschi falsche Jasmin o Sommerjasmin, nonché il bavarese Scheissamin, sorvoliamo su che tipo di gelsomino sia...) oppure ai fiori d'arancio (l'inglese mock orange, l'italiano fiore d'arancio e il siciliano zagara americana). Anche i botanici hanno contributo: prima Caspar Bauhin, che cercando di dissipare la confusione, l'ha ribattezzato con un nome che probabilmente designava tutt'altra pianta; poi Linneo, che ritenendolo un nome celebrativo, l'ha arbitrariamente dedicato al sovrano ellenistico Tolomeo II Filadelfo. Bene per me, che grazie alla distrazione del principe dei botanici posso parlare di questo splendido arbusto, forse oggi un po' meno di moda, ma pur sempre ammirato per la magnifica fioritura bianca e il delicato profumo. Del resto, i meriti scientifici di Tolomeo II sono tutt'altro che equivoci, e una piccola dedica la merita davvero.  I doni dell'ambasciatore Dopo otto anni trascorsi alla corte di Solimano il Magnifico come ambasciatore imperiale, nel 1562 Ogier Ghislain de Busbecq, bibliofilo e appassionato collezionista di animali e piante esotiche, rientrò a Vienna, lasciandosi alle spalle lo zoo e i magnifici giardini che aveva creato nella sua residenza di Costantinopoli. Nei suoi bagagli, alcuni inestimabili tesori: in primo luogo, il magnifico codice miniato oggi noto come "Dioscoride di Vienna"; in secondo luogo, una collezione di bulbi e altre piante, tra cui due arbusti dai fiori profumati, novità assolute per i giardini europei. A Vienna li condivise con il curatore dei giardini imperiali, Carolus Clusius (che avrebbe poi portato con sé i bulbi di tulipano in Olanda, gettando le basi della tulipocoltura in quel paese). Avendo sentito dire che in Oriente i fusti cavi di entrambi gli arbusti venivano usati come cannelli delle pipe, il colto ambasciatore e l'amico Clusius li battezzarono entrambi syringa (espressione greco-latina che significa "tubo, cannuccia"): Syringa flore coeruleo quella a fiori violetti, Syringa flore albo quella a fiori bianchi. Queste denominazioni durarono a lungo, finché a correre ai ripari intervenne Caspar Bauhin che in Pinax theatri botanici (1623) conservò al primo Syringa caerulea e ribattezzò il secondo Philadelphus Athenaei, "filadelfo di Ateneo". Aveva pescato il nome in uno scrittore in lingua greca del II secolo d.C, Ateneo di Naucrati che, nel XV libro del suo Deipnosofisti, discute delle piante utilizzate per preparare le corone indossate durante i banchetti. A sua volta, Ateneo si rifaceva a uno scrittore precedente, Apollodoro di Artemita (I sec. a.C.). Il passo in questione è il seguente: "Apollodoro, nel quarto libro della storia del regno dei Parti, parla di un fiore chiamato philadelphum, che cresce nella terra dei persiani, e lo descrive così: «Ci sono molti tipi di mirto, il milax e quello che viene chiamato filadelfo, che ha ricevuto un nome che corrisponde alle sue caratteristiche naturali; perché quando i suoi rami, che si trovano distanti l'uno dall'altro, si mescolano insieme, si fondono in un abbraccio vigoroso e diventano uniti come se fossero sorti dalla stessa radice, e crescendo producono nuovi germogli; perciò, quando hanno rami ancora sottili, vengono piantati tutto attorni ai giardini intrecciandoli come una rete, e in tal modo queste piante creano una siepe impenetrabile»". In greco, infatti, philadelphos significa "amico fraterno" oppure "amico del fratello". Il filadelfo di Ateneo è davvero la pianta portata dall'Oriente dall'ambasciatore imperiale? Evidentemente no: non è un specie di mirto e non ha le caratteristiche descritte; probabilmente Bauhin si è lasciato suggestionare dalla citazione dotta e soprattutto dalla supposta origine persiana (anche se probabilmente, proprio come il lillà, nei giardini ottomani il filadelfo arrivò piuttosto dalla penisola balcanica). In ogni caso, la denominazione da lui proposta inizialmente venne ignorata: sia Gerard in Inghilterra sia Tournefort in Francia sia Vallisneri in Italia continuano a chiamare entrambe le piante Syringa. Finché arriviamo a Linneo, che in Hortus cliffortianus (confermerà poi questi nomi in Species plantarum), riprende la proposta di Bauhin denominando Syringa vulgaris il lillà e Philadelphus coronarius (filadelfo usato per fare corone, evidente allusione al passo di Ateneo) il nostro filadelfo. Sgombrato il terreno da un equivoco, ne crea subito un altro: sia che non abbia letto il testo di Ateneo (citandolo di seconda mano attraverso Bauhin) sia che sia stato suggestionato da altri passi dell'opera, in cui lo scrittore greco parla in termini elogiativi di questo sovrano, Linneo è convinto che il nome sia un omaggio a Tolomeo II Filadelfo, secondo re della dinastia Lagide.  Un grande protettore delle arti e delle scienze Grazie alla svista di Linneo, per vie traverse anche questo illustre personaggio si aggiunge alla nostra lista dei dedicatari dei generi botanici, e, tutto sommato, in modo non del tutto immeritato. Tolomeo II (il soprannome Filadelfo si deve al matrimonio con la sorella Arsinoe II, secondo il costume degli antichi faraoni, ma soprattutto come operazione politico-propagandistica che assimilava la coppia regale ai fratelli-sposi divini Zeus e Era oppure Osiride e Iside) è ricordato non tanto per le innumerevoli guerre in cui fu impegnato ma come fondatore delle due più importanti istituzioni culturali dell'antichità, la Biblioteca e il Museo di Alessandria d'Egitto. Da tutto il mondo greco, per sua volontà vi affluirono poeti e studiosi, che formarono il cosiddetto "sinodo", un gruppo di 30-50 intellettuali da lui stipendiati perché portassero avanti i loro studi in campo letterario e scientifico. Oltre a letterati celebri come Callimaco, Teocrito o Apollonio Rodio o opere di grande importanza culturale, come l'edizione critica delle opere di Omero, la traduzione in greco della Bibbia (la cosiddetta Bibbia dei Settanta) o la storia dell'Egitto commissionata a Manetone, nei laboratori annessi al museo fervevano le ricerche matematiche, astronomiche, mediche, con importanti scoperte nei campi dell'anatomia, della fisiologia e della medicina. Tra gli scienziati che lavorarono al Museo durante il suo regno, ricordiamo in particolare il medico Erofilo, considerato il fondatore della medicina sperimentale. Presso il Museo c'era anche un serraglio dove il re collezionava animali esotici (proprio Ateneo descrive una processione in onore di Dioniso voluta da Tolomeo II nel 270 a.C., in cui sfilarono 24 carri trainati da elefanti e coppie di leoni, leopardi, pantere, cammelli, antilopi, onagri, struzzi, un orso, una giraffa e un rinoceronte). Sempre secondo la testimonianza di Ateneo, i cortili e i portici del Museo erano inoltre abbelliti da piante rare giunte da tutto il bacino del Mediterraneo, ma anche dalla lontana India, che prosperavano grazie al mite clima egizio. Altri scrittori antichi ricordano che il sovrano cercò di migliorare le rese agricole introducendo nuove varietà di sementi (tra cui una varietà siriana di grano, che fu però rifiutata dai contadini egizi). Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Una cascata di fiori bianchi a profusione Il genere Philadelphus, della famiglia Hydrangeaceae, comprende una sessantina di specie di arbusti, nativi dell'Europa sudorientale, dell'Asia e dell'America settentrionale e centrale. Dopo il suo arrivo grazie a Ghislain de Busbecq, per circa 200 anni P. coronarius fu l'unica specie conosciuta e coltivata in Europa. Quando Linneo la descrisse in Species Plantarum (1753), dall'America era da poco giunta una seconda specie non profumata che il botanico svedese battezzò per l'appunto P. inodorus. A scoprirlo (e a disegnarlo) lungo le rive del fiume Savannah intorno al 1720 era stato Mark Catesby. Si diffuse soprattutto nei giardini statunitensi (in Europa si continuava a preferire il fratello profumato); ad esempio, nel 1792 George Washington ne ordinò parecchi esemplari a Bartram. Un'altra splendida specie nordamericana, P. lewisii, fu invece raccolta per la prima volta da M. Lewis nel 1806, nel corso della sua famosa spedizione con Clark. L'esplorazione della flora cinese permise di arricchire la scelta con altre specie, come P. delavayi, scoperta nel 1887 nella Cina meridionale dal missionario e botanico padre Pierre Delavay. Ma soprattutto, a rivoluzionare la presenza del bell'arbusto nei nostri giardini, furono i vivaisti. A farne una specialità, inizialmente esclusiva, fu il francese Victor Lemoine, che nel 1884 creò P. x lemoinei, incrociando P. microphyllus (una specie messicana, particolarmente resistente alla siccità) con P. coronarius. Fu l'inizio di un prolifico e fortunato lavoro di ibridazioni, che nell'arco di quarant'anni portò i vivai Lemoine a creare non meno di 30 ibridi, incrociando P. x lemoinei con altre specie ancora, soprattutto americane. Molto di moda ai tempi delle nostre nonne, quando era immancabile in ogni giardino, il filadelfo oggi è forse considerato un po' troppo visto, un po' troppo banale. Eppure la bellezza e la generosità delle fioriture rimangono intatte; per variare e introdurre un po' di novità, basterebbe affiancare al solito P. coronarius qualcuna delle altre specie, oppure scegliere tra le innumerevoli varietà orticole che rivaleggiano per profusione di fioriture, candore, profumo e sfoggiano nomi evocativi come "Mont Blanc", "Boule de Neige", "Innocence", "Virginal"... Per chi vuole qualcosa di speciale, ci sono persino varietà a foglie variegate oppure con fiori toccati di porpora (un po' meno angelici, ma davvero affascinanti). Qualche informazione in più su alcune specie selezionate e sulla storia degli ibridi nella scheda. Il ricordo di Crateva, medico personale di Mitridate e autore di uno dei primi trattati sulle erbe, è affidato a poche righe di Plinio e di Dioscoride, nonché a un'immagine del più antico codice illustrato della Materia medica. Tanto è bastato agli studiosi per farne il padre dell'illustrazione botanica. A questo precursore, in ogni caso, Linneo volle dedicare il genere Crateva, cui appartengono alcuni bellissimi alberi della flora tropicale.  Padre dell'illustrazione botanica? Abbiamo già incontrato Crateva (o Crateuas) come medico personale di Mitridate e direttore della sua equipe di studiosi di veleni e antidoti. A questo personaggio, citato sempre con elogio, dedicano poche righe tanto Dioscoride quanto Plinio. Così ne parla Dioscoride nella prefazione di Materia medica: "Crateva il rizotomo e Andrea il medico - poiché sembra che questi due abbiano trattato questa parte della materia con maggiore rigore di chi li aveva preceduti - descrissero le proprietà di molte radici utili e di alcune erbe". Nel corpo del trattato, lo cita poi a proposito dell'helenion egiziano e dell'halimus. Quanto a Plinio, lo ricorda nel libro XXV di Naturalis historia, dove traccia una breve storia dello studio delle erbe medicinali, insieme a altre due personaggi di cui non sappiamo altro: "Crateva, Dioniso e Metrodoro adottarono un metodo più attraente, anche se non privo di difficoltà. Infatti dipinsero le immagini delle erbe scrivendone sotto gli effetti. Ma non solo la pittura è ingannevole quando i colori sono tanti e si cerca di riprodurre la natura, ma, oltre a questo, molte imperfezioni vengono aggiunte dalla scarsa accuratezza dei copisti. Inoltre, non è sufficiente riprodurre una pianta in un solo periodo dell'anno, visto che cambia il suo aspetto nel corso delle quattro stagioni". A proposito dei suoi rapporti con Mitridate, Plinio ci informa che era il suo medico personale e che gli dedicò un trattato sulle erbe (Rhizotomikon). In una delle miniature del Dioscoride di Vienna, il prezioso codice miniato approntato nel VI secolo d.C. per la principessa bizantina Anicia Giuliana, Crateva è ritratto insieme ad altri sei medici, tra cui l'Andrea citato insieme a lui, lo stesso Dioscoride e Galeno. Anche quest'ultimo lo cita tra i suoi predecessori, in particolare come inventore di quel mithridatium da cui egli trasse la ricetta della teriaca. Da questa manciata di notizie, gli studiosi hanno cercato di estrarre qualcosa di più. A inizio '900, lo studioso di Dioscoride Max Wellmann attribuì a Crateva undici frammenti del codice di Vienna; altri eruditi sono giunti alla conclusione che le miniature che accompagnano questi frammenti (ma anche altri attributi ad altre fonti) risalgano a copie dell'opera originale di Crateva. Diversi studiosi affermano senz'altro che Crateva è niente di meno che l'autore del primo erbario illustrato e qualcuno si è spinto fino ad asserire che le immagini le avesse dipinte egli stesso. Con maggiore prudenza, altri fanno notare che tra il Dioscoride di Vienna e il Rhizotomikon di Crateva sono passati circa seicento anno (e tra Crateva e Plinio circa duecento); nel frattempo saranno state eseguite innumerevoli copie dei manoscritti originali, mentre mutavano anche i supporti scrittori (con il passaggio dai rotoli di papiro degli scrittori antichi al codice di pergamena del testo bizantino) e di conseguenza le tecniche pittoriche. Insomma, non abbiamo alcuna prova che Crateva sia stato il primo a produrre un erbario figurato (del resto, Plinio lo cita insieme ad altri due, non meglio noti), e che avesse dipinto le immagini di persona appare quanto meno improbabile; "dipinsero" può infatti semplicemente significare "effigiarono, fecero dipingere". E' certo invece che fu un medico rinomato che unì alla competenza medica una conoscenza approfondita delle virtù medicinali delle erbe. Un'unione sottolineata dall'appellativo "rizotomo" attribuitogli da Dioscoride: questo termine, letteralmente "tagliatore, quindi raccoglitore, di radici" nell'antica Grecia designava coloro che raccoglievano e vendevano le droghe medicinali. E' possibile che Crateva sia stato il primo a dare dignità scientifica a questa professione, scrivendo di piante medicinali con una competenza ben maggiore dei suoi predecessori. Non abbiamo motivo di dubitare della testimonianza di Plinio e possiamo senz'altro ritenere che quell'opera fosse illustrata, anche se difficilmente lo scrittore romano avrà potuto consultare l'originale. E sicuramente fu una delle fonti principali di Dioscoride, anche se oggi non condividiamo più le certezze di Wellmann sull'entità del suo contributo. Nel sezione biografie, qualche cenno alla vita di Crateva (di cui però sappiamo davvero pochissimo).  Alberi sacri e fioriture spettacolari Bene quindi fece Linneo a ricordarsi di questo precursore dello studio della botanica applicata alla medicina dedicandogli il genere Crateva (già pubblicato nella prima edizione di Genera plantarum del 1737, fu confermato in Species Plantarum 1753). Crateva, delle famiglia Capparaceae, è un genere pantropicale (con l'eccezione dell'Australia) che comprende da 9 a 15 specie, con principale centro di diffusione nel sudest asiatico e centro secondario in Madagascar. Si tratta di arbusti o alberi di piccole e medie dimensioni, perenni o decidui in base alle condizioni ambientali, con chioma folta e grandi foglie composte trifogliate; hanno fioritura spettacolare grazie alle grandi cime di fiori generalmente bianchi o poi crema, caratterizzati da quattro petali unguiculati (cioè con la base ristretta simile a uno stelo) disposti quasi orizzontalmente e lunghissimi stami (per questa particolarità alcune specie sono state soprannominate spider tree, "albero ragno"). Il legname (e a volte anche i frutti) ha uno sgradevole odore agliaceo. Molte specie sono importanti piante officinali nella medicina tradizionale. La più nota specie asiatica è C. religiosa, originaria dell'India, del Sud est asiatico e delle isole del Pacifico: è un albero di medie dimensioni dalla fioritura vistosa, ritenuto sacro e perciò spesso piantato nei cimiteri e accanto ai tempi. L'unica specie africana, C. adansonii, molto simile alla precedente, è presente in larga parte del continente in una varietà di habitat; le foglie fresche sono utilizzate in alcuni paesi come verdura, oltre a trovare applicazione nella medicina tradizionale. Ha usi medicinali anche la più nota specie americana, C. tapia (già descritta da Plumier come Tapia arborea triphylla), con frutti eduli, ma piuttosto insipidi, dalla buccia aranciata che ricordano una piccola arancia. Qualche approfondimento nella scheda. Negli anni turbinosi della rivoluzione, un botanico francese, capitato nelle Mascarene quasi per caso, ne esplora la flora. Per una reminiscenza erudita (o teatrale), con quello che è quasi un gioco di parole, crea il genere Monimia, dedicato a Monima, seconda moglie di Mitridate, protagonista di una storia d'amore finita malissimo. Quel piccolissimo genere endemico delle Mascarene dà il nome alla famiglia Monimiaceae, che ha fatto discutere gli studiosi per la sua distribuzione davvero singolare.  Un diadema non dà la felicità In seguito a circostanze avventurose come un romanzo, nel fatidico 1793, mentre in patria si tagliavano teste, il botanico Louis-Marie du Petit-Thouars rimane bloccato all'Ile de France (nome con il quale i francesi, strappandola agli olandesi, avevano ribattezzato Mauritius), una delle isole Mascarene, nota per le sue bellezze naturalistiche. Di questo paradiso della biodiversità in cui è capitato quasi per caso, Petit-Thouars esplora a fondo la flora, ricca di endemismi; negli anni successivi potrà visitare le altre Mascarene e anche, brevemente, Madagascar, ritornando in Francia (siamo nel 1802 e Napoleone è stato appena proclamato console a vita) con un erbario di 2000 piante. Molte sono le specie nuove per la scienza che Petit-Thouars pubblica nel 1804 in Histoire des végétaux recueillis dans les îles de France, de Bourbon et de Madagascar, dove descrive 55 specie accompagnate dai suoi disegni e dalle chiavi di determinazione. Alcune appartengono a generi nuovi che il botanico francese, dovendo rinunciare ai nomi indigeni (hanno un suono dolce, ma lui non conosce abbastanza le lingue locali per trascriverli correttamente) battezza ricorrendo alla lingua greca, appresa grazie ai suoi ottimi studi classici. Quando non ricorre a denominazioni descrittive, gli piace coniare nomi che associano memorie erudite a particolarità botaniche: la dea infernale Ecate dal triplice aspetto va a presiedere Hecatea (oggi confluito in Omphalea L.), perché gli stami hanno una triplice fessura e le foglie livide sono presumibilmente velenose; l'omerica Calipso (il cui nome significa la "nascosta") suggerisce Calypso, un genere in cui il pistillo è nascosto tra gli stami. Per due specie, in tutto simili al genere che Commerson aveva battezzato Mithridatea (oggi Tambourissa Sonn.) tranne per la struttura femminile dei fiori, conia Monimia, "da Monima, moglie di Mitridate". Grazie a questa reminiscenza erudita, l'infelice regina del Ponto entra nella storia della nomenclatura botanica, premettendomi di raccontare finalmente una storia romantica. Romantica, e ovviamente tristissima. Nell'88 a.C., Mitridate era all'apice della sua gloria e del suo potere; una dopo l'altra, le città greche lo accoglievano come liberatore e gli aprivano le porte. In una delle città conquistate (Stratonicea secondo Appiano, Mileto secondo Plutarco), il re del Ponto rimase folgorato dalla bellezza di una giovane di nobile famiglia, Monima (o Monime). Per aggiungerla al suo harem, offrì montagne d'oro al padre (15.000 pezzi d'oro secondo Plutarco), ma la fanciulla, non meno prudente e saggia che bella, rifiutò ogni profferta. Pressata da amici e familiari, a loro volta abbagliati dal potere di Mitridate, cedette solo in cambio di un regolare matrimonio e del titolo di regina del Ponto. Il re fece approntare dai suoi scribi un contratto di matrimonio e le inviò il diadema, simbolo della sua nuova condizione regale (si tratta di un nastro, tinto di porpora e intessuto d'oro, che i sovrani ellenistici annodavano intorno al capo). Dopo un breve periodo di felicità, in cui la nuova sposa esercitò una notevole influenza sul marito, Monima si pentì di quella scelta. Lasciata la nativa Ionia, ora viveva nei sontuosi palazzi di Sinope, in cui si sentiva sempre più isolata e infelice. Secondo Plutarco, prese a deplorare la sua bellezza, che invece di un marito le aveva dato un padrone, invece di un palazzo e un talamo nuziale una prigione custodita da barbari; dove, in esilio dalla Grecia, godeva solo in sogno di quei beni che in patria aveva posseduto nella realtà. Questa vita infelice si concluse tragicamente. Nel 72 a.C. Mitridate fu disfatto dal generale romano Lucullo nella battaglia di Cabira; per salvarsi, fu costretto alla fuga, travestito e accompagnato da un solo servitore. Prima di fuggire, temendo che le sue donne (che si trovano nella fortezza di Farnacea) cadessero nelle mani dei vincitori, inviò loro il suo eunuco Bacchide, con l'ordine di suicidarsi; come unica grazia, avrebbero potuto liberamente scegliere come morire. Del gruppo facevano parte, tra le altre, due sorelle nubili del re; una concubina di origini greche, Berenice, e la madre di lei; e la regina Monima. Mentre le altre optarono tutte per il veleno, Monima tentò di impiccarsi con il suo diadema. Ma il fragile nastro si spezzò; allora la giovane donna, esclamando "Fatale straccio, non servi neppure a questo ultimo servizio", porse docilmente il collo a Bacchide. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Questa affascinante storia, forse ritoccata da Plutarco, che la raccontò duecento anni dopo, ha dato a Monima una limitata fortuna postuma; fu ritratta da alcuni pittori, in particolare nel Settecento (di solito è rappresentata mentre tiene in mano il diadema spezzato o mentre porge il collo a Bacchide), ma soprattutto è diventata la protagonista femminile di una delle principali tragedie di Racine, Mitridate (1672), in cui il grande scrittore francese cambia totalmente i fatti storici, facendo della giovane greca la fidanzata di Mitridate, al centro di un quadrato amoroso in cui è contesa tra il vecchio re e i suoi due figli, il "cattivo" Farnace e il "buono" Sifare. Nella rielaborazione di Racine, Monime diviene il tipo dell'eroina di nobili sentimenti, cavallo di battaglia delle più grandi attrici. E sarà forse più Racine che Plutarco ad aver ispirato la dedica di Petit-Thouars.  La lussureggiante Monimia e le vagabonde Monimiaceae Creato, come si è detto, da Petit-Tours nel 1804, Monimia è diventato il genere tipo della famiglia Monimiaceae. Comprende solo tre specie: M. ovalifolia (presente a Mauritius e Réunion), M. rotundifolia e M. amplexicualis, endemiche di La Réunion. Si tratta di arbusti o alberi sempreverdi che vivono nelle foreste primarie umide (foreste nebulose) delle montagne di media altezza di queste isole, tra 1000 e 2000 metri. Un tempo piuttosto diffuse (soprattutto M. rotundifolia) e anche dominanti, sono oggi minacciate sia per l'eccessivo sfruttamento come alberi da legname sia per la riduzione del fragile ecosistema in cui vivono. Per l'aspetto generale e le caratteristiche ecologiche, ricordano un po' le Lauraceae delle foreste umide delle Canarie (con cui le Monimiaceae sono strettamente imparentate). Quale approfondimento nella scheda. Vale la pena di dedicare almeno un cenno alla famiglia Monimiaceae. Con le sue 200-270 specie distribuite in 22-28 generi, ha fatto discutere i botanici per due caratteristiche davvero singolari: il numero sproporzionato di generi monotipici (cioè costituiti da una sola specie), che toccano o superano il 50%; la distribuzione altamente discontinua. Sono presenti infatti in centro e sud America (5 generi), nell'Africa tropicale (un unico genere monotipico), in Madagascar e nelle Mascarene (4 generi), in Sri Lanka (1 genere), in Nuova Zelanda (una sola specie), in Australia e in Malesia. Il centro della diversità del genere e delle specie è la Nuova Guinea (75 specie distribuite in 10 generi). A lungo questa distribuzione è stata spiegata come esito della rottura del super continente Gondwana che avrebbe separato le specie occidentali (India, Sri Lanka, Madagascar, Seychelles, Australia, Malesia, Nuova Guinea), da quelle orientali (Africa e Sud America). Il recente ritrovamento di fossili identificati come Monimiaceae in Antartide e le analisi molecolari hanno ridimensionato questa ipotesi, spiegando invece la loro presenza in Africa e Sud America come esito di una dispersione oceanica a lunga distanza, con l'Antartide (dove nella fase calda del Miocene medio, tra 14 e 8 milioni di anni fa, erano presenti foreste) a fare da ponte tra Australia e Sud America. Tra i sovrani citati da Plinio per aver dato il proprio nome a una pianta, eccone finalmente uno che nello studio delle proprietà medicinali dei semplici era qualcosa di più di un dilettante: Mitridate VI re del Ponto, celebre per il fenomeno che dal suo nome è detto "mitridatismo" e per il mithridatum, o mitridato, antidoto e antiveleno di fama secolare. A ricordarlo nella nomenclatura botanica il genere linneano Eupatorium, tratto dal suo soprannome onorifico Eupatore, il "ben nato" "di nobili natali"; ridimensionato dai tassonomisti, ha sua volta dato il nome a una piccola corona di generi affini, tutti centro e sudamericani: Austroeupatorium, Eupatoriastrum, Eupatoriopsis.  Ossessionato dai veleni Tra i nemici di Roma, il più irriducibile e più pericoloso, forse anche più di Annibale, fu Mitridate VI del Ponto, detto Eupatore, che per un venticinquennio tenne sulla corda lo stato romano, in tre guerre (guerre mitridatiche, 89-85 a-C., 83-81 a.C., 74-63 a.C.) che si intrecciarono con la crisi della repubblica e la guerra civile tra Mario e Silla. Eppure è con sincera ammirazione che Plinio ne parla nei primi paragrafi del libro XXV, in cui traccia una breve storia dello studio delle piante officinali. Lo celebra come un uomo di grande cultura e intelligenza, versatissimo nelle lingue (ne parlava 22); dopo averne ricordato il profondo interesse per la medicina e gli esperimenti che fece su se stesso, fino a rendersi immune dai veleni, dichiara che la formula del suo celebre antiveleno, il mithridatium, trovata nei suoi forzieri da Pompeo e tradotta dal liberto di quest'ultimo, Leneo, è stata benefica per la vita quanto la conquista del regno lo è stata per Roma. L'interesse di Mitridate per la medicina e le erbe medicinali nasceva da un'ossessione: quella di essere avvelenato. Quando era adolescente (doveva avere tra 11 e 13 anni) suo padre morì di veleno, in seguito a una congiura in cui ebbe parte presumibilmente anche la moglie (e madre di Mitridate) Laodice, che divenne reggente. Il ragazzo si convinse che, in combutta con la cara mammina, i suoi tutori stessero cercando di assassinare anche lui; si ritirò nelle più remoti regioni del regno, dove si dedicò alla caccia e allo studio della natura, cercando soprattutto un metodo per proteggersi dai veleni. Divenuto maggiorenne e assunto il potere, continuò le ricerche e gli esprimenti. Inventò la pratica, che da lui è detta mitridatismo, di assumere quotidianamente piccolissime dosi di veleno per rendersene immune. Alla sua corte creò un vero e proprio centro di ricerca che comprendeva una biblioteca di testi di etnobotanica e tossicologia, giardini dedicati a piante tossiche e antidoti, vivai e laboratori; prese al suo servizio un'equipe internazionale, diretta dal greco Crateva (o Crateuas), dove altri medici come ellenici come Papias e Thimotheos erano affiancati da sciamani sciti e magi persiani, e forse medici indiani ayurvedici e druidi celtici. Era in corrispondenza con scienziati di tutto il mondo antico, come il greco Asclepiade che, pur rifiutando il suo invito di passare al suo servizio, gli dedicò un trattato e gli spedì formule di antidoti; l'egiziano Zopiro, che aveva creato un rimedio universale che comprendeva 20 ingredienti; gli sciamani Marsi che gli inviavano i loro medicamenti a base di veleni. Sperimentò gli effetti di centinaia di veleni e di antidoti su se stesso, sui suoi collaboratori e su prigionieri condannati a morte. Con il tempo si immunizzò contro i più noti veleni tanto che, con gusto teatrale, durante i banchetti amava esibirsi mangiando e bevendo vivande che per altri sarebbero state letali. L'obiettivo principale delle ricerche del re e della sua équipe era mettere a punto un antidoto universale, capace di proteggere da tutti i veleni. Secondo Plinio, attraverso ricerche instancabili e ogni possibile esperimento, fu ottenuto un farmaco la cui particolarità era unire insieme veleni e antidoti. Gli ingredienti sarebbero stati ben 54. Tra di essi, veleno di vipere, carne di salamandra, sangue di anitre del Bosforo che si cibavano di piante velenose, miele tossico, orpimento (solfuro d'arsenico), e moltissime piante, alcune probabilmente tossiche, altre aromatiche, resinose, depurative. Mitridate utilizzò le sue conoscenze tossicologiche anche come arma di guerra: durante la campagna di Pompeo, fece trovare ai soldati romani giare colme di miele tossico, tratto da polline di Rhododendrum ponticum, che indebolì le truppe avversarie tanto da permettergli di sconfiggerle. Dopo la morte di Mitridate, la formula della sua panacea, nota come mithridatium, giunse a Roma e fu variamente rielaborata. Ce n'è giunta una ricetta di Celsio, un medico dell'epoca di Augusto e Tiberio, che comprende 36 elementi (essenzialmente resine, spezie e erbe aromatiche, senza alcun elemento tossico a parte l'oppio); modificato da Andromaco, medico di Nerone, e Galeno, medico di Marco Aurelio, che aggiunsero come ingrediente fondamentale la carne di vipera, con il nome teriaca rimase in uso come rimedio universale almeno fino alla fine del Settecento. Quanto a Mitridate, rimase nell'immaginario collettivo come personaggio quasi leggendario. Machiavelli ne lodò l'abilità politica e militare. Gessner gli intitolò un libro che raccoglieva dati su circa 130 lingue; nel Seicento Racine gli dedicò una tragedia e nel Settecento Mozart (e non fu il solo) un'opera lirica. Una sintesi della sua lunga (anche la sua longevità, in un'epoca in cui la speranza di vita si aggirava sui 45 anni, fu considerata eccezionale) e burrascosa vita nella sezione biografie.  Eupatorium e i suoi fratelli Plinio riferisce che Creteva dedicò al suo re due piante. La prima, denominata mithridatia, è stata identificata da alcuni botanici con Erythornium dens-canis; ma l'identificazione non è convincente (non corrispondono né la descrizione né le proprietà officinali). A fine Settecento, non sappiamo per quale ragione, Commerson riprese il nome, battezzando Mitridatia quadrifida un endemismo di Mauritius, già descritto da Sonnerat come Tambourussa quadrifida. Si tratta dunque di un sinonimo. La seconda, denominata eupatorium, ha fatto discutere i botanici. In Dioscoride con il nome di eupatorion viene descritta un'erbacea generalmente identificata come Agrimonia eupatoria; è possibile che la pianta di Plinio sia la stessa, ma la sua descrizione sembra più vicina al nostro Eupatorium cannabinum, una specie le cui foglie e radici contengono alcune sostanze tossiche, ma allo stesso tempo sono usate da secoli nella medicina popolare per curare una varietà di affezioni. Questa duplicità fa pensare che potrebbe davvero trattarsi di uno dei componenti del mithridatium. In ogni caso, questa era l'opinione di Linneo che nel 1753 in Specie plantarum creò il genere Eupatorium. Appartenente alla famiglia Asteraceae, in passato era vastissimo (più 800 specie), ma nel corso del '900 è stato ripetutamente riclassificato e smembrato. Oggi comprende 40-60 specie di erbacee perenni presenti esclusivamente nelle regioni temperate dell'emisfero boreale, in America settentrionale, Europa e Asia. In Europa (e in Italia) abbiamo un'unica specie, appunto Eupatorium cannabinum, una grande perenne amante dei boschi e dei luoghi umidi, presente in tutto il continente, in Asia occidentale (compreso l'antico Ponto, regno del nostro Mitridate) e in Africa settentrionale. La medicina tradizionale le ha riconosciuto molte proprietà, sebbene sia tossica e pericolosa a concentrazioni elevate. Molto vigorosa e piuttosto infestante, è comunque utilizzata nei giardini informali, soprattutto sui bordi dei laghetti. Molte specie di grande valore ornamentale, spesso ancora descritte come Eupatorium nei testi di giardinaggio, sono stati trasferite ad altri generi: E. coelestinum è Conoclinium coelestinum, E. sordidum è Barttlettina sordida, E. rebaudianum, ovvero la stevia, nota per le sue proprietà dolcificanti, è Stevia rebaudiana. Ma soprattutto sono state trasferite a Eutrochium alcune spettacolari specie nordamericane, che almeno in Italia conosciamo come Eupatorium: Eutrichium purpureum, E. fistulosum, E. maculatum. Attorno a Eupatorium, c'è per altro una piccola corona di generi sudamericani più o meno affini che ne riprendono parzialmente il nome. Austroeupatorium, ovvero "Eupatorium nell'emisfero australe", creato da R. M. King e H. Robinson nel 1970, comprende 13 specie di piante erbacee e suffruticose presenti esclusivamente in Sud America (A. inulifolium, considerato estremamente invasivo, si è naturalizzato in alcune aree dell'Asia). Eupatoriastrum, creato nel 1903 da J.M. Greenman, è un piccolo genere endemico del Centro America (Messico, Salvador, Guatemala) con 5 specie. Eupatoriopsis ("di aspetto simile a Eupatorium"), creato da G.H. Hieronymus nel 1893, è un alquanto misterioso genere monotipico brasiliano, endemico dello stato di Manas Gerais, rappresentato dalla sola E. hoffmanniana. Per qualche approfondimento su Eupatorium, Austroeupatorium, Eupatoriastrum, Eupatoriopsis, si rimanda alle rispettive schede. Quandoque bonus dormitat Homerus, "Qualche volta anche il buon Omero sonnecchia", diceva Orazio: insomma anche a un grande come Omero capita di prendere una cantonata. E in questa storia di grandi botanici che sonnecchiano ce ne sono più di uno. All'inseguimento del dedicatario della Lysimachia, facciamo le pulci a Plinio, Boerhaave e Linneo, scoprendo che il copia-incolla non è nato con il web.  Dalla ricerca della "vera" lisimachia... Nel libro XXV della Naturalis historia, subito dopo aver parlato di Genzio e della sua genziana, prima di passare alla regina Artemisia e alla pianta che (forse) ne porta il nome, Plinio si sofferma su un'altra erba che prenderebbe il nome dal suo scopritore, la lisimachia: "Anche Lisimaco scoprì [la pianta] che da lui prende il nome, lodata da Erasistrato. Ha foglie verdi simili a quelle del salice, fiore purpureo, portamento cespuglioso con rami eretti, odore acre. Nasce in luoghi paludosi. La sua forza è tanta che posta sul giogo di due bestie da soma che litigano ne frena l'aggressività". Non dice altro su chi sia questo Lisimaco e su come abbia scoperto i poteri della magica pianta, ma va subito sottolineato che tra il suo nome e questi ultimi c'è un legame etimologico: Lisimaco è composto da λυσις (lysis, "liberare", "sciogliere"), e μαχη (mache, "battaglia"), dunque è interpretabile come "scioglitore di contese", o anche "pacificatore". Se alla pianta è stata attribuita la virtù di pacificare gli animali in forza del nome dello scopritore o se, al contrario, è stata collegata a un Lisimaco in forza di una credenza precedente, sono ipotesi aperte. La parola è greca e sicuramente Plinio si rifà a fonti greche (forse a quello stesso Erasistato, celebre medico del III sec. a.C.); in effetti anche in Dioscoride si parla di una pianta simile, che si chiama però lysimacheion. Le proprietà officinali sono quelle che anche Plinio cita nel libro successivo: è essenzialmente una pianta vulneraria, particolarmente efficace per curare le ferite recenti e stagnare il sangue; bruciandola, il suo fume acre tiene lontani i serpenti e uccide gli insetti. Anche l'habitat paludoso è lo stesso e così l'aspetto generale; le due descrizioni sono simili, tranne per due particolari: la pianta di Plinio è purpurea e ha un odore acre, quella di Dioscoride è giallo-dorata e inodora. E' probabile che queste discrepanze siano dovute a una svista (o, se preferite, a un colpo di sonno) di Plinio che ha tradotto con purpureus il gr. πυρρός, pyrròs, che non significa rosso ma giallo rossastro e ha scambiato il fumo acre della pianta bruciata con il suo odore da fresca. Oppure stanno parlando di piante diverse. In ogni caso, nei secoli successivi, la contraddizione non ha mancato di produrre i suoi effetti nefasti; i botanici successivi, puntando su erbacee palustri più o meno cespugliose con foglie simili al salice e con fiori rossi o gialli, hanno moltiplicato le ipotesi identificative; sotto l'etichetta lysimachia sono finite almeno una decina di piante anche molto lontane tra loro, tra cui Epilobium hirsutum, Oenothera biennis, Stachys palustris, o addirittura un arbusto, la ginestra dei tintori, Genista tinctoria, tirata in ballo da un addormentatissimo Ruel. Ma a contendersi la palma sono soprattutto il purpureo Lythrum salicaria (forse la "lisimachia purpurea" di Plinio) e la gialla Lysimachia vulgaris (forse il "lysimacheion dorato" di Dioscoride). Nel suo grande commento a Dioscoride (1544), Mattioli non ha dubbi: è proprio quest'ultima la vera lisimachia; la descrive e la fa disegnare sotto l'etichetta lisimachia prima, ma riserva qualche riga anche all'altra, battezzata lisimachia seconda "per avervi ritrovato quasi le medesime facultà". Ha le idee un po' meno chiare l'inglese William Turner che in A New Herball (il primo erbario in lingua inglese, 1551) pensa si tratti di due tipi della stessa pianta; con una traduzione letterale (ciò che i linguisti chiamano calco) conia il nome comune inglese loosestrife "che scioglie la lotta", battezzando quella gialla yealow loosstryfe e quella rossa red loosstryfe o purple losestryfe; è per questo che in inglese ancora oggi sia Lythrum sia Lysimachia sono ugualmente dette loosestrife. Non fa molta chiarezza neppure Caspar Bauhin che nel Pinax theatri botanici (1596) ne elenca e descrive undici tipi, molti dei quali oggi sono attribuiti a tutt'altri generi. Il nodo viene infine sciolto da Pitton de Tournefort che in Élémens de botanique (1694) crea il genere Lysimachia come lo intendiamo oggi. La sua scelta è poi validata da Linneo in Species plantarum 1753.  alla ricerca del "vero" Lisimaco Ma è ora di tornare a Lisimaco. Come abbiamo visto, Plinio non dà alcuna indicazione sulla sua identità. Va detto che si tratta di un nome piuttosto comune nell'antichità (l'autorevolissima Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft di Pauly e Wissowa ne elenca 21). Il più famoso di tutti è il diadoco Lisimaco, guardia del corpo e generale di Alessandro Magno e dopo la sua morte re di Tracia, Asia Minore e Macedonia. Visto il contesto (Plinio sta parlando di piante che hanno ricevuto il nome da un sovrano), la maggioranza dei commentatori concorda nell'identificare in lui il personaggio citato dallo scrittore romano. L'identificazione, già avanzata nel Medioevo dalla principessa bizantina Anna Comnena, è corrente nei commentari del Cinquecento e del Seicento: Mattioli lo nomina come Lisimaco di Macedonia e Bauhin precisa: "La lisimachia è detta così dallo scopritore, re Lisimaco figlio di Agatocle". L'indicazione è corretta: il padre di Lisimaco il diadoco si chiamava Agatocle. Eppure è probabilmente proprio la precisazione di Bauhin ad aver causato involontariamente il peggiore colpo di sonno di tutta questa storia. Nel 1727, il medico e botanico olandese Herman Boerhaave, illustre luminare ammirato da Linneo, pubblica il catalogo dell'orto botanico di Leida Historia plantarum quae in Horto Academico Lugduni-Batavorum crescunt; tra le piante esaminate c'è anche la lisimachia, di cui Boerhave scrive: "La Lysimachia prende il nome da Lisimaco, figlio del re di Sicilia, di cui si dice che per primo abbia scoperto questa pianta". Da dove spunta questo "Lisimaco figlio del re di Sicilia"? Anche se a quanto pare nessuno finora l'ha sottolineato, a mio parere nasce evidentemente da una lettura frettolosa del testo di Bauhin. Come per gli antichi il Lisimaco per antonomasia era il diadoco, o per noi la Vittoria per antonomasia è Vittoria d'Inghilterra, così l'Agatocle per antonomasia è Agatocle di Siracusa (che dal 307 a.C. alla morte si attribuì il titolo di re di Sicilia, l'unico a portarlo nell'antichità). Boerhaave, leggendo "re Lisimaco figlio di Agatocle", prende fischi per fiaschi e inventa un fantomatico figlio di Agatocle di Sicilia. Nel 1751, Linneo in Philosophia botanica inserisce una lista di nomi di piante derivati da opere letterarie, dal mito, da sovrani e promotori della botanica; nell'elenco di quelle dedicate ai re, troviamo "Lysimachia: Lisimaco di Sicilia". Evidentemente, senza fare alcuna verifica, ha ripreso la nota di Boerhaave. E così, sotto l'autorevole mantello linneano, il colpo di sonno di Boerhaave è (come si direbbe oggi) diventato virale. Non si contano le pubblicazioni (anche di alto livello scientifico) in cui Lysimachia è associata a un "Lisimaco figlio del re di Sicilia" o anche "Lisimaco re di Sicilia". Non parliamo poi della rete, in cui il top è la pagina di disambiguazione di Wikipedia inglese in cui si elencano tredici personaggi (reali o letterari) chiamati Lisimaco, tra cui "Lysimachus, a King of Sicily whom the Lysimachia, a genus of flowering plants, was named after". Sarebbe bastato consultare un repertorio come il Pauly-Wissowa per verificare che nessun figlio di Agatocle si chiamava Lisimaco e che nessun Lisimaco (neppure leggendario) ha mai regnato in Sicilia. Per completezza, visto che parliamo di repertori, va detto che proprio il Pauly-Wissowa avanza un'interpretazione alternativa (accolta da qualche testo e qui e là anche in rete): il Lisimaco di Plinio potrebbe anche non essere un re ma un medico o un botanico. Due sono i personaggi papabili: Lisimaco scrittore di agricoltura e botanica, citato come fonte da Varrone, Columella e dallo stesso Plinio; il medico Lisimaco di Kos, forse allievo di Erasistrato, commentatore del corpo ippocratico. Di nessuno dei due sappiano molto ed è possibile che siano la stessa persona. L'ipotesi, soprattutto grazie al collegamento con Erasistrato, è suggestiva, ma sembra adattarsi poco al contesto, in cui si parla di sovrani. Dunque, mi schiero con Mattioli e Bauhin a favore di Lisimaco di Tracia, personaggio colorito sulla cui vita troverete qualcosa in più nella sezione biografie. Ma alla nostra storia di errori manca ancora un breve capitolo. Come abbiamo visto, il laconico Plinio non spiega come Lisimaco, chiunque fosse, scoprì le virtù della sua erba eponimica. Una lacuna che qualcuno ha colmato confezionando una affascinante leggenda: un giorno Lisimaco (quasi sempre il re di Sicilia, a volte il figlio del re di Sicilia, ma anche il re di Tracia) mentre attraversava un campo fu assalito da un toro furioso; preso dalla disperazione, colse una lisimachia e la agitò davanti all'animale che immediatamente si calmò. Benché sia ripetuta in innumerevoli testi, questa storia è del tutto apocrifa e non risale all'antichità; sospetto che sia stata creata in epoca relativamente recente in ambiente anglosassone, sulla suggestione del termine comune loosestrife. Come per ogni leggenda metropolitana che si rispetti, non mancano le varianti: in una versione particolarmente colorita, la bestia furiosa è un leopardo; in una più realistica, Lisimaco calma semplicemente i suoi buoi facendo loro bere un infuso di lisimachia.  Chi ha paura della Lysimachia? Lysimachia è un grande genere, un tempo assegnato alla famiglia Primulaceae, quindi alle Myrsinaceae, che però a loro volta sono state riassorbite nella vastissima famiglia Primulaceae nella classificazione APG III. E' diffuso praticamente in tutto il mondo, soprattutto nelle fasce temperate, e comprende circa 160 specie per lo più erbacee. Sebbene L. vulgaris vanti, come abbiamo visto, un millenario uso officinale (è utilizzata soprattutto come febbrifugo e lenitivo) e sia anche una pianta tintoria (la sua tintura veniva usata per imbiondire i capelli o schiarire il mantello dei cavalli), le lisimachie sono soprattutto note come piante da giardino. Alcune sono di così facile coltivazione da essere considerate invasive. Ma sono tutte così belle (e tutto sommato non difficile da contenere), che vale la pena di accettare la sfida. Tra le specie alte, tutte scarsamente esigenti e amanti dei suoli umidi, le più coltivate sono L. punctata, una scelta vincente per giardini con terreno argilloso, umido e pesante; la bianca L. clethroides, con strane infiorescenze ricurve a collo d'oca, amante dei terreni acidi; L. ciliata, con fiori meno decorativi, ma molto apprezzata per le foglie purpuree nella bella cultivar 'Fireckraker'. Tra le tappezzanti, due specie sono particolarmente adatte anche per situazioni ombrose: L. nummularia, una strisciante con foglie tondeggianti, effettivamente molto invasiva nella forma comune, ma inestimabile nella cultivar 'Aurea' con foglie verde giallastro, più facile da controllare e insuperabile anche negli angoli più ingrati del giardino e come ricadente da muretti e fioriere; la mia preferita (amo le Lysimachiae e loro amano il terreno umifero del mio giardino-bosco) è però la spettacolare L. congestiflora 'Persian carpet', con foglie semi sempreverdi verde scuro variegate di porpora che contrastano con le infiorescenze dorate. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
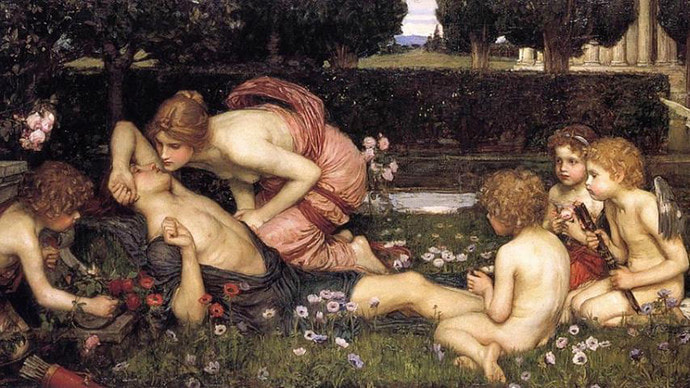

 RSS Feed
RSS Feed