|
Creato nel 1902, il Big Basin Redwoods State Park è il più antico della California. La sua nascita si deve alla battaglia di un gruppo di cittadini, con il sostegno dell'università di Stanford e del capo del suo dipartimento di botanica, William Russell Dudley, che ebbe un ruolo importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte di una delle meraviglie della natura, la sequoia della California (Sequoia sempervirens), che in meno di un secolo era stata portata alla soglia dell'estinzione dagli abbattimenti indiscriminati. Dudley era uno specialista di conifere e un appassionato raccoglitore; gli si deve la fondazione dell'erbario Dudley. A ricordarlo, il genere Dudleya, endemico dell'Oregon, della California e della Baja California. 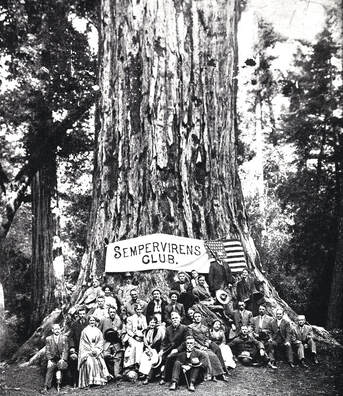 Salvare le sequoie Nell'ottobre 1899, un incendio scoppiò nei boschi delle Montagne di Santa Cruz presso Felton in California. Presto raggiunse le case di Wrights Station e l'azienda vinicola Mare Vista Winery; per scongiurare lo scoppio di un serbatoio di gas, il proprietario non esitò ad ordinare ai suoi dipendenti di estinguere le fiamme con 4000 galloni di vino rosé. Il fatto era abbastanza curioso da attirare l'attenzione della rivista inglese The Wide World Magazine che commissionò un articolo a C.F. Holder, presidente dell'accademia delle scienze della California, il quale chiese al noto fotografo e pittore californiano Andrew P. Hill di illustrarlo con le sue fotografie. Hill, oltre all'area devastata, per mostrare il contrasto, pensò di scattare qualche fotografia alle maestose sequoie (Sequoia sempervirens) secolari di un parco privato, il Welch’s Big Trees Grove (oggi parte dell'Henry Cowell State Park); aveva appena sistemato il suo cavalletto e scattato tre foto, quando arrivò l'infuriato proprietario che pretese i negativi, sostenendo che quelle foto avrebbero danneggiato la sua vendita di cartoline ai turisti. Hill ribatté che le fotografie erano per una rivista straniera e, anzi, sarebbero state un'ottima pubblicità. L'altro gli ripose piccato che la pubblicità non gli interessava, perché presto quegli alberi sarebbero diventati traversine ferroviarie e legna da ardere. La risposta sconvolse e indignò Hill: come, quella meraviglia della natura era destinata a perire? Da quel momento, salvare le sequoie della California divenne lo scopo della sua vita. Convinse due amici, l'avvocato e poeta di San Jose John E. Richard e la scrittrice Josephine Clifford McCrackin, che aveva perso la casa nell'incendio di Wrights Station, a denunciare la situazione sui giornali locali. Nel marzo 1900 McCrackin scrisse una lettera aperta al Sentinel di Santa Cruz intitolata "Salviamo gli alberi" che fu il primo atto pubblico della campagna. Il secondo fu una riunione convocata il 1 maggio 1900 da Hill e dal presidente dell'ateneo di Stanford David Starr Jordan nella biblioteca dell'Università, per discutere azioni concrete per salvare le sequoie. Durante la riunione emerse che i naturalisti dell'università avevano già individuato come area più adatta alla nascita di un parco naturale il Big Basin (molto più vasto e con alberi più grandi e antichi rispetto al bosco di Felton) e fu deciso di inviarvi in esplorazione un comitato, che includeva giornalisti, uomini d'affari e politici, presieduto da Hill e da Carrie Stevens Walter del San Jose Woman's Club. Due settimane dopo il gruppo visitò l'area e decise di costituirsi in associazione, denominata Sempervirens club dall'eponimo di Sequoia sempervirens, con un capitale iniziale di 32 dollari, raccolti facendo passare un cappello tra i presenti. Come presidente fu scelto l'avvocato di San Francisco Charles Wesley Reed, che contava diversi appoggi politici, affiancato da varie personalità più o meno eminenti come vicepresidenti onorari. A rappresentare la scienza, William Russell Dudley (1849-1911), capo del dipartimento di botanica sistematica di Stanford, che aveva partecipato al meeting del 1 maggio e da tempo denunciava i rischi di estinzione della sequoia della California. Dudley era cresciuto in una fattoria del Connecticut e fin da bambino si era innamorato della natura; ventunenne si iscrisse alla Cornell University, dove per qualche tempo si pagò gli studi mungendo le mucche della fattoria universitaria. Caso volle che suo compagno di stanza fosse David Starr Jordan che abbiamo già incontrato nelle vesti di presidente dell'università di Stanford; David divenne ittiologo, mentre Willie (come lo chiamavano in famiglia) scelse la botanica. Già prima di laurearsi fu lettore di botanica alla Cornell, che lo utilizzò anche come raccoglitore. Dopo essersi laureato nel 1876, si perfezionò per qualche tempo a Strasburgo e Berlino, dopo di che insegnò botanica alla Cornell fino al 1892, quando venne nominato a Stanford, dove prese servizio nell'autunno 1893, reclutato dall'amico Jordan che era appena stato scelto come presidente del neonato ateneo. Il dipartimento di botanica era tutto da inventare, non c'erano né strutture né laboratori, ma per Dudley, che fino ad allora si era occupato della flora degli Stati uniti orientali (i suoi principali lavori riguardavano le flore della contea di Cayuga, della contea di Lackawanna e del Wyoming) ogni fatica era ricompensata dalla ricchissima flora californiana. Il suo più grande amore divennero gli alberi, in particolare le conifere, di cui studiò le relazioni evolutive e la distribuzione geografica. Era facile incontrarlo con i suoi studenti in escursioni botaniche in varie parti dello stato, specialmente nella Sierra Nevada e nella Sierra Santa Lucia. Più conosceva la flora californiana, più crescevano le sue raccolte (oggi formano il nucleo principale del Dudley Herbarium dell'Università di Stanford) ma anche la consapevolezza della devastazione degli habitat naturali e la preoccupazione per gli alberi minacciati dalla speculazione. Nel 1892 fu uno dei primi membri del Sierra Club, una delle primissime associazioni ambientaliste, fondata da John Muir per proteggere la Sierra Nevada e i suoi boschi di sequoie giganti Sequoiodendron giganteum. Nel 1895, insieme allo stesso Muir e al geologo di Berkeley Joseph Le Conte, fu uno dei portavoce del club in un forum pubblico tenutosi a San Francisco sul tema "Parchi nazionali e riserve forestali", in cui sostenne che bisognava cessare di cedere a privati le terre demaniali, che andavano invece convertite in parchi nazionali. In un articolo pubblicato sul bollettino del Sierra club tra la fine del 1895 e l'inizio del 1896, riferì che le sue indagini sul campo dimostravano che i due milioni di acri di sequoie che un tempo si estendevano per cinquecento miglia lungo le colline costiere dell'Oregon e della California stavano scomparendo a un ritmo tale che l'antica specie rischiava l'estinzione. Insieme a un collega di Stanford, il docente di ingegneria civile Charles Wing, visitò e mappò l'area del Big Basin, scoprendo che i migliori boschi di sequoie erano stati venduti a compagnie di legname e decimati. L'unico modo per salvarli era acquistare i boschi e trasformarli in un parco statale, e l'area più adatta era proprio il Big Basin, che la distanza dalla ferrovia e le peculiarità topografiche avevano preservato pressoché intatto; tuttavia, i boscaioli avevano già iniziato il loro lavoro e, se non venivano fermati, scrisse in un articolo pubblicato nel marzo 1900, entro due anni "la regione, invece di un Eden, diventerà peggio del Sahara". Nella fatidica riunione del maggio 1900 nella biblioteca di Stanford, l'indignazione di Hill e la competenza di Dudley si incontrarono. Tra l'estate e l'autunno la campagna per salvare le sequoie del Big Basin prese il volo, con ogni membro del club impegnato a suo modo per smuovere l'opinione pubblica, coinvolgere altre associazioni, arruolare politici e convincere gli industriali che i turisti attirati dal parco avrebbero portato più soldi dello sfruttamento del legname. L'argomentazione fece breccia almeno su Henry L. Middleton che si dichiarò disposto a vendere i 14000 acri che la sua compagnia possedeva nel Big Basin offrendone al club l'opzione di acquisto per un anno. Dudley, che da tempo era membro dell'American Forestry Association, fece da tramite con il servizio forestale nazionale e ottenne l'appoggio del suo capo, Gifford Pinchot. Reed scrisse una proposta di legge per l'istituzione di un parco statale che nel gennaio 1901 fu presentata all'Assemblea dello Stato della California da un politico amico; respinta nella forma iniziale, che prevedeva lo stanziamento di 500.000 dollari per l'acquisto di 5000 acri, fu approvata quando venne ridotta a 250.000 dollari e a 2500 acri. Era una grandissima delusione per il Sempervirens club che puntava su un grande parco da 35.000 a 60.000 acri; anche Dudley riteneva che "per gli scopi scientifici, e anche per un buon parco pubblico" il minimo fossero 35.000 acri. L'istituzione del California Redwood Park (dal 1927 avrebbe mutato nome in Big Basin Redwoods State Park) venne approvata dal senato con voto quasi unanime nel marzo 1901. Per presiedere alla sua realizzazione, venne creata una commissione, formata dal governatore e da quattro membri di sua nomina, tra cui il professor Dudley, che ne fu il segretario fino allo scioglimento nel 1905. Finalmente, nel settembre 1902, con l'acquisto di 2500 acri di foresta, più 800 acri di chaparral e 500 acri di terreno da riforestare donati da Middleton, il parco divenne realtà. Molto più piccolo di quanto sperato, era comunque un inizio, nonché il primo dei circa 280 tra parchi statali e riserve naturali che oggi esistono in California. Il Sempervirens Club non si sciolse, ma continuò la sua battaglia per estenderne i limiti. Negli anni successivi arrivarono piccole donazioni di altri terreni e nel 1916 il parco incorporò quasi 4000 acri convertiti da terre federali, estendendosi così fino alla costa. Oggi la sua estensione è di 10,800 acri (44 Km2). Oltre ad ospitare il più grande gruppo di Sequoia sempervirens a sud di San Francisco, include una varietà di ambienti che vanno dalle foreste miste di sequoie, altre conifere e querce al chaparral, ai canyon umidi, alla vegetazione costiera, estendendosi dal livello del mare a circa 600 metri di altitudine. Purtroppo nell'agosto 2020 è stato catastroficamente investito dagli incendi che hanno devastato la California settentrionale; sono andate distrutte tutte le strutture del parco e almeno 15.000 alberi, principalmente abeti di Douglas. Anche alcune sequoie sono cadute, ma la maggior parte di quelle più antiche sono rimaste in piedi. Dopo essere rimasto chiuso per due anni, oggi il parco è di nuovo aperto, sebbene in modo limitato. Il paesaggio ha mutato volto ma, secondo gli esperti sta lentamente recuperando. La maggior parte delle sequoie è sopravvissuta, e dai tronchi anneriti dall'incendio stanno rispuntando ciuffi di fogliame. Non è certo la prima volta che questi antichi giganti affrontano il fuoco: si sono evoluti con gli incendi e si riprendono molto più facilmente di altre specie, grazie alla corteccia spessa più di 30 cm che protegge gli strati più interni dal fuoco, ai tannini che proteggono le eventuali ferite dagli attacchi di funghi e insetti, alle gemme dormienti sia alla base sia lungo il tronco e i rami che permettono loro sia di emettere germogli basali sia di rigermogliare dai rami e dallo stesso tronco.  Perché i botanici cambiano i nomi: il caso di Dudleya Ma è ora di ritornare al prof. Dudley che tanto fece per far nascere il parco. Anche negli anni successivi continuò ad impegnarsi nelle battaglie ambientaliste. Nel 1904, insieme all'amico Jordan e alla botanica Alice Eastwood, partecipò a una manifestazione indetta a San Francisco dal California Club per bloccare la vendita di 1000 acri di foresta contenenti antiche sequoie ai piedi del Monte Tamalpais. Era un insegnante innamorato della sua materia e amato dagli studenti e nei suoi 18 anni di insegnamento a Stanford formò intere generazioni di eccellenti botanici; era uno studioso coscienzioso, ma forse fin troppo autocritico e forse per questo le sue pubblicazioni californiane si limitano ai numerosi articoli, dedicati soprattutto alle foreste e agli alberi della California, che egli pubblicò tra il 1889 e il 1910 sul Bollettino del Sierra Club e su The Forester, la rivista dell'American Forestry Association. Progettò a lungo un lavoro complessivo sulle conifere degli Stati Uniti occidentali, ma il progetto non andò mai oltre lo stadio di manoscritto incompleto. Nel 1908 andò Persia per esplorarne le foreste; in Egitto contrasse una grave bronchite che degenerò in tubercolosi, che nel 1910 lo costrinse a lasciare l'insegnamento e nel 1911 lo portò alla morte. Grande esploratore della flora californiana, è ricordato dall'eponimo di vari funghi (fu anche micologo) e di piante come gli endemismi Triteleya dudleyi, Pedicularis dudleyi e Polystichum dudleyi. Nel 1903 Britton e Rose gli dedicarono il genere Dudleya, endemico di ambienti rocciosi lungo la costa pacifica, dall'Oregon meridionale alla Baja California settentrionale, con una laconica nota: "Nominato in onore del prof. William R. Dudley della Stanford University". Questo genere di una cinquantina di piante succulente della famiglia Crassulaceae è caratterizzato da una grande varietà morfologica (dalle piccole geofite decidue alte pochi cm alle grandi sempreverdi con rosette di 50 cm di diametro), con fiori a stella simili a quelli di Sedum, oppure tubolari o amcora pendenti e campanuliformi come quelli di Echeveria. Solo recentemente tanta varietà è stata ricondotta a un unico genere, mentre i primi botanici che si occuparono di queste piante le attribuirono variamente ai generi Echeveria, Cotyledon e Sedum. Queste incertezze sono perfettamente testimoniate da Dudleya cespitosa, una geofita tuberosa endemica della California meridionale, la prima ad essere descritta. Nel 1803 Haworth la pubblicò come Cotyledon cespitosum, mentre nel 1811 von Jacquin la classificò come Sedum cotyledon e Aiton come Cotyledon linguiformis. Altre due specie, Dudleya pulverulenta e D. lanceolata, furono invece pubblicate nel 1840 da Nuttall come Echeveria pulverulenta e E. lanceolata. All'inizio del Novecento una vera rivoluzione fu attuata da Nelson e Rose che sistemarono questo gruppo di piante in ben tre nuovi generi: Dudleya, cui attribuirono una sessantina di specie, 40 delle quali descritte da loro per la prima volta, Stylophyllum con 12 specie, e Hasseanthus con 4 specie. Negli anni '30, Alwin Berger li ritenne tutti e tre superflui, spostando Dudleya e Stylophyllum in Echeveria e Hasseanthus in Sedum, i due generi da cui riteneva si fossero rispettivamente evoluti. Le sue conclusioni furono largamente accettate dai botanici fino alla metà del Novecento, quando incominciarono ad apparire le prime analisi filogenetiche molecolari. Nel 1942, Reid Moran separò nuovamente Dudleya e Stylophyllum da Echeveria, riunendoli in Dudleya come sottogeneri; mantenne Hasseanthus come genere distinto, ma strettamente imparentato. Fu il punto di partenza delle ricerche successive che hanno dimostrato che Dudleya si è evoluto in epoca relativamente recente (5 milioni di anni fa) da Sedum, non da Echeveria, come si riteneva in precedenza, e va assegnato alla tribù Sedoideae. Anche se rimangono molti punti da chiarire, oggi al variabile genere Dudleya sono assegnate circa 50 specie, divise in tre sottogeneri: Dudleya (Eududleya secondo la terminologia di Moran), caratterizzato da rosette di foglie appiattite e fiori con petali saldati in un tubo; Stylophyllum, caratterizzato da foglie strette che assomigliano a dita o più raramente da foglie piatte, e petali non fusi che si allargano al centro; Hasseanthus, caratterizzato da cormi sotterranei, piccole foglie che cadono dopo la fioritura, fiori ampiamenti diffusi. Le Dudleya in genere si presentano come succulente da piccole a grandi con foglie carnose, in alcune specie appiattite, in altre tubolari, in altre ancora orbicolari, riunite a rosetta; in diverse specie sono ricoperte da un rivestimento ceroso, detto farina, generalmente bianco, gessoso o farinoso; in poche specie a proteggere le piante dal sole è un sottile strato oleoso e appiccicoso. Il colore del fogliame varia dal verde al grigio. Le rosette possono essere solitarie o cespitose, con diverse rosette che partono da un caudex centrale. Mentre, ad eccezione delle specie più grandi, nel resto dell'anno rimangono piuttosto nascoste nelle fessure delle rocce che sono il loro habitat tipico, al momento della fioritura al centro delle rosette emergono uno o più robusti gambi carnosi che in genere si dividono all'apice in divesri rami, ciascuno dei quali portano 10-15 piccoli fiori (o più) comunemente bianchi o gialli, ma anche rosa, arancio o rossi. Nelle specie di maggiori dimensioni, come D. brittonii (non ha caso nota come "giant Dudleya"), la rosetta raggiunge i 50 cm di diametro e l'infiorescenza può arrivare anche a un'ottantina di cm, mentre nelle minuscole specie del sottogenere Hasseanthus come D. brevifolia le foglie rimangono quasi sepolte nella terra e il peduncolo florale non supera i 4 cm. A differenza di Echeveria, con il quale è ancora spesso confuso, Dudleya non è ancora largamente coltivato, ma purtroppo ha attirato fin troppo l'attenzione dei collezionisti: uno dei pericoli maggiori per la sopravvivenza di molte specie, endemiche di aree piuttosto ristrette, è la raccolta indiscriminata in natura di quelle più rare, che vendono vendute a carissimo prezzo soprattutto sul mercato asiatico. Una recente legge ha introdotto una multa di 5000 dollari per ogni esemplare di Dudleya raccolto su suolo pubblico, che salgono a 40.000 alla seconda infrazione. A minacciare le Dudleya sono anche l'espansione degli ambienti urbani e sempre più i cambiamenti climatici, ed in particolare la siccità invernale: ad differenza di altre succulente, sono per lo più originarie di aree con piogge invernali, che è anche la stagione del loro massimo rigoglio, mentre l'estate, quando la temperatura supera i 30°, è la stagione del riposo.
0 Comments
Ancora negli anni '80 del Novecento, quando ormai era in pensione, era ben noto ai botanici che affluivano da ogni parte del mondo in Sudafrica per studiare la sua flora, che una visita da non perdere era quella alla piccola casa di Elsie Elisabeth Estrerhuyzen a Città del Capo. La sua competenza era tale da farla considerare un'enciclopedia vivente, mentre il suo contributo alla raccolta di nuove specie, soprattutto di alta montagna, l'aveva resa leggendaria: le è infatti accreditata la raccolta di ben 36.000 esemplari d'erbario. Eppure Elsie, come la chiamavano tutti, non era affatto una Indiana Jones della botanica in gonnella: era una piccola esile donna amante dei gatti e della montagna, che non guidava e si muoveva dappertutto in bicicletta; così modesta, che, una volta studiato a fondo un genere e, "colmati i vuoti" dell'erbario Bolus, dove lavorò per decenni, preferiva lasciare ad altri la pubblicazione. La ricordano due generi endemici delle montagne delle Provincie del Capo, che esplorò metodicamente per decenni: Esterhuysenia (Aizoaceae) e Trieenea (Scrophulariaceae). 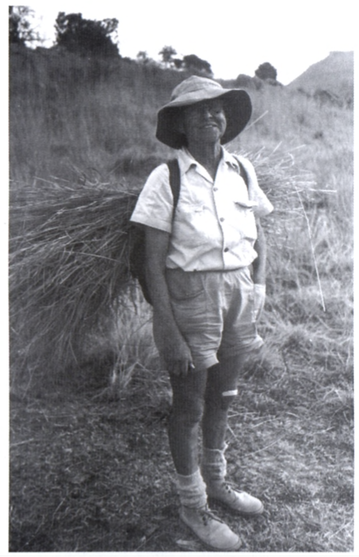 Raccogliere piante per "colmare i vuoti" Nel giugno 2006, nella sala conferenze dell'orto botanico di Kirstenbosch si riunì una piccola folla per dare l'ultimo saluto a Elsie Elizabeth Esterhuysen (1912-2006) che si era spenta all'inizio di quell'anno a 93 anni. John Rourke, curatore del Compton Herbarium e presidente della Botanical Society of South Africa, aprì il suo ricordo con queste parole: "Oggi siamo qui per celebrare la vita di una leggenda, perché Elsie era una leggenda, certamente lo era per la comunità botanica locale". A renderla tale non era solo la sua età venerabile, né una personalità indubbiamente fuori del comune, ma le sue incredibili raccolte botaniche: con 36.000 esemplari d'erbario, è stata uno dei più prolifici raccoglitori di sempre. Eppure non c'era nulla di eroico in questa piccola ed esile donna. Elsie era nata a Cape Town in una famiglia di avvocati; dopo aver studiato alla Wynberg Girls’ High School, si iscrisse all'Università di Cape Town dove nel 1933 conseguì la laurea di primo livello (Master of Arts) in botanica con una tesi sull'anatomia di Myrothamnus flabellifolius, una pianta xerofila nota come "resurrection plant" per la sua capacità di rinverdire alla prima pioggia anche quando sembra totalmente disseccata. Ma alle ricerche di laboratorio già allora preferiva di gran lunga quelle sul campo. Dopo aver lavorato per poco tempo nel Dipartimento educativo, nel 1935 grazie a una borsa di studio poté studiare la rigenerazione del fynbos a Kirstenbosch dopo l'eliminazione di piante aliene. La sua aspirazione era entrare a far parte del gruppo di ricerca che, guidato da Pole Evans, stava mappando la flora del Sudafrica, ma la sua domanda fu respinta per la semplice ragione che era una donna. Così nel 1936 accettò un posto di assistente al McGregor Museum di Kimberley, diretto dalla geologa e botanica Maria Wilman, che in quegli anni stava dirigendo un progetto di ricerca sulla flora del Griqualand occidentale. Dato che l'area da esplorare era vasta, per raggiungere i luoghi più remoti la direttrice insistette che imparasse a guidare. Ma un giorno Elsie Esterhuysen rimase bloccata a un passaggio a livello: si spaventò talmente che da quel giorno non guidò più. In compenso, si procurò una bicicletta e divenne una provetta ciclista. Nel 1938 tornò a Cape Town e cominciò a lavorare per il Bolus Herbarium, dove avrebbe trascorso tutta la sua vita professionale. Per ben 18 anni, però, non fece parte ufficialmente dello staff, venendo pagata di volta in volta con la cassa per le piccole spese; solo nel 1956, su insistenza del nuovo curatore, Ted Schelpe. fu creato per lei un posto di ricercatrice, con uno stipendio fisso. Grande appassionata di montagna, fin dal 1935 si era iscritta al club alpinistico del Sudafrica (MCSA). Conoscendo questa passione, le fu affidata la ricognizione della flora di alta quota delle montagne del Capo, che all'erbario era documentata in modo irregolare. Insomma, come lei stessa si espresse, il suo compito era "colmare i vuoti". Quasi ogni week end, approfittando del passaggio di qualche membro del MCSA, esplorava un angolo di quelle montagne, e tornava a valle con un sacco nero pieno di piante. Durante le vacanze, approfittava delle escursioni organizzate dal club per erborizzare in altre aree, come il Drakensberg. Non bisogna però pensare che raccogliesse a caso. Per "colmare i vuoti" concentrava la sua attenzione su un genere rappresentato in modo inadeguato e quando individuava una specie che poteva essere nuova, ritornava più volte nell'area per studiarne i tempi di fioritura e l'ecologia, raccogliere semi e frutti; esplorava i dintorni per mapparne la distribuzione e studiare specie affini, a volte per anni. Metteva a confronto le proprie raccolte con il materiale d'erbario e con le pubblicazioni, e, quando aveva finito, il genere era perfettamente documentato nelle sue schede, con gli esemplari ben montati nell'erbario e la loro tassonomia pronta per la pubblicazione. Un compito che però lasciava volentieri agli "accademici". Così, anche se scoprì almeno 150 taxa, pubblicò pochissimo. La maggiore eccezione è costituita dalle Restionaceae, di cui pubblicò una cinquantina di specie, soprattutto grazie alle insistenze del botanico svizzero Hans Peter Linder, uno dei tanti giovani studenti e perfezionandi che impararono ad amare e conoscere la flora sudafricana grazie alla sua generosità e disponibilità. Insieme a T. M. Salter, pubblicò inoltre alcune specie di Erica. Tra le sue scoperte più sensazionali, quella di Protea nubigena, una specie molto rara che vive solo nei pascoli ad alta quota dell'uKhahlamba-Drakenberg nel Natal. Nel 1989 l'Università di Città del Capo le conferì la laurea honoris causa (Master of Science). La lettera di accettazione al rettore la dice lunga sulla sua modestia: "Grazie per la sua cortese lettera del 9 gennaio. Accetto la laurea onoraria e apprezzo l'onore. Tuttavia mi chiedo se lo staff dell'erbario Bolus è stato consultato. Se la questione non fosse riservata, vorrei farlo io stessa, perché non mi sembra che il mio lavoro meriti questo grado. Spero che il Consiglio [di facoltà] non sia caduto in errore pensando che la scoperta di nuove specie sia chissà che risultato, perché non lo era. A parte questo, ho lavorato come tecnico mantenendo l'erbario in ordine e aggiornato". Altri tratti della sua singolare personalità - che dovette colpire profondamente chiunque la conobbe -emergono dai ricordi pubblicati in occasione della sua commemorazione. Ogni giorno, sulla sua fida bicicletta faceva la spola tra l'erbario e la sua modestissima casa, doveva viveva con alcuni adorati gatti; guidava studenti e perfezionandi in gite in bicicletta, distaccando anche i più giovani; detestava le ingiustizie ed era socialmente impegnata; ma il suo vero ambiente era la montagna, con la quale aveva un contatto così intimo che preferiva dormire all'aperto, su un giaciglio improvvisato di paglia ed erbe, piuttosto che in una tenda. Per celebrare i suoi ottant'anni, insieme agli amici del Club alpino, scalò lo Sneeuberg, la cima maggiore del Cederberg (2027 metri).  Tante specie e due generi A questa formidabile raccoglitrice, i tanti botanici con cui collaborò hanno dedicato una trentina di specie e due generi validi. Ad esempio, il suo "capo" Louisa Bolus le dedicò non meno di sette Aizoaceae, tra cui Delosperma esterhuyseniae e Gibbaeum esterhuyseniae; Compton Erica esterhuyseniae; Hilliard Selago elsiae (una specie oggi estinta) e Selago esterhuyseniae; Pillans Restio esterhuyseniae. Ci sono anche dediche più nascoste: alludendo alla sua passione per le montagne, dove si muoveva con l'agilità delle antilopi saltarupi Oreotragus oreotragus, E G. H. Oliver le dedicò Erica oreotragus. Con lo stesso gioco di parole, Karis pensava a lei nominando Monticapra ("capra di montagna") una sezione del genere Disparago. I generi dedicati a Elsie Esterhuyen sono tre, due in modo diretto, uno anch'esso in modo indiretto ed allusivo. Ad aprire le danze fu una delle sue colleghe al Bolus Herbarium, Frances Margaret Leighton, specialista dei generi Ornithogalum e Agapanthus, che nel 1944 le dedicò Elsiea con una motivazione semplice ed eloquente: "Il nome del genere onora Miss Elsie Esterhuysen del Bolus Herbarium, le cui raccolte hanno dato un valido contributo alla conoscenza della flora delle montagne più alte del Capo sudoccidentale". Il genere, stabilito sulla base di una specie raccolta quell'anno dalla stessa Esterhuysen, Elsiea corymbosa, è considerato sinonimo di Ornithogalum, e la specie è stata rinominata Ornithogalum esterhuyseniae. Nel 1967 Louisa Bolus, che, come abbiamo già visto, aveva già dedicato molte specie alla più prolifica dei suoi raccoglitori, le dedicò anche un genere, Esterhuysenia (Aizoaceae). Laconica (e tecnica) la dedica: per Elsie Elizabeth Esterhuysen, raccoglitrice del tipo, Provincia del Capo, nel distretto di Worcester; Hex River Mountains, Milner Peak, versante est, sulle sporgenze, 5,500-6,000 piedi, dicembre 1948. La specie in questione è Esterhuysenia alpina, una delle sei di questo piccole genere endemico di un'area relativamente ristretta della Provincia del Capo occidentale (distretti di Caledon, Ceres, Robertson, Worcester); sono piccoli arbusti nani, spesso a cuscinetto, che crescono tra le rocce intorno ai 2000 metri di altitudine. Hanno foglie carnose, tra quadrangolari a cilindriche, caratterizzate da un apice mucronato, fiori per lo più solitari con numerosissimi petali (in realtà staminoidi) bianchi, rosa o viola; i frutti sono capsule con cinque loculi, come quelli degli affini Ruschia e Lampranthus, di cui si distinguono perché mancano sia degli opercoli del primo, sia delle ampie ali del secondo. Tutte le specie sono rare, spesso limitate a aree molte ristrette, ma le loro popolazioni sono stabili. Anche il terzo genere dedicato a Esterhysen si deve a una botanica sudafricana, Olive Mary Hillard, nota soprattutto per aver fatto risorgere l'allora quasi moribondo orto botanico di Edimburgo, a sua volta una notevolissima raccoglitrice. Trovandosi già impiegati i possibili e più ovvii nomi ricavati da nome personale e cognome, Hillard dovette ricorrere a un vero e proprio gioco enigmistico: il suo Trieenea allude infatti alle tre E che formano le iniziali di Elsie Elisabeth Esterhuysen. Anch'esso endemico della Provincie del Capo occidentale e meridionale, questo genere della famiglia Scrophulariaceae comprende erbacee perenni o piccoli arbusti, più raramente annuali, che vivono in habitat montani; sette specie su dieci sono endemiche del Cedarberg, alcune note solo dagli esemplari d'erbario, altre ristrette ad aree molto limitate. Ha invece un areale relativamente più esteso T. glutinosa, in precedenza Phyllopodium glutinosum, che si spinge anche nella Provincia del Capo orientale. E' un piccolo arbusto che vive nelle spaccature delle rocce, con fusti eretti, foglie lievemente carnose con lamina quasi triangolare e margini dentati, piccoli fiori bianchi raccolti in brevi infiorescenze. Tra le specie del Cederberg, T. elsiae ricorda anche nell'eponimo Elsie Esterhuysen che la scoprì sul Sandfontein Peak, nel Cedarberg meridionale, il 5 aprile 1947. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, anche in Sud Africa alle donne si apre la carriera accademica. La prima ad insegnare botanica in istituto universitario sudafricano fu la statunitense Bertha Stoneman, che era stata una delle primissime laureate in scienze naturali del suo paese. La sua allieva Augusta Vera Duthie fu la prima persona formata in Sudafrica ad ottenere un lettorato di botanica, nel 1902, all'università di Stellenbosch. All'epoca aveva solo 21 anni. Come lettrice, poi come lettrice senior, vi avrebbe lavorato per quasi quarant'anni, dedicando le sue ricerche principalmente alle piante e all'ecologia degli Stellenbosch Flats, la pianura alluvionale dove sorge la città. A preservare almeno in parte questa flora ricca di endemismi, provvede la piccola riserva naturale che le è stata dedicata. Suo merito anche aver gettato le basi dello Stellenbosch Botanical Garden, il più antico orto botanico universitario del Sudafrica. A ricordarla la rara iridacea Duthiastrum linifolium.  Esplorare la flora... del campus universitario Il primo orto botanico universitario sudafricano, quello dell'Università di Stellenbosch, nacque nel 1902, e a fondarlo fu la botanica Augusta Vera Duthie (1881-1963), che fu anche la prima persona educata in Sudafrica ad ottenere un lettorato di botanica in un'università del paese. Augusta (ma in famiglia la chiamavano Avie) aveva trascorso l'infanzia nella tenuta di Belvidere, posta in splendida posizione panoramica sulla laguna di Knysna (Provincia occidentale del Capo) che apparteneva alla sua famiglia da oltre un secolo. Come i suoi fratelli, fu inizialmente educata in casa, finché a 17 anni si iscrisse all'Huguenot College di Wellington per studiare matematica e fisica. A indirizzarla verso la botanica fu una straordinaria insegnante, Bertha Stoneman (1866-1943), la prima donna in assoluto ad insegnare in un istituto universitario sudafricano. Nata negli Stati Uniti, nel 1894 Stoneman si era laureata in scienze naturali alla Cornell University di New York, specializzandosi in micologia (era una delle primissime donne a farlo). Dopo alcune esperienze di insegnamento in patria, nel 1897 accettò un incarico di un anno come lettrice di botanica all'Huguenot College, che era stato fondato appena due anni prima e fu il primo istituto sudafricano di istruzione superiore riservato alle ragazze. A convincerla a trasformare quell'incarico temporaneo nella sua occupazione per la vita furono, da una parte, la straordinaria ricchezza della flora sudafricana; dall'altra il suo impegno a favore dell'educazione scientifica femminile. Stoneman creò praticamente dal nulla il dipartimento di botanica del College, dotandolo di un erbario con le piante che raccoglieva nelle escursioni cui dedicava il tempo libero. Per le sue allieve nel 1906 pubblicò Plants and their Ways in South Africa che per molti decenni fu uno dei manuali scolastici più diffusi nel paese. Eccellente insegnante, formò generazioni di allieve preparate, tra le quali oltre a Avie Duthie, vale la pena di citare l'illustratrice Olive Coates Palgrave, autrice insieme al figlio Keith Coates Palgrave di Trees of Southern Africa; la micologa Averil Maud Bottomley, che lavorò presso il dipartimento delle crittogame dell'erbario nazionale di Pretoria, cui contribuì con importanti raccolte di funghi; e soprattutto la micologa e batteriologa Ethel Doidge, la prima donna ad ottenere un dottorato in Sudafrica, autrice del monumentale The South African fungi and lichens e di ricerche fondamentali sui patogeni di diverse colture agricole. All'inizio del Novecento, l'Hugenot College non assegnava ancora diplomi; così Augusta Duthie completò gli studi all'Università di Città del Capo e nel 1901 fu una delle prime allieve di Stoneman ad ottenere il diploma di Bachelor of Arts; l'anno dopo (aveva appena 21 anni) fu nominata lettrice di botanica presso il Victoria College (oggi Università di Stellenbosch). Come la sua maestra all'Huguent College, dovette creare dal nulla il dipartimento di botanica: aveva una stanza per le lezioni, ma non c'era né un laboratorio, né un erbario, né un orto botanico dove mostrare le piante agli allievi; per non parlare di microscopi e tanto meno di assistenti. Fortunatamente, però, benché sorgessero in una delle zone del Sudafrica più battute fino dal Seicento (Stellenbosch si trova a una cinquantina di km ad est di Cape Town), proprio attorno agli edifici universitari c'era molto da scoprire. Posta ai piedi dei rilievi della Stellenbosch Mountain, la città si trova in una pianura alluvionale (Stellenbosch Flats) con suolo argilloso e una vegetazione diversa da quella delle dune sabbiose dei Cape Flats di cui costituisce la continuazione. E' una zona di confine tra il fynbos granitco di Boland e il renosterveld dello Swartland, dove non mancano le piante rare o endemiche. Anche se era oberata dal lavoro (era costretta a supplire i magri proventi dello stipendio di lettrice con lezioni di inglese, storia e botanica in una scuola media), Duthie incominciò ad esplorare questo ricco terreno di caccia per creare un erbario e accanto all'edificio principale del Campus allestì alcune aiuole didattiche, il primo nucleo del futuro orto botanico. Per tre anni di seguito, il suo dipartimento riuscì a vincere il premo assegnato dal Dipartimento per l'educazione del Capo al miglior erbario montato e classificato, grazie al quale poterono essere acquistati libri, dieci microscopi e un microtomo. Nel 1904, l'erbario aveva raggiunto i 500 esemplari. Nel 1909, venne finalmente assunto un assistente part time, anche se in compartecipazione con il dipartimento di zoologia. Intanto Augusta aveva continuato a studiare e nel 1910 conseguì la laurea magistrale (Master of Arts) all'Università del Capo. Nel 1912 fu affiancata da un secondo lettore di botanica, l'inglese Sidney Garside, che si era laureato all'università di Manchester ed era specializzato in fisiologia vegetale. Duthie ne approfittò per ottenere un anno di congedo di studio, che trascorse in Inghilterra all'Università di Cambridge. Al suo ritorno in Sudafrica, nel 1913, riprese immediatamente ad occuparsi dell'espansione del dipartimento: entro il 1920, fu creato un laboratorio sperimentale e un museo botanico che presto divenne il più ampio del paese. Nel 1920, ottenne un secondo congedo per ragioni di salute, che trascorse in Australia ad erborizzare. All'inizio degli anni '20, al dipartimento di botanica ci furono molti cambiamenti: nel 1920 Garside tornò in Inghilterra; nel 1921 l'università decise di creare una cattedra di botanica, che però non fu assegnata ad Augusta Duthie, ma a uno dei suoi ex allievi, Gert Cornelius Nel, che dopo aver ottenuto la laurea di primo livello a Stellenbosch si era perfezionato a Berlino dove aveva studiato tra l'altro con Engler. Da quel momento, a Duthie, che era stata promossa lettrice senior, fu assegnato soprattutto l'insegnamento delle Crittogame e dei funghi; ma essendo venute meno molte incombenze amministrative, poté dedicare più tempo alle ricerche sul campo. Anche se fece raccolte pure nella zona di Knysna, si concentrò sulla flora degli Stellenbosch Flats che, grazie a una serie di articoli pubblicati da Duthie tra il 1924 e il 1940 sulla rivista dell'Università, Annale van die Universiteit van Stellenbosch, divenne la più studiata del paese. Il più ampio di questi lavori, Vegetation and Flora of the Stellenbosch Flats, pubblicato nel 1929 e presentato come tesi di laurea di dottorato all'Università del Capo, è un approfondito studio sull'intera ecologia dell'area e ancora oggi, dopo quasi un secolo, è un testo di riferimento. L'area è particolarmente ricca di bulbose e le sei specie di Angiosperme la cui scoperta e pubblicazione si deve a Duthie appartengono tutte alla famiglia Asparagaceae (generi Eriospermum, Ornithogalum e Drimia). Le sue ricerche toccarono però anche le crittogame dei generi Selaginella e Isoetes e i funghi Myxomyceti. Nel 1933 un evento tragico mutò la sua vita: in seguito alla morte dell'ultimo dei suoi fratelli, si trovò ad essere l'unica in grado di occuparsi della gestione della tenuta di famiglia. Alla fine del 1939, diede le dimissioni dal dipartimento di botanica e nell'agosto 1940 tornò a Knysna. Da quel momento non avrebbe più pubblicato e si sarebbe dedicata interamente all'azienda, dove morì ultraottantenne nel 1963.  Omaggi floreali e non solo Augusta Duthie era un'insegnante preparata e trascinante, e diversi dei suoi allievi diedero un importante contributo allo studio della flora sudafricana. Era anche una persona colta e affabile, in rapporti di scambio scientifico e amicizia con colleghi botanici in patria e all'estero. Particolarmente stretta fu la sua relazione con un'altra grande botanica sudafricana, Louisa Kensit Bolus, la curatrice dell'erbario Bolus, che le dedicò un Impatiens, un'Erica e tre specie di Aizoaceae da lei scoperte: Membryanthemum duthieae (oggi Ruschia duthieae), Psilocaulon duthieae (oggi Mesembryantemum articulatum), Stomatium duthieae. Anche il genere che la ricorda le è stato dedicato da una botanica, Miriam Phoebe de Vos, a sua volta grande specialista di bulbose, che fu sua allieva a Stellenbosch. Nel 1975 le dedicò con il nome Duthiella linifolia una nuova specie di Iridaceae; il nome però era illegittimo, perché esisteva già un genere Duthiella (famiglia Leskeaceae, muschi dell'Asia orientale e dell'Australia settentrionale); così ripubblicò il genere come Duthiastrum, commettendo però un errore ortografico (a rigori, il nome dovrebbe essere Duthieastrum, grafia adottata da diversi repertori, compreso il sito del SANBI, South African National Biodiversity Institute). L'unica specie di questo genere monotipico è Duthiastrum linifolium, una geofita endemica del Karoo settentrionale (Provincia settentrionale del Capo). Affine al genere Sparaxis, è una piccola bulbosa dotata di cormo con lunghi fiori tubolari aranciati con sei lobi lunghi e stretti disposti a stella, da cui il nome, letteralmente "stella di Duthie". Di lunga durata, per diversi giorni successivi si aprono all'inizio del pomeriggio e si chiudono subito dopo il tramonto. Come alcune specie di crochi, una volta che il fiore è stato fecondato, lo stelo si piega in modo che l'ovario rimanga interrato e maturi i frutti sottoterra (geocarpia). A ricordare Augusta Duthie e le sue ricerche, ci sono però anche l'orto botanico di cui gettò le basi e una riserva naturale. Lo Stellenbosch University Botanical Garden era originariamente ubicato di fronte all'edificio principale (Main Building) al lato occidentale del campus. Nel 1922, il neonominato Nel riuscì a convincere l'università ad assegnare al giardino un terreno apposito non lontano dal centro cittadino; la pianta del nuovo guardino, ispirato all'orto botanico di Padova, previde quattro aiuole principali a cerchi concentrici, separate da quattro viali a croce, più aiuole didattiche con le piante disposte per famiglie. Vennero anche costruite alcune serre, per proteggere le piante delicate dalle piogge invernali e dall'eccessivo calore estivo. Il giardino fu inaugurato ufficialmente nel 1925 ed ebbe come primo curatore il tedesco Hans Herre, che si era formato a Dalhem con Engler. Viste le limitate dimensioni del giardino, egli decise di concentrare le collezioni sulle piante succulente e per popolarlo fece molte spedizioni soprattutto nel Namaqualand. Oggi il compito principale del giardino, oltre agli scopi didattici, è la conservazione della flora nativa della regione del Capo, anche se non mancano rarità esotiche e collezioni speciali. Quando l'università si trasferì della vecchia sede, fu deciso di trasformare una parte dei terreni in una riserva naturale, battezzata Duthie Nature Reserve in onore della botanica che aveva dedicato tanta parte della sua vita allo studio della sua rara flora. Ricchissima di specie rare ed endemiche (per farvene un'idea potete sfogliare questa gallery), è oggi uno dei pochissimi luoghi dove cresce ancora in natura il rarissimo Haemanthus pumilio, oggetto di un progetto di riproduzione e salvataggio dell'Università di Stellenbosch. Non è opportuno assumere una donna per questo scopo: Mary Agnes Chase ovvero una storia di genere31/3/2022 Ancora all'inizio del Novecento e anche negli Stati Uniti, sebbene le ragazze che si iscrivevano alle facoltà scientifiche fossero sempre più numerose, non era facile per loro fare ricerca; se riuscivano ad entrare in questa o quella istituzione, accedere ai finanziamenti era molto più difficile che per i colleghi maschi. Se poi non avevano neppure una laurea, le cose si complicavano ulteriormente. Per la botanica, la porta d'accesso più praticabile continuava a rimanere l'illustrazione, un settore in cui la presenza femminile era ormai sdoganata da tempo. Fu questa la strada percorsa dall'autodidatta Mary Agnes Chase che, grazie ad alcuni incontri fortunati, ma soprattutto a una tempra eccezionale riuscì a superare tutti gli ostacoli di genere e ad affermarsi come uno dei botanici più importanti del suo campo, l'agrostologia, ovvero lo studio delle graminacee. Animata da una forte coscienza sociale, non concepì la sua battaglia come una questione individuale, ma politica: ecco perché fu in prima fila nel movimento suffragista e non fece mancare il suo sostegno alle ragazze che intendevano seguire le sue orme. Esperta di graminacee di valore mondiale, è ricordata da ben tre piccoli generi di Poaceae: Agnesia, Chasechloa e Sinochasea.  Come un'illustratrice divenne botanica Tra i 27 milioni di visitatori della Fiera Colombiana di Chicago del 1893, organizzata per celebrare i 400 anni dalla scoperta dell'America, c'erano anche una giovane donna e un ragazzo: Mary Agnes Chase (1869-1963) e Virginius Heber Chase (1876-1966), rispettivamente zia e nipote. A stupirli ed emozionarli furono soprattutto le collezioni botaniche, tanto che decisero di iniziare ad esplorare la flora dei dintorni della città. Mary Agnes aveva solo ventiquattro anni, ma aveva già alle spalle una vita difficile. All'età di due anni perse il padre, Martin Meara, un fabbro di origini irlandesi che lavorava per le ferrovie, e andò ad abitare a Chicago dalla nonna materna con la madre e i quattro fratelli. La famiglia era molto povera, e finita la scuola di base, dovette lavorare per contribuire al bilancio familiare. Trovò lavoro come tipografa e correttrice di bozze allo School Herald , una modesta rivista destinata agli insegnanti rurali, diretta da Willam Ingraham Chase; nonostante la notevole differenza d'età (lei aveva diciotto anni, lui trentaquattro) i due si innamorarono e presto si sposarono. Ma William era ammalato di tubercolosi e entro un anno morì, lasciando Mary Agnes vedova e oberata di debiti. Per tirare avanti, di notte lavorava come correttrice di bozze per il Chicago Inter Ocean e di giorno dava una mano nell'emporio del cognato, dove strinse una grande amicizia con il nipote Virginius. Sempre più affascinato dalla botanica, il ragazzino leggeva tutto quello che poteva sull'argomento e cominciò a trascinare la zia nelle sue scorribande. Raccoglievano piante, prendevano note, essiccavano i soggetti e imparavano a classificarli. Per saperne di più, Mary Agnes decise di seguire corsi aperti di botanica all'Università e al Lewis Institute, dove imparò a disegnare le piante. La botanica per ora era solo un hobby, qualche ora di pausa in una difficile vita di lavoro e di fatica. Durante un'escursione, un primo incontro fortunato cominciò a cambiare la sua vita: quello con un altro appassionato, il pastore presbiteriano Ellsworth Jerome Hill, che, ormai in pensione, poteva dedicare parecchio tempo alla raccolta e allo studio delle sue piante preferite, i muschi e le epatiche. Hill incoraggiò Chase a perseverare, le insegnò le basi della tassonomia e l'uso del microscopio e le chiese di illustrare (gratis) i suoi numerosi articoli. Queste illustrazioni, molto classiche per impostazione e notevoli per la precisione dei dettagli, attirarono l'attenzione di Charles Frederick Millspaugh, curatore di botanica del Field Museum of Natural History, che le chiese di illustrare (sempre a titolo gratuito) due pubblicazioni dell'istituto: Plantae Utowanae (1900) e Plantae Yucatanae (1904). Nel frattempo, la pratica del microscopio aveva permesso a Chase di trovare un lavoro meglio pagato nei laboratori di controllo dell'industria conserviera. Ma per lei era ora che la botanica da hobby si trasformasse in professione; sempre su suggerimento di Hill, nel 1903 presentò la sua candidatura come illustratrice botanica al Dipartimento di agricoltura (USDA). Vinto il concorso, si trasferì a Washington e per due anni lavorò alla Divisione delle piante da foraggio. Nel 1905 un secondo incontro fortunato impresse la svolta definitiva alla sua vita: il suo capo divenne Albert Spear Hitchcock, un botanico specializzato in agrostologia (ovvero lo studio delle graminacee). Egli apprezzò il suo talento e decise di farne la propria allieva e la propria assistente (lo divenne ufficialmente nel 1907). Chase cominciò così ad abbandonare gradualmente l'illustrazione a favore dello studio scientifico delle piante, accompagnando Hill anche nelle sue spedizioni sul campo in varie parti degli Stati Uniti. Il primo frutto di questa collaborazione, che sarebbe durata trent'anni, furono due lavori a quattro mani sulle specie statunitensi del genere Panicum (1910 e 1915). Nel 1911 Hill partecipò alla ricognizione botanica di Panama finanziata dallo Smithsonian; al suo ritorno, chiese che i 54 $ che aveva risparmiato fossero assegnati a Mary Agnes Chase per continuare le ricerche. La risposta dello Smithsonian fu un netto rifiuto: "Spiace dire che non posso raccomandare di inviare la signora Chase nella Zona del Canale, sia perché dubito che la somma menzionata sia sufficiente sia perché dubito dell'opportunità di assumere una donna per questo scopo". Allo stesso modo, la stazione di Barro Colorado (che pure Chase aveva contribuito a installare) rifiutò l'accesso alle donne. Per Mary Agnes fu chiaro che non si trattava di una questione personale, ma politica. Fu così che, senza lasciarsi intimorire dalle conseguenze di questa scelta per la sua carriera, si impegnò attivamente nel movimento suffragista. Nel 1915 fu arrestata una prima volta mentre, insieme ad altre donne, manteneva acceso un falò dei discorsi di Wilson che contenevano le parole freedom e liberty (somma ipocrisia finché non c'era libertà per le donne). Nel 1918 fu tra le attiviste (le Silent Sentinels) che picchettarono la Casa bianca per ricordare al neoeletto Wilson la promessa di sostenere il suffragio femminile; arrestata e incarcerata, partecipò allo sciopero della fame che guadagnò al movimento il sostegno di parte dell'opinione pubblica e costrinse l'amministrazione a rilasciare le donne arrestate. Per le sue posizioni "incompatibili per un dipendente dello stato" rischiò anche il licenziamento; a salvarle il posto fu Hitchcock che dichiarò che gli era impossibile continuare le sue ricerche senza di lei.  Viaggi e pubblicazioni della "signora delle graminacee" Non era un'esagerazione. Il programma di ricerca dei due botanici era niente meno che la mappatura di tutte le graminacee delle Americhe e dopo gli Stati Uniti intendevano estendere le loro ricerche all'America latina. Non potendo attingere a finanziamenti pubblici, Chase (abituata fin da bambina a vivere frugalmente) finanziò autonomamente i suoi primi viaggi e anche più tardi si appoggiò su organizzazioni e missioni femminili, a proposito delle quali scrisse: "I missionari viaggiano ovunque e come i botanici lo fanno spendendo il meno possibile". A partire dal 1906, dedicò molto del suo tempo libero a viaggi negli Stati Uniti (ne visitò ben 19) e nel Messico. Tutti autofinanziati, benché il suo stipendio fosse nettamente inferiore a quello dei colleghi maschi. Nel 1913 poté trascorrere diversi mesi in Porto Rico dove tra l'altro scoprì una nuova specie di felce; le sue raccolte di graminacee confluirono nel 1917 in Grasses of the West Indies, scritto in collaborazione con Hitchcock. Nel 1922 pubblicò il suo primo libro, illustrato da lei stessa, First Book of Grasses: The Structure of Grasses Explained for Beginners. Come è evidente dal sottotitolo, si rivolge non a botanici professionisti bensì "a studiosi seri ma dilettanti". Lo stesso anno partì per il suo primo viaggio in Europa, nel corso del quale visitò diversi erbari, tra cui quelli di Pisa e Firenze e l'Hackel Herbarium del Museo nazionale di Vienna, dove poté collaborare con Hackel alla raccolta di graminacee alpine. Anche grazie al successo del suo libro, nel 1923 fu promossa botanica assistente e nel 1925 botanica associata. Nel 1924, con il finanziamento di diverse organizzazioni, tra cui l'USDA e il Field Museum di Chicago e l'appoggio logistico delle missioni femminili, Chase partì per il Brasile. Incontrò i colleghi dell'orto botanico di Rio de Janeiro Paulo de Campos Porto e María de Carmo Bandeira, quindi per sei mesi percorse il Brasile orientale in treno, in autobus, in automobile, a dorso d'asino, a piedi, raccogliendo più di 500 nuove specie di graminacee e 19.000 altri esemplari. Insieme a Maria Bandeira, scalò persino il monte Itatiaia (erano le prime donne a farlo), da cui discesero "con le gonne piene di esemplari". Nel 1929, tornò in Brasile per una seconda spedizione di un anno. Nel 1935 uscì il magnum opus di Hitchcock, Manual of the Grasses of the United States, a cui le ricerche di Chase avevano dato un contributo decisivo. Ma nel dicembre di quell'anno il botanico morì all'improvviso sulla nave che lo riportava negli Stati Uniti da un lungo viaggio attraverso gli orti botanici e gli erbari europei. Nel 1936 Chase (che ora aveva 67 anni) le succedette come botanico senior, responsabile del dipartimento di agrostologia sistematica dell'USDA. Nel 1937, fu nominata anche curatrice del settore delle graminacee dell'Erbario nazionale. Nel 1939, andò in pensione, ma mantenne l'incarico all'erbario e continuò a lavorare allo Smithsonian come volontaria. Era ormai riconosciuta come la più importante specialista di graminacee del mondo. Nel 1940 fu invitata in Venezuela dal governo come consulente per un programma di sviluppo; anche se ormai aveva superato la settantina, ne approfittò per continuare le ricerche, raccogliendo 400 taxa di graminacee in ambienti diversi: le Ande, la savana e la foresta pluviale. Come già in Brasile, in Venezuela incontrò molti studenti e studentesse di botanica; per molti di loro, divenne una consigliera, un'amica e non fece mancare loro il suo sostegno concreto, aiutando decine di giovani promettenti ma privi di mezzi a continuare gli studi negli Stati Uniti. Per le ragazze, l'ostacolo era duplice: incoraggiare le giovani donne ad abbracciare la carriera scientifica divenne uno dei principali scopi dei viaggi che nel dopoguerra la videro ancora in America latina, in Canada e nelle Filippine. La sua casa, che soprannominò affettuosamente in spagnolo "Casa contenta", era sempre aperta alle studentesse e alle botaniche che passavano da Washington. Tra di loro la venezuelana Zoraida Luces de Febres (1922–2015), che grazie a lei poté entrare allo Smithsonian; tradusse in spagnolo First Book of Grasses, fu la prima donna venezuelana a laurearsi in scienze naturali e divenne a sua volta un'importante agrostologa. E' solo un esempio dell'impegno personale e politico di Chase per le cause in cui credeva. Oltre ad essere impegnata nel movimento femminista, come membro del Women's Party e della Women's Christian Temperance Union, aderì al Socialist Party, si batté contro la discriminazione razziale aderendo alla National Association for the Advancement of Colored People. Attiva e lucida fino in tarda età, nel 1951 pubblicò la seconda edizione di Manual of the grasses of the United States di Hitchcock. E finalmente anche l'establishment botanico le tributò gli onori che meritava: nel 1956 la Botanical Society of America la premiò con un certificato di merito definendola "uno dei più importanti agrostologi del mondo e preminente tra gli studiosi americani in questo campo"; nel 1958 (aveva appena compiuto 89 anni) ricevette la laurea honoris causa dall'università dell'Illinois e fu nominata membro onorario dello Smithsonian; nel 1961 divenne membro della Linnean Society. Nel 1962, ultranovantenne, in collaborazione con un'altra botanica, Cornelia D. Niles, riuscì ancora a completare il monumentale Index to grass species, in tre volumi. Morì l'anno dopo all'età di 94 anni, poco dopo essersi ritirata in una casa di riposo. Le sue raccolte sono custodite in diversi erbari. L'Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburg ospita la Hitchcock-Chase Collection of Grass Drawings, una straordinaria collezione che comprende 2713 disegni - per lo più a china - di graminacee raccolti e in parte disegnati da Albert Spear Hitchcock e Mary Agnes Chase.  Un giro del mondo in tre graminacee Alla "signora delle graminacee" non potevano mancare gli omaggi botanici. Le sono stati dedicati ben quattro generi, tre dei quali tuttora validi; non stupisce che tutti appartengano alla famiglia Poaceae. In ordine di tempo (1911), la prima dedica giunse dal sacerdote, chimico e botanico Julius Nieuwland che, nell'ambito di una revisione del genere Panicum, creò Chasea, prendendo le mosse dallo studio su questo genere pubblicato l'anno precedente da Hitchcock e Chase; non valido, è considerato un doppione di Panicum. Con i tre generi validi facciamo un piccolo giro del mondo, segno della reputazione internazionale di Agnes Mary Chase. Iniziamo dal Madagascar, con il genere endemico Chasechloa (1949), omaggio di una delle tante colleghe con cui Chase era in corrispondenza, la francese Aimée Antoinette Camus (che a sua volta, prima di diventare specialista di orchidee, si era occupata di graminacee). Comprende due sole specie, C. egregia e C. madagscarensis, in precedenza assegnate anch'esse al genere Panicum, a cui sono molto affini; tuttavia, le analisi filogenetiche ne hanno confermato l'indipendenza. Sono grandi erbe piuttosto rare limitate alle regioni nord-occidentali dell'isola. La seconda tappa è la Cina, con il genere monotipico Sinochasea (1958), dedica di Yi-Li Keng, uno dei tanti studenti stranieri che poterono giovarsi dell'aiuto della generosa botanica statunitense. Keng, infatti, dopo essersi laureato a Nanchino, si spostò all'università di Washington per la laurea di secondo livello, per la quale scrisse una tesi sulle graminacee cinesi. Come ricorda nella dedica "il nome è una combinazione di Sino, Cina, e Chasea, in onore della sig.a Agnes Chase, la nota agrostologa degli Stati Uniti, che mi aiutò molto nello studio delle graminacee cinesi". L'unica specie, S. trygina, è un'erba dei pascoli alpini della Cina, del Tibet e dei piccoli stati himalayani adiacenti. Concludiamo il viaggio in Amazzonia con un altro genere monotipico, Agnesia (1993). I due autori, l'argentino Fernando Omar Zuloaga e lo statunitense Emmet Joseph Judziewicz, con questa dedica vollero sottolineare quanto utile e ancora attuale fosse (e sia ancora) il lavoro di questa grande botanica: "Il genere è dedicato all'eccezionale agrostologa statunitense Agnes Chase, autrice del monumentalmente completo e utilissimo indice delle specie pubblicate di graminacee. Ancora oggi le sue note manoscritte sugli esemplari e sulle cartelle dell'erbario nazionale statunitense spesso forniscono suggerimenti benvenuti e permettono di risparmiare molto tempo nell'identificazione e nelle relazioni reciproche di molte graminacee". L'unica specie di questo genere, A. lancifolia, è un raro bambù delle foreste umide dell'area amazzonica. Nel 1996, la National Gallery of Victoria di Melbourne celebrava la grande artista botanica australiana Margaret Stones con una mostra che riuniva il meglio della sua produzione. Il titolo della mostra e del catalogo, curato da Irina Zdanowicz, Beauty in Truth, "Bellezza nella verità", sintetizza perfettamente le due caratteristiche principali della sua arte: da una parte, l'assoluta precisione dei dettagli (in particolare quelli utili all'identificazione tassonomica del soggetto), dall'altra la capacità di catturarne la bellezza e la vita, con una perfetta disposizione nello spazio e una straordinaria purezza di colore. Un binomio che nella mostra organizzata dalla Louisiana State University nel 2020, in occasione del suo centenario, è stato espresso con la più banale formula "Arte e scienza". Nata e formata in Australia, ma vissuta in Inghilterra per mezzo secolo, Stones ha collaborato con i Kew Gardens e tra il 1958 e il 1983 è stata la principale illustratrice del Curtis's Botanical Magazine, per il quale ha realizzato 400 tavole. Due le sue opere principali, entrambe spettacolari: le illustrazioni di Endemic Flora of Tasmania di Winifred Curtis e di Native Flora of Louisiana. A riflettere i due aspetti che si congiungono nella sua arte anche i due generi che le sono stati dedicati: "scienza/verità" in Stonesia, "arte/bellezza" in Stonesiella.  Dipingere piante in tre continenti Nel Novecento, probabilmente le personalità più note della botanica australiana al femminile sono state la botanica Winifred Curtis e la pittrice botanica Elsie Margaret Stones. Unite nella realizzazione di Endemic Flora of Tasmania, di cui la prima ha curato le descrizioni botaniche e il commento ecologico, la seconda le illustrazioni, hanno avuto entrambe in sorte una lunghissima vita: Curtis morì centenaria nel 2005, Stones (1920-2018) ci ha lasciati a novantotto anni. Nata a Colac, nello stato di Victoria, nella sua lunga carriera Stones ha lavorato in tre continenti. Dopo essersi formata presso lo Swinburne Technical College e la National Gallery Art School di Melbourne, iniziò a lavorare come disegnatrice commerciale; durante la seconda guerra mondiale, divenne infermiera. La scoperta della sua vera vocazione avvenne quasi per caso: contrasse la tubercolosi e dovette rimanere a letto per quasi un anno; per passare il tempo, incominciò a disegnare i fiori che le portavano gli amici. Il suo medico curante fu così colpito dai suoi acquarelli che li mostrò a John Turner, professore di botanica e fisiologia vegetale all'Università di Melbourne, che la invitò a seguire le sue lezioni e a partecipare alle escursioni estive da lui organizzate nelle Bogong High Plains sulle Alpi australiane. Nel 1946 arrivava la prima mostra. Nel 1951 Stones decise di traferirsi in Inghilterra; come ricorda lei stessa, non aveva alcuna prospettiva concreta. Acquistò un biglietto di sola andata per 95 sterline; gliene rimanevano 100 per vivere. Fortunatamente, incominciò a lavorare all'erbario di Kew come artista free-lance: un'esperienza importantissima, perché la obbligò a concentrarsi sulla struttura anatomica e sui dettagli. Sarebbe rimasta a lavorare a Kew per mezzo secolo, fino al 2002. Molto apprezzata per l'esattezza e l'accuratezza scientifica dei suoi disegni, illustrò molte monografie scientifiche dei botanici di Kew e di altre istituzioni scientifiche, come il British Museu, con precississimi disegni in bianco e nero che spesso richiedevano l'uso del microscopio. Nel 1956 pubblicò il primo disegno sul Curtis’s Botanical Magazine; dal 1958 al 1983, ne diventò l'artista principale, preparando per questa prestigiosa rivista, oltre a molti disegni di particolari in bianco e nero, ben 400 acquarelli. Poté così raffinare anche l'aspetto artistico del suo lavoro, e in particolare la disposizione del soggetto, complicata dal piccolo formato della rivista. Ora il suo nome incominciava ad essere piuttosto noto; fu così che Lord Talbot de Malahide, un collezionista che coltivava molte piante originarie della Tasmania nel suo giardino irlandese, le chiese di illustrare per lui 35 piante endemiche di quell'isola. Il progetto poi si allargò fino a diventare una grande serie di sei volumi in folio, The Endemic Flora of Tasmania (1967-1978). I testi furono commissionati alla botanica Winifred Curtis (che, in un certo senso, aveva compiuto il percorso inverso rispetto a Stones: nata in Inghilterra, si era infatti trasferita in Tasmania); Margaret andò in Tasmania a incontrare Winifred e in diverse occasioni lavorarono fianco fianco, ma per lo più una viveva a Londra, l'altra a Hobart. Le piante raccolte in Tasmania venivano spedite per via aerea e ogni mattino arrivavano sulla scrivania delle pittrice che doveva lavorare in fretta per sfruttare le poche ore di luce dell'inverno inglese (le stagioni in Australia sono invertite rispetto all'emisfero boreale); se non riusciva a completare il lavoro prima che l'esemplare appassisse, toccava aspettare l'anno successivo. Fu dunque un lavoro particolarmente complesso, che si protrasse per quasi quattordici anni. Alla morte di lord Talbot, erano usciti solo i primi quattro volumi; gli ultimi due furono finanziati da sua sorella Rose. The Endemic Flora of Tasmania è una pietra miliare della botanica del Novecento, sia per le ricerche e i testi di Curtis, sia per lo splendore delle illustrazioni di Stones, che, lavorando sul grande formato di un volume in foglio, poté ritrarre le piante a grandezza naturale e raggiunse il vertice della sua arte. L'accordo tra le due autrici era perfetto. Curtis scrisse di Stones: "Non c'era nessun bisogno di dirle quali parti o sezioni bisognasse disegnare per facilitare una corretta classificazione tassonomica: lo sapeva già". Stones era ancora impegnata in questa impresa quando, nel settembre 1975, la State University of Louisiana le commissionò l'illustrazione di sei piante native per celebrare il duecentesimo anniversario degli Stati Uniti che sarebbe caduto l'anno successivo. Fu l'inizio di un lavoro molto più impegnativo che andò allargandosi di anno in anno e alla fine diventò una ricerca sull'intera flora della Louisiana, che impegnò un gruppo di ricercatori e Margaret Stones per ben quattordici anni e si tradusse in un'altra opera spettacolare: Native flora of Louisiana, pubblicata nel 1991 con 224 acquarelli dell'artista australiana e testi di Lowell Urbatsch. Stones iniziò il lavoro in Inghilterra servendosi di piante coltivate a Kew o di esemplari che le venivano spediti per via aerea; ma presto scoprì che molte piante erano troppo fragili per sopravvivere al trasporto e che le piante coltivate differivano per dimensioni e altri aspetti da quelle selvatiche. Cominciò così a intervallare alla sua vita londinese uno o due lunghi soggiorni annuali a Baton Rouge per ritrarre le piante dal vivo; si trattava infatti di catturare l'essenza di ciascuna pianta, che è sempre diversa da ogni altra: "un buon disegno botanico deve essere vivo, ben disegnato e accurato. Le piante, come gli esseri umani, non sono sempre ben progettate, così l'artista girare attorno all'esemplare finché riesce a farne emergere l'aspetto naturale e tipico". Gli acquerelli originali per la Flora della Louisiana sono oggi custoditi presso l'università che li aveva commissionati; selezioni più o meno ampie furono presentate in mostre che toccarono le tre "patrie" di Stones, venendo esposte, oltre che in Louisiana, allo Smithsonian, a Oxford, Cambridge, Edimburgo e Melbourne. All'artista australiana sono anche toccati numerosi importanti riconoscimenti: medaglia Veitch d'argento nel 1976, membro dell'ordine dell'Impero britannico nel 1977, medaglia Veitch d'oro nel 1985, membro dell'ordine d'Australia nel 1988; laurea honoris causa da parte dell'Università di Louisiana (1986) e dell'Università di Melbourne (1989). Nel 2002, Margaret Stones andò in pensione e tornò in Australia, dove morì novantottenne nel 2018. Anche nella sua vecchiaia, continuava a disegnare e ad essere lucida ed attiva. Se volete conoscerla più da vicino, e sentirne anche la voce, potete ascoltare questa interessante intervista sul suo percorso artistico, rilasciata nel 2008. 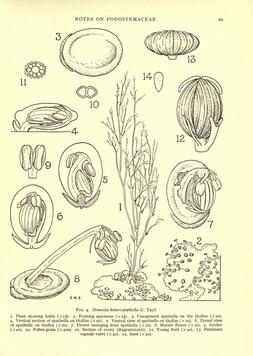 La scienza: Stonesia I due generi dedicati a Margaret Stones in due momenti lontani della sua vita riflettono non solo differenti fasi della sua carriera, ma in qualche modo anche le due caratteristiche che sapeva congiungere nelle sue illustrazioni botaniche: la precisione e l'accuratezza scientifica da una parte, la bellezza e l'arte dall'altra. Il primo genere, Stonesia, le fu dedicato nel 1953, quando Margaret era arrivata a Kew da poco più di un anno, da George Taylor, uno dei botanici del British Museum si giovò delle sue illustrazioni; la motivazione non potrebbe essere più eloquente: "Denominando questo genere Stonesia voglio esprimere la mia profonda gratitudine a Miss Margaret Stones le cui bellissime illustrazioni, completate con infinita cura e pazienza, sono state del massimo valore per chiarire la struttura fiorale microscopica di queste notevoli piante". Taylor pubblicò il nuovo genere nell'ambito di un articolo sulle Podostemaceae africane (Notes on Podostemaceae for the Revision of the Flora of West Tropical Africa, "Bulletin of the British Museum (Natural History)", Botany 1, 1953) al quale Stones aveva contribuito con quindici tavole di illustrazioni, in cui possiamo notare non solo l'estrema precisione del tratto, la cura dei dettagli, ma anche la scelta sapiente dei particolari, che documentano e rendono evidenti le caratteristiche distintive dei generi e delle specie esaminati, nonché le diverse fasi della vita di ciascuna pianta. Un lavoro di grande precisione, ma anche di sintesi, che richiese certamente molte sedute al microscopio. Le Podstemaceae in effetti sono una famiglia assai singolare, il più vasto gruppo di piante strettamente acquatiche tra le angiosperme; si trovano per lo più nei fiumi tropicali, in particolare nelle acque veloci di cascate e cataratte di corsi d'acqua caratterizzati da una forte stagionalità; si aggrappano alle rocce e al fondo con le radici e durante la stagione delle piogge sono totalmente sommerse nell'acqua corrente, mentre i fiori e i frutti emergono nella stagione secca, quando le acque recedono. In queste particolari condizioni ecologiche, hanno sviluppato caratteristiche uniche: in molte specie non c'è una netta differenziazione tra fusto e foglie; presentano invece un corpo vegetativo più o meno indifferenziato simile al tallo delle alghe, con ramificazioni dicotomiche estremamente sottili e sfrangiate; alcune sono dotate di piccole vescicole che permettono loro di fluttuare a pelo d'acqua. Tipiche sono anche alcune strutture dei fiori: prima dell'antesi sono racchiusi in una specie di piccolo sacco, detto spathella; i tepali, che possono essere più o meno numerosi, in molte specie sono ridotti a scaglie; gli stami per lo più sono due, retti da un unico filamento relativamente inspessito, detto andropodium. Il frutto è una capsula striata. La tassonomia della famiglia è piuttosto complicata perché, a parte poche eccezioni, comprende molti piccoli generi con poche specie, solitamente endemiche di aree ristrette, che si differenziano l'uno dall'altro soprattutto per le strutture dei fiori e le caratteristiche delle capsule. Ciò vale anche per Stonesia, endemico di due aree disgiunte dell'Africa occidentale (Guinea e Cameron), che si distingue dai generi più vicini per il numero e la disposizione delle righe della capsula e per i fiori, caratterizzati da un andropodium e da tre tepali, due ad ogni lato dell'andropodium, il terzo posto alla forcella di quest'ultimo.  e l'arte: Stonesiella Ci porta invece alla stagione di Endemic Flora of Tasmania il secondo genere che celebra Stones, Stonesiella (le è stato dedicato nel 1999 da Crisp e Weston separandolo da Pultenaea). E' un genere monotipico della famiglia Fabaceae endemico della Tasmania la cui unica specie, all'epoca ancora denominata Pultenaea selaginoides, fu raccolta nell'isola da Talbot di Malahide, decritta da Curtis e illustrata da Stones, che nel disegnarla ebbe modo di unire alla precisione (molto evidente nei particolari a grandezza naturale di foglie, petali, stami, frutti, collocati al piede della tavola) una vivace rappresentazione di questo arbusto che, sebbene un po' rigido, non manca di grazia. Molto raro (se ne conoscono solo cinque popolazioni, confinate in due ambienti specifici: da una parte, le brughiere più umide con arbusti alti e le boscaglie aperte di Eucalyptus, dall'altro le macchie arbustive su suolo arido), è alto circa due metri e ha portamento piuttosto sparso, con pochi rami eretti, spogli alla base e fittamente coperti di foglie raggruppate nella parte terminale; i fiori papilionacei giallo brillante bordati di rosso si dispongono in giri che si aprono in successione all'ascella delle foglie o all'apice dei rami. La pubblicazione di The Cactaceae dei botanici statunitensi Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose segna una pietra miliare nella classificazione dei cactus e ne rivoluziona la tassonomia. I quattro volumi, editi tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution for Science, sono anche una sontuosa opera d'arte, grazie ai disegni in bianco e nero e alle tavole a colori, di impressionante precisione, della pittrice britannica Mary Emily Eaton e delle sue collaboratrici; centinaia di fotografie in bianco e nero ne arricchiscono l'apparato iconografico. Anche se da allora le Cactaceae hanno subito numerose revisioni, almeno 50 dei 79 generi stabiliti da Britton e Rose rimangono validi, e i volumi di The Cactaceae sono ricercati da ogni cactofilo. L'opera nasce dalla stretta collaborazione tra Nathaniel Britton, all'epoca direttore del New York Botanical Garden, e Joseph Nelson Rose, un grande e metodico tassonomista al cui il destino ha riservato il ruolo dell'eterno secondo. A ricordarlo i generi Rhodosciadium (Apiaceae) e Roseodendron (Bignoniaceae). 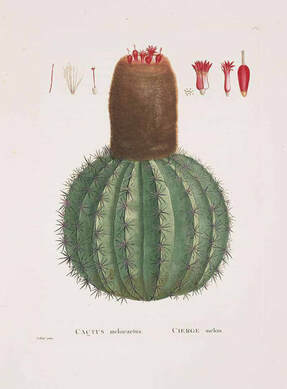 Una classificazione spinosa Come ben sanno gli appassionati di cactus, abituati a fare i conti con continue revisioni e cambi di nome, la classificazione delle Cactaceae è una faccenda spinosa; a ciò contribuiscono diversi fattori: citiamo soltanto la grande variabilità morfologica che spesso rende difficile distinguere specie da specie, specie da sottospecie, specie da varietà; l'alto grado di convergenza evolutiva di queste piante di habitat estremi che fa sì che piante lontane dal punto di vista genetico tendano ad assomigliarsi perché devono affrontare le stesse condizioni ambientali; la difficoltà di raccogliere, seccare e preservare esemplari d'erbario di queste piante spinose, con forme arrotondate e tessuti succulenti. Con la sola eccezione di Rhipsalis baccifera, si tratta di una famiglia esclusivamente americana, in cui gli europei si sono imbattuti con le scoperte geografiche. Probabilmente la prima specie ad arrivare in Europa, forse già con i viaggi di Colombo, fu il fico d'India (qui le Indie sono quelle occidentali) Opuntia ficus-indiae, ma la prima ad essere attestata è un Melocactus "cactus a melone" noto a Londra intorno al 1570. Qualche anno dopo nell'erbario di Tabaernemontanus vengono descritti sia cactus globosi, sia cactus colonnari, che il botanico tedesco chiama Cereus, ovvero "cero, candela". A cavallo tra Cinquecento e Seicento diverse specie sono descritte da altri botanici, come Clusius, L'Obel e Gerard. Pitton de Tournefort pubblica Melocactus e Opuntia, mentre Plumier riporta dai suoi viaggi nelle Antille Pereskia. Questa è la situazione prima di Linneo che nel 1753, in Species Plantarum, descrive 22 specie ma sorprendentemente le raggruppa nell'unico genere Cactus, nome che ricava dal gr. kaktos, una pianta spinosa di Teofrasto non meglio identificata. Più analitico di lui Philip Miller che nella quarta edizione di The Gardener's Dictionary (1754) descrive quattro generi: Cactus, Cereus, Opuntia e Pereskia. Tuttavia, nella nona edizione (1787) farà marcia indietro e si adeguerà alla posizione di Linneo. Poco dopo, nel 1789, Antoine Laurent de Jussieu crea la famiglia Cactaceae. A rimescolare le carte è Haworth che nel 1812 dichiara il genere linneano Cactus inutilizzabile, riservandolo al solo Cactus melocactus L., e lo smembra in Cactus, Cereus, Epiphyllum, Mammillaria, Opuntia, Pereskia e Rhipsalis (creato da Gaertner nel 1788). Nel terzo volume del Prodromus (1828) de Candolle opta per la prudenza, descrivendo sette generi e 174 specie, suddivisi nei grandi gruppi di cactus epifiti e cactus non epifiti. Il grande collezionista principe di Salm-Dyck, che nel suo castello nei pressi di Düsseldorf possedeva la più importante collezione di Cactaceae dell'epoca, in Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (1850) pubblica 20 generi, dividendo la famiglia in due gruppi: Cacteae Rotatae, con fiori a disco, e Cacteae Tubulosae, con fiori tubolari. Nel corso del secolo, mano a mano che gli ambienti aridi del Nuovo mondo vengono esplorati e sempre nuove specie vengono scoperte e inviate ai giardini botanici ma anche ai vivai europei, si aggiunge una grande quantità di specie che i botanici tendono a riunire in pochi grandi generi. Nel 1891 nella sua revisione di Genera Plantarum, Otto Kuntze torna addirittura all'antico, ovvero a Linneo, riconoscendo solo tre generi: i piccoli Pereskia e Pterocactus e un super genere Cactus con oltre 1000 specie. La sistematizzazione più influente a cavallo tra i due secoli è tuttavia la monumentale Gesamtbeschreibung der Kakteen, "Descrizione generale dei cactus", di Karl Moritz Schumann, in tredici volumi pubblicati tra il 1897 e il 1898, con un appendice nel 1903. Rifacendosi soprattutto a Salm-Dick, egli accetta 21 generi e 640 specie. Divide poi la famiglia in tre tribù: Rhipsaloideae, Mammillarieae, Echinocactaceae. Una posizione in parte più aperta è quella di Alwin Berger, curatore dei giardini Hambury, che accetta 41 generi e propone di dividere il vasto genere Cereus in 5 1sottogeneri. E' questa la situazione quando entrano in scena i nostri protagonisti, Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose. 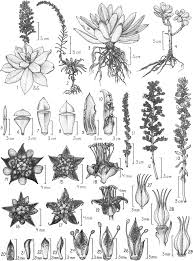 Un botanico taciturno, eterno secondo Britton e Rose incominciarono a studiare le Cactaceae nel 1904; entrambi conoscevano bene le flore degli Stati Uniti, dei Caraibi e del Messico e inizialmente il loro intento era pubblicare una revisione complessiva delle specie nordamericane. Solo più tardi, nel gennaio 1911, Daniel MacDougal, il direttore del Desert Laboratory di Tucson, suggerì loro di allargare le ricerche all'intera famiglia e di chiedere il sostegno finanziario della Carnegie Institution for Science. Di Britton ho già parlato in questo post; è ora di conoscere meglio Rose. Aaron M. Socha, un esperto di cactus che ha lavorato per il Giardino botanico di New York, lo ha definito "un individuo così spiccato che neppure Shakespeare avrebbe potuto renderlo universale". Era un uomo taciturno, riservato, modesto e disinteressato agli onori, ma allo stesso tempo determinato; come botanico, un ricercatore instancabile (qualcuno lo ha definito un "cavallo da tiro"), un descrittore minuzioso e un tassonomista di estremo rigore. Ripercorrendo la sua carriera, a me è sembrato un eterno secondo, un Bartali della botanica. E a Bartali assomiglia anche per la forza di volontà, la bontà d'animo, la generosità, la profonda religiosità. Nato nell'Indiana e rimasto presto orfano durante la guerra di Secessione, studiò nel piccolo college di Wabash; mentre seguiva i corsi post laurea di biologia, divenne assistente del suo professore di botanica, John Merle Coulter, che lo volle al suo fianco per studiare un'altra famiglia difficile, le Apiaceae (a quei tempi, si chiamavano ancora Umbellifere); la collaborazione tra professore e allievo iniziò con Revision of the North American Umbelliferae (1888) e, dopo una serie di articoli su vari generi, culminò con Monograph of the Umbelliferae (1900). Secondo i biografi, a fare il lavoro duro fu Rose, mentre Coulter ebbe piuttosto un ruolo di revisore. Nel frattempo, Rose si era sposato e si era trasferito a Washington per iniziare la sua carriera professionale nel Dipartimento di Agricoltura (USDA) come assistente di George Vasey, botanico capo dell'USDA e curatore dell'erbario nazionale. Rose lo affiancò nella pubblicazione delle raccolte di Edward Palmer in Messico e Centro America, con grande apprezzamento di quest'ultimo che nel 1897 lo invitò ad accompagnarlo in Messico; grazie a questa spedizione, Rose si familiarizzò con il lavoro sul campo e imparò le tecniche di raccolta e conservazione anche di piante difficili come le succulente messicane. Nel 1896 l'Erbario nazionale era passato sotto la giurisdizione dello Smithsonian, e Rose fu promosso assistente curatore di botanica, poi dal 1905 curatore associato. Fu questo il vertice della sua carriera, come notiamo anche dal ruolo di vice presidente - in armonia con il suo carattere e il suo destino - di associazioni attive nella capitale come Botanical Society, Washington Botanical Society, Washington Society, Washington Biological Society (di cui, a dire la verità, dopo essere stato il vicepresidente dal 1909 al 1917, divenne presidente nel 1918). Come assistente curatore dell'USDA, organizzò nove spedizioni in Messico e in Centro America, di cui pubblicò i risultati in Studies of Mexican and Central American Plants, 1897-1911. Intorno all'inizio del secolo, incominciò a corrispondere con Britton, cui inviò molti esemplari per il New York Botanical Garden; entrambi erano particolarmente interessati alle Crassulaecae e a partire dal 1903 incominciarono a scrivere vari articoli a quattro mani su questa famiglia, pubblicati per lo più sul Bollettino del New York Botanical Garden. I loro primi lavori comuni sulle Cacataceae risalgono al 1905. Il progetto suggerito da MacDougall fu presentato da Britton e Rose alla Carnegie all'inizio del 1911 e fu immediatamente approvato. Nel 1912 Rose prese un congedo non pagato dallo Smithsonian e fu nominato ricercatore associato della Carnegie, affiancato da due assistenti, W.R. Fitch e P.G. Russel. Britton, che continuava a dirigere l'orto botanico di New York, fu nominato ricercatore associato onorario (ovvero senza paga), mentre il suo collaboratore R.S. Williams fu incaricato di selezionare e preservare gli esemplari per le illustrazioni. 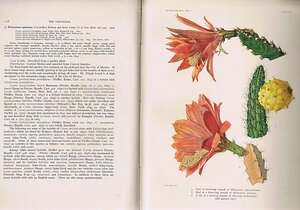 Una rivoluzione tassonomica Quando Britton e Rose incominciano il loro lavoro, la situazione è confusa al massimo grado. Nel corso di un secolo, le specie di cactus, spesso introdotte direttamente non da botanici, ma da raccoglitori di piante al servizio di collezionisti e vivai, si sono moltiplicate a dismisura; e insieme si sono moltiplicati gli errori. Un caos perfettamente descritto dai due botanici nella prefazione del I Volume di The Cactaceae: "descrizioni interpretate scorrettamente, piante identificate in modo sbagliato, errori perpetuati; così la distribuzione geografica di molte specie è stata pubblicata in modo erroneo e le conclusioni basate su dati di questo tipo risultano inaffidabili. Non solo ci sono nomi specifici attribuiti a piante cui non spettano, ma i nomi generici sono diventati interscambiabili e le leggi della priorità sono state ignorate". Quella che Britton e Rose decidono di operare è una rivoluzione; il botanico Lyman Benson ha osservato che, se gli stessi criteri fossero stati applicati a tutte le piante "almeno un milione di piante avrebbero dovuto cambiare nome". Nei quattro volumi di The Cactaceae, i 21 generi accettati da Schumann esplodono e diventano 124, mentre le specie classificate sono 1325. Insomma, per la tassonomia delle Cactaceae, dopo un secolo di prudenza e di enormi super generi, è arrivata l'ora dell'audacia e della suddivisione in molti generi più piccoli, basati sia sulle evidenze morfologiche, sia sulla distribuzione geografica. Anche se i due botanici ottimizzano il tempo, dividendosi il lavoro sia di ricerca sia di scrittura e sono affiancati da una dozzina di collaboratori, il compito è immenso e i cinque anni previsti inizialmente si dilatano a dieci. Bisogna reperire e leggere tutte le descrizioni originali e verificarle quanto più possibile sugli esemplari tipo custoditi negli erbari, quindi confrontarle con le piante vive in coltivazione e/o in natura. Senza dimenticare che il lavoro (1912-1923) verrà a cadere a cavallo della Prima Guerra Mondiale e anche il Messico si chiuderà alle ricerche a causa della rivoluzione messicana. Le Cactaceae vivono nei deserti delle Americhe, ma nell'Ottocento sono state prevalentemente studiate e classificate da studiosi europei, commercializzate da vivai europei e collezionate da collezionisti europei. Ecco perché le ricerche di Rose, già nei primi mesi del 1912, si spostano in Europa. A Londra visita gli erbari di Kew, del Natural History Museum e della Linnean Society e a Parigi l'Hérbier National. Passa poi in Italia dove visita piccole collezioni pubbliche e private di Roma, Napoli, Firenze e Venezia. La tappa principale è però la Riviera, dove Rose va a trovare Alwin Berger; i due botanici corrispondono fin dal 1905, quando Rose aveva scritto a Berger per complimentarsi per il suo studio sulle Cactaceae. E' poi la volta della Germania con gli erbari e gli orti botanici di Monaco e Berlino, la collezione privata di Leopold Quehl ad Halle, il vivaio Haage & Schmidt a Erfurt e l'orto botanico di Darmstadt. Prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, Rose fa ancora un salto ad Anversa per esaminare la collezione privata di Frans de Laet. Le spedizioni sul campo iniziano l'anno successivo. Insieme a sua moglie Elizabeth Knight Britton, all'amica Delia West Marble, membro del Botanical Club, pittrice e fotografa, e al raccoglitore dell'orto botanico di New York John Adolph Shafer, Nathaniel Britton visita le Isole vergini americane, Porto Rico e Curaçao; Rose e i suoi assistenti percorrono Saint Croix, St. Kitts, Antigua e Hispaniola. Nel 1914, mentre in Europa si accendono i fuochi di guerra, Britton torna a Porto Rico per esplorare le isole dell'arcipelago, mentre Rose, accompagnato dalla moglie Lou Beatrice Sims, parte per il suo lungo giro in Sud America. Dopo due brevi tappe in Giamaica e Panama, nel 1915 esplora le zone ricche di cactus di Perù, Bolivia centrale, Cile settentrionale e centrale; come aveva fatto in Europa, a Santiago del Cile esamina le specie tipo raccolte il secolo precedente da Rodolfo Amando Philippi e le specie rare dell'orto botanico. Passa in Brasile, dove studia soprattutto le aree di Bahia e Rio de Janeiro, quindi in Argentina, dove si concentrata sulle province di Mendoza e Cordoba. Come in Europa e in Cile, visita botanici e collezionisti da cui ottiene esemplari e informazioni di prima mano. Nel 1916 Britton è a Cuba insieme a Percy Wilson, mentre Rose e sua moglie concludono il viaggio sudamericano con Curaçao e Venezuela. Per i due botanici è arrivata l'ora del lavoro da scrivania, tanto più che la guerra ora rende difficile gli spostamenti anche in America. Nel 1918, per Rose c'è ancora un viaggio (ad accompagnarlo questa volta è suo figlio Thomas) in Ecuador. Inoltre sono stati coinvolti altri raccoglitori, come J.K. Small inviato nel 1916 in Florida alla ricerca di rare specie di Opuntia o Shafer che nell'inverno 1916-17 fa importanti raccolte in Bolivia, Argentina, Paraguay e Uruguay. Altri esemplari furono inviati da collezionisti, curatori di orti botanici e erbari, studiosi e appassionati. Il primo volume, dedicato alle tribù Pereskieae e Opuntieae, uscì infine nel 1919; il secondo, dedicato alle sottotribù Cereanae e Hylocereanae della tribù Cereae, nel 1920; il terzo, dedicato alle sottotrbù Echinocereanae, Echinocactanae e Cactanae, seguì nel 1922; il quarto, dedicato alle sottotribù Coryphanthanae, Epipyllanae y Rhipsalidanae, completò l'opera nel 1923. Nel 1922 Rose era tornato una seconda volta in Europa, per consultare nuovamente Berger, con il quale aveva continuato a corrispondere, almeno finché la guerra non lo aveva reso impossibile. Ma appena il conflitto era finito, si era affrettato a inviare dall'opulenta America un ricco pacco di cibo all'amico e alla sua famiglia, alle prese con la fame nella Germania postbellica. Pubblicati dalla Carnegie Institution of Science senza badare a spese, oltre ad essere una pietra miliare della botanica, i quattro volumi di The Cactaceae sono una raffinata opera d'arte grazie al ricchissimo apparato iconografico con tavole a colori, disegni e fotografie in bianco e nero nel corpo del testo. A dipingere tre quarti delle 800 tavole fu la pittrice inglese Mary Emily Eaton, che all'epoca lavorava per l'orto botanico di New York; per la precisione del tratto e la vivezza dei colori questa eccellente artista fu definita dai contemporanei "la più grande pittrice di piante dal vivo". A coadiuvarla, un team tutto al femminile: Deborah Griscom Passmore, Helen Adelaide Wood, Kako Morita. Britton e Rose partirono dalle revisioni di Schumann e di Berger, ma si spinsero molto più in là, creando molti generi più piccoli; oltre a correggere le denominazioni di molte specie, ne pubblicarono numerose per la prima volta. Anche se nel secolo che è intercorso da allora la storia tassonomica della Cactaceae ha continuato ad essere travagliata e molte sono state le revisioni, è significativo della qualità del loro lavoro il fatto che ben 50 dei 79 generi da loro creati continuato ad essere accettati, anche se spesso ne sono stati ridefiniti i confini. Inoltre, anche grazie alla splendida veste editoriale, The Cactaceae ebbe anche il merito di destare l'interesse del grande pubblico per una famiglia di piante che all'epoca era ancora poco di moda.  Modeste piante aromatiche e alberi d'oro Terminata l'impresa, Rose riprese il suo lavoro allo Smithsonian. Non cessò però la sua collaborazione con Britton; negli anni '20 i due botanici scrissero insieme la trattazione delle Mimosaceae e delle Caesalpinaceae per la North American Flora. Rose diede ancora prova delle sue grandi capacità di tassonomista ridefinendo il super genere Cassia, il cui status all'epoca era estremamente confuso. Egli morì nel 1928, sei anni prima dell'amico e compagno di avventura. Nella sezione biografie, una sintesi della vita di questo grande botanico, che il destino e l'ordine alfabetico collocano in seconda posizione anche come autore di The Cactaceae. Vorrei salutarlo con le parole di Alwin Berger che lo definì "uno degli uomini meno egoisti e di animo più gentile che io abbia mai incontrato". Come a Britton, anche a Rose furono dedicati numerosi generi (c'è anche una dedica comune, Brittonrosea Speg., oggi sinonimo di Echinocactus); a essere attualmente validi sono due: Rhodosciadium e Roseodendron. Come abbiamo visto, nella sua lunga carriera di tassonomista specializzato nel riportare ordine nella sistematica di famiglie complicate, i primi lavori di Rose furono dedicati alle Apiaceae. E proprio a questa famiglia appartiene Rhodosciadium, che nel 1889 gli fu dedicato dall'illustre botanico Sereno Watson. Il nome, un composto di rhodon, "rosa" e sciadeion "ombrello", si basa su un gioco di parole tra rose, "rosa" in inglese, e Rose, il cognome del nostro botanico e significa "ombrellifera dedicata a Rose". Il genere è distribuito tra Stati Uniti meridionali e Guatemala e gli sono attribuite da cinque a quindici specie. Sono erbacee perenni degli ambienti montani, con ombrelle rade con pochi fiori viola o giallo-verdastro. E' curioso che proprio Rose nel 1895 abbia separato dal genere dedicato a lui stesso alcune specie messicane, assegnandole al nuovo genere Deanea (oggi non accettato). In rete sono disponibili davvero poche informazioni su questo genere discusso; Rhodosciadium longipes (una specie pubblicata per la prima volta da Rose con il nome Deanea longipes) in Messico, dove è chiamata espico, è considerata una pianta medicinale. Una sintetica presentazione del genere nella scheda. Le ricerche di Rose prima in Messico e poi in Sud America ne hanno fatto una figura quasi leggendaria per i botanici dell'America latina. Non stupisce che Faustino Miranda, forse il più noto botanico messicano, nel separare da Tabebuia due specie abbia voluto dedicare a Rose il nuovo genere Roseodendron (1965), ovvero "albero di Rose". La denominazione di Miranda tuttavia fu presto respinta, e le piante furono assegnate a Cybistax, per poi ritornare a Tabebuia. Ricerche molecolari pubblicate nel 2007 hanno però dato ragione a Miranda, raccomandando di resuscitare Roseodendron. Appartenente alla famiglia Bignoniaceae, comprende due sole specie: R. donnell-smithii, e R. chryseum. R. donnell-smithii è la specie più diffusa; raccolta in Messico da Palmer, fu pubblicata proprio da Rose nel 1892 come Tabebuia donell-smithii. E' un albero magnifico che al momento della fioritura si ricopre di grandi fiori dorati; è nota con il nome colloquiale "primavera"; ha un areale abbastanza ampio (dal Messico meridionale al Guatemala) ma è anche frequentemente coltivata. R. chryseum è invece un endemismo delle foreste aride del Venezuela nordoccidentale e della Colombia settentrionale. Rispetto all'altra specie è di dimensioni minori e presenta infiorescenze meno compatte. Qualche approfondimento nella scheda. Il Giardino botanico di New York (New York Botanical Garden, NYBG) è uno dei più importanti orti botanici del mondo; situato nel quartiere del Bronx, oggi si estende per oltre 1 km², contiene 48 diversi giardini, ospita serre, laboratori, il maggiore erbario dell'emisfero settentrionale con 7.800.000 esemplari e la biblioteca botanica più importante del paese, ricca anche di manoscritti e testi storici. Eppure tutto è incominciato da un fazzoletto di terra e dal sogno di una coppia di botanici, Nathaniel L. Britton e Elizabeth G. Knight Britton. Lui, oltre ad aver diretto il NYBG per più di trent'anni, è stato un riconosciuto esperto della flora del centro America, ma è famoso soprattutto per il libro sulle Cactaceae che scrisse a quattro mani con J.N. Rose. Lei è stata una pioniera degli studi sui muschi degli Stati Uniti orientali e delle battaglie ecologiste. Entrambi sono ricordati da generi monotipici: Neobrittonia (Malvaceae) per Nathaniel, Bryobrittonia (Encalyptaceae) per Elizabeth.  Un giardino nato dal sogno di una coppia di botanici Anche se uno dei primi orti botanici statunitensi, l'Elgin Botanic Garden, sorse proprio qui, alla fine dell'Ottocento New York era priva di un orto botanico. Infatti, nel 1808 David Hosack, il fondatore, era stato costretto a vendere l'Elgin Botanical Garden alla città; trasferito al Columbia College, era stato lasciato all'abbandono fino a scomparire. Sopravvivevano soltanto i resti della biblioteca e dell'erbario. Se oggi la città vanta uno dei prestigiosi giardini botanici del mondo, New York Botanical Garden (NYBG), si deve a una coppia di straordinari botanici, Nathaniel Lord Britton e Elizabeth Gertrude Knight Britton. Nathaniel si era laureato in geologia e aveva partecipato alla ricognizione geologica del New Jersey, ma fin dagli anni universitari era appassionato di botanica ed era un membro attivo del Torrey Botanical Club. Verso la metà degli anni '80 divenne insegnante di geologia e botanica alla Columbia University. I suoi interessi si spostarono sempre più verso la botanica; al Torrey conobbe una giovane briologa, Elizabeth Gertrude Knight, che sposò nel 1885. Nel 1888 la coppia andò a Kew per condurre alcune ricerche e entrambi furono impressionati dai giardini, dall'erbario e dalla biblioteca. Sembra che sia stata Elizabeth ad esclamare: "Dobbiamo avere un'istituzione così a New York!". Di ritorno a casa, Elizabeth presentò una entusiastica relazione al Torrey Club e propose di fondare un Comitato per promuovere la creazione di un orto botanico, concepito allo stesso tempo come un giardino per il piacere della cittadinanza, un'istituzione educativa e un centro di ricerca e irradiazione della conoscenze botaniche sul modello di Kew. Entrambi i Britton erano energici e convincenti e seppero coinvolgere nel progetto le maggiori istituzioni scientifiche cittadine: oltre al Torrey Botanical Club, la Columbia University (dove Nathaniel insegnava e Elizabeth prestava servizio volontario come curatrice dell'erbario dei muschi), l'American Museum of Natural History. La campagna di raccolta fondi, di cui Elizabeth divenne l'anima, coinvolse quotidiani come il Sun e l'Herald Tribune e guadagnò il sostanzioso sostegno dei grandi magnati della città, da Morgan a Carnegie a Vanderbildt, che poi figurarono ai vertici del consiglio di amministrazione. Fondato ufficialmente con un atto del New York State Legislature il 28 aprile 1891, il nuovo orto botanico sorse nel Bronx Park, a nord della città; i lavori cominciarono tuttavia solo nel 1896 e richiesero diversi anni. La biblioteca fu completata nel 1900 e la grande serra nel 1909. Nominato segretario del consiglio di amministrazione fin dall'atto di fondazione, nel 1896 Britton lasciò la Columbia University, dove, oltre a insegnare geologia e botanica, era anche il curatore della biblioteca e dell'erbario, e divenne il primo direttore del NYGB. Con l'assenso della Columbia University, che continuò a collaborare strettamente con la nuova istituzione, le collezioni di cui era curatore si trasferirono con lui. In quegli anni, mentre Elizabeth si batteva anima e corpo per raccogliere i fondi per il nascente giardino, Nathaniel era anche impegnato nelle ricerche per la sua prima opera importante, An Illustrated Flora of the Northern United States and Canada, finanziata da Addison Brown e nota come Britton & Brown Illustrated Flora, la prima flora illustrata dell'America settentrionale. I Britton pensavano che come Kew era la "capitale botanica" dell'impero coloniale britannico, allo stesso modo il NYBG dovesse assumere la guida delle ricerche botaniche non solo nel territorio metropolitano, ma anche nelle aree di influenza statunitense in America centrale, a partire dal protettorato di Porto Rico. Fu così che il NYBG fu in prima linea nelle ricerche botaniche nell'area; nel 1902 la coppia iniziò una serie di viaggi nelle Antille e nei Caraibi. Tutti gli anni, quando l'inverno newyorchese si faceva più duro, i Britton si trasferivano a sud, non in vacanza, ma in spedizioni botaniche sul campo finanziate in parte da loro stessi, in parte da cordate tra diverse istituzioni scientifiche. Nathaniel partecipò di persona a una trentina di spedizioni; la più importante è senza dubbio la ricognizione scientifica di Porto Rico e delle Isole Vergini, condotta dall'Accademia delle Scienze di New York in collaborazione con il governo di Porto Rico e l'American Museum of Natural History che si protrasse per sette anni, dal 1919 al 1926 e coinvolse scienziati di molte discipline. Furono i viaggi in America centrale a destare l'interesse di Britton per le Cactaceae. Ne nacque il progetto che porterà alla stesura di The Cactaceae, il suo capolavoro, scritto a quattro mani con Joseph Nelson Rose. Un'opera così importante che merita un post a parte. Britton diresse il NYBG fino al pensionamento, nel 1929. Oltre ad essere uno scienziato di grande valore, aveva grandi capacità organizzative e sotto la sua direzione il giardino crebbe rapidamente; nel 1915, con l'acquisizione di un settore sottoutilizzato del Brox Park, passò da 250 a 400 acri. Britton curò l'arricchimento delle collezioni, varò programmi di conferenze e fece del giardino (il cui accesso rimase gratuito per mezzo secolo) uno spazio bello e piacevole per i suoi concittadini, un punto di incontro reso vivo da mostre e iniziative divulgative; ma soprattutto lo rese un'istituzione scientifica di primo piano. Si batté per centralizzare le collezioni di libri e erbari disperse tra le varie istituzioni newyorchesi; grazie a affidi, doni e acquisti, al termine del suo mandato la biblioteca contava 43.500 volumi e l'erbario 1.700.000 esemplari. Egli credeva nella collaborazione tra le varie istituzioni scientifiche, e fu tra gli animatori della Scientific Alliance of New York, purtroppo di breve durata. Era anche noto per il carattere imperioso e poco accomodante (scherzosamente, usando il suo secondo nome, lo chiamavano "il Lord"). In campo tassonomico si batté per la stretta osservanza della regola della priorità; ma lo fece in modo talmente rigido e poco diplomatico da provocare una rottura sia con molti colleghi statunitensi sia con i botanici europei. Britton scisse moltissimo; accanto e dopo il grande lavoro sulle Cactaceae, pubblicò numerosi volumi sulla flora delle Antille: Flora of Bermuda (1918), The flora of the American Virgin Islands (1918), Descriptions of Cuban plants new to science (1920), The Bahama flora (1920) in collaborazione con Charles Frederick Millspaugh. 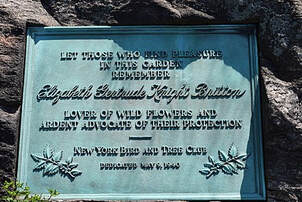 Dallo studio dei muschi alla battaglia per le piante native E' ora di conoscere più da vicino sua moglie Elisabeth Gertrude Knigth; proprio come il marito, era una figlia della città di New York, ma aveva trascorso lunghi periodi a Cuba, dove il nonno possedeva una piantagione di canna da zucchero. A soli 17 anni si diplomò e incominciò a insegnare come tutor di Scienze naturali alla Normal School (oggi Hunter College). Nel 1879, a ventun anni, si iscrisse al Torrey Botanical Club e fece il suo esordio nella carriera botanica scoprendo la fruttificazione del muschio Eustichium norvegicum e la presenza in Nuova Scozia della rara felce Schizaea pusilla. Aveva già deciso di specializzarsi nello studio delle piante di cui sarebbe diventata una dei massimi esperti: i muschi. Era un'appassionata escursionista e in questi anni visitò gli Adirondack e gli Appalachi. Fu al Torrey che conobbe Nathaniel Britton, che era il responsabile del bollettino dell'associazione, su cui Elizabeth pubblicò i suoi primi articoli; nel 1884 divenne curatrice dei muschi e nei 1886 redattrice del bollettino. Nel 1893, fu la sola donna tra i 25 membri fondatori della Botanical Society of America. Dopo il matrimonio, lasciò l'insegnamento e prestò servizio come volontaria alla Columbia University, dove era la responsabile non ufficiale dell'erbario dei muschi. Benché non avesse un titolo accademico, era una guida e punto di riferimento per studenti e specializzandi. Abbiamo già parlato del viaggio a Kew (dove era andata a studiare la collezione di muschi di Henry Hurd Rusby) e della battaglia per il NYBG. Quando l'erbario della Columbia fu trasferito nel neonato giardino, continuò nella nuova sede l'attività volontaria come curatrice dei muschi dal 1912 al 1929; grazie a lei, furono acquisite molte collezioni. Molto del suo tempo fu dedicato alla catalogazione dell'erbario di muschi di William Mitten, acquisito dal NYBG nel 1906. Insieme al marito, erborizzò in Porto Rico, Giamaica e Cuba. Durante la sua carriera, scrisse quasi 350 articoli, metà dei quali dedicati ai muschi. Il progetto di un grande Handbook of Mosses of Eastern America, fu abbandonato a favore di una serie di articoli più brevi, in parte confluiti nella North American Flora pubblicata dal NYBG. Dall'inizio del secolo, quando la battaglia per l'orto botanico era già stata vinta, Elizabeth Britton abbracciò con tutta la sua determinazione una seconda causa: quella della salvaguardia dei fiori selvatici. Nel 1902 fu tra i fondatori della Wild Flower Preservation Society che si batteva per proteggere le piante native anche attraverso provvedimenti legislativi; ne divenne segretaria e tesoriera e, oltre a pubblicare numerosi articoli sull'argomento nella rivista del NYBG, per sensibilizzare l'opinione pubblica partecipò letteralmente a migliaia di eventi in scuole e garden club. Nel 1925 come presidentessa del comitato per la conservazione dei Garden Club dello Stato di New York guidò una vittoriosa campagna di boicottaggio contro la pratica di utilizzare rami di agrifoglio selvatico come decorazione natalizia. Nel 1929, quando Nathaniel andò in pensione, la coppia, che abitava in una casa del Brox non lontana dall'orto botanico, alternò ai soggiorni in città quelli nel Cottage di Richmond, un edificio storico che apparteneva alla famiglia Britton fin dal 1695. Nathaniel lavorava a una flora di Porto Rico (Flora Borinquena) che rimase incompiuta. Entrambi morirono nel 1934, a quattro mesi di distanza, prima Elizabeth, poi Nathaniel, che non si era mai ripreso dalla perdita della moglie. Una sintesi delle loro vite nella sezione biografie.  Due piccoli generi per due grandi botanici Non sorprende che, come direttore di un'istituzione tanto prestigiosa, come ricercatore con all'attivo la scoperta di numerose specie e come autore di opere decisive come The Cactaceae, Nathaniel Lord Britton abbia collezionato la dedica di quasi settanta nomi di specie e di sei generi. Tuttavia uno solo rimane valido, Neobrittonia, che gli fu dedicato nel 1905 da Hochreutiner dell'Orto botanico di Ginevra, riclassificando una specie messicana precedentemente denominata Abutilon acerifolium Don. Neobrittonia acerifolia, l'unico rappresentante di questo genere della famiglia Malvaceae, è un arbusto diffuso dal Messico centrale a Panama in boschi misti, pinete e boschi mesofili di montagna tra 2100 e 2400 metri. Alto tra due e tre metri, ha rami ricoperti di lunghi peli e foglie che ricordano quelle dell'acero, profondamente lobate, con tre o cinque lobi; ha fiori attraenti, con cinque petali lilla violaceo, seguiti da frutti tondeggianti, formati da 8-12 segmenti ravvicinati e disposti a ruota, abbastanza simili a quelli del nostrano Abutilon theophrasti, ma irsuti e spinosi. Qualche dettaglio in più nella scheda. Anche Elizabeth Knight Britton ha ricevuto la sua parte di onori: a ricordarla i nomi specifici di una quindicina di piante, come la felce Thelypteris brittoniae, e il genere di muschi Bryobrittonia, che gli fu dedicato nel 1901 da R.S. Williams, soprattutto in riconoscimento del suo ruolo educativo quando era curatrice dei muschi alla Columbia University. Scrive infatti Williams: "Il genere è dedicato a Mrs. Elizabeth G. Britton, il cui aiuto ha incoraggiato molti studiosi americani dei nostri muschi". Appartenente alla famiglia Encalyptaceae, è anch'esso un genere monotipico, che comprende solo B. longipes, una specie dei climi rigidi che vive su substrati calcarei in Nord America, Europa e Asia centrale. Altre informazioni nella scheda. Due simboli iconici si incontrano in questa storia: da una parte il saguaro, il cactus gigante dei deserti americani, reso familiare dall'immaginario cinematografico; dall'altra, Andrew Carnegie, incarnazione del sogno americano, multimiliardario che ha ispirato la figura di zio Paperone, a suo tempo considerato l'uomo più ricco del mondo, ma anche celebre benefattore e filantropo. Il punto d'incontro tra i due è una collina nei pressi di Tucson, dove i saguaro sono di casa e dove, finanziato da Carnegie, nacque il Desert Laboratory. Qui li studiarono i botanici Britton e Rose, scoprendo che appartenevano a un genere tutto loro; e in onore del finanziatore, il saguaro divenne Carnegiea gigantea.  Prologo: cactus giganti e film western Chiudete gli occhi e provate a immaginare la scena madre di un tipico film western. Siamo alla resa dei conti: l'eroe, pistola in pugno, sta per affrontare il cattivo. A fare da sfondo, il deserto: terra rossastra, in lontananza le sagome della Monument Valley. La vegetazione è ridotta a pochi cespugli spinosi ma qua e là si stagliano le maestose sagome del cactus a candelabro. Lo state vedendo? E' lui, il nostro primo protagonista, il saguaro, ovvero Carnegiea gigantea, simbolo iconico dei film western; eppure, nella Monument Valley, i saguari non ci sono; e neppure nelle tante location in Utah, Colorado, New Mexico, Texas dove la fantasia di registri e scenografi li ha sparsi a piene mani. In realtà, il saguaro vive solo nel deserto di Sonora, anzi in alcune parti della porzione orientale di questo deserto, in Messico e in Arizona meridionale e occasionalmente nella California sudorientale; il cuore del suo regno è il Parco nazionale dei saguaro, nell'Arizona meridionale, con due sezioni rispettivamente nelle Tucson Mountains e nelle Rincon Mountains. Non lontano dalle Tucson Mountains e dal parco, nel 1939 la Columbia Pictures allestì il set dove fu girato Arizona, diretto da Wesley Ruggles. Al termine delle riprese, la casa di produzione decise di trasformarlo in uno studio cinematografico permanente, dove da quel momento sarebbero stati girati tutti i suoi western. Da allora sono stati oltre 300 tra film e telefilm, tra cui un monumento della cinematografia come Sfida all'OK Corral (1957). E' stato così che i saguaro hanno incominciato ad essere associati ai film western e diventarne un immancabile accessorio di scena, andando a popolare il nostro immaginario e paesaggi dove non esistono in natura.  Primo atto: il miliardario filantropo Altrettanto iconico è anche il secondo protagonista di questa storia, il miliardario Andrew Carnegie, incarnazione del sogno americano "dall'ago al milione" e prototipo della figura di zio Paperone. Come da copione, il nostro nasce in Scozia, arriva in America poverissimo e fa i più diversi mestieri: a tredici anni è un bobbin boy, uno dei ragazzi addetti al cambio e alla raccolta delle spolette in una manifattura di cotone, per dodici ore al giorno, sei giorni su sette, per una paga di un dollaro la settimana; lavora poi in una fabbrica di spolette, quindi passa ad una compagnia locale di telegrafi, prima come fattorino, poi come operatore. A 18 anni (adesso il suo salario è di 4 dollari la settimana) diventa operatore telegrafista della compagnia ferroviaria Pennsylvania Railroad Company e poi segretario di uno dei dirigenti; è un avido lettore, che nel tempo libero legge più che può e studia da autodidatta. A 24 anni diventa sovrintendente della Western Division. Siamo nel 1859 e le ferrovie sono un settore in grande espansione; Carnegie conosce le persone giuste e grazie ai loro consigli fa i suoi primi investimenti proprio nelle ferrovie, prendendo in prestito 500 dollari con un'ipoteca sulla casa di sua madre. Conosce per caso T. T. Woodruff, l'inventore del vagone letto, e insieme a lui fonda una piccola società per sfruttare l'invenzione. Il primo affare importante arriva con la guerra di successione; con la sua esperienza sia nei telegrafi sia nelle ferrovie, Carnegie è incaricato dal governo dell'Unione di ristabilire le linee ferroviarie e telegrafiche tagliate dai sudisti. Il trasporto di truppe e di materiali al fronte fornisce altre opportunità di guadagno. Dopo la guerra, Carnegie lascia le ferrovie, e si lancia nel siderurgico. La prima fabbrica, Cyclops Iron Company, fondata nel 1864 insieme al fratello, assorbe via via alcune fucine della zona e diventa la Union Mill. Produce ferro, un prodotto che il mercato chiede sempre meno, ormai soppiantato dall'acciaio. Durante un viaggio in Inghilterra, Carnegie conosce un nuovo metodo di produzione dell'acciaio, il processo Bessemer, e lo introduce nella sua acciaieria, fondata nel 1872. Da quel momento, sarà un successo travolgente. Combinando innovazione tecnologica, organizzazione efficiente e bassi salari, riesce via via ad assorbire i concorrenti, come la rivale Homestead Steel Works acquisita nel 1883, e diventa l'imperatore dell'acciaio; Pittsburgh è la capitale mondiale di quell'impero. Alla fine degli anni '80 la Carnegie Steel è la più grande produttrice di ghisa, rotaie ferroviarie e coke del mondo. Con i suoi associati, controlla l'integrazione verticale di tutte le fasi produttive, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione del prodotto finito. Nel 1892 nasce ufficialmente la Carnegie Steel Company, che dà una struttura formale a una ragnatela di interessi ed attività, che include la costruzione di locomotive, ferrovie, ponti, porti, edifici e la proprietà di 18 giornali. Lo stesso anno, mentre Carnegie si trova in vacanza in Italia, le sue acciaierie sono al centro di uno scontro sindacale (Homestead Strike), risolto da suoi associati con l'uso della forza. Carnegie è lontano, ma approva pienamente l'operato dei suoi uomini, compreso l'uso di milizie private e l'uccisione di diversi scioperanti. La sua reputazione ne esce compromessa. E' forse anche per questo che nel 1901, all'età di 66 anni, decide di ritirarsi. Trasforma l'azienda in una società per azioni e vende le sue attività industriali al banchiere John Morgan per la cifra record di 480 milioni di dollari. Le cronache del tempo lo considerano l'uomo più ricco del mondo (gli studiosi lo ritengono il quarto uomo più ricco di tutti i tempi). Da questo momento in avanti, non sarà più un industriale, ma un filantropo; anche se le sue attività filantropiche erano già iniziate da qualche anno, ora saranno la sua occupazione esclusiva. Autodidatta, crede nel valore dell'istruzione, e si impegna nella creazione di biblioteche: per suo impulso ne nasceranno oltre 2500, non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi anglofoni. Per gli amanti della musica, il suo nome è perpetrato dalla Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto del mondo, costruita a New York per sua volontà nel 1890; per quelli delle arti, dal Carnegie Museum of Pittsburgh.  Secondo atto: un laboratorio nel deserto I musei, le fondazioni, le università, gli istituti di ricerca finanziati da Carnegie sono innumerevoli; sono una ventina le fondazioni che portano il suo nome, impegnate nei campi più diversi. Soffermiamoci su una soltanto, Carnegie Institution for Science di Washington. Molto interessato al progresso scientifico, subito dopo il ritiro, il miliardario-filantropo pensò di fondare una università nazionale a Washington, simile ai grandi centri di ricerca europei; temendo però lo scontento delle università già esistenti, vi rinunciò, puntando su un istituto di ricerca indipendente impegnato ad accrescere le conoscenze scientifiche di base. Comunicò al presidente Theodore Roosvelt che era pronto a dotare la nuova istituzione di 10 milioni di dollari; nel 1907 ne aggiunse 2, e altri 10 nel 1911. Inizialmente, l'istituzione finanziò soprattutto ricerche individuali, ma creò anche alcuni laboratori di ricerca. E finalmente stiamo per scoprire qual è il legame tra Andrew Carnegie e il saguaro. Nel 1891 Frederick V. Coville, botanico capo del Dipartimento federale di Agricoltura, aveva esplorato la Death Valley in California ed era rimasto affascinato dalla varietà di forme di vita in un ambiente così estremo. Poco dopo la sua fondazione, egli propose alla Carnegie Institution for Science di finanziare un laboratorio dove studiare le condizioni di vita delle piante dei deserti; l'istituto approvò la proposta e concesse un finanziamento di 8000 dollari. Restava da trovare un sito appropriato: insieme a Daniel T. MacDougal, direttore assistente del New York Botanical Garden, Coville visitò varie aree promettenti in California, New Mexico, Chihuaha, Sonora e Arizona; alla fine la scelta cadde su Tumamoc Hill, un'area collinare ricca di vegetazione ma facilmente accessibile nei pressi di Tucson. Nasceva così il Desert Botanical Laboratory, inaugurato il 7 ottobre 1903. Diretto inizialmente da MacDougal, che mantenne l'incarico fino al pensionamento nel 1928, divenne la base del Carnegie Department of Botanical Research, dotandosi via via di edifici per ospitare lo staff, di una serra, di aiuole sperimentali, di una rivista. Nella primavera del 1906, Volney Spalding, professore in pensione dell'Università del Michigan, che si era trasferito a Tucson in cerca di un clima più mite, propose di delimitare 19 quadrati di 10 metri x 10, e monitorare le piante perenni, identificando, mappando e fotografando tutti gli individui. Era un metodo innovativo che faceva i suoi esordi proprio in quegli anni. Lo stesso anno vennero acquisiti ulteriori terreni e l'intera area fu circondata da una palizzata per tenere lontano il bestiame. Primo laboratorio al mondo dedicato alla flora dei deserti, il Desert Laboratory in pochi anni divenne un'istituzione di punta e uno stimolo per la nascita dell'ecologia negli Stati Uniti; nel 1915, tra i 30 fondatori della Ecological Society of America, sette erano ricercatori del Desert laboratory. Nel 1938, in seguito a problemi economici, la Carnegie Institution for Science decise prima di tagliare drasticamente i finanziamenti, riducendo all'osso il personale, poi di liberarsi del laboratorio, vendendolo simbolicamente per un dollaro. Propose l'acquisto all'Università dell'Arizona, che rifiutò; ad accettare fu invece il dipartimento federale delle foreste, che fino al 1956 lo usò come stazione sperimentale. Fu un periodo di sostanziale decadenza, con poche ricerche condotte soprattutto dall'Università dell'Arizona. La quale, nel 1956 si decise ad acquistare il laboratorio: ma invece di pagarlo un dollaro, dovette sborsarne 100.000. Il laboratorio rinacque. Nel 1964, venne realizzato un censimento dei saguaro, da confrontare con la mappa disegnata da Spanding nel 1907; il censimento fu ripetuto nel 1970, nel 1993 e tra il 2011 e il 2012. Nel 1982, furono creati nuovi quadrati per studiare le piante annuali. Nove di quelli creati da Spanding per le piante perenni esistono ancora: è la più lunga serie di dati fornita da quadrati ecologici al mondo. Oggi, con il nome di Desert Laboratory on Tumamoc Hill, è allo stesso tempo un'area protetta che preserva un ambiente unico, un laboratorio di studi ambientali, un'istituzione educativa collegata con l'Università dell'Arizona. Molte informazioni nel sito, inclusi coinvolgenti filmati.  Epilogo: come il cactus gigante divenne Carnegiea Tra i primi progetti del Desert Laboratory, figura la collaborazione con Britton e Rose per la grande ricerca sulle Cactaceae che sfocerà nei magnifici volumi su questa famiglia pubblicati tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution. Fu MacDougal a suggerire a Nathaniel Britton, all'epoca direttore dell'orto botanico di New York, di ampliare la sua ricerca sulle cactacee americane e di chiedere il finanziamento del Carnegie Institution per un progetto molto più ambizioso. Le trattative richiesero tempo, ma alla fine l'istituzione accettò di finanziare le ricerche e la pubblicazione e nel 1912 tanto Britton quanto Rose furono nominati ricercatori associati alla Carnegie. Il progetto si configurò fin da subito come una collaborazione tra l'orto botanico di New York, lo Smithsonian (dove a lungo aveva lavorato Rose) e il Desert Laboratory, che fu anche una delle sue basi logistiche. Tra le piante più caratteristiche di Tumamoc Hill ci sono proprio i saguaro; fu qui che li studiarono Britton e Rose, capendo che dovevano essere assegnati a un genere proprio (all'epoca erano ancora attribuiti al genere Cereus con il nome C. giganteus); era un'ottima occasione per ingraziarsi lo sperato finanziatore, ovvero Mr. Carnegie. Fu così che nel 1908 i due botanici crearono in suo onore il genere Carnegiea, con questa motivazione: "Questo genere è dedicato a Mr. Carnegie. Il Desert Laboratory della Carnegie Institution di Washington, a Tucson, Arizona, è circondato da esemplari tipici di questa pianta unica". Qualche maligno ha osservato che la dedicata era azzeccata non solo per la bellezza e l'unicità di questa specie, ma anche per le sue micidiali spine, evocative del carattere spinoso del dedicatario. Spinosità dimostrata anche in occasione della presentazione della nuova denominazione: inizialmente, Carnegie fu molto lusingato, ma quando scoprì che non si trattava di una nuova specie, ma solo di un cambio di nome, perse ogni interesse. Per inciso, egli morì nel 1919, pochi mesi dopo l'uscita del primo fascicolo di Cactaceae di Britton e Rose. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Sia come sia, da allora il saguaro è Carnegiea gigantea Britton & Rose, unica specie del suo genere. E' un cactus colonnare, con un tronco imponente, che mediamente raggiunge i dieci metri. Il più grande esemplare conosciuto è alto 13 metri e ha una circonferenza di 3 metri. I fusti colonnari hanno in genere 11-15 coste, lungo le quali si trovano areole ben separate, distanziate di circa 2-3 cm tra loro, ciascuna delle quali porta da 15 a 30 spine, lunghe da 5 a 11 cm, che provocano ferite dolorose e facili ad infettarsi. Sono piante a lentissima crescita. Quando nascono, sono minuscole, e a due anni non misurano ancora un cm. Una pianta di 15 anni è alta intorno ai 30 cm, mentre una pianta di un metro ha tra 20 e 50 anni di età. Intorno a 30 anni, incomincia a produrre i primi fiori e i primi frutti, ma la vera maturità arriva tra i 50 e i 75 anni, quando incomincia a sviluppare rami laterali; gli esemplari più vecchi e imponenti ne hanno molti (il record è di 49 rami, o braccia, su una singola pianta): lo sviluppo di molteplici rami è importante per la riproduzione, dal momento che la fioritura avviene soprattutto agli apici di fusti. Molti esemplari, tuttavia, non li sviluppano mai. I rami laterali sono piuttosto diversi dal fusto principale: hanno costolature molto più numerose, poco profonde, con spine più ravvicinate ma molto più brevi e meno acuminate, in modo da permettere l'accesso degli ospiti che impollinano i fiori e si cibano dei frutti. I bellissimi fiori bianchi, di consistenza cerosa, ricchissimi di polline, si aprono nel tardo pomeriggio e durano meno di una giornata; sono impollinati da numerosi animali, tanto diurni quanto notturni: api da miele, pipistrelli e molte specie di uccelli, tra cui colombe dalle ali bianche e diversi colibrì. I fiori sono seguiti da frutti che ricordano i fichi d'India, appetiti dagli uccelli. Ognuno contiene circa 2000 semi; in effetti, anche se hanno un'alta germinabilità, l'aridità e la predazione comportano molte perdite, tanto che si stima che solo l'1% produca una pianticella. Appena nata è minuscola, e ha bisogno di essere protetta per sopravvivere e crescere; a provvedere sono alberi e cespugli, come le leguminose Olneya tesota o Parkinsonia florida, che forniscono ombra e trattengono l'umidità. Negli ambienti più aridi, tuttavia, queste piante sono assenti e i saguaro iniziano la loro vita in mezzo a ciuffi d'erba o cespugli di Ambrosia dumosa o ancora accanto ad altre Cactaceae come Opuntia kunzei. Il saguaro è una specie chiave nel suo ambiente, che provvede cibo, riparo e protezione a molti animali. L'abbondantissimo polline è una fonte di cibo importante per i suoi impollinatori, come lo sono i frutti per le formiche e vari uccelli, in particolare le colombe dalle ali bianche. I picchi Melanerpes uropygialis e Colaptes chrysoides scavano i loro nidi nei tronchi; in genere, li usano per una sola stagione, rinnovandoli ogni anno. I loro nidi abbandonati, attorno al quale la pianta ha prodotto un callo legnoso, si trasformano in case "chiavi in mano" per molte altre specie di uccelli. Anche i nativi hanno sfruttato i saguaro per secoli in vari modi: le costole lignificate degli esemplari morti venivano usate per palizzate e gli antichi nidi dei picchi come cestini; con i frutti si preparavano marmellate, sciroppi e bevande fermentate per le cerimonie religiose. Qualche approfondimento nella scheda. Alice Eastwood è stata probabilmente la più nota botanica statunitense: per quasi sessant'anni diresse il dipartimento di botanica dell'Accademia delle Scienze di California, fu la massima esperta della flora degli Stati Uniti occidentali, descrisse e classificò 395 specie, scrisse oltre 300 tra articoli e libri. E soprattutto, fece risorgere letteralmente dalle ceneri l'erbario dell'Accademia, di cui la terribile mattina del terremoto di San Francisco riuscì a salvare il nucleo più prezioso con un impulsivo atto eroico. A ricordarla, l'epiteto di numerose specie e sottospecie, e due generi: Eastwoodia e Aliciella. Una preziosa collezione strappata alle fiamme All'alba del 18 aprile 1906 un violento terremoto si abbatté sulla città di San Francisco, con due scosse successive, la seconda delle quali violentissima. Moltissimi edifici furono lesionati, altri crollarono e centinaia di persone (non sapremo mai esattamente quante) rimasero sotto le macerie; ma i danni peggiori non furono causati dal sisma, bensì dal terribile incendio (negli Stati Uniti è passato alla storia come Great Fire) che continuò ad ardere per quattro giorni e quattro notti, distruggendo circa 25.000 edifici. Tra gli abitanti della città che in quella mattina tragica persero tutto c'era anche Alice Eastwood, la curatrice dell'erbario dell'Accademia delle Scienze della California. Preoccupata per la sorte delle collezioni di cui era la custode, si precipitò in Market Street, dove sorgeva la sede dell'Accademia. Dato che il ponticello che dava accesso all'ingresso principale del Museo era crollato, Alice si portò sul retro, dove si era raccolto un gruppetto di curatori e assistenti dei vari dipartimenti dell'Accademia. Nel cortile invaso dai detriti, tutti guardavano in su, impotenti e desolati. L'edifico era lesionato, e la scala in marmo che dava accesso ai piani superiori era parzialmente crollata. Anche se non c'era pericolo di crollo immediato, alcuni edifici vicini erano già in fiamme ed era evidente che presto l'incendio avrebbe raggiunto anche il Museo. Impossibile mettere in salvo la biblioteca, i documenti, le inestimabili collezioni naturalistiche, tutti custoditi ai piani superiori. Vedendo che il lavoro suo e degli scienziati che avevamo fatto di quella istituzione la più importante degli Stati Uniti occidentali stava per essere distrutto, Alice Eastwood prese una rapida decisione. Durante la sua gestione, aveva inaugurato una pratica all'epoca inconsueta: quella di custodire a parte gli esemplari tipo, ovvero quelli usati per descrivere e determinare le nuove entità. Almeno quello, il nucleo più prezioso dell'erbario, doveva essere salvato. Ma come raggiungerlo, visto che si trovava al sesto piano, nell'ufficio della curatrice? Con un coraggio che rasenta l'incoscienza, insieme al suo assistente Robert Porter, Alice (era un'alpinista provetta) salì sulla ringhiera di ferro della scala semicrollata e si arrampicò fin lassù mettendo i piedi tra i pioli. Dal suo ufficio prese un solo oggetto, un paio di occhiali, e incominciò a impacchettare i preziosi esemplari che poi vennero calati in cortile con l'aiuto di corde improvvisate. In tal modo salvò 1497 esemplari tipo, che vennero poi trasportati in un edificio sicuro; nel pomeriggio l'incendio si estese all'Accademia che arse per tre giorni, distruggendo tutto il resto, compresa la collezione personale della coraggiosa botanica. Diciannove giorni dopo Eastwood scrisse: "Non sento la perdita come qualcosa di personale, ma è una grande perdita per il mondo scientifico e una perdita irreparabile per la California. Non mi lamento del mio lavoro che è andato perduto, dato che per me è stato una gioia quando l'ho fatto, e lo sarà di nuovo quando ricomincerò". E sarebbe stato proprio così.  Ritratto di una botanica da giovane Abbiamo già incontrato Alice Eastwood parlando di Townshend e Catharine Brandegee. E' ora di conoscerla meglio. Alice era nata in Canada, a Toronto, ma adolescente si era trasferita con la famiglia a Denver in Colorado. Mentre ancora studiava alla scuola superiore, un casuale soggiorno in montagna l'aveva fatta innamorare delle piante delle Montagne rocciose e l'aveva spinta a studiare botanica da autodidatta sui pochi manuali disponibili e a creare un erbario. Anche se era una studentessa brillante, le condizioni economiche della famiglia le impedivano di andare all'Università; così, dopo il diploma rimase a insegnare al Shawa Convent Catholic High School, la scuola dove aveva studiato. Era una supplente sottopagata, cui veniva richiesto di insegnare ogni tipo di materia e di correggere una montagna di compiti. Tutto il poco che riusciva a risparmiare lo destinava ad acquistare libri di botanica e a pagarsi le vacanze estive, che trascorreva arrampicandosi su colline e montagne alla ricerca delle amate piante. Poco alla volta, incominciò a farsi un nome come esperta della flora del Colorado. Nel 1887 guidò sul Gray's Peak il celebre naturalista inglese Alfred Russel Wallace, che si trova negli Stati Uniti per un tour di conferenze. Nel 1889 accompagnò il naturalista Theodore Alison Cockerell a botanizzare nella Wet Mountain Valley, e grazie a lui fu nominata segretaria della Colorado Biological Association. Divenuta amica della famiglia Wetherill, che possedeva un ranch nella Mesa verde, ne fece la sua base per numerose escursioni nella cosiddetta Four Corner Region, l'area al confine tra Colorado, Utah, Arizona e New Mexico. Ormai sulla trentina, Alice desiderava lasciare l'insegnamento e diventare una botanica di professione. Alcuni investimenti le avevano permesso di farsi una piccola rendita che la rendeva economicamente indipendente. Nell'inverno 1890-91 visitò per la prima volta la California e incontrò i Brandegee. Katharine Brandegee, impressionata dalla qualità del suo erbario, le chiese di scrivere degli articoli per la sua rivista e le propose di lavorare con lei, ma Alice era piuttosto riluttante a lasciare il Colorado, tanto più che proprio in quel periodo stava scrivendo un libro, uscito nel 1893 con il titolo A popular flora of Denver, Colorado. Nell'estate del 1892, accompagnata da Al Wetherill fece una lunga escursione nell'Utah sudoccidentale alla ricerca di piante del deserto. Solo nel dicembre di quell'anno si trasferì definitivamente a San Francisco, come curatrice aggiunta dell'erbario, poi, dal 1894, al ritiro della signora Brandegee, come curatrice e capo del dipartimento di botanica dell'Accademia delle Scienze. Oltre a occuparsi della gestione dell'erbario e a scrivere articoli per varie riviste, in questo periodo Alice fece importanti raccolte botaniche, in particolare esplorando la allora poco studiata Catena costiera meridionale fino alla regione di Big Sur, che all'epoca non era collegata da nessuna strada. Escursionista e alpinista instancabile, era anche una colonna di associazioni di appassionati come il Sierra Club (con il quale nel 1903 scalò il Monte Withney, la cima più alta degli Stati Uniti esclusa l'Alaska) e il Botanical Club, per il quale scrisse anche una guida al riconoscimento delle piante selvatiche. Ottima divulgatrice, nel 1905 pubblicò A Handbook of the Trees of California, nella cui prefazione scrisse: "L'obiettivo è sempre stato la brevità e la chiarezza, il desiderio di aiutare piuttosto che di brillare".  La ricostruzione dell'erbario Ad eccoci tornati a quel maledetto 18 aprile 1906 quando tutte le collezioni dell'Accademia delle Scienze andarono in fumo, ad eccezione dei 1497 esemplari botanici salvati da Alice e di pochi documenti. Appena possibile, incominciò la ricostruzione. Mentre veniva costruita la nuova sede nel Golden Gate Park, Alice Eastwood andò a studiare nei più importanti erbari statunitensi ed europei: il Gray Herbarium di Harvard, gli erbari del New York Botanical Garden, del British Museum, di Kew e del Museo di storia naturale di Parigi. Questi viaggi le permisero anche di stabilire rapporti personali con molti colleghi. Così nel 1912, quando la nuova sede venne inaugurata e le fu nuovamente offerto il posto di curatrice del Dipartimento di botanica, era pronta per ricominciare. Il suo asso nella manica era l'eccezionale ricchezza della flora californiana, una delle regioni floristiche più ricche del pianeta, con quasi 4700 specie native di cui 1400 endemismi. Alice Eastwood percorse lo stato in centinaia di escursioni, da sola o alla guida di gruppi di cui era allo stesso tempo cuoca, organizzatrice, guida e responsabile scientifico. Esplorò i deserti e le montagne, gli angoli con caratteristiche geologiche peculiari, le zone minacciate dall'espansione urbana e agricola, la cui flora rischiava di sparire prima ancora di essere conosciuta. Le vacanze erano riservate a spedizioni più ampie negli Stati Uniti occidentali (Alaska, Arizona, Utah, Idaho). Grazie a queste estensive raccolte, Eastwood poté realizzare un intenso programma di scambi con altri orti botanici, in particolare con Harward e Kew. Infatti, mentre i primi esemplari andavano a incrementare la collezione dell'Accademia delle Scienze, i duplicati venivano scambiati con altri erbari in giro per il mondo. In cambio delle piante native della West Coast, ricercava soprattutto esemplari che la aiutassero ad identificare correttamente le numerose specie esotiche tropicali e subtropicali che fin dall'Ottocento erano venute a popolare i giardini e i vivai californiani, non di rado naturalizzandosi. Per ricostruire gli itinerari di queste piante migratrici, studiò a fondo i documenti sulle prime spedizioni europee in California. Nel 1949, quando andò in pensione, era riuscita ad aggiungere all'erbario 340.000 esemplari, più di tre volte tanto quelli perduti nell'incendio. I suoi sforzi furono diretti anche a ricostruire la biblioteca, che era andata totalmente distrutta. Lei stessa scrisse moltissimo: la sua bibliografia conta più di trecento titoli, tanto scientifici quanto divulgativi. Appassionata di giardinaggio, cercò di creare un ponte tra il mondo scientifico, i coltivatori e gli amatori. Per rendere popolare la botanica, volle che nell'atrio dell'Accademia si alternassero mostre di fiori freschi. Si impegnò per diffondere la coltivazione delle piante native nei giardini californiani e per la loro salvaguardia, battendosi per la creazione del Parco nazionale del Monte Tamalpais, una delle sue aree di raccolta preferite. Nel 1929 fu tra i soci fondatori della Fuchsia American Society e promosse il censimento delle specie e varietà di fucsie coltivate in California e l'introduzione di nuove varietà. Quando aveva 73 anni fu investita da un'automobile, riportando la frattura di un ginocchio; da quel momento, dovette servirsi di un bastone e rinunciò alle scarpinate. Ma non certo alle escursioni. Adesso, invece che a piedi o a cavallo, si muoveva in automobile, una Ford T, e mentre il suo assistente Thomas Howell si spingeva più lontano, si accontentava di erborizzare nei pressi. In piena salute fino quasi alla morte, andò in pensione nel 1949, a novant'anni, ma continuò a scrivere e a frequentare il suo vecchio ufficio all'Accademia. Nel 1950, il Settimo congresso internazionale di botanica, tenutosi a Stoccolma, la elesse Presidente onoraria (una specie di Oscar alla carriera); per rimarcare tanto onore, venne fatta sedere sul seggio che era stato di Linneo.  L'elegante Eastwoodia e le rare Aliciella Come autrice di nomi botanici, Alice Eastwood è stata una delle botaniche più prolifiche, con 652 taxa e 395 specie. Si tratta di endemismi delle Montagne rocciose e dell'Utah, da lei scoperti in gioventù, e ovviamente di piante californiane. Dato che tra le sue preferite c'erano le Liliaceae, cui dedicò vari importanti studi, vorrei citare le specie endemiche di Allium che scoprì, studiò e nominò: Allium cratericola Eastw., Allium hickmenii Eastw., Allium howellii Eastw., Allium yosemitense Eastw. Sono numerose anche le specie, sottospecie e varietà che la ricordano; tra di esse Fritillaria eastwoodiae, un endemismo della Sierra Nevada, della Cascade Mountains e dell'Oregon meridionale; Erigeron aliceae, una perenne dei pascoli e delle boscaglie del Nord-ovest pacifico; Ranunculus eastwoodinus, nativo dell'Alaska. Veniamo infine ai due generi che si fregiano del suo nome. Il primo in ordine di tempo è Eastwoodia, che gli fu dedicato nel 1894 da Townshend Brandegee. La sua unica specie, E. elegans, endemica di ambienti aridi delle praterie e delle colline della California centrale, negli anni precedenti era stata raccolta da diversi raccoglitori, tra i quale anche Alice Eastwood. Appartenente alla famiglia Asteraceae, è un arbustino alto fino a un metro, molto ramificato e con piccolissime foglie, che al momento della fioritura si fa notare per i numerosissimi capolini gialli globosi, composti unicamente di flosculi ligulati. Una sintetica presentazione nella scheda. Più complicate le vicende del secondo genere dedicato alla nostra protagonista. Nel 1892, erborizzando in Utah, Eastwood scoprì una nuova specie di Gilia che pubblicò come Gilia triodon. Nel 1905 il botanico tedesco August Brand ritenne che si differenziasse abbastanza dalle altre Gilia per essere assegnata a un nuovo genere, che denominò Aliciella in onore della scopritrice. La proposta di Brand non fu generalmente accettata, e il nuovo genere fu presto abbandonato. Tuttavia, in anni recenti è stato ripristinato sulla base di studi genetici. Appartenente alla famiglia Polemoniaceae, gli sono oggi assegnate oltre venti specie, distribuite in varie aree degli Stati Uniti occidentali, dall'Utah al New Mexico. Sono piccole annuali, biennali e perenni dei deserti o delle montagne, adattate ad ambienti molto specifici, il che le rende fragili e minacciate. Alcune sono anche molto belle, e l'eccessiva raccolta è uno dei pericoli che le insidia. La maggior parte delle specie cresce tra le fessure delle rocce o sui ghiaioni; sono terreni spesso instabili, cui si ancorano penetrando in profondità con le lunghe radici a fittone, talvolta più sviluppate della parte aerea. In questi habitat apparentemente inospitali, dove ben poche piante riescono a crescere, queste fragili bellezze non devono affrontare la concorrenza di altre specie. Mentre le specie annuali sono in genere abbastanza insignificanti, molte tra le perenni sono dei piccoli gioielli dalle fioriture smaglianti. Tra le più notevoli, anche le due più rare: A. caespitosa, un endemismo della Wayne County in Utah che cresce tra le fessure delle rocce di arenaria, oggi nota in solo sei stazioni; e la minuscola e bellissima A. sedifolia delle San Juan Mountains in Colorado, di diffusione così limitata che fino al 2007 si pensava fosse estinta. Ne furono poi scoperte due sole stazioni. Nella scheda qualche informazione anche su altre specie di notevole impatto estetico. Minuscole, tenaci, eleganti, sono tutte perfette per celebrare Alice Eastwood, che non solo amava gli ambienti impervi dove vivono, ma era lei stessa piccola di statura, piena di energia, sempre elegante anche durante le escursioni più avventurose. E da vera signora, non usciva mai senza cappello. Citato per diritto e per traverso, noto anche a chi non ha letto il romanzo, l'incipit di Anna Karenina è uno dei più celebri della letteratura mondiale: "Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo". Eppure sfido il grande Leo a trovare un amore felice simile a quello di Kate e Townshend Brandegee, che si innamorarono a quarant'anni sotto l'egida della botanica e per quasi altrettanti formarono una famiglia felice a modo loro. E a modo suo vive anche Brandegea bigelovii, tenace Curcurbitacea a suo agio nei deserti tra Stati Uniti e Messico.  Townshend prima di Kate, Kate prima di Townshend Fu la botanica a far incontrare Mary Katharine Layne Curran (1844-1920) e Townshend Stith Brandegee (1843-1925), e fu la botanica a farli innamorare. Entrambi erano sulla quarantina, nel pieno di una carriera che ne faceva personalità riconosciute nel loro campo. Ma i veri traguardi li avrebbero raggiunti insieme. Townshend era un ingegnere, ma, figlio di un medico che era anche un agricoltore, fin da bambino si era appassionato di storia naturale e aveva incominciato a creare un erbario. Dopo aver combattuto giovanissimo nella guerra civile, studiò ingegneria, ma anche botanica, alla Yale University’s Sheffield Scientific School; durante gli anni universitari, raccolse piante nella zona di New Haven, incluse alcune specie rare. Dopo la laurea, nel 1871 si trasferì a Cañon City in Colorado, come agrimensore della contea e ingegnere della città; anche qui continuò ad erborizzare, inviando piante a vari corrispondenti, incluso Asa Grey. Anche grazie alla raccomandazione di quest'ultimo, fu assunto come assistente topografo nella spedizione geografica nota come Hayden Survey, che tra il 1871 e il 1873 esplorò l'area che sarebbe diventata il parco di Yellowstone. Poté così lavorare fianco a fianco con il botanico della spedizione, John Coulter. Fu l'inizio di una carriera di ingegnere e topografo, al servizio delle compagnie ferroviarie e del servizio forestale; viaggiando in molte regioni ancora poco note degli Stati Uniti occidentali, ebbe anche occasione di esplorarne la flora. Fu anche incaricato di disegnare le mappe forestali di diverse regioni; nell'inverno 1886-87 fu inviato in California a rilevare le risorse forestali e cercare alcune essenze; visitò le isole di Santa Cruz e Santa Rosa, dove raccolse campioni per Charles Sprague Sargent. La scoperta della particolarissima flora delle isole lo convinse a stabilirsi a San Francisco e ad abbandonare la carriera di ingegnere civile per diventare un botanico a tempo pieno. Per saperne qualcosa di più, visitò l'erbario dell'Accademia delle scienze californiane. E lì avvenne l'incontro fatidico con Kate. Dopo aver raccontato di "Townshend prima di Kate", è dunque ora di parlare di "Kate prima di Townshend". Mary Katharine Layne aveva avuto un'infanzia errabonda. La famiglia Layne era approdata in California all'epoca della corsa all'oro, quando Kate aveva cinque anni, ma aveva continuato a cambiare sede al seguito di un padre inquieto. Nonostante l'educazione discontinua, la ragazza era diventata insegnante e nel 1866, a 22 anni, si era sposata con il poliziotto Hugh Curran, che purtroppo amava alzare il gomito e dopo sei anni la lasciò vedova. Kate, che adesso si chiamava ufficialmente Mary Katharine Curran, decise di trasferirsi a San Francisco e di iscriversi alla scuola di medicina, che aveva appena aperto le porte alle donne; lei fu la terza ad approfittarne. Nel 1878 si laureò. All'epoca, l'insegnamento della tradizionale "materia medica", ovvero della botanica applicata alla farmacia, faceva ancora parte del curriculum di medicina. Grazie a un professore eccezionale, Hans Hermann Behr, un convinto evoluzionista, la giovane donna incominciò ad interessarsi di piante e apprese il metodo rigoroso che poi sempre l'avrebbe contraddistinta. Behr la introdusse all'Accademia delle Scienze e al suo erbario, dove Katharine incominciò a prestare la sua opera come volontaria. Quando scoprì che per una donna era difficile esercitare la professione medica, questo divenne il suo lavoro. Nel 1879 divenne assistente del curatore dell'erbario, Albert Kellogg, e dal 1883, quando egli andò in pensione, gli succedette come curatrice e responsabile del dipartimento di botanica dell'Accademia; era una posizione eccezionale per una donna. All'epoca, nell'intera California, le botaniche professioniste erano solo due. Oltre a lavorare intensamente al riordino e all'accrescimento delle collezioni con escursioni sul campo, per presentare le nuove scoperte la dottoressa Curran ebbe l'idea di creare una rivista che scriveva di fatto da sola, Bulletin of the California Academy of Sciences; ufficialmente era solo la curatrice, e non il direttore responsabile, perché l'Accademia era riluttante a riconoscere che la sua principale pubblicazione era diretta da una donna. Fin a quel momento, l'autorità di Asa Gray e di Harvard era tale che all'Ovest nessuno osava pubblicare una nuova specie senza consultare quell'oracolo. La rivista fornì un veicolo per pubblicare più rapidamente le nuove specie e diede un grande contributo alla coscienza di sé e all'indipendenza della botanica californiana. Determinata, dotata di leadership e grinta, quando incontrò Towshend, la dottoressa Curran era una delle poche donne a dirigere una importante istituzione scientifica, senza tirarsi indietro anche quando si trattava di dare battaglia per conquistare un finanziamento. Vedova, senza figli, divideva il suo tempo tra il lavoro quotidiano all'erbario, la redazione di articoli scientifici e del Bollettino, le spedizioni sul campo.  Un'unione di cuore e di mente Il fatidico incontro tra Towshend e Kate dovette avvenire nell'inverno 1886. Non conosciamo i particolari del loro innamoramento, che dovette essere profondo e fulminante, nonché piuttosto inconsueto per l'epoca, tanto da destare battutine e pettegolezzi. Katharine confessò a una sorella di essere "innamorata in modo folle" e i sentimenti di Townshend, benché fosse un uomo discreto e taciturno, non dovettero essere diversi. Presto decisero di sposarsi, ma lontano dal pettegolo ambiente dell'Accademia; dunque non a San Francisco, ma a San Diego, dove nel maggio 1889 Kate raggiunse Towshend di ritorno dalla sua prima spedizione botanica in Baja California per conto dell'Accademia delle Scienze. Dopo la cerimonia, officiata da un pastore, iniziarono la loro vita di coppia con un inconsueto viaggio di nozze: da San Diego a San Francisco, raccogliendo piante lungo la strada; una bella camminata, se si pensa che le due città sono separate da oltre 800 km! Oltre che innamorati e devoti l'uno all'altro, anche come botanici i Brandegee erano perfettamente complementari. Il punto forte di Towshend era il lavoro sul campo, la vasta conoscenza della flora degli Stati Uniti occidentali acquisita in quasi vent'anni di viaggi e raccolte; quello di Kate, che aveva erborizzato solo nella California centrale, era l'eccezionale competenza di tassonomista. Inizialmente la coppia rimase a San Francisco; Kate, che adesso si firmava Katharine Layne Brandegee, continuò a lavorare all'erbario; Townshend entrò a far parte dell'Accademia delle Scienze. Nel 1890 ricevette una piccola eredità; grazie a questa somma, Kate poté fondare una propria rivista scientifica, Zoe; tuttavia, ufficialmente come direttore responsabile figurava il marito, perché la comunità scientifica non era ancora pronta ad accettare una rivista diretta da una donna. Nel 1891 Katharine fondò il California Botanical Club, aperto anche agli amatori, la prima associazione di questo tipo della West Coast. Entrambi i coniugi intensificarono le attività di raccolta, lui soprattutto in Baja California, lei prevalentemente nella California centrale. Durante un'escursione, Townshend incontrò una giovane botanica canadese, Alice Eastwood, e la presentò alla moglie, che esaminando il piccolo erbario raccolto dalla ragazza a Denver, rimase colpita dalla sua qualità. Rinunciando a una parte dello stipendio, la assunse come assistente, finché nel 1892 l'Accademia l'assunse ufficialmente come curatrice aggiunta. Potendo affidare molto del lavoro di routine ad Alice, ora Katharine poteva concentrarsi su ciò che più la interessava: la descrizione, l'identificazione e la classificazione delle piante. Profondamente consapevole che le specie possono presentare un altro grado di variabilità, secondo l'esposizione, il suolo, le condizioni climatiche, era convinta che, prima di denominare una nuova specie, bisognasse studiarne le crescita in situazioni differenti, raccogliendo e confrontando il maggior numero possibile di esemplari cresciuti in diverse condizioni ambientali. Di conseguenza, non sopportava i botanici egocentrici che moltiplicavano le denominazioni al puro scopo di aggiudicarsi l'effimera gloria di una nuova scoperta. Contro di loro, lanciò i suoi strali su Zoe, divenendo celebre - potremmo dire famigerata - per la ferocia delle sue critiche. Nel suo rigore, arrivò a lamentarsi persino del marito che "ha descritto come nuova una specie contro la mia volontà". Townshend si specializzò nella flora del Messico, in particolare della Baja California, che percorse in numerose spedizioni, divenendone il massimo esperto. Tra aprile e maggio 1893 insieme a altri cinque botanici esplorò la Sierra San Pedro Mártir nella Baja California settentrionale; lo stesso anno, tra settembre e ottobre, fece due viaggi da San Jose del Cabo nelle montagne della regione del Capo; al primo partecipò anche Katharine, che fotografie del tempo ritraggono a cavallo di una mula vestita in abiti maschili. Mentre rientrava da sola da questo viaggio, la sua imbarcazione naufragò. Fu forse considerano questi rischi e la distanza di San Francisco dal Messico che i Brandegee decisero di trasferirsi a San Diego; Katharine diede le dimissioni dall'erbario (come curatrice le succedette Alice Eastwood) e nel marzo 1894 acquistarono un vasto terreno non edificato sull'altopiano alle spalle della città, la mesa, con vista sulla baia di San Diego. Il loro primo pensiero, prima ancora di costruire la casa, fu per l'erbario, per ospitare il quale fecero costruire un padiglione di mattoni, mentre loro vivevano in una tenda. Fu poi la volta della casa e di una serra. Tutto attorno uno straordinario orto botanico, con piante raccolte in natura e portate qui dalle spedizioni della coppia in Messico e nella California meridionale. Era in primo luogo un laboratorio all'aria aperta, dove le piante raccolte durante le spedizioni venivano coltivate riproducendo le diverse condizioni naturali di crescita, in modo da osservarne le variazioni e giungere a una classificazione corretta. Ma era anche un giardino bellissimo, che così è stato descritto da un ospite: "Un paradiso botanico, con fiori rari da tutte le parti, e i canti di tordi beffeggiatori, quaglie e altri uccelli canori nativi a rendere l'aria musicale". Nel 1896, l'appassionato raccoglitore di piante di origine tedesca Carl A. Purpus scrisse a Katharine per chiedere l'identificazione di diverse specie; la cortese ed esperta risposta della botanica fu l'inizio di una collaborazione e di un'amicizia. Da quel memento la casa di San Diego divenne la base delle spedizioni di Purpus in Messico; in cambio, egli arricchì il giardino e l'erbario dei Brandegee con continui invii di piante dei deserti messicani, che i due botanici studiavano, coltivavano, classificavano. Townshend rinunciò alle faticose spedizioni in Messico, ma continuò ad esplorare assiduamente i dintorni di San Diego. Unica eccezione, una spedizione del 1902 in compagnia di Kate Sessions, una intraprendente e creativa vivaista dalla quale i Brandegee al loro arrivo a San Diego avevano acquistato alcune piante. Insieme a lei, Townshend ritornò nella regione del Capo per visitare alcune località trascurate nelle spedizioni precedenti; dopo aver raggiunto San Jose del Capo in battello, si addentrarono sulle montagne a dorso d'asino; fu così che scoprirono una palma ancora ignota, Brahea brandegeei. Lo stesso anno, Sessions fu incaricata dalla Città di San Diego di piantare un nuovo parco (Balboa Park) e convinse il botanico a prestare la sua consulenza per la scelta delle piante. Avvicinandosi la sessantina, i Brandegee cominciarono a pensare al futuro del loro amatissimo erbario, a cui dedicavano molte ore della giornata e che adesso comprendeva circa 76.000 esemplari. Decisero di farne dono, insieme alla biblioteca, all'Università della California a Berkeley, a condizione di poter continuare a lavorarvi fino alla fine dei loro giorni. Nonostante la munificenza del dono, le trattative si trascinarono per quattro anni. I Brandegee dovettero farsi carico anche delle spese di trasporto e non vennero aiutati neppure a trovare una casa. Poco prima della data fissata per il trasloco, nell'aprile 1906, avvenne il disastroso terremoto di San Francisco. Fortunatamente Berkeley e il campus subirono danni limitati e entro la fine dell'anno il trasferimento era completato. Fino a tarda età marito e moglie continuarono a lavorare gratuitamente ogni giorno all'erbario, di cui Townshend era stato nominato curatore onorario, e finché fu possibile continuarono anche le spedizioni botaniche; nel 1913, anche se soffriva di diabete in una forma sempre più grave, Katharine fece ancora una lunga spedizione in California alla ricerca di esemplari-tipo, per sostituire quelli andati perduti nell'incendio di San Francisco. Per molti anni, a occupare le giornate di lui fu anche la pubblicazione delle piante raccolte da Purpus in Messico, nella imponente Plantae Mexicanae Purpusianae, in 12 volumi (1909-1924). Quando completò l'opera, era già rimasto solo. Kate se ne era andata per prima, nel 1920, a 76 anni. Townshend la raggiunse nel 1925. Chi li conobbe durante gli anni di Berkeley, notò che anche da vecchi continuavano a mostrare "lo stesso indomabile amore per il pensiero critico e difficile che li aveva caratterizzati già da giovani". A rimanere invariato fino alla fine era stato anche l'amore reciproco, che li aveva sorprendentemente uniti quasi quarant'anni prima. Una sintesi delle loro vite tutte dedite alla scienza nella sezione biografie.  Brandegea, una deserticola variabile Il lascito di Townshend Brandegee sta soprattutto nelle piante che scoprì nelle sue spedizioni: gli è accreditata la scoperta di circa 225 piante della Baja California. Parecchie lo ricordano nel nome specifico. Abbiamo già incontrato Brahea brandegeei; tra le californiane, aggiungiamo Salvia brandegeei, una notevole Salvia dell'isola di Santa Rosa che è stata anche introdotta nei giardini per il grande valore ornamentale; tra le messicane, Echinocactus brandegei, una specie molto variabile che sembra fatta apposta per confermare le teorie di Katharine Layne Brandegee. Anche Katharine scoprì diverse piante notevoli, come Eriastrum brandegeeae, una rara Polemoniacea della catena costiera californiana. Ma questa grandissima botanica è ancora più importante come ricercatrice, tassonomista, teorica; giocò un ruolo enorme nell'emancipare la botanica californiana e diede un contributo altrettanto incisivo agli studi tassonomici, soprattutto sul piano metodologico. Di valore incalcolabile è poi il lascito comune di entrambi: il grande erbario ora custodito a Berkeley. Quanto al giardino di San Diego, purtroppo passò in altre mani che lo lasciarono morire, e non ne rimane nulla. Né Townshend né Katharine cercavano fama e onori; a loro interessava unicamente il progresso della scienza. Così la piccola pianta del deserto che li celebra appare straordinariamente adatta a ricordarli. A rigori, fu dedicata solo a lui, ma poiché vive sia in California sia nel Messico settentrionale, le aree di cui i due botanici erano specialisti, possiamo considerarlo un omaggio a entrambi. Durante la sua prima spedizione in Baja California, Townshend raccolse una cucurbitacea dai fiori molto minuti che pubblicò come Cyclanthera monosperma Brandegee; poco dopo, l'importante tassonomista belga Célestin Alfred Cogniaux, esperto di Cucurbitaceae, la unì a una specie già nota come Elaterium bigelovii S. Watson, creando il genere Brandegea con due specie, B. bigelovii (S.Watson) Cogn. e B. monosperma (Brandegee) Cogn. Oggi al genere Brandegea, una liana della famiglia Cucurbitaceae, con profondissime radici a fittone, sottili fusti volubili, piccole foglie verde scuro profondamente palmate, ma molto variabili nella forma e nelle dimensioni, piccolissimi fiori bianchi con cinque petali appuntiti, minuscoli frutti secchi spinosi, è assegnata una sola specie, B. bigelovii. Come molte piante del deserto, che devono affrontare condizioni estreme e molto differenziate nel corso delle stagioni e da un anno all'altro, anch'essa è estremamente variabile, tanto che in passato i botanici, meno prudenti di Katharine Layne Brandegee, le avevano assegnato almeno quattro specie, con una foresta di sinonimi. E' dunque anch'essa una conferma vivente della correttezza del metodo di questa grande botanica, che ne diventa così la co-dedicataria onoraria. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed