Wilibald Besser e il giardino di Kremenc', ovvero come nacque, fiorì e fu distrutto un orto botanico10/11/2023 Fondato nel 1806, l'orto botanico del Liceo di Kremenec' fu il primo nel territorio dell'attuale Ucraina, e nell'arco di pochissimi anni si impose come uno dei più ricchi dell'intero impero russo. Merito dei suoi due creatori: il giardiniere paesaggista irlandese Denis McClair che lo progettò e il botanico austriaco Wilibald Besser che lo diresse per più di vent'anni e lo arricchì di migliaia di piante, native ed esotiche. Prima di arrivare a Kremenec', il giovane Besser aveva già all'attivo molte ricerche e un libro sulla flora della Galizia, e nei trent'anni che trascorse in Volinia e in Ucraina divenne uno dei maggiori esperti della flora delle regioni sudoccidentali dell'Impero russo. Il magnifico giardino che aveva fatto crescere con amore e sapienza durò meno di trent'anni e al povero Besser toccò l'ingrato compito di presiedere al suo smantellamento, atto di forza e di vendetta dell'imperialismo russo. A ricordarlo il bellissimo genere messicano Bessera.  Antefatto: un liceo prestigioso e un orto botanico Nel 1803, lo zar Alessandro I autorizzò la fondazione di un istituto scolastico desinato alla formazione dei giovani della parte sud-orientale dell'ex Confederazione polacco-lituana, passata sotto il dominio russo con la spartizione del 1795, e ne affidò la realizzazione al pedagogista Tadeusz Czacki, importante esponente dell'illuminismo polacco, membro della Commissione d'educazione nazionale all'epoca dell'indipendenza e ora direttore dei distretti scolastici dei governatorati di Volinia, Podolia e Kiev. Czacki individuò il luogo ideale in Kremenec' (Krzemieniec in polacco) nella regione storica della Volinia, che offriva il vantaggio di non essere lontana dalla frontiera con la Galizia austriaca, da cui sperava di attirare studenti di lingua madre polacca. La scuola fu sistemata negli edifici del precedente collegio gesuitico e in un palazzo della famiglia Wiśniowiecki; offriva corsi dalle elementari alle secondarie e ammetteva anche allievi ebrei. Inizialmente fu chiamata Ginnasio della Volinia, per poi diventare dal 1819 Liceo di Kremenec'; ma il suo prestigio era tale che per molti era semplicemente l'"Atene della Volinia". Impartiva un insegnamento laico e aperto in lingua polacca e polacchi erano tutti i suoi insegnanti, ad eccezione di uno che presto conosceremo. Sovvenzionata da molti donatori, che vedevano nel liceo di Kremenec' un modo per preservare almeno l'eredità culturale della nazione polacca, cancellata e divisa dalle spartizioni, avendo potuto incorporare le collezioni dell'ultimo re di Polonia Stanislao Poniatowski, la scuola vantava una biblioteca di quasi 35.000 volumi, era ben dotata di attrezzature e forniva un vasto programma educativo che comprendeva anche l'insegnamento della lingua inglese ed offriva agli studenti migliori la possibilità di perfezionarsi a Edimburgo o in altre università britanniche. Il particolare legame con il mondo anglosassone era visibile in un altro dei fiori all'occhiello del prestigioso istituto: l'orto botanico. Fondato nel 1806, fu disegnato dal giardiniere paesaggista irlandese Denis McClair (1762-1853) e posto sotto la direzione dal primo docente di botanica del liceo, il polacco Franciszek Scheldt, che in precedenza aveva diretto l'orto botanico di Cracovia. L'avventurosa storia dell'uomo che importò in Polonia e in Ucraina il giardino paesaggistico all'inglese merita una piccola digressione. McClair era figlio di un fittavolo che, avendo partecipato alla Rivolta dei Whiteboys del 1777, fu condannato a morte; per salvarsi, fuggì e si arruolò prima nell'esercito prussiano poi in quello polacco dove fece una discreta carriera, divenendo maggiore di artiglieria. Nonostante la situazione difficile, il giovane Denis studiò botanica e scienze naturali all'Università di Dublino, poi si trasferì a Londra dove incominciò a lavorare come giardiniere, lavorando anche per il duca di Bedford. Dopo altre avventure, nel 1790 incontrò la principessa Izabela Lubomirska, venuta appositamente nella capitale inglese per ingaggiare un abile giardiniere paesaggista. Anche nella speranza di ritrovare il padre, McClair accettò il suo invito di seguirla in Polonia e, anche se non incontrò mai il genitore (questi nel frattempo aveva approfittato di un'amnistia e era ritornato in Irlanda, dove sarebbe morto in un'altra rivolta, quella del 1798), incominciò ad essere sempre più apprezzato dai committenti polacchi. Creò vari giardini sia a Varsavia sia in altre località polacche. In Volinia arrivò nel 1792, quando il principe Lubomirski gli affidò la realizzazione del parco "Palestina" a Dubno; nonostante fossero gli anni difficili che portarono alla terza spartizione della Polonia e all'annessione sia di questa regione sia della Podolia da parte della Russa, i grandi proprietari polacchi conservarono le loro terre e McClair - che in Polonia era diventato Dionizy Mikler - continuò a lavorare per loro; nell'arco di oltre trent'anni progettò una cinquantina di parchi nelle terre dell'attuale Ucraina occidentale. Tra di essi appunto l'orto botanico del Liceo di Kremenec', il più antico dell'Ucraina. Nel 1805 McClair ricevette da Czacki l'incarico di progettarlo, nel 1806 il giardino fu inaugurato, ma fu completato solo nel 1809; si estendeva su 4.5 ettari, comprendeva un parco all'inglese, un roseto, tre arancere, serre e le vere e proprie aiuole didattiche, con piante medicinali; nei primi tre anni della sua esistenza (1806-1809) conteneva 760 specie esotiche e 460 specie di flora locale, raccolte da McClair. Lo sappiamo dal primo catalogo del giardino, Catalogue des plantes du Jardin botanique de Krzemieniec en Volhynie, pubblicato nel 1810 dal vero protagonista di questa storia: il botanico e entomologo austriaco Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784-1842). 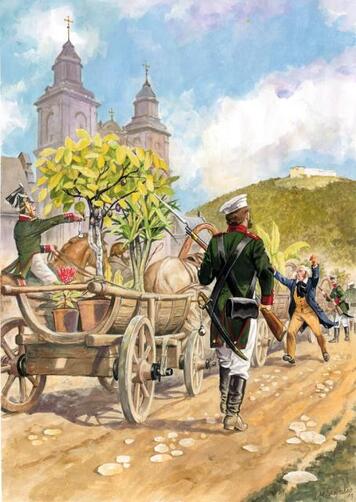 Dalla flora della Galizia a quella dell'Ucraina Senza una duplice disgrazia, il destino di Wilibald Besser sarebbe stato totalmente diverso. Nato a Innsbruck, nel 1797, quando aveva appena 13 anni, perse in un'epidemia entrambi i genitori, Samuel Gottlieb Besser e Josepha von Lansenhoffer; a occuparsi del piccolo orfano fu un parente della madre e suo padrino, il botanico Swibert Burkhard Schiverek (1741-1806). Questi, dopo aver insegnato per vari anni chimica e botanica all'università di Innsbruck (dove aveva posto mano a una Flora Tyrolensis, mai completata), in seguito alla soppressione di questa nel 1783, era stato trasferito all'Università di Leopoli di cui fu il primo professore di chimica e botanica. Egli prese con sé il ragazzo, lo fece studiare al Liceo di Leopoli e poi alla facoltà di medicina dell'Università, di cui era anche rettore. Soprattutto, gli trasmise la passione per le scienze naturali, in particolare per botanica e entomologia. Schiverek, più che insegnare ex cathedra, amava guidare i suoi studenti in escursioni sul campo. Lo aveva fatto a Innsbruck, lo faceva a Leopoli e lo avrebbe fatto a Cracovia, la sua terza sede, dove nel 1805, quando anche l'università di Leopoli venne chiusa, fu trasferito come curatore dell'orto botanico e direttore del dipartimento di storia naturale. Inutile dire che Besser (ora diciannovenne) era con lui. Purtroppo l'anno successivo Schiverek morì e Besser perse un secondo padre. Trovò però un altro validissimo maestro nel suo successore alla cattedra di botanica, Josef August Schultes. Se da Schiverek aveva assorbito l'amore per piante e insetti e aveva imparato come muoversi sul campo, con Schultes perfezionò la competenza tassonomica. Già a Leopoli, da solo o con l'aiuto di amici, aveva raccolto una vasta collezione di piante galiziane, che andava ad aggiungersi al notevole erbario ereditato da Schiverek, e a Cracovia lo ampliò ulteriormente grazie alle escursioni organizzate da Schultes, che toccarono anche i Carpazi. Notevolissima anche la sua collezione di insetti. Besser si laureò in medicina nel dicembre 1807 e quasi immediatamente fu assunto come assistente presso la Clinica universitaria di Cracovia. Benché fosse un bravo medico (esercitò la professione per tutta la vita ed era apprezzato dai suoi pazienti), la sua vera vocazione era la botanica. Così quando nel 1808 Czacki gli offrì la cattedra vacante di professore di botanicae zoologia e il posto di direttore dell'orto botanico del liceo di Kremenec' (Scheldt, il primo titolare, era morto nel 1807), egli non esitò ad accettare, nonostante le due condizioni poste dal governo russo e da Czacki: che egli prendesse la cittadinanza russa e si impegnasse a insegnare in polacco. Del resto, l'offerta era generosa. Prima di assumere il suo incarico a Kremenec', egli fu infatti inviato a Vienna e gli furono forniti i fondi per pubblicare un'opera sulla flora della Galizia austriaca, basata sulle raccolte proprie e di Schiverek (Primitia Florae Galiciae Austriacae utriusque in due volumi). In cambio, doveva attenersi alle precise istruzioni scritte di Czacki: praticare gli ambienti scientifici, acquistare libri aggiornati per la biblioteca del Liceo, contattare un artigiano cui commissionare modelli didattici di piante, frequentare la comunità polacca per perfezionare il suo polacco, che aveva appreso dal vivo vivendo in Galizia fin dall'adolescenza. Il soggiorno viennese duro quasi un anno, e permise a Bessere anche di approfondire gli studi di entomologia sotto la guida di Franz Anton Ziegler. Dopo questa fruttuosa parentesi, il giovane professore (aveva 25 anni) iniziò a svolgere i suoi compiti a Kremenec' nell'agosto 1809. Poiché si è conservato il programma delle sue lezioni, sappiamo che si teneva aggiornato sugli sviluppi della biologia (tra l'altro, illustrò ai suoi allievi le tesi di Lamarck) e che era attento alle relazioni tra piante e substrato, come dimostrano le sue lezioni su piante alofile come Salsola e Chenopodium. Si innamorò subito della varia vegetazione dei dintorni di Kremenec' e dedicò tutta la sua passione arricchimento dell'orto botanico. I progetti del suo predecessore Scheldt erano stati presto interrotti dalla malattia e dalla morte e probabilmente anche le collezioni di McClair gli parevano insufficiente, se questi nel 1811 questi fu inviato a procurarsi altre piante in un lungo giro in cui toccò San Pietroburgo, Danimarca, Finlandia, Svezia e Inghilterra. Grazie a questa ampia spedizione, le piante coltivate a Kremenec salirono a 2270 specie, come ci informa la seconda edizione del catalogo e i suoi supplementi, pubblicati da Besser tra il 1811 e il 1815. Finita la collaborazione con McClair nel 1811, Besser continuò ad incrementare le collezioni con scambi con altri orti botanici e con doni di appassionati e dei proprietari terrieri che finanziavano copiosamente il liceo. Riuscì anche ad ottenere dal conte Rumjancev le piante raccolte durante la spedizione Kotzebue. Nel 1830, alla vigilia della sua soppressione, il giardino misurava 20 ettari e ospitava 12000 piante. Quel gran numero si doveva anche alle raccolte dello stesso Besser che, come aveva fatto a Leopoli e a Cracovia, esplorò a fondo la flora prima dei dintorni della città e dei monti Kremenec', quindi estese sempre più il campo delle sue ricerche ce spaziarono dalla Polesia al mar Nero, dalla Volinia e dalla Podolia fino alla riva destra del Dnepr; in queste raccolte seppe anche coinvolgere tanto i suoi studenti quanto un gruppo di amici e appassionati, per i quali scrisse in polacco Przepisy do układania zielników ("Regole per la compilazione di un erbario" , Vilnius 1826). Il più attivo dei suoi collaboratori fu A. L. Andrzejowski, che divenne il suo assistente e lo accompagnò in molti viaggi, aiutandolo a raccogliere un ricchissimo materiale d'erbario, ampliato ed esteso anche grazie agli scambi con altri botanici. Besser non mancò di fare raccolte anche nei dintorni di Vilnius in Lituania, dove si era recato per confermare il titolo di dottore in medicina in modo da poter esercitare la professione in Russia; infatti al suo rientro ottenne l'incarico di medico cittadino di Kremenec', che andò ad aggiungersi all'insegnamento, alla direzione dell'orto botanico e all'attività scientifica. Nel 1821 pubblicò un articolo sulla flora di Vilnius; nel 1822 uscì la sua opera più importante (Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, Gub. Kiioviensi, Bessarbia Cis-Tyraica et circa Odessam collectarum), dedicata alle piante raccolte nel corso dei suoi viaggi nelle regioni sud-occidentali dell'Impero russo; nel 1834 il più breve saggio Über die Flora des Baikal. Tra il 1832 e il 1834, a Besser toccò il più doloroso dei compiti: liquidare lo splendido giardino cui aveva dedicato tanto amore e tanti sforzi. Dopo la morte di Alessandro I, che lo aveva favorito e protetto, il Liceo di Kremenec' cominciò a declinare e ad attirare i sospetti del rigido successore Nicola I, che vi vedeva sempre più un covo della resistenza polacca al dominio russo. Così la rivolta polacca, iniziata nel novembre 1830, segnò la fine dell'Atene della Volinia. Il liceo venne chiuso e nel 1834 la biblioteca e molti professori vennero traferiti all'ateneo di Kiev, contestualmente fondato dallo zar. Tra di loro c'era anche Besser, primo titolare della cattedra di botanica. Ma prima di trasferirsi nella capitale ucraina, dovette presiedere allo smantellamento dell'orto botanico; nel 1832 il giardino fu chiuso e fu decretato il trasferimento delle piante più preziose a Kiev. Espiantate, imballate e preparate secondo le indicazioni di Besser, circa 500 piante lasciarono Kremenec' in un lungo convoglio di carri sotto scorta militare, come si faceva per i deportati e i condannati. Per i polacchi, era uno sfregio e un gesto di vendetta, tanto più che a Kiev non c'era alcun orto botanico ad accoglierle. Così esse furono temporaneamente sistemate nel giardino imperiale. Per la nascita ufficiale dell'orto botanico dell'Università di Kiev si dovette attendere il 1839, ma a occuparsi del trapianto delle esuli di Kremenec' non fu Besser. Egli infatti rimase a Kiev solo tre anni, dal 1834 al 1837. Era sempre stato un grande lavoratore, ma il compito di creare dal nulla il dipartimento di botanica comportò un super lavoro che finì per minare la sua salute; inoltre, mentre parlava fluentemente polacco, non conosceva il russo ed era costretto a fare lezione in latino. Così nel 1837 diede le dimissioni e tornò nell'amata Kremenec', dove sarebbe morto nel 1842. Prima di lasciare Kiev, donò la sua vasta collezione di insetti all'università che, dopo la sua morte, avrebbe acquistato dalla vedova il suo vastissimo erbario e la sua notevole biblioteca. Besser dedicò gli ultimi della sua vita principalmente agli studi tassonomici, campo in cui era così reputato che l'orto botanico di Berlino chiese il suo aiuto per la classificazione di generi controversi; era uno specialista di Asteraceae ed in particolare di Artemisia, cui dedicò otto monografie che molto contribuirono a chiarire questo difficile genere, tanto che de Candolle adottò quasi integralmente la sua sistemazione nel Prodromus. Forse vi piacerà scoprire che l'orto botanico di Kremenec' esiste di nuovo: nel 1990, alla vigilia dell'indipendenza, il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina decretò la ricostruzione del giardino, anche se i lavori veri e propri iniziarono nel 2001 quando esso passò sotto la gestione del Ministero dell'ecologia e delle risorse naturali dell'Ucraina. Certo, con le sue 2000 specie e varietà è ben lontano dalle passate glorie, ma è comunque una realtà importante, con un arboreto di oltre 200 specie, una collezione di piante native, undici delle quali elencate nella lista rossa delle piante in pericolo da salvare, e diversi dipartimenti scientifici che riprendono la tradizione interrotta di Besser. Il giardino - che, com'era un simbolo della resilienza polacca a inizio '800 ora è un simbolo dell'identità e dell'orgoglio nazionale ucraino - non dimentica i suoi due fondatori: Besser è ricordato da un monumento, McClair da un cippo commemorativo; nel nome di quest'ultimo è in atto un progetto di collaborazione con diversi partner irlandesi, tra cui l'orto botanico nazionale di Dublino, ed è stato realizzato un "angolo irlandese" con specie provenienti dalla sua patria.  Bessera, una fantasmagoria di colori Autorevole esponente della comunità scientifica tanto germanica quanto russa, Besser fu membro tra l'altro della Società imperiale dei naturalisti di Mosca, della Società medica imperiale di Vilnius, dell'Accademia Leopoldina e, come socio corrispondente, della Royal Society e dell'Accademia Imperiale delle Scienze di San Pietroburgo. Nel 1828 fu ammesso alla nobiltà del Governatorato di Volinia e aggiunse al cognome l'ambita particella von. Ad attestare la stima in cui era tenuto è anche la quadruplice dedica di un genere Bessera: in ordine cronologico troviamo infatti nel 1809 Bessera (Boraginaceae) da parte del suo maestro Josef August Schultes, oggi sinonimo di Pulmonaria; nel 1815 da parte di K.P.J. Sprengel Bessera (Phyllanthaceae), sinonimo di Flueggea; nel 1829 Bessera (Nyctaginaceae) da parte del brasiliano Vellozo, sinonimo di Guapira, e Bessera (Asparagaceae) da parte di Julius Hermann Schultes, figlio di Josef August. Poiché per un motivo o l'altro le altre denominazioni sono illegittime, a essere valido è quest'ultimo. Ne era ben consapevole Schultes junior che creò questo genere sia per rispettare la volontà paterna, sia per evitare che un botanico tanto stimabile rimanesse privo di un genere celebrativo; nella dedica, sotto forma di lettera a D.F.L. von Schlechtendal, egli infatti scrive: "Poiché il genere Bessera fondato da mio padre non è stato accettato e quello di Sprengel è stato emendato dallo stesso autore, ho creato un nuovo Bessera in onore del dottore e professor Besser, ottimo amico di mio padre e benemerito dello studio delle piante, come è noto a te e a tutti i botanici". Non scelse una pianta a caso, ma una specie di grande bellezza (Schultes la definisce pulchra "bella") appena giunta dal Messico, Bessera elegans. Oggi a questo piccolo genere di geofite tuberose sono assegnate quattro-cinque specie, tutte endemiche del Messico. Come Brodiaea, di cui ho scritto in questo post, appartiene alla sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Fino a pochi anni fa, le specie riconosciute era solo due: appunto B. elegans, con una vasta distribuzione nel versante pacifico del Messico (dal Sinaloa al Durango nella Sierra Madre Occidental, alla parte meridionale del Deserto di Chihuahua e alla Sierra Madre del Sur nell'Oaxaca), e B. tuitensis, un endemismo della Sierra de El Cuale nello stato di Jalisco. Nel 2021, lo studio di 21 popolazioni di B. elegans e delle loro variazioni morfologiche ha portato all'individuazione di altre due specie, B. ramirezii e B. elegantissima. Incerto è invece lo status di una eventuale quinta specie, B. tenuiflora. a seconda se si include o meno in Bessera il genere Behria. Plants of the World on line sposa la prima posizione e denomina questa specie Bessera tenuiflora, mentre il sito della Pacific Bulb Society, sulla base degli studi dei botanici dell'Università di La Paz in Baja California, mantiene separati i due generi e riporta la specie come Behria tenuiflora. Si tratta della posizione più convincente a cui mi atterrò anch'io. Le Bessera posseggono cormi rivestiti da uno strato membranoso di minute fibrille, da cui emergono strette foglie lineari e lunghi scapi che terminano con un'ombrella di eleganti fiori penduli a campana dai colori vividi: le corolle sono rosso rubino in B. elegans, rosso chiaro, scarlatto, viola, magenta o fucsia in B. elegantissima, da rosa a lilla in B. tuitensis, viola scuro in B. ramirezii. Ma i colori non finiscono qui: in B. elegans il tubo è bianco e il pistillo, racchiuso tra lunghi filamenti rossi, è viola, mentre il polline è grigio. Questa fantasmagoria di colori e la forma dei fiori ci dicono che queste bellissime piante sono impollinate dai colibrì. Solo i cormi di B. elegans (in inglese la chiamano molto giustamente coral drops, gocce di corallo) sono talvolta disponibili da noi; poiché non è rustica e va mantenuta rigorosamente asciutta durante il riposo vegetativo, è consigliabile la coltivazione in vaso. Altre informazioni nella scheda.
0 Comments
Forse nel vostro giardino coltivate la bella e robusta Euphorbia characias subsp. wulfenii, oppure, se amate le piante alpine, conoscete Primula wulfeniana o Androsace wulfeniana, o addirittura la rara e bellissima Wulfenia carinthiaca. Tutte ricordano il sacerdote austriaco Franz Xaver von Wulfen, ex gesuita di santa vita, che nella seconda metà del Settecento fu tra i pionieri dello studio delle piante alpine, che andava a cercare nel loro ambiente naturale, tra malghe e crode; nella sua lunga carriera di naturalista delle grandi cime, fece più di 60 scalate, scalando tra gli altri il Grintovec in Slovenia, la Croda Rossa di Braies nelle Dolomiti, l'Eisenhut e lo Schleinitz nelle Alpi austriache. Ultra settantenne, partecipò addirittura all'epica sfida che portò alla conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria, anche se non fu tra quelli che raggiunsero la vetta. A ricordarlo non può che essere una pianta che egli stesso raccolse sulle sue montagne, appunto Wulfenia carinthiaca, specie tipo di un genere che non cessa di intrigare i botanici per la sua curiosa distribuzione disgiunta. Su montagne ancora più alte e lontane ci porta il secondo genere che lo celebra indirettamente, Wulfeniopsis. Entrambi appartengono alla famiglia Plantaginaceae.  Sacerdote e scienziato A Klagenfurt, la capitale della Carinzia, in una piazza affacciata su un giardino, sorge un modesto monumento, un cippo piramidale su base quadrata sormontato da una sfera; su una delle facce, la scritta: "Franz X. barone von Wulfen, ugualmente grande come sacerdote, studioso ed essere umano 1728-1805". Eretto inizialmente come cippo funerario, il monumento riflette la gratitudine e l'affetto dei cittadini di Klagenfurt per questo gesuita che visse nella città carinziana per quarant'anni distinguendosi per il suo spirito di carità. Ripercorriamone la vita, soffermandoci per ora sulla sua figura di sacerdote. Wulfen nacque a Belgrado, dove il padre, un militare tedesco al servizio dell'impero, era di stanza in quegli anni; la madre era invece una nobildonna ungherese. Secondogenito, dopo aver completato gli studi presso il liceo classico di Kaschau (oggi Košice, Slovacchia), a diciassette anni entrò nella compagnia di Gesù; seguì i due anni di noviziato a Vienna e completò gli studi umanistici a Györ (attuale Ungheria). Gli studi superiori lo riportarono a Vienna, dove studiò per tre anni filosofia e per due matematica superiore; quindi lo troviamo a Graz dove studiò teologia per quattro anni e completò i primi due anni di prova. Il terzo e ultimo lo trascorse a Banska Bystrica (nell'odierna Slovacchia) dove pronunciò i voti solenni nel 1763. Intanto aveva incominciato ad insegnare nei collegi gesuitici di diverse città: grammatica (ovvero le materie umanistiche dei primi tre anni del ginnasio) nel 1755 al Collegio di Gorizia e nel 1756 al Theresianum di Vienna; matematica nuovamente a Gorizia nel 1761; logica e metafisica a Lubiana nel 1762 e fisica newtoniana sempre a Lubiana nel 1763. Infine nel 1764 fu trasferito a Klagenfurt, dove insegnò dapprima matematica poi tutte le materie degli studi filosofici (studia superiora) fino alla fine del 1768. Nel 1769 lasciò l'insegnamento per dedicarsi esclusivamente alla cura pastorale. Dal 1769 al 1773 fu confessore e catechista presso le Suore Orsoline. La sua più profonda aspirazione era essere inviato come missionario in Cina o nelle Indie, ma nel 1773 lo scioglimento della Compagnia dei Gesù mise fine a questa speranza. Gli fu assegnata una piccola pensione e un alloggio in una casa sulla Burggasse; disponeva così di un modesto reddito che devolveva in gran parte ai poveri, così come dedicava molto del suo tempo all'assistenza spirituale dei poveri, dei malati e di chiunque cercasse in lui consolazione e consiglio. Non c'è da stupirsi se alla sua morte fu salutato dai concittadini d'adozione come santo. Ma era anche uno stimato scienziato, membro di numerose società scientifiche e corrispondente di naturalisti di fama, compreso lo stesso Linneo. Su questo secondo aspetto della sua personalità ci illumina la lapide posta sulla casa della Burggasse: "In questa casa visse e studiò fino alla fine della sua vita Franz Xavier v. Wulfen 1728-1805. Prendono il nome da lui la wulfenia e la wulfenite". La wulfenite è un minerale (molibdato di piombo), la wulfenia una rara pianta montana (Wulfenia carinthiaca); è il simbolo vegetale della Carinzia ed è ritratta nella parte bassa della lapide. Entrambi sono strettamente collegati all'attività scientifica di questo sacerdote-naturalista. 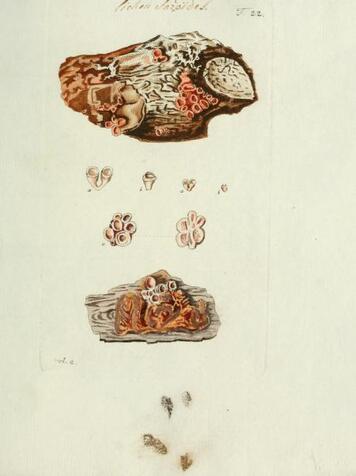 Alla scoperta della flora alpina Coltissimo, versato tanto nelle scienze umane quanto nelle matematiche, poliglotta che parlava e scriveva in quattro lingue (latino, tedesco, francese e italiano), come naturalista Wulfen era autodidatta; scoprì le scienze naturali, e in particolare la botanica, quando era novizio a Vienna, grazie a un amico medico Cominciò a tenere un erbario e ad esplorare le campagne in cerca di piante; come raccontò più tardi, per molto tempo il suo unico manuale fu Systema naturae di Linneo. Il primo terreno di ricerca furono ovviamente i dintorni di Vienna. Poi i continui spostamenti imposti dalla Compagnia di Gesù gli permisero di esplorare molte parti del variegato territorio asburgico, a cominciare dai paesaggi carsici dei dintorni di Gorizia, dove incominciò ad interessarsi anche di insetti e altri animali. Nel 1754 con un amico fece un viaggio a Venezia ed esplorò il Lido e Caorle. A Gratz ritrovò un amico d'infanzia, Leopold Biwald, che era entrato nella Compagnia qualche anno dopo di lui; gli diede lezioni di botanica e insieme batterono assiduamente le campagne. Forse durante il secondo soggiorno a Gorizia entrò in contatto con Scopoli, cui inviò esemplari sia per Entomologia Carniolica (1763) sia per la seconda edizione di Flora Carniolica (1772), in cui compaiono una sessantina di specie da lui raccolte; Scopoli così lo loda: "Grandissimi per la nostra flora sono i meriti del padre Francesco Saverio Wulfen della Compagnia di Gesù che benevolmente mi ha comunicato molte piante raccolte con indefessa industria nei dintorni di Gorizia". La passione per le ricerche naturalistiche si rinvigorì nei due anni trascorsi a Lubiana. Wulfen strinse amicizia con un confratello, padre Janez Jožef Erberg, anch'egli appassionato di botanica, che gli fece conoscere i dintorni della città; poiché nel mese di luglio le lezioni erano sospese e i professori erano in vacanza, Wulfen ne approfittò per esplorare i monti della Carniola; nacque probabilmente in questo periodo un'altra delle sue grandi passioni: l'alpinismo. Fu sul monte Nevoso nei pressi di Trieste e scalò il Grintovec, la cima maggiore della Carniola. Trasmise la sua passione per la montagna e la natura a uno dei suoi allievi, Sigmund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che fu suo compagno in alcune escursioni nelle Alpi di Kamnik e della Savinja, grazie alle quali incominciò a interessarsi anche di mineralogia. Situata sul lago Wörthersee tra verdi colline, in una zona ricca di stazioni termali, al centro di uno splendido scenario alpino, benché periferica e lontana dalle grandi biblioteche, Klagenfurt si offrì a Wulfen come un perfetto terreno di studio; presto si propose di scrivere una Flora norica, progetto a cui si sarebbe assiduamente dedicato fino alla fine dei suoi giorni. A tale scopo esplorò a fondo non solo i dintorni della città, ma gran parte delle valli e delle catene montuose della Carinzia, estendendo le sue raccolte alle crittogame e ai licheni, che egli classificava tra le alghe e che divennero il suo soggetto preferito. D'estate non perdeva occasione per percorrere le montagne per cercare minerali e piante alpine; durante i 40 anni in cui visse a Klagenfurt, fece più di sessanta scalate (ma su questo aspetto torneremo più avanti). Anche se finora non aveva pubblicato nulla, il suo nome incominciava ad essere conosciuto. Nel 1772 iniziò a collaborare con von Jacquin per Florae austriacae [...] icones; la loro era una tipica relazione patrono-cliente: grazie a corrieri, amici comuni, viaggiatori, commercianti, librai, da Klagenfurt partivano per Vienna esemplari d'erbario, semi, piante alpine vive e descrizioni, mentre da Vienna arrivavano libri e pubblicazioni difficili da reperire nella periferica Klagenfurt, nonché contatti con altri studiosi, come il padre della briologia Johannes Hedwig, che in quegli anni stava lavorando al suo trattato sui muschi. Jacquin utilizzò materiali comunicati da Wulfen sia per il quinto volume di Florae austriacae icones sia per Icones plantarum rariorum; inoltre pubblicò la prima opera a stampa di Wulfen, Plantae rariores carinthiacae, in sei puntate: nel primo e nel secondo volume della sua Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia (rispettivamente 1778 e 1781); nei primi quattro volumi di Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem (1786, 1788, 1789, 1790). Le specie più nuove ed interessanti erano anche corredate di immagini di eccellente qualità, eseguite dal valente pittore Joseph Menning e pagate di tasca propria da Wulfen; di particolare importanza storica le descrizioni e le immagini dei licheni, che per le prima volta ricevevano un'attenzione privilegiata. Le 364 specie di piante, funghi e licheni descritte in Plantae rariores carinthiacae erano il frutto di diversi viaggi nelle montagne della Carinzia e del Tirolo che Wulfen poté intraprendere grazie al finanziamento del consigliere imperiale Franz von Mygind. corrispondente di Linneo e amico di Jacquin. Nel 1781, con la dedica da parte di Jacquin del genere Wulfenia nel secondo volume di Miscellanea austriaca, si ebbe la sua consacrazione simbolica nell'empireo della botanica, anche se, nella sua infinita modestia, il buon sacerdote si schermì, scrivendo di non essere degno di tanto onore. Eppure la collaborazione con von Jacquin lo lasciava insoddisfatto. Era uno studioso scrupolosissimo e perfezionista. Le sue descrizioni erano un capolavoro di precisione: già sul posto, per ogni specie osservata dal vivo stendeva su un foglio a parte una prima versione, che poi inseriva nel quaderno che portava sempre con sé; a casa, consultava la bibliografia botanica e ricopiava ogni nota in bella copia, corredandola di sinonimi e note d'autorità, per poi inserirla al suo posto nell'erbario, classificato secondo il sistema linneano. In tal modo le sue descrizioni risultavano allo stesso tempo precise, fedeli e vivaci. Quanto alle identificazioni, aveva spesso dubbi, e avrebbe desiderato confrontarsi alla pari con altri botanici. A von Jacquin invece premeva pubblicare, ed era molto più sbrigativo; almeno tale pareva all'ipercritico e perfezionista Wulfen. Fu questo a provocare la rottura: quando espresse le sue perplessità a Thomas Host, che, in viaggio per la Dalmazia, gli aveva fatto visita nella sua casa di Klagenfurt, questi le prese come una critica personale e le riferì a von Jacquin; da quel momento ogni collaborazione si interruppe. Ma Wulfen nel frattempo aveva trovato altri mecenati. Come membro della Società di agricoltura di Klagenfurt, aveva stretto amicizia con l'imprenditore Johann (Jan) von Thys, di origine olandese, che aveva fondato una manifattura di tessuti a Klagenfurt ed era uno degli animatori della modernizzazione agricola della Carinzia; Thys e dopo la sua morte il figlio Rainer Franz finanziarono alcune spedizioni di Wulfen, che nel 1781 accompagnò Thys figlio in un memorabile viaggio in Olanda, nel corso del quale visitò tra l'altro gli orti botanici di Leida e Amsterdam e ne incontrò i prefetti David van Royen e Nicolaas Laurens Burman; la moglie di quest'ultimo gli donò una collezione di insetti sudafricani, che egli tre anni dopo pubblicò a Erlangen sotto il titolo Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum. Durante il viaggio, si era fermato a Erlangen per incontrare di persona Johann Christian von Schreber, con il quale già corrispondeva grazie a un altro naturalista ex gesuita, Franz von Paula Schrank. Allievo di Linneo e traduttore delle opere linneane in tedesco, professore di materia medica e direttore dell'orto botanico di Erlangen, dal 1791 presidente dell'Accademia leopoldina, Schreber, oltre che uno dei più importanti zoologi del suo tempo, era una figura di primo piano del mondo accademico tedesco; anche grazie alla sua amicizia, Wulfen fu via via ammesso a molte società scientifiche (oltre alla stessa Leopoldina, quelle di Erlangen, Jena, Berlino, Göttingen, nonché l'Accademia delle scienze di Stoccolma). Inoltre Schreber sostituì von Jacquin come curatore editoriale di Wulfen, che a partire dal 1786 pubblicò tutte le sue opere a Erlangen. In precedenza, fu ancora pubblicata a Vienna Abhandlung vom Kärntner Bleispate (1785), una monografia sui minerali di piombo di Bleiburg in Carinzia, magnificamente illustrata da Joseph Menning; tra di essi il minerale originariamente battezzato da Ignaz von Born che lo descrisse per primo nel 1772 plumbum spatosum flavo-rubrum, poi denominato da von Jacquin Kärntherischer bleispath, "spato di piombo di Carinzia"; nel 1845 venne infine ribattezzato wulfenite in onore del nostro. Oltre a Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum (1786), le opere uscite a Erlangen sono Plantae rariores descriptae (1803) e Cryptogama aquatica (1803). Di particolare interesse l'ultima, dedicata ad alghe e piante acquatiche, con la descrizione di oltre settanta specie; anch'essa fu resa possibile dal mecenatismo di Thys, che gli procurò un'amichevole accoglienza presso la filiale triestina della sua ditta; nel corso di due lunghi soggiorni, Wulfen poté così esplorare la fauna e la flora della costa adriatica, visitando anche l'Istria e le isole di Veglia, Cherso e Arbe. Gli si deve tra l'altro la prima descrizione di Ulva stellata, Fucus musciformis, Fucus filamentosus e Fucus simplex. 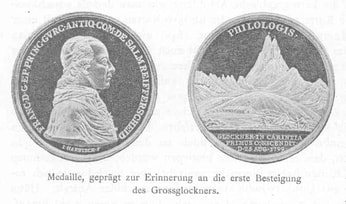 Scalate e piante alpine A Klangefurt, Wulfen riunì attorno a sé un piccolo circolo di più giovani studiosi, molti dei quali ecclesiastici, cui trasmise la sua passione per le scienze naturali e la montagna. Tra di loro spicca l'antico allievo di Lubiana Sigismund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che dal 1787 era vicario generale del principe-vescovo di Klangenfurt. Come il suo maestro era un grande appassionato di montagna e lo accompagnò in diversi viaggi ed escursioni. Insieme al barone Joseph von Seenus (che nel 1805 avrebbe pubblicato il resoconto di un viaggio botanico in Istria e Dalmazia), fu compagno di Wulfen in un secondo viaggio a Venezia; sulla via del ritorno visitarono varie località del Friuli e a Tolmezzo non mancarono di scalare La Mariana (Monte Amariana, 1906 s.l.m). In compagnia di un terzo ecclesiastico, il domenicano Ignaz von Eisentratten, scalarono l'Eisenhut (2441 m), la cima maggiore delle Alpi della Gurtal, e nel 1790 lo Schleinitz (2904 m) nel Gruppo dello Schober. Nel 1791, quando il botanico dilettante Carl von Zois venne apposta da Lubiana per incontrare Wulfen, venne organizzata per lui una grande escursione attraverso le catene della Carinzia superiore e del Tirolo, alla quale partecipò, oltre a Wulfen e Hohenwart, anche il goriziano Joseph Reiner, archivista e cappellano di corte prima a Gorizia poi a Klangenfurt. L'anno dopo Reiner e Hohenwarth raccontarono l'impresa in Botanische Reisen nach einigen Oberkärntnerischen und benachbarten Alpen unternommen [...], che contribuì grandemente a diffondere l'interesse per le montagne e l'alpinismo. Le testimonianze del tempo descrivono Wulfen come un uomo di alta statura, eretto anche in tarda età, forte ed agile, capace di camminare per mezza giornata senza stancarsi alla ricerca di una pianta rara e di lasciare indietro guide ed accompagnatori più giovani. Quando aveva superato la sessantina, tra il 1791 e il 1794, di passaggio da uno dei suoi viaggia a Trieste, esplorò le Dolomiti di Braies. scalando il Monte Lungo, il Picco di Vallandro e addirittura la Croda Rossa, la cima maggiore con i suoi 3.148 m. Vista la sua età, c'è chi ha messo in dubbio questa impresa; ma aveva più settant'anni quando prese parte alla più celebre impresa alpinistica austriaca dell'epoca, la conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria (3718 metri). La spedizione fu organizzata dal principe-vescovo della Carinzia Xaver von Salm-Reifferscheidt-Krautheim, sull'onda della prima ascensione del monte Bianco del 1786. Wulfen e Hohenwart conoscevano benissimo la catena del Grossglockner, frequente terreno delle loro esplorazioni botaniche, ne furono gli ispiratori e nel 1795 furono incaricati di una prima ricognizione; nel 1798 l'area fu ispezionata dall'arcivescovo in persona, che non badò a spese per la spedizione dell'anno successivo. Furono ingaggiati due montanari (le relazioni li ricordano come "i Glokner" e ci sono incertezze sui loro nomi esatti), che predisposero sentieri e all'altezza di 2620 m costruirono un rifugio, chiamato Salmhütte in onore del principe-vescovo, sufficientemente grande da ospitare i 30 membri della spedizione, tra cui Wulfen e Hohenwart. Il 23 luglio 1799 le due guide giunsero poco sotto la vetta del Kleinglochner, ma il maltempo rallentò a lungo la spedizione dei "signori"; solo il 24 agosto Hohenwart e quattro guide riuscirono a raggiungere il Kleinglochner, una cima un poco più bassa divisa dalla vetta principale da una forcella molto esposta, ma dovettero rinunciare a scalare la cima maggiore. Si diffuse però la voce che l'impresa fosse riuscita, e che i cinque avessero addirittura eretto una croce sulla cima, avvalorata da una medaglia commemorativa fatta coniare dal vescovo, con il suo ritratto sul recto, e il profilo del Grossglockner sul verso, con la croce sulla cima e la data dell'ascesa 25 agosto 1799. In realtà fin da settembre fu pianificata una seconda spedizione per l'estate successiva. Era ancora più imponente della precedente, con ben 62 partecipanti, tra i quali di nuovo Hohenwart, Wulfen, il botanico David Heinrich Hoppe, il geologo Ulrich Schiegg e il suo allievo Valentin Stanič . Fu costruito un secondo rifugio più in alto del precedente sull'Adlesruhe (3454 m). La spedizione si servì di scale, corde e rudimentali ramponi e fu guidata dai quattro montanari che avevano già partecipato alla spedizione precedente. Furono proprio loro a raggiungere la cima maggiore il 28 luglio, mentre Hoppe, Hohenwart e il parroco Orrasch li attendevano sulla cima del Kleinglocker; quindi, ridiscesero e raggiunsero nuovamente la vetta insieme a un altro parroco, Mathias Hautzendorfer, l'unico dei primi scalatori di cui conosciamo con esattezza il nome. Il giorno successivo anche Schiegg e Stanič raggiunsero la vetta; fecero misurazioni della pressione barometrica dell'aria e misurarono l'altezza della cima, mentre le guide vi fissavano una croce. Nel 1802 e nel 1806 il vescovo finanziò altre due spedizioni; in quella del 1802, finalmente anche Hohenwart raggiunse la vetta principale. Invece, sia nel 1799 sia nel 1800, l'ormai anziano Wulfen dovette accontentarsi di assistere alla scalata insieme all'arcivescovo dal rifugio dell'Adlesruhe. Erano anni tempestosi e stupisce che il principe-vescovo avesse profuso tanto impegno (e tanto denaro) in questa impresa alpinistica e scientifica. Nel 1797 Klagenfurt era stata occupata dai francesi, che rubarono gran parte delle raccolte di Wulfen. Nonostante questo il vecchio sacerdote continuava a lavorare alla sua Flora norica, un work in progress che nel suo maniacale perfezionismo non gli pareva mai pronta per la pubblicazione, per la quale del resto gli mancavano i soldi. Rimase sano e attivo fino alla fine, quando una polmonite lo stroncò nell'arco di tre giorni nell'aprile 1805. Contava che avrebbe provveduto alla pubblicazione Schreber, al quale lasciò il manoscritto ormai completato, con le illustrazioni relative e esemplari d'erbario. Il resto delle collezioni passò invece a Hohenwart, che nel 1809 sarebbe diventato arcivescovo di Linz. Purtroppo Schreber non poté esaudire l'ultima volontà di Wulfen, sia per la situazione di guerra sia perché morì egli stesso pochi anni dopo, nel 1810. Così Flora norica rimase inedita fino al 1858, quando la Società botanico-zoologica di Vienna decise di finanziarne la pubblicazione, affidandola a Eduard Fenzl, professore di botanica dell'Università di Vienna, con l'assistenza di Rainer Graf, spiritualmente vicino a Wulfen come sacerdote originario di Lubiana; l'opera contiene anche una delle prime biografie di Wulfen. In mezzo secolo gli studi sulla flora austriaca avevano fatto molti progressi e l'opera conservava un valore quasi solo storico; in particolare, Fenzl e Graf considerarono obsoleta la parte dedicata alle crittogame e limitarono la pubblicazione alle angiosperme, sotto il titolo Flora Norica Phanerogama; benché tardiva, con le sue vivide descrizioni di 717 specie dell'Austria e delle Alpi orientali rimane una pietra miliare per la conoscenza soprattutto della flora alpina.  Wulfenia, Wulfeniopsis e altre rarità montane A Wulfen si deve la prima pubblicazione di circa 120 taxa di vegetali. Tra di essi spiccano ovviamente molte piante alpine: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), endemica dei monti della Carinzia e della Slovenia e dedicata al discepolo "a distanza" Karl von Zois che ne fu il primo raccoglitore; Primula glutinosa, un endemismo delle Alpi orientali presente anche in Italia tra Lombardia e Trentino; Saxifraga moschata, diffusa invece dai Pirenei al Caucaso; Androsace chamaejasme, presente oltre che sui monti europei, nella catena dell'Atlante in Marocco; la genzianella nana Gentiana nana (oggi Comastoma nanum), una specie di alta quota delle Alpi orientali. Lo ricordano nell'eponimo specie endemiche delle Alpi orientali di cui fu il primo raccoglitore: Primula wulfeniana, Alyssum wulfenianum, Sempervivum wulfenii, Androsace wulfeniana. E' invece originaria dei litorali mediterranei Euphorbia characias subsp. wulfenii, oggi molto coltivata nei giardini e ampiamente naturalizzata. Torniamo in montagna con Wulfenia carinthiaca, la specie tipo del genere Wulfenia (Plantaginaceae), scoperta da Wulfen nel luglio 1779 alla malga Kuehweger (1625 m.) sulle pendici del Gartnerkofel nelle alpi Carniche; von Jacquin gliela dedicò con queste parole: "Ho nominato questa bellissima pianta dal suo scopritore, uomo di grande merito botanico, cui dobbiamo tante belle e rarissime piante della Carinzia". Oltre che bellissima (speciosa, scrive von Jacquin) è anch'essa assai rara, come tutte le consorelle del genere Wulfenia, caratterizzato da una singolare distribuzione disgiunta in tre aree non contigue: le Alpi Carniche tra Austria e Italia, le Alpi Dinariche in Albania, i monti Nur nella Turchia meridionale. La stessa W. carinthiaca ha distribuzione disgiunta: nelle Alpi Carniche è presente in una ristretta area di appena 10 km² attorno al Passo Pramollo-Nassfeld Pass sia sul versante italiano sia su quello austriaco; più ampie le popolazioni dinariche, a cavallo tra Albania, Montenegro e Kosovo. Ha foglie a rosetta obovate, crenate e carnose dalle quali a metà estate, per pochi giorni, emergono alti racemi fitti di fiori campanulati blu-viola. Cresce su pietraie umide, nel sottobosco degli ontaneti e delle pinete di Pinus mugo (Alpi Carniche) e Pinus peuce (Alpi Dinariche) o nei pascoli ricchi di azoto nei pressi delle malghe appena al di sopra del limite degli alberi. W. baldaccii, simile alla specie precedente, ma di dimensioni minori, fu segnalata per la prima volta negli anni '30 del Novecento dal botanico italiano Antonio Baldacci. E' un endemismo dei Monti Prokletje nell'Albania settentrionale, dove cresce nelle fessure tra le rocce nei boschi di betulla o ai margini di essi. Le altre due specie, W. glanduligera e W. orientalis, crescono su monti più bassi e mesofili della Turchia sud-orientale, entrambe nelle fessure delle rocce, la prima nei boschi di Fagus orientalis, la seconda nelle foreste sempreverdi submediterranee. In passato erano assegnate al genere Wulfenia anche due specie himalayane. La distribuzione fortemente discontinua tra Mediterraneo e Himalaya, benché non unica, è piuttosto rara e negli anni '80 del Novecento ha spinto gli studiosi ad approfondire la questione. Paragonando esemplari di tutte le specie e i loro pollini, essi sono giunti alla conclusioni che le differenze sono tali da far assegnare quelle himalayane a un genere proprio, che è stato denominato Wulfeniopsis (simile a Wulfenia); si distingue da Wulfenia per il numero dei cromosomi, le caratteristiche del polline e i racemi molto più radi, con i fiori portati da un solo lato dell'asse, con corolla non bilabiata con quattro lobi anziché cinque. Gli sono assegnate due specie, W. amherstiana (Himalaya occidentale, dal Pakistan al Nepal centrale, da 1500 a 3000 metri di altitudine) e W. nepalensis (talvolta considerata una varietà della precedente, endemica del Nepal, tra 1500 e 2700 m). Dunque, di nuovo piante di alta montagna che non sarebbero spiaciute a padre Wulfen. Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola. Negli anni che precedono immediatamente la rivoluzione francese, si intrecciano due storie che sembrerebbero non avere nulla in comune. Da una parte c'è il marinaio francese Nicolas Baudin, che l'origine borghese esclude da una carriera di comando nella marina reale; sceglie allora la marina mercantile, tanto più che è nipote di un armatore di Nantes dai traffici non sempre limpidi. Dall'altra parte, c'è una spedizione di botanici austriaci, che fallisce per la defezione di metà dei suoi membri. Finché, nell'isola di Haiti, dove forse è venuto a contrattare un carico di schiavi, il marinaio incontra il capo dei botanici e ne riceve una soffiata che cambierà per sempre la sua vita. Perché le piante non basta raccoglierle, bisogna anche che qualcuno le porti a casa. E magari le faccia arrivare vive. Questa diventa la specialità del capitano Baudin, che comanda una dopo l'altra ben tre Jardinière (ovvero serre viaggianti). Tutte, puntualmente, finite male. Su queste e altre navi navighiamo su e giù per l'Atlantico e l'Oceano Indiano, mentre i botanici erborizzano nelle Americhe, in Sud Africa e a Mauritius. Alla fine, a portare a casa un genere valido sono un austriaco e un francese: il giardiniere viennese Franz Bredemeyer, dedicatario di Bredemeyera (Polygalaceae), e il botanico Pierre André Ledru, dedicatario di Drusa (Apiaceae).  Come un capitano di marina si appassionò di botanica Il 9 termidoro dell'anno VI (27 luglio 1798) la folla parigina assiste a un grandioso spettacolo: muovendo dalla sede del Museo di storia naturale, un corteo di carri ornati di ghirlande raggiunge il Campo di Marte, dove verranno pronunciati numerosi discorsi e i musicisti del conservatorio offriranno un concerto. E' questo il modo scelto dal Direttorio per esporre coram populo i tesori trafugati durante la campagna d'Italia, in un'operazione propagandistica che trasforma un saccheggio in un atto di libertà: quei tesori, anziché essere gelosamente nascosti nei palazzi e nei conventi per il godimento di pochi privilegiati - si proclama - sono ora messi a disposizione di tutti nei musei della Repubblica, per il progresso delle scienze e delle arti. Il corteo è strutturato in tre divisioni: la prima è riservata alla storia naturale, con sei carri carichi di piante e animali esotici; la seconda alla scienza e alla tecnica, con altri sei carri ricolmi di libri, manoscritti, medaglie, spartiti; la terza, il clou dell'intera manifestazione, ai capolavori dell'arte: tra gli altri sfilano la quadriga di san Marco, la Venere capitolina, lo Spinario, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, quadri di Raffaello, Tiziano, Domenichino, Giulio Romano, per un totale di 300 tra statue e dipinti. Se questi ultimi sono stati strappati ai palazzi italiani, non è certo così per molta parte degli oggetti naturali: qualcosa arriva dall'Egitto, dove in quel momento si trova Napoleone, ma il grosso proviene dalle Antille, ed è stato aggiunto al corteo all'ultimo momento, su suggerimento di Antoine-Laurent de Jussieu. In un certo senso, sono anche quelli prede di guerra: è il bottino del viaggio di Nicolas Baudin ai Caraibi, un successo che di lì a un anno garantirà a questo marinaio di lungo corso il comando della più importante missione scientifica della Repubblica: la "spedizione Baudin" nelle Terre Australi. In attesa di raccontarla in un prossimo post, facciamo conoscenza con questo personaggio, le cui vicende si sono curiosamente intrecciate con quelle della "spedizione Märter", promossa dall'Austria di Giuseppe II. Nicolas Baudin (1754-1803) era nato nell'isola di Ré in una famiglia relativamente agiata; prese il mare a quindici anni, a bordo di uno dei vascelli dello zio materno Jean Peltier Dudoyer, un armatore che aveva iniziato la sua carriera armando navi negriere e aveva interessi sia in America sia nell'Oceano indiano; per molti anni Baudin navigò sulle navi sia dello zio sia della Compagnia delle Indie; quando scoppiò la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, Peltier Dudoyer fu uno degli armatori che fornirono navi e rifornimenti alle colonie ribelli; il nipote si trovò coinvolto in prima persona e si comportò con onore, tanto da essere promosso capitano. Nel 1780 gli fu assegnato il comando della fregata Apollon incaricata di trasportare truppe al Capo di Buona Speranza per sostenere gli olandesi contro i britannici; un compito squisitamente militare, tanto che il comandante del porto di Brest gli ritirò il comando per assegnarlo a un nobile (solo questi ultimi potevano diventare ufficiali della marina militare). Baudin per il momento abbandonò ogni speranza di farne parte e continuò a comandare navi mercantili. Nel 1785 come capitano della Caroline, anch'essa armata da Peltier Dudoyer, trasportò in Louisiana l'ultimo gruppo di Acadiani di Nantes; a New Orleans (all'epoca ancora francese, e ancora Nouvelle Orlèans) alcuni mercanti lo incaricarono di trasportare varie merci a Mauritius (all'epoca ancora francese e ancora Ile del France) a bordo della Joséphine (detta anche Pepita o Josepha). Forse per contrattare un trasporto di schiavi dal Madagascar nel viaggio di ritorno, egli fece scalo a Haiti, dove incontrò il botanico austriaco di origine tedesca Franz Joseph Märter (1753-1827). Facciamo un passo indietro per raccogliere questo secondo filone della nostra storia. Nel 1783 il direttore dell'orto botanico di Vienna Nikolaus von Jacquin convinse l'imperatore Giuseppe II ad inviare in America una spedizione alla ricerca di piante esotiche per i giardini di Schönbrunn. La capeggiava appunto Märter, professore di storia naturale al Theresianum, accompagnato da un altro botanico, Matthias Leopold Stupicz, dal pittore Adam Moll e dai giardinieri Franz Boos e Franz Bredemeyer. Imbarcatosi a Le Havre ad agosto, insieme al nuovo console imperiale negli Stati Uniti, il gruppo raggiunse Filadelfia dopo un viaggio di quaranta giorni, in cui sperimentò tre tempeste e Märter scoprì il proprio tallone d'Achille: un irrimediabile mal di mare. A Filadelfia egli incontrò William Bartram e avrebbe voluto senz'altro iniziare le raccolte prima dell'inverno, ma gli mancavano i libri e le attrezzature, che viaggiavano su un'altra nave. Poté così mettersi all'opera solo a novembre. Mentre tutti gli altri raggiungevano Charleston in nave, egli attraversò a cavallo Pennsylvania, Maryland, Virginia e le due Caroline, accompagnato dal medico e zoologo Johann David Schöpf, che aveva partecipato come volontario alla guerra d'indipendenza da parte britannica e aveva deciso di fermarsi nel paese per studiarne la fauna. Arrivato a Charleston nel gennaio 1784, Märter inizialmente pensò di inviare nelle Bahamas Stupicz e un giardiniere, mentre lui con gli altri esplorava le due Caroline e la Florida, ma, rendendosi conto che Stupicz non parlava quasi l'inglese, lo mandò nella Carolina del Nord, dove vivevano numerosi tedeschi. Mentre Moll e Bredemeyer rimanevano a Charleston, egli si imbarcò con Schöpf e Boos per le Bahamas, soffrendo di nuovo atrocemente il mal di mare. Fu così costretto a ritornare a Charleston, mentre nei mesi seguenti Boos, spesso in condizioni difficili, esplorò diverse isole, rientrando a Charleston verso la fine dell'anno. Nel frattempo Bredemeyer era stato inviato a Vienna con un primo trasporto; il viaggio, iniziato nel giugno 1784, si protrasse per cinque mesi con la perdita di molte piante. Poco dopo il suo arrivo, insieme all'aiuto giardiniere Schücht, egli fu rimandato in America per ricongiungersi alla spedizione, la cui situazione si era fatta piuttosto critica. All'inizio del 1785, Boos era a Charleston gravemente ammalato; Moll e Supicz, che in realtà si erano imbarcati proprio nella speranza di emigrare negli Stati Uniti, diedero le dimissioni uno dopo l'altro, per stabilirsi a Charleston, il primo come insegnante di disegno e incisore, il secondo come medico. A sua volta Märter aveva contratto la malaria. A maggio lo lasciò anche Boos, che partì per Europa con una parte delle collezioni: più fortunato di Bredemeyer, ebbe un viaggio breve e senza contrattempi, consegnando piante e animali in perfette condizioni. Poco dopo la sua partenza, Märter si imbarcò per la Martinica, fissata come punto d'incontro con Bredemeyer e Schücht. Ma il mal di mare lo tradì ancora una volta e dovette sbarcare a Guadalupa. Riuscì poi a raggiungere Haiti, dove nell'agosto 1785 finalmente arrivarono anche i due giardinieri. Tutti e tre erano malati; il più grave era proprio Märter, che fu bloccato per sei mesi e a lungo dovette anche essere ricoverato nell'Hôpital de la Charité a Cap-Français. Fu in queste circostanze che conobbe Baudin. Lo sfortunato botanico (che probabilmente lo aveva saputo da Bredemeyer) lo informò che il suo antico compagno Boos era stato inviato ad erborizzare al Capo di Buona Speranza ed era in attesa di un imbarco per Mauritius. Proprio la meta del nostro intraprendente capitano che non perse l'occasione, dirigendosi immediatamente al Capo. Almeno, questa è la storia vulgata: le date non coincidono perfettamente. Comunque, prendiamola per buona. Le collezioni americane di Franz Boos avevano fatto una tale impressione all'imperatore, che aveva deciso che, anziché tornare in America a dare supporto all'inconcludente Märter, era meglio andasse direttamente in Sud Africa, per poi passare a Mauritius. Boos partì da Vienna nell'ottobre 1785 insieme all'aiuto giardiniere Georg Scholl. Dopo un lungo e penoso viaggio, funestato dallo scoppio a bordo di un'epidemia che aveva fatto più di trenta morti, erano arrivati al Capo solo nel giugno 1786; furono generosamente ospitati dal colonnello Gordon, che comandava la guarnigione della Compagnia delle Indie olandesi; egli fece loro conoscere Francis Masson, con il quale esplorarono Swartand e il Karoo, fino ad allora non molto battuto dai botanici europei, raccogliendo non poche novità. Baudin arrivò al Capo nel febbraio 1787 e imbarcò Boos e una parte delle sue collezioni, mentre Scholl, secondo le istruzioni ricevute, rimaneva in Sud Africa. A marzo erano a Mauritius, dove Boos incontrò il governatore Ceré, che era già in corrispondenza con Vienna cui nel 1783 aveva inviato piante e semi. Boos gli consegnò i doni dell'imperatore e si trattenne a lungo a Pamplemousses, stringendo ottime relazioni con i botanici e gli appassionati che ruotavano attorno a quel magnifico orto botanico, ricevendo molte piante provenienti non solo a Mauritius, ma dall'intera Asia. Poté anche visitare l'Île Bourbon (ovvero La Réunion) ed esplorare le montagne dell'interno con il botanico Joseph Hubert. Intanto si era accordato con Baudin per noleggiare la Joséphine per trasportare a Vienna le sue collezioni, rese preziose dai contributi dei nuovi amici delle Mascarene. Nel dicembre 1787 la Joséphine-Pepita (che, tanto per aumentare la confusione, Boos aveva ribattezzato Pepinière, "vivaio") riprese il mare. Come ci informano i giornali dell'epoca, raggiunse il porto austriaco di Trieste il 18 giugno 1788. Il suo carico, che comprendeva anche qualche zebra viva, fece sensazione. Gli animali e le piante presero la via di Vienna, dove rientrò anche Boos. Durante quei lunghi mesi di viaggio, capitano e botanico avevano fatto amicizia. Boos illustrò a Baudin le tecniche migliori per preservare le piante e gli animali durante i lunghi viaggi oceanici; per Baudin fu la scoperta di una nuova vocazione: quella di raccoglitore-naturalista.  Avventure quasi corsare Il riuscito trasporto delle collezioni di Boos era senz'altro un ottimo biglietto da visita; Baudin sperava gli assicurasse il comando di una nuova spedizione di cui si andava vociferando: niente meno che la prima circumnavigazione austriaca del globo. Nel frattempo, al comando della nave commerciale Jardinière (ovvero "serra viaggiante", un nome non scelto a caso, visto che nel vaiggio di ritorno avrebbe dovuto imbarcare Scholl e le sue piante) partì per Canton, non è troppo chiaro se per conto proprio o della Compagnia imperiale delle Indie. Forse temendo guai con l'amministrazione cinese, viaggiava infatti sotto bandiera statunitense. Giunto a Canton, spedì il suo secondo in America per un traffico di pellicce, ma la Jardinière naufragò nelle Marianne settentrionali, di fronte all'isola di Asuncion. E' l'inizio di una serie di vicende rocambolesche: Baudin andò a Mauritius a procurarsi un'altra nave, che battezzò Jardinière II; il nome non portò fortuna: il 15 dicembre 1789 un ciclone colpì l'isola e la nave andò distrutta in porto. Allora Baudin si imbarcò come passeggero su una nave della Compagnia reale delle Filippine; di passaggio al Capo, poté prendere con sé solo una piccola parte delle collezioni di Georg Scholl. La nave era diretta a Cadice, ma non vi giunse mai. Lo scafo era in uno stato così deplorevole che si dovette fare rotta per le Antille e fare scalo a Trinidad, dove la collezione venne sbarcata. Baudin si imbarcò su un'altra nave e arrivò in Martinica, dove scrisse a Vienna per spiegare la situazione e riproporsi come comandante della progettata spedizione in Estremo oriente. Forse era giunta la volta buona. Nel gennaio 1792 la corte di Vienna gli concesse il titolo di capitano della Marina imperiale e gli affidò il comando di una nuova Jardinière che, oltre a prelevare Scholl e le sue collezioni, avrebbe dovuto esplorare le Indie Orientali e la Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Per accompagnarlo furono designati Franz Bredemeyer e l'aiuto giardiniere Joseph van der Schot che ad aprile si imbarcarono a Genova alla volta di Malaga. Ma i tempi erano cambiati: in Francia la monarchia era crollata, e pochi giorni dopo la loro partenza, il 20 aprile 1792, la Convenzione dichiarò guerra alla Prussia e all'Impero. Baudin all'improvviso diventava un nemico; raggiunta anch'egli Malaga, dapprima pensò di abbandonare la spedizione e cercò di negoziare il suo rientro nella marina francese; avendo avuto un rifiuto, continuò i preparativi, mentre Austria e Gran Bretagna chiedevano alle autorità spagnole il suo arresto e il sequestro della nave. Nella confusa situazione politica di quei mesi, in cui la Spagna tentava la difficile strada della neutralità, dopo una breve detenzione fu rilasciato e riprese possesso della nave. Lasciati i botanici a terra, il 1 ottobre la Jardinière salpò; ma Baudin, anziché tornare in Francia, cercò di realizzare da solo il programma scientifico inziale. Eccolo al Capo di Buona Speranza, dove caricò una parte delle collezioni di Scholl (che si accorse troppo tardi che ora la nave batteva bandiera francese); quindi si diresse verso la Nuova Olanda ma incappò in due cicloni successivi che la costrinsero ad attraccare a Bombay per riparazioni. La navigazione volse ora verso occidente, toccando il Golfo persico, il mar Rosso, la costa orientale dell'Africa, dove vennero raccolti esemplari di animali e piante, e terminò di fronte a Table Bay, dove la terza Jardinière si arenò durante una tempesta. Baudin si salvò e, a quanto pare, riuscì a recuperare almeno qualcosa delle sue raccolte, visto che anche queste finirono a Trinidad, dove passò durante il viaggio di ritorno, passeggero di una nave americana. Rientrato in Francia, nel marzo 1796 Baudin incontrò Antoine Laurent de Jussieu e gli suggerì di organizzare per conto del Museo nazionale una spedizione a Trinidad per recuperare le collezioni (sue o austriache, ormai poco importava...). Il direttorio accettò la proposta e il 30 settembre 1796 Baudin partì alla volta delle Antille al comando della Belle-Angelique. Lo accompagnava una piccola équipe scientifica: il botanico André Pierre Ledru, il giardiniere Anselme Riedlé, gli zoologhi René Maugé e Stanislas Levillain. Ma la nave era così inadatta a tenere il mare che alle Canarie Baudin dovette abbandonarla e sostituirla con una nuova nave, la Fanny, con la quale nell'aprile 1797 raggiunse Trinidad. Qui scoprì che l'isola era da poco passata nelle mani degli inglesi, che rifiutarono di consegnargli le collezioni. Baudin non era tipo da tornare in Francia a mani vuote. Nelle Antille c'erano diverse isole neutrali, come la portoghese São Tomé e la danese Saint Croix. Baudin e i suoi naturalisti le esplorarono e fecero buone raccolte di piante e animali; quindi a Saint Croix la Fanny venne sostituita con un vascello più agile, ribattezzato Belle-Angelique, a bordo della quale visitarono Porto Rico, quindi proseguirono per la Francia, dove giunsero nel giugno 1797, pochi giorni prima del grande corteo da cui abbiamo preso le mosse, giusto in tempo per esibire i loro trofei nella divisione di storia naturale. Quello stesso giorno, anche grazie ai buoni uffici del cugino Marie-Etienne Peltier - che dal 1794 batteva i mari come "corsaro della Repubblica - Baudin ricevette il comando della nave corsara Virginie; il 4 agosto fu reintegrato nella marina militare con il grado di capitano di vascello, e partecipò ad alcuni episodi della guerra contro l'Inghilterra. Ma la vera rivincita se la sarebbe presa nell'ottobre 1800, quando gli venne affidato il comando della grandiosa spedizione nelle Terre australi, più nota come "spedizione Baudin". In queste vesti lo ritroveremo in un prossimo post. E con lui tre dei naturalisti della Belle Angélique che lo seguirono nella nuova avventura, per perdervi la vita.  Epilogo: e vissero felici e contenti Molti sono i personaggi di questa storia affollata ad aver ricevuto l'onore della dedica di un genere botanico, anche se ne rimane valido uno solo. Ad aprire le danze è lo stesso capitano Baudin. Per ben due volte, De Candolle gli dedicò un genere Baudinia, ma entrambi sono ridotti a sinonimi: Baudinia (Myrtaceae) di Melaleuca e Baudinia (Goodeniaceae) di Scaevola. Si consola con l'eponimo di Limonium baudinii, una specie della Tasmania raccolta durante la sua celebre spedizione. Veniamo ora ai suoi compagni austriaci, raccontando ancora qualcosa delle loro vite dopo il turbinoso incontro con il capitano francese. L'ottimo Franz Boos (1753 - 1832) dopo il ritorno a Vienna fece carriera. Nel 1787, quando von Jacquin lasciò l'incarico, fu nominato direttore dei giardini e dell'orto botanico di Schönbrunn, cui nel 1790 si aggiunse la direzione del serraglio imperiale e del cosiddetto "Giardino olandese". Fino al ritiro nel 1827, continuò anche ad essere capo giardiniere e nel 1816 insieme al figlio Joseph Boos, anch'egli un valente professionista, pubblicò un catalogo delle piante selvatiche e coltivate di Schönbrunn. Nel 2001 il botanico austriaco Speta ha voluto ricordarlo con il genere Boosia, generalmente non accettato (è sinonimo di Drimia). Gli è stata anche dedicata una via nel quartiere di Hietzing. Dopo aver visto involarsi una parte delle sue collezioni per l'inganno di Baudin, Georg Scholl (1751-1831) rimase ancora in Sudafrica per diversi anni (il suo soggiorno ne durò in tutto dodici), ancora ospite del colonello Gordon. Le sue raccolte diventavano sempre più imponenti e sempre più difficili da trasportare, come ci informa Francis Masson nelle sue lettere a Joseph Banks. Di tanto in tanto, riusciva a spedire a Vienna bulbi e semi, tra cui quattro spedizioni tra il 1790 e il 1792 che, attraverso il console austriaco in Olanda, raggiunsero Vienna via Amsterdam. Solo nel 1799 gli fu possibile lasciare il paese, ritornando a Vienna con la collezione di piante vive sudafricane più importante d'Europa (ora capiamo meglio perché Banks, appena tornata la pace, si sia affrettato ad inviare al Capo il suo raccoglitore James Bowie). L'esemplare più sensazionale era una Fockea capensis, una specie così rara che a lungo si credette fosse estinta in natura. E' tuttora possibile ammirarla nella serra di Schöbrunn, grazie alla previdenza di un giardiniere che, durante la seconda guerra mondiale, lo salvò portandoselo a casa. Con i suoi 600 anni valutati, è considerata la più vecchia pianta in vaso del mondo. Quanto a Scholl, tornò a lavorare a Schönbrunn, quindi dal 1802 divenne capo giardiniere al Belvedere. Nel 1811 il figlio di von Jacquin gli dedicò Schollia (sinonimo di Hoya) e sempre nel 2001 Speta Geschollia (ugualmente sinonimo di Drimia). Lo ricorda l'eponimo dell'Aizoacea sudafricana Ruschia schollii. Nonostante la grande ricchezza e l'importanza storica delle collezioni di Boos e Scholl, la maggior gloria botanica è però riservata a Franz Bredemeyer (1758-1839), ricordato da un genere valido e da una decina di eponimi. Lo abbiamo lasciato ad Haiti al momento del ricongiungimento con Märter. Nel febbraio 1786 questi inviò lui e Schücht in Venezuela, dove contava di raggiungerli appena recuperata la salute. I due passarono da Porto Rico, che furono i primi botanici a visitare, quindi visitarono Caracas e il porto di La Guaira, dove avrebbe dovuto raggiungerli Märter. Nel frattempo questi aveva di nuovo cambiato idea e li richiamò, ma i due giardinieri ormai agivano in modo indipendente (e molto più efficace). Pur dovendo fare i conti con difficoltà economiche, carte sbagliate e i sospetti delle autorità spagnole, che temevano fossero spie, decisero di esplorare il più possibile quel paese tanto affascinante quanto quasi inedito per la botanica. Acquistarono dei muli e assunsero un assistente; a settembre viaggiarono a est di Caracas, visitando Guatire, Caucagua e la foresta pluviale nei pressi di Capaya (nell'attuale stato di Miranda); da marzo a maggio dell'anno successivo si spostarono verso ovest nell'attuale stato di Aragua e nei Llanos. Nell'aprile del 1788 si imbarcarono a La Guaira alla volta di Curaçao, dove noleggiarono la goletta americana The Commerce che li avrebbe riportati in Europa insieme a molte piante che fecero sensazione per l'aspetto decisamente esotico e tropicale. Li aveva preceduti di circa un anno lo stesso Märter. Invece di raggiungere i due giardinieri in Venezuela, era passato in Giamaica; qui aveva visitato le Blue Mountains, dove lo incontrò il botanico svedese Olof Schartz; secondo la testimonianza di quest'ultimo, era di nuovo malato, nonché depresso per la disgrazia in cui era caduto presso la corte di Vienna, che gli attributiva tutta la colpa del fallimento della spedizione. Nel maggio 1787 imbarcò totalmente a sue spese una collezione che secondo le sue dichiarazioni ammontava a non meno di 3000 esemplari, tra cui 1800 piante vive. Giunto a Londra, le fece svernare in serra; qui e in Olanda acquistò anche molti uccelli impagliati. Poté così presentarsi a testa alta all'imperatore che dovette perdonarlo, se lo nominò professore di botanica e storia naturale all'Università dei Paesi Bassi austriaci, fondata l'anno prima. Su sua raccomandazione, Bredemeyer venne nominato direttore dell'annesso orto botanico. Per entrambi, un incarico di brevissima durata. La rivoluzione del Brabante dell'ottobre 1789 li costrinse alla fuga. Una nuova occasione si presentò per Bredemeyer quando, come abbiamo anticipato, venne nominato naturalista della missione della terza Jardinière. Già sappiamo che l'avventura sfumò e il povero giardiniere rimase a terra, mentre Baudin partiva senza di lui. Non gli restava che tornare a Vienna. Nel 1793 divenne supervisore dei frutteti e dei parchi di Schönbrunn; in seguito si occupò dei giardini degli arciduchi, che nel 1802 accompagnò ad erborizzare in montagna. Al pensionamento di Boos, divenne a sua volta direttore dei giardini e del serraglio di corte. Sotto la sua direzione, furono allestite la "Casa delle giraffe" e una collezione di piante parassite. Divenuto consigliere imperiale e membro di molte società orticole, inclusa la Horticultural Society di Londra, morì ottantenne nel 1839. Le specie tropicali raccolte in Venezuela divennero una delle maggiori glorie delle serre di Schönbrunn, destando l'ammirazione di Humboldt, che fu spinto anche da quello spettacolo al suo viaggio in Sud America, dove non avrebbe mancato di ripercorrere le orme di Bredemeyer e Schücht. Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, conosceva bene Bredemeyer, delle cui note si servì ad esempio per descrivere le piantagioni di cacao del Venezuela, ombreggiate da alberi di bucaré (Erythrina poeppigiana) dagli smaglianti fiori rossi tra cui volavano eserciti di pappagalli dalle piume multicolori. Fu sicuramente lui a suggerire l'acquisto dell'erbario di Bredemeyer, 180 fogli del quale si trovano ora al Museo botanico di Berlino-Dahlem. Non stupisce dunque che sia stato proprio Willdenow a dedicargli il genere Bredemeyera, sulla base di una pianta raccolta da Franz Bredemeyer nei pressi di Caracas. Oggi a questo genere della famiglia Polygalaceae sono attribuite 18 specie, distribuite dal Messico al Paraguay settentrionale. Sono liane legnose o piccoli arbusti con foglie semplici, fiori con cinque sepali, due esterni e tre interni, con ali petaloidi; la corolla ha cinque petali (due laterali, la carena, e due rudimentali): i frutti sono capsule con semi protetti da un arillo con peli più lunghi dei semi stessi. La specie tipo descritta di Willdenow B. floribunda, diffusa dal Venezuela al Paraguay, presenta cospicui grappoli di fiori bianchi; è una specie officinale, con proprietà disintossicanti, cui la medicina tradizionale attribuisce efficacia contro i morsi dei serpenti. Tra le diverse specie che si fregiano dell'eponimo bredemeyeri o bredemeyerianus, vorrei ricordare almeno la spettacolare Bomarea bredemeyeriana: con i suoi grappoli di fiori a campana aranciati fu probabilmente una delle piante la cui vista colpì al cuore Humboldt. E Märter? forse qualcuno si domanderà. Sappiamo che la collezione d'uccelli fu da lui donata alla loggia massonica Zur true Eintracht (frequentata anche da Mozart e Schikaneder che ne avrebbero tratto ispirazione per l'uccellatore Papageno del Flauto magico) e andò dispersa quando il cattolicissimo imperatore Francesco bandì la massoneria nel 1794. Non ci è noto il destino della collezione botanica, forse meno favolosa di quanto Märter pretendesse. In condizione di professore "giubilato", ovvero in pensione, nel 1796 egli pubblicò una seconda edizione assai accresciuta di un libro sugli alberi austriaci che aveva pubblicato prima della spedizione (Verzeichniß der östreichischen Bäume, Stauden und Buschgewächse); l'anno successivo fu la volta di una monografia sulla batata dolce. Nel 1797, quando venne riaperta l'Accademia dei cavalieri teresiani, gli fu assegnata la cattedra di silvicoltura. La coltivazione di alberi da frutta e da legname era infatti ormai il suo interesse principale, tanto che nel 1799 aprì un vivaio con 300 piante da frutto; l'avrebbe venduto nel 1806 per motivi di salute, così come nel 1803 per la stessa ragione aveva dato le dimissioni dal Theresianum. Per altro morì più di vent'anni dopo, nel 1827, a 73 anni. Giuseppe II lo considerava streitsüchtig, ovvero polemico. A me pare piuttosto inconcludente. Sta di fatto che nessun botanico ha mai pensato di dedicargli, nonché un genere, neppure una specie. Fu invece nientemeno che de Candolle a dedicare un genere al solo botanico francese di questa storia, André Pierre Ledru (1761-1825), uno dei naturalisti della Belle Angélique. Sappiamo che era un sacerdote, da poco consacrato quando scoppiò la rivoluzione, cui aderì senza esitare, prestando giuramento alla Costituzione civile del clero. Nella fase più convulsa della controrivoluzione vandeana, come prete giurato si trovò in pericolo di vita; si trasferì così a Parigi, dove presumibilmente entrò in contatto con gli ambienti del Museum national e in particolare con Antoine Laurent de Jussieu (nel suo erbario si trovano esemplari donatogli da lui, comprese alcune piante coltivate al Trianon da suo zio Bernard de Jussieu). Grazie a queste frequentazioni, fu scelto come botanico della spedizione nelle Antille, durante la quale fece notevoli raccolte a Tenerife, Porto Rico e in diverse isole. Al suo rientro, tornò in provincia, divenendo insegnante, anche se non abbandonò mai del tutto la botanica, visto che allestì un orto botanico privato e possedeva un notevole erbario, ora conservato al Museo di Le Mans. De Candolle, che all'epoca lavorava ancora al Museum national, gli dedicò Drusa (Apiaceae), sulla base di un esemplare raccolto da Ledru (che egli definisce "ragguardevole botanico") a Tenerife, lungo la strada che conduce a La Orotava. La sua unica specie D. glandulosa è una piccola rampicante pelosa e appiccicosa, con fiori minuscoli e curiosi frutti dotati di ali dentate. Singolare la sua distribuzione: oltre che nelle Canarie e in Marocco (dove si ritiene introdotta), si trova in alcune stazioni della catena Cal Madow in Somalia. Il medico austriaco di origine croata Nicolaus Thomas Host dedicò tutta la vita alla ricerca, alla pubblicazione e alla valorizzazione della flora nativa del vasto e variegato impero austriaco, tanto da fondare un "Giardino delle terre della Corona". E' dunque curioso che oggi sia ricordato, più che per questa impresa o per le sue pubblicazioni, per aver dato il nome a un genere che arriva da molto lontano. Le specie del genere Hosta, oggi tra le piante più amate e coltivate, sono infatti originarie dell'Estremo oriente. Le prime hanno fatto timidamente la loro comparsa in pochi orti botanici europei negli ultimi anni del Settecento; la loro vera diffusione in Europa si deve però a Siebold, che a partire dal 1830 ne importò dal Giappone una ventina tra specie e varietà. Questa rimase più o meno la situazione per circa un secolo, tanto che si dice che buona parte delle piante coltivate in Europa all'inizio del '900 discendesse in un modo o nell'altro dagli esemplari importati da Siebold. Ancora nel 1950, in Olanda se ne coltivavano non più di una trentina di varietà. Ma nel secondo dopoguerra la selezione di cultivar e ibridi è cresciuta in modo esponenziale, tanto che ormai essi si contano a migliaia (anche più di 10.000 secondo alcune fonti). 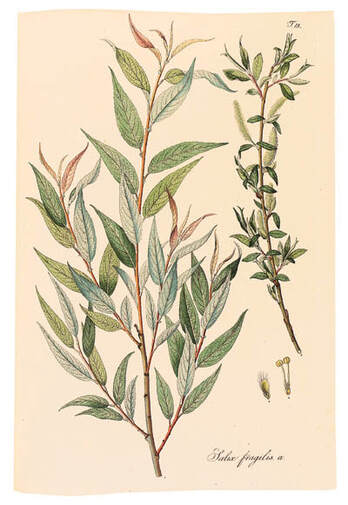 Alla ricerca delle piante native La monarchia asburgica, nata dall'accumulo secolare di eredità disparate più ancora che dalle conquiste territoriali, è nota per essere l'antitesi dello stato nazionale: ne facevano parte territori molto diversi tra loro per lingua, cultura, storia, strutture economiche. Ovviamente, queste considerazioni valgono anche per l'ambiente naturale: dalla vegetazione tipicamente alpina del Tirolo a quella continentale dell'Austria orientale e della Pannonia, per non parlare delle aree con flore peculiari come l'Istria. Con i cinque volumi della spettacolare Florae austriacae (1773-78), Nicolaus Joseph von Jacquin aveva cominciato a rendere disponibile questo variegato patrimonio; tuttavia, il suo lavoro si limitava all'arciducato d'Austria, escludendo dunque non solo territori che oggi fanno parte di altri stati come l'Ungheria, la Croazia, la Boemia, l'Istria, la Carniola, la contea di Gorizia, ma anche la Stiria, la Carinzia, l'Austria anteriore, il Tirolo, il principato di Salisburgo. Forse non è strano che l'idea di allargare l'indagine quanto più possibile a tutti questi territori, che all'epoca erano raggruppati sotto l'etichetta Kronländer, "terre della corona", sia venuta a un suddito dell'impero originario di una regione di confine: il croato Nicolaus Thomas (o Nikola Toma) Host. Era a nato a Fiume / Rijeka, una città multietnica che dopo aver fatto parte per circa duecento anni prima della Carniola quindi della Bassa Austria, dal 1776 era stata unita al regno d'Ungheria come porto franco e corpus separatum, ovvero entità autonoma. Molto giovane Host si trasferì a Vienna per studiare medicina; fu accolto nell'entourage di von Jacquin, suo professore di botanica, e strinse amicizia con suo figlio Joseph Franz; insieme i due iniziarono ad esplorare la flora di aree ancora poco studiate, come la Stiria, il Tirolo, l'Istria. Laureatosi nel 1786, Host rimase a Vienna dove si fece un nome come medico, tanto nel 1792, a poco più di trent'anni, fu scelto come medico personale dall'imperatore Francesco II che più tardi lo volle come consigliere. Nel frattempo Host aveva continuato ad alternare all'attività professionale lunghe escursioni nelle terre della corona, incluse l'Ungheria e la Croazia, raccogliendo non solo esemplari d'erbario ma anche piante vive e semi che coltivava nel suo giardino. Nel 1793 propose all'Imperatore di creare un orto botanico esclusivamente dedicato alle piante native; Francesco II, grande appassionato di botanica, accolse la proposta con entusiasmo e gli mise a disposizione un'area del parco di Belvedere, adiacente all'orto botanico imperiale. Durante i suoi soggiorni estivi sul Danubio, l'imperatore si faceva suo allievo e gli chiese di dare lezioni ai suoi fratelli minori, gli arciduchi Johann, Anton e Rainer. Per il loro uso, Host creò un giardino didattico nel parco di Schönbrunn con le piante collocate secondo il sistema di Linneo. Il primo nucleo del Garten der Kronländer fu costituito dalle piante coltivate da Host nel suo giardino privato, cui si aggiunsero via via le piante native che andava raccogliendo nelle sue escursioni botaniche in molte parti dell'Impero. Funzionale alla realizzazione del giardino fu anche la prima pubblicazione di Host, Synopsis plantarum in Austria (1797), che contiene molte nuove specie; a differenza della monumentale opera illustrata di Jacquin, costosissima, stampata in poche copie e diventata presto quasi irreperibile, vuole essere un'opera di consultazione il più possibile completa (conta oltre 600 pagine) ma relativamente agile e di ampia diffusione; proprio per questo è priva di illustrazioni. Il capolavoro botanico di Host tuttavia è Icones et descriptions graminum austriacorum (1801-09), una magnifica opera in quattro volumi in folio con le illustrazioni di Johann Ibmayer che illustra le graminacee dell'Austria e dell'Europa centrale. Ugualmente splendido è Salix (1808), anch'esso illustrato da Ibmayer, dedicato ai salici delle provincie austriache. L'ultima fatica di Host fu ancora un'opera complessiva sulla flora dei territori asburgici, Flora austriaca, in due volumi (1827-1831), particolarmente importante per l'inclusione di specie di aree all'epoca poco note e ricche di endemismi, l'Istria e la Dalmazia, con tavole tratte da acquarelli di Ibmayer. Anche se Host è stato a volte criticato perché tendeva a moltiplicare le specie, classificando come specie distinte qualsiasi variazione, si tratta di lavori molto importanti che arricchirono notevolmente la conoscenza della flora dell'Austria e delle aree limitrofe. Host morì a Schönbrunn nel 1834. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Sembra che dopo la sua morte il giardino che aveva concepito, creato e diretto sia caduto presto nella trascuratezza. Intorno al 1865, quanto rimaneva della collezione di piante alpine fu trasferita al Belvedere e divenne il primo nucleo dell'attuale giardino alpino.  Hosta, una po' di storia Come medico imperiale ed esponente di punta della scuola botanica di Vienna, Host era in contatto con molti colleghi in patria e all'estero. Tra i suoi corrispondenti ed amici troviamo anche Leopold Trattinick che 1812 volle onorarlo ribattezzando Hosta plantaginea una pianta giapponese precedentemente pubblicata da Thunberg come Hemerocallys japonica. Nacque così il genere Hosta, famiglia Asparagaceae; oggi è una superstar dei giardini, ma a quel tempo solo due specie erano arrivate in Europa ed erano ancora una curiosità coltivata in pochissimi orti botanici. A rigori, il nome di Trattinick era illegittimo, perché la denominazione era già stata utilizzata da von Jacquin per un genere poi riconosciuto sinonimo di Cornutia. Nel 1817 il botanico prussiano Kurt Sprengel propose una denominazione alternativa, ribattezzando il genere Funkia, in onore del botanico bavarese Heinrich Christian Funck. Questo nome ottenne un certo successo, tanto da fornire il nome comune in varie lingue, tra cui il tedesco Funkie; venne inoltre largamente usato in campo orticolo ed è ancora presente in vecchie pubblicazioni. Tuttavia, anche la denominazione di Sprengel era altrettanto illegittima, perché preceduta da Funckia Willd. (sinonimo di Astelia). Per farla corta (vennero proposte anche altre denominazioni, che però per una ragione o per l'altra non si affermarono), la questione venne risolta solo nel 1905, quando il Congresso internazionale di botanica optò per Hosta. E così, un botanico che aveva dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla valorizzazione della flora nativa si è trovato associato a un genere che arriva da molto lontano, ovvero dall'Estremo oriente (Cina, Giappone, Corea, Russia sud-orientale). Il primo incontro tra i botanici europei e le Hosta avvenne in Giappone, dove queste piante sono chiamate giboshi e, oltre a crescere in natura (le isole giapponesi sono il centro di diversità del genere) sono coltivate almeno dall'ottavo secolo. Engelbert Kaempfer, che soggiornò a Deshima tra il 1690 e il 1692 come medico della Compagnia olandese orientale, descrisse e disegnò Joksan, vulgo gibbooschi Gladiolus plantagenis folio che è stata identificata come Hosta lancifolia. Quasi un secolo dopo fu la volta di Carl Peter Thunberg, che fu a Deshima tra il 1775 e il 1776 e pubblicò due specie, assegnandole al genere Hemerocallis. Tuttavia le prime specie di Hosta raggiunsero l'Europa dalla Cina. La prima fu H. plantaginea, arrivata nel Jardin des Plantes di Parigi nel 1784 grazie ai semi inviati dal console francese a Macao. I semi germinarono e nel 1788 Lamarck descrisse la pianta come Hemerocallis plantaginea. La seconda specie arrivò a Londra nel 1790 e qualche anno dopo fu descritta da Salisbury come Bryocles ventricosa. Ma il personaggio più importante per l'introduzione delle Hosta in Europa fu senza dubbio Philipp Franz von Siebold, anche lui medico a Deshima per la Compagnia olandese delle Indie tra il 1823 e il 1828. Al suo ritorno in Europa ne portò con sé diversi esemplari, aprendo anche un proprio vivaio a Leida; più tardi, quando poté ritornare in Giappone, ne importò altri ancora; grazie a lui, il numero di specie o cultivar coltivate in Europa passò di colpo da due a una ventina. Non a caso, due tra le specie più note portano il suo nome: H. sieboldiana e H. sieboldii. Dall'Europa le Hosta raggiunsero anche gli Stati Uniti; tuttavia negli anni '70 Thomas Hogg, un vivaista che lavorava in Giappone per il governo statunitense, aprì un canale di importazione diretto. Le Hosta incominciarono via a via ad acquistare popolarità, ma fino alla seconda guerra mondiale le varietà disponibili erano ancora più o meno quelle note nell'Ottocento. Intorno al 1950, nei Paesi Bassi, se ne coltivavano una trentina di specie. Si era alla vigilia della grande esplosione dei nuovi ibridi e della selezione di cultivar sempre nuove, il cui numero nell'arco di mezzo secolo è cresciuto in modo esponenziale. Nel 2009 il vivaista e ibridatore americano Mark Zilis nella sua Hostapedia ha elencato 7000 tra specie, ibridi e cultivar. Ovviamente, quelle non selezionate sono ancora di più. Altre informazioni su questo genere molto amato nella scheda, dove troverete soprattutto una selezione di link per approfondire la conoscenza con il "pianeta Hosta". Quando arrivò in Brasile come giardiniere della spedizione austriaca, Heinrich Wilhemn Schott era un giovanotto di ventitré anni. Quell'avventura che sognava fin da bambino, quando, malato, aveva ricevuto la visita del grande Humboldt, cambiò per sempre la sua vita, facendogli incontrare le piante a cui avrebbe dedicato quasi mezzo secolo di studio meticoloso ed appassionato: le Araceae. Prima di lui, erano ancora poco conosciute e mal classificate; basandosi tanto su esemplari d'erbario, quanto sulle piante vive che coltivava nel giardino di Schönbrunn, di cui era capo giardiniere, fu il primo ad analizzarne in modo comparativo infiorescenze, fiori e frutti, stabilendo molti generi validi anche oggi e gettando le basi della tassonomia della famiglia. A ricordarlo non potevano che essere due generi di Araceae, originarie di Sarawak, nel Borneo settentrionale: Schottarum e Schottariella.  Una passione iniziata nel segno di Humboldt Sull'infanzia di Heinrich Wilhelm Schott, brillante giardiniere imperiale e grande tassonomista, si racconta un aneddoto dal sapore di fiaba. Nato a Brno in Moravia, a sette anni aveva raggiunto a Vienna il padre, capo giardiniere dell'Orto botanico universitario; poco dopo cadde malato e sembrò in punto di morte. Quando seppe che l'uomo che più ammirava al mondo, il grande Alexander von Humboldt, si trovava in città, espresse il desiderio di conoscerlo. Suo padre scongiurò il direttore dell'orto botanico, Nicholas Joseph von Jacquin, di intercedere presso lo scienziato perché visitasse il piccolo malato. Humboldt acconsentì prontamente; rivolse al bimbo parole così giuste e incoraggianti da risvegliare la sua forza vitale. Heinrich Wilhem guarì e giurò che avrebbe dedicato la sua vita a studiare la natura e le sue intime relazioni, sull'esempio del suo idolo. Negli anni successivi segui le lezioni di botanica, agricoltura e chimica all'Università, senza però conseguire alcun titolo, visto che adolescente incominciò a lavorare come aiuto giardiniere agli ordini del padre. Nel 1815 (all'epoca aveva ventun anni) divenne giardiniere del Palazzo Belvedere, dove gli fu assegnata la cura delle piante native. Due anni dopo, Joseph Franz von Jacquin lo raccomandò come giardiniere della spedizione austriaca in Brasile: era la persona ideale, unendo solide basi teoriche e abilità pratica. In Brasile il compito principale di Schott fu l'allestimento di un giardino di acclimatazione annesso all'ambasciata austriaca a Rio de Janeiro, dove coltivava le piante raccolte dai membri della spedizione e le preparava per il lungo e difficile viaggio verso l'Europa. Egli stesso si procurava semi e piantine in brevi spedizioni nei dintorni, ma, affascinato dall'esuberante natura tropicale, avrebbe desiderato spingersi più lontano. Solo dopo circa un anno, quando arrivò da Vienna l'aiuto giardiniere Schücht, poté soddisfare questo desiderio, con qualche missione a più largo raggio in compagnia del pittore Frick. Il suo diario di campo, notevole per la precisione delle descrizioni e arricchito da informazioni sulla geografia, l'economia e l'etnografia delle aree visitate, fu pubblicato a Brno nel 1822, dopo il rientro in Austria. Schott era infatti tornato a casa nell'estate del 1821. A Vienna, riprese il suo lavoro al Belvedere; nel 1828 fu promosso Hofgärtner, ovvero capo giardiniere. Ma intanto in Brasile aveva incontrato le piante del suo destino: le Araceae. Da quel momento avrebbe alternato al lavoro di giardiniere lo studio delle sue piante preferite; oltre al metodo rigoroso e a una brillante capacità di mettere a confronto una grande quantità di piante, a facilitargli il compito fu proprio la sua doppia veste di tassonomista e giardiniere; come capo dei giardini imperiali (nel 1845 venne nominati direttore del Giardino Imperiale di Schönbrunn, di cui diresse anche la trasformazione in giardino all'inglese) aveva accesso a una vasta collezione di piante esotiche, che egli stesso ebbe cura di incrementare grazie agli invii dei suoi numerosi corrispondenti. Così, poteva studiare le piante non solo su esemplari d'erbario o conservati sott'alcool, ma anche dal vivo, sperimentando diverse condizioni di coltivazione e osservando tutti gli stadi di sviluppo. Inoltre, come giardiniere, diede un importante contributo all'introduzione nei nostri giardini e nelle nostre case di piante oggi molto popolari, come Dieffenbachia, Anthurium scherzerianum, Schindapsus aureus. Grande esperto di piante tropicali, era anche appassionato di piante alpine e a palazzo Belvedere creò uno dei primi giardini ad esse dedicato. Una sintesi della sua vita operosa nella sezione biografie.  Araceae, fortissimamente Araceae Schott iniziò a studiare le Araceae fin dal suo ritorno dal Brasile, a partire dalle sue raccolte brasiliane e dalle collezioni di N.J. von Jacquin nelle Indie occidentali. All'epoca, questo gruppo di piante era ancora poco conosciuto. La famiglia è diffusa in tutto il mondo, ma il 90% delle specie proviene dai tropici. Alcune specie europee erano note fin dall'antichità e i botanici prelinneani, come Dodoens, tendevano a unirle tutte insieme sotto l'etichetta Arum, un nome di etimologia incerta, dal gr. aron, che indicava qualche pianta di questo gruppo, forse Dracunculus vulgaris. All'inizio del Settecento, Tournefort circoscrisse i tre generi europei Arum, Dracunculus, Arisaema e li raggruppò in una "classe" caratterizzata da un unico petalo; la struttura fiorale delle Araceae non era infatti ancora stata compresa e la brattea che avvolge lo spadice, l'infiorescenza tipica della famiglia, fu scambiata per un petalo sia da lui sia da Linneo. Quest'ultimo, in Species Plantarum (1753) ne descrisse 26 specie (oggi ne conosciamo circa 3750 distribuite in oltre 120 generi) distribuite nei quattro generi Arum, Dracontium, Calla, Pothos, cui l'anno successivo aggiunse Pistia; descrisse anche Orontium e Acorus, di cui però, come per Pistia, non riconobbe un'affinità con Arum. Intanto, con il moltiplicarsi delle spedizioni botaniche nei paesi tropicali molte nuove specie affluivano in Europa. Nel 1789 Antoine Laurent Jussieu fu il primo a riconoscere che il cosiddetto fiore è in realtà un'infiorescenza composta da uno spadice con numerosissimi minuscoli fiorellini avvolto in una brattea, o spata. A lui si deve anche la creazione della famiglia Araceae. Nel frattempo erano stati riconosciuti diversi nuovi generi, ma il primo a studiare sistematicamente questo gruppo di piante fu appunto Heinrich Wilhelm Schott, che può fregiarsi a ragione del titolo di "papà delle Araceae". Esordì con una serie di brevi articoli pubblicati in una rubrica intitolata Für Liebhaber der Botanik, "Per gli amanti della botanica", sulla rivista culturale Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode; benché solitamente molto brevi e rivolti a un pubblico generalista, sono molto importanti perché Schott vi venne via via pubblicando molti nuovi generi. Nel 1832 pubblicò la prima monografia sulle Araceae, Meletemata botanica (in collaborazione con Stephan Ladislaus Endlicher, all'epoca direttore dell'orto botanico di Vienna), uscito in sole sessanta copie; in questo lavoro, dedicato a una miscellanea di piante tropicali di recente raccolta, Schott riconobbe 40 generi e incominciò a delineare l'organizzazione della famiglia in sottofamiglie e sezioni. Seguì uno iato di vent'anni, nel corso del quale il botanico pubblicò solo due lavori estranei alla famiglia, uno sulle Rutaceae e l'altro sulle felci. In realtà, era tutt'altro che inattivo ma stava perfezionando con cura meticolosa il suo sistema di classificazione; era in contatto con molti colleghi che operavano in zone tropicali e gli inviavano nuove Araceae che studiava e spesso coltivava nelle serre di Schönbrunn; supervisionava il lavoro dei disegnatori e degli illustratori che, a sue spese, lo assistevano preparando i disegni e gli acquarelli per le future pubblicazioni. Così, a partire dal 1853, incominciarono a susseguirsi a breve intervallo diverse importanti monografie illustrate; la serie fu aperta tra il 1853 e il 1857 da Aroideae, con sessanta tavole; continuò con Synopsis Aroidearum (1856) e Genera Aroidearum Exposita (1858) e culminò con Prodromus Systematis Aroidearum (1860), in cui Schott portò a conclusione il sistema di classificazione perfezionato nell'arco di uno studio quarantennale. Contemporaneamente, diede alle stampe una magnifica raccolta di litografie in 4 volumi, Icones Aroidearum (1857-58). In questo periodo di iperattività, pubblicò anche dozzine di brevi articoli, usciti prevalentemente su Oersterichisches Botanisches Wochenblatt. Nel 1878, 14 anni dopo la sua morte, venne infine pubblicato, a cura di J.J. Peyritsch, un magnifico in folio illustrato con testi di Schott, dedicato alle Araceae raccolte nel Brasile orientale durante la spedizione finanziata nel 1859-60 dall'arciduca Ferdinando Massimiliano, più tardi imperatore del Messico come Massimiliano I. Il contributo di Schott alla conoscenza delle Araceae è incalcolabile; nel suo capolavoro, Prodromus Systematis Aroidearum, pubblicato a proprie spese all'età di 66 anni, trattò 110 generi, la maggioranza dei quali è tuttora valido o come genere o come sottogenere; si calcola che circa una terzo dei generi di questa famiglia debbano il loro nome a Schott, a testimonianza della vastità e della serietà del suo lavoro scientifico. I suoi lavori hanno gettato le basi della tassonomia delle Araceae e sono rimasti imprescindibili per tutti i botanici che sono venuti dopo di lui.  Resistere alle correnti Stranamente, questo grandissimo botanico ha rischiato di non ricevere il "solo onore che spetta a un botanico", come lo definiva Linneo, ovvero la dedica di un genere celebrativo. Certo, sono decine le piante che si fregiano degli eponimi schottii o schottianus come Philodendron schottii o Aphelandra schottiana; ma fino a tempi recenti un genere mancava. A rimediare a tanta ingiustizia hanno provveduto tra il 2008 e il 2009 i botanici P.C. Boyce e S.Y. Wong che in due studi dedicati alle Araceae del Borneo hanno voluto ricordalo con altrettanti generi: Schottarum e Schottariella. Appartenenti alla tribù Schismatoglottideae, sono molto simili tra loro e condividono l'habitat e le caratteristiche ecologiche. Sono piccole erbacee che crescono sulle ripide sponde argillose di corsi d'acqua dalle correnti impetuose, tributari di fiumi maggiori; le piante di questi habitat sono dette reofite, dal greco rèos "corrente" + phytòn "pianta". Riescono a sopravvivere in un ambiente così difficile grazie all'apparato radicale, molto profondo ed esteso, e alle foglie strette, allungate, flessibili e talvolta sfrangiate; nel descriverle, Beccari, che fu tra i primi a studiare la flora di Sarawak, nella parte nord occidentale dell'isola, ha definito questo carattere "stenofillia". Le foreste del Borneo sono insolitamente ricche di specie di Araceae (ne sono state recensite circa 130), tra cui numerose reofite. Sono ancora poco note perché spesso limitate a poche località, ma anche difficili da studiare perché le rive dei fiumi dove vivono possono essere totalmente sommerse per molti mesi all'anno, senza contare che le loro acque sono infestate dai coccodrilli. I due nuovi generi dedicati a Schott sono entrambi endemici di Sarawak, rari e presenti in poche stazioni. Schottarum comprende due specie, S. josefii e S. sarikense; Schottariella una sola, S. mirifica. Tutte sono piccole erbacee acquatiche con profondo ed esteso apparato radicale strisciante che consente di abbarbicarsi al substrato argilloso, con una rosetta di molte foglie strette e allungate, infiorescenze solitarie ma spesso numerose con spata a conchiglia e spadice subcilindrico. I due generi differiscono tra loro per alcuni particolari dei fiori apprezzabili solo al microscopio. Nei periodi di piena le piante possono trovarsi completamente sommerse, e quando emergono trattengono residui di fango sulle foglie; nei periodi di siccità, quando le acque scendono di molto e i corsi d'acqua si riducono a rigagnoli, possono trovarsi completamente all'asciutto. Anzi, coltivata in laboratorio, Schottariella mirifica ha dimostrato di essere in grado di rivivere anche dopo essere rimasta totalmente senza foglie e con l'apparato radicale inaridito per la siccità prolungata. Qualche approfondimento su Schottarum e Schottariella nelle rispettive schede. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed