|
Nel 1794, quando fu assegnato al Dipartimento medico della presidenza del Bengala, Francis Buchanan aveva già trentadue anni e da dieci prestava servizio come chirurgo sulle navi della Compagnia delle Indie. Ora finalmente contava di dedicarsi alla sua vera passione: la botanica. Ma, contrariamente a quella del conterraneo William Roxburgh, da poco nominato sovrintendente dell'Orto botanico della Compagnia a Calcutta, la sua carriera ventennale in India proseguì in un'alternanza di grandi speranze e cocenti delusioni. Quando finalmente fu chiamato a succedere a Roxburgh, di anni ne aveva orami più di cinquanta, ed era già deciso a ritornare in Europa. Benché sia stato un raccoglitore straordinario e sia stato tra i primi ad esplorare la flora della Birmania e del Nepal, più che come botanico è noto come geografo ed esploratore, grazie alle due ricognizioni che diresse nel 1800-01 a Mysore e tra il 1807 e il 1814 in Bengala. A ricordarlo il genere Buchanania, che comprende una ventina di specie di alberi tropicali diffusi tra l'India e l'Australia; alcuni producono semi commestibili simili a quelli dell'anacardio.  Sedici anni di gavetta Nella vita di Francis Buchanan, più tardi Buchanan-Hamilton (1762-1829), c'è una specie di convitato di pietra: William Roxburgh. Quasi coetanei (Roxburgh gli è maggiore di dieci anni) i due sono entrambi scozzesi, si sono formati con gli stessi maestri e si sono laureati in medicina alla stessa università, quella di Edimburgo. Subito dopo la laurea, a dieci anni di distanza, entrambi sono entrati al servizio della Compagnia inglese delle Indie (EIC), spinti dalla necessità (l'uno come l'altro sono privi di mezzi), ma anche dal sogno di farsi un nome come scienziati. Prima di potersi dedicare interamente alla botanica, anche a Roxburgh non erano mancati gli anni di apprendistato, quando lavorava come sotto chirurgo e poi chirurgo dell'EIC; ma fin dal 1781 (all'epoca aveva trent'anni) è diventato botanico ufficiale, poi capo naturalista della presidenza di Madras, quindi dal 1793 direttore dell'orto botanico di Calcutta, che trasforma in uno straordinario centro di ricerca. La carriera di Buchanan ripercorre alcune di queste tappe, ma in tempi dilatati e con un percorso segnato da speranze e delusioni. Le leggi scozzesi, ancora basate sul maggiorascato, escludono Francis, quarto figlio maschio, dall'eredità del padre, un facoltoso medico appartenente alla piccola nobiltà, che è anche un proprietario terriero. Per mantenersi deve avere una professione e sceglie la medicina. All'università, due incontri segnano per sempre la sua vita: il primo è con il suo professore di botanica, John Hope, che lo inizia alla scienza delle piante e al culto di Linneo; il secondo è con il condiscepolo James Edward Smith. Nel 1783, l'anno in cui Francis Buchanan si laurea, quest'ultimo acquista le collezioni linneane e di colpo, da oscuro studente, si trasforma in una stella di prima grandezza del firmamento dei naturalisti. E' probabilmente questo esempio a spingere Francis ad entrare al servizio dell'EIC, anziché iniziare una tranquilla carriera di medico di provincia. La prima delusione è immediata: l'EIC ha già fin troppi chirurghi nelle stazioni di terra, e Buchanan è costretto a prestare servizio sulle navi della Compagnia che fanno la spola tra l'Inghilterra e l'Asia; gli scali sono brevi e occasionali, e, come egli stesso si esprime, la botanica, di cui aveva sperato di fare una professione, diventa il suo hobby horse. Finalmente nel 1794 l'ultimo ingaggio lo porta da Portsmouth a Calcutta, dove entra al servizio del Dipartimento medico della Presidenza del Bengala. Va a fare visita a Roxburgh, che è ciò che lui vorrebbe essere: un botanico professionista e uno scienziato riconosciuto a livello internazionale. Per lui è un punto di riferimento, un amico, un corrispondente, un modello, ma, come vedremo, più tardi si trasformerà in un rivale, o per lo meno in un ostacolo. Assegnato alla remota stazione rurale di Luckipore, dove c'è ben poco da scoprire, Buchanan ha la sua prima occasione nel 1795, quando, forse proprio grazie alla raccomandazione da Roxburgh, accompagna il capitano Michael Symes in missione diplomatica in Birmania come medico della legazione. Anche se non fa parte dei suoi compiti, Buchanan ne approfitta per mettere insieme un erbario birmano di 168 esemplari e per interessarsi alla cultura, alla religione e alla letteratura del paese. Dotatissimo naturalista, egli è anche un osservatore acuto e un meticoloso raccoglitore di informazioni. Tuttavia, tutti questi talenti per ora rimangono inutilizzati. Nonostante doni l'erbario e il catalogo delle piante birmane alla Compagnia, nella speranza di accreditarsi come botanico, il dono cade nel vuoto e gli toccano altri cinque anni di purgatorio. Fino al 1798 rimane a Luckipore, quindi viene trasferito a Buraipur che ha il vantaggio di distare solo una giornata da Calcutta, ma non presenta alcuna attrattiva per un botanico; Buchanan si rassegna a trasformarsi in zoologo e a studiare gli animali. Unico diversivo, sempre nel 1798, una missione a Chittagong, che gli è stata procurata da Roxburgh che lo considera il migliore tra i botanici che operano in India. Quando Buchanan scopre che nel volume di Symes sull'ambasceria (An Account of the Embassy to the Kingdom of Ava, London 1800) sono stati usati i suoi disegni e le sue descrizioni naturalistiche senza neppure citarlo, anzi attribuendone la paternità a Joseph Banks, alla frustrazione si aggiungono il dolore e l'indignazione. Per la Compagnia e per gli ambienti scientifici londinesi, Buchanan come naturalista non esiste. Al momento, è più accreditato come orientalista; nel 1796 è ammesso all'Asiatic Society, sulla cui rivista pubblica l'importante saggio On the Religion and Literature of the Burmas, in cui contrappone "l'egualitarismo del Buddismo alla natura oppressiva e gerarchica del Bramanesimo".  L'"inchiesta statistica" a Mysore e la scoperta della flora del Nepal La seconda occasione arriva nel 1800, quando il governatore generale dell'India, Richard Wellesley, si accorge di lui e gli affida una ricognizione del recentemente conquistato territorio di Mysore. Nell'India meridionale è già all'opera Colin Mackenzie, incaricato dei rilievi topografici, ma, prima di essere completato, il suo lavoro richiederà anni; al governatore serve invece in tempi rapidi una relazione che dimostri che l'invasione di Mysore, fortemente criticata da parte dell'opinione pubblica inglese ma anche da settori influenti della Compagnia, era pienamente giustificata e corrispondente agli interessi tanto dell'EIC quanto del Regno britannico. L'oggetto privilegiato dell'inchiesta affidata a Buchanan è l'agricoltura, ma, oltre che sulle produzioni vegetali e animali, gli viene chiesto di raccogliere informazioni sul clima, i minerali, le produzioni artigianali, le condizioni di vita degli abitanti, inclusi il cibo, i vestiti, i costumi, la religione, le leggi, i commerci ecc. E' un tipico statistical survey, dove l'aggettivo non ha il significato odierno: è un'inchiesta ufficiale (promossa da uno stato, questo il significato originario) a tutto campo sulle risorse, la popolazione, gli aspetti umani di un territorio. E, come ha dimostrato la sua esperienza in Birmania, Buchanan ha gli strumenti per gestire un compito così complesso, anche se ovviamente per lui la botanica viene prima di tutto. Il suo viaggio muove da Madras nella primavera del 1800 e a Madras si conclude nell'estate nel 1801; segue un itinerario tortuoso, che lo porta a visitare non solo Mysore, ma anche il Malabar e la costa del Karnataka. Spesso a guidare i suoi passi sono gli interessi botanici, ma egli visita località strategiche come Sira, incontra il diwan di Mysore, intervista persone di ogni classe sociale e raccoglie informazioni di ogni genere. E' il primo a osservare e descrivere la laterite. Mette insieme un erbario imponente e disegna o fa disegnare da artisti locali centinaia di piante. Alla fine, la sua relazione ai vertici della compagnia sarà esattamente come Wellesley la desidera: Tipu Sultan vi è dipinto come un despota orientale, odioso agli occhi dei suoi stessi sudditi, l'occupazione britannica come il ristabilimento della giustizia, dell'equità, della pace e del progresso. Il premio non si fa attendere. Poco dopo il rientro a Madras, Wellesley gli chiede di accompagnare il capitano Knox a Katmandu dove verrà fondata la prima sede diplomatica britannica in Nepal. La situazione del paese è instabile e dopo appena un anno Knox è bruscamente richiamato; la presenza dei britannici è mal tollerata e i raccoglitori nepalesi di Buchanan sono addirittura accusati di essere spie al servizio degli inglesi. Ma nonostante la brevità e la brusca interruzione, per la storia della botanica il soggiorno di Buchanan in Nepal è importantissimo: è il primo botanico occidentale ad esplorarne la flora ricchissima di endemismi; prima che un altro studioso vi sia ammesso di nuovo, passeranno quasi vent'anni: si tratta di Nathaniel Wallich, che visiterà il Nepal nel 1820. Nel 1825, sulla base delle collezioni di entrambi, David Don pubblicherà il suo Prodromus florae nepalenisis, rimasto l'opera di riferimento sulla flora del paese himalayano praticamente fino alla seconda metà del Novecento. Al suo rientro in India, Buchanan viene rispedito a Buraipur; ancora una delusione, ma di breve durata. Wellesley lo vuole come medico personale e poco dopo lo chiama a Barrackpore, la sua residenza di campagna, a dirigere il suo zoo e il Natural History Project of India, ovvero la ricognizione, l'illustrazione, la descrizione e la classificazione di tutti i mammiferi e gli uccelli dell'India. Di colpo, Buchanan si trova a fare parte del circolo più intimo del governatore, e su un gradino superiore a quello di Roxburgh, di cui per altro spera di prendere il posto; voci insistenti dicono che è ammalato e che presto sarà costretto a lasciare l'India. Il momento di gloria è brevissimo. Nel 1805 Wellesley viene richiamato e sostituito da lord Cornwallis, che taglia tutte le spese che considera inutili, tra cui il Natural History Project. Cronwallis è uno dei critici più feroci di Wellesley e Buchanan capisce che per il momento in India per lui non c'è futuro; decide di imbarcarsi con il suo patrono per Londra, dove potrà difendere meglio i propri interessi. Conta soprattutto sul vecchio amico James Edward Smith, ora presidente della Linnean Society, cui affida i manoscritti con le descrizioni in latino, gli esemplari raccolti a Mysore e una magnifica collezione di illustrazioni botaniche che ha fatto eseguire a Calcutta da un artista locale. Spera che Smith li faccia conoscere includendone una parte nella sua Exotic Botany e li custodisca finché egli stesso possa pubblicarli. E' una fiducia mal riposta: Smith utilizza sono una dozzina di illustrazioni (fatte ridisegnare da Sowerby), dieci di piante nepalesi e due di Mysore, ne pubblica altre 37 senza illustrazioni sulla Rees's Cyclopedia; e non restituisce mai i materiali a Buchanan. Dopo la sua morte, passeranno alla Linnean Society, finendo semi dimenticati, fino a tempi recenti, quando la collezione di illustrazioni è stata riscoperta e pubblicata anche in forma digitale. In ogni caso, il nome di Buchanan incomincia ad essere conosciuto negli ambienti scientifici della capitale e nel maggio 1806 egli è ammesso alla Royal Society. Nel 1807, a spese dell'Asiatic Society e della Compagnia delle Indie, viene pubblicata la relazione sul viaggio a Mysore, in tre volumi (A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar). Negli stessi mesi, è a Londra anche Roxburgh: in effetti è molto malato e, sebbene abbia sono 54 anni, pensa davvero di ritirarsi; è qui per trattare con la Compagnia la sua quiescenza e soprattutto per assicurare la successione al figlio omonimo. Buchanan, che aspira a quel posto per se stesso, fa di tutto per impedirlo; scrive non meno di quattro volte a Smith perché faccia pesare tutta la sua influenza sui vertici dell’EIC, denuncia il nepotismo di Roxburgh e scredita il rivale: quel giovanotto non ha studiato in un’università europea, ciò che sa di botanica gli deriva dall’essere l’assistente del padre; insomma, più o meno un giardiniere. Le pressioni di Buchanan fanno centro: nel gennaio 1807 la direzione della Compagnia lo nomina successore di Roxburgh.  Grandi speranze deluse Come due anni prima, anche questa sarà una vittoria di Pirro. Roxburgh non solo recupera la salute, ma ritorna in India e riassume pienamente i suoi doveri. Ma, se non altro, la ricchezza delle sue raccolte ha fatto capire alla Compagnia le grandi qualità di Buchanan, e, forse anche come premio di consolazione, viene deciso di affidargli la ricognizione del territorio bengalese. E' il secondo, più noto, statiscal survey diretto da Buchanan, che lo impegnerà per ben sette anni, dal 1807 al 1814. Come a Mysore, la sua inchiesta non riguarda solo le risorse naturali, ma ogni aspetto della vita quotidiana, della cultura locali, della religione, della storia, dell'archeologia. Rispetto a Mysore, il suo compito è però molto più impegnativo. La Corte dei direttori della compagnia esige una relazione distretto per distretto e il nuovo governatore, lord Minto, che è rimasto impressionato dai risultati dei rilievi topografici di Mackenzie, in particolare dalle carte a scala di un pollice a un miglio (1/63.000), esige una descrizione topografica dettagliata. Ecco perché i lavori si prolungano ben oltre le attese sia dell'EIC sia dello stesso Buchanan. Ovviamente egli prosegue le raccolte botaniche ma, dato che il Bengala è una regione ricca di acque, incomincia a interessarsi sempre più ai pesci. Il risultato sarà l'importante An account of the fishes found in the river Ganges and its branches (1822), in cui descrive oltre cento specie in precedenza ignote alla scienza. Rimane sempre la prospettiva di succedere a Roxburgh, la cui salute nel frattempo si è di nuovo deteriorata, ma ora è lo stesso Buchanan a provare molto meno interesse per l'incarico un tempo tanto agognato. In primo luogo, la Compagnia, insoddisfatta dell'indirizzo scientifico impresso da Roxburgh, vorrebbe che il giardino tornasse allo scopo iniziale: l'acclimatazione di specie esotiche di interesse economico. In secondo luogo, gli anni passano e anche Buchanan sta per toccare la cinquantina; la sua salute è ancora buona, ma teme di rovinarsela definitivamente e di essere privato di qualche anno di serena vecchiaia da dedicare allo studio e alla pubblicazione dei suoi sempre più cospicui materiali. Almeno dal 1810, è intenzionato a ritirarsi appena possibile e a questo scopo inizia a risparmiare e inviare denaro da investire al suo banchiere londinese. Intanto, continua ad esplorare il Bengala, seguendo un itinerario divagante e a zigzag, anche più che a Mysore dettato dalla passione botanica. Se una zona è arida e priva di vegetazione, si sposta in un'altra più promettente. Nel 1808 abbandona "il fango del Bengala" per organizzare una spedizione botanica nelle Alpi del Bhutan; a Ronggopur e Purnea si spinge oltre i confini del territorio della Compagnia per esplorare la flora alpina; nel 1812 va ad esplorare le foreste di Bhagalpur, e l'anno dopo si spinge a Gorakpur, lungo il turbolento confine con il Nepal. Nel 1813 la salute di Roxburgh precipita; l'anno dopo egli dà le dimissioni e lascia definitivamente l'India per tornare in Scozia, dove morirà appena due anni dopo. La Compagnia conferma la nomina di Buchanan, ma quel traguardo per cui ha intrigato appena sette anni prima è orami privo di interesse, tanto più che si pretende da lui che si occupi sia del giardino sia del completamente del survey. Dopo pochi mesi anche lui si dimette e rientra in Europa. Dopo trent'anni di viaggi, è ora di dedicarsi esclusivamente allo studio e alla pubblicazione dei suoi ricchissimi e disparati materiali. Ma c'è ancora un problema (con Buchanan, ce ne sono sempre): le sue raccolte sono così imponenti che gli è impossibile portarle con sé. Decide così di farne dono alla Compagnia delle Indie in cambio del trasporto gratuito; ma durante le trattative il governatore generale lord Moira confisca più di cinquecento disegni di animali e piante, pretendendo che siano di proprietà dell'EIC. E' un nuovo affronto, probabilmente il più amaro di tutti. Anche se i direttori ordinano che gli siano restituiti, sembra che ciò non sia mai accaduto. In cambio di un dono inestimabile, dalla Compagnia che ha servito per trent'anni ha ricevuto al più un ringraziamento formale, è stato come "dare perle ai porci", commenta amareggiato. Torna in Gran Bretagna nel 1815 e lo stesso anno, alla morte della madre, ne eredita la proprietà e cambia il proprio nome in Francis Buchanan-Hamilton. Ancora alla ricerca del riconoscimento scientifico, lavora molto e pubblica più che può, impegnandosi in direzioni diverse. Il suo lavoro più noto è probabilmente The Kingdom of Nepal (1819), al cui successo contribuisce anche la prossimità della prima guerra nepalese (1814-1816); seguirono Genalogies of Hindus (1819), pubblicato in poche copie in edizione privata, che lo accreditò presso letterati e orientalisti, e il già citato volume sui pesci del Gange. Nel 1818 la morte del fratello e l'eredità delle terre di famiglia gli assicurano un nuovo status e una inedita tranquillità economica. Buchanan-Hamilton va a vivere in Scozia, nella residenza baronale di Leny House, nei cui giardini ha fatto piantare piante rare. Si sposa e si dedica interamente al lavoro scientifico, in particolare al commento di Hortus malabaricus e Herbarium amboinense di Rumphius: vuole ricavarne un'opera complessiva di grande impegno, in cui potrà trasfondere tutto ciò che ha imparato in trent'anni di ricerca e raccolte in India e nell'Asia orientale. Nel 1822 ne pubblica la prima parte, ma il lavoro non sarà mai completato. Buchanan-Hamilton muore nella sua residenza scozzese nel 1829.  Nutrienti Buchanania Almeno sul versante delle denominazioni botaniche, i riconoscimenti arrivarono presto. Nel 1801, Curt Sprengel, assegnando a un nuovo genere un albero raccolto da Buchanan durante la missione diplomatica in Brimania, crea in suo onore il genere Buchanania. Nel 1806 il suo esempio è seguito da Smith nel suo Exotic Botany. Troppo tardi: ad essere valida è ovviamente la denominazione di Sprengel. Il genere Buchanania Spreng. (Anacardiaceae) comprende circa venticinque specie di alberi o arbusti tropicali, distribuiti tra la Cina meridionale, l'India, l'Indocina, l'Indonesia, le isole del Pacifico e l'Australia. Hanno foglie semplici, inserite a spirale, con margini interi; piccoli fiori bianchi, profumati, raccolti in infiorescenze a pannocchia. Il frutto è una drupa con sottile endocarpo legnosi; i semi, come quelli dell'anarcardio, in alcune specie sono commestibili. E' il caso della specie tipo, B. cochinchinensis (più nota con il sinonimo B. lanzan), di relativamente ampia diffusione in India e in Indocina; in India, dove è anche coltivata, è nota come chironji o charoli; i suoi semi dall'aroma di mandorla e dalle dimensioni di un pinolo sono consumati crudi dopo una leggera tostatura o utilizzati nei dolci; ridotti in polvere, entrano anche in piatti salati. Ha antichissimi usi alimentari anche l'australiana B. obovata, un piccolo alberello del sottobosco dell'Australia settentrionale, i cui frutti, noti come green plum o wild mango, sono tradizionalmente consumati dalle comunità indigene. Ricchi di proteine, fibre e minerali come potassio, fosforo e magnesio, si segnalano per l'alto contenuto di acido folico. Di altre specie sono note le proprietà medicinali.
0 Comments
Nel 1824, Nathaniel Wallich dedica "con grande soddisfazione" un bell'arbusto dell'Himalaya, Leycesteria formosa, all'amico William Leycester, giudice della suprema corte di giustizia del Bengala, appassionato orticultore e primo presidente della Agri-Horticultural Society of India. Poco sappiamo di questo personaggio che in tal modo ha donato il suo nome al genere Leycesteria e a questa notevole pianta, di moda nei giardini vittoriani e oggi ingiustamente un po' dimenticata.  Nuove introduzioni per migliorare l'orticultura indiana Fino alla grande rivolta dei Sepoy del 1857, che spinse la monarchia britannica a prendere il controllo diretto del Raj, gran parte della penisola indiana era amministrata dai funzionari della Compagnia delle Indie (più correttamente, Compagnia Britannica delle Indie Orientali), una compagnia commerciale privata. Gli storici valutano che verso la metà del secolo, quando sotto il suo controllo passarono anche gran parte della Birmania, Singapore ed Hong Kong, un quinto dell'umanità fosse sottoposto alla sua autorità. Per assolvere i propri immensi compiti amministrativi, la Compagnia si avvalse di una schiera di migliaia di funzionari, reclutati in Gran Bretagna, ma cercò anche di coinvolgere le élites locali (caratteristica che differenziò profondamente il colonialismo britannico, tra gli altri, da quello francese). Un esempio relativamente riuscito di questa politica di integrazione può essere la Agri-Horticultural Society of India, fondata, come si è visto in questo post, nel settembre 1820 da William Carey. Per la sua storia personale, che lo aveva messo in contatto con studiosi, tipografi, filantropi indiani, egli era sicuramente la persona più adatta per imprimere alla nuova società un carattere multietnico. Infatti nel progetto di statuto scrisse esplicitamene: "E' particolarmente desiderabile che i gentlemen nativi possano non solo essere membri, ma anche dirigenti della società esattamente nello stesso modo degli europei". Considerando che le riunioni si tenevano in inglese, i "gentlemen nativi" erano ovviamente notabili colti e anche ricchi, visto che l'iscrizione era abbastanza costosa. Nel primo comitato direttivo, ne troviamo due, che erano anche vecchie conoscenze di Carey. Il primo era Radhakanta Deb (1784-1867), un linguista e uno studioso, autore di un dizionario di sanscrito, ma anche un pedagogo impegnato nella promozione dell'educazione (inclusa quella delle ragazze) e un uomo politico conservatore; egli mise a disposizione della società cinquecento acri di terreno e intervenne assiduamente alle riunioni, presentando diversi contributi sullo stato dell'agricoltura in Bengala. Il secondo, Ramkamal Sen (1783-1844), rappresenta molto bene il tipo del funzionario nativo di successo; all'inizio della sua carriera era un compositore tipografico sotto pagato; poi passò a lavorare al Fort William College e acquisì posizioni di crescente prestigio, fino a diventare tesoriere della Banca del Bengala e segretario dell'Asiatic Society; per le edizioni missionarie di Serampore curò la prima edizione in bengali dell'Hitopadesha, una raccolta di fiabe in sanscrito risalente al XII secolo. Tra i soci c'erano altri bengalesi eminenti. Vale la pena di citare almeno l'uomo d'affari Dwarkanath Tagore (1794-1846), fondatore di una delle prime grandi aziende anglo-indiane, che si occupava tra l'altro della produzione e dell'esportazione di prodotti agricoli, e più tardi fu coinvolta sia nell'introduzione del tè cinese in Assam sia nel traffico dell'oppio in Cina. Era il nonno del poeta premio Nobel Rabindranath Tagore. E' chiaro che né il governatore dell'India, né i funzionari della Compagnia, né tanto meno i magnati e proprietari terrieri indiani, e tutto sommato neppure i missionari, intendevano mettere in discussione la struttura agraria del paese e lo sfruttamento dei piccoli contadini da parte dell'élite rurale degli zamindar (era proprio da questa classe che la Compagnia reclutava gran parte dei suoi funzionari); erano però convinti che le condizioni di vita dei contadini e più in generale l'economia del paese (e della potenza colonizzatrice) avrebbero tratto giovamento dall'introduzione di nuove coltivazioni e di tecniche agrarie più moderne. Nonostante l'ostilità degli ambienti indù più conservatori, che temevano che la Società promuovesse la coltivazione di piante proibite (come l'aglio e le cipolle, il cui consumo era vietato dai testi sacri), il progetto di Carey ottenne un immediato successo, anche grazie all'alto patronato del governatore dell'India e di sua moglie, lord e lady Hastings, che misero a disposizione un terreno a Barrackpore. Il numero dei soci, sia britannici sia indiani, crebbe abbastanza rapidamente e oltre che in Bengala, vennero fondate sezioni in Punjab, a Madras e a Bombay. La presenza tra i soci di un certo numero di esperti permise anche alla società di varare una serie di comitati di studio, dedicati alla coltivazione del cotone, del grano, della canna da zucchero, del tè, del lino e della canapa, del tabacco, all'orticoltura, alla sericoltura e all'allevamento. In una prima fase, più o meno dalla fondazione al 1835, tuttavia, la società si concentrò prevalentemente sulle produzioni orticole su piccola scala e sull'acclimatazione di ortaggi europei, coinvolgendo non solo grandi proprietari terrieri, ma un vasto tessuto di ortolani e giardinieri a cui vennero distribuiti i semi fatti giungere dall'Europa o da altre colonie britanniche. Ad esempio, nel 1824 dalla Colonia del capo giunse una consegna di semi che comprendeva spinaci, carciofi, asparagi, lattuga, insalata pan di zucchero, pastinaca, cavoli, cavolfiori, zucche, cavolini di Bruxelles, sedano, zucchine, rape e crescione. Sul modello delle fiere agricole britanniche, i giardinieri indiani erano incoraggiati a presentare i prodotti migliori in esposizioni periodiche, ben pubblicizzate dalla stampa. La prima si tenne nel gennaio 1827 e premiò cinque bengalesi con medaglie e piccoli premi in denaro. Certamente i risultati non furono trascurabili, tanto da cambiare permanentemente le abitudini alimentari indiane: due casi eclatanti sono l'introduzione del cavolfiore e della patata (giunta dall'Inghilterra nel 1832), ortaggi oggi molti comuni nelle ricette indiane. Tuttavia, dopo il primo decennio, si registrò una certa crisi. Nel 1827, la Compagnia delle Indie decise di utilizzare il terreno di Barrackpore per espandere le coltivazioni sperimentali dell'orto botanico di Calcutta, e la Società fu costretta a cercare una nuova sede, che alla fine fu trovata ad Alipore. Tuttavia già nel 1834 il giardino fu dismesso, in seguito alla bancarotta del tesoriere della società, l'agenzia Alexander and Co. Non si trattava solo di problemi finanziari. La Compagnia delle Indie era insoddisfatta dell'indirizzo assunto dalla società; i risultati economici si facevano attendere, mentre all'introduzione di nuove coltivazioni provvedeva anche meglio l'orto botanico di Calcutta, ora abilmente diretto da Nathaniel Wallich. La Società rispose creando un vivaio all'interno dello stesso orto botanico; l'importazione di semi orticoli e di alberi da frutto dall'Europa non cessò, così come continuarono le mostre orticole, ma venne incrementata l'introduzione di piante alimentari e industriali. Abbiamo già visto il caso delle patate, giunte nel 1832. Nel 1830, da Londra arrivarono semi di cotone e tabacco. Tra le colture introdotte per la prima volta dalla Società, possiamo aggiungere il mais, introdotto dagli Stati Uniti nel 1831; la segale e l'orzo; il lino, importato dalla Scozia nel 1842, e il ramié bianco Boehmeria nivea, giunto dall'orto botanico di Edimburgo nel 1854. Tra le foraggere, il trifoglio e l'erba di Guinea Megathyrsus maximus. Molti sforzi furono anche rivolti all'introduzione di alberi da frutto tipicamente europei (meli, peschi, peri, ciliegi, susini), inclusi piccoli frutti come il ribes e l'uva spina, particolarmente richiesti dai proprietari terrieri indiani. Tuttavia alla fine degli anni '30, la Società aveva ormai cambiato natura. Anche per influenza di personaggi come Dwarkanath Tagore, il focus andava sempre più spostandosi dalle piante alimentari e medicinali a quelle industriali, come la canna da zucchero, dalle necessità della popolazione al profitto e alla produzione per l'esportazione. Non seguiremo questa evoluzione per soffermarci su uno dei protagonisti della prima fase "orticola" della società: William Leycester.  Un giudice appassionato di orticultura Purtroppo su di lui sappiamo meno di quanto vorremo. William Leycester (1775 - 1831), giunto in India quindicenne, nel 1790, inizia la carriera dalla gavetta, come scrivano della Compagnia delle Indie. Nel 1802 è esattore nel Bihar. Forse dal 1804 entra in magistratura. Nel 1809 lo troviamo come magistrato e giudice nel distretto di Moradabad (Uttar Pradesh). Nel 1814 è promosso secondo giudice della corte di giustizia di Bareilly (sempre nell'Uttar Pradesh). Nel 1820 diventa primo giudice sia della corte suprema delle entrate sia dell'alta corte di giustizia, entrambe con sede a Calcutta. In questo ruolo, si trovò a conciliare la legge inglese con quelle musulmane e indù, come possiamo notare da diverse sentenze da lui emesse. Il caso più clamoroso riguarda una bimba dodicenne arrestata per aver evirato l'uomo cui era stata venduta dal fratello e condannata da una fatwa del tribunale musulmano; Leycester ne dispose il rilascio, sostenendo l'inapplicabilità della fatwa a un soggetto di età inferiore a tredici anni, non punibile secondo la legge inglese. Più tardi fu uno dei giudici che si pronunciò contro la pratica (sati) di sacrificare le vedove bruciandole vive sulla pira del marito defunto. Era noto come un giudice preparato e imparziale, e difese la separazione delle funzioni di magistrato e di giudice. Le testimonianze del tempo lo dicono appassionato di orticoltura e botanica. Quella più ampia si deve a Nathaniel Wallich che, proprio nel dedicargli Leycesteria, si espresse in questi termini: "E' con grande soddisfazione che lo dedico al mio stimatissimo amico William Leycester, giudice capo della principale corte nativa della Presidenza del Bengala, che in una lunga serie di anni e in varie parti dell'Indostan distanti tra di loro ha perseguito ogni ramo dell'orticultura con munificenza, zelo e successo tali da assicurargli pienamente questa distinzione". Queste esperienze gli garantirono anche l'elezione alla presidenza dell'Agri-Horticultural Society, incarico che mantenne dalla fondazione nel 1820 al 1829, quando ripresentò la sua candidatura ma non fu rieletto; pare che ci fossero stati dissapori con Carey, ma sicuramente fu determinante la svolta della linea di fondo della società, che dalla vocazione orticola stava ormai virando verso le produzioni agricole e industriali. Non che Leycester si disinteressasse del tutto di queste ultime: come membro del comitato del lino e della canapa nel 1822 presentò uno studio sulle potenzialità delle fibre di tre specie di Musa (M. x sapientum, M. ornata, M. textilis). Ma certo era un convinto sostenitore della linea "orticola" e come presidente la sua maggiore incombenza fu l'organizzazione delle esposizioni annuali, di cui ebbe a lamentare lo scarso numero di partecipanti. Si è già visto che Nathaniel Wallich ne aveva grande stima, tanto che nel 1822, quando dovette lasciare momentaneamente Calcutta per recarsi a Singapore con Raffles, Leycester ne fece le veci. In questa occasione, guadagnò anche una medaglia d'argento della Royal Horticultural Society per "il valido dono di piante, semi e frutti conservarti sotto alcool inviati alla Società dall’Orto botanico di Calcutta”. Dal 1821, era anche membro della Asiatic Society.  Un arbusto dalla bellezza inconsueta Leycesteria è un piccolo genere della famiglia Caprifoliaceae che raggruppa sei o sette specie di arbusti originari dell'Himalaya e dell'Asia temperata, dal Pakistan al Myanmar. Decidui, hanno rami cavi o con midollo solido, foglie opposte con margini interi o serrati, fiori raccolti in infiorescenze a spiga o in giri sovrapposti, spesso con brattee vistose. E' il caso della specie più nota, L. formosa (quella dedicata da Wallich a Leycester), un notevole arbusto con eleganti rami arcuati e fiori penduli bianchi sottesi da brattee viola porpora. In autunno sono seguiti da bacche lucide viola scuro, molto gradite agli uccelli, ma amare per gli esseri umani. Piacciono molto anche ai fagiani, il che ne ha favorito la voga all'epoca vittoriana quando veniva piantata in grandi quantità nelle macchie di arbusti delle grandi tenute per la gioia dei cacciatori. Poi la moda è cambiata e ora è un po' dimenticata; in Inghilterra è ancora abbastanza coltivata, anche se piuttosto che la specie si privilegiano le cultivar. Da noi non è molto diffusa. E' un peccato, perché è una specie inconsueta, attraente, del tutto rustica e poco esigente. D'altra parte, poiché ogni medaglia ha il suo rovescio, in alcuni paesi, come l'Australia, si è rivelata infestante e pone seri problemi di controllo. Le altre specie non sono in genere coltivate, tranne in qualche orto botanico. La più notevole è L. crocothyrsos, originaria delle valle montane dell'Assam; un arbusto spettacolare, ma non rustico, che ostenta vistosi grappoli di fiori giallo-oro. Altre informazioni nella scheda. Il missionario William Carey è una personalità molto nota della storia indiana. Prodigioso poliglotta, tradusse e pubblicò il Vangelo e la Bibbia in molte lingue del subcontinente, creò una tipografia, una rete di scuole, la prima università indiana. Forse è meno noto che era un appassionato botanico e un agronomo sperimentatore, e come tale fu tra i soci fondatori della Società agricola indiana, di cui dettò gli obiettivi. Il suo giardino botanico privato era il più ricco dell'India, secondo solo a quello della Compagnia delle Indie diretto dal suo amico William Roxburgh, a cui Carey donò per altro molte piante. Roxburgh ricambiò con la dedica di Careya, ma Carey lo contraccambio con un inestimabile servizio postumo: la pubblicazione di Flora indica. Una missione rivoluzionaria Nel 1755, la Compagnia danese delle Indie Orientali, in cambio di cinquemila rupie e vari doni, ottenne dal Nawab del Bengala il permesso di commerciare e di stabilire un emporio e un porto. Poté così installarsi a Serampore sulla riva dell'Hoogly, uno dei bracci del delta del Gange, un piccolo centro circondato da villaggi agricoli che già da secoli ospitava un mercato frequentato da portoghesi, olandesi e francesi. Con l'impegno di versare una tassa annuale e di far rispettare la legge e l'ordine, vi creò una minuscola stazione commerciale battezzata Frederiksnagore in onore del re di Danimarca Federico V (anche se è per lo più nota come Serampore). Rispetto a altre città dell'area controllate dalle compagnie francesi e inglesi, era insignificante ma i danesi furono abili a sviluppare attività artigianali e mercantili, attraendo mercanti europei e migliaia di indiani, impiegati soprattutto come tessitori. Nel 1777 l'amministrazione di Serampore passò alla corona danese. Grazie all'abile governatore Ole Bie (1776-1805) la cittadina conobbe un eccezionale sviluppo urbanistico, tanto da essere descritta dai contemporanei come la città più elegante e meglio amministrata dell'India europea. Gli affari andavano a gonfie vele, la presenza danese favoriva lo sviluppo dell'artigianato tessile e incise anche sull'agricoltura: i contadini vennero infatti incoraggiati ad affiancare alla traduzionale coltivazione del riso, quella l'indaco (Indigofera tinctoria), utilizzato nella tintura delle stoffe. Nel 1799 Ole Bie permise a un gruppo di missionari battisti britannici di stabilirsi a Serampore. I primi missionari battisti, John Thomas e William Carey, era arrivati a Calcutta nel 1793, ma avevano dovuto scontrarsi con l'ostilità della Compagnia inglese delle Indie che temeva che la loro attività di proselitismo causasse insanabili attriti con gli indiani; inoltre, come non conformisti con idee sociali avanzate, erano visti come pericolosi sovversivi. Il governatore Bie invece contava su di loro per creare una scuola aperta ai ragazzi tanto indiani quanto europei; per i missionari sarebbe stato un asilo dove iniziare finalmente la sospirata attività di proselitismo. A fondare la missione furono tre energici personaggi, noti come il "trio di Serampore": il maestro Joshua Marsham, il tipografo William Ward e il più famoso di tutti, il reverendo William Carey (1761-1834), una figura così eccezionale che il filantropo William Wilberforce lo definì "una delle principali glorie della nazione britannica", mentre Rabindranath Tagore lo salutò "padre del Bengala moderno". Figlio di un tessitore, nacque in un piccolo villaggio del Northamptonshire dove non esistevano scuole, finché, quando aveva sei anni, suo padre venne assunto dalla parrocchia come funzionario e maestro. Da lui ricevette una sommaria istruzione, rivelando un precoce talento per le lingue (imparò il latino da autodidatta) e un grande interesse per la natura, specialmente per gli insetti e le piante. A quattrodici anni fu collocato come apprendista presso un calzolaio e uno dei suoi compagni lo avvicinò all'ambiente dei dissidenti religiosi. Passò quindi a lavorare per un calzolaio battista; ne abbracciò la fede e ne sposò la cognata, una giovane donna analfabeta. Alla morte del padrone, ne rilevò la bottega; sempre più coinvolto nelle attività della congregazione battista, studiò i testi sacri e imparò da autodidatta altre lingue: il greco, l'ebraico, l'italiano, l'olandese e il francese, sempre con un libro sotto mano mentre fabbricava scarpe. Nel 1785, come mastro si trasferì in un villaggio più grande dove venne invitato a servire come pastore; lo diverrà a pieno tempo nel 1789. Intanto aveva incominciato a interessarsi sempre più alle attività missionarie. Nel 1792 grazie al finanziamento di un amico e correligionario pubblicò An Enquiry into the Obligations of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens, un vero e proprio manifesto in cui sostenne che ogni cristiano deve farsi apostolo del messaggio di Cristo. Lo stesso anno fu tra i fondatori della Società battista per la propagazione del Vangelo (poi nota come Baptist Missionary Society) e nel 1793, con la moglie e i figli, partì per l'India insieme al medico John Thomas. Pensava di mantenersi come agricoltore e portò con sé bulbi e semi di piante orticole e alimentari; anche in questo campo era un colto autodidatta: conosceva la classificazione linneana, e aveva una certa esperienza di raccolta sul campo. Giunto in India nel novembre 1793, venne a sapere che in seguito alla morte del colonnello Kyd il posto di intendente del giardino della Compagnia delle Indie era vacante. Si precipitò a Calcutta per presentare la sua candidatura, ma scoprì che era già stato designato William Roxburgh. La cosa non lo amareggiò, anzi andò a fargli visita: fu l'inizio di una grande amicizia. Carey scoprì ben presto che, a causa dell'ostilità della Compagnia delle Indie, gli era impossibile predicare; anche Thomas abbandonò l'impresa. Grazie a un amico, fu assunto come sovrintendente di una piantagione di indaco a Madnabati, dove visse per sei anni. Fu così testimone della miserevole condizione dei contadini indiani e si convinse che fosse compito degli inglesi risollevarla introducendo strumenti migliori e nuove coltivazioni. Vi creò un orto botanico e come l'amico Roxburgh, fece molti esperimenti agricoli. Scriveva agli amici in Inghilterra per ottenere pianticelle di piante da frutto e semi di ortaggi; da Roxburgh ebbe alberi di cannella, noce moscata, teak; a sua volta gli inviava esemplari che raccoglieva in natura. Tra di essi l'albero di sal, che nel 1798 Roxburgh pensò di dedicargli con il nome di Careya saulea. Carey respinse l'omaggio, sia per modestia sia nella convinzione che le piante debbano conservare i nomi indigeni; in effetti, le sue proteste furono accolte e la pianta fu rinominata Shorea robusta (dal nome sanscrito sarja). Furono anni durissimi che gli costarono la perdita di un figlio di cinque anni e l'alienazione mentale della prima moglie. Non aveva certo dimenticato lo scopo per cui era venuto in India; si preparò alla missione imparando il sanscrito e il bengali e tradusse in quest'ultima lingua il nuovo testamento. Dall'Inghilterra giunsero altri confratelli, in particolare Marsham e Ward che nel 1799 lo precedettero a Serampore; acquistarono una grande casa che doveva ospitare sia le loro famiglie sia i locali della scuola. Carey con la moglie e i figli superstiti li raggiunse all'inizio del 1800 portando con sé una macchina da stampa procuratagli dal proprietario della piantagione di Madnabati. Ad occuparsi della scuola furono soprattutto Joshua Marsham e sua moglie Hannah: era aperta a tutti, senza badare alla religione o alla casta: fu l'inizio di una vasta rete di scuole in lingua bengali che nel 1818 ne contava 92 frequentate da 10.000 alunni. Intanto anche la Compagnia delle Indie incominciava a convincersi che i missionari di Serampore non costituivano un pericolo, anzi potevano tornare utili per dare una patina di credibilità alla sua immagine offuscata. Nel 1801 il governatore Wellesley lo chiamò a insegnare bengali al Fort William College, una scuola dove i funzionari della Compagnia studiavano le lingue, le culture, le tradizioni e la storia dell'India. Continuò a dedicarsi con zelo allo studio del maggior numero possibile di lingue indiane e alle traduzioni e insieme a Ward creò una casa editrice, che iniziò la sua attività con la stampa del Nuovo testamento in bengali da lui tradotto; seguirono il Nuovo testamento in sanscrito, in marathi, in panjabi, e l'intera Bibbia in bengalese. Entro il 1835, l'anno successivo alla morte di Carey, la Bibbia era stata tradotta e stampata in non meno di 42 lingue e dialetti. Ma non si pubblicavano solo testi religiosi: nello stesso arco di tempo, la casa editrice giunse a stampare oltre 200.000 volumi: c'erano classici della tradizione indiana come il Mahabaratha e il Ramayana, grammatiche, lessici e dizionari per l'uso del Fort William College, ma anche - come vedremo meglio tra poco - testi scientifici. A partire dal 1818 venne anche pubblicato un quotidiano bilingue, in inglese e bengali. Anche se nel 1812 un devastante incendio distrusse manoscritti, carta, set di caratteri tipografici, le macchine da stampa si salvarono; la tipografia rimase ufficialmente attiva fino al 1837, ma anche dopo questa data uscì ancora occasionalmente qualche volume. Nel 1818 Carey, Marsham e Ward fondarono il Serampore College, destinato sia ai futuri pastori, sia a studenti di "ogni casta, colore o paese". Posto inizialmente sotto la giurisdizione danese, quindi passato sotto controllo britannico dal 1845, è considerato la prima università indiana, di cui ha costituito un duraturo modello. 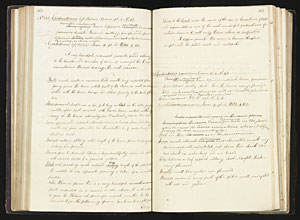 Carey e Roxburgh: una collaborazione fraterna Per Carey, la coltivazione di un giardino era una passione, un svago salutare per la mente e il corpo, ma lo studio delle scienze naturali aveva anche un risvolto religioso: la lettura del libro della natura avvicina a Dio quanto quella della Bibbia. Al suo arrivo a Serampore, portò con sé le piante che coltivava a Madnabati e creò un orto botanico privato; più tardi, quando in seguito a dissidi con la casa madre in Inghilterra lasciò la Baptist Missionary Society e si trasferì nel College, vi spostò anche il giardino. Misurava cinque acri, vantava una collezione di migliaia di piante (seconda solo a quella del giardino di Calcutta della Compagnia delle Indie), quattro vasche per le piante acquatiche, voliere per gli uccelli. Dopo la sua morte (1834), divenuto giardino del Serampore College, fu posto sotto la direzione di Joachim Otto Voigt, che ne scrisse il catalogo, insieme a quello dell'orto botanico di Calcutta (Hortus suburbanus Calcuttensis, 1845). Alcune piante erano state raccolte dallo stesso Carey, molte le aveva ottenute dai suoi corrispondenti, molto numerosi tanto in India quanto all'estero, grazie alla rete delle missioni e ai suoi contatti con studiosi, proprietari terrieri e filantropi indiani. Collezionava anche acquarelli di piante e insetti dipinti da artisti indiani, di alcuni dei quali fece dono alla Linnean Society di Londra di cui divenne membro nel 1823. Fin dai tempi di Madnabati, era molto interessato ai risvolti pratici della botanica e all'agricoltura; per sostenere la missione, progettò una piantagione di alberi da legname, cui dovette rinunciare perché la Compagnia delle Indie non concesse i terreni. Nel settembre 1820, su sollecitazione di lady Hastings, la moglie del governatore generale dell'India, insieme a Joshua Marsham e altri due europei fondò l'Agricultural and horticultural society of India, che entro un mese, posta sotto il patronato di lord e lady Hastings, che concessero anche un terreno sperimentale a Barrackpore, contava già cinquanta soci, metà europei e metà indiani. Gli obiettivi della società, fissati dallo stesso Carey, includevano il miglioramento dei terreni, tramite metodi di coltivazione più avanzati, incluse le più efficienti tecniche di rotazione delle culture; l'introduzione di nuove piante utili; il miglioramento delle attrezzature; il miglioramento degli animali agricoli; la bonifica e la coltivazione dei terreni abbandonati. Fin da quando si conobbero nel 1793, la collaborazione tra Carey e William Roxburgh fu strettissima. Il missionario considerava il suo stesso giardino quasi una succursale dell'orto botanico di Calcutta cui donò non meno di ottanta esemplari. Tra di essi, forse il più notevole è l'himalayana Rosa clinophylla (che Roxburgh chiamava R. involucrata) da lui spedita al giardino di Calcutta nel 1797; negli anni venti, ne inviò un esemplare anche a Hooker, all'epoca direttore dell'orto botanico di Glasgow. Nel 1813, quando Roxburgh, lasciò l'India nella speranza di recuperare la salute (sarebbe purtroppo morto poco più di un anno dopo) gli affidò due manoscritti: il catalogo dell'orto botanico di Calcutta Hortus Bengalensis e la sua monumentale Flora indica. Il primo fu pubblicato dalla tipografia di Serampore già nel 1814, con una prefazione dello stesso Carey. Durante il suo servizio in India (dal 1773 al 1813, interrotti solo da due brevi soggiorni in patria) Roxburgh descrisse circa 2600 specie, e di circa 2500 fece preparare i disegni. Nel 1795, quando da poco si era trasferito a Calcutta, una selezione di cento piante da lui raccolte in Cormandel fu pubblicata a spese della Compagnia delle Indie nel primo volume di Plants of the Coast of Coromandel, sotto la direzione di Joseph Banks e con la prefazione di Patrick Russell. Seguirono, a lunghi intervalli di tempo, altri due volumi, in tutto trecento piante; l'ultimo uscì nel 1819, dopo la morte di Roxburgh. Negli anni di Calcutta, quest'ultimo aveva continuato a lavorare alla sua Flora indica, un grosso manoscritto con 2542 descrizioni botaniche di cui preparò due copie. Per prudenza, tornando in patria una la portò con sé, con l'intenzione di completarla e prepararla per la stampa, l'altra la affidò a Carey. Durante il viaggio, aggiunse ancora alcune descrizioni, e inviò copia anche di queste a Carey. Le gravi condizioni di salute e la morte però gli impedirono di attuare il suo proposito. Non trovandosi in Inghilterra nessuno disposto a pubblicarlo (Plants of the Coast of Coromandel, tre volumi in folio con illustrazioni a piena pagina, si era rivelato costosissimo), Carey decise di stamparlo nella tipografia di Serampore. Con l'aiuto di Nathaniel Wallich (assistente di Roxburgh e suo successore alla testa dell'orto botanico di Calcutta dal 1817) che aggiunse le sue note, ne pubblicò una parte in due volumi, usciti rispettivamente nel 1820 e nel 1824. Nel 1832, su richiesta dei figli di Roxburgh, visto che ancora mancava un'edizione inglese, pubblicò l'intera opera in tre volumi, questa volta senza le note di Wallich. Tanto la prima edizione parziale, quanto la seconda edizione integrale per ragioni di costi furono stampate senza illustrazioni. Anche così, è un'opera fondamentale, fondativa della botanica indiana, di cui Roxburgh è considerato il padre.  Un albero dai molti usi Se Carey aveva rifiutato la dedica dell'albero di sal, dovette accettare un secondo omaggio di Roxburgh che nel 1811 nel secondo volume di Plants of the Coast of Coromandel gli intitolò il genere Careya sulla base di un esemplare di C. erbacea, raccolto dal missionario in Bengala e da lui inviato all'orto botanico di Calcutta; Roxburgh ricorda queste circostanze e aggiunge "nominata per il suo scopritore, un buono botanico, e un promotore della storia naturale in generale". Se avesse dovuto far propria la propensione di Carey per le denominazioni indigene, avrebbe dovuto chiamarla Kumbhaadu-lataa. Il genere Careya (famiglia Lecythidaceae) comprende tre specie, distribuite tra Afghanistan, isole Andamane, subcontinente indiano, Indocina e Malaysia. C. herbacea è un'erbacea perenne diffusa dalle pendici himalayane al Bengala; C. valida, un albero endemico delle isole Andamane. La specie più nota è però C. arborea, anch'essa descritta da Roxburgh. E' un bell'albero da medio a grande, deciduo, con le foglie che diventano rosse prime della caduta. Produce vistosi fiori a coppa crema o bianco verdastro con lunghissimi stami e filamenti sterili, porpora o soffusi di rosso alla base. All'epoca del Raj, la sua corteccia fibrosa veniva usata per gli stoppini dei fucili. Nella medicina tradizionale indiana, la corteccia e i fiori, ricchi di mucillaggini, trovano impiego per le loro proprietà astringenti. In Myanmar le grandi foglie vengono usate per fabbricare i tradizionali sigari detti cheroot, ma fermentate entrano in alcune specialità culinarie. In Tailandia invece le foglie giovani e i boccioli si consumano freschi in insalata. Il frutto è edule (tanto che l'albero è noto come guaiava selvatica) ma si ritiene che i semi siano lievemente tossici. A pochi km da Bangalore, capitale del Karnataka, si trova uno spettacolare giardino, Lalbagh (un nome spiegato in vari modi, forse "giardino rosso"). Nato come giardino reale nel 1760, passò attraverso varie vicissitudini, finché nella seconda metà dell'Ottocento divenne orto botanico governativo. All'inizio del secolo, subito dopo la conquista inglese, era stato diretto per qualche anno dal medico e botanico tedesco Benjamin Heyne; vissuto per quasi trent'anni in India, fece importanti raccolte e fu il primo a notare un fenomeno connesso con il metabolismo acido delle Crassulaceae. A ricordarlo il piccolo genere Heynea. Piccola storia del "giardino rosso" Come abbiamo già visto parlando di Johann Gerhard König, l'avamposto danese di Tranquebar funzionò in un certo senso da fucina di naturalisti che poi passarono al servizio della Compagnia delle Indie. E' il caso anche del medico tedesco Benjamin Heyne (1770-1819) che però, al contrario di König, era venuto in India non per lavorare alla missione luterana di Halle, ma alla "rivale" missione morava. Heyne arrivò in India nel gennaio del 1792, ventiduenne. Nato a Döbra in Sassonia, probabilmente non molto prima di partire si era laureato in medicina a Dresda. Forse viaggiò da Copenhagen a Tranquebar in compagnia di un altro giovane collega, Johann Gottfried Klein, figlio di uno dei pastori della missione luterana, Jakob Klein. Nato in India, il giovane Klein era stato mandato in Germania a studiare medicina e ora tornava a casa per diventare medico della missione. Anche se uno dipendeva dai moravi, l'altro dai luterani, due medici missionari erano troppi per quel piccolo avamposto. Heyne trovò difficile sbarcare il lunario, tanto che pensò di tornare in Germania. Sarebbe stato un peccato, pensò Christoph Samuel John (1746-1813), il pastore-capo della missione luterana; buon amico di König e Roxburgh, era anch'egli un notevole naturalista e aveva potuto apprezzare le vaste competenze di Heyne soprattutto nel campo della botanica e della mineralogia. Nell'agosto 1783 scrisse a Roxburgh per chiedergli di raccomandarlo alla Compagnia delle Indie. Roxburgh lo prese con sé nel giardino della Compagnia a Samalkot, a circa 200 km a nord di Madras, dove egli sperimentava la coltivazione di piante industriali e alimentari. Un mese dopo Heyne vi si traferì e a ottobre la sua assunzione fu approvata dalla Compagnia. Pochi mesi dopo, nel marzo 1794, quando il botanico scozzese fu nominato sovrintendente dell'orto botanico di Calcutta, lo sostituì "come Botanico della Compagnia durante l'assenza del Dr. Roxburgh". Nel 1796, l'incarico gli fu confermato ufficialmente, insieme alla nomina ad assistente chirurgo. In questi anni, Heyne fece cospicue raccolte e fece eseguire numerosi acquerelli botanici da artisti locali (Plants of the Coromandel coast: a collection of 394 botanical watercolour drawings of plants and flora), che tuttavia non vennero mai pubblicati. Nel 1799, dopo la presa di Mysore, gli fu ordinato di unirsi alla ricognizione del territorio appena conquistato. Se all'inizio l'obiettivo fondamentale di quello che è passato alla storia come Mysore Survey (1799-1810) era procedere al rilievo trigonometrico della regione al fine di disegnarne una carta aggiornata, presto divenne un'indagine a tutto campo, che prevedeva di raccogliere ogni sorta di informazione (e di materiale) sulla storia, l'archeologia, la religione, i costumi, le arti, le risorse naturali, l'industria, i commerci. I ricognitori, che comprendevano interpreti, disegnatori, cartografi, vennero divisi in tre squadre, capeggiate rispettivamente dall'ingegnere militare Colin Mackenzie, dal geografo Francis Buchanan Hamilton e appunto da Benjamin Heyne. Come botanico e naturalista, doveva studiare la flora, la fauna, le produzioni agricole; come geologo, le risorse minerarie e le tecniche industriali (tra l'altro, si occupò della produzione della soda e delle manifatture di rame e ferro); come medico, che aveva studiato i testi medici tamil, doveva verificare la disponibilità nei mercati di medicinali per l'esercito della Compagnia, specialmente per combattere la malaria, il principale ostacolo all'espansione britannica in India. Quanto alla botanica, le istruzioni del governatore generale Wellesley puntualizzavano: "Bisogna assolutamente privilegiare le piante utili rispetto a quelle che si raccomandano solo per la loro rarità o la loro bellezza [...]. Occorre raccogliere con cura tutto ciò che è connesso alle arti e alle produzioni di questo paese, o che promette di essere utile al nostro; prestare la dovuta attenzione al legname impiegato nelle varie province che toccherà nel suo percorso [...] e raccogliere con particolare diligenza le preziose piante legate alla sua professione immediata, cioè alla medicina". Il governatore aggiunse un compito specifico: trovare una sede più adatta di Samalkot per il giardino botanico della Compagnia nella presidenza di Madras. La scelta di Heyne cadde su un giardino già esistente: quello di Lalbagh nei pressi di Bangalore. A farlo costruire, intorno al 1760, fu il sultano di Mysore Hyder Alì che si inspirò al modello dei giardini Moghul, in particolare quello di Sira. Esteso su 40 acri, comprendeva una serie di ambienti squadrati, separati da viali, sentieri e canali alimentati da una cisterna. Era sia un giardino di piacere, sia un orto-frutteto. Nelle aiuole fiorivano una profusione di rose e altri fiori rossi, che potrebbero aver dato il nome al giardino (Lalbagh potrebbe significare "giardino rosso", ma anche "giardino prediletto"). Lungo i viali erano piantati cipressi. C'erano specchi d'acqua con loti e diversi frutteti, ciascuno dedicato a diversa varietà di alberi: tra gli altri, banani, melograni, papaye, jackfruit, fichi. Il giardino fu ulteriormente arricchito dal figlio e successore Tipu Sultan, che vi fece piantare alberi di mango (si dice che qualcuno ancora sopravviva) e ogni sorta di alberi e fiori rari, fatti venire dall'Afghanistan, dalla Persia, dalla Turchia e dall'isola di Mauritius. Dato che l'acqua della cisterna era insufficiente per irrigare il giardino, fece anche costruire un pozzo. Tipu morì nel maggio del 1799 mentre tentava di difendere la sua capitale dall'assalto dell'esercito della Compagnia delle Indie. Il regno di Mysore divenne uno stato satellite dell'impero anglo-indiano e vari distretti passarono direttamente alla Compagnia, che già nel corso della guerra aveva fissato il quartier generale del proprio esercito a Bangalore. La bellezza del giardino non lasciò insensibili i britannici, che inizialmente però lo utilizzarono soprattutto per coltivare patate, cavoli, rape ed altri ortaggi per il rancio delle truppe. Nel 1802 Heyne venne ufficialmente promosso "Botanico della Compagnia" e da quell'anno al 1808 diresse Lalbagh, lavorando duramente per riportarlo alla sua bellezza e trasformarlo in un vero orto botanico; vi trapiantò le piante del giardino di Samalcot, dismesso dalla Compagnia. Molte piante le raccolse egli stesso, soprattutto nei distretti di Bangalore e Combatore; gli è accreditata la scoperta di circa 350 specie. Spedì molti esemplari al botanico tedesco Albrecht Wilhelm Roth, che se ne servì per Novae plantarum species praesertim Indiae orientali, che dipende in gran parte dalle raccolte di Heyne. Nel maggio del 1808 l'incarico di "Botanico della Compagnia" fu soppresso. Siamo poco informati sui movimenti di Heyne in questo periodo; secondo alcuni rimase a dirigere Lalbagh fino al 1812, secondo altri la lasciò appunto nel 1808. Sappiamo invece con certezza perché lo riferisce egli stesso che nel 1811, essendo la sua salute compromessa dopo vent'anni in India, ottenne dalla Compagnia un congedo di tre anni. Si recò quindi a Calcutta per salutare Roxburgh, ma anche nella speranza di trovare un ingaggio come medico di bordo di una nave in partenza per l'Inghilterra. Non lo trovò, ma in compenso poté imbarcarsi su un mercantile diretto a Sumatra, dove fece qualche raccolta. Solo nel 1813 poté raggiungere Londra, dove fu ammesso alla Linnean Society alla quale presentò le sue osservazioni su Cotyledon calycina (oggi Kalanchoe pinnata): assaggiandone le foglie, egli aveva notato che di primo mattino erano fortemente acide; con il passare delle ore, perdevano la loro acidità, finché verso mezzogiorno erano totalmente prive di sapore. Si tratta della prima descrizione dei fenomeni connessi alla fotosintesi CAM (Metabolismo acido delle Crassulaceae): oggi sappiamo che molte piante succulente dei climi caldi e aridi di notte aprono gli stomi - chiusi di giorno per limitare la traspirazione - consentendo l'ingresso dell'anidride carbonica che va a formare acidi carbossilici, i responsabili di quel gusto "aspro come l'acetosella, se non di più" osservato da Heyne. Approfittò del soggiorno londinese anche per pubblicare la sua opera principale, Tracts, historical and statistical, on India: with journals of several tours through various parts of the peninsula: also, an account of Sumatra, in a series of letters, che contiene il resoconto delle sue esplorazioni dell'India e di Sumatra; a fare la parte del leone, però, più che la botanica sono la geologia, la mineralogia e le tecniche industriali tradizionali. L'opera anche una delle prime mappe geologiche dell'India meridionale. Terminato il suo congedo, già nella primavera del 1815 Heyne rientrò a Madras, dove riassunse l'incarico di naturalista e botanico della Compagnia delle Indie. Il breve soggiorno in Europa non era stato sufficiente a restituirgli la salute, visto che morì nel 1819, ad appena 49 anni. Come si capisce tra le righe anche da Tracts, historical and statistical on India, almeno negli ultimi anni le sue relazioni con la Compagnia non dovette essere idilliache. Nel 1807 quest'ultima aveva nominato custode di Lalbagh il proprio ufficiale pagatore, il capitano - e più tardi maggiore - Gilbert Waugh, e, come abbiamo già visto, nel 1808 soppresse l'incarico di botanico di Heyne. E' dunque probabile che egli non sia rimasto a Bangalore. Del resto, sappiamo che la gestione di Waugh non lasciava spazio a coabitazioni; egli prese il controllo assoluto del giardino che ben presto fu noto come "giardino di Waugh"; interessato agli aspetti pratici della botanica, introdusse coltivazioni sperimentali di canna da zucchero e caffè. Nel 1814, il giardino passò sotto il controllo del governo di Mysore, che prese a eliminare gli alberi per lasciare spazio a un grande orto. Preoccupato, Waugh scrisse a lord Hastings, il governatore generale dell'India, proponendo che il giardino fosse posto sotto la giurisdizione dell'orto botanico di Calcutta. Consigliato in tal senso da Nathaniel Wallich che riteneva che Lalbagh potesse diventare "un vivaio di passaggio o un deposito per l'introduzione e l'acclimatazione di piante da frutto in Inghilterra", Hastings accettò. Troppo impegnato a Calcutta, Wallich dovette limitarsi a qualche visita e la soluzione giovò poco al giardino di Bangalore (le due città per altro sono lontanissime). La situazione si protrasse fin al 1831 quando, con la fine dello stato fantoccio di Mysore, anche il giardino passò sotto il controllo governativo. Affidato per qualche anno all'effimera Società agricola dell'India, fu rilanciato solo a partire del 1856, quando divenne ufficialmente Government Botanical Garden e fu affidato alla direzione di un botanico di Kew, William New. Nel 1899, in occasione della visita del nipote della regina Vittoria Albert Victor (che pose la prima pietra), venne costruita una grande serra ispirata al Crystal Palace di Londra, che è ancora la maggiore attrazione del giardino. Oggi, con un'estensione di 240 acri, continua ad essere uno dei più vasti e importanti giardini dell'India; anche se non ha più la funzione di orto botanico, ma piuttosto di parco, è famoso sia per la rarità delle collezioni sia per il pregio estetico, che con le sue fontane e i suoi specchi d'acqua richiama le origini, il "giardino rosso" di Hyder Alì.  Una dedica amichevole Benjamin Heyne entra a fare parte della nostra galleria di dedicatari di generi botanici grazie all'amico William Roxburgh che nel 1815 denominò in suo onore Heynea trijuga un albero nativo del Nepal i cui semi erano stati spediti all'orto botanico di Calcutta da un altro comune conoscente, Francis Buchanan. La dedica ricorda che "il Dr. Heyne per molti anni ha prestato grande attenzione alla storia naturale dell'India; recentemente è tornato al servizio della Compagnia. Per il suo talento e la sua industriosità possiamo attenderci molte altre utili informazioni". Come sappiamo, la morte gli impedì di soddisfare queste lusinghiere aspettative. Heynea, della famiglia Meliaceae, comprende solo due specie, appunto H. trijuga e H. velutina; la prima è un piccolo albero, diffuso dal subcontinente indiano alla Malesia, il secondo un arbusto diffuso dalla Cina meridionale all'Indocina. Hanno foglie disposte a spirale e minuti fiori bisessuali con quattro-cinque petali imbricati disposti in tirsi, seguiti da frutti a capsula, che contengono uno-due semi avvolti in un arillo. Quelli di H. trijuga vengono raccolti per ricavarne olio illuminante. Questa specie, la nota delle due, di crescita veloce e con una chioma espansa e densa, nella Thailandia settentrionale trova impiego nella riforestazione di aree disturbate, anche perché i frutti sono molto apprezzati da uccelli e pipistrelli, favorendo la dispersione dei semi. Di notevole bellezza, è anche coltivato nei giardini. Le foglie e la corteccia, di gusto amaro, sono utilizzate nella medicina tradizionale. Altre informazioni nella scheda. Nel 1740, lo scozzese Alexander Russell prende servizio ad Aleppo come medico della stazione commerciale della Compagnia del Levante. Vi rimarrà 14 anni, stabilendo ottime relazioni con la variegata e multietnica comunità della città siriana e tutto osservando con occhio libero da ogni pregiudizio. Al suo ritorno in patria, scrive The Natural History of Aleppo. Il libro, improntato agli ideali illuministi, con la sua miriade di informazioni spesso di prima mano su zoologia, botanica, meteorologia, medicina e quella che oggi chiameremmo antropologia, desta un profondo interesse tra gli intellettuali europei e già nel 1760 gli guadagna la dedica del genere Russelia. Ma qui è impossibile non parlare anche del fratello minore Patrick. Di dodici anni più giovane, fin dal 1750 raggiunge Alexander ad Aleppo, quindi ne prende il posto e rimane in Siria per più di vent'anni, guadagnandosi l'unanime stima di locali ed europei. Come medico, studia l'inoculazione del vaiolo e le ricorrenti pestilenze che affliggono la città e diviene un grande esperto di malattie epidemiche e dei metodi per prevenirle. Tornato in patria nel 1771, nel 1781, rispondendo all'appello di un terzo fratello, Claud, lo raggiunge in India. Nel 1785, succede a Johann Gerhard König come naturalista della Compagnia delle Indie; importantissimi saranno i suoi contributi alla conoscenza della flora e della fauna indiane. Il principale frutto delle sue ricerche è An Account of Indian Serpents Collected on the Coast of Coromandel. Nel 1794 pubblica anche un'edizione rivista di Natural History of Aleppo. Un medico scozzese ad Aleppo Nel 1740, per prendere servizio come medico della stazione commerciale (factory) della Compagnia del Levante, giunse ad Aleppo lo scozzese Alexander Russell (ca. 1715-1768). Arrivava da Edimburgo, una città tutt'altro che provinciale, e conosceva Londra, ma non poté che innamorarsi di quella bellissima, ordinata, vivace e prospera città multietnica: "Le moschee, i minareti e numerose cupole formano uno splendido spettacolo, e i tetti piatti delle case situate sulle colline, sorgendo una dietro l'altra, presentano una successione di terrazze sospese, intervallate da cipressi e pioppi". Situata al crocevia tra la via della seta, che collegava l'Impero ottomano con la Cina attraverso l'Asia centrale e la Persia, e la via della spezie, che lo congiungeva con l'India attraverso lo Yemen e la penisola arabica, era la terza città più popolosa dell'Impero, dopo Istanbul e il Cairo. Nelle botteghe del suo suq, uno dei più vasti del mondo, accanto ai prodotti agricoli e ai manufatti locali, come il pregiato sapone d'Aleppo, era possibile acquistare prodotti d'ogni genere e di ogni provenienza: ceramiche e sete cinesi, tappeti e stoffe dell'Asia centrale, metalli persiani, pepe indiano, avorio africano, vetri veneziani. Luogo nevralgico delle strade commerciali che collegavano l'Oriente con i porti del Mediterraneo, fin dal Medioevo Aleppo era frequentata dai mercanti europei, che vi avevano creato empori o stazioni commerciali. Gli inglesi della Compagnia del Levante vi si erano stabiliti verso la fine del Cinquecento e ne avevano fatto la loro principale piazza commerciale. Commerciavano soprattutto tessuti: acquistavano sete persiane e vendevano panni di lana inglesi. Il momento d'oro era durato circa un secolo, ma quando Russell giunse ad Aleppo era già finito: il Mediterraneo e le vie di terra avevano perso la loro centralità rispetto alle rotte oceaniche che ora collegavano in modo diretto la Gran Bretagna con l'India o la Cina; le guerre tra la Russia e la Persia avevano interrotto il flusso delle merci persiane; la Russia stessa aveva aperto nuove vie commerciali che facevano concorrenza alla Compagnia. Mal gestita, sull'orlo della bancarotta, quest'ultima era ormai una realtà residuale, tanto che nel 1754 (per coincidenza, lo stesso anno in cui Russell lasciò la città) la corona le tolse il monopolio del commercio con l'impero ottomano, aprendolo al commercio libero. Ma nel 1740 si godevano ancora gli ultimi barlumi di prosperità. La Compagnia coordinava l'attività di una quarantina di mercanti, disponeva di magazzinieri, facchini, interpreti o dragomanni e di un piccolo staff costituito da un console (che all'occasione agiva anche come diplomatico), un viceconsole, un tesoriere, un cappellano e, appunto, un medico, alloggiati nel caravanserraglio Khan al-Gumruk. Quando arrivò ad Aleppo, Alexander aveva venticinque anni. Era il terzo figlio di un noto avvocato di Edimburgo, aveva ricevuto un'ottima educazione classica e tra il 1734 e il 1735, anche se non aveva conseguito la laurea, aveva seguito i corsi del prestigioso professore Alexander Monro primus, allievo di Boerhaave e esponente della "nuova medicina". Edimburgo era una città intellettualmente vivace, aperta al nuovo non solo nel campo medico, la culla dell'illuminismo scozzese i cui ideali sono ben riconoscibili anche in Alexander Russell: umanitarismo, convivialità sociale, tolleranza religiosa, apertura al diverso, fiducia nella ragione; i suoi maestri gli avevano trasmesso un metodo rigoroso basato sull'osservazione attenta, l'oggettività, la verifica empirica. Nel 1734 Alexander fu uno dei primi membri della Medical Society di Edimburgo; poi forse lavorò come praticante con uno zio chirurgo o come chirurgo navale; certo al suo arrivo ad Aleppo era un medico competente che seppe farsi apprezzare non solo dai dipendenti della Compagnia ma da clienti di ogni provenienza sociale e di ogni etnia e religione: franchi, ovvero europei, greci, turchi ottomani, armeni, ebrei, cristiani siriaci. Presto imparò l'arabo, che parlava fluentemente, e si fece una vasta clientela; era ben accolto in ogni ambiente e si guadagnò la stima di Mehmet Raghib Pasha, il governatore di Aleppo, che gli concesse di praticare la dissezione dei cadaveri e lo nominò medico capo. Nel 1742 in città scoppiò una delle ricorrenti epidemie di peste; Russell ne studiò i sintomi, ne ricercò le cure e le cause e prese a registrarne l'andamento in un diario. Era il primo nucleo di quella che sarebbe diventata Natural history of Aleppo: dagli argomenti propriamente medici, la sua attenzione si allargò al clima, agli animali selvatici e domestici, alle piante non solo medicinali, ai giardini, ai monumenti, agli abitanti, ai loro costumi, ai luoghi di ritrovo, ai commerci. In campo medico, il suo contributo più importante è lo studio della leishmaniosi, di cui diede la prima descrizione in Occidente. Tra gli animali descritti per la prima volta da Alexander, il criceto dorato Mesocricetus auratus, antenato di molti criceti di allevamento. Nel 1750 Alexander fu raggiunto dal fratellastro Patrick (1727-1805), fresco di laurea in medicina appena conseguita ad Aberdeen. Figlio della terza moglie del padre, gli era minore di dodici anni. Anche lui era allievo di Monro I, ma aveva potuto anche seguire i corsi di Francis Home, il primo professore di Materia medica a Edimburgo. Era un naturalista più completo di Alexander e, come quest'ultimo riconosceva apertamente, la sua competenza botanica era ben maggiore della sua. Grazie alla sua assistenza, che ne aveva anche alleggerito i compiti quotidiani, Alexander incominciò ad esplorare in modo più sistematico la flora dei dintorni di Aleppo, deciso a redigerne una lista completa. Delle raccolte botaniche dei due fratelli (Patrick ne ricavò un erbario) si giovarono anche gli amici londinesi, cui essi inviavano semi ed esemplari essiccati. Nel 1754 sulle montagne tra Aleppo e Lataika Alexander raccolse semi di Convolvolus scammonia, di cui inviò i semi a John Fothergill, suo condiscepolo ad Edimburgo e il più stretto dei suoi amici, insieme a una lettera in cui descriveva la pianta e i metodi di raccolta, più tardi pubblicata nella rivista della Medical Society di Londra. Si trattava infatti di una specie di notevole interesse medico, perché dalle sue radici si ricava una resina purgativa, nota come scammonea, che veniva esportata dalla Siria sotto forma di pani ed era soggetta a frequenti adulterazioni. Dopo il rientro a Londra, ne diede alcuni semi anche a John Ellis, che ne informò Linneo. Lo stesso anno raccolse semi del bellissimo corbezzolo greco Arbutus andrachne e ne inviò i semi sia a Fothergill sia all'amico comune Peter Collinson, che li seminarono nei loro giardini; Collinson li passò anche all'abile vivaista James Gordon, notoriamente infallibile nelle semine di arbusti. Il primo a fiorire fu l'esemplare coltivato nei giardini di Fothergill, dove nel 1766 Ehret lo immortalò. All'epoca Alexander si trovava già a Londra. Nel 1754 lasciò Aleppo e rientrò in Inghilterra, passando dall'Italia dove visitò i lazzeretti di Napoli e Livorno. Nel febbraio 1755 era a Londra dove, sollecitato da Fothergill, si dedicò alla preparazione per la stampa di The natural history of Aleppo, and parts adjacent; uscita nel 1756, l'opera era un bel volume in quarto arricchito dalle incisioni di vari artisti, tra cui Ehret e John Miller; in uno stile vivace e spontaneo, offriva una miriade di informazioni di prima mano che spaziavano dalla flora e la fauna al clima, dai monumenti cittadini ai caffè, dalla musica alla vita sociale delle diverse comunità aleppine, senza dimenticare ovviamente lo studio delle malattie epidemiche. Il libro ottenne un notevole successo e lo stesso anno Alexander fu ammesso alla Royal Society. Egli stesso ne era però insoddisfatto e pensava già a una seconda edizione; ma i crescenti impegni professionali e familiari glielo impedirono. Si sposò, ottenne la laurea formale all'università di Glasgow (sempre che non l'avesse conseguita in absentia mentre si trovava ad Aleppo), divenne consulente del governo per la prevenzione delle epidemie, nel 1760 fu ammesso al Royal College of Physicians e assunto come medico del St Thomas Hospital, un incarico che comportava anche l'insegnamento ai praticanti. Grande esperto di malattie epidemiche, che aveva affrontato senza paura durante gli anni di Aleppo, mettendo sempre il bene dei suoi pazienti al primo posto, fu egli stesso vittima di un'epidemia, quella di febbri putride che imperversò a Londra nel 1768.  Medico e naturalista in Siria e in India Patrick era rimasto ad Aleppo e aveva preso il posto del fratello come medico della Compagnia del Levante. Abbiamo già visto che era un naturalista più completo del fratello maggiore; come lui era un gentiluomo amabile e un conversatore piacevole. Era dotatissimo per le lingue e si inserì presto nella società aleppina. Anche la sua competenza di medico non fece rimpiangere quella del fratello, anzi la superò. Il Pasha lo stimava tanto da permettergli di indossare il turbante, un simbolo di prestigio raramente concesso agli europei. Tra il 1760 e il 1762 la peste tornò a più riprese ad Aleppo; Patrick ne studiò attentamente le manifestazioni e introdusse metodi di prevenzione, come proteggere bocca e naso con un fazzoletto imbevuto d'aceto. Raccolse le sue osservazioni in un trattato sulla peste, che avrebbe pubblicato molti anni dopo. Ma i suoi interessi erano ancora più vasti di quello del fratello: la conoscenza approfondita dell'arabo gli permise di studiare i testi medici medievali, di raccogliere manoscritti, di interessarsi di letteratura e di musicologia. Sia per interesse personale, sia per contribuire alla seconda edizione di Natural history of Aleppo, proseguì l'opera del fratello, continuando a raccogliere informazioni che inviava nelle sue lettere ad Alexander; due di queste lettere, rispettivamente sui terremoti in Siria e sull'inoculazione del vaiolo furono poi stampate nelle Transactions della Royal Society. Ad Alexander e ai corrispondenti londinesi inviava anche semi e esemplari di piante. I due fratelli non si sarebbero mai rivisti. Patrick infatti lasciò Aleppo solo nel 1771, rientrando in patria nel 1772, quattro anni dopo la morte di Alexander. Inizialmente pensava di stabilirsi ad Edimburgo, ma fu convinto da Fothergill a trasferirsi a Londra. Incominciò subito a lavorare alla seconda edizione di Natural history of Aleppo, doveroso tributo alla memoria del fratello. Grazie a Fothergill, conobbe Banks e Solander che gli furono di grande aiuto per identificare le piante siriane e adeguarne la nomenclatura agli standard linneani. Nel 1777 anch'egli fu ammesso alla Royal Society. Ma prima che potesse terminare quel compito, lo attendeva un nuovo viaggio. Nel 1781 il fratello minore Claude, funzionario della Compagnia delle Indie, fu nominato amministratore capo della Compagnia a Visakhapatnam nella provincia di Madras. Non godendo di buona salute, gli chiese di accompagnarlo in India come suo medico. Anche se aveva già superato la cinquantina, Patrick accettò; durante il lungo viaggio in nave, portò a termine la revisione di Natural history of Aleppo e fu pronto per una nuova avventura. Nell'India meridionale, scoprì una flora e una fauna in gran parte inesplorate; strinse amicizia con Johann Gerhard König e incominciò a raccogliere animali e piante che inviava ai suoi corrispondenti londinesi; alla morte di König nel 1785, ne prese il posto come botanico e naturalista della Compagnia delle Indie. Imparò le lingue locali, incominciò a fare la spola tra le diverse sedi della Compagnia per raccogliere dai medici residenti "ogni genere di informazione sulle piante utili", mettendo insieme un erbario di 900 esemplari. Molte delle specie da lui raccolte sarebbero state pubblicate da Roxburgh (suo successore come botanico della Compagnia) in Plants of the Coast of Coromandel, di cui Russell scrisse la prefazione. Raccolse anche molti animali marini, ma come medico dovette soprattutto confrontarsi con il problema del morso dei serpenti. Incominciò a studiarli, alla ricerca di un metodo che permettesse di distinguere quelli letali da quelli innocui; ne esaminò le scaglie, la dentatura, sperimentò gli effetti dei loro morsi su cani, conigli e galline, verificò l'efficacia di possibili antiveleni. Fu così che conobbe e descrisse per la prima volta molti serpenti precedentemente ignoti alla scienza, tra cui quello che oggi porta il suo nome, la vipera di Russell Daboia russelii, una specie dal morso letale che ancora oggi in India causa ogni anno migliaia di vittime. Nel 1791, insieme a Claude e alla sua famiglia, Patrick ritornò definitamente a Londra per occuparsi della pubblicazione di varie opere, a cominciare dal trattato sulla peste A treatise of plague, uscito quello stresso anno. Nel 1794 fu la volta della seconda edizione di Natural history of Aleppo; anche se per rispetto della memoria del fratello apparve solo sotto il nome di Alexander e fu presentato come una semplice riedizione, in realtà si tratta di un libro in gran parte diverso. La prima parte del volume di Alexander, piuttosto caotica e frammentaria, si trasformò in un volume a sé, suddiviso in capitoli ben articolati; l'apparato di note e la bibliografia si arricchirono di fonti orientali e occidentali; molto argomenti furono trattati in modo molto più approfondito e il tono si fece decisamente più accademico. I vecchi nomi-descrizione prelinneani di Alexander, spesso ripresi dal Dictionary di Philip Miller, con la collaborazione di Banks e Solander vennero sostituiti con le denominazioni binomiali. Oltre ad essere trattato un numero maggiore di piante, crebbero anche le informazioni fornite, soprattutto sugli usi officinali. A questo punto, assolto il debito con Alexander, Patrick, oltre a pubblicare un certo numero di articoli sulle Transaction della Royal Society, poté dedicarsi a una serie di pubblicazioni riccamente illustrate, finanziate dalla Compagnia delle Indie. Nel 1795, come ho anticipato, scrisse la prefazione a Plants of the Coast of Coromandel di Roxburgh. Nel 1796 seguì il primo volume di An Account of Indian Serpents Collected on the Coast of Coromandel; il secondo volume, in quattro fascicoli, uscì tra il 1801 e il 1809, concludendosi dopo la morte dell'autore. Nel 1803 fu la volta di una corposa opera sui pesci, Descriptions and Figures of Two Hundred Fishes. Patrick Russell morì settantottenne nella sua casa londinese nel 1805.  Russellia, un fuoco d'artificio di fiori Come ho anticipato, la prima edizione di Natural history of Aleppo fu ben accolta dalla critica e assicurò fama europea ad Alexander Russell. Nel 1760 von Jacquin volle onorarlo con la dedica del genere americano Russelia, di cui aveva raccolto la specie tipo, R. sarmentosa, durante il suo viaggio a Cuba. Qualche anno dopo, sia König sia il figlio di Linneo si ricordarono anche di Patrick con due generi omonimi, ovviamente non validi per la regola delle priorità. Dunque anche Patrick Russell sarebbe a rigori un "botanico senza Nobel", ma la sua vita si intreccia talmente con quella del fratello, i suoi studi sono tanto importanti che era impossibile non dargli il giusto spazio, erigendo anche lui a "dedicatario onorario" del bel genere Russelia Jacq., famiglia Plantaginaceae (un tempo Scrophulariaceae). Diffuso dal Messico alla Colombia passando per le Antille, raccoglie una quarantina di specie di arbusti molto ramificati, eretti o decombenti, con foglie in genere piccole, coriacee o membranacee, piccoli fiori dalla corolla tubolare raccolti molto numerosi in cospicue infiorescenze. Nell'Ottocento diverse specie vennero introdotte dal Messico in Europa e divennero popolari piante da serra: nelle riviste degli anni 30-50 sono citate R. sarmentosa, R. multiflora, R. floribunda, R. rotundifolia e addirittura ibridi orticoli come R. lemoinei (R. juncea x R. sarmentosa) e R. elegantissima. Poi, come spesso succede, la moda cambiò e ora è sostanzialmente coltivata una sola specie, R. equisetiformis. Originaria dell'America settentrionale e centrale dal Messico al Guatemala, è oggi diffusissima nei giardini di tutti i paesi a clima mite, dove si fa apprezzare per la facilità di coltivazione e l'esplosiva fioritura di fiori tubolari color corallo che le ha guadagnato il nome comune inglese firecracker plant, "pianta fuoco d'artificio". Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1768, come medico della missione luterana e direttore dell'ospedale, arriva a Tranquebar, minuscola colonia danese sulla costa del Coromandel, l'allievo di Linneo Johann Gerhard König. Non lascerà l'India fino alla morte. Il suo arrivo agisce come un lievito che segna l'inizio dello studio scientifico della flora indiana; è un grande raccoglitore, ma soprattutto trasmette il suo entusiasmo ad amici e colleghi, creando forse la prima società scientifica del paese e incoraggiando le ricerche di altri naturalisti, tra cui il "padre della botanica indiana" William Roxburgh. Prima di tutto questo, il maestro Linneo lo aveva già premiato con il genere Koenigia, creato sulla base di una pianta che il suo pupillo aveva raccolto in Islanda. Un forte danese in India, là dove cantano le onde Meno noti di quelli di potenze maggiori come il Portogallo, la Francia o la Gran Bretagna, per circa duecento anni (1620-1848) in India ci furono anche alcuni insediamenti o empori danesi. Erano territori minuscoli, e dal punto di vista economico, con l'eccezione di qualche momento felice, non furono un successo. Ma sul piano culturale ebbero un ruolo sorprendente: in una di queste colonie operò la prima missione protestante della storia, nacque la prima tipografia e vennero stampati i primi libri stampati in una lingua indiana, furono create la prima scuola aperta anche alle bambine, e (forse) la prima società scientifica dell'Asia. Il luogo dove fiorirono quelle primizie è Tranquebar (oggi Tharangambadi, un nome poetico che significa "il luogo delle onde che cantano") a circa 300 km a sud di Madras sulla costa del Coromandel, nell'attuale stato indiano di Tamil Nadu, il primo e più importante avamposto danese in India. Nel 1616, l'ambizioso re di Danimarca Cristiano IV, sull'esempio della Compagnia olandese delle Indie orientali, sponsorizzò la nascita della Ostindisk Kompagni (Compagnia danese delle Indie orientali). Nella speranza di allearsi con il sovrano singalese contro i portoghesi, ottenendo in cambio una base a Ceylon, nel 1618 inviò in India una piccola flotta; tuttavia la trattativa diplomatica fallì e i danesi ripiegarono su Tranquebar, dove una delle loro navi aveva casualmente fatto naufragio. In cambio di un tributo annuo, il re di Thanjavur Raghunatha Nayak concesse loro una fascia costiera lunga otto km e profonda quattro; a partire dal 1620, i danesi vi crearono piantagioni e un emporio, protetti da un forte, Fort Daneborg, che divenne anche la sede ufficiale del governatore dell'India danese. Intanto in Europa era scoppiata la guerra dei Trent'anni, il cui esito disastroso cancellò i sogni di gloria di Cristiano IV e travolse anche la Ostindisk Kompagni. I viaggi tra India e Danimarca si interruppero, la compagnia fu sciolta e la piccola colonia rimase abbandonata a se stessa per circa trent'anni. Solo nel 1669 una fregata danese gettò di nuovo l'ancora a Tranquebar. Tornò in patria con un carico di pepe e altre spezie così promettente che venne deciso di rifondare la Compagnia, risorta dalle proprie ceneri nel 1670. Nonostante la concorrenza olandese che le impedì di allargare i suoi traffici più a est, la rinata compagnia riuscì a ritagliarsi uno spazio nel commercio dei tessuti e delle spezie indiane; la neutralità della Danimarca le permise di approfittare delle rivalità tra le potenze maggiori, traendo forti guadagni soprattutto dal nolo delle proprie navi "neutrali" ai mercanti delle potenze belligeranti. A questo effimero momento di prosperità mise fine la Grande guerra del Nord (1700-1721) che portò al fallimento anche la seconda Ostindisk Kompagni, sciolta nel 1729. Dal punto di vista religioso ed etnico, la colonia danese era un mosaico di fedi ed etnie. A inizio Settecento, quando il territorio danese si era allargato ad altri villaggi, vi vivevano circa 15.000 mila persone, musulmani, indù e cattolici indiani, convertiti dalla vigorosa attività missionaria dei gesuiti. Gli europei (soldati, funzionari, mercanti) erano una minoranza, e i danesi, circa 200 persone, una minoranza nella minoranza. La situazione preoccupava il re di Danimarca Federico IV, che decise di inviarvi missionari evangelici; non trovando nessuno disponibile in Danimarca, si rivolse all'università di Halle, uno dei centri propulsori del pietismo. Il pietismo di Halle era caratterizzato da un accentuato riformismo, che per certi aspetti lo avvicinava all'illuminismo e si traduceva in un forte impegno in campo pedagogico, sociale e culturale; l'energico caposcuola August Hermann Francke vi aveva fondato diverse scuole, un orfanatrofio, il più antico istituto biblico, una tipografia, una legatoria, una biblioteca, una farmacia e un piccolo museo di scienze naturali. La missione indiana, la prima in assoluto di una chiesa protestante, offriva ai pietisti di Halle un nuovo, inedito campo d'azione. Francke la affidò a due dei suoi migliori allievi, Bartholomäus Ziegenbalg e Heinrich Plütschau, che portarono in India la fede fervente, l'attivismo sociale, l'impegno pedagogico della scuola di Halle, destando l'ostilità non solo dei gesuiti, ma anche delle autorità locali e della Compagnia inglese delle Indie, che fece addirittura arrestare Ziegenbalg con l'accusa di tubare l'ordine pubblico. Egli approfittò della detenzione per studiare il tamil e incominciare a tradurre la Bibbia. Dopo la liberazione, oltre a due chiese e altre strutture funzionali alla missione, creò una cartiera, una tipografia (la prima dell'intero subcontinente a stampare testi in una lingua locale), una scuola aperta anche alle ragazze (anche questa una assoluta novità), un seminario per il futuro clero indiano. I missionari di Halle erano in costante contatto con la madrepatria, cui inviavano lettere, diari, contributi scientifici su vari aspetti della cultura indiana. A partire dal 1720, la tipografia della Fondazione Francke incominciò a pubblicarli in una rivista nota come Hallesche Berichte, che presto ebbe diffusione europea, influenzando a lungo l'immagine dell'India in Europa. Tra gli argomenti che più interessavano il pubblico colto c'era anche la medicina tradizionale indiana, il cui valore era stato riconosciuto dagli europei fin dai tempi di Garcia de Orta; d'altra parte, si riteneva che quell'antico patrimonio dei conoscenze fosse ormai degenerato e ridotto a un insieme di pratiche superstiziose. Urgeva inviare in India un medico con una buona preparazione in chimica e in botanica farmaceutica per studiare dal vivo le piante medicinali, tanto più che l'assistenza sanitaria a Tranquebar era inadeguata e non riusciva a far fronte alle epidemie che decimavano gli europei. Mentre gli indigeni disponevano di un certo numero di medici ayurvedici, a occuparsi della loro salute c'erano solo il chirurgo e l'aiuto chirurgo della guarnigione militare, che gestivano anche l'ospedale con l'aiuto di assistenti indiani. Nel 1732 la Fondazione Francke inviò dunque a Tranquebar Samuel Benjamin Cnoll (1705–67), un medico laureato ad Halle, che dagli anni '40 diresse anche l'ospedale; sappiamo che creò un piccolo orto botanico e scrisse un articolo sulla preparazione indiana della borace pubblicato sulla rivista danese Acta Medica Hafniensis. Alla sua morte, ne prese il posto il protagonista di questa storia, Johann Gerhard König (1728–85). Ma prima di concentrarci su di lui, due parole sulle ulteriori vicende dell'India danese. Dopo le pesanti perdite subite nella Grande guerra del Nord, la Danimarca tornò alla politica di neutralità che non avrebbe più abbandonato fino alle guerre napoleoniche. Nel 1730 venne fondata una terza compagnia, la Compagnia asiatica (Asiatisk Kompagni) che, ottenuto dal re il monopolio dei traffici asiatici per quarant'anni, aprì una nuova via commerciale con la Cina e rilanciò il commercio indiano. Anche se i maggiori profitti vennero dalla rotta cinese, ci fu una certa espansione anche nell'area indiana, con la fondazione di altri empori, il più importante dei quali fu Serampore in Bengala, fondato nel 1755. Tra il 1754 e il 1756, la compagnia cercò anche di creare un avamposto nelle isole Nicobare, che presto dovette essere abbandonato a causa della malaria e di altre malattie che decimarono i coloni. Per evangelizzare le Nicobare, la corona danese decise l'invio di una seconda missione evangelica, affidata all'Unione dei fratelli boemi, anche noti come Fratelli moravi. Il re di Danimarca assicurò la più ampia libertà religiosa e l'agguerrita congregazione lanciò immediatamente una sottoscrizione tra i propri membri per autofinanziarsi. Un primo gruppo di quattordici missionari, tutti giovani e scapoli, fu inviato Tranquebar nel 1760; ne facevano parte un pastore, due studenti di teologia e undici tra artigiani e mercanti. L'anno successivo furono raggiunti da alcune famiglie, con donne e bambini. Anche se l'evangelizzazione delle Nicobare fallì prima di cominciare, a Tranquebar i Fratelli moravi riuscirono ad affermarsi rapidamente, suscitando non poche gelosie tra i confratelli luterani. 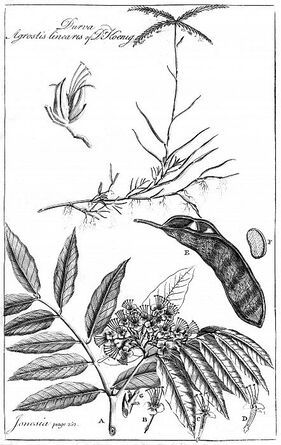 In missione per conto di Linneo A gettare un ponte tra i due gruppi missionari rivali fu proprio il nostro Johann Gerhard König. E' ora che si prenda la scena. König era un tedesco del Baltico, nato a Kreutzburg nella Livonia polacca. Incominciò la sua formazione come apprendista farmacista a Riga. Dopo aver lavorato come farmacista in diverse località danesi e svedesi, nel 1757 andò a Uppsala a studiare scienze naturali con Linneo, con il quale poi rimase in contatto. Nel 1759 si trasferì in Danimarca, dove lavorò al Frederikshospital e studiò medicina all'Università di Copenhagen con un altro discepolo di Linneo, Christen Friis Rottbøll. Come abile raccoglitore, fu ingaggiato da Oeder per Flora Danica; nel 1764 fece raccolte nell'isola di Bornholm e tra il 1766 e il 1767 in Islanda. Fu proprio la sua fedeltà a Linneo, al quale aveva inviato un certo numero di esemplari, a metterlo in urto con Oeder. Su consiglio di Rottbøll, accettò il posto di medico della missione luterana di Tranquebar, vacante per la morte di Cnoll. Non era ancora laureato, ma avrebbe potuto continuare gli studi e scrivere la sua tesi anche in India. Fu così che nel 1768 egli arrivò a Tranquebar; anche lui si sentiva un missionario, ma del verbo linneano, che fu il primo a far conoscere in India. Era un avido raccoglitore, un ottimo sistematico, e soprattutto una personalità carismatica che seppe contagiare con il suo entusiasmo amici e colleghi. Insieme ad alcuni pastori della missione luterana e qualche membro della comunità morava creò un gruppo informale il cui scopo principale era promuovere lo studio scientifico della botanica. Alcuni studiosi lo considerano la prima società scientifica indiana e gli attribuiscono anche un nome, United Brethren, "Fratelli uniti" o "Unione dei fratelli"; altri fanno notare che era la denominazione usuale della chiesa morava ed è dubbio che i "fratelli botanici" l'abbiamo mai applicata a se stessi. Ma certo il gruppo esisteva; dapprima limitato a Tranquebar, via via ne superò i confini e si allargò a medici, funzionari, naturalisti che operavano nell'India meridionale, per lo più al servizio della Compagnia inglese delle Indie. I membri del gruppo raccoglievano e scambiavano piante, le identificavano, ne discutevano "fraternamente" la classificazione; quindi cominciarono a inviare gli esemplari, identificati o meno, a botanici europei. Come allievo di Linneo che aveva studiato e lavorato in Danimarca, König era in contatto in Svezia con Retzius e in Danimarca con il maestro Rottbøll, Fabricius e Martin Vahl. Attraverso il condiscepolo Solander, incominciò a corrispondere con Banks, che a sua volta lo mise in contatto con i naturalisti al servizio della Compagnia delle Indie, il più noto dei quali, William Roxburgh, divenne un membro attivo del gruppo e suo amico personale. A loro volta, i missionari luterani coinvolti da König fecero conoscere le loro ricerche a Halle; attraverso Johann Reinhold Forster, che insegnava storia naturale in quella università, le relazioni si allargarono ad altri atenei tedeschi, con il risultato che il lavoro dei "botanici di Tranquebar" divenne ben noto in Europa e numerose piante indiane da loro segnalate per la prima volta furono pubblicate da personaggi come Retzius, Vahl, Willdenow o James Edward Smith. König lavorò a Tranquebar fino al 1773, quando ottenne la laurea in medicina in absentia all'Università di Copenhagen, sottoponendo una tesi in cui discuteva l'efficacia dei rimedi indigeni per curare le malattie endemiche della regione (De remediorum indigenorum ad morbes cuius regioni endemicos expugnandos efficacia). Insoddisfatto del magro salario che limitava di molto le sue possibilità di viaggiare, "più desideroso di fama che di fortuna", come confidò all'amico Patrick Russell, passò al servizio del nababbo di Arcot come medico personale. Poté così esplorare le colline a nord di Madras e anche visitare l'isola di Ceylon. Frequenti divennero anche i soggiorni a Madras, dove condivise le sue conoscenze con i medici inglesi, primo fra tutti William Roxburgh che all'epoca lavorava come assistente chirurgo al Madras Medical Service. Grazie agli amici inglesi nel 1778 fu assunto dalla Compagnia inglese delle Indie, di cui fu il primo naturalista ufficiale. Nel 1779 la compagnia lo inviò in Siam e negli stretti di Malacca alla ricerca di piante di interesse economico da introdurre nell'India meridionale. L'anno successivo rientrò a Madras; erborizzava spesso con Roxburgh, che all'epoca era più noto come disegnatore che come botanico, trasmettendogli i suoi metodi e rafforzando la sua vocazione botanica. Nel 1785, mentre stava recandosi a Vizagaptam per incontrare il fratello di Patrick Russell Claud, si ammalò di gastroenterite e, nonostante le cure dell'amico Roxburgh, ne morì, lasciando i suoi erbari e le sue carte in eredità a Joseph Banks. König pubblicò poco: il primo articolo scientifico sulle termiti, uscito nel 1779 su una rivista tedesca, quindi due contributi sulle piante dell'India sudorientale pubblicati da Retzius in Observationes botanicae rispettivamente nel 1783 e nel 1791. Fu invece un grande raccoglitore; suoi esemplari furono pubblicati da Linneo in Mantissa plantarum altera (1771) e dal figlio di Linneo in Supplementum plantarum (1781), fornirono le basi per la descrizione delle Cyperaceae pubblicate da Rottbøll in Descriptiones plantarum rariorum e Descriptiones et iconum rariores (1772-73) e in parte per Plants of the Coast of Coromandel di Roxburgh.  Un genere artico e montano Quando König arrivò in India, aveva già ottenuto da Linneo il "massimo riconoscimento per un botanico", ovvero la dedica di un genere. In Mantissa Plantarum Prima (1767) il suo maestro aveva creato in suo onore Koenigia (famiglia Polygonaceae), sulla base di una delle piante da lui raccolte in Islanda, K. islandica; è una minuscola erbacea, tipica delle tundre artiche e delle praterie alpine. Non solo è una delle piante da fiore più piccole del mondo (non supera i 4 cm d'altezza), ma anche una delle pochissime annuali di quelle flore in cui la bella stagione è troppo breve per garantire la maturazione dei semi. A lungo rimase l'unica specie riconosciuta, finché, rispettivamente nel 1825 e nel 1881 si aggiunsero due specie himalayane, K. nepalensis e K. pilosa. Emendato da Hedberg sulla base delle caratteristiche del polline, verso la fine del '900 il genere giunse a comprendere cinque o sei specie, tutte alpine o artiche. Finché, nel 2015, è arrivata una rivoluzione tassonomica. Sulla base dei dati molecolari, il genere è stato ridefinito, includendovi Aconogonon. Oggi dunque comprende una trentina di specie dell'emisfero boreale, con centro di diversità nell'Himalaya. Sono erbacee perenni o annuali, molto varie per dimensioni ed aspetto, con radici a fittone e piccoli fiori dai colori chiari (bianchi, crema, rosa) raccolti in cime ascellari o terminali che in alcune specie formano vistose pannocchie piramidali. Tra di esse c'è anche una bella specie abbastanza comune nei pascoli montani delle Alpi occidentali e centrali e degli Appennini settentrionali. La conosco da sempre, ma con il nome che le aveva dato Allioni, Polygonum alpinum, cui corrisponde anche il nome comune poligono alpino. Come molte piante di questa famiglia dalle vicende tassonomiche travagliate, ha cambiato nome molte volte, e adesso si chiama ufficialmente Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal. Anche se varie specie sono aggressive infestanti, alcune sono apprezzate per il loro valore ornamentale. La più coltivata è forse K. x fennica, un ibrido naturale tra K. alpina e K. weyrichii, un'imponente perenne con fioriture spettacolare. Qualche informazione in più su questa e altre specie nella scheda. Moglie di un alto funzionario civile e militare, la contessa scozzese Christian Dalhousie seguì il marito prima in Canada poi in India. Forse per lei, come per molte dame del suo ceto, all'inizio la botanica fu solo un piacevole passatempo, ma presto divenne una missione, il suo modo di contribuire al progresso scientifico e alla diffusione della cultura. Corrispondente di William Jackson Hooker, fece parte di un singolare gruppo di signore che collaborarono attivamente alla raccolta di piante canadesi per la sua Flora boreali-americana; al contrario delle sue amiche, per lei però non fu un episodio. Le sue raccolte indiane furono così importanti da guadagnarle l'ingresso nella Società botanica di Edimburgo, unica donna del tempo a farne parte. La ricordano varie piante indiane e malesi e il genere Dalhousiea.  Quattro signore a caccia di piante Tra il 1829 e il 1840 William Jackson Hooker, all'epoca direttore dell'orto botanico di Glasgow, pubblicò la monumentale Flora boreali-americana, un'opera capitale per la conoscenza delle piante dell'America settentrionale. Si basò soprattutto sulle piante raccolte durante la seconda spedizione Franklin (1825-26), ma si servì anche degli esemplari e delle informazioni forniti da circa 120 raccoglitori e collaboratori: naturalisti e cacciatori di piante, ma anche militari, funzionari coloniali, persone comuni. Per preparare al compito quelli tra loro che non avevano una formazione come naturalisti (ed erano la maggior parte), predispose addirittura delle istruzioni su come raccogliere ed essiccare correttamente gli esemplari (Directions for Collecting and Preserving Plants in Foreign Countries: On Preserving Plants for a Hortus Siccus, 1828). Tra i più entusiasti raccoglitori canadesi di Hooker spiccano i nomi di quattro signore: Christian Broun Ramsay (più nota come Lady Dalhousie), Anne Mary Perceval, Harriet Sheppard e Mary Brenton. Tre di loro erano amiche intime e vivevano a Quebec City, all'epoca il centro amministrativo delle province orientali del Nord America britannico: Christian Ramsay (1786-1839) era la moglie di lord Dalhousie, prima vice governatore della Nuova Scozia, poi governatore generale del Nord America britannico; Anne Mary Flowers Perceval (1790-1876) era la moglie del direttore delle dogane del porto di Quebec; Harriet Sheppard (1786-1858) era la moglie di un facoltoso mercante di legname appassionato di scienze naturali. La quarta, Mary Brenton (1792-1884), viveva a Terranova, dove il padre era giudice della Corte Suprema; era l'unica a non far parte del gruppo di amiche, ma apparteneva alla stessa classe sociale, l'élite costituita dagli alti funzionari e dai facoltosi mercanti britannici. Come vedremo meglio tra poco, Hooker corrispondeva già con lady Dalhousie, ma la prima ad essere reclutata formalmente fu Anne Mary Flower Perceval. Non solo è citata in Flora boreali-americana non meno di 150 volte, ma fu lei a coinvolgere nell'avventura le due amiche e altri conoscenti. I coniugi Perceval erano bel noti nella vita mondana e culturale della colonia; il marito Michael Henry era figlio dell'ex primo ministro britannico Spencer Perceval, mentre la moglie era nata in una ricca famiglia di mercanti londinesi; molto apprezzati erano i pranzi e le serate danzanti che si tenevano nella loro bella casa, Spencer Wood, al centro di una grande tenuta. Anne Mary era una "castellana elegante", una dama dalle maniere squisite, ma anche una madre di famiglia con dieci figli che cercava di educare secondo i metodi più all'avanguardia. Fu probabilmente pensando alla loro educazione che incominciò ad interessarsi di botanica, approfittando della ricchezza di piante che poteva raccogliere nella sua stessa tenuta. Avviò un erbario, appassionandosi soprattutto di crittogame, e incominciò a corrispondere con vari botanici americani, tra cui John Torrey. Fu proprio quest'ultimo nel 1824 a raccomandarla a Hooker: la signora Perceval - scrisse - era un'eccellente botanica, che avrebbe potuto essergli utile spedendogli piante essiccate; ma era anche una dama dell'alta società con vasti contatti che poteva aiutarlo coinvolgendo altre persone. Tra Hooker e Perceval iniziò un scambio epistolare; la donna accettò con entusiasmo di contribuire al progresso dell'amabile scienza delle piante, coinvolgendo anche i suoi bambini di varie età. Per venire incontro alle sue esigenze pedagogiche Hooker le inviò una copia delle sue Botanical Illustrations (1822), un manuale che aveva scritto per la classe iniziale dei suoi studenti di botanica all'università di Glasgow. Perceval, che già utilizzava come punto di riferimento Flora Americae septentrionalis di Pursh, di cui apprezzava la chiarezza didattica, ne fu deliziata. Già nel giugno 1825 fu in grado di spedire a Hooker un primo invio, assicurandogli che presto ne sarebbe seguito un altro, grazie al coinvolgimento di diversi amici. A ottobre dello stesso anni gli scriveva: "Ho sguinzagliato i miei amici in tutte le direzioni. I signori Sheppard si occuperanno del Quebec, lady Dalhousie di Sorel e Montreal, e io di quello che resta". Tra il 1825 e il 1826 la signora Perceval, insieme ai figli, trascorse l'inverno a Filadelfia, dove incontrò il botanico Lewis von Schweinitz, cui diede vari esemplari tra cui Pterospora andromedea, un'ericacea rara che cresceva nel sottobosco di pini di Spencer Wood, e il medico e botanico William Darlington cui donò un album di piante canadesi. Avrebbe continuato a collaborare attivamente con Hooker fino al 1828, quando rimase improvvisamente vedova e lasciò il Canada. Non risultano sue raccolte dopo questa data. Delle amiche reclutate da Anne Mary Perceval, l'acquisto più produttivo fu indubbiamente Harriet Campbell Sheppard, anche perché, al contrario di Perceval e Ramsay, rimase in Canada fino alla fine dei suoi giorni. Le sue raccolte si estendono per tutti gli anni '20 e '30 e in Flora boreali-americana è citata 144 volte; molte delle piante da lei raccolte appartengono a generi "difficili", ovvero di classificazione problematica. Anche suo marito era interessato alla botanica e la coppia inviò esemplari non solo a Hooker, ma anche a Torrey e Asa Grey. Anche i loro bambini furono coinvolti nelle raccolte, con gli stessi intenti pedagogici di Anne Mary Perceval, che del resto era un'amica intima della coppia e loro vicina di casa. Sappiamo che non di rado erborizzavano insieme. Negli anni '20, William e Harriet Sheppard furono in prima fila nelle istituzioni che promuovevano la diffusione della cultura e della conoscenza scientifica in Canada, come la Literary and Historical Society of Quebec; sorta nel 1824 sotto il patronato di lord Dalhousie, divenne anche una tribuna dove comunicare le loro ricerche. Tuttavia, contrari all'esclusivismo della LHSQ, che accettava solo membri della ricca élite anglofona, nel 1827 furono tra i fondatori della più democratica Society for the Encouragement of Sciences and the Arts, che era aperta a anglofoni e francofoni e incoraggiava la partecipazione femminile. Harriet Sheppard pubblicò anche diversi contributi, tra cui una memoria sulle conchiglie. Già anziana, nel 1864 fu invitata a parlare alla conferenza annuale della Montreal Natural History Society come "una dei pionieri della storia naturale in questo paese". Ne approfittò per fare l'elogio della sua vecchia amica lady Dalhousie. Prima di occuparci di lei (la vera protagonista di questo post), ancora due parole sulla quarta raccoglitrice di Hooker, Mary Brenton. Alla fine del 1829, il botanico scrisse a lady Dalhousie lamentando che rimaneva scoperta la flora dell'estremità orientale dall'America britannica. Lady Dalhousie chiese al marito di coinvolgere ufficialmente i governatori del New Brunswick e di Terranova. Fu così che fu individuata Mary Brenton, le cui raccolte si estendono dal 1830 al 1838 circa. In Flora Boreali-Americana è citata 102 volte per piante sia native sia introdotte. Accompagnando il padre nei suoi doveri d'ufficio, poté viaggiare parecchio. Un'alta percentuale delle sue raccolte è costituita da piante boreali, molte delle quali provengono da stagni e paludi. Alcune sono rare, come Halenia brentoniana (oggi H. deflexa subsp. brentoniana), così denominata da Hooker in suo onore. Alla ricerca di piante "nuove e rare" in Canada e in India Ma è ora di parlare di lady Dalhousie. Nata Christian Broun, discendeva da una nobile famiglia scozzese tradizionalmente impegnata in campo legale. Diciannovenne si sposò con George Ramsay, ottavo conte di Dalhousie, un militare che aveva combattuto sotto Wellington nelle guerre napoleoniche. Tornata la pace, anche per far fronte alle ingenti spese della ristrutturazione dell'amato Dalhousie Castle, egli accettò di entrare nell'amministrazione civile e nel 1816 fu nominato vicegovernatore della Nuova Scozia. La moglie e i tre figli lo accompagnarono in Canada, stabilendosi ad Halifax. Entrambi i coniugi coltivavano interessi culturali e promossero il progresso della cultura scientifica. Lord Dalhousie fondò il Dalhousie College di Halifax, ora Dalhousie University; inoltre acquistò una vasta proprietà dove introdusse miglioramenti agricoli. Lady Dalhousie faceva da padrona di casa, presiedeva alle occasioni mondane e accompagnava il marito nei frequenti viaggi imposti dai suoi doveri. Era una grande lettrice, di vasta cultura, molto spiritosa (come si evince sia dalle sue lettere, piene di humor, sia dalle divertenti caricature della buona società di Halifax che disegnò in quegli anni), ma anche seria e determinata. Una serietà e una metodicità ben riconoscibili nell'erbario che iniziò in questi anni, in cui luogo e data di raccolta sono indicati con precisione, le piante sono accompagnate da indicazioni sull'habitat e spesso da schizzi ad acquarello e le specie sono identificate con notevole precisione sulla scorta di Flora Americae septentrionalis di Pursh. Ben presto le sue preferite divennero le felci. Iniziò anche a spedire in Scozia semi e piante vive per il giardino di Dalhousie Castle. Nel 1820 lord Dalhousie fu promosso Governatore generale dell'America britannica e la famiglia si trasferì a Quebec City. La sede ufficiale era Chateau St. Louis, nella città alta, ma la residenza preferita divenne la tenuta di Sorel, una cittadina situata a sud-est di Montreal. Era una zona ricca di piante che permise a lady Dalhousie di raffinare le sue conoscenze botaniche. L'erbario crebbe rapidamente. Nel 1823, tra Sorel e Montreal, raccolse 328 piante, alcune delle quali rare. Nell'estate del 1826, tra Sorel, Quebec City, l'Ottawa River e il Gaspé, ne raccolse circa 300. Lady Dalhousie entrò in contatto con Hooker ancora prima che questi lanciasse il suo appello per Flora boreali-americana. Nel 1823 gli inviò alcune scatole con varie rarità raccolte nelle vicinanze di Montreal, soprattutto orchidee. Lo stesso anno egli la raccomandò all'esploratore artico John Richardson come "una botanica molto zelante" e nel suo saggio On the Botany of America del 1825 la collocò in prima fila tra coloro che maggiormente stavano contribuendo alla conoscenza della flora canadese. Dunque accolse volentieri l'invito dell'amica Anne Mary Perceval. Tuttavia, rispetto a lei e alle altre due raccoglitrici di Hooker, il suo contributo quantitativo a Flora boreali-americana si riduce a una cinquantina di specie, soprattutto orchidee e felci: infatti era sua ambizione contribuire con piante nuove o rare. Insieme al marito, progettava anche di creare un orto botanico in un'isola del San Lorenzo, ma ostacoli politici ne impedirono la realizzazione. Nel 1824 la famiglia tornò momentaneamente in patria e lady Dalhouisie diede mano alla ristrutturazione del giardino di Dalhousie Castle; lord Dalhousie era intenzionato a dare le dimissioni e ad occuparsi della sua proprietà in Scozia, ma le finanze familiari furono rovinate dal fallimento del suo agente. I Dalhousie dunque tornarono in Canada, rimanendovi fino al 1828. Nel 1827 lady Dalhousie presentò alla Literary and Historical Society of Quebec (di cui era cofondatrice con il marito) circa 400 piante canadesi; il catalogo fu pubblicato nel 1829 nel primo volume delle Transactions della società. Nel frattempo, lord Dalhousie era stato nominato comandante in capo dell'esercito britannico in India. Nel luglio 1829 marito e moglie partirono per la nuova destinazione; durante il viaggio, lady Dalhousie approfittò degli scali a Madeira, Sant'Elena e al capo di Buona Speranza per incrementare le sue raccolte. Lo stesso fece durante il soggiorno indiano, che si protrasse fino al 1834. Anche se si definiva a tyro "una tirocinante, una principiante", e all'inizio fu sconcertata da una flora che appariva tanto diversa da quella scozzese o canadese, era ormai una botanica ben più che dilettante. Le raccolte del periodo indiano ammontano a non meno di 1200 esemplari; quelle più significative le fece a Simla e a Penang. In una spiritosa lettera del febbraio 1833 a Hooker riassume i suoi viaggi, scusandosi della scarsa qualità e quantità delle piante raccolte in Malesia: il loro soggiorno è durato solo sei settimane ed è coinciso con la stagione delle piogge, rendendo impossibile seccare le piante a regola d'arte. Racconta poi del viaggio a Simla: dopo aver risalito il Gange per 700 miglia, hanno percorso le pianure indiane per 800 miglia a dorso d'elefante: viaggiare a tanti piedi d'altezza non è molto pratico per botanizzare! A Simla si sono fermati sette mesi, e lì davvero ha trovato un paradiso botanico, ma - aggiunge modestamente - non c'era nessuno ad aiutarla e potrebbe aver identificato scorrettamente molte piante. In realtà, era un'abile raccoglitrice con occhi esercitati per individuare piante nuove e rare. Grazie a lei molte andarono ad arricchire l'orto botanico di Calcutta. Del suo vasto ed eccellente erbario poté giovarsi ancora il figlio di Hooker Joseph Dalton per la sua Flora Indica. Hooker padre volle manifestare la sua gratitudine dedicandole il volume del 1833 del Curtis Botanical Magazine "per gli essenziali servizi che, nonostante i suoi vari doveri in Canada e in Bengala, ha reso alla botanica con le sue estese collezioni e l'introduzione di molte specie interessanti nei giardini di questo paese". Tornata definitivamente in Scozia nel 1834, donò le sue collezioni all'orto botanico di Edimburgo e divenne membro onorario della Società botanica della città, la sola donna ad esservi ammessa. Fu presto una figura riconosciuta della società cittadina e dedicò i suoi ultimi anni soprattutto al giardino di Dalhousie Castle, dove aveva creato un felceto con le piante raccolte durante i suoi viaggi. Era sua intenzione descriverle in un volume, come annuncia in una lettera a Hooker; la morte improvvisa nel 1839 le impedì di realizzare il progetto. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Omaggi floreali Diverse piante ricordano la nostra raccoglitrice "ai quattro angoli del mondo" (l'espressione è sua). La maggior parte delle piante che portano o hanno portato il suo nome nell'eponimo furono raccolte durante il "piovoso" soggiorno a Penang: le felci Asplenium dalhousiae e Pteris dalhousiae, la licopodiacea Huperzia dalhousieana, la spettacolare orchidea Dendrobium dalhousieanum (oggi D. pulchellum). Fu raccolta invece a Simla la bella Acantacea Strobilanthes dalhousiana. Le è stato dedicato anche il coloratissimo beccolargo codalunga, un passeriforme dell'Himalaya, Psarisomus dalhousiae; ne vediamo un esemplare impagliato nell'unico ritratto ufficiale della contessa: austeramente vestita di nero, ostenta un cipiglio severo che non ci aspetteremmo leggendo le sue lettere piene di ironia. Lo splendido Rhododendron dalhousiae non è invece dedicato a lei, ma a sua nuora Susan, moglie dell'unico figlio sopravvissuto, James Broun-Ramsay, marchese di Dalhousie. Quest'ultimo alla fine del 1847 fu nominato governatore generale dell'India e, insieme alla moglie, raggiunse la sua sede viaggiando sulla stessa nave che portò in India Joseph Dalton Hooker. Il botanico divenne buon amico della coppia e, grato dei molti aiuti ricevuti dal governatore durante la sua spedizione indiana, dedicò la bella pianta a lady Susan. Lady Christien è infine ricordata dal genere Dalhousiea (famiglia Fabaceae). Roxburgh nelle foreste del Bengala aveva raccolto un rampicante che denominò Podalyria bracteata, ma Robert Brown osservò che non poteva appartenere a quel genere. Robert Graham, professore di botanica di Edimburgo e membro eminente della Edinbourgh Botanical Society, la attribuì a un genere proprio che denominò appunto Dalhousiea. Si tratta di un piccolo genere con areale disgiunto, che comprende due sole specie: D. africana, che vive nell'Africa occidentale tropicale, e D. bracteata, diffusa nell'Himalaya orientale, in Bengala, in Assam e in Myanmar. Entrambe vivono nelle foreste tropicali umide. D. africana è una liana, mentre D. bracteata è un arbusto sarmentoso o una rampicante, con infiorescenze terminali di fiori bianco neve. Le foglie fresche sono usate in impiastri, mentre nella comunità Tagin dell'Arunachal Pradesh pezzi di corteccia trovano uso in rituali divinatori. Scoperto nel giardino abbandonato di un monastero buddista birmano, quello che fu presto soprannominato "l'albero più bello del mondo" venne battezzato dal botanico Nathaniel Wallich Amherstia nobilis in onore di Sarah e Sarah Elizabeth Amherst, rispettivamente moglie e figlia del governatore dell'India. Sembrerebbe il solito, banale, omaggio cortigiano se non fosse che le due ladies si erano rese benemerite della botanica come pioniere dell'esplorazione della flora indiana, scoprendo e introducendo in Europa, tra l'altro, una beniamina dei nostri giardini, Clematis montana.  Una nobile pianta... Nel marzo del 1826, il trattato di Yandaboo metteva fine alla prima guerra anglo-birmana (1824-1826) con la cessione all'Inghilterra di Assam, Manipur, Arakan e Tenasserim. Lord Amherst, il governatore generale dell'India, inviò immediatamente nella Birmania meridionale una missione esplorativa capeggiata dal medico e esperto diplomatico John Crawfurd; ne faceva parte anche il botanico Nathaniel Wallich, direttore dell'orto botanico di Calcutta, il cui compito principale era valutare le potenzialità forestali della regione. Alla fine del mese, mentre Wallich rimaneva a Rangoon, Crawford con alcuni accompagnatori esplorò la zona tra Rangoon e la foce del fiume Thanlwin. Il 4 aprile, il gruppo visitò la grotta naturale di Kogún, decorata con centinaia di tavolette votive di terracotta; tra le offerte dei fedeli, manciate di splendidi fiori rossi. Erano stati raccolti poco lontano, nel giardino incolto di un monastero buddista semiabbandonato, dove cresceva "un albero alto circa venti piedi, abbondante di lunghi grappoli penduli di fiori di un ricco color geranio, con lunghe eleganti foglie lanceolate" (An Account of Martaban in March and April 1826). Crawfurd capì subito di trovarsi di fronte a una pianta ancora ignota alla scienza, impressione confermata al ritorno a Rangoon da Wallich, cui mostrò i campioni raccolti. Nei mesi successivi, il botanico danese la cercò inutilmente nelle foreste birmane, finché la ritrovò nel sito già segnalato da Crawfurd. Ne prelevò anche diversi germogli che poi trapiantò nell'orto botanico di Calcutta. Al suo ritorno in Inghilterra, pubblicò lo splendido albero in Plantae asiatiacae rariores (1830) come Amheristia nobilis, in onore della moglie e della figlia del governatore. Sembrerebbe il più scontato degli omaggi cortigiani, se non fosse che quel riconoscimento la madre, la contessa Sarah Amherst, e la figlia, Sarah Elizabeth Amerherst, se l'erano guadagnato davvero non solo come protettrici della scienza, ma come instancabili raccoglitrici di piante. Lo ricorda nella dedica lo stesso Wallich: "Dedicato alla nobile contessa Amherst e a sua figlia lady Sarah Amherst, in segno di riconoscimento della somma cura, della debita assiduità e degli indefessi e felici successi con i quali, finché dimorarono in India, coltivarono e promossero la scienza botanica". Tanto più che, quando Wallich scrisse queste parole, la burrascosa carriera pubblica di lord Amherst era ormai giunta al termine. William Pitt Amherst (1773-1857) è passato agli annali della diplomazia come responsabile del fallimento della sfortunata ambasceria in Cina (1816) a causa del suo rifiuto di prostrarsi di fronte all'imperatore. Anche il suo mandato in India, di cui fu governatore generale tra il 1823 e il 1828, fu sfortunato e discusso. Poco dopo il suo arrivo nel subcontinente, egli si lasciò incautamente convincere a dichiarare guerra alla Birmania, convinto che il conflitto si sarebbe risolto in poche settimane. Invece durò due anni, costò 13 milioni di sterline, scatenò un'epidemia di colera, provocò l'ammutinamento dei sepoys, rovinò l'economia indiana e le finanze della Compagnia delle Indie. Se non avesse avuto potenti protettori a Londra, primo fra tutti il duca di Wellington, egli sarebbe stato destituito. La conclusione positiva della guerra, insieme a una sua condotta più prudente, fece cambiare idea ai vertici della compagnia. Tuttavia, nel 1826, con una tipica operazione promoveatur ut amoveratur, il re lo nominò visconte, ma contemporaneamente fu richiamato in patria e per i quasi trent'anni che gli rimasero dal vivere non gli fu più affidato alcun incarico pubblico. Molto più gloriosi dunque gli allori botanici (e ornitologici) di sua moglie e sua figlia.  E due nobili raccoglitrici La contessa Amherst (1762-1838), nata Sarah Archer, apparteneva all'alta nobiltà britannica. Sedicenne, si sposò con un cugino, il conte di Plymouth, da cui ebbe diversi figli. Rimasta vedova, nel 1800 si risposò con lord Amerhest, da cui ebbe una figlia, appunto Sarah Elizabeth, e tre figli. Non sappiamo come fosse nata la sua passione per le piante né se precedesse il soggiorno indiano. Come molte dame del suo ceto, coltivava le arti del disegno e della musica, che aveva trasmesso anche alla figlia. Nel 1823, quando partì alla volta dell'India con il marito, la figlia Sarah Elizabeth e il figlio maggiore Jeffrey, la contessa aveva già compiuto sessant'anni. Sui circa cinque anni trascorsi in India siamo ben informati grazie alle lettere di Sarah Elizabeth ai fratelli e soprattutto grazie al diario della stessa lady Amherst, di notevole freschezza e ammirevole semplicità. Il 18 marzo 1823 la famiglia sbarcò a Madras, dove fu ricevuta in pompa magna; proseguì poi via terra per Calcutta, dove giunse il 1 agosto. La residenza del governatore, Gouvernment House, era, anzi è, un lussuoso palazzo posto al centro di un vastissimo complesso, di cui conosciamo l'aspetto all'epoca grazie a uno schizzo di Sarah Elizabeth. Lady Amherst, che considerava assurdi i tentativi delle sue compatriote di ricreare in India cloni dei giardini inglesi, con piante portate dalla madrepatria condannate a morte certa, era decisa a crearvi un giardino popolato di piante locali. Fu forse con questo intento che visitò ripetutamente l'orto botanico della Compagnia delle Indie, a Shibpur, a una decina di km dall'area governativa di Calcutta. Fondato nel 1787, sotto la direzione prima di William Roxburgh e ora di Nathaniel Wallich, era divenuto un centro di studio e di acclimatazione di prim'ordine e un'oasi verde con migliaia di specie provenienti da tutte le regioni del subcontinente, ma anche da altri paesi tropicali. Diligente, lady Sarah ne percorreva i sentieri disegnando schizzi, prendendo note, chiedendo lumi al direttore, che divenne subito un amico. Fu forse su suo incoraggiamento che la nobildonna, con l'aiuto dell'inseparabile figlia, iniziò a creare il suo erbario indiano, con le piante raccolte e preparate "in modo abile e industrioso" (sono parole di Wallich). I numerosi viaggi ufficiali cui partecipò a fianco del marito le diedero occasione di visitare diverse aree del paese e di mettere insieme una collezione di non meno di cinquecento specie. Non è però il caso di immaginare le due ladies nei dimessi panni di cacciatrici di piante in gonnella. Coinvolgendo la prima dama del paese, anche una breve escursione diventava un affare di stato. Ad esempio, come leggiamo nel diario della contessa, nel gennaio 1825 madre e figlia, scortate da aiutanti di campo, risalgono il fiume in battello per visitare le rovine del forte di Gaukachi; fanno un picnic nella foresta, accettano graziosamente gli omaggi di banane, arance, latte offerte dai contadini; poi, mentre i battitori le aprono la strada a colpi di machete, lady Amherst issata su un elefante può penetrare nella giungla, che le si mostra come uno scrigno prezioso e selvaggio di alberi coperti di fiori e frutti. Alla sera, le due dame tornano trionfanti a casa con i loro trofei: piante, schizzi, fiori. Tra battellieri, cuochi, servitori, portatori, battitori la gitarella ha coinvolto qualche centinaio di persone. Lo stesso anno, un viaggio fluviale di una decina di giorni con la famiglia Amherst al completo impegnerà, tra servitori, battellieri e soldati di scorta, circa cinquecento persone. Tra i viaggi ufficiali, il più lungo e impegnativo fu quello che tra il giugno 1826 e il luglio 1827 portò il governatore (accompagnato dalla consorte e dalla figlia) a visitare gran parte dell'India settentrionale. Nella primavera del 1827, dopo una lunga visita di stato al moghul a Dehli, Amherst raggiunse Simla, dove doveva incontrare il maharaja del Punjab e l'ex re di Kabul. Fu così che scoprì quella che qualche anno dopo sarebbe diventata anche ufficialmente la "capitale estiva del Raj Britannico". Situata a un'altitudine di oltre 2000 metri e circondata dalle maestose cime dell'Himalaya, incantò tutti; le più felici erano la contessa e sua figlia che nei due mesi e mezzo trascorsi a Simla poterono sfogare la loro passione per la natura arrampicandosi instancabili sulle pendici di colline e montagne alla ricerca di piante rare o sconosciute alla scienza. In quel paradiso botanico che erano tra le prime ad esplorare scoprirono numerose nuove specie, tra cui Spiraea argentea Benth. (forse da identificarsi con S. media), Astragalus amherstianus, Allium leptophyllum (oggi A. rubellum), Bosea amherstiana, Wulfeniopsis amherstiana, Anemone vitifolia (oggi Eriocapitella vitifolia). Nel sottobosco di una foresta di cedri deodora, la scoperta più bella: Clematis montana, nella forma alba. Al loro ritorno a Calcutta, Sarah Elizabeth si ammalò gravemente. Il governatore e la sua famiglia dovettero così attendere l'inizio del 1828 per lasciare l'India. All'appello mancava Jeffrey che nel 1826 era morto di febbri a soli 24 anni. Nei loro bagagli, molti souvenir indiani, un erbario di cinquecento specie, semi e piante vive da introdurre in Inghilterra e una coppia di splendidi fagiani birmani, dono del re di Birmania alla contessa. Oggi sono noti come "fagiani di lady Amherst", Chrysolophus amherstiae. Ormai escluso dalla vita pubblica, lord Amherst si ritirò a vivere a Montreal, la sua casa di campagna nel Kent. Nel giardino e nelle serre, la contessa coltivava le piante portate dall'India, ma anche altre esotiche, come le brasiliane Justicia amherstiae (oggi J. brasiliana) e Grobya amherstiae. Il magnifico giardino che aveva creato attorno alla Gouvernment House non sopravvisse alla sua partenza: la moglie del nuovo governatore, lady Bentinck, dichiarò che quei fiori erano "veramente malsani" e tempo una settimana fece spiantare tutto. Una sintesi della vita delle due ladies Amherst nella sezione biografie.  Una gara tra giardinieri La pubblicazione di Amherstia nobilis da parte di Wallich destò sensazione; la pianta venne immediatamente proclamata "l'albero più bello del mondo" e destò la cupidigia dei collezionisti. Tuttavia, al momento si conosceva solo l'esemplare di Kogún e i virgulti trapiantati da Wallich a Calcuitta che ci misero qualche anno a fiorire. Nel 1836 il duca di Devonshire spedì in India a caccia di piante l'aiuto giardiniere John Gibson: le sue istruzioni recitavano "procurarsi tutte le orchidee possibili e ritrovare Amherstia nobilis". Gibson ebbe la fortuna di arrivare a Calcutta proprio al momento della fioritura delle Amherstiae trapiantate da Wallich; si dice che ne fu così emozionato da mettersi a battere le mani come un bambino piccolo. Poi andò in Martaban a raccogliere semi e talee che però non sopravvissero. Un anno dopo tornò in Inghilterra con 300 nuove specie, tra cui 80 orchidee, e una pianticella di Amherstia nobilis. Per accoglierla degnamente, il duca fece costruire nel suo giardino di Chatsworth una serra apposita, la Amherstia house. Ma nonostante tutte le cure, la pianta morì qualche anno dopo, senza mai essere arrivata a fiorire. Negli anni successivi, la stessa sorte toccò ad altri esemplari coltivati a Syon House e a Kew. Il successo sarebbe arriso a un'altra signora, Louisa Lawrence. Moglie di William Lawrence, presidente del reale ordine dei chirurghi di Londra, a partire dal 1838 creò a Ealing un giardino famoso per la bellezza, la grande varietà di piante rare, la perfezione con cui erano coltivate. Orgogliosa della sua abilità e molto competitiva, Louisa accumulava premi su premi alle principali mostre orticole; il suo più grande rivale era Joseph Paxton, il capo giardiniere del duca di Devonshire. Nel 1849 gli inflisse la suprema umiliazione di riuscire a far fiorire per la prima volta Amherstia nobilis; ottenne quel risultato semplicemente lasciando aperta la porta della serra. Da allora, finché Louisa visse, il miracolo si ripeté ogni anno. Alla sua morte, nel 1855, la pianta venne trasferita a Kew, dove fiorì ancora per tre anni, poi morì. Ma nel frattempo i suoi fiori erano stati offerti alla regina Vittoria e aveva fatto in tempo a vederla e disegnarla anche Marianne North. Come scrive nelle sue memorie, furono anzi quei meravigliosi fiori ad accendere il suo desiderio di viaggiare per dipingere piante esotiche: "Una volta Sir William Hooker mi diede un mazzo di Amherstia nobilis, uno dei più grandi fiori esistenti. Era la prima volta che fioriva in Inghilterra, e quel dono mi fece desiderare ancora di più di vedere i tropici". Amherstia nobilis è l'unica specie del suo genere (famiglia Fabaceae). E' originaria delle foreste umide della Birmania e della Tailandia, ma in natura è molto rara. Considerata sacra, nel sudest asiatico viene spesso piantata nei giardini dei templi, in modo da poterne offrire i fiori freschi alle immagini del Budda. Inoltre è stata introdotta in altri paesi tropicali, anche se, come si è potuto notare, la sua coltivazione non è semplice, quindi a coltivarla sono soprattutto gli orti botanici. E' un albero sempreverde, alto fino a 15 metri, con chioma arrotondata, eleganti rami penduli e lunghe foglie composte. Fiorisce due volte l'anno, in ottobre e in aprile, e ciascuna volta per appena due o tre giorni. Le infiorescenze, lunghe anche 80 cm, portano venti fiori o più; retti da piccioli con la parte terminale cremisi, hanno cinque petali diseguali, quelli superiori più piccoli anch'essi cremisi, quelli medi cremisi con apici gialli, quello centrale di dimensioni maggiori, a forma di ventaglio con un triangolo giallo che si estende dal labbro alla gola; molto decorativi anche gli stami arcuati, rosso chiaro con antere gialle. Anche i frutti, a forma di scimitarra e dapprima rossi, sono di piacevole aspetto. La spettacolare pianta è nota anche con il nome "orgoglio di Birmania". Altre informazioni nella scheda. Nel settembre 1534, il medico portoghese Garcia de Orta, figlio di una coppia di ebrei espulsi dalla Spagna e costretti alla conversione forzata, sbarca a Goa. A spingerlo a venire in India, da una parte, l'angosciosa situazione dei marrani, gli ebrei convertiti; dall'altra la curiosità per quel mondo esotico, ma in qualche modo familiare, visto che ne sono originarie molte droghe che usa nella sua professione. Si stabilisce a Goa, diventa il medico di fiducia di maggiorenti indiani e portoghesi, commercia in spezie e gioielli, impara dai suoi numerosi corrispondenti i principi delle medicine unani e ayurvedica, fa esperimenti e coltiva un orto botanico di acclimatazione. Frutto di trent'anni di vita e di ricerche nel subcontinente il suo originalissimo Colóquios dos simples e drogas he cousas medicinais da Índia segna il primo vero incontro tra la botanica europea e la flora indiana. Ma, come il suo autore, sarà vittima dell'intolleranza religiosa: dodici anni dopo la sua morte, l'Inquisizione sottopone Garcia de Orta a un processo postumo e ne condanna le spoglie al rogo e i libri all'Indice. Se nonostante tutto, i Colóquios hanno lasciato un segno nella storia della botanica e nella conoscenza delle piante indiane è merito di Corolus Clusius, che li scoprì durante un viaggio in Portogallo e li tradusse in latino. Un medico di origini ebraiche scopre l'India Il 12 marzo 1534, al comando di Martim Afonso de Sousa, ammiraglio dei mari delle Indie, una squadra di cinque navi salpa da Lisbona alla volta di Goa. A bordo, nelle vesti di medico personale dell'ammiraglio e di medico capo della flotta, il dottor Garcia de Orta. Ha poco più di trent'anni, e potremmo considerarlo un uomo arrivato: è molto reputato nella sua professione e da qualche anno tiene lezioni di filosofia naturale all'Università della capitale. Eppure quando don Martim Afonso gli propone di accompagnarlo in India, non esita a lasciare tutto per seguirlo. Dietro quella scelta, almeno due ragioni. Una è il fascino dell'India, ancora quasi inedita per gli Europei, se si pensa che Vasco da Gama è sbarcato sulle sue coste appena nel 1497. Inedita, ma in un certo senso anche familiare, visto che proprio dall'India parte la via delle spezie e proprio da lì arrivano molte delle sostanze che egli usa nel suo lavoro. Anzi, è stupito che i suoi conterranei vedano l'India solo come una fonte di guadagno, senza provare alcuna curiosità per quel mondo tutto da scoprire. La seconda ragione è più drammatica. Garcia de Orta è figlio di una coppia di conversos, ebrei che sono fuggiti dalla Spagna nel 1492 in seguito al decreto di espulsione dei re cattolici e nel 1497, per poter rimanere in Portogallo, si sono dovuti sottomettere alla conversione forzata. Hanno avuto la fortuna di trovare un protettore nel nobile Lobo de Sousa (il padre di dom Martim Afonso), grazie al quale Garcia ha potuto studiare nelle prestigiose università spagnole di Salamanca e Alcalá, e poi avviare una carriera di successo come medico e insegnante universitario. Ma è pur sempre un converso, anzi un marrano (un insulto che forse significa porco) che potrebbe cadere vittima di un pogrom come quello della Pasqua del 1506, quando a Lisbona la folla, istigata dai frati domenicani, massacrò quasi 2000 ebrei convertiti. E si vocifera che l'Inquisizione stia per essere istituita anche in Portogallo. A settembre la flotta getta l'ancora a Goa e Garcia de Orta sbarca per la prima volta nella terra che non lascerà più fino alla morte, trentaquattro anni dopo. Per quattro anni, accompagna il suo protettore in tutte le sue imprese: la cessione di Diu e la costruzione della sua fortezza; la devastazione dei porti del Samorin di Calcutta e dei suoi alleati; la guerra contro i corsari. Ogni volta che ne ha l'occasione, scende a terra, avido di scoperte: osserva ogni cosa, si informa sulle persone, i costumi, le lingue, impara tutto quello che può sulle piante e le tradizioni mediche locali. Un incontro molto importante è quello con il sultano di Ahmadagar, Buhran Nizam Shah, un principe tollerante, che si circonda di uomini di scienza e lettere senza badare alla loro origine; alla sua corte, Garcia da Orta conosce medici arabi e indiani, da cui apprende i principi delle medicine unani e ayurvedica. Nel 1538, quando l'ammiraglio viene momentaneamente richiamato in patria, il medico preferisce rimanere in India: la ama con tutto il cuore, ha ancora molto da scoprire, inoltre i suoi timori si sono concretizzati con l'istituzione dell'Inquisizione anche in Portogallo nel 1536. Si stabilisce a Goa, dove acquista una casa e esercita la professione medica, integrata con attività redditizie come il commercio di spezie e di pietre preziose. Ha molti clienti, sia tra i portoghesi sia tra gli indiani, ma anche incarichi ufficiali, come medico dell'ospedale cittadino e della prigione. Piante indiane e Inquisizione Da questo momento, troppo impegnato con le sue varie attività, Garcia de Orta non viaggia più, ma vivendo a Goa, il centro del commercio portoghese delle spezie, ha modo di incontrare persone di ogni genere e di accedere a molte fonti di informazione. Nelle botteghe multietniche del bazar (i mercanti sono indiani, arabi, persiani) trova oggetti curiosi, frutti esotici, spezie ed erbe medicinali. La sua rete di agenti commerciali e di corrispondenti gli spedisce piante e semi da altre regioni del subcontinente. Il dottore, che oltre al portoghese, all'ebraico e alle lingue classiche, parla bene anche l'arabo, si intrattiene con tutti, si interessa di tutto, ma soprattutto di medicina, spezie, piante: di ciascuna vuole conoscere il luogo di coltivazione, gli usi, gli effetti terapeutici. Nella sua casa c'è un piccolo museo di curiosità (che anni dopo farà la delizia del poeta Luis de Camões, suo intimo amico) e una fornita biblioteca, dove accanto ai classici che ha portato con sé dal Portogallo e ai testi arabi che ha acquistato in India, ci sono tutte le più importanti novità dei medici e dei naturalisti europei che si fa spedire dalla madre patria. Sul retro ci sono un piccolo orto-giardino dove coltiva le piante medicinali che sperimenta sui suoi pazienti e qualche albero da frutto. Nel 1541 Martim Afonso de Sousa ritorna a Goa come viceré, incarico che manterrà fino al 1546, e di nuovo vuole Garcia de Orta come medico personale. Anche i successori lo stimano e uno di essi nel 1548 gli assegna in enfiteusi l'isola di Mombain (qui più tardi sorgerà la città di Bombay, oggi Mumbai); il dottore ora può fare esperimenti molto più in grande nel curatissimo orto botanico o giardino di acclimatazione, dove coltiva piante di ogni provenienza. E' un personaggio estremamente stimato, con molti amici, tra cui appunto Camões, che arriva a Goa nel 1555, e il dottore Dimas Bosque, che vi giunge nel 1558 al seguito del nuovo governatore Constantino de Bragança. E' probabilmente questa rete di amici e protettori a tenere lontane dalla sua persona le ombre dell'Inquisizione. Dal canto suo, il dottore bada ad allontanare ogni sospetto: va a messa ogni giorno, ha relazioni cordiali con francescani, domenicani e gesuiti e assiste alle loro cerimonie pubbliche. Tuttavia, il pericolo si fa sempre più vicino. Nel 1548, le sorelle Isabel e Catarina, rimaste in Portogallo, vengono arrestate; rilasciate, fortunatamente possono raggiungerlo a Goa, insieme alla vecchia madre e alle rispettive famiglie. Ma proprio a Goa, nel 1557, si tiene un processo contro un gruppo di venti conversos accusati di praticare segretamente il giudaismo; poiché nella colonia non esiste ancora l'Inquisizione, vengono inviati a Lisbona dove una donna è arsa viva. E' la premessa per l'istituzione dell'Inquisizione anche a Goa, nel 1560 (a richiederla a gran voce è Francesco Saverio). Orta riesce probabilmente a ingraziarsi l'inquisitore Aleixo Dias Falcão, appena arrivato nell'isola; rassicurato dalla fama del dottore e dai suoi protettori altolocati, nel 1563 egli concede l'imprimatur alla pubblicazione di Colóquios dos simples. Egli ignora che in quel momento Garcia de Orta è già nella lista dei sospetti: nel 1561 a Lisbona è stato arrestato un suo nipote; rilasciato dopo lunga detenzione, ha fatto il nome dello zio e l'Inquisizione portoghese ha aperta un'inchiesta su di lui. Falcão viene a trovarsi in una situazione imbarazzante che forse spiega perché, fino alla morte di Gracia de Orta, avvenuta nei primi mesi del 1568, questi venga lasciato in pace. Ma pochi mesi dopo, sua sorella Catarina è nuovamente arrestata, processata, costretta alla confessione e bruciata viva in un autodafé; sottoposta a tortura, ha denunciato anche il fratello. Se il dottore è ormai irraggiungibile, non lo sono né le sue spoglie né la sua opera. Nel 1572 gli viene intentato un processo postumo, in cui è assolto; ma, processato nuovamente nel 1580, viene condannato: l'Inquisizione ordina di esumare il cadavere e di gettarlo alle fiamme insieme a tutte le copie reperibili dei Colóquios. Il suo nome diventa maledetto e la sua opera proibita. Per una sintesi della vita, si rimanda alla sezione biografie. 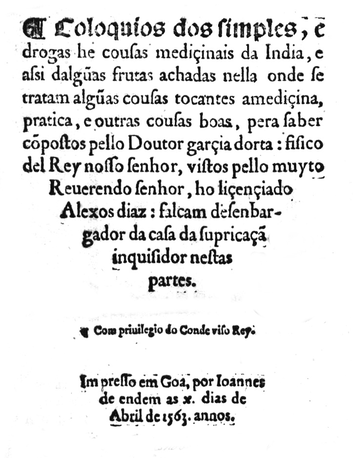 Dialoghi sui semplici e le droghe dell'India In questo modo rischiò di scomparire l'opera che segna il primo incontro tra la botanica europea e le piante indiane: Colóquios dos simples e drogas e coisas medicinais da Índia, "Dialogo sui semplici, le droghe e la materia medica dell'India", che come ho anticipato Garcia de Orta pubblicò a Goa nel 1563. Era il frutto di un trentennio di studi ed esperienze sulla medicina, le spezie e le piante medicinali dell'India, anche se non sappiamo quando esattamente il medico portoghese abbia iniziato a scriverla. Quando venne data alle stampe, l'arte della tipografia era neonata a Goa, e il tipografo Ioannes de Endem commise tanti errori che per correggerli furono necessarie più di venti pagine di errata corrige, un record nella storia dell'editoria. Il libro è aperto dalla dedica al viceré Martim Afonso de Sousa, dall'introduzione di Dimas Bosque e da due poesie: una di un poeta locale non meglio noto, l'altra di Camões, la prima sua ad essere pubblicata: è una lirica encomiastica in cui il viceré è paragonato ad Achille e Garcia da Orta al centauro Chirone, suo maestro nell'arte medica e nella conoscenza delle erbe. Non mancano giochi di parole tra Orta, il cognome del dottore, e orta, che in portoghese significa giardino. Colóquio dos simples è un'opera originale da ogni punto di vista, a cominciare dalla lingua e dalla forma. Garcia de Orta decise di scriverla in portoghese, anziché in latino, una scelta che ne limitava la diffusione internazionale, ma allargava il pubblico potenziale dei lettori portoghesi ai non specialisti. La forma è quella del dialogo tra due personaggi: lo stesso Garcia de Orta e il dottor Ruano, che si immagina laureato ad Alcalá e appena giunto a Goa con l'intenzione di saperne di più sulle piante medicinali e le spezie indiane. Occasionalmente intervengono anche altri personaggi, tra cui la schiava Antonia, assistente di Orta, Dimas Bosque e un medico indiano. Si ritiene generalmente che entrambi i personaggi principali siano proiezioni dell'autore: Ruano è Orta al momento del suo arrivo in India, un giovane studioso con una preparazione ancora libresca, ma desideroso di apprendere, Orta è sempre lui, ma vecchio e ormai esperto di cose indiane dopo trent'anni di vita e pratica medica in India. Suddiviso in 59 dialoghi, di cui il primo funge da introduzione, Colóquios dos simples tratta in ordine alfabetico una settantina di sostanze medicamentose o semplici, 56 delle quali vegetali; si aggiunge qualche prodotto animale (l'ambra, il benzoino, l'avorio, le perle) o minerale (i diamanti e le pietre preziose). Molte sono allo stesso tempo familiari e esotiche: percorrendo la via delle spezie, raggiungono l'Europa da secoli, sono oggetto del commercio più redditizio (e i portoghesi sono qui proprio per assicurarsene il monopolio), ne parlano gli autori antichi, a cominciare da Dioscoride, Plinio e Galeno, oppure gli scrittori arabi. Tuttavia quelli che arrivano nelle botteghe degli speziali e nelle cucine dei ricchi sono semi, foglie, cortecce, radici essiccate; delle piante in sé, si sa poco o nulla. Orta è perfettamente consapevole di essere praticamente il primo studioso europeo ad averle viste nelle loro condizioni naturali; e, benché conosca bene i classici, proclama che la loro autorità viene meno di fronte all'esperienza diretta: "Inutile cercare di intimorirmi con Dioscoride o Galeno, io dico solo la verità e ciò che so". Altrettanta indipendenza di pensiero dimostra verso i botanici contemporanei, che in Europa discettano da lontano di ciò che non hanno mai visto. Dunque, anche se in Europa di molte piante si conosce il nome o i prodotti, Colóquios dos simples è un'opera di novità assoluta. Ovviamente ci sono le spezie e le sostanze aromatiche note fin dall'antichità e citate dagli autori classici: cannella, cardamomo, chiodi di garofano, zenzero, noce moscata, pepe, aloe, canfora, calamo aromatico, incenso, mirra; quelle che avevano raggiunto l'Europa solo nel Medioevo, di cui parlavano le fonti arabe: curcuma, galanga, sandalo, tamarindo; ma in molti casi, soprattutto per i frutti, quella di Garcia de Orta è la prima trattazione: carambola, giuggiola, mangostano, jackfruit, litchi, cocco delle Maldive, mango, neem. E anche quelle apparentemente note finalmente escono dalla leggenda e dal sentito dire. Ogni dialogo tratta una singola sostanza, o al più un gruppo di sostanze affini, e segue uno schema ricorrente, che possiamo esemplificare con la prima ad essere discussa, Aloe socotrina (Dialogo 2), forse da identificarsi con Aloe perryi Baker. Si inizia con il nome in varie lingue: prima latino e greco, quindi arabo, diverse lingue indiane, spagnolo, portoghese, turco, persiano. Si prosegue con la provenienza: è coltivata in vari luoghi, ma la migliore viene da Socotra. Seguono informazioni sul suo commercio, correggendo la falsa credenza che cresca ad Alessandria, dovuta al fatto che, prima che i portoghesi aprissero la via diretta con le Indie, la via delle spezie faceva capo a quel porto. A questo punto Orta ne discute l'uso medico, riportando sia quanto ne dicono le fonti arabe sia quanto ha appreso da altri medici sia ancora ciò che egli stesso ha sperimentato sui suoi pazienti. La pianta non viene descritta (e questa è l'eccezione, non la regola), ma se ne analizza il sapore e l'odore. Infine si discutono gli effetti collaterali, sui quali, in base alla sua esperienza, Orta si trova in accordo con Avicenna, e in disaccordo con Mesuè (ovvero Yuhanna ibn Masawayh). Nei dialoghi si inseriscono ogni sorta di digressioni, con informazioni sulla geografia, i popoli, i commerci, e aneddoti curiosi. Per la storia della medicina, è di particolare interesse il dialogo 17, in cui, a proposito del Costus, Gracia de Orta dà la prima descrizione clinica del colera. Era una malattia nuova per i medici portoghesi, che non sapevano come curarla; Orta raccolse informazioni sulle cure e le erbe usate dai medici locali, rivolgendosi anche ai loro pazienti portoghesi, visto che i medici indiani era poco inclini a svelare i segreti professionali, e le provò sui suoi pazienti, ottenendo risultati molto migliori di quelli dei colleghi. Eseguì anche un'autopsia su una delle vittime, la prima praticata in Asia da un medico europeo. 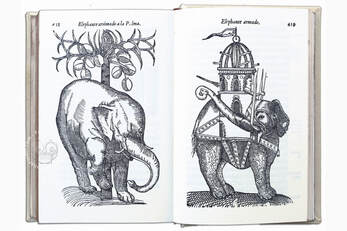 Traduzioni, rifacimenti, plagi e giardini Pubblicati nella remota Goa in un'edizione infarcita di errori tipografici, in una lingua periferica e condannati all'oblio dall'Inquisizione, nonostante la loro importanza i Colóquios dos simples hanno rischiato di sparire dalla storia della scienza. Libro rarissimo, è stato preservato in meno di venti copie, nessuna delle quali si trova a Goa. Ma prima della condanna, qualcuna aveva fatto in tempo ad arrivare nelle biblioteche portoghesi. Appena un anno dopo la pubblicazione, una capitò nelle mani di Carolus Clusius, che stava visitando la penisola iberica come accompagnatore di un giovane Fugger. Capì immediatamente la sua importanza e decise di tradurlo in latino, la lingua internazionale della scienza. Tornato nelle Fiandre, lo pubblicò ad Anversa per i tipi di Plantin con il titolo Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indios nascentium (1567). Come spiega lo stesso Clusius nell'introduzione, non si tratta di una traduzione integrale, ma di un compendio e in un certo senso di un rifacimento: "Ho tradotto i Colloqui in latino, quindi li ho ridotti in epitome, scrivendo ogni capitolo in modo individuale e in un ordine più adatto di quello originale, espungendo diversi argomenti che non giudico importanti". In particolare, Clusius elimina la forma dialogica e trasforma il libro in un trattato; scarta le digressioni non rilevanti per la botanica e la medicina; aggiunge un indice dei nomi e le referenze bibliografiche degli autori citati; inoltre, per quanto riguarda l'origine geografica e le virtù medicinali delle piante, integra quanto più possibile il testo con notizie ricevute da altri informatori. Insomma, un libro tutto diverso, e decisamente più rispondente agli standard accademici; senza parlare dell'edizione: non c'è raffronto possibile tra la terremotata edizione dell'apprendista tipografo Joannes de Endem e la curatissima edizione plantiniana, corredata anche da una quindicina di xilografie. Non stupisce dunque che a circolare non sia stata l'edizione originale, ma l'epitome di Clusius; il botanico fiammingo continuò a lavorarci per tutta la vita, pubblicandone cinque edizioni successive, costantemente riviste e ampliate, e incluse quella finale nella sua ultima opera, Exoticorum libri decem (1605). Risalgono anche al testo di Clusius le traduzioni in lingue moderne, come quella italiana precoce di Briganti (1589). E' invece almeno in parte un rifacimento del testo originale di Orta il Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales del medico portoghese Cristóvão da Costa, più noto con il nome spagnolo Cristobal Acosta, pubblicato in lingua spagnola nel 1567. Acosta era vissuto a lungo in India e aveva conosciuto di persona Garcia de Orta. Anch'egli riorganizzò la struttura dei Colóquios, ne corresse gli errori, corredò il testo di illustrazioni e aggiunse la trattazione di semplici non contemplati nell'originale; ma il Tractado, in modo meno trasparente del lavoro di Clusius, non si presenta come un'epitome dei Colóquios, ma come un'opera a sé che "verifica" quanto scritto da Orta, come enuncia il sottotitolo: "Trattato delle droghe e delle medicine delle Indie Orientali [...] di Cristobal Acosta, medico e chirurgo che le vide con i suoi occhi: nel quale si verifica molto di ciò che è stato scritto dal dottor Garcia de Orta". Ecco perché molti commentatori parlano esplicitamente di plagio. In ogni caso, grazie a Clusius (che tradusse in latino ed incluse in Exoticorum libri decem anche il testo di Acosta) l'opera e il nome di Garcia de Orta furono conosciuti dai botanici europei, andando a costituire una fonte imprescindibile per gli studiosi successivi. Per leggere il testo originale, tuttavia, bisognò attendere il 1872 quando ne fu stampata la prima edizione moderna, che lo riproduce pagina per pagina ma corregge silenziosamente gli errori tipografici, e quindi non è un facsimile. Seguì tra il 1891 e il 1895 la prima edizione critica commentata. Ormai i tempi erano cambiati e il marrano Garcia de Orta poteva essere riconosciuto come una gloria nazionale. Nel 1998, in occasione dell'Expo di Lisbona, nel Parque das Nações è stato creato il Jardim Garcia d'Orta che ospita cinque giardini tematici con ecosistemi delle zone toccate dai navigatori portoghesi nell'età delle scoperte: la foresta temperata di Macao e dell'isola di Coloane; la vegetazione di Goa, dominata dai palmizi; la foresta tropicale umida di São Tomé e Príncipe; la flora della Macaronesia (Madera, Azzorre e Canarie); la flora semidesertica e le savane della costa orientale dell'Africa. Un piccolo giardino con lo stesso nome si trova anche a Panjim, la capitale del distretto nord di Goa. A rendere omaggio a Orta i botanici avevano pensato da un pezzo, dedicandogli successivamente tre generi: Garcinia, stabilito da Linneo nel 1753; Garciana, creato dal conterraneo Loureiro nel 1770 (oggi sinonimo di Phylidrum); Horta, stabilito dal brasiliano Vellozo e pubblicato nel 1829 (oggi sinonimo di Clavija). L'unico valido è dunque quello linneano; ma poiché Garcia da Orta deve condividerlo con un altro dedicatario, per saperne di più dovete aspettare il prossimo post. Chi è l'autore di un'opera a cui hanno messo mano decine di persone? Chi l'ha concepita? Chi ne ha dettato il testo? Chi l'ha scritta materialmente? Chi l'ha rivista? Chi ne ha curato l'editing e la stampa? Ripercorrendo la storia di un eccezionale testo botanico di fine Seicento, l'Hortus Malabaricus, probabilmente non troveremo la risposta, ma conosceremo indiani, portoghesi, olandesi che lavorano insieme alla prima opera etno-botanica della storia. Molti avrebbero meritato di dare il proprio nome a un genere, ma alla fine ci sono riusciti solo in tre, e più fortunati sono stati gli ultimi arrivati, i Commelin, che hanno dato il loro nome al notissimo genere Commelina. 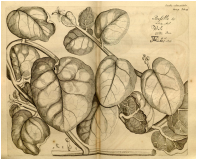 Prima tappa: 1670-1675, Cochin, Malabar Nel 1602 a Amsterdam viene fondata la Compagnia olandese delle Indie Orientali (Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie, meglio nota con la sigla VOC); per circa 150 anni - fino all'affermazione dell'Inghilterra come superpotenza coloniale - essa avrà il monopolio del commercio delle spezie lungo le rotte che collegano l'Europa al Capo di Buona Speranza, all'India e all'Indonesia. Nei luoghi strategici vengono creati avamposti commerciali, che sono allo stesso tempo porti, empori e fortezze. Uno di essi è Cochin, sulla costa indiana del Malabar, strappato nel 1663 ai Portoghesi. A differenza di questi ultimi, che avevano cercato di imporre la religione cattolica, gli olandesi calvinisti si dimostrano molto più tolleranti. Anche i rapporti con il sovrano del Malabar (detto Samoothirippadu, che nelle lingue occidentale diventa Zamorin) sono relativamente positivi. E' in questo contesto che Hendrik van Rheede, governatore del Malabar olandese tra 1670 e il 1677, progetta un'opera senza precedenti: esplorare e catalogare l'intera flora locale, allo scopo fondamentale di individuare piante medicinali utili contro le malattie tropicali. L'aspetto più originale, che sicuramente contribuisce alla riuscita del progetto, è il coinvolgimento dell'intellighenzia locale; l'opera è affidata a un'équipe di 15-16 persone che comprende medici e studiosi indiani, capeggiati dal medico ayurvedico Itty Achudan; un disegnatore, il frate carmelitano Johannis Mathei, noto come padre Matteo; traduttori dalla lingua locale (il malayam) al portoghese, dal portoghese all'olandese e infine dall'olandese al latino (lingua della redazione finale). Essenziale - per assicurare i contatti con l'équipe indiana e permettere il lavoro di raccolta degli esemplari - è anche la benevola assistenza del re di Cochin e dello Zamorin di Calcutta. Per due anni, il territorio viene accuratamente esplorato da un centinaio di raccoglitori; ciascun esemplare è portato a Cochin e accuratamente disegnato da padre Matteo; quindi Achudan detta in malayan la descrizione della pianta, corredata di note mediche e etnografiche (spesso tratte da manoscritti su foglie di palma, tramandati di generazione in generazione nella sua famiglia di medici); il suo lavoro è discusso con gli altri membri dell'équipe e validato dalla supervisione di tre medici-bramini. Alla fine, vengono catalogate e descritte circa 800 piante; gli esemplari, inseriti in fogli di carta corredati con i nomi in malayam, latino, olandese e altre lingue e accompagnati dai disegni e dalle descrizioni vengono quindi spediti a Amsterdam, per essere trasformati in un'opera a stampa.  Seconda tappa: 1678-1703, Amsterdam, Paesi Bassi Prima che il materiale così raccolto sia pubblicabile occorre ancora molto lavoro e il coinvolgimento di molte altre persone (medici, botanici, incisori, tipografi...). L'intero testo deve essere rivisto da botanici e medici europei; bisogna realizzare le tavole calcografiche e curare la stampa; insomma per completare l'opera, che alla fine comprenderà 12 volumi di circa 200 pagine ciascuno, in folio, con 794 calcografie (712 delle quali a doppia pagina), saranno necessari altri venticinque anni; il primo volume esce nel 1678, l'ultimo nel 1703. Van Reede nel 1678 rientra ad Amsterdam e affida la redazione dell'opera, iniziata in India dal suo collaboratore, il pastore Johannes Casearius, a Arnold Seyen, professore di medicina a botanica a Leida. Poco dopo la pubblicazione del primo volume, questi però muore. Il principale curatore dell'opera a questo punto diventa il botanico dilettante Jan Commelin che, in collaborazione con diversi studiosi, redigerà i volumi 2-11 e parzialmente il volume 12. Saranno 25 anni di lavoro che si interromperà solo con la morte. Il poco che ancora rimane sarà portato a termine dal nipote, Caspar Commelin, che redigerà anche un indice plurilingue delle specie citate. Jan Commelin era un mercante di prodotti farmaceutici che, grazie al successo commerciale, aveva fatto carriera fino a diventare borgomastro della città di Amsterdam; appassionato di botanica, gli era stata affidata la direzione dell'Hortus medicus della capitale olandese quindi la sovrintendenza di tutte le aree verdi della città. Il nipote era un medico e botanico che, in un certo senso, aveva "ereditato" dallo zio la carica di direttore dell'Hortus medicus, ne terminò le opere e insegnò medicina e botanica all'Università di Amsterdam. Altre notizie sui due botanici olandesi nella sezione biografie. Linneo consultò e apprezzò il grande libro sulla flora del Malabar: anzi arrivò ad affermare che a suo parere le uniche descrizioni affidabili era quelle dell'Hortus Elthamensis di Dillenius, del Nova plantarum americanarum genera di Plumier e dell'Hortus malabaricus di van Reede; anzi queste ultime erano le più accurate delle tre. Non stupisce quindi che nell'assegnare il nome a piante del subcontinente egli abbia ripreso molti nomi dell'Hortus malabaricus; K. S. Manilal, studioso e curatore delle edizioni moderne inglese e malayan dell'opera ha calcolato che Linneo ha riutilizzato 258 nomi malayan. Fonte: B. Dharmapalan, Hortus Malabaricus, Celebrating a Tricentennal of a Botanic Epic, http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/14856/1/SR%2049(10)%2026-28.pdf  Casearia, ovvero amici filosofi Tra i tanti personaggi che abbiamo incontrato in questa storia, cinque hanno avuto l'onore di dare il loro nome a un genere. Nella lotteria del Who's who della botanica, l'assegnazione non sempre corrisponde però ai meriti. L'ideatore (che viene sempre citato come "autore" dell'opera, di cui probabilmente non ha scritto una riga), Hendrik van Rheede si è visto assegnare Rheedia, un genere di alberi tropicali della famiglia delle Clusiacaee oggi non più accettato (è sinonimo di Garcinia); ha dato anche il nome specifico a Entada rheedi, una Fabacaea di origine africana dagli enormi baccelli. Ugualmente sfortunato Itty Achudan; nell'Ottocento Carl Ludwig Blume - un botanico olandese di origine tedesca che aveva lavorato a lungo nell'Asia olandese - gli dedicò il genere Achudemia, che tuttavia oggi è considerato una sezione del genere Pilea (Urticacaee). Più fortunato nella memoria postuma Johannes Casearius, il giovane pastore al quale van Rheede aveva affidato la versione latina dell'opera. Ma sfortunatissimo nella vita reale: la morte precoce gli impedì di andare oltre il secondo volume. Il suo contributo avrebbe potuto essere ben più importante, visto che gli si deve anche la stesura del disegno generale, esposto nella prefazione. Giovanissimo studente di teologia a Leida (all'epoca doveva essere sui diciotto anni) gli era capitata la ventura di condividere l'abitazione con Spinoza; il filosofo prese a esporgli gli elementi essenziali della filosofia di Descartes, che più tardi pubblicò nella sua unica opera edita in vita, I principi della filosofia di Cartesio (1663). In una lettera ad un altro membro del suo circolo, Simon de Vries, lo invita a non essere geloso di Casearius e della sua intimità con lui; dice anzi di odiarlo per il suo infantilismo e la sua superficialità, ma di amarlo per il suo talento, che fa bene sperare per il futuro. Casearius frequentò ancora Spinoza per qualche tempo; poi, dopo aver completato gli studi di teologia a Leida e Utrecht, divenne pastore ad Amsterdam e si sposò. Nel 1668 come pastore della VOC fu inviato a Cochin e collaborò con van Rheede all'edizione latina di Hortus Malabaricus fino al 1677, quando morì di dissenteria a poco più di trent'anni. Memore del suo contributo, il botanico austriaco von Jacquin volle dedicargli Casearia, un importante genere di alberi tropicali della famiglia Salicaceae (un tempo Flacourtiaceae). Ampiamente distribuito nella fascia tropicale e subtropicale di America, Asia, Africa e isole del Pacifico, comprende 180-200 specie di arbusti o alberi, alcuni dei quali di notevoli dimensioni. Come altre piante di questa famiglia, contengono principi attivi e alcune specie sono state ampiamente utilizzate nella medicina popolare in America e in Asia, in particolare come antisettici, cicatrizzanti e anestetici. Ad esempio, C. sylvestris, un grande arbusto nativo delle Antille, dell'America centrale e della parte settentrionale di quella meridionale, dove è noto con vari nomi, tra cui il brasiliano guacatonga, ha una lunga storia di usi medicinali in tutti i paesi in cui vive: la sua corteccia e le sue foglie sono state usate per combattere le ulcere, i morsi di insetti, addirittura le piaghe della lebbra. C. decandra, un alberello deciduo diffuso dai Caraibi al Brasile, ha invece frutti eduli, che vengono raccolti in natura e consumati a livello locale. Ugualmente eduli sono i frutti della sudamericana C. rupestris, un albero molto ornamentale delle foreste semidecidue, con una elegante chioma piramidale. Qualche approfondimento nella scheda.  Chi sono i petali di Commelina? Ma il genere più noto e familiare è indubbiamente toccato agli ultimi venuti, ovvero ai due Commelin, zio e nipote, che sono per altro anche i più illustri nella storia della botanica come fondatori dell'Orto botanico di Amsterdam. Già Plumier nel 1703 dedicò loro il genere Commelina (famiglia Commelinacae), celebrandoli come autori di un'altra opera comune ai due, il catalogo dell'Hortus medicus di Amsterdam. Probabilmente l'assegnazione si basa sul fatto che il fiore della specie da lui descritta (si tratta presumibilmente di Commelina erecta) in apparenza ha due soli petali, ciascuno dei quali rappresenta uno dei due botanici olandesi. Linneo - che usò come specie di riferimento Commelina communis - confermerà l'omaggio, ma con una precisazione: questa pianta può bene rappresentare i Commelin, perché ha due petali vistosi, mentre il terzo è insignificante; i primi due stanno per due illustri botanici (Jan e Caspar), mentre il terzo per un altro Commelin (Caspar il giovane, morto a trent'anni) a cui la morte non ha permesso di fare nulla. Il genere Commelina è diffuso in tutta l'area tropicale e subtropicale, comprende circa 170 specie e ha dato il proprio nome alla famiglia delle Commelinacaee. Per altre notizie, si rimanda alla scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


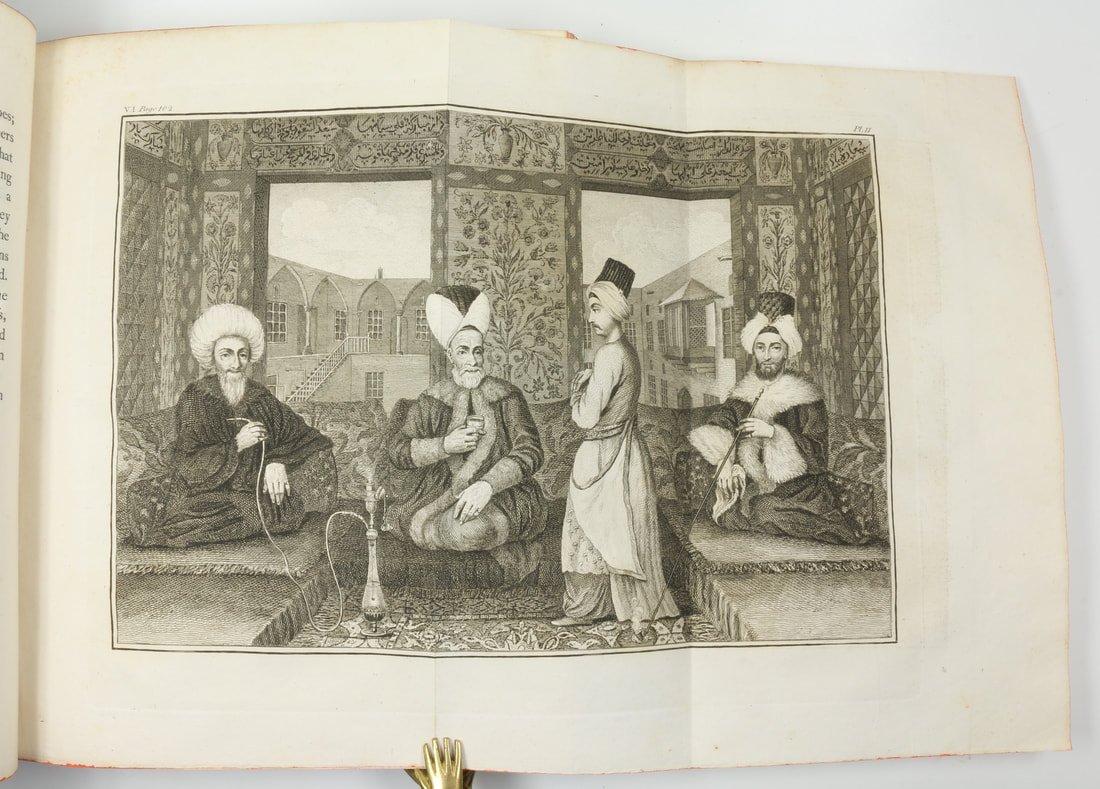


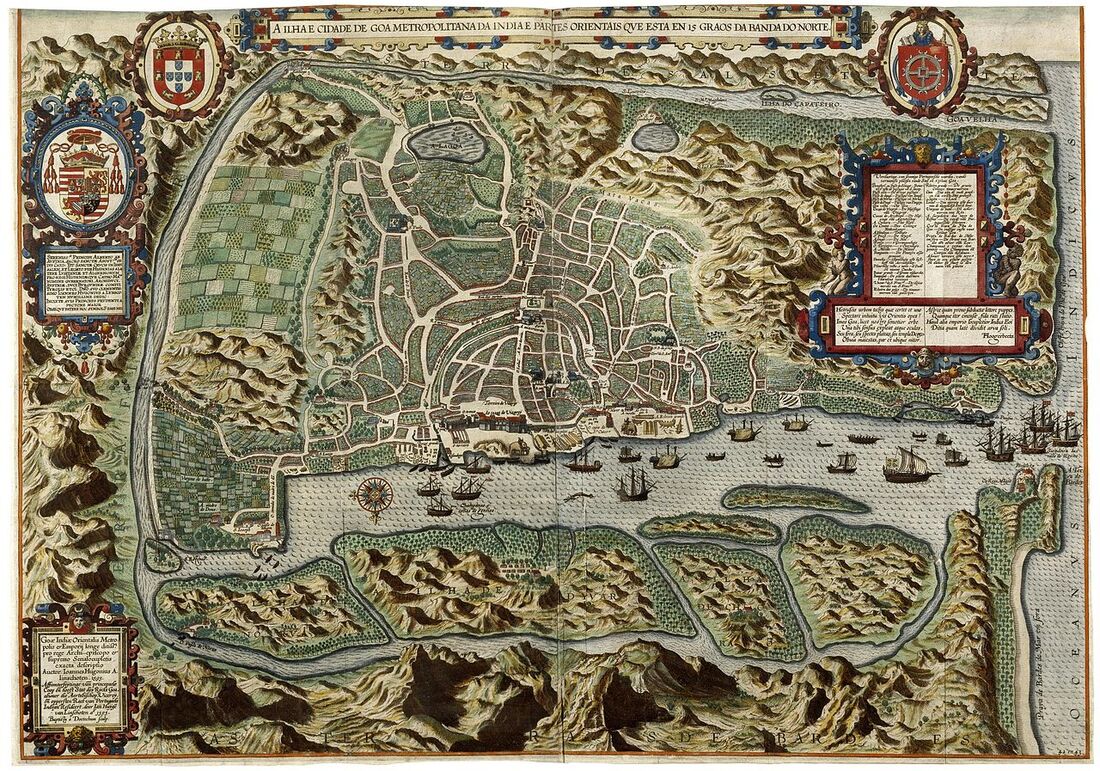


 RSS Feed
RSS Feed