|
Completiamo il racconto della spedizione La Pérouse seguendo la Boussole e l'Astrolabe prima nei mari della Siberia, dove il comandante fa le scoperte geografiche più importanti, compreso lo stretto che porta il suo nome, e forse si riconcilia con i "diavolacci" naturalisti. Dopo una breve sosta in Kamčatka, dove sbarca l'ultimo sopravvissuto, le accompagniamo nei sognati mari del sud, dove un gruppo di isolani mette fine al mito del buon selvaggio facendo a pezzi il secondo Fleurot de Langle e il combattivo geologo Lamanon. Con i nostri naviganti provati nel corpo e nello spirito, arriviamo a Botany Bay, dove è appena avvenuto un evento di portata storica. Poi le navi ripartono e scompaiono nel nulla, inghiottite da un mistero lungo quarant'anni. Ma di misteri ce ne sono altri, tra cui: che c'entra il sudafricano genere Galopina con il comandante La Pérouse? 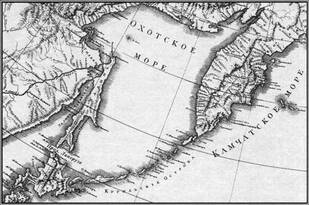 Idillio geografico-naturalistico: esplorando la Tartaria In questo post, avevamo lasciato la Boussoule e l'Astrolabe a Manila. Il dieci aprile 1787, con l'equipaggio al completo, gli scafi in stato perfetto e le stive cariche, salpano dirigendosi di nuovo a nord. L'obiettivo è la costa asiatica del Pacifico settentrionale: al contrario di quella americana (per non parlare del Pacifico meridionale, che Cook ha battuto isola per isola) è ancora poco nota ai navigatori europei e c'è molto da scoprire; è l'occasione tanto attesa da La Pérouse, che è un grande ammiratore di Cook ma è anche ossessionato dal suo fantasma. La navigazione procede rapida e senza scali fino al 23 giugno, quando, dopo aver risalito la Corea, le navi sostano nella baia di Ternej, in "Tartaria" (ovvero in Siberia). Da questo momento inizia l'esplorazione vera e propria, con la rilevazione accurata delle coste siberiane; sono finalmente appagati anche i naturalisti, Lamanon che scopre cristalli, quarzi e pietre curiose, i botanici affascinati dalla vegetazione che nell'arco di tre mesi nasce dal terreno gelato in profondità (è il permafrost), fiorisce e muore; a stupire tutti è anche la grande quantità e varietà di uccelli. Forse anche le tensioni di Macao sono acqua passata e i diavolacci sono meno diabolici: il comandante ribattezza due montagne Pic Lamanon e Pic La Martinière. Le due navi si addentrano nello stretto dei Tartari, che separa il continente da Sachalin; La Pérouse è stato informato dai pescatori locali che si tratta di un'isola e cerca un passaggio a nord, ma là dove il canale si restringe e i fondali si fanno sempre più bassi, desiste; la Boussole e l'Astrolabe invertono la rotta e tornano a sud, per doppiare l'isola passando attraverso lo stretto che separa Sachalin da Hokkaido; oggi, in onore del comandante, si chiama Stretto di La Pérouse: fino a quel momento, infatti, in occidente si pensava che si trattasse di un'isola unica. E' la seconda importante scoperta geografica di La Pérouse, dopo la baia di Lituya. Ormai è metà agosto, la stagione estiva sta per finire, e le navi fanno rotta direttamente per la Kamčatka, dove giungono all'inizio di settembre. Amichevolmente accolti dai russi, i francesi sostano qui un mese, prima nella baia di Avača poi a Petropavlovsk; Barthélemy de Lesseps presta i suoi servigi come interprete; quindi, terminato il suo compito, saluta gli amici e si accinge a traversare la Siberia per tornare in Francia via terra. Porta con sé lettere, disegni, raccolte e la seconda parte del diario di bordo. Sarà un viaggio epico della durata di un anno. Ma così Lesseps (a proposito, zio del più celebre Ferdinand, il promotore del canale di Suez) salva se stesso e molti materiali preziosi. E' il terzo, e ultimo, sopravvissuto della spedizione. 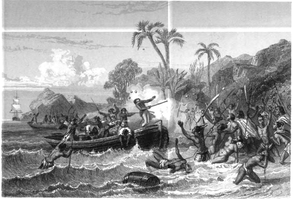 Prima tragedia: il buon selvaggio non è così buono E' ora di andare a sud, per fissare le coordinate dei punti già cartografati e eventualmente completare l'inventario delle isole "in questa vasta parte del grande Oceano disseminato di isole che sul globo terrestre sono l'equivalente della via lattea in cielo". Insomma, quello che La Pérouse avrebbe dovuto fare due anni prima, se avesse rispettato l'itinerario ufficiale. Senza alcun scalo, alla fine di novembre le navi superano la linea dell'equatore, mentre a bordo incominciano a farsi sentire i primi effetti dello scorbuto. In cerca di acqua e viveri freschi, La Pérouse punta verso le Isole dei navigatori (ovvero le Samoa), scoperte da Bougainville poco meno di vent'anni prima. Il 7 dicembre getta l'ancora al largo di Maouna (oggi Tutuila), la maggiore delle isole e la più ricca di villaggi e risorse. Nel corso di una prima spedizione di vettovagliamento alcuni segni lo allarmano, ma si lascia convincere dal suo secondo Fleuriot de Langle ad organizzare una secondo spedizione per caricare acqua di fonte, all'epoca considerata un rimedio infallibile contro lo scorbuto. La spedizione fatale ha luogo l'11 dicembre; vi prendono parte una sessantina di uomini, imbarcati su quattro scialuppe al comando dello stesso Langle; tra loro ci sono anche il geologo Lamanon, i botanici Collignon e La Martinière, il cappellano padre Receveur. Mentre i marinai caricano l'acqua, l'atmosfera si fa sempre più tesa, con forse un migliaio di indigeni che si riversano sulla spiaggia. Langle, che si rifiuta di sparare, seguendo alla lettera gli ordini del re che raccomandano di usare "dolcezza", cerca di calmare gli animi offrendo doni, con il risultato di eccitarli ancora di più. Incominciano a volare le pietre e una lo colpisce alla testa. E' il segnale del massacro: l'ufficiale viene fatto a pezzi, e con lui undici uomini, tra cui Lamanon. La Martinière si salva a nuoto: con un braccio nuota, con l'altro regge un sacco con la raccolta di piante. Anche Collignon e Receveur sono tra gli scampati, ma il cappellano è stato ferito a un occhio. La Pérouse è sconvolto per la perdita di alcuni dei suoi migliori uomini e di colui che non era solo il suo secondo, ma anche l'amico più caro; tuttavia rifiuta di vendicarsi sugli indigeni che sono a bordo, come vorrebbero i suoi marinai, perché essi sono innocenti e non si risponde alla violenza con la violenza. Ma rimpiange che il re abbia vietato l'uso delle armi e che Langle e Lamanon siano andati incontro alla morte illusi dal mito del buon selvaggio. La colpa ce l'hanno i filosofi: "Scrivono i loro libri all'angolo del focolare, e io viaggio da trent'anni; sono testimone delle ingiustizie e delle furberie di questi popoli che ci dipingono così buoni perché sono tanto vicini alla natura; ma è impossibile [...] fare società con l'uomo della natura, perché è barbaro, malvagio e furbo". 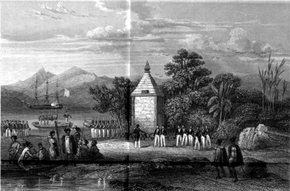 Un mistero durato quarant'anni (e oltre) Traumatizzati, comandante ed equipaggio riprendono il viaggio. Dopo le Samoa, è la volta dell'arcipelago di Tonga; qui gli abitanti sono così amichevoli da aver guadagnato a questo gruppo il soprannome di "isole degli amici". Incominciano i primi decessi per scorbuto e le condizioni di padre Receveur si aggravano. Il 13 gennaio 1788 le navi passano al largo dell'isola di Norfolk ma non possono sbarcare; non resta che fare rotta per Botany Bay, sulla costa orientale dell'Australia, che raggiungono il 26 gennaio. Sono stati preceduti di appena una settimana dalla cosiddetta First Fleet, ovvero la flotta che ha trasportato in Australia il primo convoglio di un migliaio di galeotti deportati. C'è un grande trambusto, perché il comandante, il capitano Arthur Phillip, ha ordinato di trasferire la colonia da Botany Bay a Port Jackson (oggi Sidney), dodici km più a nord. L'accoglienza dei britannici è amichevole, e offrono tutta l'assistenza possibile; non viveri, perché ne hanno meno di loro. I francesi si fermano sei settimane; all'inizio di febbraio padre Receveur muore in seguito alla ferita ricevuta a Tutuila; è il secondo europeo a morire e ad essere tumulato nell'Australia orientale (il primo è stato un marinaio di Cook) e il suo funerale è la prima cerimonia sacra ricordata negli annali australiani. La Boussole e l'Astrolabe ripartono verso metà marzo; il 10 marzo, il capitano de Clonard, che adesso comanda l'Astrolabe, si presenta a Phillip e gli affida un pacco di documenti da consegnare all'ambasciata francese a Londra: contiene dispacci, carte, relazioni, l'ultima parte del diario di bordo; nell'ultima lettera al ministro della marina, La Pérouse enuncia il suo programma; conta di completare l'esplorazione delle isole del Pacifico e di rientrare in Francia passando dalla Réunion, dove dovrebbe essere al più tardi all'inizio di dicembre. Da quel momento, le navi entrano nel mistero. A Réunion non arrivano né a dicembre né mai. Mano a mano che il tempo passa, cresce l'ansia delle famiglie, degli amici, del re, della stessa opinione pubblica che aveva seguito appassionatamente le vicende della spedizione. All'inizio del 1791, la Società di storia naturale di Parigi fa pressioni sull'assemblea legislativa perché venga organizzata una spedizione di soccorso; tra quei deputati siede anche il fratello di uno dei nostri scienziati, l'avvocato Pierre Joseph Didier de Boissieu. All'inizio di febbraio l'assemblea nazionale costituente decreta la missione di soccorso, che sarà posta sotto il comando di Antoine Bruny d'Entrecasteaux; il re promette un premio di 10.000 lire a chi porterà notizie. Come ho già raccontato in questo post, la spedizione Entrecasteux (a sua volta sventurata) non riuscirà a trovare traccia degli scomparsi. E il tempo continua a passare. Il 21 gennaio 1793 Luigi XVI sale al patibolo; sembra che ancora pochi giorni prima abbia chiesto ansioso: "Ci sono notizie di La Pérouse?" Cambiano i regimi: il terrore, il termidoro, l'impero napoleonico, la restaurazione. E arriviamo al 1826. Peter Dillon, irlandese che comanda una nave mercantile britannica, nella sua rotta verso l'India fa una deviazione per visitare alcuni amici nell'isola di Tikopia, nell'arcipelago di Santa Cruz; gli vengono mostrati un'elsa di spada e un cucchiaio d'argento con delle cifre e uno stemma, proveniente dai relitti di un naufragio avvenuto in un'altra isola, Vanikoro. Dillon, che è al corrente del premio offerto dalla monarchia francese, pensa subito alla Boussole e all'Astrolabe. Per ora non può indagare oltre, ma appena arriva a Calcutta informa il governatore della scoperta e la Compagnia delle Indie gli mette a disposizione una nave, prontamente ribattezzata The Research, per andare a cercare altre prove a Vanikoro. Qui trova altri resti, tra cui una campana di bronzo; con i suoi reperti va in Francia, li mostra a Ferdinand de Lesseps, che li riconosce senza ombra di dubbio come provenienti dalle navi scomparse. Il re di Francia (ancora per poco è Carlo X) paga sull'unghia il premio, fa Dillon cavaliere e gli concede una pensione vitalizia. Intanto, il Ministero francese della marina ha finanziato una nuova spedizione nel Pacifico, al comando del navigatore di lungo corso Jules Dumont d'Urville; tra gli obiettivi c'è anche scoprire qualcosa sul mistero delle navi perdute, tanto che la nave di d'Urville viene ribattezzata Astrolabe. Quando arriva in Nuova Zelanda, all'inizio del 1827, il francese viene a sapere delle scoperte di Dillon e si dirige immediatamente a Vanikoro, dove trova abbondanti resti del relitto di una delle due navi e ascolta le testimonianze degli indigeni sul naufragio di quasi quarant'anni prima. Buona parte del mistero è risolto, ma molti particolari rimangono oscuri: per fare totale chiarezza, bisogna aspettare il lavoro dei sommozzatori e degli archeologi, che nel 2005 permettono di trovare, sommersi in un altro punto della barriera corallina, il relitto del secondo vascello, e di identificare con sicurezza le due navi: quella che si è schiantata sulla costa dell'isola è l'Astrolabe, quella che si è arenata più in là è la Boussole, nel cui relitto viene anche trovato un scheletro intatto. Molte ipotesi sulla sua identità; tumulato a Brest con una cerimonia solenne, è noto come lo "sconosciuto di Vanikoro", e, come il milite ignoto, è diventato un po' il simbolo dei duecento e più giovani uomini scomparsi insieme alle due navi. E finalmente anche noi siamo in grado di raccontare come andò. Forse a maggio, forse a giugno, quando la regione è battuta dalle tempeste tropicali, un violento tifone scaglia le due navi contro la barriera corallina che circonda l'isola di Vanikoro. La Boussole, che è più veloce, riesce a vedere in tempo l'ostacolo e a virare, mentre l'Astrolabe lo urta violentemente e va letteralmente in mille pezzi; probabilmente ci sono ben pochi sopravvissuti. A sua volta, la Boussole si incaglia sulle rocce coralline e incomincia ad affondare. Gran parte dell'equipaggio è risparmiato e può raggiungere l'isola. Secondo le testimonianze degli isolani, gli scampati sono un centinaio; ma non trovano un'accoglienza amichevole: gli indigeni sono convinti che siano stati loro a provocare quel terribile tifone e li accolgono come gli abitanti di Tutuila avevano accolto Lange e Lamanon. I francesi (ci piace immaginare che a guidarli ci sia La Pérouse, grande marinaio e eccellente uomo d'armi) resistono con le armi in pugno; alla strage sopravvive una quarantina di marinai che si arrocca in un fortino improvvisato e incomincia a costruire una nave di fortuna usando il fasciame dei relitti e gli alberi delle foreste dell'isola. Quando l'imbarcazione è pronta, la lanciano in mare e scompaiono per la seconda volta, questa volta definitivamente (anche sul loro viaggio non mancano indizi e congetture, ma noi la finiremo qui). Sull'isola lasciano indietro due uomini, che sarebbero vissuti molti anni. Se il 17 maggio 1793 il capitano Entrecasteaux, invece di passare al largo di Vanikoro, fosse sbarcato, li avrebbe trovati ancora vivi e avrebbe ricevuto indicazioni sulla rotta degli altri. Ma la storia, anche della marineria, non è fatta con i se.  Che c'entra La Pérouse con la botanica? E Galopina con La Pérouse? Forse vi state chiedendo: che c'entra la botanica con questa storia, visto che ci siamo già congedati dai botanici della spedizione con il post precedente? Il fatto è che anche i botanici hanno voluto rendere omaggio a La Pérouse; gli sono stati dedicati vari generi, anche se le confusioni non mancano, sia per problemi ortografici, sia per la quasi omonimia con il naturalista Philippe Picot de Lapeyrouse, tanto che in alcuni casi è difficile capire chi sia il vero dedicatario. Nessuno è però oggi valido, ad eccezione del genere Galopina; la dedica si deve a Thunberg, che non spiega l'etimologia del nome, formato a partire dal cognome Galaup, trascritto a orecchio, e non a partire dal gentilizio La Pérouse. E' dunque probabile, ma non certa. Poiché risale addirittura al 1781, non ha nulla a che fare con la tragica spedizione nel Pacifico, ma si riferisce o alla lunga spedizione nei mari dell'India intrapresa da La Pérouse nel 1773 o più in generale ai suoi viaggi nell'Oceano Indiano; infatti, Thunberg inserisce questo genere in mezzo ad altri dedicati a personaggi connessi con l'esplorazione dell'India. Prima di partire per la sua ultima avventura, il navigatore francese aveva già alle spalle una lunga carriera di marinaio e soldato, che è sintetizzata nella biografia. Galopina Thun. è un piccolo genere della famiglia Rubiaceae, con quattro specie diffuse in Sud Africa e nell'Africa tropicale sud-orientale. Sono erbacee con fusti esili, foglie lanceolate e aeree infiorescenze di fiori minuscoli bianco-verdastri; assomigliano molto al loro parente europeo Galium. Ad eccezione di una specie, vivono nel sottobosco delle foreste d'altura. Sono piccole piante che non hanno nulla di eroico, tranne vivere in diverse condizioni anche sulle rocce. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
La spedizione La Pérouse è una delle più celebri della storia della marina: non per i risultati scientifici, che pure furono importanti, ma per il mistero che ha a lungo avvolto la sua fine. In questo primo post, seguiremo le vicende della prima parte della spedizione e faremo conoscenza con i numerosi membri della variegata squadra di scienziati che avevano aderito con entusiasmo a un'impresa da cui si aspettavano grandiosi risultati e una larga fama. Le loro aspettative si scontrarono con le scelte del comandante, che considerava prioritaria la sua missione oceanografica e mal sopportava le pretese di quegli spocchiosi studiosi terricoli (in tre anni di navigazione, i periodi passati a terra furono ridotti agli scali indispensabili per i rifornimenti e il raddobbo). Con due eccezioni, anch'essi condivisero la sorte tragica e oscura dei loro compagni. A tre di loro sono dedicati altrettanto generi botanici: i sudamericani Lamanionia e Colignonia, e l'australiano Bossiaea.  La partenza: dramatis personae All'alba del primo agosto 1785, al comando di Jean-François de Galaup, conte di La Pérouse, salpano dal porto di Brest le fregate La Boussole e L'Astrolabe. A bordo circa duecentoventi uomini, tra ufficiali, marinai, scienziati. Solo tre di loro torneranno a casa. La spedizione che avrebbe dovuto essere la risposta francese alle imprese del capitano Cook si risolverà infatti nel più celebre disastro della storia della marina d'oltralpe. Eppure è stata preparata con estrema cura e nulla, apparentemente, è stato lasciato al caso; le navi sono state raddobbate per affrontare un viaggio della durata prevista di tre anni, attraverso tre oceani, mari tropicali e mari artici; la strumentazione di bordo è all'avanguardia (l'ingegnere capo è andato personalmente a Londra a procurarsi persino alcuni degli strumenti utilizzati da Cook); gli uomini sono stati scelti con cura, tra fin troppi candidati: molti avrebbero voluto partecipare a un'impresa tanto gloriosa. Tra quelli che sono stati scartati pare ci sia anche un ambizioso allievo ufficiale sedicenne, un genio in matematica, ma davvero troppo giovane: un certo Napoleone Bonaparte. La missione è stata concepita inizialmente dal ministro della marina de Castries come esclusivamente diplomatico-economica, con lo scopo principale di inserire la Francia nei traffici dell'Oceano Pacifico, soprattutto nel promettente commercio delle pellicce . Tuttavia, con il coinvolgimento di istituzioni come l'Accademia delle scienze e il Jardin des Plantes, si è allargata fino ad divenire la più ambiziosa della sua epoca, con l'obiettivo che è insieme scientifico e politico di completare l'esplorazione del Pacifico, delle sue terre, delle sue popolazioni e delle sue rotte per "costituire un catalogo ragionato delle conoscenze in tutti i campi del sapere". Ecco perché a bordo c'è un nutrito drappello di studiosi, specialisti in tutti i campi delle scienze naturali e esponenti delle più prestigiose istituzioni scientifiche del regno. Gli ufficiali, a cominciare dal comandante La Pérouse, sulla Boussole, e dal suo secondo Paul Fleuriot de Langle, sulla Astrolabe, hanno una lunga esperienza di navigazione oceanica; molti sono stati scelti personalmente da La Pérouse tra gli uomini che hanno combattuto al suo fianco nella guerra d'indipendenza americana. I marinai sono in buona parte sperimentati bretoni dal piede marino. Quanto agli scienziati, che si sono imbarcati con una interminabile lista di compiti scientifici e un voluminoso bagaglio di strumenti all'avanguardia (c'è persino una mongolfiera), hanno un'età media di trent'anni e sono membri già affermati delle più prestigiose istituzioni scientifiche del paese; hanno grandi aspettative sui loro compiti, e un'altrettanto grande considerazione di sé. I rilievi cartografici sono ovviamente affidati a ufficiali della marina, a cominciare dall'ingegnere capo Paul Monneron, coadiuvato da Sébastien Bernizet. Gli astronomi sono Joseph Lepaute Dagelet, che ha già partecipato alla spedizione nelle "terre australi" di Kerguelen, e Louis Monge (fratello del più celebre matematico Gaspard). Lo scienziato più prestigioso (e più spocchioso, a detta del comandante) è Jean Honoré Robert de Paul de Lamanon, fisico, geologo, mineralogista, paleontologo, membro dell'Accademia delle scienze di Torino e di Parigi. Il botanico ufficiale è Joseph Hugues Boissieu La Martinière del Jardin des Plantes. Anche i due elemosinieri hanno una formazione scientifica: Jean-André Mongez è un mineralogista rinomato, ma è anche ornitologo, entomologo e chimico, "uomo curioso di tutte le cose"; Louis Receveur è botanico, geologo, chimico, astronomo. Una mano la danno anche i medici di bordo Claude Rollin, Jacques Joseph Le Cor, Simon Lavaux e Jean Guillou. Con un ruolo incerto c'è il naturalista Jean-Nicolas Dufresne, che si è aggiunto come soprannumerario e, al contrario degli altri scienziati, non divide i pasti con gli ufficiali ma con i marinai. Ci sono tre pittori: il paesaggista e ritrattista Gaspard Duché de Vancy, raccomandato personalmente dalla regina; e due illustratori naturalisti, zio e nipote: Guillaume e Jean-Louis Prévost. C'è un interprete, il diciannovenne Bathélemy de Lesseps, figlio del console a San Pietroburgo. Ho volutamente lasciato per ultimo il secondo botanico, o meglio il giardiniere Jean-Nicolas Collignon; ventitrenne, è uno degli assistenti André Thouin al Jardin des Plantes. Parte con un sacco di sementi e pianticelle di alberi da frutto ben protette in speciali serre portatili in legno e vetro, da seminare e trapiantare nel corso del viaggio a beneficio degli indigeni; è il suo compito principale, ma anche lui parteciperà alla raccolta di semi, esemplari vivi o essiccati. Tuttavia Thouin raccomanda che sia indipendente e non subordinato a La Martinière. E infatti La Pérouse lo farà imbarcare sulla nave ammiraglia, mentre l'altro botanico viaggia sull'Astrolabe.  La spedizione: prima parte, da Brest a Manila (1735-1737) Seguendo la rotta puntigliosamente tracciata dall'ammiragliato (e rivista di persona dal re), le navi puntano direttamente sull'America meridionale, con solo due brevi scali a Madera e a Tenerife (29 agosto), dove c'è la prima defezione: l'astronomo Monge ha sofferto talmente il mal di mare che chiede di essere lasciato a terra. Sarà così il primo sopravvissuto. Si registra anche la prima frizione tra il comandante e gli scienziati. Lamanon e i suoi compagni decidono di scalare il Pico de Teide, per misurarne esattamente l'altezza. Sono convinti che rientri pienamente nei loro compiti scientifici e che il costo delle mule e delle guide sarà coperto dai fondi della spedizione; non così la pensa La Pérouse che informa il geologo che la notevole spesa dovrà pagarla lui. Alla gita partecipa anche Collignon, che in una lettera a Thouin racconta di un piccolo incidente: mentre scendeva dalla montagna, il suo mulo si è spaventato e si è messo a correre, di conseguenza il suo vacuolo si è aperto e tutte le piante che aveva raccolto sono andate perdute. Ripartite da Tenerife già il giorno dopo, il 9 novembre le navi gettano l'ancora nell'isola di Santa Catarina, di fronte alle coste brasiliane. Dopo i rifornimenti (gli astronomi approfittano della sosta per montare un telescopio e provare la precisione degli orologi, indispensabili per determinare la longitudine), si riparte per doppiare Capo Horn, con una navigazione insolitamente tranquilla. Il 24 febbraio 1786 la spedizione attracca al porto di cileno di Concepcion; è una vera città, sede del governatore e del vescovo. L'accoglienza è molto cortese e i francesi ricambiano offrendo un ricevimento in una tenda appositamente eretta sulla spiaggia, seguito da un ballo, da fuochi artificiali e dal lancio di una mongolfiera; La Pérouse è euforico e paga da bere a tutti i suoi uomini. Sicuramente i naturalisti avranno approfittato della sosta per le loro raccolte, ma, al contrario del diario di bordo del capitalo, i loro diari di campo sono andati perduti. Terminati i rifornimenti, a metà aprile, si riparte. L'itinerario stabilito dall'ammiragliato prevede che si dirigano a sud, per esplorare le isole del Pacifico meridionale non toccate da Cook. La Pérouse decide di invertire la rotta e di puntare direttamente verso l'America settentrionale, con due sole tappe intermedie: l'isola di Pasqua e le Hawaii. Nella prima si fermano solo un giorno e Collignon, accompagnato da Lange, ne approfitta per seminare verdure e alberi da frutto; gli indigeni vivono in condizioni miserevoli, e rubano tutto quello che possono, specialmente i cappelli e i fazzoletti dei marinai. Anche la sosta alle Hawaii è brevissima; il comandante evita l'isola di Hawaii, tristemente legata alla morte di Cook, e va a fare rifornimento a Maui, dove arriva il 18 maggio; rinnovate le scorte di acqua, maiali, banane, taro, il 1 giugno si riparte in direzione nord. Dopo tre settimane di navigazione sotto costa, spesso resa difficile dalle nebbie, si vede emergere dalle nubi la cima del Monte Sant'Elia. E' ancora estate, e, secondo gli ordini del re, devono esplorare con la massima accuratezza quest'area dove secondo i racconti dei marinai spagnoli potrebbe trovarsi l'imbocco del mitico passaggio a Nord-ovest. La Pérouse è scettico e scrive nel diario di bordo: "Bisogna ammettere una volta per tutte che si tratta di favole geografiche che sono state accettate troppo facilmente dai moderni geografi". Tuttavia, non si sottrae al compito. Il 2 luglio a 58° 52' nord scopre un'insenatura non indicata sulle carte che battezza Porto dei francesi (oggi si chiama Lituya Bay). Gli indigeni li accolgono amichevolmente e, in cambio di oggetti di ferro, offrono salmoni e pelli di lontre di mare. I francesi si fermano qui per un mese e i naturalisti sono finalmente felici di esplorare una natura che, tuttavia, li delude un po' perché fin troppo familiare. La Martinière lamenta di aver trovato al massimo tre specie sconosciute; tutte le altre avrebbe potuto raccoglierle agevolmente nei dintorni di Parigi. Il più contento è Lamanon, che si arrampica sulle scogliere e trova conchiglie a 400 metri dal livello del mare; insieme a Mongez, Receveur e Collignon va anche in cerca di minerali. Questa baia ben riparata, ricca di cacciagione e abitata da indigeni accoglienti, sembra la sede ideale di una futura base commerciale, ma il soggiorno dei francesi è funestato da una prima tragedia. L'imboccatura della baia, molto stretta, è percorsa da correnti pericolose che inghiottono due lance e le vite di 21 uomini. E' dunque con l'animo gravato dal dolore per i compagni morti che La Pérouse decide di ripartire verso sud: il passaggio a nord-ovest, decisamente, è una "pia frottola" di epoche più credulone, e ci vorrebbero anni per esplorare a dovere quelle coste intricate, immerse nelle nebbie e rese pericolose da correnti imprevedibili e dal gioco delle maree. Partite dall'Alaska il 30 luglio, la Boussole e l'Astrolabe a metà settembre attraccano a Monterey, in California, che è stata fondata appena quindici anni prima. Si fermano dieci giorni, visitano la missione francescana (non senza criticare, da veri uomini dei lumi, lo sfruttamento degli indigeni da parte dei frati). E' un'area incredibilmente fertile, e i botanici si danno da fare, anche se la stagione è poco favorevole, con le piante inaridite dalla calura estiva e i semi già caduti. Ammirano invece la ricchezza di fauna, comprese le balene che riempiono letteralmente la baia. E' ora di ripartire alla volta della Cina. Fallito il tentativo di attraccare alle Marianne, occorreranno tre mesi senza neppure uno scalo per raggiungere Macao (3 gennaio 1787). Una lunga traversata che finisce di esasperare i naturalisti, già irritati dal cambio di itinerario e dalla brevità degli scali; senza informare il capitano, guidati da Lamanon, decidono di lasciare la nave e di acquartierarsi a terra. La Pérouse risponde escludendoli dai ricevimenti offerti dai portoghesi e, alle loro proteste, li mette agli arresti per ventiquattro ore. Entrambe le parti inviano lettere di fuoco in Francia; in un dispaccio il comandante si lamenta di quei "diavolacci che mettono alla prova la mia pazienza oltre ogni limite". Ad averne abbastanza è anche Dufresne, che probabilmente non è mai riuscito ad integrarsi con gli altri scienziati più titolati. Chiede il permesso di lasciare la spedizione e di tornare in Francia, imbarcandosi su una delle tante navi che fanno la spola con l'Europa; porterà con sé la corrispondenza e il giornale di bordo della prima parte della spedizione. Prima però si incarica di vendere, con grande profitto, le pellicce acquistate in Alaska. Sarà così il secondo sopravvissuto, e uno dei cronisti della spedizione. Per uno che parte, altri che arrivano. A sostituire uno degli ufficiali morti in Alaska si imbarca sull'Astrolabe un ragazzo di appena vent'anni, Gabriel Jean du Pac de Bellegarde, che scrive a Parigi per sollecitare il suo brevetto d'ufficiale. Altri ufficiali e altri marinai si imbarcheranno a Manila, dove la Boussole e l'Astrolabe arrivano alla fine di febbraio e sostano fino a metà aprile per riparare le vele, calafatare gli scafi, completare le provviste. Quindi ripartono verso nord, per completare l'esplorazione del Pacifico settentrionale con la costa occidentale. Per ora non li seguiremo, rimandando il racconto della seconda parte dell'avventura a un altro post.  Tre generi per tre scienziati: l'energico Lamanon e Lamanonia Dobbiamo infatti occuparci di piante, ovvero dei numerosi generi che sono stati dedicati agli scienziati che hanno preso parte alla spedizione. Cominciamo dagli ottimi abati Receveur e Mongez, entrambi dedicatari di generi botanici non più accettati. A ricordarsi dei due "colleghi", morti al servizio della scienza, fu un altro sacerdote naturalista, il brasiliano José Mariano Vellozo che in Flora flumienensis dedicò loro Receveura e Mongezia, oggi rispettivamente sinonimi di Hypericum e Symplocos. Sempre a Vellozo si deve anche la dedica di Lamanonia al combattivo Robert de Lamanon, il più prestigioso scienziato della spedizione. Geologo e paleontologo in anticipo sulla sua epoca, era così appassionato delle sue ricerche da apparire "folle" a chi lo conosceva poco e mancava di diplomazia, tanto che osò polemizzare con il potentissimo Buffon; amava lo studio sul campo (aveva percorso a piedi molti paesi europei ed era un appassionato alpinista che forse scalò il Monte Bianco qualche anno prima di Saussure) e sicuramente avrà sofferto più di ogni altro la reclusione per mesi e mesi nell'angusto spazio di una nave. Era sicuramente lui il "diavolaccio" che più faceva uscire dai gangheri La Pérouse. Ma seppe mettere a frutto il suo tempo, anticipando due importanti scoperte: la marea barometrica all'equatore e la variazione dell'intensità magnetica con la latitudine. Purtroppo, anche se riuscì a inviarle a Parigi, le sue comunicazioni all'Accademia delle scienze rimasero inedite e le sue scoperte passarono quasi inosservate, non fosse per l'apprezzamento di Humboldt. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Lamanonia è un piccolo genere della famiglia Cunoniaceae che comprende sei specie di piccoli alberi o occasionalmente arbusti diffusi in Argentina settentrionale, Paraguay e Brasile, in ambienti diversi, dalla formazione vegetale del cerrado, alle foreste di araucaria e alle foreste nebulose. Hanno foglie composte palmate con margini dentati e infiorescenze a spiga di fiori privi di petali con calice a stella e numerosissimi stami, da bianco a crema. La specie più notevole è L. ternata, un albero che può superare i venti metri, con chioma arrotondata, di notevole impatto estetico soprattutto al momento della fioritura, tanto che in Brasile viene anche utilizzato nell'arredo urbano. Qualche notizia in più nella scheda.  Dalle sabbie della California alle foreste andine: Collignon e Colignonia Tutt'altra personalità deve essere stata quella di Jean-Nicolas Collignon, sempre attivo e pronto a eseguire modestamente i suoi compiti di botanico-giardiniere. Era anche uno dei più giovani della spedizione (al momento della scomparsa, aveva solo ventisei anni). Una sintesi della sua breve vita nelle biografie. Di lui ci rimangono poche lettere al suo mentore Thouin e l'onore di aver inviato in Francia la prima pianta californiana ad essere descritta dalla scienza. Nei pressi di Monterey raccolse infatti diversi semi che poi spedì a Parigi da Macao; al Jardin des Plantes tra gli altri germinarono quelli di Abronia umbellata, una piccola annuale tappezzante che si accontenta delle zone più aride e sabbiose. I discendenti di quei semi furono studiati da Lamarck che li descrisse nel 1791 (la pubblicazione però è del 1793). Ricordandosi di questo merito piccolo ma significativo, il tedesco Endlicher nel 1837 volle rendere omaggio al nostro solerte giardiniere rinominando Colignonia una specie precedentemente assegnata proprio al genere Abronia. Anche questo genere, appartenente come Abronia alla famiglia Nyctaginaceae, è sudamericano, ma è esclusivamente andino. Le sue sei specie sono erbacee perenni, suffrutici e liane, originarie delle foreste pluviali d'altura e delle foreste nebulose, talvolta anche in aree disturbate. Hanno foglie intere, opposte o verticillate, con lunghi piccioli e fiori raccolti in cime a ombrella; presentano due tipologie di fiori, con perianzio campanulato o a imbuto con tre o cinque lobi. Più che per i fiori, si fanno notare per le grandi brattee bianche. Un profilo di questo genere non molto noto nella scheda.  Una puntata in Australia: Boisseu de La Martinière e Bossiaea Veniamo infine al botanico ufficiale della spedizione, ovvero Boisseau de La Martinière. Anche lui era un protetto di André Thouin e abbastanza competente da essere nominato botanico del re a poco più di vent'anni; inoltre era un medico laureato a Montpellier. Apparteneva a una famiglia abbastanza influente e uno dei suoi fratelli fu deputato all'Assemblea legislativa e alla Convenzione (cosa che avrà qualche importanza per il seguito della nostra storia). La partecipazione di La Martinière alla spedizione fu in un certo senso una seconda scelta; il Jardin des Plantes aveva infatti indicato Louis-Augustin Bosc d'Antiq che tuttavia (per sua fortuna) rifiutò. Abbiamo anche l'impressione che Thouin nutrisse qualche riserva nei suoi confronti, visto che raccomandò che Collignon non gli fosse subordinato. Perdute le sue raccolte botaniche, il suo contributo più importante è affidato ad alcune memorie sulla biologia marina. Anche sulla sua vita una sintesi nella sezione biografie. Diversi botanici hanno voluto ricordarlo, facendo anche un po' di confusione con i suoi due nomi, scritti in vari modi. Ancora a Vellozo si deve Martinieria, oggi sinonimo di Kielmeyera; si deve invece a Guillemin Martiniera, sinonimo di Balbisia. Grazie a Ventenat, lo sfortunato botanico si è comunque aggiudicato il notevole genere australiano Bossiaea, con la seguente motivazione: "Genere consacrato alla memoria di Boisseu-Lamartinière, che accompagnò La Pérouse nel suo viaggio intorno al mondo. La relazione di questo viaggio, pubblicato l'anno V della Repubblica francese, contiene un gran numero di scoperte che testimoniano lo zelo e le conoscenze di questo sapiente naturalista". Bossiaea della famiglia Fabaceae comprende oltre settanta specie, distribuite un po' ovunque in Australia, tranne nelle zone centrali. E' un genere molto variabile, e altrettanto variabili sono anche le singole specie, in base all'habitat e soprattutto al regime delle piogge. Alcune specie hanno un areale ampio, ma molte sono endemiche di aree limitate e si distinguono tra loro soprattutto per le dimensioni, il portamento e le foglie, mentre i fiori sono relativamente omogenei. Dal punto di vista ecologico, sono l'equivalente australiano delle nostre ginestre. Sono arbusti da piccoli a medi, alcuni dei quali per adattarsi al clima arido hanno fusti e rami modificati in cladodi cilindrici o appiattiti; le foglie sono alternate od opposte, in genere piuttosto piccole, talvolta ridotte a scaglia oppure assenti; i fiori solitari o raccolti in infiorescenze poco numerose hanno corolla papilionacea gialla, aranciata o bicolore e sono sottesi da una serie brattee e da una coppia di bratteole. Il frutto è un baccello più o meno compresso. In alcune specie si apre in modo esplosivo, disperdendo i semi lontani dalla pianta madre. Nonostante la loro bellezza, sono raramente coltivate; tra tante specie, tutte interessanti, è difficile scegliere quali citare. Per esemplificare la variabilità del genere, la mia scelta è caduta su B. aquifolium, un grande arbusto o addirittura un alberello con foglie con nove o più punte che ricordano quelle dell'agrifoglio e piccoli fiori che fioriscono in massa, da arancio a giallo e da rosso a bruno; B. procumbens, di portamento prostrato e tappezzante, con minuscole foglie da ellittiche a ovate e fiori giallo oro con una macchia rossa alla gola; B. rhombifolia, un arbusto alto anche due metri, con foglie romboidali glauche e fiori bicolori gialli e aranciati; la sorprendente B. walkeri, priva di foglie e con fusti modificati in cladodi, con fiori rosso vivo. Qualche approfondimento su queste e altre specie nella scheda. Più o meno negli stessi anni in cui Dante Alighieri dà inizio al "poema sacro cui ha posto mano e cielo e terra", più modestamente un giurista bolognese in pensione, Pietro de' Crescenzi, scrive un trattato di agricoltura in cui la lettura dei testi classici è arricchita da ciò che ha visto e appreso nei suoi viaggi nell'Italia settentrionale o ha ricavato dall'esperienza diretta di proprietario terriero. Elaborato tra il 1304 e il 1309, nasce così Liber ruralium commodorum, il primo e l'unico trattato di agricoltura del Medioevo. L'opera gode di immediata popolarità: ce ne sono giunti circa 120 manoscritti; è quasi subito tradotta in toscano e nel 1373 il re di Francia Carlo V la fa tradurre in francese; fin dal 1471 è stampata e entro il 1500 se ne contano 12 incunaboli, seguiti il secolo successivo da numerosissime edizioni in latino e nelle principali lingue europee. Oggi gli studiosi sono divisi sul reale valore del trattato di Crescenzi; Linneo invece lo apprezzò abbastanza da dedicargli il genere Crescentia, i cui frutti sorprendenti hanno dato il nome alle chicchere, le tazzine in cui le dame del Settecento sorbivano il caffè o la cioccolata. 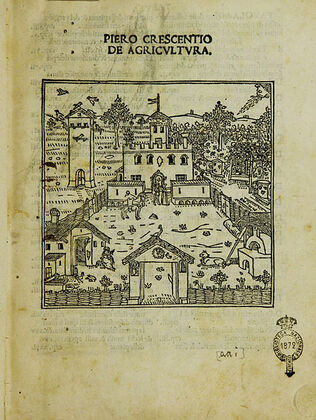 Un giudice in pensione rilancia l'agronomia Nei turbolenti anni a cavallo tra Duecento e Trecento, un giurista formatosi nella prestigiosa università di Bologna aveva una carriera assicurata. Se era nobile o proveniva da una famiglia di magnati, e magari alla competenza giuridica univa il mestiere delle armi, era richiestissimo dai comuni del Nord Italia come podestà; se proveniva dalle classi medie, poteva far parte dello staff podestarile come aiutante, consigliere ed esperto di diritto. Per quasi trent'anni, fu questo il lavoro di Pietro de' Crescenzi. Nato proprio a Bologna, ebbe una formazione ampia e variegata, che comprendeva logica, filosofia, medicina, scienze naturali ma soprattutto diritto. Anche se non conseguì la laurea, poté fregiarsi del titolo di "iudex" e a partire dal 1268 lo troviamo al fianco di vari podestà nei ruoli di assessore e giudice. Quell'anno è a Ravenna, l'anno dopo a Senigallia, nel 1271 a Asti, nel 1283 a Imola, nel 1286 a Ferrara, nel 1287 a Pisa, nel 1293 nuovamente a Imola, nel 1298 a Piacenza. Non furono però le sole località dove soggiornò e lavorò: secondo quanto egli stesso dichiara, fu anche ad Ancona, Bergamo, Chioggia, Cortona, Cremona, Cesena, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Padova, Pistoia e Verona. Insomma, in trent'anni di carriera fu un po' dappertutto nell'Italia centro-settentrionale, e dappertutto osservò le coltivazioni e le pratiche agricole. Investì oculatamente ciò che riuscì a mettere da parte in case a Bologna e in terreni attorno a una residenza rurale, Villa dell'Olmo, situata nel territorio di Urbizzano (oggi Rubizzano, frazione di San Pietro in Casale, a circa 25 km da Bologna). Quando si ritirò, divise la sua vecchiaia tra la residenza di Bologna e la villa di campagna. Su sollecitazione degli amici, nacque il desiderio di mettere per iscritto ciò che aveva osservato nella sua carriera itinerante, ciò che egli stesso aveva messo in pratica come proprietario terriero e soprattutto ciò che aveva ricavato da ampie letture degli antichi e dei contemporanei; ormai settuagenario (le date della stesura sono comprese tra il 1304 e il 1309), Pietro de' Crescenzi scrisse così Ruralium Commodorum libri XII , detto anche Liber ruralium commodorum, ovvero "Libro dei benefici agricoli". Prima (e unica) opera complessiva sull'agricoltura dell'Occidente medievale, il trattato di Crescenzi colma una lacuna secolare. Mentre nel mondo islamico (compresa la Spagna, con Il libro di agricoltura del sivigliano Ibn al-Awwan, XII secolo) al progresso delle pratiche agricole si era unita la riflessione teorica, nell'Europa cristiana per trovare un antecedente bisogna risalire addirittura al IV secolo d.C., con il De re rustica di Palladio (una delle fonti principali di Crescenzi). Crescenzi scrive in latino, la lingua dei dotti, e infarcisce il suo trattato di citazioni classiche; ma il suo pubblico di riferimento sono le persone come lui: quei ricchi cittadini del ceto medio che investono nella campagna i guadagni di attività cittadine; desiderano far fruttare le loro terre nel modo migliore, ma anche trarre dalla "villa" (dal significato antico, latino, di "podere", sta incominciando ad assumere quello moderno di dimora signorile di campagna) tutto il piacere possibile. E dunque i commoda ruralia sono sì i benefici materiali, i proventi, delle terre, ma anche gli agi, i piaceri che vi si possono godere: la caccia, le cavalcate, la bellezza e la serenità dei giardini. Senza contare che possedere una proprietà agricola nel contado è anche il più ricercato degli status symbol di questi nuovi ricchi che aspirano ad entrare nella nobiltà, ma ovviamente non dimenticano la propensione all'utile. Crescenzi concepisce il Liber ruralium commodorum come un trattato organico in cui trova spazio ogni aspetto della gestione di un podere agricolo, dalla scelta del terreno, alla costruzione degli edifici rurali, alla scelta delle colture, alla coltivazione delle produzioni principali, in una concezione filosofica che punta all'equilibro tra le parti e il tutto, l'uomo e i quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco). E' stato sottolineato che la maggiore novità dell'opera sta proprio in questo disegno unitario, anche se i contenuti delle singole parti sono quasi sempre ripresi da altre fonti (tanto che non sono mancate le accuse di plagio). Dopo la lettera dedicatoria a Carlo II d'Angiò, re di Napoli, il primo libro tratta dei requisiti della villa e dei criteri di scelta del sito, tenendo conto del terreno, dei venti, del regime delle piogge. Il secondo libro espone i principi generali dell'agronomia, illustra le principali operazioni agricole e fornisce indicazioni per l'analisi del terreno. Si passa quindi alle colture specifiche, con il terzo libro dedicato alle principali colture dei campi (cereali, leguminose, piante tessili), il quarto al vigneto e alla vinificazione, il quinto al frutteto e agli alberi in generale, il sesto all'orto e alle erbe (inclusi i semplici, ovvero le erbe medicinali), il settimo ai prati e ai boschi, l'ottavo ai giardini. Il nono libro, il più lungo del trattato, è interamente dedicato all'allevamento, dal bestiame grosso fino agli animali da cortile, con un'ampia parte riservata ai cavalli. Il decimo libro è dedicato alla caccia (compresa la falconeria) e alla pesca. L'undicesimo libro è un sommario generale dell'opera, mentre il dodicesimo è un calendario delle operazioni agricole mese per mese.  Giardini minimi, mezzani, regali Diamo un'occhiata più da vicino all'ottavo libro, dedicato, come si è detto ai giardini. Già nel sesto libro Crescenzi si era occupato di uno dei tipi di giardino più diffusi nel Medioevo, il giardino d'erbe o verziere, destinato alla coltivazione delle erbe medicinali, ma in questo libro troviamo una trattazione organica dei giardini di piacere. Il primo capitolo (un plagio quasi parola per parola di passi di De vegetabilibus et plantis di Alberto Magno) fornisce indicazioni sulla scelta del sito e la sua accurata preparazione, in modo da poter ospitare con successo una grande varietà di erbe ed alberi. Il giardino deve essere recintato, per proteggerlo dai venti, e deve esserci una fonte d'acqua, se possibile un pozzo o una fontana. Immancabili un prato d'erba fine e dei sedili ricoperti d'erba, alberi o una pergola per donare ombra e frescura, ma badando che l'ombra non sia troppo fitta e lasci circolare l'aria. I vialetti saranno abbastanza ampi da far sì che un ragno non possa tendervi le sue ragnatele. I fiori e le erbe saranno scelti tra quelli odorosi e medicinali, per giovare insieme al corpo e allo spirito. I due capitoli successivi, dedicati ai giardini di dimensioni maggiori, sono invece un contributo originale di Crescenzi. Il giardino mezzano, destinato alla classe media, occuperà da due a quattro iugeri; sarà circondato da fossati o da una siepe di rose o piante spinose; ci saranno alberi da frutto, potati in modo formale e filari di viti; il prato dovrà essere rasato almeno una volta l'anno per conservare la sua bellezza; ci saranno pergole e padiglioni di verzura formati da tralicci rivestiti di rampicanti. Ancora più vasto il giardino regale, che può misurare diversi ettari ed è circondato da muri. E' preferibile che ci sia una sorgente, con canaletti d'irrigazione che alimentano una peschiera; a nord ci sarà un boschetto che dia rifugio ad animali selvatici, inclusi cervi. Per il ristoro e le passeggiate della corte, ci saranno lunghi viali alberati che si dipartono radialmente dal palazzo. Oltre agli alberi da frutto, ci saranno alberi "più nobili" e padiglioni di piante vive, dove il re e la regina possano trovare riparo dal sole o dalla pioggia. E, per destare meraviglia, alberi innestati con diverse varietà di frutta o voliere create sulla chioma degli alberi con rami intrecciati.  L'albero delle zucche... e delle chicchere Ruralium commodorum libri XII ottenne immediato successo. Ce ne sono giunti oltre 120 manoscritti, redatti tra Trecento e fine Quattrocento. Verso la metà del XIV secolo, fu reso accessibile anche a chi non leggeva il latino da una versione in toscano, redatta da un anonimo forse fiorentino e in genere nota sotto il titolo Dell'agricoltura. Nel 1373 il re di Francia Carlo V ordinò che fosse tradotto in francese. L'invenzione della stampa giovò ancora di più alla diffusione del libro di Crescenzi, che fu una delle prime opere ad essere stampata: l'editio princeps, stampata da Schlusser ad Augusta, è del 1471. La seconda edizione, del 1474, è anche il primo libro stampato a Lovanio. Le edizioni di soli incunaboli (ovvero, di libri stampati entro l'anno 1500) sono ben 15. Il successo continuò almeno fino metà secolo, con una ventina di edizioni italiane, 15 edizioni francesi, 12 edizioni tedesche e due edizioni polacche. Poi la sua fortuna cominciò a declinare, mano mano che si scoprivano i testi antichi originali, si affermavano scuole agricole nazionali e nuove tecniche agraricole. In tempi più recenti, a partire dall'Ottocento, gli studiosi si sono divisi sul reale valore dell'opera: chi ne sottolinea il pesante debito con altri autori, tanto da parlare apertamente di Crescenzi come di un plagiario; chi invece indica la vera originalità dell'opera non nelle sue parti, ma nell'impianto complessivo; chi ne mette in rilievo il valore documentario; chi al contrario ne sottolinea il carattere astratto e letterario. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Rimane l'importanza storica del Liber ruralium commodorum, che non sfuggì a Linneo il quale, prima in Hortus Cliffortianus, poi in Species plantarum rinominò Crescentia una pianta già segnalata da Plumier con il nome indigeno Cujete. Il genere Crescentia della famiglia Bignonianceae comprende sei specie di alberi neotropicali, diffusi dal sud degli Stati Uniti al Brasile e al Perù, ma anche introdotti altrove, in particolare nell'Africa occidentale e in Sud Africa. La caratteristica più notevole sono i grandi frutti sferici con la polpa morbida e un guscio sottile ma duro e resistente che è tradizionalmente usato per fabbricare contenitori. La specie più nota e più diffusa è proprio quella tipo, C. cujete, la cui diffusione va dalla Florida meridionale fino al Sud America settentrionale, passando per il Messico, le Antille e l'America centrale. Pianta sacra in molte culture indigene, è stata domesticata da secoli, tanto che è impossibile determinare quale sia la zona d'origine. E' un albero che può superare i dieci metri, spesso con tronchi multipli, chioma leggera irregolare e molto ramificata con foglie semplici ellittiche raccolte su brevi germogli lungo i rami; i fiori nascono direttamente lungo il tronco o i rami principali e sono seguiti da grandi frutti sferici, che possono raggiungere i 25 cm di diametro. Sia per la forma, sia per gli usi del guscio essiccato, questi frutti possono ricordare piccole zucche; da qui i nomi in molte lingue: calabash o gourd tree in inglese, calabasse, calebassier in francese, calabacero in portoghese, cui possiamo aggiungere il nostro "albero delle zucche" (anche se Crescentia, Bignoniaceae, non ha nulla a che fare con le vere zucche, Cucurbitaceae). L'importanza culturale di questo albero è davvero straordinaria: i frutti sono utilizzati per contenitori spesso decorati e con funzioni rituali, ma anche per strumenti musicali. A Haiti se ne ricava il sonaglio sacro emblema del sacerdote vudu; nelle Antille, suppellettili di calabaca sono prescritti nei pasti rituali del movimento rastafariano. In Costa Rica, se ne fanno contenitori spesso coloratissimi utilizzati in feste e balli popolari. In Brasile, oltre che come contenitore, è abitualmente usato come cassa di risonanza del berimbau, uno strumento tradizionale ad arco con funzioni rituali nella capoeira. In Messico, gli Aztechi li tagliavano a metà e li trasformavano in scodelle dette xicalli, usate per sorbire il cioccolato e altre bevande calde; gli spagnoli adattarono il nome nahuatl in jicara, che poi passò alle tazzine in ceramica con la stessa forma e gli stessi usi. E' questa l'etimologia del nostro chicchera, come si spiega in questo articolo. Le altre specie, con un'area di diffusione minore, alcune endemiche di zone limitate, hanno localmente usi analoghi. Di C. alata inoltre la polpa, dal gusto simile a quello della liquirizia, è consumata fresca o in bevande rinfrescanti; inoltre ha usi medicinali. Altre informazioni nella scheda. Almeno una piantina di Fittonia l'abbiamo coltivata o la stiamo coltivando tutti: con le sue foglie dalle mille sfumature di colore, le dimensioni contenute, la facilità di coltivazione è una delle piante di appartamento più frequenti e popolari. E se vi chiedete come mai una specie che non ha radici a fittone si chiami Fittonia, ecco la spiegazione: è anche questo un nome celebrativo. Le dedicatarie sono due sorelle irlandesi, Sarah Mary e Elizabeth Fitton, autrici di un libro di botanica per l'infanzia, oggi dimenticato, ma che ai suoi tempi fu un piccolo bestseller. 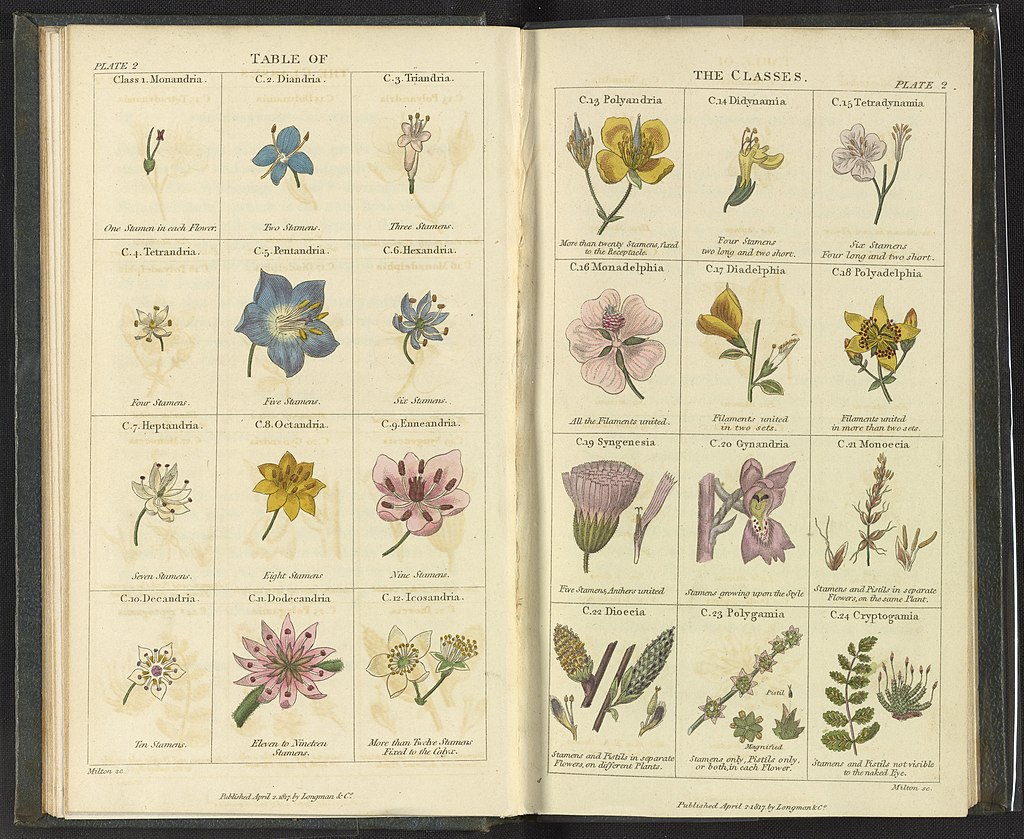 Insegnare Linneo ai bambini (e alle bambine) La storia della botanica è fatta di grandi libri, ma anche di piccoli testi che hanno avuto la loro importanza per divulgarne la conoscenza presso il largo pubblico, compresi le donne e i bambini. Uno di questi piccoli libri è Conversations on botany, pubblicato per la prima volta a Londra nel 1817 dalla casa editrice Longman, specializzata in libri di divulgazione scientifica. Il filone era stato inaugurato nel 1805 da Conversations on chemistry di Jane Marcet (1769-1858), il cui pubblico è chiaramente dichiarato dal sottotitolo: Intended More Especially for the Female Sex, "destinato in modo particolare al sesso femminile". Le donne all'epoca non erano ancora ammesse all'università e solitamente la loro educazione non comprendeva né il latino né la matematica superiore, le due porte d'accesso al linguaggio scientifico. Materie come la chimica erano considerate poco femminili, e pubblicare un libro sull'argomento poco adatto a una signora. Infatti Marcet pubblicò il suo libro anonimo, e solo nel 1832 (si era ormai alla dodicesima edizione) accettò che sul suo nome venisse stampato sul frontespizio. Conversations on chemistry, come si dichiara apertamente nella prefazione, fornisce a Conversations on botany il titolo e la formula editoriale, quella delle "conversazioni": il contenuto scientifico è trasmesso attraverso un botta-risposta tra un adulto (nel libro di Marcet, una benevola istitutrice) e uno o più bambini (le bimbe Emily e Caroline). In Conversations on botany, i protagonisti diventano una mamma, buona conoscitrice delle piante e della botanica, e suo figlio, il piccolo Edward. Lo scopo e la destinazione del volume sono dichiarati nelle prime righe della prefazione: "L'obiettivo delle pagine che seguono è avviare i bambini e i giovani alla conoscenza dei vegetali del loro paese, introducendoli in modo familiare al sistema della botanica linneana". All'inizio dell'Ottocento, non era così scontato che il sistema di Linneo, basato sugli organi sessuali, fosse adatto alle giovani menti; e infatti si spiega subito che si farà riferimento alla versione purgata (e priva di riferimenti sessuali) di Arrangement of british plants di Whitering. Riprendendo poi le parole di un'altra divulgatrice e scrittrice per l'infanzia, Mary Edgeworth, la prefazione si conclude con una difesa del ruolo della botanica nell'educazione dei fanciulli (comprese bimbe e signorine): "Non è una scienza di parata, offre un'occupazione e una varietà infinita, non richiede la forza del corpo, può essere perseguita in privato, e non c'è pericolo che infiammi l'immaginazione perché la mente è intenta a cose reali. Permette di acquisire conoscenze esatte: e il piacere di conseguirlo è una ricompensa sufficiente". Dopo due "conversazioni" introduttive dedicate rispettivamente alla botanica in generale con le parti delle piante e all'introduzione del sistema di Linneo, ognuna delle conversazioni successive (sono in tutto diciotto) presenta una o due classi del sistema linneano attraverso l'esempio di una pianta molto nota della flora britannica, cui segue la trattazione di qualche pianta della stessa classe, di importanza economica o di comune coltivazione nei giardini. Privilegiare la flora indigena è una scelta di campo, intesa anche ad allargare il pubblico della botanica ai meno abbienti: nelle prime pagine del libro, a Edward che vorrebbe iniziare lo studio della botanica da un Geranium (oggi diremmo da un Pelargonium) la mamma replica: "i Geranium della serra non sono nativi dell'Inghilterra, ovvero non crescono nelle siepi e nei campi. Ed è meglio che ci limitiamo, almeno per un po', all'esame delle sole piante native. Anche se spesso sono considerate erbacce, molte di esse sono belle quanto i fiori dei giardini". Conversation on botany ottenne un buon successo, tanto che entro il 1840 ne uscirono nove edizioni; era graficamente curato e illustrato. Le tavole della prima e della seconda edizione furono incise da Thomas Milton, mentre dalla terza in poi furono affidate a un membro della famiglia Sowerby. 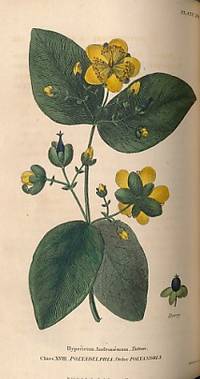 Chi ha scritto questo libro? Ma chi ha scritto Conversation on botany? Proprio come Conversation on chemistry, l'opera uscì anonima e il mistero non fu svelato neppure nelle edizioni successive, tanto che la paternità (la maternità?) è stata erroneamente attribuita alla stessa Jane Marcet o anche a Elizabetha Jacson (la più nota scrittrice di botanica a cavallo tra i due secoli). Eppure il nome dell'autore, o meglio delle autrici, doveva essere un segreto di Pulcinella: è vero che non comparirà mai sul frontespizio di nessuna edizione, ma è stampato nero su bianco nel catalogo Longman a partire dalla terza edizione. Eccole dunque, le nostre misteriose autrici: si tratta di due sorelle irlandesi, Sarah Mary e Elizabeth Fitton. Purtroppo sappiamo poco della prima e quasi nulla della seconda. Le sorelle Fitton erano nate a Dublino, figlie del procuratore Nicholas Fitton e di sua moglie Jane Greene; in famiglia c'era anche un'altra sorella, Susanna, e un brillante fratello, William Henry. Ed è proprio grazie a lui se sappiamo qualcosa almeno della giovinezza di Sarah Mary e Elizabeth. A differenza delle sorelle, che come tutte le ragazze di buona famiglia saranno state educate in casa, William Henry (1780-1861) poté studiare al Trinity College dove si diplomò nel 1799. Avendo sviluppato un forte interesse per la geologia, nel 1808 si trasferì a Edimburgo e l'anno dopo a Londra dove studiò chimica e medicina. Accanto a lui, c'erano la madre e le sorelle Sarah Mary e Elizabeth (di Susanna ormai abbiamo perso le tracce). Non conosciamo la data di nascita di Elizabeth; Sarah Mary, nata intorno al 1796, era molto più giovane del fratello e al momento del trasferimento in Inghilterra era ancora una ragazzina. Sappiamo che negli anni irlandesi almeno una delle sorelle Fitton aveva studiato le piante locali e aveva creato un erbario, interessandosi soprattutto di crittogame. In Inghilterra, grazie al fratello che frequentava attivamente i circoli scientifici, anche le sorelle furono introdotte nell'ambiente; secondo Coemans (lo vedremo meglio tra poco) erano amiche di Robert Brown e il nome di Sarah Mary è citato nella corrispondenza di Darwin. Non sappiamo se le sorelle abbiano seguito William Henry anche a Northampton, dove egli praticò la medicina dal 1812, o se siano rimaste a Londra, dove del resto il fratello tornava spesso per prendere parte alle riunioni della Royal Society e della Geological Society (di cui qualche anno dopo sarebbe diventato presidente). La data certa è ovviamente il 1817, anno in cui uscì la prima edizione di Conversations on botany, che secondo il catalogo della British Library è opera di Sarah Mary Fitton "con l'assistenza di Elizabeth Fitton". Ma intanto si preparavano altri cambiamenti. Nel 1816 la signora Fitton morì e nel 1820 William Henry si sposò con un'ereditiera; poté così lasciare la professione medica e tornare a Londra per dedicarsi esclusivamente agli studi scientifici. Evidentemente, nel nuovo ménage non c'era più posto per le sorelle. Ignoriamo cosa abbia fatto a questo punto Elizabeth (da questo momento, su di lei si stende la nebbia dell'oblio); quanto a Sarah Mary, come racconta nel romanzo autobiografico How I became a governess (1861), "Come sono diventata istitutrice", andò in Francia a lavorare come istitutrice o governante. A un certo punto si trasferì a Parigi, dove all'inizio degli anni '50 abitava in Rue de la Ville l'Eveque. In questi anni, dopo una lunga interruzione, riprese a scrivere. Inviò vari racconti a Dickens per la sua rivista Household World; pubblicò almeno tre piccoli libri per l'infanzia e due testi di introduzione alla musica: Conversations on Harmony (1857), pubblicato sia in inglese sia in francese, e Little by Little (1866). Tra questi titoli, quello che mi ha incuriosito di più è Dicky Birds : A True Story In Words Of One And Two Syllables (1865): come sarà questa storia vera di un uccellino scritta usando solo parole di una o due sillabe? Il compito è più facile in inglese che in italiano, ma rimane pur sempre un tour de force. Ancora nel 1865 Sarah Mary tornò a scrivere di botanica con The Four Seasons: A short account of the structure of plants , dedicato al "mio eccellente vecchio amico William Jackson Hooker". Si tratta della trascrizione di una serie di conferenze tenute al Working Men's Institute di Parigi; benché cambino il destinatario e il formato, riprende ampiamente Conversations on botany, spesso parola per parola. La partecipazione a queste conferenze ci dice che la scrittrice doveva essere vicina agli ambienti filantropici se non socialisti, come testimonia anche l'amicizia con Eugene Sue, ricordata in una lettera di Elizabeth Barret Browning del dicembre 1851; la scrittrice racconta di essere stata invitata a un party natalizio con il marito e il piccolo figlio: "La signora della casa, un'inglese residente a Parigi, Miss Fitton, una donna già anziana, accorta e gentile, ha detto a Robert che gli sarebbe davvero piaciuto invitare anche Sue, se non fosse così birichino"; e in un'altra lettera aggiunge: "Non è sposata e ricca, per niente giovane, e sembra che in lei ci sia parecchio". L'ultimo testo pubblicato da Sarah Mary è del 1866; conosciamo anche la sua data di morte, avvenuta nella casa parigina il 30 marzo 1874, quando la scrittrice doveva essere vicina agli ottant'anni. Come ho anticipato, di Elizabeth invece non sappiamo nulla, neppure se rimase in Inghilterra o andò a vivere in Francia con la sorella. Una breve sintesi delle notizie disponibili sulla vita delle sorelle Fitton nella sezione biografie.  Fittoniae dai mille colori E' bastato quel piccolo libro divulgativo (tra l'altro, piuttosto noioso e pedante) a far entrare le sorelle Fitton nell'Olimpo dei dedicatari di nomi botanici. Vissuta per decenni in Francia, Sarah Mary Fitton doveva essere relativamente nota nei paesi di lingua francese. Altrimenti non si spiegherebbe perché il botanico belga Henri Eugène Coemans pensò fosse degna di essere ricordata, insieme alla sorella, dal genere Fittonia. La motivazione è tanto semplice quanto inequivocabile: "Questo genere è dedicato a Elizabeth e Sarah Mary Fitton, autrici di Conversations on Botany e amiche del celebre Robert Brown". Il genere Fittonia, della famiglia Acanthaceae, comprende solo due specie, ma è notissimo a tutti gli amanti delle piante: non c'è fioraio o garden center che non offra almeno qualche varietà di F. albivenis (spesso commercializzata con vecchi sinonimi come F. argyroneura o F. verschaffeltii). Facile spiegare perché: si adattano bene alle nostre case, sono semplici da coltivare e da moltiplicare, la scelta di varietà e di colori è pressoché infinita. A renderle attraenti, non sono i fiori, piccoli e insignificanti, ma le foglie, che possono essere in tutte le sfumature del verde, ma anche rosa, color rame, porpora, addirittura quasi nere, percorse da nervature in colore contrastante che disegnano un bizzarro mosaico (in inglese il loro nome è nerve plant o mosaic plant). Il grazioso portamento strisciante le rende particolarmente adatte ad essere coltivate in cestini appesi. Le Fittoniae sono originarie del sud America nord-occidentale, in particolare del Perù, dove vivono nelle foreste tropicali pluviali. Le piccole dimensioni hanno reso popolare soprattutto F. albivenis, mentre F. gigantea, pure essa notevolmente attraente ma più esigente, è molto meno coltivata. Qualche approfondimento nella scheda. 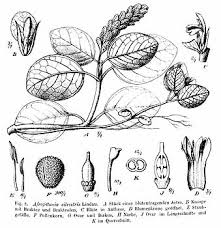 Una gemella diversa: Afrofittonia L'americana Fittonia ha una sorellina africana, molto meno famosa. Per la sua somiglianza con Fittonia verschaffeltii (come abbiamo visto, oggi considerato sinonimo di F. albivenis), nel 1913 Gustav Lindau denominò Austrofittonia sylvestris una specie recentemente raccolta in Camerun. E' ancora oggi l'unica specie di questo genere monotipico della famiglia Acanthaceae. Anch'essa è un coprisuolo delle foreste pluviali delle foreste d'altura; relativamente abbondante in alcune stazioni sul monte Camerun, è ormai rara altrove e minacciata per la restrizione dell'ambiente naturale. Ha foglie obovate simili a quelle di Fittonia albovenis, anch'esse, con nervature in colore contrastante, fusti che radicano ai nodi e piccoli fiori malva. Nota con il nome locale mmeme, è utilizzata come digestivo e durante lo svezzamento. C'è uno strano parallelo tra il destino delle sorelle Fitton e quello dei due generi che le ricordano: come delle due sorelle, una è più nota e l'altra oscura, così Fittonia è ampiamente coltivata e notissima, mentre la "sorella" Afrofittonia è rara, minacciata nel suo ambiente naturale, e nota solo agli specialisti di Acanthaceae, tanto che in rete non è disponibile neppure un'immagine della pianta viva. Anche su questo genere, un breve profilo nella scheda. Con otto edizioni durante la vita dell'autore (l'ultima era un mostro di otto chili di peso) The Gardeners Dictionary di Philip Miller fu la più importante opera di orticultura e giardinaggio del XVIII secolo. Ancora oggi, è un testo di riferimento per chi vuole ricostruire non solo le tecniche orticole del tempo, ma anche la storia dell'introduzione delle piante esotiche in Europa. Miller, grazie ai suoi contatti con raccoglitori, studiosi e collezionisti, ne introdusse in coltivazione a centinaia. Non era però solo un giardiniere (anzi, il "principe dei giardinieri" per dirla con Linneo), ma anche un eccellente botanico educato alla scuola di Ray e Tournefort; per decenni rifiutò ostinatamente sia il sistema sia i nomi di Linneo, con il risultato di "salvare" molte denominazioni prelinneane: i generi che portano il nome assegnato da Miller, spesso recuperato in tal modo, sono dozzine e dozzine. La dedica di Milleria, una curiosissima Asteracea dell'America centrale che fiorì per la prima volta nel giardino di Chelsea dai semi inviati a Miller da uno dei suoi corrispondenti, risale a quest'ultimo, William Houstoun, ma fu fatta propria e validata dall'amico-nemico Linneo.  Una nuova stagione per il giardino di Chelsea Per il Chelsea Physic Garden, ovvero il giardino della Società dei farmacisti londinesi, il 1722 segna una duplice svolta. Fondato nel 1673 per provvedere le piante medicinali per i suoi membri, il giardino sorgeva in un terreno cintato lungo il Tamigi, all'interno della proprietà di lord Cheyne a Chelsea, all'epoca un villaggio di poche case a due miglia da Londra. Dopo un inizio brillante, durante il quale era stato anche stabilito un proficuo rapporto di scambio con l'orto botanico dell'Università di Leida, da qualche tempo, la Società aveva difficoltà a sostenere le spese di affitto e gestione. Nel 1712 Hans Sloane, il medico e naturalista che aveva fatto fortuna con le piantagioni di zucchero e da lì a qualche anno sarebbe diventato il presidente della Royal Society, acquistò la proprietà e appunto nel 1722 decise di cederla in perpetuo alla Società dei farmacisti in cambio di un affitto simbolico di 5 sterline annue, ma a una condizione: ogni anno la Società doveva fornire alla Royal Society 50 esemplari d'erbario di specie nuove, fino a raggiungere un totale di 2000 specie. Un compito che richiedeva un cambio di gestione, e un capo giardiniere all'altezza. Su raccomandazione dello stesso Sloane, al quale a sua volta era stato segnalato dal chirurgo e membro della Royal Society Patrick Blair, il comitato direttivo decise di assumere un giovane e preparato vivaista, Philip Miller. Egli avrebbe mantenuto l'incarico per 48 anni, e avrebbe trasformato il Chelsea Physic Garden nell'orto botanico più importante del mondo. Philip Miller era figlio d'arte e aveva imparato il mestiere dal padre, un giardiniere scozzese che intorno al 1660 si era trasferito a Londra e aveva creato un fiorente vivaio a Deptford, grazie ai cui proventi aveva potuto garantire al figlio un'eccellente educazione. Miller parlava fluentemente diverse lingue e da ragazzo aveva viaggiato a lungo sia in Gran Bretagna sia nei Paesi Bassi, che all'epoca erano il paese più all'avanguardia per le tecniche orticole e floricole. Al momento dell'assunzione, gestiva un proprio vivaio a St George's Fields a Southwark, specializzato nella coltivazione di fiori. Per rispettare la condizione posta da Sloane, il giardino doveva essere rinnovato, in modo da poter accogliere il maggior numero possibile di specie esotiche, coltivate secondo le tecniche più aggiornate. Poiché molte piante esotiche erano delicate e sarebbe stato impossibile coltivarle all'aperto, nel 1727 Miller tornò in Olanda per studiare le più innovative serre olandesi. Propose i suoi progetti al Comitato di gestione e nel 1732 Hans Sloane posò la prima pietra dei nuovi edifici del giardino, incluse una serra fredda e due "stufe", ovvero serre riscaldate con aria calda immessa nelle intercapedini dei muri. Miller introdusse anche la pratica dei lettorini caldi, che aveva ugualmente appreso in Olanda. Per procurarsi piante esotiche sempre nuove, Miller creò una vastissima rete di corrispondenti e fornitori: i colleghi vivaisti, altri orti botanici con cui scambiare esemplari (oltre a quello di Leida e di Parigi, spiccano quelli di Oxford e Edimburgo), studiosi e botanici come lo stesso Linneo, viaggiatori e raccoglitori occasionali o professionisti ai quattro angoli del globo. Tra i corrispondenti più attivi, ad esempio, il chirurgo William Houstoun che gli inviò dal Messico e dai Caraibi (dove prestava servizio sulle navi negriere) numerose specie neotropicali. La sua rete in qualche modo anticipò quello che Linneo fece con i suoi apostoli e quello che Banks (che disponeva di mezzi infinitamente superiori) fece con i cacciatori di piante di Kew. Non c'è bisogno di dire che Miller fu uno dei principali sottoscrittori degli invii di Bartram a Collinson, le famose "Bartram Boxes", cui si deve l'arrivo in Inghilterra di almeno 2000 specie di piante nordamericane. Durante la sua gestione, il numero di specie coltivate a Chelsea passò da 1000 a 4000. Come Kew a fine secolo (all'epoca era ancora soltanto il giardino privato della Principessa di Galles), Chelsea giocò anche un ruolo nell'introduzione di nuove coltivazioni nelle colonie: fu proprio Miller, nel 1732, a inviare a James Oglethorpe, il fondatore della Georgia, i primi semi di cotone da cui sarebbe nata un'intera economia di piantagione. 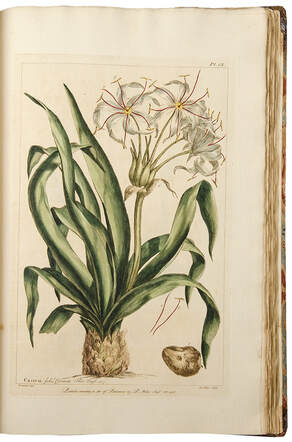 Un capolavoro dell'orticoltura e del giardinaggio L'abilità professionale di Miller era leggendaria. Linneo, che visitò tre volte il giardino di Chelsea durante il suo viaggio in Inghilterra del 1736, lo proclamò "principe dei giardinieri". Ma Miller, vero figlio di quel secolo della divulgazione che fu il Settecento, non tenne per sé le sue conoscenze: fu anche l'autore della più importante opera di orticoltura e giardinaggio dell'epoca, il celebre (e celebrato) The Gardeners Dictionary. L'attività editoriale di Miller iniziò poco dopo l'assunzione a Chelsea, con The Gardeners and Florists Dictionary or a Complete System of Horticulture, due volumi in quarto di quasi 1000 pagine usciti nel 1724. Con la formula del dizionario con voci in ordine alfabetico, è un'opera essenzialmente compilatoria in cui Miller riassunse nozioni riprese da altri testi. Una soluzione che lasciò insoddisfatto per primo lo stesso autore, che invece nelle sue opere successive preferì sempre riscontrare i pareri autorevoli con l'esperienza diretta. L'anno successivo Miller fu tra i fondatori della Society of Gardeners, un club informale che riuniva una ventina di importanti vivaisti dell'area londinese; una volta al mese, gli aderenti si riunivano in un caffè o forse nel vivaio di uno di loro per mostrarsi le piante di nuova introduzione e individuarne il nome preciso. In una fase in cui il mercato inglese era sommerso da incessanti arrivi di piante esotiche, avidamente ricercate dai collezionisti, capitava spesso che la stessa pianta fosse introdotta con nomi diversi; inoltre, il miglioramento delle strade aveva favorito la nascita di un mercato nazionale delle piante e anche in questo caso era frequente che piante autoctone o da tempo introdotte nelle isole britanniche fossero note, e commercializzate, con nomi diversi nelle varie regioni del paese. A più di un vivaista era capitato di dover affrontare un cliente inferocito che, dopo aver pagato a caro prezzo una "novità", aveva scoperta che la possedeva già, sotto un altro nome. I nomi usati dai botanici di professione (siamo in epoca prelinneana) erano lunghissime e inutilizzabili descrizioni in latino, senza contare che variavano da un botanico all'altro. L'unica soluzione era quella di stilare un catalogo collettivo (una specie di antenato di Plant Finder) con la descrizione delle piante e le varie denominazioni. Miller, che era il segretario della società, collaborò attivamente alla stesura del Catalogus plantarum, di cui purtroppo uscì solo il primo volume, nel 1730, dedicato agli alberi e agli arbusti. Subito dopo la società si sciolse. In ogni caso, l'esperienza gli fu poi molto utile per The gardeners dictionary, la cui prima edizione uscì l'anno successivo. L'opera si propone come una vera e propria enciclopedia pratica del giardinaggio, come sottolinea il sottotitolo Containing the Methods of Cultivating and Improving the Kitchen, Fruit and Flower Garden, and the Wilderness, "con i metodi di coltivazione e miglioramento dell'orto, del frutteto, del giardino dei fiori e le piante selvatiche". Voce dopo voce, Miller spiega quali verdure coltivare nel corso dell'anno, come scegliere gli alberi e gli arbusti per parchi e giardini, come coltivare insieme fiori nativi ed esotici; fornisce istruzioni (e illustrazioni) per costruire strutture per il giardino, come lettorini, serre e stufe; elenca e spiega come coltivare nel modo migliore centinaia di piante. Pubblicata in un poderoso in-folio illustrato con 215 carte (ovvero 430 pagine), The gardeners dictionary era un'opera piuttosto costosa; per venire incontro a lettori meno abbienti, nel 1735 Miller ne pubblicò un'edizione ridotta in due volumi in quarto. Da quel momento, fino alla morte, egli non avrebbe cessato di aggiornare e accrescere il suo dizionario, curandone ben otto edizioni successive; l'ultima è del 1768, tre anni prima della morte dell'autore, ed è un mastodonte alto 48 cm, di quasi settecento pagine e otto chili di peso. In un periodo in cui le tecniche orticole erano in costante progresso, e sempre più numerose piante esotiche giungevano in Europa, le edizioni successive del dizionario di Miller sono dunque anche uno strumento straordinario per ricostruire la storia dell'orticultura e datare l'introduzione di nuove specie nel nostro continente. A lungo Miller, che in gioventù aveva conosciuto personalmente Ray, rimase fedele al suo sistema e rifiutò le denominazioni binomiali di Linneo, nonostante la loro evidente praticità. La cocciutaggine di questo giardiniere scozzese scorbutico e di pessimo carattere ha avuto risvolti positivi per la storia della botanica: grazie a lui, molte denominazioni introdotte dai botanici precedenti, e respinte da Linneo, sono state conservate e sono state poi accolte dai botanici successivi. I generi creati da Miller sono decine e decine, e a elencarli ci vorrebbero molte pagine; mi accontento di citare generi "pesanti" come Larix, Castanea, Acacia, Helianthemum, Petasites, Ananas, Cereus, Opuntia, Muscari, Polygonatum, Helichrysum, Foeniculus, Cotinus, Senna. Dopo un'ostinata battaglia durata più di trent'anni, Miller si arrese e, dopo una parziale apertura nella settima edizione, nell'ottava, e ultima edizione del The Gardeners Dictionary adottò finalmente le denominazioni binomie linneane; in fondo, gli affari sono affari, ed era quello che volevano i suoi clienti. Sfogliamola dunque insieme, questa mastodontica ottava edizione. Potete farlo comodamente da casa cliccando qui. Il volume si apre con un dizionario dei termini botanici, seguito da tavole con le varie parti delle piante e le strutture di fiori e frutti. Segue il dizionario vero e proprio, con le voci in ordine alfabetico. Ci sono le tecniche di coltivazione, propagazione, impianto, potatura; le indicazioni per realizzare sentieri, viali, aiuole, siepi, staccionate, grotte, lettorini, serre; i suggerimenti su come prevenire o rimediare ai danni del gelo, del fuoco, della pioggia, della neve e della siccità, di malattie e parassiti. E tante, tantissime piante, nelle intenzioni di Miller tutte le piante coltivate nelle isole britanniche e tutte quelle che vengono "dalle Alpi, i Pirenei, la Boemia, il Levante, l'Egitto, la Siberia, il nord e il sud America, l'est e l'ovest, l'India, la Cina e il Giappone". Ogni voce si apre con il nome generico in latino, seguito da una descrizione in inglese delle caratteristiche comuni al genere; segue poi l'elenco delle specie con il nome binomio e una breve diagnosi in latino, ricavata da Linneo o altri autori; per le specie coltivate, sono fornite dettagliate informazioni sull'origine, la data di introduzione, le varietà, la coltivazione. Dotata di indici in inglese e in latino e di un calendario dell'operazioni orticole, l'opera è anche riccamente illustrata; le piante di nuova introduzione sono accompagnate da tavole disegnate da artisti di grido, tra cui Georg Ehret, che era anche imparentato con Miller, avendo sposato la sorella di sua moglie. Nel 1729 Miller era stato accolto nella Royal Society e contribuì alle Transactions con molti interventi; la sua bibliografia conta non meno di 120 titoli. Il suo lavoro al Chelsea Physical Garden si protrasse fino al 1770, quando, riluttante, dopo uno sgradevole braccio di ferro con il Comitato di gestione, fu costretto al pensionamento. I testi dell'epoca parlano impietosi di "imbecillità e irascibilità dovuta alla tarda età". Malleabile non lo era stato mai. Ma, soprattutto, era cambiato il clima, e l'ostinata resistenza al sistema linneano era diventata imperdonabile; e se Miller si era rassegnato ad accettare la nomenclatura binomiale nel dizionario, non era disposto a fare altrettanto con il sistema di Linneo nelle sue aiuole, ancora rigorosamente ordinate secondo il sistema di Ray. Infatti, uno dei primi compiti del suo successore, William Forsyth, fu riorganizzare le piante secondo il nuovo sistema. Miller non assistette a tanto scempio; morì infatti un anno dopo il ritiro, a ottant'anni d'età (una sintesi della sua vita nella sezione biografie). Ma non finì la vita del suo capolavoro, un testo di riferimento tradotto nella principali lingue europee. A tenerlo aggiornato e a pubblicarne ulteriori edizioni pensarono altri botanici: la più importante è quella curata da George Don, pubblicata tra il 1832 e il 1838 con il titolo A general system of Gardening and Botany, founded upon Miller's Garden Dictionary.  La curiosa Milleria I rapporti tra Miller e Linneo furono quanto meno contraddittori. In occasione delle sue visite a Chelsea nel 1736, lo svedese dovette fare appello a tutta la sua diplomazia per non contrariare lo scorbutico scozzese e farsi donare qualche esemplare per il suo datore di lavoro George Clifford; ovviamente tutti i suoi tentativi di fargli accettare il suo sistema fallirono, anzi Miller sentenziò che "sarebbe stato di corta durata". Nondimeno, tra i due si instaurò una corrispondenza che durò tutta la vita, con scambi di piante e pareri. E Linneo fu prodigo di lodi per The Gardeners Dictionary, anche se era evidente che si poneva in aperta concorrenza con Species plantarum. Di buon grado, accettò anche di far proprio il genere che rendeva omaggio all'amico-nemico, Milleria. Nel 1731, William Houstoun raccolse in Campeche una pianticella piuttosto curiosa di cui inviò i semi a Miller, proponendo di battezzarla in suo onore Milleria. Miller la pubblicò nell'edizione del 1735 del Dictionary, e Linneo accolse la denominazione prima in Hortus cliffortianus, poi nel secondo volume di Species plantarum. Com'è noto, Linneo amava che ci fosse qualche relazione tra la pianta e il dedicatario. In questo caso, i sepali piuttosto corti che si chiudono a coppa potevano suggerire la figura atticciata di Miller, mentre il calice che racchiude totalmente i semi richiamava "l'impegno di Miller per procurarsi rari semi americani e per preservarli", o magari più malignamente la sua riluttanza a dividerli con altri. D'altra parte, Milleria quinqueflora (l'unica specie nota a quel momento e l'unica oggi accettata) è una pianta interessante e curiosa, ma non particolarmente bella, anzi potrebbe rientrare tranquillamente nella categoria delle erbacce. Cioè in quella dove Linneo andava a scegliere le piante da dedicare ai colleghi che ostacolavano il cammino trionfale del suo sistema. Sia come sia, il genere Milleria Houst. ex L. si distingue all'interno della sua famiglia, le Asteraceae, per le caratteristiche singolari del fiori. Monotipico, è rappresento unicamente appunto da M. quinqueflora, abbastanza comune nei terreni disturbati in un'area che va dal Messico al sud America settentrionale. E' un'erbacea annuale piuttosto alta (anche due metri) con esili fusti molto ramificati e foglie cordate in basso e ovate nella parte alta, con nervature evidenti; in estate porta molti minuscoli capolini gialli sottesi da brattee, che da lontano possono richiamare il fiore di una labiata, con il labbro inferiore giallo trilobato; in realtà sono infiorescenze formate da quattro fiori del disco (maschili) che emergono dal ricettacolo a calice e da un unico fiore del raggio (femminile) giallo sgargiante che funziona da richiamo e da pista d'atterraggio per gli impollinatori. Singolare anche il frutto, ovviamente uno solo per capolino, un achenio racchiuso in una specie di borsetta legnosa raggrinzita. Le foglie e gli steli sono usati nella medicina tradizionale per curare le infezioni della pelle. Le radici essiccate sono talvolta vendute come dimagranti. Qualche approfondimento nella scheda. Curioso destino, quello del dottor John Boswell, ultimo allievo scozzese di Boerhaave, stimato medico di Edimburgo, collezionista e studioso di cose naturali: per tutti è solo lo zio di suo nipote, lo scrittore James Boswell (che a sua volta vive di gloria riflessa come biografo del dottor Johnson). Eppure, grazie a un atto di generosità, è anche il dedicatario di un genere botanico di enorme importanza culturale: Boswellia, ovvero le piante da cui si ricava l'incenso.  Sacri granelli misteriosi Il sacro profuma d'incenso. Un aroma che aleggia non solo nelle chiese cattoliche, ma nei templi buddisti o indù, nelle moschee e nelle sinagoghe, e che arriva da lontano. La più antica attestazione del suo uso cerimoniale ci porta addirittura nelle tombe dell'antico Egitto 3500 anni fa. Nel suo significato generale, il termine incenso, dal latino incendere "bruciare", può indicare una varietà di sostanze vegetali (resine, foglie, radici, legno, bacche) che quando vengono bruciate emanano un fumo aromatico. Molte sostanze possono rientrare in questa categoria, ma nel significato più specifico il termine designa un gruppo di oleoresine ricavate da diverse specie del genere Boswellia, note come franchincenso, ovvero "incenso vero". Nell'antichità, come è esistita una via della seta, c'era anche una via dell'incenso. Fin dal II millennio a.C., le carovane cariche dei preziosi grani di resina profumata, partite dallo Yemen meridionale, il mitico regno di Saba, la percorrevano per raggiungere l'Egitto, le coste mediterranee, la Mezzaluna fertile, la Persia, mentre le navi, cariche di questa e altre merci preziose, salpavano per l'India. I migliori clienti divennero però i Romani, che importavano da quella che chiamavano Arabia Felice enormi quantità di thus o olibanum (adattamento del gr. libanon, a sua volta da una parola semitica che significa "bianco", il colore dei granelli di resina essiccati). Tuttavia, in seguito a una serie di circostanze politiche, il flusso incominciò ad inaridirsi a partire dal III secolo d.C. e nella tarda antichità la via dell'incenso cessò d'esistere. Solo dopo il Mille, e ancor più con le crociate, le chiese europee tornarono a profumare d'incenso. Ma, visto che la preziosa sostanza arrivava in Europa sotto forma di granuli, nessuno sapeva con precisione da quale pianta si ricavasse. Nei libri degli antichi gli studiosi del Rinascimento trovavano informazioni contraddittorie: secondo Teofrasto era un arbusto di modeste dimensioni, molto ramificato, con foglie simili a quelle del pero, con corteccia sottile come quella del lauro; ma ne conosceva anche un'altra varietà, simile al lentisco. Una veniva dall'Arabia, l'altra dall'India. Secondo Diodoro Siculo, si trattava di un'acacia con foglie allungate come quelle del salice. Anche della terra d'origine si discuteva; era opinione comune che arrivasse dall'Arabia, ma qual era la "libanophora regio"? Secondo Plinio, Augusto per scoprirne l'esatta ubicazione aveva inviato in Arabia una spedizione che aveva dovuto tornare indietro sconfitta dal deserto; e concludeva sconsolato che nessun autore latino aveva la minima idea di quale e come fosse la pianta da cui era ricavato. In tanta confusione, gli studiosi più prudenti, come Clusius e Ray, evitavano di avanzare ipotesi; Thevet sosteneva fosse la resina di un pino, ma l'opinione prevalente era che derivasse dalla resina di un ginepro, Juniperus thurifera (ipotesi inconsistente, trattandosi di una specie del Mediterraneo occidentale). Linneo notò la contraddizione e propose Juniperus lycia, oggi Juniperus phoenicea, che se non altro è presente in tutto il bacino del Mediterraneo, compreso il Libano e la Palestina, ma anche lungo le coste del Mar Rosso e nella penisola arabica. Uno degli obiettivi principali dalla spedizione del suo allievo Pehr Forsskål nell'Arabia Felice era proprio scoprire qualcosa di più sulla misterioso pianta; egli identificò quella da cui si ricava un'altra resina, opobalsamum o balsamo di Gilead, ovvero Commiphora gileadensis, ma sull'incenso non riuscì a sapere nulla. La risposta sarebbe arrivata non dalla penisola arabica, ma dall'India, e non da un linneano, ma da un medico scozzese al servizio della compagnia delle Indie.  Il mistero è stato svelato? Si tratta di William Roxburgh (1751-1815), il "padre della botanica indiana": anche lui un "botanico senza Nobel", visto che purtroppo il genere Roxburghia che gli fu dedicato da W. Jones non è valido. Come sappiamo oggi, il genere Boswellia è relativamente vasto, e comprende una ventina di specie, diffuse in un'ampia area che va dall'Africa tropicale all'India passando per la penisola arabica e il Madagascar. Le specie presenti nel subcontinente indiano sono due, B. ovalifoliata e B. serrata. Quest'ultima, oggi nota come incenso indiano o franchincenso indiano, è una pianta medicinale, un grande albero chiamato salai, ben noto alla medicina ayrvedica, così come la sua resina odorifera che nei trattati medici indiani è nota con il nome sanscrito kunduru. Da tempi immemorabili, anche in India (che tra l'altro oggi detiene il primato mondiale della produzione di bastoncini di incenso) il fumo (e l'aroma) dell'incenso accompagna le cerimonie sacre, le preghiere e molte occasioni della vita quotidiana; è bruciato in varie forme, ma la più tipica sono dei bastoncini di bambù intinti in miscele infiammabili e profumate, a base di vari ingredienti; uno dei più apprezzati sono proprio i granuli di resina di B. serrata, che in lingua bengali si chiama luban, un nome che richiama immediatamente il misterioso olibanum. A segnalare a Roxburgh la resina e a suggerire la sua identificazione con l'olibanum sembra sia stato il chirurgo della residenza di Naipur, D. Turnbull. Il botanico scozzese esaminò la pianta e ne scrisse la descrizione, anche se non la pubblicò direttamente; come faceva spesso, affidò i suoi appunti a un amico, l'orientalista H.T. Colebrooke, che la inserì in un articolo comparso nel 1807 su Asiatic Researches in cui sosteneva che la pianta dell'incenso andava identificata con questo albero indiano; Roxburgh l'aveva denominata Boswellia serrata, ovvero B. con foglie seghettate; da parte sua Colebrooke era così sicuro dell'identificazione che suggeriva di chiamarla Lebanus thuriferus, ovvero Lebanus produttore di incenso. In realtà non era proprio così, ma prima di raccontare questa parte della storia, è ora di fare conoscenza con l'uomo che ha dato il nome al genere Boswellia, il dottor John Boswell di Edimburgo. Come si è guadagnato la dedica è presto detto: negli anni in cui studiava all'Università di Edimburgo, il giovane Roxburgh, uno studente brillante ma privo di mezzi, era stato ospitato nella casa del dottor Boswell; la famiglia Boswell, piuttosto nota e influente, doveva anche aver messo una buona parola per farlo assumere come chirurgo di bordo dalla Compagnia delle Indie. Insomma, il botanico aveva un debito di riconoscenza con il suo vecchio benefattore, con cui strinse anche legami familiari, visto che la sua terza moglie, Mary Boswell, non era altri che la nipote del nostro dottore.  Un medico colto, affabile ed eccentrico Per me, e forse per tutti, John Boswell è soprattutto lo zio di Boswell, ovvero del celebre scrittore James Boswell (1740-1795), il biografo del dottor Johnson. Conosciamo il suo volto da un ritratto a olio, dipinto da C. R. Parker e conservato nelle collezioni del Royal College of Physician of Edinburgh, e il suo carattere da alcune righe di chi lo conobbe all'inizio e alla fine del suo percorso esistenziale. Nelle collezioni del Royal College è conservata anche la sua cassa da dottore, donata da un bisnipote di Roxburgh. A farci conoscere il giovane John Boswell, all'epoca venticinquenne, è un altro medico scozzese, Isaac Lawson, amico e corrispondente di Linneo; nella sua lettera del 2 novembre 1736, egli lo descrive come un giovanotto molto colto e dotato, ben noto negli ambienti colti di Edinburgo. Ha molto gradito la copia di Musa Cliffortiana datagli da Lawson e in cambio sarebbe felice di donare a Linneo una copia della sua tesi di laurea, De ambra, che ha discusso il giorno prima ed è stata appena stampata. Fratello minore di Alexander Boswell, il padre del biografo, John Boswell, come tanti studenti di medicina scozzesi, era dunque venuto a Leida per seguire le lezioni di Boerhaave, anzi è considerato l'ultimo degli "uomini di Boerhave". Tornato a Edimburgo, divenne un ottimo professionista e uno stimato membro dell'establishment medico cittadino; nel 1748 fu ammesso al Collegio dei medici, di cui fu tesoriere dal dicembre 1748 al 1756 e di nuovo dall'agosto 1758 al dicembre 1763; ne fu poi presidente dal dicembre 1770 al 1772. Abitava in una confortevole casa a sud della collina del castello, nota come Boswell's Court, proprio quella dove ospitò Roxburgh, che doveva essere amico di uno dei suoi otto figli, Bruce. Sappiamo che era massone (una tradizione di famiglia) e che tra il 1753 e il 1754 fu Primo grande guardiano della Grande loggia di Scozia; secondo F.A. Pottle, curatore dei carteggi del nipote, era un "medico abile, ma decisamente eccentrico". Un'eccentricità che si manifestava soprattutto nelle sue scelte religiose: abbandonò la chiesa ufficiale per aderire alla setta dei Galassiti, ma ne fu cacciato e scomunicato per la sua abitudine di frequentare le case chiuse. Era anche un uomo generoso: oltre ad ospitare Roxburgh e ad aiutare la sua carriera, protesse il poeta Allan Ramsay che gli dedicò alcuni versi. Il nostro migliore informatore su John Boswell è però il famoso nipote. L'eccentrico zio era indubbiamente il più caro dei suoi parenti, e anche se non si frequentavano spesso ogni incontro era una festa per entrambi. Una di queste visite, quella del 26 ottobre 1726, suggerì a James questo sintetico ritratto: "E' un uomo degnamente affettuoso, un buon medico, un compagno gradevole e un grande virtuoso" (espressione che all'epoca indicava uno studioso dilettante e un collezionista). Il sogno di James era sicuramente far incontrare i suoi due idoli: il caro zio e il dottor Johnson. E l'incontro avvenne nel novembre 1773, come ricorda lo scrittore nel suo Diario delle Ebridi: il dottor Johnson "ha trascorso una mattinata con mio zio il dottor Boswell che gli ha mostrato il suo museo di curiosità; e, dato che è uno studioso elegante e un medico allevato alla scuola di Boerhaave, il dottor Johnson ha gradito la sua compagnia". Settantenne, il simpatico dottore morì il 15 maggio 1780 dopo una lunga malattia che lo aveva lasciato mezzo morto per un anno, come ci informa ancora il nipote James. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Boswelliae d'India, d'Arabia e d'Africa Adesso che sappiamo tutto del dottor Boswell, torniamo a Boswellia. L'identificazione di Roxburgh e Colebrooke fu accettata dagli ambienti colti britannici, tanto più che la Compagnia delle Indie ne approfittò per importare in Inghilterra l'incenso indiano pubblicizzato come il "vero" incenso. Tuttavia non è lo è; è sicuramente di ottima qualità, ma è più balsamico, con maggiori sentori legnosi. Per risolvere davvero il mistero, fu necessario attendere quasi un altro quarantennio. Nel 1846 il dottor H.J. Carter, chirurgo della nave H.M.S. Palynurus, in ricognizione lungo le coste dell'Arabia meridionale, in Oman e nello Yemen meridionale vide e studiò alcuni esemplari che dapprima attribuì alla stessa specie di Roxburgh, ma che più tardi venne identificata come il vero franchincenso, B. sacra. In suo onore una specie somala è stata denominata B. carteri. Come ho anticipato, il genere Boswellia, della famiglia Burseraceae, comprende una ventina di specie; il centro di diversità è lo Yemen, compresa l'isola di Socotra particolarmente ricca di specie endemiche. Da tutte si ricava incenso, ma per la maggior parte delle specie si tratta di piccole produzioni, destinate al consumo locale. Le specie importanti per l'esportazione sono quattro: B. sacra, B. frereana, B. papyrifera e la già citata B. serrata. B. sacra è presente in Yemen, Oman e Somalia settentrionale; è dunque la specie che alimentava la via dell'incenso, il mitico olibanum dell'Arabia felice che già Augusto aveva tentato inutilmente di ritrovare. E' un alberello alto fino a 8 metri, solitamente molto ramificato, con corteccia che si sfoglia, resinoso in tutte le sue parti. Per produrre l'incenso, i raccoglitori praticano delle incisioni nei rami più bassi e robusti; la resina ne fuoriesce in forma di gocce che cristallizzano in superficie, ma continuano ad ingrossarsi finché dopo una decina di giorni sono sufficientemente grandi per essere raccolte. Anche se i granuli potrebbero essere pronti per la vendita dopo una ventina di giorni, in Oman, dove si produce l'incenso di migliore qualità, si usa immagazzinarli in grotte per qualche mese, una pratica che ne migliora la conservazione. B. frereana è originaria della Somalia. E' nota come incenso copto poiché la sua resina è tradizionalmente usata dalla chiesa copta in Egitto; l'80% della produzione è però esportato in Arabia saudita dove viene utilizzato nelle cerimonie legate all'annuale pellegrinaggio alla Mecca. Anche l'incenso copto è di ottima qualità, tanto che è detto anche "incenso dei re". B. papyrfera è la più importante e diffusa specie africana, presente in una vasta area dell'Africa centrale e nord-orientale ( Etiopia, Nigeria, Camerun, Repubblica centro africana, Chad, Sudan, Uganda e Eritrea); è un albero di medie dimensioni alto fino a 10 metri; estremamente resistente alla siccità, è considerato una delle piante più utili e polivalenti di questa regione: oltre alla resina, di eccellente qualità, se ne usa il legname, le foglie come foraggio, diverse parti come medicinali; i fiori sono una importante fonte di nettare e polline per le api. Oggi è minacciata per l'eccessivo sfruttamento e la restrizione del suo habitat, le foreste tropicali aride. Meritano almeno un cenno le specie di Socotra, un'isola che si trova proprio al centro dell'area di diffusione di Boswellia, essendo quasi equidistante dalle coste dello Yemen e della Somalia. In un territorio di appena 3800 km quadrati ne vivono ben sette specie: B. ameero, B. bullata, B. dioscoridis, B. elongata, B. nana, B. popoviana, B. socotrana. B. bullata e B. dioscoridis sono state scoperte e pubblicate solo nel 2001 dal botanico svedese Mats Thulin. Altri approfondimenti nella scheda. Per finire, un'ultima curiosità. Come ho detto all'inizio, in senso generale il termine incenso può essere utilizzato per qualsiasi sostanza vegetale che produce fumo aromatico. E infatti in rete sono presenti moltissimi produttori di "incenso", "incenso religioso", "incenso liturgico", con nomi evocativi come "incenso dei re Magi", "incenso cattedrale", "Bethlem", "Caspar", ecc. Quasi mai è possibile scoprirne la composizione, ma è evidente che sotto l'etichetta incenso può esserci di tutto: franchincenso etiope, yemenita o africano, benzoino, mirra, legno di sandalo, ma anche lavanda, Syderitis, Artemisia, vetiver, e così via. Del resto, diverse piante che nulla hanno a che fare con l'incenso (a bruciare le loro foglie si otterrebbe soltanto fumo... senza arrosto, ovvero senza profumo) vengono chiamate impropriamente "incenso". La più nota probabilmente è Plechtrantus glabratus (sin. P. coleoides). Linneo arriva in Olanda nel giungo 1735, con due propositi: laurearsi in medicina, come esige il futuro suocero per concedergli la mano della promessa sposa Sara Lisa Moraea, e far conoscere al mondo scientifico europeo le sue idee innovative. Nei bagagli ha molti manoscritti. Quello a cui tiene di più è il suo schema per classificare i tre regni della natura: animale, vegetale, minerale. Quando lo mostra al botanico di Leida Jan Frederik Gronovius, quest'ultimo ne è entusiasta e proclama che deve essere immediatamente stampato. Dato che Linneo non ha un soldo, a pagare le spese sarà lui, con il concorso di un altro amico, il "coltissimo scozzese" Isaac Lawson. E' grazie a questo atto d'amicizia che esce la prima edizione dell'opera seminale della moderna sistematica: Systema naturae. Linneo pagherà il suo debito di riconoscenza dedicando ai due finanziatori un genere di piante; a Lawson toccherà Lawsonia, cui appartiene un'unica specie, L. inermis, dalle cui foglie si ricava l'henné. 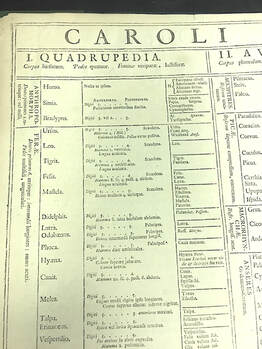 In Olanda alla ricerca di una laurea... e di uno sponsor Linneo arrivò in Olanda il 2 giugno 1735. Aveva 28 anni, era privo di mezzi, e doveva laurearsi al più presto in medicina: era questa la condizione ultimativa postagli dal dottor Johan Moraeus per concedergli la mano di sua figlia Sara Elizabeth, detta Sara Lisa. Al giovane svedese non mancava la fiducia in se stesso, o se preferite la faccia tosta. Appena sbarcato ad Amsterdam (dove si fermò solo tre giorni) chiese udienza a Johannes Burman, che aveva solo un anno più di lui, ma era già professore universitario e direttore dell'orto botanico. Burman, un uomo pieno di impegni, accettò di incontralo, ma non ne fu minimamente impressionato. La tappa successiva di Linneo fu Harderwijk, una piccola università che richiedeva solo un breve soggiorno per concedere la laurea. Bastarono pochi giorni per sbrigare le formalità, e nell'arco di una settimana egli fu in grado di discutere la tesi che aveva già scritto in Svezia. Il 23 giugno venne proclamato Dottore in medicina. La condizione imposta dal futuro suocero era soddisfatta, ma Linneo era venuto in Olanda con un altro obiettivo: far conoscere (e accettare) le sue teorie innovative al mondo scientifico europeo. Per riuscirci, gli serviva un patrono. Il tentativo con Burman era fallito sul nascere, ma Linneo non si scoraggiò. Appena laureato, si spostò a Leida, il maggior centro accademico olandese, nonché sede del più antico ed illustre orto botanico. E questa volta fece centro. Si presentò a Jan Frederik Gronovius, che non aveva alcuna posizione accademica ma era già un botanico noto per i suoi studi sulla flora americana, e gli mostrò il manoscritto di Systema naturae. Gronovius ne fu entusiasta: non solo scrisse lettere di presentazione per Burman e il celebre medico Herman Boerhaave, ma decretò che l'opera andava stampata immediatamente. E dato che Linneo non aveva soldi, a finanziare la stampa sarebbe stato lui, con il concorso del "coltissimo scozzese" Isaac Lawson (così Linneo stesso lo presenta nella prefazione di Systema naturae).  Una vita attraverso le lettere Isaac Lawson si trovava in Olanda per la stessa ragione di Linneo: anche lui era deciso a laurearsi in medicina, ma anziché conseguire una laurea lampo nel diplomificio di Hardweijk, stava seguendo regolari corsi presso l'università di Leida, la più prestigiosa del paese. Era una tradizione di lunga data per i medici scozzesi studiare a Leida; ad attirarli era soprattutto la fama di Boerhaave, che insegnò qui dal 1701 al 1731 e educò diverse generazioni di medici scozzesi, noti come gli "uomini di Boerhaave". Non conosciamo nulla né dell'origine familiare né della giovinezza di Lawson; maggiore di Linneo di tre anni, quando si conobbero aveva 31 anni. Visto che, oltre a concorrere alle spese di stampa di Systema naturae, soccorse finanziariamente il nuovo amico in più occasioni, doveva appartenere a una famiglia facoltosa. Per altro, sappiamo abbastanza poco di lui. La nostra fonte principale sono le undici lettere che egli scrisse a Linneo tra il 1735 e il 1744 (non possediamo le risposte), le prime indirizzate formalmente al "doctissimo ac celeberrimo doctore Carlo Linnaeo", le ultime confidenzialmente all' "amico suo praestantissimo". Molte informazioni ci arrivano poi da altri corrispondenti di Linneo, in particolare Gronovius per il periodo olandese e Collinson per quello inglese. A presentare Lawson a Linneo sarà stato probabilmente proprio Gronovius che considerava lo svedese il suo protetto e la sua scoperta. Sicuramente lo scozzese era uno dei membri più assidui dell'accademia informale che si riuniva attorno a Gronovius, dove Linneo estasiava i presenti raccontando le sue avventure in Lapponia (in puro stile barone di Munchhausen) e si esibiva suonando il tamburo vestito con un improbabile costume lappone. L'aiuto di Gronovius e Lawson per Systema naturae non si fermò al finanziamento. L'esilissimo opuscolo di appena dodici pagine richiese ben cinque mesi tra la revisione del manoscritto e la correzione delle bozze; iniziato il 30 giugno, il lavoro finì a dicembre. In tutte questi mesi, i due amici furono a fianco di Linneo come consulenti e editor (per usare un termine moderno) e da settembre, quando lo svedese si trasferì a Hartekamp a lavorare per Clifford, si sobbarcarono totalmente i rapporti con il tipografo e la correzione delle bozze. Negli anni successivi, svolsero lo stesso ruolo di editor per le altre opere linneane stampate in Olanda, in particolare la prima edizione di Genera plantarum e Critica botanica (entrambe uscite a Leida nel 1737). Una trionfante lettera di Gronovius, datata la vigilia di Natale del 1736, informa Linneo che ha appena letto le ultime pagine di Genera plantarum e che è pronto a portarle all'editore; en passant, nelle ultime righe aggiunge che Lawson ha appena ottenuto il titolo di "candidato in medicina", ma non ne va troppo fiero. Possediamo poco meno di una decina delle lettere che Lawson scrisse a Linneo mentre quest'ultimo si trovava a Hartekamp, tra il 1736 e il 1737; riguardano soprattutto la soluzione di problemi editoriali, ma qua e là aprono uno spiraglio sulla vita intellettuale dei due amici: ad esempio, nel settembre 1737, Lawson propone a Linneo di andare a visitare il Museo di storia naturale di Haarlem insieme a un amico comune, il tedesco Johann Bartsch. In un'altra lettera, ringrazia per l'invio di un campione di zinco. Il suo interesse principale era infatti la mineralogia. Secondo gli atti dell'Università di Leida, Lawson ottenne il titolo di dottore in medicina il 28 dicembre 1737 con una tesi sull'ossido di zinco; ma prima di tornare a casa, si concesse un lungo giro in Germania, per visitare le miniere della famosa regione mineraria dello Harz e alcune importanti città. Siamo minutamente informati del viaggio grazie a due lettere a Linneo, la prima inviata da Goslar il 10 aprile 1738, la seconda da Londra il 27 maggio 1739. Il viaggio si protrasse dalla primavera all'autunno del 1738; Lawson visitò le miniere di Zellerfeld e Clausthal, quindi si spostò a Sankt Andreasberg e a Züdlinburg, raccogliendo campioni di minerali per la propria collezione o da inviare ad altri studiosi, tra cui Gronovius. Visitò quindi Berlino, Halle, Lipsia, Dresda e i distretti minerari della Sassonia. Quando arrivò nella celebre città termale di Carlsbad, si rese conto che i suoi piani di proseguire per Praga, Vienna e Ungheria non erano realistici (avrà finito i soldi o la sua famiglia si sarà spazientita?) e tornò in Inghilterra, con una sosta di appena qualche giorno in Olanda per salutare gli amici. Durante il viaggio in Germania, Lawson incontrò molti studiosi. L'incontro forse più importante per la diffusione del metodo linneano nel mondo tedesco fu quello con Johann Joachim Lange ad Halle; Lawson gli mostrò Systema naturae e Lange (che era un teologo, e come naturalista un autodidatta) ne fu così entusiasta che decise di pubblicarne un'edizione tedesca. Questa edizione bilingue (in latino e in tedesco) uscì nel 1740. Nel 1739 Lawson si stabilì a Londra, dove esercitava la medicina. Continuò a corrispondere attivamente con Gronovius e con Linneo (anche se di questo periodo ci sono rimaste due sole lettere); come aveva fatto in Germania, continuò a diffondere il verbo linneano, stringendo amicizia con personaggi come Peter Collison, che insieme al pettegolo Gronovius è la nostra principale fonte per questo periodo. Sono notizie sparse e discontinue, che non formano una biografia ma ci danno un'idea del personaggio. Nel marzo 1739 Lawson prese parte alla seduta della Royal Society in cui fu presentata una copia di Hortus Cliffortianus. Nel 1740 fece pubblicare una lista delle regole a cui dovrebbe attenersi il naturalista per raccogliere e preservare correttamente gli esemplari; Gronovius la tradusse in latino e la inviò a Linneo, suggerendogli di pubblicare a sua volta qualcosa di simile. Nel 1742, quando il Presidente della Reale accademia delle Scienze Abraham Bäck (un altro amico di Linneo) visitò Londra, soggiornò nella stessa casa di Lawson. Sappiamo inoltre (anche se la corrispondenza tra di loro è andata perduta) che il medico fu in contatto con lord Bute, un altro scozzese che aveva studiato a Leida, e fu proprio lui, nel 1741, a proporre a Linneo di dedicare al nobile conterraneo il genere Stewardia. Dell'influenza di Lawson sui linneani ci informa una lettera di Pehr Kalm del giugno 1748, in cui leggiamo che a Londra c'è un nutrito gruppo di seguaci di Linneo: studiano accanitamente le sue opere, ne sanno recitare interi brani a memoria, e "Isaac Lawson è il loro maestro". La notizia è quanto meno curiosa: nel giugno 1748, come vedremo tra poco, Lawson era già morto. La frase di Kalm andrà dunque interpretata in senso metaforico. Quello che sappiamo con certezza è che nel 1747 Lawson divenne medico capo delle truppe britanniche inviate in Olanda a respingere l'invasione francese durante la guerra di successione austriaca, e morì nel corso di questa campagna. Forse fu una delle vittime della battaglia di Lauffeldt del 2 luglio 1747. Una breve profilo biografico nella sezione biografia.  Capelli rossi e tatuaggi rituali Proprio come aveva fatto con Gronovius, dedicandogli Gronovia, Linneo pagò il suo debito di riconoscenza con Isaac Lawson dedicandogli il genere Lawsonia. Lo scienziato svedese amava trovare qualche affinità tra i dedicatari e le piante e spesso nascondeva dietro le sue dediche un ritratto vegetale. Sicuramente lo fece per Gronovius, ma è difficile capire quale relazione vedesse tra Lawsonia inermis, ovvero l'esotica pianta da cui si ricava l'henné, e il generoso medico scozzese. Si tratta dell'unica specie del genere Lawsonia (famiglia Lythraceae). Nonostante il nome specifico (che significo "senza spine") è un grande arbusto spinoso con piccole foglie ellittiche e fiori profumati da bianchi a rosati seguiti da piccole capsule brunastre. La pianta è nota fin dall'antichità per le sue proprietà tintorie: la polvere di henné, ricavata dalle foglie essiccate, fornisce una tintura temporanea; unita a un fissatore, può essere impiegata per tingere stoffe e cuoio, ma il suo uso principale è nella cosmesi e nei tatuaggi. La pianta è coltivata da talmente tanto tempo che ne ignoriamo l'origine precisa; nel corso dei secoli è stata diffusa in un'area vastissima, dal Nord Africa fino al Sud Est asiatico; in alcuni di questi paesi i coloranti a base di henné costituiscono anche un importante prodotto di esportazione. In molte culture l'henné ha assunto un rilevante significato simbolico, religioso, rituale, associato alle feste principali dell'anno e ai momenti di passaggio della vita, in particolare la nascita e il matrimonio. Già gli antichi Egizi lo usavano per colorare le unghie, i capelli, le mani e i piedi delle mummie. In buona parte del mondo islamico e in India i matrimoni sono preceduti da speciali cerimonie durante le quali le mani e i piedi della sposa sono decorati con elaboratissimi tatuaggi tracciati con l'henné, un rito purificatore e apotropaico che dovrebbe allontanare il malocchio e propiziare la fertilità e la felicità del matrimonio. I disegni e lo stesso calore dei tatuaggi variano da una regione all'altra. In India i tatuaggi temporanei creati con l'henné sono anche una forma d'arte. In molte medicine tradizionali, l'henné è anche utilizzato per curare affezioni diverse, tanto da essere considerato una vera panacea. Sembra che in Europa l'uso dell'henné per tingere i capelli, oltre ad essere legato alla moda dell'orientalismo, sia stato diffuso dai preraffaelliti, a partire da Elizabeth Sidall, la moglie e musa di Gabriel Dante Rossetti, che esaltava il biondo-rosso naturale dei suoi capelli con impacchi di henné. Passò poi agli Impressionisti, e lunghi capelli rossi tinti con l'henné divennero quasi un marchio di fabbrica delle ragazze della bohème. La moda sarebbe stata poi rinnovata a partire dagli anni '60 del Novecento dal movimento hippie e dalle tendenze new age, che esaltavano il ritorno alla natura e il recupero dei saperi tradizionali. Altre informazioni nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed