|
La pubblicazione di The Cactaceae dei botanici statunitensi Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose segna una pietra miliare nella classificazione dei cactus e ne rivoluziona la tassonomia. I quattro volumi, editi tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution for Science, sono anche una sontuosa opera d'arte, grazie ai disegni in bianco e nero e alle tavole a colori, di impressionante precisione, della pittrice britannica Mary Emily Eaton e delle sue collaboratrici; centinaia di fotografie in bianco e nero ne arricchiscono l'apparato iconografico. Anche se da allora le Cactaceae hanno subito numerose revisioni, almeno 50 dei 79 generi stabiliti da Britton e Rose rimangono validi, e i volumi di The Cactaceae sono ricercati da ogni cactofilo. L'opera nasce dalla stretta collaborazione tra Nathaniel Britton, all'epoca direttore del New York Botanical Garden, e Joseph Nelson Rose, un grande e metodico tassonomista al cui il destino ha riservato il ruolo dell'eterno secondo. A ricordarlo i generi Rhodosciadium (Apiaceae) e Roseodendron (Bignoniaceae). 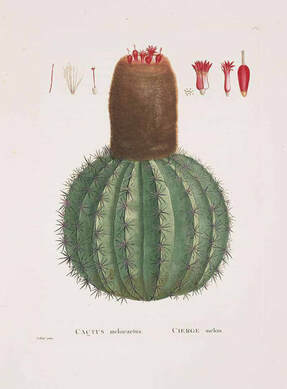 Una classificazione spinosa Come ben sanno gli appassionati di cactus, abituati a fare i conti con continue revisioni e cambi di nome, la classificazione delle Cactaceae è una faccenda spinosa; a ciò contribuiscono diversi fattori: citiamo soltanto la grande variabilità morfologica che spesso rende difficile distinguere specie da specie, specie da sottospecie, specie da varietà; l'alto grado di convergenza evolutiva di queste piante di habitat estremi che fa sì che piante lontane dal punto di vista genetico tendano ad assomigliarsi perché devono affrontare le stesse condizioni ambientali; la difficoltà di raccogliere, seccare e preservare esemplari d'erbario di queste piante spinose, con forme arrotondate e tessuti succulenti. Con la sola eccezione di Rhipsalis baccifera, si tratta di una famiglia esclusivamente americana, in cui gli europei si sono imbattuti con le scoperte geografiche. Probabilmente la prima specie ad arrivare in Europa, forse già con i viaggi di Colombo, fu il fico d'India (qui le Indie sono quelle occidentali) Opuntia ficus-indiae, ma la prima ad essere attestata è un Melocactus "cactus a melone" noto a Londra intorno al 1570. Qualche anno dopo nell'erbario di Tabaernemontanus vengono descritti sia cactus globosi, sia cactus colonnari, che il botanico tedesco chiama Cereus, ovvero "cero, candela". A cavallo tra Cinquecento e Seicento diverse specie sono descritte da altri botanici, come Clusius, L'Obel e Gerard. Pitton de Tournefort pubblica Melocactus e Opuntia, mentre Plumier riporta dai suoi viaggi nelle Antille Pereskia. Questa è la situazione prima di Linneo che nel 1753, in Species Plantarum, descrive 22 specie ma sorprendentemente le raggruppa nell'unico genere Cactus, nome che ricava dal gr. kaktos, una pianta spinosa di Teofrasto non meglio identificata. Più analitico di lui Philip Miller che nella quarta edizione di The Gardener's Dictionary (1754) descrive quattro generi: Cactus, Cereus, Opuntia e Pereskia. Tuttavia, nella nona edizione (1787) farà marcia indietro e si adeguerà alla posizione di Linneo. Poco dopo, nel 1789, Antoine Laurent de Jussieu crea la famiglia Cactaceae. A rimescolare le carte è Haworth che nel 1812 dichiara il genere linneano Cactus inutilizzabile, riservandolo al solo Cactus melocactus L., e lo smembra in Cactus, Cereus, Epiphyllum, Mammillaria, Opuntia, Pereskia e Rhipsalis (creato da Gaertner nel 1788). Nel terzo volume del Prodromus (1828) de Candolle opta per la prudenza, descrivendo sette generi e 174 specie, suddivisi nei grandi gruppi di cactus epifiti e cactus non epifiti. Il grande collezionista principe di Salm-Dyck, che nel suo castello nei pressi di Düsseldorf possedeva la più importante collezione di Cactaceae dell'epoca, in Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (1850) pubblica 20 generi, dividendo la famiglia in due gruppi: Cacteae Rotatae, con fiori a disco, e Cacteae Tubulosae, con fiori tubolari. Nel corso del secolo, mano a mano che gli ambienti aridi del Nuovo mondo vengono esplorati e sempre nuove specie vengono scoperte e inviate ai giardini botanici ma anche ai vivai europei, si aggiunge una grande quantità di specie che i botanici tendono a riunire in pochi grandi generi. Nel 1891 nella sua revisione di Genera Plantarum, Otto Kuntze torna addirittura all'antico, ovvero a Linneo, riconoscendo solo tre generi: i piccoli Pereskia e Pterocactus e un super genere Cactus con oltre 1000 specie. La sistematizzazione più influente a cavallo tra i due secoli è tuttavia la monumentale Gesamtbeschreibung der Kakteen, "Descrizione generale dei cactus", di Karl Moritz Schumann, in tredici volumi pubblicati tra il 1897 e il 1898, con un appendice nel 1903. Rifacendosi soprattutto a Salm-Dick, egli accetta 21 generi e 640 specie. Divide poi la famiglia in tre tribù: Rhipsaloideae, Mammillarieae, Echinocactaceae. Una posizione in parte più aperta è quella di Alwin Berger, curatore dei giardini Hambury, che accetta 41 generi e propone di dividere il vasto genere Cereus in 5 1sottogeneri. E' questa la situazione quando entrano in scena i nostri protagonisti, Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose. 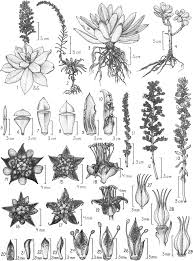 Un botanico taciturno, eterno secondo Britton e Rose incominciarono a studiare le Cactaceae nel 1904; entrambi conoscevano bene le flore degli Stati Uniti, dei Caraibi e del Messico e inizialmente il loro intento era pubblicare una revisione complessiva delle specie nordamericane. Solo più tardi, nel gennaio 1911, Daniel MacDougal, il direttore del Desert Laboratory di Tucson, suggerì loro di allargare le ricerche all'intera famiglia e di chiedere il sostegno finanziario della Carnegie Institution for Science. Di Britton ho già parlato in questo post; è ora di conoscere meglio Rose. Aaron M. Socha, un esperto di cactus che ha lavorato per il Giardino botanico di New York, lo ha definito "un individuo così spiccato che neppure Shakespeare avrebbe potuto renderlo universale". Era un uomo taciturno, riservato, modesto e disinteressato agli onori, ma allo stesso tempo determinato; come botanico, un ricercatore instancabile (qualcuno lo ha definito un "cavallo da tiro"), un descrittore minuzioso e un tassonomista di estremo rigore. Ripercorrendo la sua carriera, a me è sembrato un eterno secondo, un Bartali della botanica. E a Bartali assomiglia anche per la forza di volontà, la bontà d'animo, la generosità, la profonda religiosità. Nato nell'Indiana e rimasto presto orfano durante la guerra di Secessione, studiò nel piccolo college di Wabash; mentre seguiva i corsi post laurea di biologia, divenne assistente del suo professore di botanica, John Merle Coulter, che lo volle al suo fianco per studiare un'altra famiglia difficile, le Apiaceae (a quei tempi, si chiamavano ancora Umbellifere); la collaborazione tra professore e allievo iniziò con Revision of the North American Umbelliferae (1888) e, dopo una serie di articoli su vari generi, culminò con Monograph of the Umbelliferae (1900). Secondo i biografi, a fare il lavoro duro fu Rose, mentre Coulter ebbe piuttosto un ruolo di revisore. Nel frattempo, Rose si era sposato e si era trasferito a Washington per iniziare la sua carriera professionale nel Dipartimento di Agricoltura (USDA) come assistente di George Vasey, botanico capo dell'USDA e curatore dell'erbario nazionale. Rose lo affiancò nella pubblicazione delle raccolte di Edward Palmer in Messico e Centro America, con grande apprezzamento di quest'ultimo che nel 1897 lo invitò ad accompagnarlo in Messico; grazie a questa spedizione, Rose si familiarizzò con il lavoro sul campo e imparò le tecniche di raccolta e conservazione anche di piante difficili come le succulente messicane. Nel 1896 l'Erbario nazionale era passato sotto la giurisdizione dello Smithsonian, e Rose fu promosso assistente curatore di botanica, poi dal 1905 curatore associato. Fu questo il vertice della sua carriera, come notiamo anche dal ruolo di vice presidente - in armonia con il suo carattere e il suo destino - di associazioni attive nella capitale come Botanical Society, Washington Botanical Society, Washington Society, Washington Biological Society (di cui, a dire la verità, dopo essere stato il vicepresidente dal 1909 al 1917, divenne presidente nel 1918). Come assistente curatore dell'USDA, organizzò nove spedizioni in Messico e in Centro America, di cui pubblicò i risultati in Studies of Mexican and Central American Plants, 1897-1911. Intorno all'inizio del secolo, incominciò a corrispondere con Britton, cui inviò molti esemplari per il New York Botanical Garden; entrambi erano particolarmente interessati alle Crassulaecae e a partire dal 1903 incominciarono a scrivere vari articoli a quattro mani su questa famiglia, pubblicati per lo più sul Bollettino del New York Botanical Garden. I loro primi lavori comuni sulle Cacataceae risalgono al 1905. Il progetto suggerito da MacDougall fu presentato da Britton e Rose alla Carnegie all'inizio del 1911 e fu immediatamente approvato. Nel 1912 Rose prese un congedo non pagato dallo Smithsonian e fu nominato ricercatore associato della Carnegie, affiancato da due assistenti, W.R. Fitch e P.G. Russel. Britton, che continuava a dirigere l'orto botanico di New York, fu nominato ricercatore associato onorario (ovvero senza paga), mentre il suo collaboratore R.S. Williams fu incaricato di selezionare e preservare gli esemplari per le illustrazioni. 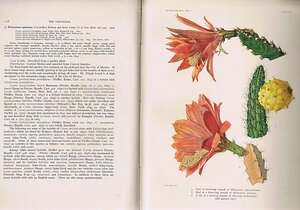 Una rivoluzione tassonomica Quando Britton e Rose incominciano il loro lavoro, la situazione è confusa al massimo grado. Nel corso di un secolo, le specie di cactus, spesso introdotte direttamente non da botanici, ma da raccoglitori di piante al servizio di collezionisti e vivai, si sono moltiplicate a dismisura; e insieme si sono moltiplicati gli errori. Un caos perfettamente descritto dai due botanici nella prefazione del I Volume di The Cactaceae: "descrizioni interpretate scorrettamente, piante identificate in modo sbagliato, errori perpetuati; così la distribuzione geografica di molte specie è stata pubblicata in modo erroneo e le conclusioni basate su dati di questo tipo risultano inaffidabili. Non solo ci sono nomi specifici attribuiti a piante cui non spettano, ma i nomi generici sono diventati interscambiabili e le leggi della priorità sono state ignorate". Quella che Britton e Rose decidono di operare è una rivoluzione; il botanico Lyman Benson ha osservato che, se gli stessi criteri fossero stati applicati a tutte le piante "almeno un milione di piante avrebbero dovuto cambiare nome". Nei quattro volumi di The Cactaceae, i 21 generi accettati da Schumann esplodono e diventano 124, mentre le specie classificate sono 1325. Insomma, per la tassonomia delle Cactaceae, dopo un secolo di prudenza e di enormi super generi, è arrivata l'ora dell'audacia e della suddivisione in molti generi più piccoli, basati sia sulle evidenze morfologiche, sia sulla distribuzione geografica. Anche se i due botanici ottimizzano il tempo, dividendosi il lavoro sia di ricerca sia di scrittura e sono affiancati da una dozzina di collaboratori, il compito è immenso e i cinque anni previsti inizialmente si dilatano a dieci. Bisogna reperire e leggere tutte le descrizioni originali e verificarle quanto più possibile sugli esemplari tipo custoditi negli erbari, quindi confrontarle con le piante vive in coltivazione e/o in natura. Senza dimenticare che il lavoro (1912-1923) verrà a cadere a cavallo della Prima Guerra Mondiale e anche il Messico si chiuderà alle ricerche a causa della rivoluzione messicana. Le Cactaceae vivono nei deserti delle Americhe, ma nell'Ottocento sono state prevalentemente studiate e classificate da studiosi europei, commercializzate da vivai europei e collezionate da collezionisti europei. Ecco perché le ricerche di Rose, già nei primi mesi del 1912, si spostano in Europa. A Londra visita gli erbari di Kew, del Natural History Museum e della Linnean Society e a Parigi l'Hérbier National. Passa poi in Italia dove visita piccole collezioni pubbliche e private di Roma, Napoli, Firenze e Venezia. La tappa principale è però la Riviera, dove Rose va a trovare Alwin Berger; i due botanici corrispondono fin dal 1905, quando Rose aveva scritto a Berger per complimentarsi per il suo studio sulle Cactaceae. E' poi la volta della Germania con gli erbari e gli orti botanici di Monaco e Berlino, la collezione privata di Leopold Quehl ad Halle, il vivaio Haage & Schmidt a Erfurt e l'orto botanico di Darmstadt. Prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, Rose fa ancora un salto ad Anversa per esaminare la collezione privata di Frans de Laet. Le spedizioni sul campo iniziano l'anno successivo. Insieme a sua moglie Elizabeth Knight Britton, all'amica Delia West Marble, membro del Botanical Club, pittrice e fotografa, e al raccoglitore dell'orto botanico di New York John Adolph Shafer, Nathaniel Britton visita le Isole vergini americane, Porto Rico e Curaçao; Rose e i suoi assistenti percorrono Saint Croix, St. Kitts, Antigua e Hispaniola. Nel 1914, mentre in Europa si accendono i fuochi di guerra, Britton torna a Porto Rico per esplorare le isole dell'arcipelago, mentre Rose, accompagnato dalla moglie Lou Beatrice Sims, parte per il suo lungo giro in Sud America. Dopo due brevi tappe in Giamaica e Panama, nel 1915 esplora le zone ricche di cactus di Perù, Bolivia centrale, Cile settentrionale e centrale; come aveva fatto in Europa, a Santiago del Cile esamina le specie tipo raccolte il secolo precedente da Rodolfo Amando Philippi e le specie rare dell'orto botanico. Passa in Brasile, dove studia soprattutto le aree di Bahia e Rio de Janeiro, quindi in Argentina, dove si concentrata sulle province di Mendoza e Cordoba. Come in Europa e in Cile, visita botanici e collezionisti da cui ottiene esemplari e informazioni di prima mano. Nel 1916 Britton è a Cuba insieme a Percy Wilson, mentre Rose e sua moglie concludono il viaggio sudamericano con Curaçao e Venezuela. Per i due botanici è arrivata l'ora del lavoro da scrivania, tanto più che la guerra ora rende difficile gli spostamenti anche in America. Nel 1918, per Rose c'è ancora un viaggio (ad accompagnarlo questa volta è suo figlio Thomas) in Ecuador. Inoltre sono stati coinvolti altri raccoglitori, come J.K. Small inviato nel 1916 in Florida alla ricerca di rare specie di Opuntia o Shafer che nell'inverno 1916-17 fa importanti raccolte in Bolivia, Argentina, Paraguay e Uruguay. Altri esemplari furono inviati da collezionisti, curatori di orti botanici e erbari, studiosi e appassionati. Il primo volume, dedicato alle tribù Pereskieae e Opuntieae, uscì infine nel 1919; il secondo, dedicato alle sottotribù Cereanae e Hylocereanae della tribù Cereae, nel 1920; il terzo, dedicato alle sottotrbù Echinocereanae, Echinocactanae e Cactanae, seguì nel 1922; il quarto, dedicato alle sottotribù Coryphanthanae, Epipyllanae y Rhipsalidanae, completò l'opera nel 1923. Nel 1922 Rose era tornato una seconda volta in Europa, per consultare nuovamente Berger, con il quale aveva continuato a corrispondere, almeno finché la guerra non lo aveva reso impossibile. Ma appena il conflitto era finito, si era affrettato a inviare dall'opulenta America un ricco pacco di cibo all'amico e alla sua famiglia, alle prese con la fame nella Germania postbellica. Pubblicati dalla Carnegie Institution of Science senza badare a spese, oltre ad essere una pietra miliare della botanica, i quattro volumi di The Cactaceae sono una raffinata opera d'arte grazie al ricchissimo apparato iconografico con tavole a colori, disegni e fotografie in bianco e nero nel corpo del testo. A dipingere tre quarti delle 800 tavole fu la pittrice inglese Mary Emily Eaton, che all'epoca lavorava per l'orto botanico di New York; per la precisione del tratto e la vivezza dei colori questa eccellente artista fu definita dai contemporanei "la più grande pittrice di piante dal vivo". A coadiuvarla, un team tutto al femminile: Deborah Griscom Passmore, Helen Adelaide Wood, Kako Morita. Britton e Rose partirono dalle revisioni di Schumann e di Berger, ma si spinsero molto più in là, creando molti generi più piccoli; oltre a correggere le denominazioni di molte specie, ne pubblicarono numerose per la prima volta. Anche se nel secolo che è intercorso da allora la storia tassonomica della Cactaceae ha continuato ad essere travagliata e molte sono state le revisioni, è significativo della qualità del loro lavoro il fatto che ben 50 dei 79 generi da loro creati continuato ad essere accettati, anche se spesso ne sono stati ridefiniti i confini. Inoltre, anche grazie alla splendida veste editoriale, The Cactaceae ebbe anche il merito di destare l'interesse del grande pubblico per una famiglia di piante che all'epoca era ancora poco di moda.  Modeste piante aromatiche e alberi d'oro Terminata l'impresa, Rose riprese il suo lavoro allo Smithsonian. Non cessò però la sua collaborazione con Britton; negli anni '20 i due botanici scrissero insieme la trattazione delle Mimosaceae e delle Caesalpinaceae per la North American Flora. Rose diede ancora prova delle sue grandi capacità di tassonomista ridefinendo il super genere Cassia, il cui status all'epoca era estremamente confuso. Egli morì nel 1928, sei anni prima dell'amico e compagno di avventura. Nella sezione biografie, una sintesi della vita di questo grande botanico, che il destino e l'ordine alfabetico collocano in seconda posizione anche come autore di The Cactaceae. Vorrei salutarlo con le parole di Alwin Berger che lo definì "uno degli uomini meno egoisti e di animo più gentile che io abbia mai incontrato". Come a Britton, anche a Rose furono dedicati numerosi generi (c'è anche una dedica comune, Brittonrosea Speg., oggi sinonimo di Echinocactus); a essere attualmente validi sono due: Rhodosciadium e Roseodendron. Come abbiamo visto, nella sua lunga carriera di tassonomista specializzato nel riportare ordine nella sistematica di famiglie complicate, i primi lavori di Rose furono dedicati alle Apiaceae. E proprio a questa famiglia appartiene Rhodosciadium, che nel 1889 gli fu dedicato dall'illustre botanico Sereno Watson. Il nome, un composto di rhodon, "rosa" e sciadeion "ombrello", si basa su un gioco di parole tra rose, "rosa" in inglese, e Rose, il cognome del nostro botanico e significa "ombrellifera dedicata a Rose". Il genere è distribuito tra Stati Uniti meridionali e Guatemala e gli sono attribuite da cinque a quindici specie. Sono erbacee perenni degli ambienti montani, con ombrelle rade con pochi fiori viola o giallo-verdastro. E' curioso che proprio Rose nel 1895 abbia separato dal genere dedicato a lui stesso alcune specie messicane, assegnandole al nuovo genere Deanea (oggi non accettato). In rete sono disponibili davvero poche informazioni su questo genere discusso; Rhodosciadium longipes (una specie pubblicata per la prima volta da Rose con il nome Deanea longipes) in Messico, dove è chiamata espico, è considerata una pianta medicinale. Una sintetica presentazione del genere nella scheda. Le ricerche di Rose prima in Messico e poi in Sud America ne hanno fatto una figura quasi leggendaria per i botanici dell'America latina. Non stupisce che Faustino Miranda, forse il più noto botanico messicano, nel separare da Tabebuia due specie abbia voluto dedicare a Rose il nuovo genere Roseodendron (1965), ovvero "albero di Rose". La denominazione di Miranda tuttavia fu presto respinta, e le piante furono assegnate a Cybistax, per poi ritornare a Tabebuia. Ricerche molecolari pubblicate nel 2007 hanno però dato ragione a Miranda, raccomandando di resuscitare Roseodendron. Appartenente alla famiglia Bignoniaceae, comprende due sole specie: R. donnell-smithii, e R. chryseum. R. donnell-smithii è la specie più diffusa; raccolta in Messico da Palmer, fu pubblicata proprio da Rose nel 1892 come Tabebuia donell-smithii. E' un albero magnifico che al momento della fioritura si ricopre di grandi fiori dorati; è nota con il nome colloquiale "primavera"; ha un areale abbastanza ampio (dal Messico meridionale al Guatemala) ma è anche frequentemente coltivata. R. chryseum è invece un endemismo delle foreste aride del Venezuela nordoccidentale e della Colombia settentrionale. Rispetto all'altra specie è di dimensioni minori e presenta infiorescenze meno compatte. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
Il Giardino botanico di New York (New York Botanical Garden, NYBG) è uno dei più importanti orti botanici del mondo; situato nel quartiere del Bronx, oggi si estende per oltre 1 km², contiene 48 diversi giardini, ospita serre, laboratori, il maggiore erbario dell'emisfero settentrionale con 7.800.000 esemplari e la biblioteca botanica più importante del paese, ricca anche di manoscritti e testi storici. Eppure tutto è incominciato da un fazzoletto di terra e dal sogno di una coppia di botanici, Nathaniel L. Britton e Elizabeth G. Knight Britton. Lui, oltre ad aver diretto il NYBG per più di trent'anni, è stato un riconosciuto esperto della flora del centro America, ma è famoso soprattutto per il libro sulle Cactaceae che scrisse a quattro mani con J.N. Rose. Lei è stata una pioniera degli studi sui muschi degli Stati Uniti orientali e delle battaglie ecologiste. Entrambi sono ricordati da generi monotipici: Neobrittonia (Malvaceae) per Nathaniel, Bryobrittonia (Encalyptaceae) per Elizabeth.  Un giardino nato dal sogno di una coppia di botanici Anche se uno dei primi orti botanici statunitensi, l'Elgin Botanic Garden, sorse proprio qui, alla fine dell'Ottocento New York era priva di un orto botanico. Infatti, nel 1808 David Hosack, il fondatore, era stato costretto a vendere l'Elgin Botanical Garden alla città; trasferito al Columbia College, era stato lasciato all'abbandono fino a scomparire. Sopravvivevano soltanto i resti della biblioteca e dell'erbario. Se oggi la città vanta uno dei prestigiosi giardini botanici del mondo, New York Botanical Garden (NYBG), si deve a una coppia di straordinari botanici, Nathaniel Lord Britton e Elizabeth Gertrude Knight Britton. Nathaniel si era laureato in geologia e aveva partecipato alla ricognizione geologica del New Jersey, ma fin dagli anni universitari era appassionato di botanica ed era un membro attivo del Torrey Botanical Club. Verso la metà degli anni '80 divenne insegnante di geologia e botanica alla Columbia University. I suoi interessi si spostarono sempre più verso la botanica; al Torrey conobbe una giovane briologa, Elizabeth Gertrude Knight, che sposò nel 1885. Nel 1888 la coppia andò a Kew per condurre alcune ricerche e entrambi furono impressionati dai giardini, dall'erbario e dalla biblioteca. Sembra che sia stata Elizabeth ad esclamare: "Dobbiamo avere un'istituzione così a New York!". Di ritorno a casa, Elizabeth presentò una entusiastica relazione al Torrey Club e propose di fondare un Comitato per promuovere la creazione di un orto botanico, concepito allo stesso tempo come un giardino per il piacere della cittadinanza, un'istituzione educativa e un centro di ricerca e irradiazione della conoscenze botaniche sul modello di Kew. Entrambi i Britton erano energici e convincenti e seppero coinvolgere nel progetto le maggiori istituzioni scientifiche cittadine: oltre al Torrey Botanical Club, la Columbia University (dove Nathaniel insegnava e Elizabeth prestava servizio volontario come curatrice dell'erbario dei muschi), l'American Museum of Natural History. La campagna di raccolta fondi, di cui Elizabeth divenne l'anima, coinvolse quotidiani come il Sun e l'Herald Tribune e guadagnò il sostanzioso sostegno dei grandi magnati della città, da Morgan a Carnegie a Vanderbildt, che poi figurarono ai vertici del consiglio di amministrazione. Fondato ufficialmente con un atto del New York State Legislature il 28 aprile 1891, il nuovo orto botanico sorse nel Bronx Park, a nord della città; i lavori cominciarono tuttavia solo nel 1896 e richiesero diversi anni. La biblioteca fu completata nel 1900 e la grande serra nel 1909. Nominato segretario del consiglio di amministrazione fin dall'atto di fondazione, nel 1896 Britton lasciò la Columbia University, dove, oltre a insegnare geologia e botanica, era anche il curatore della biblioteca e dell'erbario, e divenne il primo direttore del NYGB. Con l'assenso della Columbia University, che continuò a collaborare strettamente con la nuova istituzione, le collezioni di cui era curatore si trasferirono con lui. In quegli anni, mentre Elizabeth si batteva anima e corpo per raccogliere i fondi per il nascente giardino, Nathaniel era anche impegnato nelle ricerche per la sua prima opera importante, An Illustrated Flora of the Northern United States and Canada, finanziata da Addison Brown e nota come Britton & Brown Illustrated Flora, la prima flora illustrata dell'America settentrionale. I Britton pensavano che come Kew era la "capitale botanica" dell'impero coloniale britannico, allo stesso modo il NYBG dovesse assumere la guida delle ricerche botaniche non solo nel territorio metropolitano, ma anche nelle aree di influenza statunitense in America centrale, a partire dal protettorato di Porto Rico. Fu così che il NYBG fu in prima linea nelle ricerche botaniche nell'area; nel 1902 la coppia iniziò una serie di viaggi nelle Antille e nei Caraibi. Tutti gli anni, quando l'inverno newyorchese si faceva più duro, i Britton si trasferivano a sud, non in vacanza, ma in spedizioni botaniche sul campo finanziate in parte da loro stessi, in parte da cordate tra diverse istituzioni scientifiche. Nathaniel partecipò di persona a una trentina di spedizioni; la più importante è senza dubbio la ricognizione scientifica di Porto Rico e delle Isole Vergini, condotta dall'Accademia delle Scienze di New York in collaborazione con il governo di Porto Rico e l'American Museum of Natural History che si protrasse per sette anni, dal 1919 al 1926 e coinvolse scienziati di molte discipline. Furono i viaggi in America centrale a destare l'interesse di Britton per le Cactaceae. Ne nacque il progetto che porterà alla stesura di The Cactaceae, il suo capolavoro, scritto a quattro mani con Joseph Nelson Rose. Un'opera così importante che merita un post a parte. Britton diresse il NYBG fino al pensionamento, nel 1929. Oltre ad essere uno scienziato di grande valore, aveva grandi capacità organizzative e sotto la sua direzione il giardino crebbe rapidamente; nel 1915, con l'acquisizione di un settore sottoutilizzato del Brox Park, passò da 250 a 400 acri. Britton curò l'arricchimento delle collezioni, varò programmi di conferenze e fece del giardino (il cui accesso rimase gratuito per mezzo secolo) uno spazio bello e piacevole per i suoi concittadini, un punto di incontro reso vivo da mostre e iniziative divulgative; ma soprattutto lo rese un'istituzione scientifica di primo piano. Si batté per centralizzare le collezioni di libri e erbari disperse tra le varie istituzioni newyorchesi; grazie a affidi, doni e acquisti, al termine del suo mandato la biblioteca contava 43.500 volumi e l'erbario 1.700.000 esemplari. Egli credeva nella collaborazione tra le varie istituzioni scientifiche, e fu tra gli animatori della Scientific Alliance of New York, purtroppo di breve durata. Era anche noto per il carattere imperioso e poco accomodante (scherzosamente, usando il suo secondo nome, lo chiamavano "il Lord"). In campo tassonomico si batté per la stretta osservanza della regola della priorità; ma lo fece in modo talmente rigido e poco diplomatico da provocare una rottura sia con molti colleghi statunitensi sia con i botanici europei. Britton scisse moltissimo; accanto e dopo il grande lavoro sulle Cactaceae, pubblicò numerosi volumi sulla flora delle Antille: Flora of Bermuda (1918), The flora of the American Virgin Islands (1918), Descriptions of Cuban plants new to science (1920), The Bahama flora (1920) in collaborazione con Charles Frederick Millspaugh. 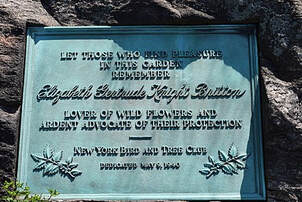 Dallo studio dei muschi alla battaglia per le piante native E' ora di conoscere più da vicino sua moglie Elisabeth Gertrude Knigth; proprio come il marito, era una figlia della città di New York, ma aveva trascorso lunghi periodi a Cuba, dove il nonno possedeva una piantagione di canna da zucchero. A soli 17 anni si diplomò e incominciò a insegnare come tutor di Scienze naturali alla Normal School (oggi Hunter College). Nel 1879, a ventun anni, si iscrisse al Torrey Botanical Club e fece il suo esordio nella carriera botanica scoprendo la fruttificazione del muschio Eustichium norvegicum e la presenza in Nuova Scozia della rara felce Schizaea pusilla. Aveva già deciso di specializzarsi nello studio delle piante di cui sarebbe diventata una dei massimi esperti: i muschi. Era un'appassionata escursionista e in questi anni visitò gli Adirondack e gli Appalachi. Fu al Torrey che conobbe Nathaniel Britton, che era il responsabile del bollettino dell'associazione, su cui Elizabeth pubblicò i suoi primi articoli; nel 1884 divenne curatrice dei muschi e nei 1886 redattrice del bollettino. Nel 1893, fu la sola donna tra i 25 membri fondatori della Botanical Society of America. Dopo il matrimonio, lasciò l'insegnamento e prestò servizio come volontaria alla Columbia University, dove era la responsabile non ufficiale dell'erbario dei muschi. Benché non avesse un titolo accademico, era una guida e punto di riferimento per studenti e specializzandi. Abbiamo già parlato del viaggio a Kew (dove era andata a studiare la collezione di muschi di Henry Hurd Rusby) e della battaglia per il NYBG. Quando l'erbario della Columbia fu trasferito nel neonato giardino, continuò nella nuova sede l'attività volontaria come curatrice dei muschi dal 1912 al 1929; grazie a lei, furono acquisite molte collezioni. Molto del suo tempo fu dedicato alla catalogazione dell'erbario di muschi di William Mitten, acquisito dal NYBG nel 1906. Insieme al marito, erborizzò in Porto Rico, Giamaica e Cuba. Durante la sua carriera, scrisse quasi 350 articoli, metà dei quali dedicati ai muschi. Il progetto di un grande Handbook of Mosses of Eastern America, fu abbandonato a favore di una serie di articoli più brevi, in parte confluiti nella North American Flora pubblicata dal NYBG. Dall'inizio del secolo, quando la battaglia per l'orto botanico era già stata vinta, Elizabeth Britton abbracciò con tutta la sua determinazione una seconda causa: quella della salvaguardia dei fiori selvatici. Nel 1902 fu tra i fondatori della Wild Flower Preservation Society che si batteva per proteggere le piante native anche attraverso provvedimenti legislativi; ne divenne segretaria e tesoriera e, oltre a pubblicare numerosi articoli sull'argomento nella rivista del NYBG, per sensibilizzare l'opinione pubblica partecipò letteralmente a migliaia di eventi in scuole e garden club. Nel 1925 come presidentessa del comitato per la conservazione dei Garden Club dello Stato di New York guidò una vittoriosa campagna di boicottaggio contro la pratica di utilizzare rami di agrifoglio selvatico come decorazione natalizia. Nel 1929, quando Nathaniel andò in pensione, la coppia, che abitava in una casa del Brox non lontana dall'orto botanico, alternò ai soggiorni in città quelli nel Cottage di Richmond, un edificio storico che apparteneva alla famiglia Britton fin dal 1695. Nathaniel lavorava a una flora di Porto Rico (Flora Borinquena) che rimase incompiuta. Entrambi morirono nel 1934, a quattro mesi di distanza, prima Elizabeth, poi Nathaniel, che non si era mai ripreso dalla perdita della moglie. Una sintesi delle loro vite nella sezione biografie.  Due piccoli generi per due grandi botanici Non sorprende che, come direttore di un'istituzione tanto prestigiosa, come ricercatore con all'attivo la scoperta di numerose specie e come autore di opere decisive come The Cactaceae, Nathaniel Lord Britton abbia collezionato la dedica di quasi settanta nomi di specie e di sei generi. Tuttavia uno solo rimane valido, Neobrittonia, che gli fu dedicato nel 1905 da Hochreutiner dell'Orto botanico di Ginevra, riclassificando una specie messicana precedentemente denominata Abutilon acerifolium Don. Neobrittonia acerifolia, l'unico rappresentante di questo genere della famiglia Malvaceae, è un arbusto diffuso dal Messico centrale a Panama in boschi misti, pinete e boschi mesofili di montagna tra 2100 e 2400 metri. Alto tra due e tre metri, ha rami ricoperti di lunghi peli e foglie che ricordano quelle dell'acero, profondamente lobate, con tre o cinque lobi; ha fiori attraenti, con cinque petali lilla violaceo, seguiti da frutti tondeggianti, formati da 8-12 segmenti ravvicinati e disposti a ruota, abbastanza simili a quelli del nostrano Abutilon theophrasti, ma irsuti e spinosi. Qualche dettaglio in più nella scheda. Anche Elizabeth Knight Britton ha ricevuto la sua parte di onori: a ricordarla i nomi specifici di una quindicina di piante, come la felce Thelypteris brittoniae, e il genere di muschi Bryobrittonia, che gli fu dedicato nel 1901 da R.S. Williams, soprattutto in riconoscimento del suo ruolo educativo quando era curatrice dei muschi alla Columbia University. Scrive infatti Williams: "Il genere è dedicato a Mrs. Elizabeth G. Britton, il cui aiuto ha incoraggiato molti studiosi americani dei nostri muschi". Appartenente alla famiglia Encalyptaceae, è anch'esso un genere monotipico, che comprende solo B. longipes, una specie dei climi rigidi che vive su substrati calcarei in Nord America, Europa e Asia centrale. Altre informazioni nella scheda. Due simboli iconici si incontrano in questa storia: da una parte il saguaro, il cactus gigante dei deserti americani, reso familiare dall'immaginario cinematografico; dall'altra, Andrew Carnegie, incarnazione del sogno americano, multimiliardario che ha ispirato la figura di zio Paperone, a suo tempo considerato l'uomo più ricco del mondo, ma anche celebre benefattore e filantropo. Il punto d'incontro tra i due è una collina nei pressi di Tucson, dove i saguaro sono di casa e dove, finanziato da Carnegie, nacque il Desert Laboratory. Qui li studiarono i botanici Britton e Rose, scoprendo che appartenevano a un genere tutto loro; e in onore del finanziatore, il saguaro divenne Carnegiea gigantea.  Prologo: cactus giganti e film western Chiudete gli occhi e provate a immaginare la scena madre di un tipico film western. Siamo alla resa dei conti: l'eroe, pistola in pugno, sta per affrontare il cattivo. A fare da sfondo, il deserto: terra rossastra, in lontananza le sagome della Monument Valley. La vegetazione è ridotta a pochi cespugli spinosi ma qua e là si stagliano le maestose sagome del cactus a candelabro. Lo state vedendo? E' lui, il nostro primo protagonista, il saguaro, ovvero Carnegiea gigantea, simbolo iconico dei film western; eppure, nella Monument Valley, i saguari non ci sono; e neppure nelle tante location in Utah, Colorado, New Mexico, Texas dove la fantasia di registri e scenografi li ha sparsi a piene mani. In realtà, il saguaro vive solo nel deserto di Sonora, anzi in alcune parti della porzione orientale di questo deserto, in Messico e in Arizona meridionale e occasionalmente nella California sudorientale; il cuore del suo regno è il Parco nazionale dei saguaro, nell'Arizona meridionale, con due sezioni rispettivamente nelle Tucson Mountains e nelle Rincon Mountains. Non lontano dalle Tucson Mountains e dal parco, nel 1939 la Columbia Pictures allestì il set dove fu girato Arizona, diretto da Wesley Ruggles. Al termine delle riprese, la casa di produzione decise di trasformarlo in uno studio cinematografico permanente, dove da quel momento sarebbero stati girati tutti i suoi western. Da allora sono stati oltre 300 tra film e telefilm, tra cui un monumento della cinematografia come Sfida all'OK Corral (1957). E' stato così che i saguaro hanno incominciato ad essere associati ai film western e diventarne un immancabile accessorio di scena, andando a popolare il nostro immaginario e paesaggi dove non esistono in natura.  Primo atto: il miliardario filantropo Altrettanto iconico è anche il secondo protagonista di questa storia, il miliardario Andrew Carnegie, incarnazione del sogno americano "dall'ago al milione" e prototipo della figura di zio Paperone. Come da copione, il nostro nasce in Scozia, arriva in America poverissimo e fa i più diversi mestieri: a tredici anni è un bobbin boy, uno dei ragazzi addetti al cambio e alla raccolta delle spolette in una manifattura di cotone, per dodici ore al giorno, sei giorni su sette, per una paga di un dollaro la settimana; lavora poi in una fabbrica di spolette, quindi passa ad una compagnia locale di telegrafi, prima come fattorino, poi come operatore. A 18 anni (adesso il suo salario è di 4 dollari la settimana) diventa operatore telegrafista della compagnia ferroviaria Pennsylvania Railroad Company e poi segretario di uno dei dirigenti; è un avido lettore, che nel tempo libero legge più che può e studia da autodidatta. A 24 anni diventa sovrintendente della Western Division. Siamo nel 1859 e le ferrovie sono un settore in grande espansione; Carnegie conosce le persone giuste e grazie ai loro consigli fa i suoi primi investimenti proprio nelle ferrovie, prendendo in prestito 500 dollari con un'ipoteca sulla casa di sua madre. Conosce per caso T. T. Woodruff, l'inventore del vagone letto, e insieme a lui fonda una piccola società per sfruttare l'invenzione. Il primo affare importante arriva con la guerra di successione; con la sua esperienza sia nei telegrafi sia nelle ferrovie, Carnegie è incaricato dal governo dell'Unione di ristabilire le linee ferroviarie e telegrafiche tagliate dai sudisti. Il trasporto di truppe e di materiali al fronte fornisce altre opportunità di guadagno. Dopo la guerra, Carnegie lascia le ferrovie, e si lancia nel siderurgico. La prima fabbrica, Cyclops Iron Company, fondata nel 1864 insieme al fratello, assorbe via via alcune fucine della zona e diventa la Union Mill. Produce ferro, un prodotto che il mercato chiede sempre meno, ormai soppiantato dall'acciaio. Durante un viaggio in Inghilterra, Carnegie conosce un nuovo metodo di produzione dell'acciaio, il processo Bessemer, e lo introduce nella sua acciaieria, fondata nel 1872. Da quel momento, sarà un successo travolgente. Combinando innovazione tecnologica, organizzazione efficiente e bassi salari, riesce via via ad assorbire i concorrenti, come la rivale Homestead Steel Works acquisita nel 1883, e diventa l'imperatore dell'acciaio; Pittsburgh è la capitale mondiale di quell'impero. Alla fine degli anni '80 la Carnegie Steel è la più grande produttrice di ghisa, rotaie ferroviarie e coke del mondo. Con i suoi associati, controlla l'integrazione verticale di tutte le fasi produttive, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione del prodotto finito. Nel 1892 nasce ufficialmente la Carnegie Steel Company, che dà una struttura formale a una ragnatela di interessi ed attività, che include la costruzione di locomotive, ferrovie, ponti, porti, edifici e la proprietà di 18 giornali. Lo stesso anno, mentre Carnegie si trova in vacanza in Italia, le sue acciaierie sono al centro di uno scontro sindacale (Homestead Strike), risolto da suoi associati con l'uso della forza. Carnegie è lontano, ma approva pienamente l'operato dei suoi uomini, compreso l'uso di milizie private e l'uccisione di diversi scioperanti. La sua reputazione ne esce compromessa. E' forse anche per questo che nel 1901, all'età di 66 anni, decide di ritirarsi. Trasforma l'azienda in una società per azioni e vende le sue attività industriali al banchiere John Morgan per la cifra record di 480 milioni di dollari. Le cronache del tempo lo considerano l'uomo più ricco del mondo (gli studiosi lo ritengono il quarto uomo più ricco di tutti i tempi). Da questo momento in avanti, non sarà più un industriale, ma un filantropo; anche se le sue attività filantropiche erano già iniziate da qualche anno, ora saranno la sua occupazione esclusiva. Autodidatta, crede nel valore dell'istruzione, e si impegna nella creazione di biblioteche: per suo impulso ne nasceranno oltre 2500, non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi anglofoni. Per gli amanti della musica, il suo nome è perpetrato dalla Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto del mondo, costruita a New York per sua volontà nel 1890; per quelli delle arti, dal Carnegie Museum of Pittsburgh.  Secondo atto: un laboratorio nel deserto I musei, le fondazioni, le università, gli istituti di ricerca finanziati da Carnegie sono innumerevoli; sono una ventina le fondazioni che portano il suo nome, impegnate nei campi più diversi. Soffermiamoci su una soltanto, Carnegie Institution for Science di Washington. Molto interessato al progresso scientifico, subito dopo il ritiro, il miliardario-filantropo pensò di fondare una università nazionale a Washington, simile ai grandi centri di ricerca europei; temendo però lo scontento delle università già esistenti, vi rinunciò, puntando su un istituto di ricerca indipendente impegnato ad accrescere le conoscenze scientifiche di base. Comunicò al presidente Theodore Roosvelt che era pronto a dotare la nuova istituzione di 10 milioni di dollari; nel 1907 ne aggiunse 2, e altri 10 nel 1911. Inizialmente, l'istituzione finanziò soprattutto ricerche individuali, ma creò anche alcuni laboratori di ricerca. E finalmente stiamo per scoprire qual è il legame tra Andrew Carnegie e il saguaro. Nel 1891 Frederick V. Coville, botanico capo del Dipartimento federale di Agricoltura, aveva esplorato la Death Valley in California ed era rimasto affascinato dalla varietà di forme di vita in un ambiente così estremo. Poco dopo la sua fondazione, egli propose alla Carnegie Institution for Science di finanziare un laboratorio dove studiare le condizioni di vita delle piante dei deserti; l'istituto approvò la proposta e concesse un finanziamento di 8000 dollari. Restava da trovare un sito appropriato: insieme a Daniel T. MacDougal, direttore assistente del New York Botanical Garden, Coville visitò varie aree promettenti in California, New Mexico, Chihuaha, Sonora e Arizona; alla fine la scelta cadde su Tumamoc Hill, un'area collinare ricca di vegetazione ma facilmente accessibile nei pressi di Tucson. Nasceva così il Desert Botanical Laboratory, inaugurato il 7 ottobre 1903. Diretto inizialmente da MacDougal, che mantenne l'incarico fino al pensionamento nel 1928, divenne la base del Carnegie Department of Botanical Research, dotandosi via via di edifici per ospitare lo staff, di una serra, di aiuole sperimentali, di una rivista. Nella primavera del 1906, Volney Spalding, professore in pensione dell'Università del Michigan, che si era trasferito a Tucson in cerca di un clima più mite, propose di delimitare 19 quadrati di 10 metri x 10, e monitorare le piante perenni, identificando, mappando e fotografando tutti gli individui. Era un metodo innovativo che faceva i suoi esordi proprio in quegli anni. Lo stesso anno vennero acquisiti ulteriori terreni e l'intera area fu circondata da una palizzata per tenere lontano il bestiame. Primo laboratorio al mondo dedicato alla flora dei deserti, il Desert Laboratory in pochi anni divenne un'istituzione di punta e uno stimolo per la nascita dell'ecologia negli Stati Uniti; nel 1915, tra i 30 fondatori della Ecological Society of America, sette erano ricercatori del Desert laboratory. Nel 1938, in seguito a problemi economici, la Carnegie Institution for Science decise prima di tagliare drasticamente i finanziamenti, riducendo all'osso il personale, poi di liberarsi del laboratorio, vendendolo simbolicamente per un dollaro. Propose l'acquisto all'Università dell'Arizona, che rifiutò; ad accettare fu invece il dipartimento federale delle foreste, che fino al 1956 lo usò come stazione sperimentale. Fu un periodo di sostanziale decadenza, con poche ricerche condotte soprattutto dall'Università dell'Arizona. La quale, nel 1956 si decise ad acquistare il laboratorio: ma invece di pagarlo un dollaro, dovette sborsarne 100.000. Il laboratorio rinacque. Nel 1964, venne realizzato un censimento dei saguaro, da confrontare con la mappa disegnata da Spanding nel 1907; il censimento fu ripetuto nel 1970, nel 1993 e tra il 2011 e il 2012. Nel 1982, furono creati nuovi quadrati per studiare le piante annuali. Nove di quelli creati da Spanding per le piante perenni esistono ancora: è la più lunga serie di dati fornita da quadrati ecologici al mondo. Oggi, con il nome di Desert Laboratory on Tumamoc Hill, è allo stesso tempo un'area protetta che preserva un ambiente unico, un laboratorio di studi ambientali, un'istituzione educativa collegata con l'Università dell'Arizona. Molte informazioni nel sito, inclusi coinvolgenti filmati.  Epilogo: come il cactus gigante divenne Carnegiea Tra i primi progetti del Desert Laboratory, figura la collaborazione con Britton e Rose per la grande ricerca sulle Cactaceae che sfocerà nei magnifici volumi su questa famiglia pubblicati tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution. Fu MacDougal a suggerire a Nathaniel Britton, all'epoca direttore dell'orto botanico di New York, di ampliare la sua ricerca sulle cactacee americane e di chiedere il finanziamento del Carnegie Institution per un progetto molto più ambizioso. Le trattative richiesero tempo, ma alla fine l'istituzione accettò di finanziare le ricerche e la pubblicazione e nel 1912 tanto Britton quanto Rose furono nominati ricercatori associati alla Carnegie. Il progetto si configurò fin da subito come una collaborazione tra l'orto botanico di New York, lo Smithsonian (dove a lungo aveva lavorato Rose) e il Desert Laboratory, che fu anche una delle sue basi logistiche. Tra le piante più caratteristiche di Tumamoc Hill ci sono proprio i saguaro; fu qui che li studiarono Britton e Rose, capendo che dovevano essere assegnati a un genere proprio (all'epoca erano ancora attribuiti al genere Cereus con il nome C. giganteus); era un'ottima occasione per ingraziarsi lo sperato finanziatore, ovvero Mr. Carnegie. Fu così che nel 1908 i due botanici crearono in suo onore il genere Carnegiea, con questa motivazione: "Questo genere è dedicato a Mr. Carnegie. Il Desert Laboratory della Carnegie Institution di Washington, a Tucson, Arizona, è circondato da esemplari tipici di questa pianta unica". Qualche maligno ha osservato che la dedicata era azzeccata non solo per la bellezza e l'unicità di questa specie, ma anche per le sue micidiali spine, evocative del carattere spinoso del dedicatario. Spinosità dimostrata anche in occasione della presentazione della nuova denominazione: inizialmente, Carnegie fu molto lusingato, ma quando scoprì che non si trattava di una nuova specie, ma solo di un cambio di nome, perse ogni interesse. Per inciso, egli morì nel 1919, pochi mesi dopo l'uscita del primo fascicolo di Cactaceae di Britton e Rose. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Sia come sia, da allora il saguaro è Carnegiea gigantea Britton & Rose, unica specie del suo genere. E' un cactus colonnare, con un tronco imponente, che mediamente raggiunge i dieci metri. Il più grande esemplare conosciuto è alto 13 metri e ha una circonferenza di 3 metri. I fusti colonnari hanno in genere 11-15 coste, lungo le quali si trovano areole ben separate, distanziate di circa 2-3 cm tra loro, ciascuna delle quali porta da 15 a 30 spine, lunghe da 5 a 11 cm, che provocano ferite dolorose e facili ad infettarsi. Sono piante a lentissima crescita. Quando nascono, sono minuscole, e a due anni non misurano ancora un cm. Una pianta di 15 anni è alta intorno ai 30 cm, mentre una pianta di un metro ha tra 20 e 50 anni di età. Intorno a 30 anni, incomincia a produrre i primi fiori e i primi frutti, ma la vera maturità arriva tra i 50 e i 75 anni, quando incomincia a sviluppare rami laterali; gli esemplari più vecchi e imponenti ne hanno molti (il record è di 49 rami, o braccia, su una singola pianta): lo sviluppo di molteplici rami è importante per la riproduzione, dal momento che la fioritura avviene soprattutto agli apici di fusti. Molti esemplari, tuttavia, non li sviluppano mai. I rami laterali sono piuttosto diversi dal fusto principale: hanno costolature molto più numerose, poco profonde, con spine più ravvicinate ma molto più brevi e meno acuminate, in modo da permettere l'accesso degli ospiti che impollinano i fiori e si cibano dei frutti. I bellissimi fiori bianchi, di consistenza cerosa, ricchissimi di polline, si aprono nel tardo pomeriggio e durano meno di una giornata; sono impollinati da numerosi animali, tanto diurni quanto notturni: api da miele, pipistrelli e molte specie di uccelli, tra cui colombe dalle ali bianche e diversi colibrì. I fiori sono seguiti da frutti che ricordano i fichi d'India, appetiti dagli uccelli. Ognuno contiene circa 2000 semi; in effetti, anche se hanno un'alta germinabilità, l'aridità e la predazione comportano molte perdite, tanto che si stima che solo l'1% produca una pianticella. Appena nata è minuscola, e ha bisogno di essere protetta per sopravvivere e crescere; a provvedere sono alberi e cespugli, come le leguminose Olneya tesota o Parkinsonia florida, che forniscono ombra e trattengono l'umidità. Negli ambienti più aridi, tuttavia, queste piante sono assenti e i saguaro iniziano la loro vita in mezzo a ciuffi d'erba o cespugli di Ambrosia dumosa o ancora accanto ad altre Cactaceae come Opuntia kunzei. Il saguaro è una specie chiave nel suo ambiente, che provvede cibo, riparo e protezione a molti animali. L'abbondantissimo polline è una fonte di cibo importante per i suoi impollinatori, come lo sono i frutti per le formiche e vari uccelli, in particolare le colombe dalle ali bianche. I picchi Melanerpes uropygialis e Colaptes chrysoides scavano i loro nidi nei tronchi; in genere, li usano per una sola stagione, rinnovandoli ogni anno. I loro nidi abbandonati, attorno al quale la pianta ha prodotto un callo legnoso, si trasformano in case "chiavi in mano" per molte altre specie di uccelli. Anche i nativi hanno sfruttato i saguaro per secoli in vari modi: le costole lignificate degli esemplari morti venivano usate per palizzate e gli antichi nidi dei picchi come cestini; con i frutti si preparavano marmellate, sciroppi e bevande fermentate per le cerimonie religiose. Qualche approfondimento nella scheda. C'è chi lo chiama il Plinio tedesco (anche se non era tedesco, ma svizzero, era erudito quanto Plinio, ma molto più dotato di senso critico), oppure il Leonardo svizzero (dato che, oltre a essere un genio poliedrico, era anche un disegnatore di talento, il paragone calza di più). In ogni caso, anche per gli standard del Rinascimento, epoca che coltivò più d'ogni altra l'aspirazione all'uomo universale, lo svizzero Conrad Gessner fu certamente una personalità d'eccezione. Fu teologo, medico, insegnante, linguista, filologo, bibliografo, naturalista, un poligrafo che scrisse degli argomenti più diversi. Per i posteri è il padre di due discipline tanto lontane come la bibliografia e la zoologia, con le enciclopediche Bibliotheca universalis e Historia animalium. Ma per i contemporanei, e forse per lui stesso, era soprattutto un botanico; la morte precoce e improvvisa gli impedì di completare e pubblicare quella che riteneva la vera grande opera della sua vita, l'altrettanto enciclopedica Historia plantarum. Rimasta manoscritta e pubblicata parzialmente solo duecento anni dopo la morte dell'autore, è la grande opera mancata della botanica rinascimentale. A rivelarci il metodo innovativo di Gessner, basato sull'osservazione minuziosa delle piante e sul confronto tra il maggior numero possibile di specie alla ricerca di una chiave di classificazione, sono soprattutto le lettere ai numerosissimi corrispondenti e ancor più i disegni allestiti per il suo magnum opus, sorprendenti per la precisione e per la scelta dei particolari, del tutto inconsueti per l'epoca. Il poligrafo svizzero era anche un alpinista entusiasta, oltre che il primo in età moderna a rimarcare il legame tra la distribuzione delle piante, il terreno e l'altitudine. Inoltre fu uno degli animatori della grande rete di scambio di informazioni, semi, piante, esemplari che caratterizzò l'ambiente naturalistico del Cinquecento; in relazione con molti dei maggiori botanici del suo tempo, influenzò direttamente l'opera di Jean Bauhin, che fu suo allievo. Stimato dai botanici delle generazioni successive, fu ricordato da Plumier (e da Linneo) con la dedica del genere Gesneria, che dà il nome alla famiglia Gesneriaceae.  Una memorabile ascensione Nel 1541, Conrad Gessner (all'epoca aveva ventisei anni) in una lettera all'amico Jakob Vogel, poi pubblicata come dedicatoria dell'opuscolo Libellus de lacte ac operibus lactariis, espresse tutto il suo entusiasmo per le montagne e promise: "Mi propongo per il futuro, finché Dio mi concede di vivere, di scalare le montagne, o almeno di scalare una montagna all'anno". Sappiamo che tenne fede alla promessa, ma di queste escursioni annuali purtroppo ci rimane un solo resoconto: quella della scalata del Grepfstein (1926 m. sul livello del mare), una delle cime del gruppo del Pilatus, alle spalle di Lucerna, nell'agosto 1555. Insieme ad alcuni amici, da Zurigo, dove abitava, Gessner raggiunse Lucerna, dove assunse una guida, dal momento che le autorità cittadine vietavano di accedere al Pilatus da soli. Si credeva infatti che la montagna fosse infestata dal fantasma di Ponzio Pilato, che qui sarebbe stato esiliato e qui sarebbe morto suicida; meglio non sfidare quell'anima in pena, che alla minima provocazione scatenava terribili tempeste! Gessner non ci crede più di tanto e si gode la gita con tutti i sensi: la vista ammaliata dallo spettacolo delle cime e dal magnifico panorama; il tatto piacevolmente solleticato dalle fresche e pure brezze alpine, tanto in contrasto con l'inquinata aria cittadina; l'olfatto deliziato dal profumo dei fiori e delle erbe; persino il gusto è appagato da uno rustico spuntino a base di pane e acqua di fonte: "Dubito che i sensi umani possano assaporare un piacere più grande e più epicureo". Prima di affrontare l'ultimo tratto, nell'ultima malga Gessner vede e ascolta un corno delle Alpi e, quasi per sfida, prova a suonarlo. Quindi la guida li conduce alla cima, attraverso un cammino abbastanza arduo e non segnato da sentieri. Sulla cima, gli amici incidono il loro nome sulle rocce, come hanno fatto molti altri viandanti prima di loro; di Pilato nessun segno, da nessuna parte. Gessner conclude: "Da parte mia, sono inclinato a pensare che non sia mai stato qui". All'andata e al ritorno, il naturalista osserva gli animali (le trote del torrente Rumling, camosci, stambecchi, marmotte) e erborizza, raccogliendo una quarantina di specie diverse. E' affascinato dalla maestosità delle montagne, che per un uomo profondamente religioso come lui è segno e prova della grandezza di Dio, e dalla varietà della natura alpina: "In nessun altro luogo come in montagna è possibile incontrare tanta varietà; a parte ogni altra considerazione, solo in montagna è possibile contemplare e sperimentare le quattro stagioni, estate, autunno, inverno e primavera, riuniti in una sola giornata". Al ritorno a Zurigo, racconterà l'escursione in Descriptio Montis fracti sive Montis Pilati ut vulgo nominant, la prima monografia dedicata alla descrizione di un ambiente alpino, tanto precisa da essere in gran parte valida ancora oggi. In quel laboratorio all'aria aperta che è per lui la montagna, Gessener osserva le piante nel loro ambiente naturale e, secoli prima di Humboldt, è il primo naturalista a intuire l'influenza della temperatura e dell'altitudine sulla distribuzione della flora alpina. Per le sue precise notazioni sull'ecologia delle piante osservate, Descriptio Montis fracti è considerata la prima opera di geografia botanica. 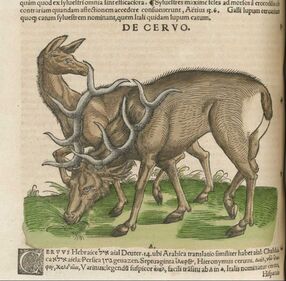 L'opera poliedrica di un genio universale Quando organizza la memorabile escursione, Gessner ha già dato alle stampe Bibliotheca universalis (1545-1549) ed è impegnato nella stesura e nella pubblicazione di Historia animalium (1551-1587). Sono le due grandi opere enciclopediche che hanno consegnato la sua fama ai posteri. Gessner era nato a Zurigo in una famiglia con troppi figli e troppi pochi soldi. Il padre, che secondo alcune fonti era un pellicciaio, era un seguace di Zwingli e morì insieme a lui nella battaglia di Kappel. Il quindicenne Conrad fu affidato a uno zio materno, un canonico che coltivava un piccolo giardino ed era esperto di erbe medicinali; fu lui, a quanto pare, a trasmettergli l'amore per la natura. Per il dotatissimo adolescente iniziava una vita errabonda: sempre a corto di soldi e dipendente dal sostegno finanziario di diversi mecenati, lo troviamo a studiare ebraico a Strasburgo, lingue classiche e medicina a Brouges, teologia e medicina a Parigi. Nel 1535 tornò in patria e a soli 19 anni si sposò con una ragazza povera quanto lui nonché malaticcia. Una scelta che egli stesso anni dopo giudicherà avventata e che lo privò momentaneamente dell'aiuto dei suoi protettori. Per vivere, fu costretto a insegnare per qualche tempo in una scuola elementare. Presto fu perdonato e poté riprendere gli studi di medicina a Basilea, quindi si spostò a Losanna, dove per tre anni (1537-1540) insegnò latino e greco all'Accademia cittadina, appena fondata; fu un periodo relativamente tranquillo, durante il quale godette di una certa tranquillità economica e iniziò a pubblicare i primi scritti di medicina, filologia e filosofia. Risalgono a questi anni anche le prime escursioni nel Giura, nel Vallese e sulle Alpi della Savoia e i primi testi di botanica, in cui l'interesse per le piante si coniuga con quelle per le lingue: Historia plantarum ordine alphabetico ex Dioscoride sumtis descriptionibus, et multis ex Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis (1541), una lista in ordine alfabetico dei nomi di piante che compaiono negli autori dell'età classica e del primo Medioevo; Catalogus Plantarum Latine, Graece, Germanice, et Gallice, un catalogo quadrilingue (1542) in ordine alfabetico dei nomi delle piante in latino, greco, tedesco e francese. Nel 1540, sollecitato dalla città di Zurigo che gli offrì una borsa di studio, Gessner riprese gli studi di medicina a Montpellier; un soggiorno breve, ma decisamente importante, che consolidò le sue conoscenze in botanica e anatomia e gli permise di stringere legami personali con altri studiosi, primo fra tutti Rondelet. L'anno successivo si laureò in medicina a Basilea e tornò a Zurigo; qui, a parte le consuete escursioni in montagna e qualche viaggio occasionale, sarebbe rimasto fino alla morte, mantenendosi con vari incarichi: lettore di Aristotele al Carolinum; medico capo della città dal 1554; docente di fisica, scienze naturali ed etica al Carolinum dal 1557 alla morte, avvenuta nel 1565 in seguita a un'epidemia di peste. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Negli anni zurighesi Gessner pubblicò numerose traduzioni e edizioni di testi classici, soprattutto di argomento medico, e scrisse copiosamente di teologia, medicina, linguistica, zoologia, botanica. Soffermiamoci solo sulle opere maggiori. Subito dopo il ritorno a Zurigo, egli fu impegnato nella stesura della monumentale Bibliotheca universalis: impressionato dalla distruzione della biblioteca di Buda, data alle fiamme dai Turchi, che aveva causato la perdita di numerosi inestimabili manoscritti, egli decise di pubblicare un catalogo completo di tutte le opere "esistenti o no, antiche o più recenti fino ai giorni nostri, dotte o no, pubblicate o conservate manoscritte nelle biblioteche". Dopo tre anni di ricerche, che egli stesso definì "un labirinto", il grandioso catalogo uscì infine a Zurigo nel 1545. E' la prima bibliografia dell'età moderna. Nel 1548, l'erudito svizzero la completò con le Pandectae, un indice tematico in cui i testi sono catalogati in 19 materie e 3000 voci; potremmo definirlo il primo motore di ricerca della storia. Subito dopo, egli iniziò a lavorare alla enciclopedia zoologica Historia animalium, una grandiosa opera in cinque volumi: il primo uscì nel 1551, l'ultimo nel 1587, ventidue anni dopo la morte dell'autore. L'intento di Gessner era presentare tutti gli animali conosciuti, nonché una bibliografia di tutte le opere di storia naturale a partire dall'antichità. In mancanza di un criterio di classificazione globale soddisfacente, gli animali, divisi in quadrupedi (I volume), ovipari (II volume), uccelli (III volume), pesci e animali acquatici (IV volume), serpenti e scorpioni (V volume), compaiono in ordine alfabetico; tuttavia alcune grandi categorie sono raggruppate insieme: ad esempio, tutti i bovini sono trattati sotto la voce Bos e tutte le scimmie sotto la voce Simia. Historia animalium è indubbiamente un'opera contraddittoria, con un piede nel passato e uno nel futuro. Da una parte è una compilazione erudita, in cui si riversa il patrimonio di conoscenze zoologiche ereditato dall'antichità o anche dal folklore, tanto che, accanto agli animali reali, non mancano quelli fantastici. Dall'altra parte, Gessner cerca di distinguere i fatti dai miti, e spesso si basa sull'osservazione diretta degli animali e delle loro abitudini; inoltre introduce informazioni sugli animali esotici recentemente conosciuti nelle Americhe o nelle Indie orientali. Di grande rilevanza è poi l'apparato iconografico, con oltre 1500 tavole spesso di grande precisione e realismo. Tra gli autori delle xilografie, va ricordato Albrecht Dürer. Nel 1555, Gessner pubblicò una terza opera notevole, Mithridates sive de differentiis linguarum, che possiamo considerare il testo fondante della linguistica comparata. Il breve opuscolo contiene un elenco in ordine alfabetico di 130 lingue e dialetti, corredato da osservazioni linguistiche, da informazioni sui popoli che li parlano, da esempi testuali e dal testo del Padre nostro in ventisei lingue.  Alla ricerca di una chiave per classificare le piante Nonostante questa mole di lavori in altri campi, il principale interesse di Gessner fin dagli anni di Losanna, quando si era innamorato delle piante alpine del Vallese, era la botanica. Negli anni in cui scriveva le grandi opere erudite, continuava a raccogliere e studiare le piante: nei suoi viaggi ne scoprì almeno 200 specie. Corrispondeva con molti colleghi, con cui scambiava esemplari e osservazioni e talvolta polemizzava, nonostante il carattere mite e conciliante (celebre è la controversia con Mattioli sull'identificazione dell'Aconitum primum di Dioscoride). Negli anni cinquanta, diede alle stampe una serie di brevi opere botaniche, talvolta in forma di lettera, tra cui De raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias ob causas, Lunariae nominantur (1556) in cui si occupa del fenomeno della luminescenza e espone le sue osservazioni sulle differenze tra alcune piante con nomi simili. All'inizio del decennio successivo risale De hortis Germaniae (1561), che contiene la descrizione di varie giardini botanici tedeschi, svizzeri, polacchi, francesi e italiani, incluso quello dello stesso Gessner a Zurigo, piccolo ma ricco di piante particolari; seguono indicazioni per la scelta e la coltivazione delle piante e una lista di piante coltivate in ordine alfabetico. E' interessante sottolineare che non si tratta solo di specie officinali o utilitarie, ma anche ornamentali. Terminata la stesura di Historia animalium (anche se la pubblicazione, come abbiamo già visto, si protrasse per decenni oltre la sua morte), Gessner decise che era venuto il tempo di dedicarsi interamente alle piante. Gli ultimi dieci anni della sua vita furono così consacrati alle ricerche e alla scrittura di un'altrettanto enciclopedica Historia plantarum. Fu un lavoro febbrile, una lotta contro il tempo: da sempre di salute cagionevole, miope e con la vista compromessa dallo studio e dall'uso delle lenti di ingrandimento, il grande naturalista temeva che la sua vita non sarebbe durata abbastanza per consentirgli di portare a termine l'impresa. E, come abbiamo visto, purtroppo non si sbagliava. Nella sua casa, che già da tempo era un piccolo museo naturalistico, incominciarono ad ammassarsi fogli di erbario inviati da amici (come Daléchamps e l'allievo Jean Bauhin, piuttosto nervoso quando il maestro li trattenne molto oltre le promesse), testi di altri botanici con le pagine fitte di annotazioni di mano di Gessner, e soprattutto disegni su disegni. Le oltre 1500 illustrazioni, in gran parte disegnate da lui stesso (era un disegnatore di grande talento) o affidate a collaboratori sotto la sua supervisione, erano diventate il suo principale strumento di lavoro, un modo per fissare sulla carta e rendere evidenti i particolari anatomici di ciascuna specie: ogni pianta era "fotografata" in tutti gli stadi di sviluppo, con tutti gli organi disegnati con la massima precisione e gli ingrandimenti di particolari significativi come i petali, gli organi riproduttivi, il sacco pollinico, i frutti e i semi. Attorno ai disegni, una ragnatela di annotazioni in una scrittura minutissima, con osservazioni sulla località di crescita, le forme di sviluppo, i particolari morfologici, le caratteristiche distintive. Attraverso queste osservazioni e questi disegni, Gessner stava cercando di scoprire una chiave di classificazione del vasto mondo vegetale, i cui confini non facevano che allargarsi con l'afflusso di sempre nuove specie da altri continenti. Una fatica di Sisifo e un fallimento annunciato. Anche se da nessuna parte Gessner ha esposto le sue conclusioni e in Historia plantarum le piante sono effettivamente raggruppate in modo incoerente ed empirico, dai particolari su cui insiste nei disegni e da alcune lettere possiamo ricavare chiaramente che aveva capito l'importanza dei fiori, dei frutti e dei semi per classificare le piante. Non a caso, la sua opera fu particolarmente apprezzata da Tournefort che possedeva una copia di De raris et admirandis herbis fittamente annotata. Inoltre fu tra i primi a distinguere con una certa chiarezza i concetti di genere e specie, scrivendo tra l'altro: "Non esiste quasi pianta che costituisca un genere che non possa essere diviso in due o tre specie. Gli antichi descrissero una specie di genziana. Io ne conosco dieci o più". Abbiamo già anticipato che Historia plantarum rimase incompleta ed inedita. Alla morte dell'autore i disegni furono acquistati da Camerario il Giovane che ne utilizzò una quarantina per il suo Hortus medicus (1588); il manoscritto passò per varie mani e fu parzialmente riscoperto da Trew, che lo pubblicò sotto il titolo Opera botanica tra il 1753 e il 1759, quando ormai era troppo datato per influire sugli sviluppi della scienza botanica. Circa 150 disegni furono scoperti nel 1927 nella Biblioteca di Erlangen; il terzo volume dell'opera, che si credeva perduto, è stato ritrovato solo nel 2013 nella biblioteca dell'Università di Tartu.  Gesneria, tropicali per intenditori L'ammirazione di Tournefort per Gessner era condivisa dal suo amico Plumier, che volle celebrare il botanico svizzero dedicandogli uno dei suoi nuovi generi americani. La dedica di Gesneria fu poi confermata da Linneo, che riteneva Gessner uno dei botanici più importanti delle generazioni precedenti e gli riconosceva il merito di essere stato il primo ad usare la struttura dei fiori come criterio di classificazione delle piante. Grazie a Plumier e Linneo, Gessner è diventato così il patrono non solo del genere Gesneria, ma delle Gesneriacae, una grande famiglia di più di 150 generi e 3500 specie, per lo più tropicali, caratterizzate da fiori vistosi e di grande bellezza. Molto meno nota delle cugine Achimenes, Gloxinia, Sinningia, Streptocarpus o Saintpaulia, anche Gesneria non manca di farsi notare per le fioriture smaglianti. Con circa cinquanta specie di piccoli arbusti, suffrutici ed erbacee perenni, è un genere quasi esclusivamente caraibico, ad eccezione di due o tre specie dell'America meridionale. Le Gesneriae sono vere tropicali, abitanti delle foreste d'altura, dove vivono sulle rocce e sulle pareti rocciose, godendo di ombra luminosa, suolo ricco e sciolto e umidità costante. Condizioni difficili da riprodurre in coltivazione, tanto più che basta che il terreno secchi troppo anche per un breve periodo per ucciderle; ecco perché sono piante da collezione, da coltivare in un terrario o in una serra protetta. Tra le poche specie relativamente diffuse, G. cuneifolia, nativa dei Caraibi orientali; è una erbacea in miniatura con foglie alternate lucide e fiori tubolari arancio vivo. Ne sono stati introdotti anche alcuni ibridi. G. ventricosa, nativa della Giamaica e delle piccole Antille, è invece un arbusto relativamente grande che vive in spazi semi-aperti sulla sommità delle colline nelle foreste pluviali di mezza montagna; ha corolle a imbuto rosso aranciato lievemente ricurve e rigonfie. Qualche approfondimento nella scheda. I maggiori risultati della spedizione "nuziale" in Brasile non furono raggiunti dagli scienziati austriaci (con l'eccezione del ribelle Natterer, che disobbedì agli ordini e rimase nel paese sudamericano quasi vent'anni), ma dai naturalisti bavaresi Spix e Martius. La loro fu una delle più fortunate e celebri spedizioni dell'epoca, seconda solo a quella di Bompland e Humboldt. Non solo i due amici ritornarono in patria con straordinarie collezioni, ma i loro studi successivi diedero un contributo eccezionale alla conoscenza della fauna e della flora del Sud America. Martius divenne uno dei botanici più importanti della sua generazione; la sua squisita Storia naturale delle palme è stata definita "la più superba trattazione delle palme che sia mai stata prodotta" e gli ha guadagnato il soprannome "padre delle palme". Quanto all'immensa Flora Brasiliensis, di cui fu il primo curatore e che coinvolse oltre sessanta botanici di diversi paesi, ancora oggi è il testo di riferimento per la flora brasiliana ed una delle opere più importanti della storia della botanica. I colleghi gli dedicarono molti generi, creando un nodo gordiano di sinonimi e omonimi che è stato risolto solo nel Novecento con la creazione del genere Martiodendron.  Un viaggio epico Verso la fine del 1816, il re di Baviera Massimiliano I Giuseppe fu invitato a un matrimonio: le nozze per procura dell'arciduchessa Maria Leopoldina d'Austria con l'erede al trono del Portogallo. A Vienna seppe che si stava preparando una grande spedizione scientifica che avrebbe accompagnato la principessa in Brasile. Il sovrano bavarese era di idee progressiste (era stato il principale alleato di Napoleone in Germania) ed era un grande ammiratore di Humboldt. Già da tempo pensava a una spedizione in Sud America che, partita da Buenos Aires, avrebbe dovuto dirigersi in Cile e in Perù, per poi rientrare in Europa imbarcandosi in Venezuela o in Messico. La situazione politica e difficoltà finanziarie lo avevano costretto a desistere. Ora si presentava l'occasione di riprendere quel progetto su nuove basi, aderendo all'iniziativa austriaca. Fu così che sull'Austria, salpata da Trieste il 10 aprile 1817, si imbarcarono anche due scienziati bavaresi, lo zoologo Johann Baptist Spix e il botanico Carl Friedrich Philipp Martius. Al momento della partenza, Spix aveva 35 anni ed era già uno studioso riconosciuto, allievo di Cuvier a Parigi e curatore delle collezioni zoologiche dell'Accademia delle scienze di Monaco di Baviera. Martius, che avrebbe compiuto 23 anni pochi giorni dopo la partenza da Trieste, era assistente all'orto botanico monacense. I due si erano conosciuti a Erlangen, la città natale di Martius, quando questi era uno studente diciottenne. Figlio del farmacista di corte, era stato introdotto alla botanica da un amico del padre, Johann von Schreber, uno degli ultimi allievi di Linneo. Dopo la morte di Schreber, la famiglia propose l'acquisto delle sue collezioni naturalistiche al re di Baviera; nel 1812, per condurre la trattativa venne inviata a Erlanger una commissione formata dal botanico ed entomologo Franz Paula von Schrank e da Spix. Entrambi furono colpiti dal giovane Martius, un brillante ragazzo prodigio, e ne raccomandarono l'ammissione come allievo all'Accademia delle Scienze di Monaco. Martius si trasferì nella capitale, dove nel 1814 si laureò in medicina e chirurgia e divenne assistente di Schrank all'orto botanico. Poco prima di partire per il Brasile pubblicò il suo primo lavoro scientifico, una monografia sulle crittogame dell'area di Erlangen. Il gruppo di Spix e Martius, insieme al professor Mikan, fu il primo a giungere in Brasile, nel luglio 1817. Nell'attesa dell'arrivo del resto della spedizione, i naturalisti incominciarono a prendere confidenza con la natura tropicale e incontrarono diversi membri della comunità tedesca di Rio, primo fra tutti il barone Langsdorff, la cui casa ai piedi delle colline alla periferia della città si trasformò nel loro quartier generale. Subito dopo aver assistito alle nozze di Leopoldina e don Pedro, Martius e Spix iniziarono le raccolte nelle immediate vicinanze della capitale, quindi trascorsero qualche giorno a Mandioca, la tenuta di Langsdorff a nord della baia di Guanabara; a novembre tornarono a Rio, dove appresero che il governo austriaco aveva deciso di dividere la spedizione in piccoli gruppi; da Monaco arrivò l'ordine di non protrarre il soggiorno in Brasile oltre due anni. L'otto dicembre, accompagnati dal pittore Thomas Ender, dal direttore delle miniere del Brasile Wilhelm von Eschwege e da un certo Dürming, console tedesco ad Anversa, i due bavaresi lasciarono Rio alla volta di Sao Paulo, dove arrivarono l'ultimo giorno dell'anno. Nel primi mesi del 1818 il gruppo esplorò il sud dello stato di Bahia, poi si spostò verso nordest per raggiungere la zona mineraria; a maggio, Ender, in seguito a una caduta da cavallo, si fratturò una gamba e fu costretto a rientrare a Rio in compagnia di Dürming. Il trio Martius, Spix e Eschwege continuò per Diamantina, Minas Novas e Montes Claros. Secondo gli accordi con gli austriaci, a questo punto avrebbero dovuto tornare a Rio, ma i due bavaresi decisero di continuare da soli. Salutato Eschwege, penetrarono nell'interno in direzione nord-nordovest fino a Carinhanha, punto di partenza per un ampio giro della Serra Geral, una delle catene costiere della Mata Atlantica; tornati a Carinhanha, raggiunsero la costa a el Salvador, dove si trovavano alla fine dell'anno. A febbraio 1819 ripartirono verso nord, percorrendo la parte settentrionale degli Stati di Bahia, Pernambuco e Piaui; l'attraversamento di questa zona estremamente arida fu uno dei momenti più duri dell'intero viaggio. All'inizio di maggio, a São Gonçalo do Amarante, nello stato di Cearà, Martius si ammalò gravemente. Una settimana dopo, Spix, che aveva contratto la bilharziosi, rischiò di morire. Appena si furono ripresi, si spostarono nel Maranhão e navigando lungo il Rio Itapicuru raggiunsero São Luis, la prima vera città che vedevano da mesi. Qui poterono spedire le collezioni a Rio, riscuotere le lettere di credito e mettere insieme i rifornimenti per la parte più eccitante dell'impresa: l'esplorazione del bacino del Rio delle Amazzoni. Il 20 luglio si imbarcarono per Belem. Dopo qualche giorno dedicato ad esplorare i dintorni della città e l'isola di Marajó, il 21 agosto erano pronti a ripartire. Viaggiando parte a dorso di mulo, parte in canoa, raggiunsero un ramo del Rio delle Amazzoni a Gurupà. Risalirono poi il fiume toccando Porto de Moz e Santarém e il 22 novembre erano a Manaus, alla confluenza con il Rio Negro. Navigarono poi lungo il Rio Solimões fino a Tefé, dove decisero di separarsi. Spix risalì il corso del Solimões fino a Tabatinga e rientrò a Manaus nel febbraio 1820, mentre Martius esplorava il Rio Japorà e a marzo si riuniva all'amico. Qualche giorno prima, la sua canoa si era rovesciata e aveva rischiato di morire annegato. Ad aprile i due ardimentosi naturalisti erano di nuovo a Belem e a giugno si imbarcarono per l'Europa con le casse delle raccolte e una coppia di ragazzi indios; il 23 agosto erano a Lisbona e prima di Natale a casa, a Monaco. Avevano percorso oltre 10.000 km, a piedi, a cavallo, a dorso di mulo, in canoa e raccolto oltre 3500 di esemplari di animali, da 25 a 30000 esemplari d'erbario ripartiti su oltre 7300 specie. La loro collezione mineralogica andò a costituire le basi della Mineralogische Staatssammlung di Monaco, così come le collezioni etnografiche quelle del Museum für Völkerkunde, oggi "Museo dei cinque continenti". 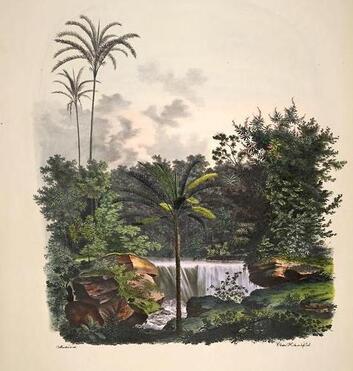 Due opere monumentali I due naturalisti furono ricevuti con grande onore dal re di Baviera. Entrambi furono nobilitati e ricevettero une pensione vitalizia. Nel 1826 Martius divenne professore di botanica all'Università di Monaco e dal 1832 direttore dell'Orto botanico. Intanto, i due amici lavoravano alacremente alla pubblicazione delle loro raccolte. A quattro mani scrissero il resoconto del loro viaggio, Reise in Brasilien, in tre volumi (1823, 1828, 1831). Spix morì mentre stavano preparando il secondo, ma Martius poté completare l'opera utilizzando le note proprie e del compagno. Morto a soli 45 anni nel 1826, Spix aveva fatto in tempo a scrivere quattro monografie, dedicate rispettivamente alle scimmie e ai pipistrelli, alle testuggini e agli anfibi, agli uccelli e ai serpenti raccolti durante la spedizione. Complessivamente descrisse da 500 a 600 specie, dando il nome a numerose specie nuove; alcune portano il suo nome, come la rarissima ara di Spix Cyanopsitta spixii che gli fu dedicata dallo zoologo Wagler. Gli furono dedicati anche due generi botanici Spixia (da Leandro e da Schrank) ma nessuno dei due è oggi valido. Diversamente dal compagno di viaggio, Martius ebbe lunga vita e poté diventare uno dei più eminenti botanici della sua generazione, autore di opere che superano in importanza persino la sua prodigiosa attività di raccoglitore. Oltre al resoconto del viaggio, pubblicò saggi sull'economia, la medicina, la cultura degli indigeni del Brasile, scrisse un romanzo rimasto inedito e, ovviamente, una lunga serie di articoli e monografie sulle piante raccolte durante la spedizione. Esordì nel 1823 con Genera et species palmarum quas in itinere per Brasiliam [...] collegit [...] C.F.P. Martius: le palme, esplorando il bacino del Rio dell'Amazzoni, la regione del globo più ricca di Arecaceae, erano diventate le sue piante preferite; seguì Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam [...] collegit C.F.P. Martius, in tre volumi (1824–1832); nel 1827 uscì un'opera dedicata al primo amore di Martius, le crittogame, Icones selectae plantarum cryptogamicarum. Ma intanto l'attivissimo botanico stava lavorando al suo capolavoro, Historia naturalis palmarum, in tre spettacolari volumi in folio pubblicati a Lipsia tra il 1823 e il 1850. E' un'opera monumentale con più di 550 pagine di testo e 240 cromolitografie, una tecnica all'epoca appena agli esordi; molti dei disegni del secondo volume si devono allo stesso Martius. Nel primo volume il botanico getta le basi della prima classificazione sistematica delle palme e fornisce una mappa della distribuzione geografica della famiglia; nel secondo descrive le palme del Brasile; nel terzo, intitolato Expositio Systematica, descrive tutte le specie allora note, basandosi sia sulle proprie raccolte sia su tutto ciò che era stato scritto da altri botanici. Questa pietra miliare dello studio delle palme ha guadagnato a Martius il soprannome di "padre delle palme" e ha fatto dire a Humboldt: "Finché le palme saranno apprezzate e conosciute, il nome di Martius sarà famoso". L'opera suscitò anche l'ammirazione di Goethe, che probabilmente ne fu influenzato nelle sue ricerche sulle metamorfosi delle piante; del resto, l'ammirazione era reciproca: lo stesso Martius durante il viaggio in Brasile scriveva poesie, inviò diversi esemplari brasiliani al poeta e si recò a fargli visita a Weimar. Ancora più grandiosa l'impresa cui Martius si accinse a partire dal 1839: la pubblicazione di una flora complessiva del Brasile. Per realizzarla, chiamò a raccolta i più importanti botanici europei. Si tratta infatti di un'opera collettiva, che andò molto oltre la vita del suo promotore, impegnando tre generazioni di studiosi e 65 collaboratori. E' considerata una delle opere botaniche più importanti di tutti i tempi ed è ancora oggi il testo di riferimento per la flora del Brasile; fino al 2004, quando uscì Flora Rupublicae popularis Sinicae, rimase la più ampia flora mai pubblicata. La gigantesca opera fu finanziata dall'imperatore d'Austria Ferdinando I, dal re di Baviera Ludovico I e dall'imperatore del Brasile Pietro II; inizialmente fu diretta da Martius e Endlicher, che però morì già nel 1849. Martius ne rimase il solo curatore fino alla morte (1868) e curò la pubblicazione di 46 fascicoli su 130; alla sua morte gli succedettero prima August Wilhelm Eichler quindi Ignatz Urban. Completata nel 1906, Flora Brasiliensis comprende più di 20.000 pagine con la trattazione di 22.767 specie, per lo più angiosperme, non solo brasiliane, ma anche dei paesi limitrofi (Venezuela, Ecuador e Perù). Quasi 6000 all'epoca erano nuove per la scienza. Il testo è arricchito da disegni, incisioni e acquarelli di artisti come Thomas Ender, Benjamin Mary e Johan Jacob Steinmann e dalle fotografie di George Leuzinger, che ne fanno una vera opera d'arte. Membro di innumerevoli società scientifiche, Martius divenne anche una figura piuttosto nota dell'ambiente culturale monacense. Era in contatto con scienziati di tutto il mondo, che ospitava volentieri a casa sua. Ogni anno, in occasione del compleanno di Linneo (il 23 maggio) vi organizzava un festival in onore del principe dei botanici, con discorsi, poesie e canzoni. Tra i suoi lasciti, non possiamo dimenticare l'erbario. Già prima che partisse per il Brasile era ragguardevole; l'avventura brasiliana gli fruttò circa 12.000 esemplari. Anche se dopo il ritorno a Monaco non viaggiò più, continuò ad arricchire l'erbario grazie ad acquisti, invii di altri botanici e scambi. Alla sua morte, con circa 300.000 esemplari e 65.000 specie, era uno degli erbari privati più importanti del mondo. Acquistato dal Belgio, è oggi custodito nell'Orto botanico di Bruxelles ed è oggetto di un importante progetto di digitalizzazione, The Martius Project. Martius riposa nel cimitero di Monaco di Baviera. Sulla sua tomba una lastra con due palme e l'epigrafe latina In palmis semper virens resurgo, "Tra le palme risorgo sempreverde". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Martiodendron, un'esplosione di fiori d'oro Molti colleghi dedicarono a Martius un genere botanico; si contano non meno di sei Martia, due Martiusia, cui vanno aggiunti Martiusella e Suitramia (dallo pseudonimo Suitram che Martius usava con gli amici e in alcuni documenti). Si venne così a creare un intrico di omonimi e sinonimi e si generò una confusione che rischiava di privare il grande botanico del giusto riconoscimento; per rimediare a tanta ingiustizia nel 1935 lo statunitense H.A. Gleason rinominò Maritiodendron un genere di Fabaceae sudamericane che nel 1818 Bentham aveva battezzato Martia e nel 1840 aveva rinominato Martiusia. Martiodendron riunisce cinque specie di alberi presenti in vari habitat del Sud America atlantico : dalla foresta pluviale alle foreste stagionalmente inondate alla savana; molto opportunamente, tra le zone di diffusione (Guyane, Venezuela meridionale, Brasile amazzonico, nord-est brasiliano) ci sono anche le due principali aree visitate da Martius, il bacino del Rio delle Amazzoni e gli Stati brasiliani di Bahia, Piauí, Maranhão. Sono alberi da medi a grandi la cui chioma svetta nello strato superiore della foresta, con robusti tronchi che in alcune specie si allargano in contrafforti; hanno foglie imparipennate con foglioline da ovate a ellittiche, da coriacee a membranacee. A farsi notare sono soprattutto le infiorescenze panicolate, fitte di fiori giallo oro con cinque petali imbricati alla base, corolla lievemente zigomorfa e lunghi stami. Le due specie più diffuse sono le amazzoniche M. parvifolium e M. elatum; si dice che la fioritura di quest'ultimo lungo le rive del fiume Tapajós, nello stato di Pará, all'inizio della stagione delle piogge, offra uno spettacolo senza uguali. Se Martius lo vide in tanta gloria, sicuramente sarà contento di questa complicata, ma più che meritata dedica. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed