|
A Bex i Thomas non erano i soli a raccogliere piante e a commercializzare campioni d'erbario e semi di piante alpine. A far loro concorrenza, negli ultimissimi anni del Settecento e nei primi due decenni dell'Ottocento, c'era il farmacista di origini tedesche Johann Christoph Schleicher, che fu il primo ad avere l'idea di pubblicizzare il suo commercio prima con annunci in riviste scientifiche, poi con un catalogo che comprendeva circa 2000 piante e giunse a quattro edizioni. Pubblicò anche a più riprese cataloghi specifici per le crittogame. Per qualche anno ottenne un notevole successo, come testimonia la presenza dei suoi campioni negli erbari di moltissime istituzioni e di qualche pianta nata dai suoi semi nei cataloghi dei vivai inglesi. Poi si fecero sentire l'età e la concorrenza del molto più giovane e aguerrito Emmanuel Thomas, tanto che fu costretto a vendere il suo erbario e terminò i suoi giorni in miseria. Oltre all'eponimo di diverse specie, lo ricorda il genere asiatico Schleichera (Sapindaceae). 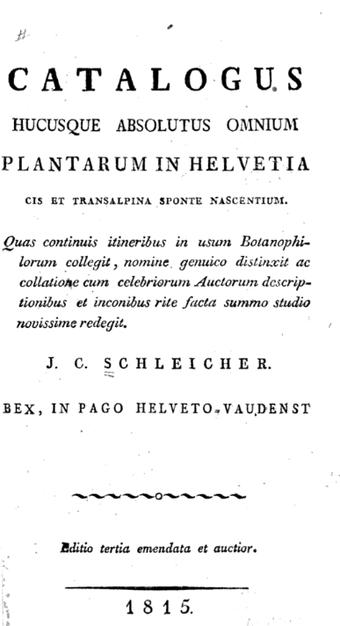 Campioni d'erbario e semi a modico prezzo Intorno al 1790, si stabilì a Bex nel Vaud un giovane di origine tedesca, Johann Christoph Schleicher (1768/70-1834), che nella nuova patria si sarebbe fatto chiamare anche Jean Charles. Talvolta viene definito dottore, ma era piuttosto farmacista, e difficilmente, per la giovane età, avrà avuto una formazione completa. Dei suoi primi anni sappiamo pochissimo. Incerta è la stessa data di nascita, 1768 secondo alcune fonti, 1770 secondo altre. Nato a Hofgeismar nell'Assia da Anna Marie Sawitzky, ebbe inizialmente il cognome materno per poi assumere quello con cui è noto quando fu adottato da un certo Carl Schleicher. Nulla sappiamo della sua formazione; secondo varie fonti, incluso il data base biografico dell'Università di Gottinga, il botanico Heinrich Schräder sarebbe stato il suo padrino; la notizia è certamente priva di fondamento per banali ragioni anagrafiche: i due erano praticamente coetanei, essendo nato Schräder nel 1767. Al momento dell'arrivo di Schleicher, a Bex il ricordo (e il magistero) di Albrecht von Haller era tenuto vivo, oltre che dall'attività commerciale della famiglia Thomas, dai medici Bernard Jean François e Jean David Ricou. Bernard Jean François Ricou (1730-1798), medico cittadino, farmacista e capo chirurgo dell'ospedale, negli anni '50 era stato uno dei raccoglitori di von Haller, per il quale aveva erborizzato nelle valli di Saint-Nicolas e di Bagnes e nelle regioni del Sempione, del Gran San Bernardo, di Alesse e di Fully. Nel 1764, insieme al pastore Abram-Louis Decoppet, pubblicò nelle "Memorie della società economica" di Berna una lista di 128 piante della flora elvetica con i nomi in dialetto, francese e latino (Essai d'une collection de noms vulgaires ou patois des principales plantes de Suisse). Certamente si deve a lui la creazione del "bell'erbario" segnalato nel 1804 nella guida della Svizzera di Johann Gottfried Ebel, all'epoca di proprietà del figlio Jean David, anch'egli medico. Schleicher dovette legarsi strettamente alla famiglia Ricou (probabilmente lavorò per loro come aiuto farmacista e nel 1797 sposò Julie, figlia di Jean David) e fu probabilmente l'esempio delle raccolte di Bernard Jean François a spingerlo a sua volta a percorrere le montagne alla ricerca di piante rare. Il suo scopo era chiaramente commerciale: l'opera di von Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici e degli amatori sulla flora elvetica e il mercato di campioni d'erbario era fiorente. Dotato di notevole spirito imprenditoriale, ispirato dall'esempio di raccoglitori di piante tedeschi, già nel 1794, nel numero 41 della rivista di Lipsia "Annalen der Botanik" Schleicher, sotto forma di lettera ai signori Le Royer e Tingry, proprietari di un'importante farmacia di Ginevra, offrì in vendita, al prezzo di 2 talleri francesi, una centuria di piante svizzere, assicurando la consegna in 4-6 settimane. Altre due centurie avrebbero fatto seguito nel numero successivo, pubblicato lo stesso anno. Nel 1796, ancora su "Annalen der Botanik" la snelle centurie si trasformarono in una più ambiziosa lista di quasi 700 "piante raccolte nel Vallese e nelle Alpi vicine nel 1795 da Schleicher", indicate con un nome binomiale, preceduto però (tranne un'appendice di una quarantina di specie scoperte successivamente alla pubblicazione di quest'opera) dal numero con cui compaiono in Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata di von Haller; non compaiono più né prezzi né indicazioni esplicite del fine commerciale, non perché Schleicher avesse cambiato intenzioni, ma probabilmente perché aveva ormai una clientela consolidata. Due anni dopo, sempre sulla stessa rivista, comparve una seconda lista sotto il titolo "Indice delle piante raccolte nel Vallese e nella Svizzera transalpina nel 1796 da C. Schleicher"; le modalità erano le stesse, ma la lista si era allungata, passando da 9 a 12 pagine, e, soprattutto, ora compariva a parte un elenco di 84 Musci & Algae (in realtà ci sono anche felci e numerosi licheni). Si trattava di un nuovo segmento di mercato che, come vedremo, sarebbe diventato una specialità del raccoglitore tedesco. Poi, nel 1800, il salto di qualità. Con quello che dovette essere un notevole impegno anche finanziario, Schleicher pubblicò a Bex quello che è considerato il primo catalogo commerciale di piante svizzero, Catalogus plantarum in Helvetia cis- et transalpina sponte nascentium; il sottotitolo precisa: "raccolte dall'autore con continui viaggi ad uso dei botanofili e verificate con sommo studio sulle descrizioni e le immagini degli autori più celebri". Nel volumetto di una settantina di pagine sono elencate circa 2000 piante, con il nome binomiale seguito dal nome d'autore e preceduto, nella maggior parte dei casi, dal rinvio numerico all'opera di Haller. Mentre le felci sono elencate nel catalogo generale, sono presentate nuovamente a parte alcune centinaia di Musci, Algae et Fungi. A chiudere il catalogo, una selezione di semi "raccolti e offerti da Schleicher"; come facevano anche i Thomas, anche i semi, come i campioni d'erbario, erano per lo più raccolti in natura. Anzi, da questo punto di vista sembra che Schleicher non andasse tanto per il sottile; secondo una nota pubblicata nel "Bulletin de l’Association pour la protection des plantes" del 1884, "distrusse [appositamente] diverse specie al solo scopo di aumentare il valore dei campioni che vendeva agli erbari, rendendole rare". Almeno alcune piante tuttavia dovevano essere coltivate nell'orto botanico che Schleicher aveva creato a Bévieux, non lontano dalla salina. Sempre secondo la guida di Ebel, meritava una visita; dopo aver parlato dell'erbario di Ricou, egli ci informa inoltre che "Suo genero M. Schleicher, abile erborizzatore che ha percorso gran parte delle montagne della Svizzera occidentale e meridionale, ha un consideravole magazzino di piante essiccate che vende per un luigi il centinaio. Ha scoperto una quantità di specie prima sconosciute in Svizzera". Per qualche anno il commercio di piante di Schleicher dovette andare a gonfie vele; numerosi suoi campioni sono presenti nei principali erbari europei; era in corrispondenza con molti importanti botanici (vendette molti esemplari a Balbis e ci è rimasta una lettera a Persoon); forniva semi al celebre vivaio londinese Loddiges che lo cita come fornitore di varie piante alpine offerte per la prima volta sul mercato britannico. L'ampliamento dell'offerta è testimaniato dalle successive edizioni del catalogo (1807, 1815, 1821, le ultime due con il titolo Catalogus hucusque absolutus omnium plantarum in Helvetia cis et transalpina sponte nascentium), e da una serie di cataloghi specifici, uno riservato ai salici (1807) e diversi alle crittogame (Plantae Cryptogamicae Helvetiae 1803-1807), parzialmente riprodotti nella rivista diretta da Schräder "Neues Journal für die Botanik", nella quale nel 1805 Schleicher pubblicò anche il resoconto di un viaggio nella Svizzera italiana. Nelle liste delle crittogame si precisa che esse erano state reccolte e essicate da Schleicher; la precisazione è significativa se considerimo che al raccoglitore tedesco si deve l'introduzione del sublimato corrosivo (cloruro di mercurio) per la trattazione dei campioni d'erbario. Tra riedizioni, supplementi e cataloghi specifici, le pubblicazioni si intensificarono tra il 1803 e il 1808, poi intorno al 1815 il successo dovette cominciare a declinare. Ne è spia la curiosa iniziativa che Schleicher prese nel 1816: una lotteria il cui premio era costituito da exsiccata. Probabilmente, incominciava a farsi sentire la concorrenza dei fratelli Thomas, che avevano pubblicato il loro primo catalogo intorno al 1806. Seguendo il loro esempio, nel catalogo del 1815, Schleicher aggiunse all'offerta minerali e plantule di conifere; c'erano anche campioni di erbario di piante esotiche, provenienti da Francia meridionale, Italia e Ungheria, e prezzi differenziati: cento esemplari costavano 36 lire francesi per acquisti di meno di 200 campioni, 30 lire da 200 a meno di 400, solo 24 lire da 400 in su. Offriva inoltre erbari completi della flora Svizzera, collezioni di piante medicinali, i semi di "tutte le piante che si coltivano o si possono coltivare in giardino" al costo di 24 lire il centinaio, piante a radice nuda pronte da piantare a 6 soldi l'una quelle erbacee, 9 soldi quelle arbustive e arboree. L'offerta non finiva qui. Leggiamo infatti: "Quest'anno e i seguenti, se Dio vorrà, a casa mia nel villaggio subalpino di Bex, darò lezioni di botanica - un corso completo di questa scienza - ai giovani botanici che me ne faranno richiesta. Quando il tempo lo permetterà, accompagnerò gli allievi in escursioni botaniche, non solo perché vedano e raccolgano le piante nel loro luogo natale, ma anche perché osservino con me le caratteristiche della flora d'altitudine. Mostrerò loro il metodo per essiccare le piante durante il viaggio stesso, in modo che conservate nel modo più perfetto possano ornare l'erbario". Lezioni in lingua francese e prezzi da concordare. Sei anni dopo, nella quarta e ultima edizione, escursioni botaniche e lezioni private non ci sono più (ora Schleicher era sulla cinquantina, e probabilmente non se la sentiva più). Scompaiono anche i minerali, mentre rimangono inalterati prezzi e offerta di exisiccata, erbari completi, semi e piante vive. Compare invece una nuova postilla che ci informa su cosa coltivasse Schleicher nel suo giardino botanico: "Oltre alle piante svizzere, coltivo un grande numero di sassifraghe esotiche, indicate in una speciale appendice in calce al catalogo. In questo giardino spuntano già diverse specie dei generi Aconithum, Delphinium, Narcissus e Allium di cui gli amanti di questi generi possono trovare presso di me un catalogo annuale, sia delle specie che possiedo sia di una moltitudine di piante esotiche che giungono per scambi con gli amici". Non abbiamo traccia di questi cataloghi annuali (erano forse manoscritti? o non furono mai realizzati?). In ogni caso, gli anni felici erano orami alle spalle. Vecchio e malato, Schleicher non poteva più salire in montagna e per sopravvivere dovette smantellare il suo prezioso erbario personale. Contrasse molti debiti; tra i suoi creditori c'era anche Emmanuel Thomas, al quale fu costretto a cedere, come pagamento, tutte le crittogame dell'erbario e diversi generi di fanerogame. Nel 1832 si rivolse al Consiglio di Stato per mettere in vendita quanto rimaneva: "Dal momento che la mia età e la mia salute non mi consentono più di salire in montagna e di continuare il mio commercio di piante, mi vedo costretto a vendere la mia biblioteca e il mio erbario per vivere". Le autorità incaricarono della perizia il direttore delle saline Jean de Charpentier, che provvide con l'assistenza dell'amico Emmanuel Thomas; nella sua relazione, emerge che l'erbario delle piante straniere (circa 10.000) "un tempo veramente magnifico, ha considerevolmente perso valore perché ne sono state tolte le specie più rare e interi generi"; per contro, il lotto di 4073 specie e varietà della flora svizzera "era ed è ancora unico nel suo genre, perché è senza discussione la collezioni più completa e curata della Svizzera. Vi si trovano non solo le piante selvatiche, ma anche le variazioni che subiscono in coltivazione". La vendita andò in porto e l'erbario delle fanerogame fu acquistato dal Museo di scienze naturali di Losanna. Schleicher investì una parte del ricavato per riscattare gli esemplari che aveva dovuto cedere a Emmanuel Thomas. Morì due anni dopo, nel 1834; nel 1837 gli eredi vendettero allo stesso museo l'erbario delle crittogame. La parte più preziosa di questa collezione è costituita dai licheni; nella proposta d'acquista dei conservatori del museo leggiamo: "Questa collezione, composta da più di 1060 campioni, la maggior parte su pietra o legno, è preziosa da ogni punto di vista [...]. Ha grande valore agli occhi dei botanici perché i campioni sono stati determinati con cura e perché è il frutto del lavoro di molti anni ed ha potuto essere formata solo a prezzo di pene, cure e spese".  Dalla Svizzera all'Asia sud-orientale Il significativo ruolo per la conoscenza della flora elvetica di questo farmacista divenuto cacciatore e commerciante di piante alpine è testimoniato dalla sua notevole presenza nella nomenclatura botanica. In primo luogo, anche se i suoi cataloghi sono meri elenchi, grazie al riferimento numerico alla flora di Haller (che, lo ricordo, usava nomi polinomiali, quindi non validi) ha introdotto alcuni nomi validi, come Hieracium canescens e Cnicus nudiflorus. Più numerose le denominazioni risalenti a lui ma introdotte attraverso altri autori che lo conobbero, erborizzarono con lui o furono sui clienti, come Campanula excisa introdotto da Murith, Phyteuma umile, Pedicularis ascendens e Festuca valesiaca introdotti da Gaudin, Lotus alpinus introdotto da Ramond. Una ventina di taxa portano in suo onore gli epiteti schleicheri e schleicherianus; si tratta di specie delle Alpi elvetiche per lo più presenti nei suoi cataloghi o nel suo erbario, ma in qualche caso anche da lui introdotte nei giardini britannici attraverso i vivai che acquistavano i suoi semi. Quattro sono tuttora validi: Alpagrostis schleicheri, Erigeron schleicheri, Fumaria schleicheri, Rubus schleicheri. Nel 1806 Willdenow, direttore di uno degli orti botanici cui forniva campioni e sementi, quello di Berlino, gli dedicò il genere Schleichera, purtroppo senza esplicitare la motivazione; si limitò infatti a scrivere "Ho nominato questo genere in memoria del celebre Schleicher, svizzero". Con questo genere monotipico della famiglia Sapindaceae ci allontaniamo dalle Alpi svizzere per spostarci sulle pendici dell'Himalaya, sull'altopiano del Deccan e nelle foreste del sudest asiatico. Il suo unico rappresentante S. oleosa è infatti un albero tropicale presente soprattutto nelle aree aride e aperte del subcontinente indiano, di Ceylon, della Thailandia e dell'Indonesia. L'epiteto è dovuto all'alto contenuto di olio dei suoi semi; quest'ultimo, noto come olio di kusum, dal nome più comune della pianta in India, viene utilizzato per la cura dei capelli, ma anche come combustibile, in cucina e come unguento medicinale.
0 Comments
Non è raro che un genere celebrativo onori allo stesso tempo due persone: un padre e un figlio, come Tradescantia per i due John Tradescant, due fratelli come Bauhinia per Jean e Gaspard Bauhin, magari due ricercatori che hanno collaborato, come Whitesloanea per gli specialisti di Cactaceae A. C. White e B. L. Sloane. Tuttavia è certo eccezionale il caso del genere Thomasia che celebra ben cinque persone, ovvero tre generazioni della stessa famiglia, quella dei raccoglitori e commercianti di piante svizzeri Thomas. A inaugurare la serie è a metà Settecento Pierre, guida e raccoglitore di Albrecht von Haller; quindi suo figlio Abraham, che ne prosegue l'attività e collabora con molti botanici affascinati dalle piante alpine; infine i suoi tre figli Philippe, esploratore della flora sardo-corsa, Louis, grande raccoglitore della flora calabra e collaboratore di Tenore, e Emmanuel, che trasformò la raccolta di piante e semi in un'impresa commerciale di successo. Tutti insieme scrissero una pagina importante della scoperta delle piante svizzere (ma anche italiane). I fondatori: Pierre e Abraham Nel 1754 il grande scienziato Albrecht von Haller venne nominato sovrintendente delle saline del distretto di Aigle nel Vaud, di proprietà del cantone di Berna. Egli prese molto sul serio l'incarico, benché gli garantisse entrate più che modeste: gli permetteva infatti di ritrovare l'amato paesaggio delle Alpi, alle quali in gioventù aveva dedicato un celebre poema, e di riprendere le ricerche sulla flora svizzera, in vista della seconda edizione ampliata della sua Enumeratio metodica stirpium Helvetiae indigenarum (la prima edizione era uscita nel 1742). Dal 1758 al 1764 visse nel castello di Roche, come un po' pomposamente veniva chiamata la dimora del sovrintendente, vi traferì la sua immensa biblioteca, il suo studio e il suo laboratorio; finché l'età e la salute glielo permisero, percorreva regolarmente le foreste e le montagne del distretto, sia per assolvere le sue funzioni sia per raccogliere piante e studiarle dal vivo. A fargli da guida erano le guardie forestali dipendenti dalle saline, alle quali demandò la raccolta di piante, quando per lui si fece difficile salire in montagna, o, come si espresse poeticamente, "alzarsi come un uccello sulle altezze". Insegnò loro a raccogliere e seccare correttamente gli esemplari, a distinguere le piante rare, a osservare e annotare i luoghi di raccolta, le condizioni di crescita, gli habitat. Nella prefazione a Historia Stirpium Indigenarum Helvetiae Inchoata, Haller ricordò con gratitudine i nomi di alcuni di loro; tra tutti spiccano quelli di Pierre Thomas (1708-1781) e di suo figlio Abraham (1740-1824). Pierre era un montanaro di Frenières; abitava con la moglie Madeleine in uno chalet della frazione di Les Plans, situata a circa 1000 metri in una valle circondata da imponenti monti calcarei; dai documenti risulta che fu assunto ufficialmente come guardia forestale delle saline nel 1761, ma il suo incontro con Haller risale a diversi anni prima. Anche se la sua istruzione era quella modesta dell'abitante di un piccolo villaggio di montagna, era dotato di intelligenza naturale, di una grande capacità di osservazione ed era un camminatore instancabile; a cementare l'insolita amicizia tra questo montanaro taciturno e il patrizio bernese Haller, il comune amore per la montagna e le sue piante. Pierre dapprima lo accompagnò alla scoperta delle montagne che circondano Les Plains, poi percorse per lui alla ricerca di piante il Vallese, i Grigioni e si spinse fino alle Alpi italiane. Ecco l'itinerario di uno di questi viaggi: nel 1763, partito da Bex, Pierre attraverso il passo di Cheville che collega il Vaud con il Vallese raggiunse Zermatt, quindi passò in Valtournenche, rientrando attraverso il colle del Gran San Bernardo. Gli era compagno il figlio Abraham, che partecipava alle raccolte paterne fin da bambino; era così abile e sveglio che appena diciottenne fu inviato da Haller ad esplorare da solo l'area del Furka. L'opera di Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici sulla flora delle montagne svizzere e il ritorno dello studioso a Berna (il suo incarico terminò nel 1764) non mise fine alle attività botaniche di Pierre ed Abraham, che anzi si traformarono in un piccolo commercio. I Thomas accompagnavano i visitatori come guide in spedizioni botaniche, raccoglievano e preparavano esemplari per i collezionisti; si deve probabilmente a Abraham la creazione di un piccolo orto botanico dove seminava piante alpine destinate soprattutto alla produzione di sementi e piante vendute a radice nuda. Nel 1775, per essere più vicini ai potenziali clienti, i Thomas trasferirono la loro abitazione a Fenalet, a metà strada tra i Plans e Bex. Pierre incominciava a sentire il peso dell'età; nel 1764 chiese alla direzione delle saline di essere affiancato come guardia forestale dal figlio, che nel 1779 gli subentrò. Due anni dopo Pierre moriva all'età di 73 anni. Grazie alle testimonianze dei diversi visitatori che nell'ultimo quarto del secolo frequentarono la casa di Fenalet, trasformata in un vero e proprio cenacolo di botanica da Abraham, conosciamo il figlio molto meglio del padre. Il giardiniere e botanico Thomas Blaikie (il creatore del parco di Bagatelle) che fu più volte ospite dei Thomas nel 1775, ha scritto di lui: "superava suo padre in intelligenza. Era dotato di un'agilità, di un vigore e di una memoria stupefacenti, accompagnati da un vero genio per l'osservazione". Un altro habitué, il poeta tedesco Matthison, afferma: "quest'uomo conosce a memoria e in modo esatto la flora alpina [...]. Mostrategli una qualsiasi montagna del Vallese o del distretto di Aigle: vi indicherà in modo infallibile le piante di ogni zona, il mese di fioritura, se all'ombra o al sole, nelle paludi o vicino a una sorgente, nel bosco o tra le rocce". Furono molti i visitatori che approfittarono della sua sapienza (e della sua agilità: sempre secondo Matthison, già vecchio nelle arrampicate ancora sfidava camosci e stambecchi)le della generosa ospitalità di sua moglie Marie-Susanne-Catherine Echenard - una grande appassionata di mitologia, sempre con un libro in mano mentre si occupava della cucina e delle faccende di casa: il botanico ginevrino Jacques Roux, il naturalista di Nechâtel Louis Perrot, il pastore e botanico Gaudin, autore di Flora helvetica, l'allievo di questi Jacques Étienne Gay, il canonico Laurent-Joseph Murith, autore del primo libro dedicato alla flora del Vallese, Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais, che molto deve all'assistenza di Abraham Thomas e di suo figlio Louis, costante compagno di viaggio del canonico. Murith collezionava anche minerali, conchiglie e fossili, che probabilmente su suo suggerimento andarono ad aggiungersi agli oggetti naturali raccolti e forniti dai Thomas. In quarant'anni di attività, Abraham fece progredire la conoscenza delle piante alpine, percorrendo e ripercorrendo le valli di Saas, Saint-Nicolas, Bagnes, Anniviers, Hérens e Binn, le pendici del Gran San Bernardo, del Cervino, del Monte Moro e i passi del Sempione, del Gries, del Furka, del Grimsel, della Gemmi, e molti altri. Stimato dai concittadini, nel 1781 fu nominato "giustiziere e consigliere di Bex per la competenza di Fenalet". Intorno al 1802, la famiglia si spostò ai Dévens, dove Abraham fece costruire per la comodità dei suoi ospiti la "casa rossa", attorno alla quale trasferì il suo orto botanico alpino. Una sola cosa mancava a quest'uomo ammirevole: il senso degli affari. Era troppo generoso con i suoi clienti, che considerava più che tali amici ed ospiti, per arricchirsi con il commercio di exsiccata, sementi, minerali, conchiglie, e di un "tè svizzero" la cui formula gli era stata insegnata da von Haller in persona. Mme la justicière trattava fin troppo generosamente i visitatori che, tra una scalata e l'altra, erano ospiti dello chalet di Fenalet e il marito non di rado inseriva una pianta rara, a titolo gratuito, nel plico di un invio. Intanto la famiglia cresceva: la coppia Thomas ebbe sette figli, due femmine e cinque maschi, ma solo tre raggiunsero l'età adulta: in ordine di età, Philippe, Louis e Emmanuel. .  I figli: Philippe, Louis e Emmanuel Come il nonno e il padre, i tre ragazzi Thomas avevano la botanica nel DNA. Fin da piccoli furono abituati a percorrere le montagne e ad imparare a distinguere le piante direttamente dal libro della natura, ma contrariamente a loro poterono anche viaggiare e godere di un'educazione formale. Quello che conosciamo meno è il maggiore dei tre sopravvissuti, Philippe (Pierre-Philippe-Louis, 1782-1831), al quale finora non è stato dedicato alcun studio approfondito, nonostante la sua importanza tra i primi esploratori della flora corso-sarda. Sappiamo che studiò medicina e che, oltre che in Svizzera e sulle Alpi, fece raccolte nei Pirenei. Nel 1814 fu la guida di William Jackson Hooker in un ampio viaggio in Svizzera. In una lettera di diversi anni dopo a Henry Fox Talbot, Hooker lo ricorda così: "Il Thomas che mi accompagnò in larghissima parte della Svizzera era Philippe; lo considero un compagno eccellente e onorevole, profondo conoscitore della botanica dell'intero paese [...]. Thomas intendeva visitare alcune isole del Mediterraneo". Qualche anno dopo avrebbe realizzato il suo sogno trasferendosi come medico a Cagliari, dove giunse tra il 1823 e il 1825. Presto entrò in contatto con Moris, di cui divenne uno dei più assidui collaboratori; in Flora sardoa, è citato quasi cento volte per esemplari raccolti sia in Sardegna, sia (sono i più numerosi) in Corsica. Doveva spedire regolarmente le sue raccolte al fratello Emmanuel che vendette piante sarde a musei, orti botanici e collezionisti. Ne troviamo un elenco nei due cataloghi (Catalogue des plantes de Sardaigne, qui se vendent chez Emmanuel Thomas, à Bex), pubblicati da Emmanuel rispettivamente nel 1837 e nel 1841. All'epoca però Philippe era già morto; morì infatti a Cagliari nel 1831. Un ruolo ancora più importante di quello di Philippe per la flora sardo-corsa ebbe Louis (Charles-François-Louis-Alexandre, 1784-1823) per la flora del regno di Napoli. Anch'egli naturalmente ricevette l'addestramento paterno en plein air e fu frequente compagno di escursioni del canonico Murith, che fu dunque il suo secondo maestro. Aveva ereditato dal nonno e dal padre l'occhio clinico e ancora ragazzo scoprì nuove specie. Ma fece anche buoni studi: studiò latino e scienze naturali, quindi si spostò a Parigi e al Jardin des Plantes seguì le lezioni di botanica di Desfontaines e quelle di mineralogia di Haüy. Quindi viaggiò nel sud della Francia, nella Repubblica di Genova, in Piemonte e in Lombardia, dove frequentò per qualche tempo l'università di Pavia. Ritornato in patria, fu nominato guardia forestale del distretto di Aigle. Probabilmente progettava di rimanere in Svizzera e di rilanciare su basi economicamente più solide l'attività di famiglia. Seguendo l'esempio di un vicino e concorrente, J.-C. Schleicher, un farmacista di origine tedesca considerato l'inventore del primo catalogo commerciale di piante, Louis predispose e fece stampare il primo Catalogue de plantes suisses, pubblicato intorno al 1806. Nell'avvertenza ai lettori, Louis scrive: «Sull'esempio di mio padre, al quale l'immortale Haller ispirò il gusto per la botanica, consacrandone il nome nei suoi scritti, anch'io, fin dalla più tenera giovinezza ho dedicato gran parte del mio tempo a percorrere diverse parti della Svizzera, e soprattutto le Alpi, nelle cui vicinanze abito. Avendo così formato una numerosa collezione di piante, di cui posso fornire agli amatori esemplari ben preparati, così come semi e radici di specie rare che io coltivo a tale scopo in un giardino, ho ritenuto di dover porre sotto gli occhi del pubblico il catalogo di queste piante. Avrei potuto aumentarlo con un gran numero di specie comuni che non mi è sembrato necessario nominare; tuttavia coloro che desiderano procurasi un erbario completo della Svizzera lo troveranno presso di me». Forse alla fine del 1806 o all'inizio del 1807, il giovane botanico slesiano Berger, in viaggio per le Calabrie da poco riconquistate dai francesi, di passaggio in Svizzera propose a Louis di unirsi a lui nell'esplorazione della flora di quella regione ancora tutta da scoprire. Egli accettò e i due, muniti di salvacondotti, poterono fare ampie raccolte, che poi affidarono per la pubblicazione a Michele Tenore. Sulla strada del ritorno, erborizzarono in Puglia, quindi rientrarono a Bex dove si divisero. Ma Louis non rimase a lungo in patria; egli soffriva di una grave forma di asma, aggravata dal rigido clima alpino. In Italia era entrato in contatto con Louis Reynier, un funzionario originario del Vaud, appassionato di botanica; nel 1808 Murat lo nominò direttore delle poste e responsabile delle foreste. In questa veste, egli offrì a Louis Thomas l'incarico di ispettore forestale delle due Calabrie. Egli assolse così bene questa funzione che il governo borbonico gli mantenne l'incarico, aggiungendovi anzi la direzione di una salina. Con le sue raccolte della flora calabra, diede un prezioso e imponente contributo alla Flora napoletana di Tenore che così scrive di lui "diligentissimo e dotto botanico, corrispondente al Real Giardino per le Calabrie", arrivando addirittura a definirlo "divus Thomas". Anche se non pubblicò nulla, il suo contributo è ricordato dalle numerose specie da lui scoperte e dedicatogli da Tenore: Crocus thomasii, Sison thomasii, Cerastium thomasii, Quercus thomasii, Ranunculus thomasii, Campanula thomasii. Purtroppo anche in Calabria la sua asma andò progressivamente aggravandosi e Louis Thomas morì nel 1823, a soli 39 anni. A portare avanti gli affari di famiglia rimaneva il solo Emmanuel (Abraham Louis Emmanuel 1788-1859). Aveva ricevuto la stessa educazione dei fratelli e ne condivideva la competenza botanica e l'occhio del raccoglitore, ma in più aveva il senso degli affari. Fu lui a trasformare il piccolo commercio avviato dal nonno e dal padre in un'impresa commerciale di risonanza europea. Come il nonno Pierre aveva scoperto la botanica grazie a Haller, così Emmanuel trovò un amico in un grande studioso, Jean de Charpentier. Nominato direttore delle saline nel 1813, egli le rilanciò, sostituendo l'estrazione diretta del salgemma allo sfutttamento delle acque delle sorgenti salate che andavano progressivamente esaurendosi. Appena arrivato a Dévens, in attesa che la direzione delle saline gli costruisse una casa, Charpentier si stabilì al primo piano della casa rossa, mentre i Thomas abitavano al piano terra. Tra Emmanuel Thomas e Charpentier si stabilì una grande amicizia e uno scambio scientifico, che andava nelle due direzioni: grazie a Charpentier, Thomas divenne un eccellente conoscitore dei minerali della Svizzera, mentre a sua volta incoraggiò Charpentier a creare un erbario e lo assisté nella stesura della sua unica opera di botanica (Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les districts d'Aigle). Ma soprattutto, la presenza di Charpentier (divenuto una celebrità europea per i suoi studi sui ghiacciai) attirò ai Dévens molti rinomati naturalisti. La casa rossa e la casa del direttore delle saline sorgevano l'una vicina all'altra e le piante - alpine ma anche esotiche - passavano da un giardino all'altro, così come i visitatori. Tra di loro, per citare solo qualche nome più familiare agli amanti della botanica, troviamo Alphonse de Candolle, Adrien de Jussieu, Jean Gaudin, Jean Muret, creatore del più completo erbario della flora svizzera; tra i geologhi, Charles Lardy, Elie de Beaumont, Leopold von Buch, Louis Agassiz. L'attività commerciale di Emmanuel è testimoniata dai tre cataloghi (Catalogue des plantes suisses qui se vendent chez Emmanuel Thomas à Bex) che egli pubblicò tra il 1818 e il 1841, cui vanno aggiunti i due già citati cataloghi di piante sarde e due supplementi, usciti rispettivamente nel 1842 e nel 1853. Il più ricco è quello del 1837 che offre più di 600 generi e quasi 2000 specie. Il grosso è costituito da gimnosperme e angiosperme, ma c'è anche una discreta scelta di felci e qualche equiseto e licopodio. Il catalogo del 1841 è invece interamente dedicato alle crittogame e ai licheni, per reggere la concorrenza di Scleicher che era uno specialista di muschi e licheni. Per mettere insieme le collezioni, Emmanuel Thomas continuava a raccogliere in natura, viaggiava molto raccogliendo anche in Piemonte, nelle Alpi italiane, in Austria; per curare le relazioni con la sua clientela internazionale (musei, orti botanici, studiosi, grandi collezionisti) fu anche a Vienna, Parigi, Londra, dove visitò l'esposizione universale. Una parte dello stock di piante vive e semi, probabilmente minoritaria, era coltivata nel giardino-vivaio di Dévens, di cui però non conosciamo l'estensione (dunque neppure le capacità produttive). I prezzi erano modici e le consegne relativamente rapide. Una delle specialità erano le conifere. Nel 1807 già Abraham Thomas pubblicò una memoria sull'utilità di pini e abeti per il rimboschimento. Tra il 1835 e il 1872, la famiglia Thomas consegnò 250.000 pianticelle e più di quattro tonnellate di semi di larice, abete rosso e bianco, pino cembro e altre conifere. Il cliente più importante era il cantone del Vaud, ma molte piante venivano inviate in altre parti della Svizzera, in Francia o addirittura in Inghilterra. Il commercio delle conifere acquistò sempre più importanza mano a mano che ne perdeva quello di exsiccata e piante rare. Dopo la morte di Emmanuel nel 1859, la ditta continuò sotto la direzione del figlio Jean-Louis (1824-1886) e poi dei suoi discendenti, ma i tempi d'oro erano terminati. Gli erbari dei musei e dei grandi orti botanici possedevano già esemplari anche delle piante svizzere più rare e tenere un erbario non era più un hobby alla moda, la concorrenza era sempre più forte e nessuno cercava più guide alpine esperte di piante. Il cliente principale divenne il vivaio Vilmorin, al quale i Thomas inviavano piante vive e sementi. Sempre più in crisi, resistettero fino al 1900, quando la ditta cessò di esistere. Ai Dévens si possono ancora vedere la casa rossa e la casa grigia, che Emmanuel fece costruire intorno al 1825, poco dopo la nascita dell'unico figlio maschio Jean-Louis. L'orto botanico di Abraham e Emmanuel è tornato ad essere un semplice orto. Tuttavia nel 1891 per iniziativa della città di Bex il botanico Ernest Wilczek, direttore dell'orto botanico di Losanna, creò un orto botanico alpino nella Valle di Nant, al di sopra dei Plans-sur-Bex, dove era iniziata l'epopea dei Thomas. Battezzato in loro onore La Thomasia, ospita un arboreto e una collezione di quasi 3000 piante alpine provenienti da tutto il mondo.  Un genere australiano per i botanici delle Alpi Abbiamo già visto che Tenore dedicò al "divus Thomas" diverse specie. Lo stesso onore è toccato ai fratelli Philippe, ricordato da specie della flora corsa come Armeria thomasii (oggi A. leucocephala) o sarda come Olopitum thomasii, ed Emmanuel, ricordato da una quindicina di specie alpine. Fu però un antico ospite della famiglia, il botanico Jacques Étienne Gay, nato nel Vaud ma fattosi parigino, a celebrare allo stesso tempo tre generazioni della famiglia con la dedica cumulativa del genere Thomasia: "Ho consacrato questo genere agli svizzeri Pierre e Abraham Thomas, contemporaei di Haller, nonché ai fratelli Philippe, Louis e Emmanuel Thomas, figli di Abraham e nipoti di Pierre, che, presi da fervido amore per la botanica, per un sessantennio non cessarono di percorrere le montagne e di conquistare piante per l'uso dei botanofili, che infine, grazie allo loro operosità, diedero un catalogo della flora svizzera tale che oggi essa è considerata tra le più ricche della superficie terrestre". A questi instancabili raccoglitori della flora elvetica però Gay non dedicò un genere svizzero e neppure alpino: le circa trenta specie del genere Thomasia (famiglia Malvaceae, in precedenza Sterculiaceae) sono infatti endemiche dell'Australia sud-occidentale, eccetto T. petalocalyx che è nativa del Victoria nell'Australia sud-orientale. Vivono in diversi ambienti, che vanno dalle dune sabbiose e gli affioramenti rocciosi, come T. sarotes, al sottobosco delle boscaglie come T. solanacea, alle brughiere come T. purpurea, alle foreste di eucalipti come T. petalocalyx. Sono arbusti da nani a medi, spesso con foglie molto decorative e fiori dai colori pastello resi spettacolari non dai petali, assenti o piccoli e non appariscenti, ma dai sepali che formano corolle a coppa o a campana piatta che ricordano un po' quelle dei Solanum. Tra le più notevoli, T. purpurea che al momento della fioritura si ricopre letteralmente di racemi color malva; T. quercifolia, con foglie molto attraenti e fiori rosa-porpora; T. pygmaea, che forma cespugli bassi e compatti ed è adatta anche alla coltivazione in contenitori. Molto apprezzate dal giardinaggio australiano, anche perché molte sono piante da sottobosco che ben si adattano agli angoli ombrosi, sono praticamente sconosciute in Europa. Alcune specie erano commercializzate nei cataloghi ottocenteschi e risulta che nel giardino Ricasoli sul Monte Argentario verso la fine del secolo si coltivasse, insieme a moltissimi altri arbusti australiani, anche T. solanacea. A parte qualche vivaio californiano, oggi non sembra siano commercializzate al di fuori dell'Australia. Nel quindicennio tra il 1798 e il 1812, lo scozzese James Niven fu un prolifico ed efficiente cacciatore di piante in Sudafrica. Prima al servizio di George Hibbert, poi di un consorzio che includeva il vivaio Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina, raccolse migliaia di semi e esemplari di erbario, introducendo nei giardini europei molte nuove specie, in particolare Ericaceae e Proteaceae. Nella realtà fu un giardiniere, poi un raccoglitore, infine forse un commerciante morto troppo presto; nel mito, chissà perché, la sua scarna biografia si colora di particolari da fantasiosi a melodrammatici. A ricordarlo il reale e bellissimo genere Nivenia, endemico della provincia del Capo occidentale, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae. 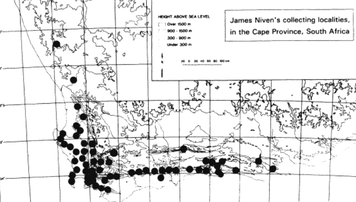 Un raccoglitore prolifico e coscienzioso Nel fascicolo del 1827 della rivista di orticultura edita da Longman e curata da Loudon The Gardener's Magazine i lettori poterono leggere il necrologio di Mr. James Niven, morto il 9 gennaio di quell'anno, corredato da una breve biografia. Ancora oggi è il resoconto più ampio della vita di questo giardiniere e cacciatore di piante; a firmarlo è J. M., ovvero James Main, che doveva aver conosciuto Niven di persona, visto che entrambi per qualche tempo avevano lavorato per il ricco collezionista di piante George Hibbert. Eppure, come vedremo meglio più avanti, le notizie fornite da Main sono da prendere con beneficio d'inventario. Figlio di un tessitore di Penicuik, non lontano da Edimburgo, James Niven (1776-1827) dovette ricevere la relativamente accurata educazione garantita dalle scuole pubbliche scozzesi; poi probabilmente lavorò come ragazzo giardiniere presso vari giardini, finché diciannovenne completò il suo apprendistato presso l'orto botanico di Edimburgo, dove rimase per circa un anno. Nel 1796 si trasferì a Londra dove fu assunto come giardiniere a Syon House, la splendida proprietà del duca di Northumberland, sotto il capo giardiniere Thomas Hoy. In qualche modo dovette attirare l'attenzione di George Hibbert che decise di inviarlo in Sudafrica a caccia di piante. Secondo Nelson e Rourle che, in assenza di un diario di campo, hanno cercato di ricostruire i suoi movimenti sulla base delle sue note d'erbario, Niven dovette arrivare al Capo alla fine del 1798 o all'inizio del 1799, dato che il suo primo esemplare datato risale all'agosto 1799. Secondo Main, presto si impadronì tanto dell'olandese quanto del khoi, tanto da poter servire come interprete e guida alle truppe del generale Craig. E' il primo mito che troviamo in questa storia: almeno un anno prima che Niven vi arrivasse, Craig, dopo aver brillantemente diretto l'occupazione inglese della Colonia del Capo, sottratta alla Repubblica batava, ed esserne stato per due anni governatore, era stato destinato al Bengala e aveva lasciato il Sudafrica per Madras. E' molto probabile (anzi certo secondo Nelson e Rourle) che al Capo Niven abbia invece incontrato un altro botanico scozzese, William Roxburgh, che vi era arrivato da Calcutta nel 1798 insieme a suo figlio John; mentre il padre lasciò il paese alla fine del 1799, il figlio vi rimase fino al 1804 a raccogliere esemplari per l'orto botanico di Calcutta. Nelson e Rourle ipotizzano che, essendo conterranei e avendo interessi comuni, Niven e i Roxburgh abbiano botanizzato insieme, anche se è difficile da dimostrare, perché, al contrario di quelli di Niven, per gli esemplari dei due Roxburgh la località di raccolta è spesso indicata in modo molto generico; una prova indiretta è il fatto è che nel suo erbario Niven usò alcuni binomiali inediti di Roxburgh, Nel 1803, in seguito al trattato di Amiens, la colonia del Capo fu restituita alla Repubblica batava; Niven, che ora non poteva più muoversi liberamente nel paese, rientrò in Inghilterra, ma, sempre stando a Main, dopo solo tre mesi tornò in Sudafrica, al servizio di un consorzio che comprendeva il vivaio Lee & Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Anche questa notizia è imprecisa; secondo Nelson e Rourle, egli invece dovette tornare in Sudafrica nel 1805. Infatti per poter raccogliere nel paese tornato sotto controllo olandese era necessario un permesso; quest'ultimo venne rilasciato a Niven in data 3 aprile 1805, limitatamente alle piccole aree di Riebeek-Kaastel e Roodezand. Tuttavia già nel gennaio 1806 i britannici rioccuparono la colonia, e dal quel momento Niven potè muoversi liberamente; vi sarebbe rimasto per altri sei anni, fino al 1812. Durante i due soggiorni sudafricani, Niven esplorò gran parte della colonia del Capo; a nord si spinse fino al Kamiesberg, il massiccio più elevato del Namaqualand, dove raccolse Vexatorella alpina (pubblicata da Knight come Protea alpina); a est percorse le catene che corrono lungo la costa (monti di Riviersonderend, Langeberg e Outeniqua) e ancora più a est, attraverso la valle Langekloof, dove raccolse Protea tenax, raggiunse Kromme River e Gamtoos River, il punto più orientale dei suoi viaggi, Tuttavia raccolse la maggior parte degli esemplari in un raggio di 150 km da Città del Capo; i suoi luoghi di raccolta preferiti risultano i distretti di Tulbagh, le catene Drakenstein e Hottentots Holland e il monte di Worcester. I suoi committenti desideravano soprattutto semi e bulbi, Ciò significava esplorare ciascuna area almeno due volte: la prima durante la stagione di fioritura per identificare le specie e raccogliere esemplari d'erbario, la seconda qualche mese più tardi per raccogliere i semi. Per ritrovare con facilità le piante e identificarle con sicurezza, Niven creò per se stesso un erbario di campo: su ogni foglio di pesante carta grigiastra incollava più esemplari (mediamente tre) corredati da precise note sul luogo di raccolta, la stagione di fioritura, l'habitat, le caratteristiche ecologiche, talvolta il tipo di suolo. Le raccolte di Niven sono particolarmente importanti per due famiglie largamente presenti in Sudafrica, le Proteaceae e le Ericaceae. Grazie alle sue raccolte delle prime, George Hibbert ne poté vantare la più ampia collezione europea, Knight specializzarsi nella loro coltivazione, Salisbury e Brown pubblicare decine di nuove specie. Una delle più rare è Leucospermum grandiflorum, che nel 1799 fu raccolta sia da Roxburgh sia da Niven. Secondo Salisbury, che la descrisse in Paradisus Londinensis nel 1808, i semi raccolti da Niven furono seminati nella serra di Hibbert dove prosperarono. Anche per le Ericaceae (molte furono pubblicate da Henry Cranke Andrews nei sei volumi di The Heathery, le raccolte di Niven hanno grande importanza storica. Secondo Aiton, le specie di Erica introdotte da Niven in Gran Bretagna sono 31, un risultato notevole se si pensa che Masson nel corso dei suoi tre viaggi ne aveva già introdotte 86. E se i numeri sono inferiori, in compenso i dati relativi ai luoghi di raccolta e agli habitat sono di gran lunga più accurati rispetto a quelli del suo predecessore. Secondo la testimonianza del curatore dell'orto botanico di Edimburgo William McNab, che ebbe con lui molte conversazioni sull'argomento dopo il suo ritorno in Scozia, "il mio molto compianto amico James Niven certamente sapeva sulla natura e sulla coltivazione di questo genere più di ogni altro uomo che io abbia mai incontrato". 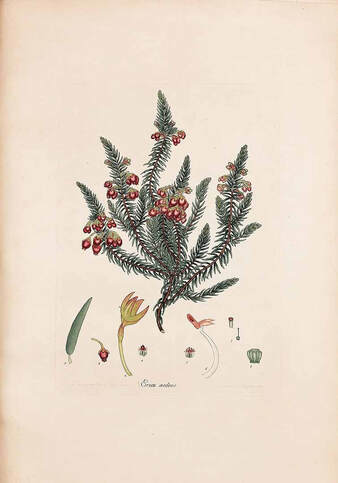 Miti e affabulazioni Dopo il suo ritorno in patria, sempre stando a Main, Niven "abbandonò le sue attività botaniche e orticole" e ritornò a Penicuik, dove aprì un'attività (non sappiamo di che genere) insieme a un fratello. Nel 1817 sposò Alison Abernethy (lo sposo aveva 40 anni, la sposa 26), da cui ebbe 5 figli; nel 1827, ad appena 50 anni morì. Main non manca di aggiungere un particolare melodrammatico: non appena la sua bara lasciò la casa, la vedova morì all'istante, lasciando cinque piccoli orfani. Documenti alla mano, è un altro mito: forse davvero per il dolore la donna ebbe un infarto o un ictus, ma morì e fu sepolta quattro settimane dopo il marito. La situazione dei bambini era comunque difficile, e i loro tutori furono costretti a vendere l'erbario; l'acquirente fu il già citato William McNab; passato al figlio John, capo giardiniere dell'orto botanico di Edimburgo, poi al nipote William Ramsay McNab, l'erbario finì a Dublino quando il suo ultimo possessore ottenne la cattedra di botanica al Collegio reale d'Irlanda. Alla sua morte precoce nel 1889, la vedova fu costretta a mettere in vendita la biblioteca, gli strumenti scientifici e l'erbario del marito, che comprendeva anche quello di Niven. In parte fu acquistato dal Museo nazionale irlandese (oggi è custodito all'erbario di Glasnevin), in parte dai Kew Gardens. Una serie di duplicati, forse in qualche modo acquisiti da Harvey, si trovano invece al Trinity College. L'erbario, già diviso, fu ulteriormente smembrato, e in parte rimase sconosciuto fino agli anni '70 del Novecento, quando venne in un certo senso "riscoperto" e studiato da un altro specialista di Proteaceae ed Ericacae, Ernest Charles Nelson dell'erbario dell'orto botanico di Glasnevin a Dublino, che si è anche incaricato di sfatare alcuni dei miti che hanno offuscato la vera storia di James Niven, Ne rimane uno, forse il più diffuso e tenace. Tra i personaggi più noti dell'orticultura irlandese troviamo Ninian Niven (1799-1879), che ridisegnò Phoenix Park, diresse per qualche anno l'orto botanico di Glasnevin, per poi diventare un affermato vivaista e un famoso architetto di giardini, nonché per diversi anni segretario della Royal Horticultural Society. Non è chiaro per quali ragioni, contro ogni evidenza, nel loro Biographical Index of British and Irish Botanists (1889) Boulger e Britten asserirono che Ninian Niven era figlio del nostro James Niven. Eppure Ninian Niven era nato a Kelvin Growe, presso Glasgow e suo padre, che si chiamava anche lui Ninian, era uno dei giardinieri di Keir House vicino a Stirling e non fu mai un cacciatore di piante. Senza contare che nel 1799 il nostro Niven aveva appena 22 anni ed era giusto arrivato in Sudafrica. I registri parrocchiali di Penicuik non lasciano dubbi: James Niven, come già sappiamo, si sposò quasi vent'anni dopo e nessuno dei suoi cinque figli era ovviamente Ninian Niven. Stranamente questa leggenda orticola è dura a morire: nel Dictonary of British Biography si legge: "suo padre, anche lui Ninian Niven, era un giardiniere di Keir House presso Stirling, e visitò due volte il Capo di Buona speranza raccogliendo piante per George Hibbert e l'imperatrice Giuseppina". Per concludere, un altro mito cinematografico. Nel notevole film Proteus, del regista canadese John Greyson, che racconta in modo romanzato la storia di due prigionieri giustiziati per sodomia in Sudafrica, compare un botanico scozzese chiamato Virgil Niven, ispirato a James Niven. A dispetto del fatto che la tragica vicenda sia avvenuta nel 1735, quarant'anni prima della sua nascita.  Iridaceae arbustive con fiori color cielo Il contributo di James Niven alla botanica e ai giardini britannici, da lui arricchiti di tante specie notevoli, è riconosciuto tanto da William Aiton, quando da Salisbury e Robert Brown, per una volta concordi. Lo ricordano gli eponimi di non molte specie sudafricane (Acmadenia nivenii, Erica niveniana, Serruria nivenii) e un genere ugualmente sudafricano, Nivenia. Glielo dedicò Ventenat sulla base di una delle molte specie da lui raccolte in Sudafrica e approdate alla Malmaison; in Decas Generum Novorum (1808) il botanico francese scrive: “questa specie è stata fornita dall’egregio Kennedy; perciò l’ho nominata dallo scopritore J. Niven, giardiniere inglese” (d'accordo, era scozzese, ma errore più errore meno...). Rispetto a questa laconica dedica, è ben più eloquente quella di Robert Brown per un secondo genere Nivenia (ovviamente non valido per la regola della priorità); dopo aver spiegato in che cosa il nuovo genere differisce da Paranomus di Salisbury, egli infatti scrive: "L’ho dunque nominato in onore di Mr. James Niven, un osservatore intelligente e un raccoglitore instancabile, con il quale i botanici sono indebitati di molte nuove specie delle due estese famiglie sudafricane delle Ericaceae e delle Proteaceae”. Nivenia Vent. è un piccolo genere della famiglia Iriaceae; insieme a Klattia e Witsenia, è uno dei soli tre generi della famiglia (tutti endemici del Sudafrica) a essere veri e propri arbusti sempreverdi, con fusti legnosi che producono vegetazione secondaria. Raggruppati nella sottofamiglia Niveoinioideae, tutti insieme comprendono appena quindici specie, contro le 1600 dell'intera famiglia (900 nel solo Sudafrica). Il genere più vasto del gruppo è proprio Nivenia, con undici specie accettate. Hanno tutte fiori azzurri e sono arbusti di medie dimensioni, con l'eccezione di tre specie a cuscino che crescono in habitat rocciosi aridi di montagna: N. levynsiae nelle Betty Bay-Kleimond Mountains, N. concinna al Viljoen Pass e N. fruticosa nel Lagenberg. Quest'ultima, di habitus quasi erbaceo e con un'infiorescenza poco vistosa di appena due fiori, fu la prima specie ad essere raccolta e descritta, da Peter Thunberg che la assegnò al genere Ixia. All'estremo opposto troviamo la specie più nota, l'unica coltivata al di fuori del Sudafrica, N. corymbosa, che cresce a Bain's Kloof e nelle montagne circostanti: gli esemplari più vecchi possono avere rami con un diametro di 4-5 cm lunghi anche tre metri. L'infiorescenza è un grande corimbo di circa 120 fiori in diverse tonalità di blu, che attirano folle di impollinatori, in particolare l'ape Amegilla fallax, dotata di una lunga ligula che le permette di raggiungere il nettare posto alla base del lungo tubo florale. A metà tra questi due specie estreme, si colloca la bella N. stokoei, un arbusto dal portamento arrotondato, che in aree protette può raggiungere il metro e mezzo, ma in aree aperte rimane molto più basso. Ha strette foglie lanceolate disposte a ventaglio che tradiscono immediatamente l'appartenenza alla famiglia, e fiori blu purissimo. E' un endemismo della Riserva della Biosfera Kogelberg. Tutte endemiche del Capo occidentale, spesso di aree estremamente limitate, purtroppo diverse specie di Nivenia sono in pericolo per la restrizione del loro habitat e anche per le conseguenze del cambiamento climatico. Tutte le sue undici specie sono incluse nella lista rossa delle piante sudafricane, due sono classificate come vulnerabili e cinque come rare. Ancora negli anni '80 del Novecento, quando ormai era in pensione, era ben noto ai botanici che affluivano da ogni parte del mondo in Sudafrica per studiare la sua flora, che una visita da non perdere era quella alla piccola casa di Elsie Elisabeth Estrerhuyzen a Città del Capo. La sua competenza era tale da farla considerare un'enciclopedia vivente, mentre il suo contributo alla raccolta di nuove specie, soprattutto di alta montagna, l'aveva resa leggendaria: le è infatti accreditata la raccolta di ben 36.000 esemplari d'erbario. Eppure Elsie, come la chiamavano tutti, non era affatto una Indiana Jones della botanica in gonnella: era una piccola esile donna amante dei gatti e della montagna, che non guidava e si muoveva dappertutto in bicicletta; così modesta, che, una volta studiato a fondo un genere e, "colmati i vuoti" dell'erbario Bolus, dove lavorò per decenni, preferiva lasciare ad altri la pubblicazione. La ricordano due generi endemici delle montagne delle Provincie del Capo, che esplorò metodicamente per decenni: Esterhuysenia (Aizoaceae) e Trieenea (Scrophulariaceae). 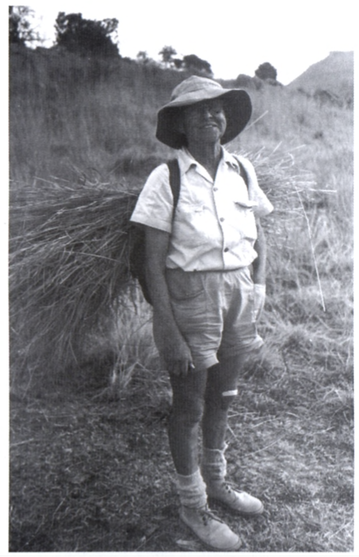 Raccogliere piante per "colmare i vuoti" Nel giugno 2006, nella sala conferenze dell'orto botanico di Kirstenbosch si riunì una piccola folla per dare l'ultimo saluto a Elsie Elizabeth Esterhuysen (1912-2006) che si era spenta all'inizio di quell'anno a 93 anni. John Rourke, curatore del Compton Herbarium e presidente della Botanical Society of South Africa, aprì il suo ricordo con queste parole: "Oggi siamo qui per celebrare la vita di una leggenda, perché Elsie era una leggenda, certamente lo era per la comunità botanica locale". A renderla tale non era solo la sua età venerabile, né una personalità indubbiamente fuori del comune, ma le sue incredibili raccolte botaniche: con 36.000 esemplari d'erbario, è stata uno dei più prolifici raccoglitori di sempre. Eppure non c'era nulla di eroico in questa piccola ed esile donna. Elsie era nata a Cape Town in una famiglia di avvocati; dopo aver studiato alla Wynberg Girls’ High School, si iscrisse all'Università di Cape Town dove nel 1933 conseguì la laurea di primo livello (Master of Arts) in botanica con una tesi sull'anatomia di Myrothamnus flabellifolius, una pianta xerofila nota come "resurrection plant" per la sua capacità di rinverdire alla prima pioggia anche quando sembra totalmente disseccata. Ma alle ricerche di laboratorio già allora preferiva di gran lunga quelle sul campo. Dopo aver lavorato per poco tempo nel Dipartimento educativo, nel 1935 grazie a una borsa di studio poté studiare la rigenerazione del fynbos a Kirstenbosch dopo l'eliminazione di piante aliene. La sua aspirazione era entrare a far parte del gruppo di ricerca che, guidato da Pole Evans, stava mappando la flora del Sudafrica, ma la sua domanda fu respinta per la semplice ragione che era una donna. Così nel 1936 accettò un posto di assistente al McGregor Museum di Kimberley, diretto dalla geologa e botanica Maria Wilman, che in quegli anni stava dirigendo un progetto di ricerca sulla flora del Griqualand occidentale. Dato che l'area da esplorare era vasta, per raggiungere i luoghi più remoti la direttrice insistette che imparasse a guidare. Ma un giorno Elsie Esterhuysen rimase bloccata a un passaggio a livello: si spaventò talmente che da quel giorno non guidò più. In compenso, si procurò una bicicletta e divenne una provetta ciclista. Nel 1938 tornò a Cape Town e cominciò a lavorare per il Bolus Herbarium, dove avrebbe trascorso tutta la sua vita professionale. Per ben 18 anni, però, non fece parte ufficialmente dello staff, venendo pagata di volta in volta con la cassa per le piccole spese; solo nel 1956, su insistenza del nuovo curatore, Ted Schelpe. fu creato per lei un posto di ricercatrice, con uno stipendio fisso. Grande appassionata di montagna, fin dal 1935 si era iscritta al club alpinistico del Sudafrica (MCSA). Conoscendo questa passione, le fu affidata la ricognizione della flora di alta quota delle montagne del Capo, che all'erbario era documentata in modo irregolare. Insomma, come lei stessa si espresse, il suo compito era "colmare i vuoti". Quasi ogni week end, approfittando del passaggio di qualche membro del MCSA, esplorava un angolo di quelle montagne, e tornava a valle con un sacco nero pieno di piante. Durante le vacanze, approfittava delle escursioni organizzate dal club per erborizzare in altre aree, come il Drakensberg. Non bisogna però pensare che raccogliesse a caso. Per "colmare i vuoti" concentrava la sua attenzione su un genere rappresentato in modo inadeguato e quando individuava una specie che poteva essere nuova, ritornava più volte nell'area per studiarne i tempi di fioritura e l'ecologia, raccogliere semi e frutti; esplorava i dintorni per mapparne la distribuzione e studiare specie affini, a volte per anni. Metteva a confronto le proprie raccolte con il materiale d'erbario e con le pubblicazioni, e, quando aveva finito, il genere era perfettamente documentato nelle sue schede, con gli esemplari ben montati nell'erbario e la loro tassonomia pronta per la pubblicazione. Un compito che però lasciava volentieri agli "accademici". Così, anche se scoprì almeno 150 taxa, pubblicò pochissimo. La maggiore eccezione è costituita dalle Restionaceae, di cui pubblicò una cinquantina di specie, soprattutto grazie alle insistenze del botanico svizzero Hans Peter Linder, uno dei tanti giovani studenti e perfezionandi che impararono ad amare e conoscere la flora sudafricana grazie alla sua generosità e disponibilità. Insieme a T. M. Salter, pubblicò inoltre alcune specie di Erica. Tra le sue scoperte più sensazionali, quella di Protea nubigena, una specie molto rara che vive solo nei pascoli ad alta quota dell'uKhahlamba-Drakenberg nel Natal. Nel 1989 l'Università di Città del Capo le conferì la laurea honoris causa (Master of Science). La lettera di accettazione al rettore la dice lunga sulla sua modestia: "Grazie per la sua cortese lettera del 9 gennaio. Accetto la laurea onoraria e apprezzo l'onore. Tuttavia mi chiedo se lo staff dell'erbario Bolus è stato consultato. Se la questione non fosse riservata, vorrei farlo io stessa, perché non mi sembra che il mio lavoro meriti questo grado. Spero che il Consiglio [di facoltà] non sia caduto in errore pensando che la scoperta di nuove specie sia chissà che risultato, perché non lo era. A parte questo, ho lavorato come tecnico mantenendo l'erbario in ordine e aggiornato". Altri tratti della sua singolare personalità - che dovette colpire profondamente chiunque la conobbe -emergono dai ricordi pubblicati in occasione della sua commemorazione. Ogni giorno, sulla sua fida bicicletta faceva la spola tra l'erbario e la sua modestissima casa, doveva viveva con alcuni adorati gatti; guidava studenti e perfezionandi in gite in bicicletta, distaccando anche i più giovani; detestava le ingiustizie ed era socialmente impegnata; ma il suo vero ambiente era la montagna, con la quale aveva un contatto così intimo che preferiva dormire all'aperto, su un giaciglio improvvisato di paglia ed erbe, piuttosto che in una tenda. Per celebrare i suoi ottant'anni, insieme agli amici del Club alpino, scalò lo Sneeuberg, la cima maggiore del Cederberg (2027 metri).  Tante specie e due generi A questa formidabile raccoglitrice, i tanti botanici con cui collaborò hanno dedicato una trentina di specie e due generi validi. Ad esempio, il suo "capo" Louisa Bolus le dedicò non meno di sette Aizoaceae, tra cui Delosperma esterhuyseniae e Gibbaeum esterhuyseniae; Compton Erica esterhuyseniae; Hilliard Selago elsiae (una specie oggi estinta) e Selago esterhuyseniae; Pillans Restio esterhuyseniae. Ci sono anche dediche più nascoste: alludendo alla sua passione per le montagne, dove si muoveva con l'agilità delle antilopi saltarupi Oreotragus oreotragus, E G. H. Oliver le dedicò Erica oreotragus. Con lo stesso gioco di parole, Karis pensava a lei nominando Monticapra ("capra di montagna") una sezione del genere Disparago. I generi dedicati a Elsie Esterhuyen sono tre, due in modo diretto, uno anch'esso in modo indiretto ed allusivo. Ad aprire le danze fu una delle sue colleghe al Bolus Herbarium, Frances Margaret Leighton, specialista dei generi Ornithogalum e Agapanthus, che nel 1944 le dedicò Elsiea con una motivazione semplice ed eloquente: "Il nome del genere onora Miss Elsie Esterhuysen del Bolus Herbarium, le cui raccolte hanno dato un valido contributo alla conoscenza della flora delle montagne più alte del Capo sudoccidentale". Il genere, stabilito sulla base di una specie raccolta quell'anno dalla stessa Esterhuysen, Elsiea corymbosa, è considerato sinonimo di Ornithogalum, e la specie è stata rinominata Ornithogalum esterhuyseniae. Nel 1967 Louisa Bolus, che, come abbiamo già visto, aveva già dedicato molte specie alla più prolifica dei suoi raccoglitori, le dedicò anche un genere, Esterhuysenia (Aizoaceae). Laconica (e tecnica) la dedica: per Elsie Elizabeth Esterhuysen, raccoglitrice del tipo, Provincia del Capo, nel distretto di Worcester; Hex River Mountains, Milner Peak, versante est, sulle sporgenze, 5,500-6,000 piedi, dicembre 1948. La specie in questione è Esterhuysenia alpina, una delle sei di questo piccole genere endemico di un'area relativamente ristretta della Provincia del Capo occidentale (distretti di Caledon, Ceres, Robertson, Worcester); sono piccoli arbusti nani, spesso a cuscinetto, che crescono tra le rocce intorno ai 2000 metri di altitudine. Hanno foglie carnose, tra quadrangolari a cilindriche, caratterizzate da un apice mucronato, fiori per lo più solitari con numerosissimi petali (in realtà staminoidi) bianchi, rosa o viola; i frutti sono capsule con cinque loculi, come quelli degli affini Ruschia e Lampranthus, di cui si distinguono perché mancano sia degli opercoli del primo, sia delle ampie ali del secondo. Tutte le specie sono rare, spesso limitate a aree molte ristrette, ma le loro popolazioni sono stabili. Anche il terzo genere dedicato a Esterhysen si deve a una botanica sudafricana, Olive Mary Hillard, nota soprattutto per aver fatto risorgere l'allora quasi moribondo orto botanico di Edimburgo, a sua volta una notevolissima raccoglitrice. Trovandosi già impiegati i possibili e più ovvii nomi ricavati da nome personale e cognome, Hillard dovette ricorrere a un vero e proprio gioco enigmistico: il suo Trieenea allude infatti alle tre E che formano le iniziali di Elsie Elisabeth Esterhuysen. Anch'esso endemico della Provincie del Capo occidentale e meridionale, questo genere della famiglia Scrophulariaceae comprende erbacee perenni o piccoli arbusti, più raramente annuali, che vivono in habitat montani; sette specie su dieci sono endemiche del Cedarberg, alcune note solo dagli esemplari d'erbario, altre ristrette ad aree molto limitate. Ha invece un areale relativamente più esteso T. glutinosa, in precedenza Phyllopodium glutinosum, che si spinge anche nella Provincia del Capo orientale. E' un piccolo arbusto che vive nelle spaccature delle rocce, con fusti eretti, foglie lievemente carnose con lamina quasi triangolare e margini dentati, piccoli fiori bianchi raccolti in brevi infiorescenze. Tra le specie del Cederberg, T. elsiae ricorda anche nell'eponimo Elsie Esterhuysen che la scoprì sul Sandfontein Peak, nel Cedarberg meridionale, il 5 aprile 1947. Rispetto alla conterranea, e quasi coetanea, Mary Barber, la figura di Caroline Hutton nata Atherstone è molto più convenzionale, anche se non mancano i tratti comuni: entrambe erano figlie di coloni del 1820, vissero nella Provincia orientale del Capo e divennero addirittura parenti; entrambe raccolsero esemplari per Harvey e Hooker, venendo ricordate dal primo con la dedica di un genere. Diversi furono invece i loro ambienti sociali e soprattutto la dedizione alla scienza. Caroline Atherstone era figlia e sorella di medici dai notevoli interessi scientifici e si trovò fin da bambina immersa in un ambiente colto e aperto; molto giovane sposò Henry Hutton, un funzionario dell'amministrazione civile, da cui ebbe moltissimi figli. Insieme a lui è ricordata da Harvey per le sue raccolte botaniche che non dovettero essere il centro della sua vita come per Barber, ma un hobby o una passione secondaria, sebbene abbastanza forte da persistere e forse intensificarsi anche quando era un'anziana vedova. Harvey le dedicò il genere di orchidee Huttonaea, la cui prima specie fu da lei scoperta sul Katberg. 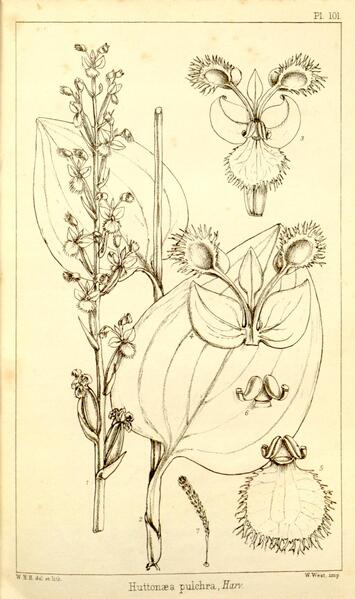 Raccolte in famiglia Come la famiglia Bowker, anche il dottor John Atherstone arrivò in Sudafrica con i coloni del 1820, ma, anziché diventare un fattore e un allevatore di bestiame, per qualche anno lavorò come chirurgo a Città del Capo, quindi nel 1828 venne nominato chirurgo del distretto di Albany sulla frontiera orientale, stabilendosi a Grahamstown. Quasi immediatamente fondò un gabinetto di lettura; fu qui, o dalla sua fornita biblioteca privata, che miss Bowker, ovvero la futura Mary Elizabeth Barber, prese in prestito la copia di Genera of South African Plants grazie alla quale scoprì la botanica. Del resto, era destinata a intrecciare strettamente la sua vita con quella della famiglia del medico: alla fine del 1839, il figlio maggiore di John Atherstone William Guybon tornò dall'Europa, dove era andato a laurearsi in medicina, accompagnato da uno dei suoi cugini inglesi: Frederick William Barber, ovvero il futuro marito di Mary. Oltre a diventare il più eminente medico della regione (tra l'altro, fu il primo a utilizzare l'anestesia durante un intervento chirurgico), William Atherstone aveva forti interessi scientifici. In Europa aveva studiato successivamente a Dublino, Londra e Parigi, ed era in contatto con molti scienziati tra cui Harvey e Hooker. Fu uno dei pionieri delle ricerche geologiche e paleontologiche in Sudafrica e nel 1855 fu tra i soci fondatori della Literary, Scientific and Medical Society di Grahamstown, le cui collezioni presto si trasformarono nell'Albany Museum, di cui per molti anni fu presidente e il maggior donatore, con esemplari che spaziavano in tutti i campi delle scienze naturali. Ma protagonista di questa storia non è il versatile dottore (cui pure il botanico della colonia Pappe dedicò il genere Athestonea, oggi ridotto a sinonimo), ma la più giovane delle sue sorelle, Caroline (1826-1908). Di lei non sapremmo nulla se non avesse lasciato traccia delle sue raccolte nei libri di Harvey e nei cataloghi dell'Albany Museum. Ignoriamo se abbia ricevuto una formazione formale, ma certo, nata in una famiglia colta, avrà condiviso l'interesse per le scienze naturali del brillante fratello maggiore, così come una delle sue sorelle, Bliss Ann (nota con il cognome da sposata White) che dopo il matrimonio fece importanti raccolte di rettili, insetti e altri animali nei dintorni di Brak Kloof, la fattoria che gestiva con il marito, donandole al museo di Albany. Nel 1848, la ventunenne Caroline sposò Henry Hutton che era arrivato in Sudafrica quattro anni prima; figlio di un pastore protestante, diciassettenne al momento del suo arrivo, forse per qualche tempo aveva lavorato per il futuro suocero, facendosi notare per l'intelligenza e gli interessi scientifici. Poi, forse con un spintarella di suocero e cognato, cui dovette essere legato da una forte amicizia, fece carriera; anche se durante le diverse guerre contro gli Xhosa egli ebbe anche qualche ruolo militare, servì soprattutto come impiegato pubblico, con compiti come sovrintendente dei forzati, giudice di pace, ispettore del dipartimento dei forzati, nonché tesoriere e segretario del Consiglio di divisione di Bedford, che lo portarono in varie località del distretto di Albany. Di tanto in tanto gestì anche una fattoria, anche per mantenere una famiglia sempre più numerosa (gli Hutton ebbero cinque figli e sette figlie, anche se solo sei raggiunsero l'età adulta). Probabilmente incoraggiati dal fratello e cognato, che era già in contatto con Harvey, forse già intorno al 1850 Caroline e Henry iniziarono a raccogliere esemplari e a inviarli a Dublino, come risulta dalla prefazione del primo volume di Flora capensis (1859), in cui il botanico ringrazia "l'egregio sig. Henry Hutton per le considerevoli raccolte fatte ad Albany". La collaborazione continuò per molti anni, anche oltre la morte di Harvey, quando il compito di completare l'opera fu assunto da Sonder e Tylseton-Dyer; i coniugi Hutter contribuirono con non meno di 120 diverse specie; come raccoglitore è in genere citato Henry, ma in una trentina di casi Caroline. Probabilmente spesso raccoglievano insieme e le raccolte dell'uno e dell'altra sono indistinguibili, ma a mantenere i contatti con Dublino e Londra provvedeva soprattutto il marito. Oltre che con Harvey, la coppia collaborò anche con il botanico coloniale Pieter MacOwan che nel 1867 cita Henry come uno dei cinque raccoglitori che avevano esplorato a fondo il distretto di Grahamstown. I coniugi Hutton spedirono esemplari anche a Hooker e ai Kew Gardens, ma il grosso delle loro raccolte fu donato al Museo di Albany, soprattutto dopo il 1891, quando si trasferirono nella fattoria Beaumont sul Fish River. Dopo la morte del marito nel 1896, Caroline, che ormai aveva settant'anni, continuò a raccogliere da sola. Nel 1900 viveva a Howick nel KwaZulu-Natal, da dove spedì 186 specie all'Albany Museum; altre spedizioni seguirono negli anni successivi, fino alla sua morte nel 1908.  Orchidee belle e rare Oltre che nel museo di Albany e nell'erbario del Natural History Museum, i coniugi Hutton hanno lasciato una traccia visibile nella nomenclatura botanica. Henry è ricordato da Lysimachia huttonii, che gli fu dedicata da Harvey già nel 1859; Moraea huttonii; Cyrtanthus huttonii, da lui raccolto nella distretto di Albany prima del 1864, data in cui fiorì per la prima volta a Kew; Ceropegia huttonii raccolta sul Botha Hill presso Grahamstown; Eulophia huttonii, Harveya huttonii, Printzia huttonii, Hesperantha huttonii e Wahlenbergia huttonii, tutte raccolte sul Katberg. Mancò invece la dedica di un genere, anche se forse ci contava. Sempre sul Katberg, una montagna a nord di Fort Beaufort, evidentemente il suo luogo di raccolta preferito, scoprì una pianta appartenente a un nuovo genere; ma Harvey la chiamò Bowiea volubilis, dedicandola, anziché a lui, al raccoglitore di Kew James Bowie. Caroline è ricordata da un numero molto minore di specie: Euphorbia huttoniae, Nerine huttoniae (oggi N. laticoma subsp. huttoniae), Sisyranthus huttoniae, Lachnagrostis huttoniae, le ultime tre risalenti agli anni della vedovanza, quando poteva "firmare" le sue raccolte senza lo schermo del marito. Se Harvey non le dedicò neppure una specie, al contrario di quanto fece con Henry, la compensò con un genere oltre tutto di notevole bellezza. Il secondo volume di Taesaurus capensis ( dedicato a suo fratello William che, ci informa Harvey, insieme a Henry Hutton, fu anche suo agente per la diffusione in Sudafrica di quest'opera e di Flora capensis), si apre con Huttonaea pulchra, una splendida e curiosa orchidea scoperta "nel marzo 1862 in angoli umidi, sotto gli alberi, sul Katberg, a 4000 piedi d'altezza, da Mrs. Henry Hutton". Ovvero dalla nostra Caroline. Il genere Huttonaea comprende cinque specie di orchidee terrestri endemiche di un'area ristretta alle montagne di Capo Orientale, KwaZulu-Natal, Stato Libero e Mpumulanga, con piogge estive. Tre specie (Huttonaea grandiflora, H. oreophila e H. woodii) vivono in spazi aperti erbosi, mentre le altre due (H. fimbriata e H. pulchra) nell'ombra delle foreste. La specie più diffusa, nonché quella che si spinge più in alto, è H. grandiflora (tra 2190 e 2800 m, dal Capo Orientale allo Stato Libero meridionale attraverso le montagne del KwaZulu-Natal), mentre la più rara è H. woodii che è stata raccolta solo tre volte in località diverse del KwaZulu-Natal. A seconda della specie, i fiori, raccolti in tozzi racemi, possono essere più piccoli e numerosi (fino a 25), oppure più grandi e pochi (2-4), ma tutti sono caratterizzati da una morfologia singolare: i sepali sono piatti, spesso verdastri, quelli superiori più o meno divergenti; i petali e il labello, da bianchi a crema, con macchie porpora, hanno margini fortemente sfrangiati; i petali hanno un'unghia più o meno lunga e sono più o meno fortemente saccati; formano così due sacchi gemelli (merianthium), una caratteristica rara tra le angiosperme e unica tra le orchidee, provvisti alla base di verruche ghiandolari che secernono olio: un "premio" ambitissimo dagli insetti impollinatori, le api del genere Rediviva. Mentre nelle altre specie l'angolo tra i petali permette a un insetto posato al centro del fiore di visitare contemporaneamente i due sacchi, in Huttonea pulchra essi formano un'angolo di 90 gradi, facendo divergere i sacchi e costringendo l'ape a visitarli separatamente. Anche se non è del tutto chiaro quali vantaggi comporti in termini di successo dell'impollinazione, è una caratteristica singolare che rende ancora più affascinante questa piccola orchidea scoperta nei boschi del Katberg da Caroline Hutton nel lontano 1862. A metà Settecento, dopo quasi un secolo di confronti armati con l'Inghilterra, in Francia i grandi alberi, indispensabili per le costrizioni navali, incominciano a scarseggiare. Ne è assai preoccupato l'abate Nolin, il direttore dei vivai reali, tanto più che la perdita del Canada ha chiuso anche quella fonte di rifornimento. E' necessario ripopolare in fretta le foreste francesi con alberi dalla crescita veloce ma dal legno inattaccabile, come hanno dimostrato essere diverse specie nordamericane. I rivali inglesi lo fanno da almeno un secolo, ma adesso che le loro 13 colonie - con l'aiuto determinante degli amici francesi - hanno conquistato l'indipendenza, perché non approfittarne per mandare nei neonati Stati Uniti un esperto di silvicoltura a fare incetta di semi e alberi? E, guarda caso, c'è la classica persona giusta al momento giusto: il "botanico del re" André Michaux ha una grande pratica di coltivazione di alberi esotici ed è appena tornato da un viaggio in Persia in cui ha dimostrato di non avere paura di nulla e di essere un instancabile cacciatore di piante dall'occhio di falco. E così nel 1785 André Michaux e il figlio quindicenne François André partono per gli Stati Uniti, dove rimarranno dieci anni, prima al servizio del re, poi di una repubblica di cui condividono gli ideali di libertà, eguaglianza e fratellanza, ma da cui presto non riceveranno più un franco. Michaux padre fonda due vivai e percorre instancabile gran parte degli Stati Uniti, spingendosi anche in Canada e nella Florida ancora spagnola. La fa quasi sempre da solo, per lo più a piedi, in modo spartano. Sulle piante americane, e in particolare sugli amati alberi, presto ne sa più di tutti. Vivaista dei due mondi, manda in Francia una stupefacente quantità di piante, ma arricchisce anche i giardini americani di tante specie esotiche. Il suo libro sulla flora dell'America nord orientale farà testo per molti anni, così come quello di suo figlio sugli alberi americani. La pianta che lo celebra però non viene dall'America, ma dal Medio Oriente.  Da Versailles al mar Caspio André Michaux (1746-1801) è nato nel parco di Versailles e se un evento tragico non avesse sconvolto la sua vita forse sarebbe rimasto per tutta la vita fattore reale, come lo era suo padre prima di lui. La famiglia gestisce la fattoria di Sautory e André, che ha potuto frequentare la scuola solo quel tanto che basta a imparare a leggere, scrivere e far di conto, lavora al fianco del padre fin da bambino. Alla sua morte, gli subentra come fattore insieme al fratello, ma nel 1770 sua moglie muore di parto dando alla luce l’unico figlio François André. Per André la vita non ha più senso. A sollevarlo dalla depressione è uno dei suoi vicini, Louis Le Monnier, professore di botanica del Jardin du roi, che gli fa scoprire la coltivazione di piante esotiche. Michaux fa esperimenti di acclimatazione a Sautory e incomincia a frequentare le lezioni di Antoine-Laurent de Jussieu al Trianon. Ha trovato la sua strada; si trasferisce a Parigi a studiare al Jardin du roi e nel 1779 ottiene il brevetto di «botanico reale». Il suo desiderio più ardente è viaggiare. Quell'anno, viene inviato ai Kew Gardens a studiarne le serre, quindi partecipa insieme ad André Thouin a una spedizione in Alvernia organizzata e finanziata da Lamarck. Nel 1780, da solo, va a caccia di piante nei Pirenei francesi e spagnoli. Sogna viaggi più esotici e quando viene a sapere che il nuovo console a Bassora, Jean-François Rousseau, cugino del filosofo, sta per partire per la Persia si unisce al suo seguito con la missione di raccogliere piante belle, utili e interessanti per i giardini di Maria Antonietta al Trianon e il Jardin du roi. Lasciata la Francia nel febbraio 1782, sbarcano ad Alessandretta e, dopo un soggiorno di qualche mese ad Aleppo, si uniscono a una carovana che a ottobre li porta a Bagdad, dove trascorrono l’inverno. Quindi Michaux saluta il console con l’intenzione di raggiungere l’impero persiano; sulla strada per Bassora è fatto prigioniero da una tribù in rivolta. Liberato, può finalmente continuare il suo viaggio visitando metodicamente la Persia, da Shiraz a Persepoli, da Isfahan a Julfa e fino alle rive del Caspio. Dopo un viaggio di tre anni, rientra in Francia nel giugno 1785 con più di quattrocento specie di piante. Tra di esse, Rosa persica, raccolta su un’alta montagna tra Shiraz e Isfahan, l’olmo del Caucaso Zelkova carpinifolia, il noce del Caucaso Pterocarya fraxinifolia e la pianta che oggi porta il suo nome, Michauxia campanuloides, trovata sulle montagne della Siria occidentale. Riporta anche manoscritti, medaglie, reperti archeologici, tra cui un kudurru babilonese, oggi conservato al Cabinet des medailles della Biblioteca nazionale e noto come "sasso di Michaux". Appena tornato, vorrebbe ripartire, magari di nuovo per l'Oriente, ma il ministero gli propone una meta totalmente diversa: gli Stati Uniti. Il direttore dei vivai reali, l'abate Nolin, preoccupato per il depauperamento delle foreste francesi, ha chiesto di inviare in America una missione a caccia di piante e Michaux è il candidato ideale. Così, appena tre mesi dopo il suo ritorno, riparte. La Francia è il principale alleato dei neonati Stati Uniti, che ha sostenuto attivamente nella guerra d’indipendenza da poco ufficialmente conclusa con la pace di Parigi (settembre 1783). Dunque in America Michaux può contare su buoni amici. Benjamin Franklin era vissuto molti anni tra Parigi e Versailles, diventando una figura di primo piano della società parigina; Thomas Jefferson, che lo aveva sostituito come ambasciatore, era di casa nel Jardin du roi, era spesso ospite di Buffon e aveva stretto una duratura amicizia con il capo giardiniere André Thouin.  Alberi d'America Dunque il viaggio può essere organizzato con la massima rapidità. L’abate Nolin consulta i cataloghi degli orticultori americani e redige una lista delle piante più desiderabili. Michaux si imbarca con il figlio quindicenne François André, il giardiniere Paul Saunier (un altro allievo di Thouin) e un servitore e a novembre sbarca a New York. Nonostante il tempo pessimo e una lingua poco familiare, riesce quasi subito a mettere insieme un primo invio di piante e semi, che si è procurato nei vivai cittadini. Nel corso dell’inverno crea un vivaio di 30 acri a Hackensack (New Jersey) e incomincia ad esplorare i dintorni di New York. Su invito di Benjamin Frankilin, va a Filadelfia a conoscere William Bartram e a visitare il suo celebre vivaio. Poi è la volta di Mount Vernon, il magnifico parco di piante native creato dal presidente Washington; quindi, prima di rientrare in New Jersey, scende a sud fino a Fredericksburg in Virginia. L’incontro con Bartram, a sua volta un grande esploratore che tra il 1773 e il 1777 ha raccolto piante in otto colonie, dalla Pennsylvania alla Florida, è determinante; i due si scrivono, scambiano semi e informazioni, ma soprattutto è Bartram a suggerirgli di spostare il centro delle sue ricerche in South Carolina, una zona particolarmente ricca di nuove piante. Nel settembre 1786, Michaux affida il vivaio di Hackensack a Saunier e insieme a suo figlio si imbarca per Charleston. Qui, a poche miglia dalla città, crea un secondo vivaio di 111 acri che sarà la sua base operativa per i prossimi dieci anni. A Charleston c’è una grossa comunità di ugonotti di origine francese e Michaux si ambienta benissimo. Il suo giardino si sviluppa in fretta e presto può funzionare da centro di interscambio nelle due direzioni: oltre a coltivare le piante americane da spedire in Francia, si fa mandare semi dalla madrepatria e arricchisce i giardini dei suoi ricchi e influenti clienti americani di piante ancora sconosciute su questa riva dell’Oceano: tra quelle di cui gli si attribuisce l’introduzione negli Stati Uniti, Albizia julibrissin, Melia azedarach, Osmanthus fragrans, Lagerstroemia indica, Ginkgo biloba e la pianta del tè, Camellia sinensis. È chiaro che uno come Michaux non è venuto in America a fare il vivaista e non vede l’ora di riprendere a viaggiare. Appena il giardino è ben avviato, ricominciano le spedizioni. Nella primavera del 1787, dapprima in compagnia del botanico scozzese John Fraser, segue il percorso di Bartram lungo il fiume Savannah, poi si addentra da solo in territorio Cherokee fino alle sue sorgenti, scoprendo la rara Shortia galacifolia. Negli anni successivi visiterà gran parte del nord America orientale, spingendosi anche nella provincia canadese del Quebec, nella Florida spagnola e nelle Bahamas. Esplorò con particolare intensità la Georgia e le Caroline, in particolate la regione del Piedmont che visitò ben sette volte. Amava viaggiare da solo, a piedi o a cavallo, e con un bagaglio minimo. Se trovava ospitalità per la notte, bene; altrimenti, si poteva dormire benissimo anche sotto le stelle. Aveva un occhio d’aquila, si fermava ad osservare ogni pianta ed era abilissimo a scovare nuove specie anche in zone già battute, come notò l’amico Bartram. Nel 1792 fece un lungo viaggio fino alla baia di Hudson; al ritorno, ebbe un colloquio con Jefferson, all’epoca segretario di stato, a cui propose di esplorare la sorgente del Missouri, individuare la linea di spartiacque e scendere fino al Pacifico. Jefferson era tentato, ma per opportunità politica rinunciò, tanto più che Michaux si trovò coinvolto in un incidente diplomatico; l’ambasciatore francese Genêt, che stava cercando di organizzare gruppi di volontari e una sommossa per strappare New Orléans agli spagnoli, approfittò dei suoi viaggi botanici per affidargli vari messaggi segreti. Le trame di Genêt indignarono il generale Washington che difendeva l’assoluta neutralità degli Stati Uniti nel conflitto tra Francia e Spagna; quando il coinvolgimento del botanico emerse, egli venne a trovarsi in una situazione difficile. Da lontano, aveva seguito con trepidazione le vicende francesi, divenendo un ardente rivoluzionario. Eppure proprio la rivoluzione finì per rovinarlo. Con la ripresa della guerra, divenne sempre più difficile fare giungere i suoi invii in Francia. Il governo rivoluzionario cessò di pagargli lo stipendio e di rimborsargli le spese. Nel 1795, dopo un ultimo viaggio, si decise a tornare casa. In dieci anni, aveva inviato in patria 90 casse di semi e 60.000 pianticelle. Tra le piante da lui introdotte in Europa molte nuove specie di querce, aceri, noccioli, lo spettacolare Rhododendron catawbiense, Magnolia micahuxii (oggi M. tripetala), la sfolgorante Cladrastis lutea, che d’autunno si tinge d’oro. Durante il viaggio di ritorno, sulle coste olandesi fu vittima di un naufragio in cui perse tutti i suoi effetti personali ma riuscì a salvare gran parte delle collezioni. Tornato a Parigi, non riuscì a ottenere se non in minima parte il pagamento degli arretrati. Nel 1800, accompagnato dall’aiuto giardiniere Jean-François Cagnet, si imbarcò con la spedizione Baudin, ma non andava d’accordo con il comandante e non accettava le nuove direttive che imponevano di consegnare tutte le raccolte al governo; a Mauritius sbarcò, vi rimase un anno, poi, sulle orme di Commerson, andò in Madagascar. Anche qui creò subito un giardino d’acclimatazione, ma, dopo appena tre mesi morì di una febbre tropicale. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Prima di partire per l’ultimo viaggio era riuscito a scrivere una monografia sulle querce americane e soprattutto Flora boreali-americana , pubblicata postuma a cura del figlio François-André e di Louis-Claude Richard, con le illustrazioni di Redouté. Quest’opera, che descrive 1700 piante, 40 delle quali inedite, fu a lungo la più completa flora del nord America orientale. Dopo la sua morte, il governo francese inviò in America François André Michaux a liquidare i due vivai. Al suo rientro, egli scrisse Mémoire sur la naturalisation des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale. Nel 1806, incaricato di individuare le specie arboree più adatte all'acclimatazione in Francia, ripartì per Charleston, ma durante la traversata fu catturato da una nave inglese e imprigionato alle Bermuda: una prigionia per modo di dire, che gli permise di esplorare la flora dell'isola St George. Tornato in patria, pubblicò l'importante Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale. Vero continuatore dell'opera paterna, visse fino a tarda età e per un trentennio fu l'amministratore della Société centrale d’agriculture per la quale creò l'arboretum di Harcourt, ricchissimo di specie americane.  Campanelle levantine Numerose sono le specie che in ricordo di André Michaux portano l’eponimo michauxii: tra gli alberi, che erano i suoi preferiti, Quercus michauxii, Betula michauxii oppure Pyrus michauxii; ma ci sono anche arbusti, come il raro sommacco nano Rhus michauxii, bulbose come Lilium michauxii o erbacee come la piccolissima Minuartia michauxii. Il genere Michauxia gli fu dedicato nel 1788 da un altro botanico francese, Charles Louis L'Héritier de Brutelle. Appartenente alla famiglia Campanulaceae, comprende sette specie di piante erbacee diffuse dal Mediterraneo orientale al Caucaso e all’Iran; la più nota è proprio la specie riportata da Michaux dal suo viaggio in Persia, M. campanuloides, un’alta erbacea annuale o perenne di breve vita con curiosi fiori bianchi a campana rovesciata con petali retroflessi e stilo verdastro protruso. Simile è M. tchihatchewii, che conquista la palma di una delle più impronunciabili tra le denominazioni botaniche. Tutto per la colpa della trascrizione francese del nome russo Čjačev (forse un diplomatico che operava nella Francia dell'Ottocento). Altre informazioni nella scheda. Quando scoprì la vocazione di naturalista, Ynés Mexía aveva superato la cinquantina, e usciva da un decennio di depressione e instabilità emotiva. Grazie alle piante, ritrovò l'amore per la vita e divenne una raccoglitrice formidabile. Nel breve arco di tredici anni - tanto durò la sua carriera - percorse le America dall'Alaska alla Terra del fuoco, raccolse oltre 145.000 esemplari, scoprì 500 nuove specie e un nuovo genere (che le è stato dedicato con il nome Mexianthus); coraggiosa, tenace, caparbia, preferiva mete non battute, viaggiando per lo più da sola in modo spartano. A chi dubitava che una donna potesse farlo, nell'America latina di quasi un secolo fa, rispondeva semplicemente "Perché no?" 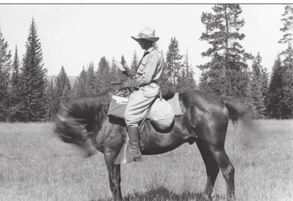 Dare senso alla vita raccogliendo piante La vita può ricominciare anche a cinquant'anni, quanti ne aveva Ynés Mexía quando scoprì la sua vera vocazione. Nata negli Stati Uniti da un diplomatico messicano e una statunitense, aveva avuto una vita abbastanza complicata a cavallo tra i due paesi. In crisi per la separazione dal secondo marito, che prima del divorzio l'aveva anche rovinata economicamente, si era trasferita a San Francisco. Per un decennio, fu afflitta da una grave forma di depressione. Quando aveva quasi cinquant'anni, decise di iscriversi al Sierra Club e, partecipando ad escursioni all'aria aperta insieme a persone innamorate della natura, incominciò a recuperare la salute del corpo e dello spirito. La natura californiana l'affascinò tanto che nel 1921, a cinquantun anni, decise di iscriversi al corso di Scienze naturali all'Università di Berkeley. Nel 1922, partecipando a una spedizione paleontologica, scoprì il fascino delle piante e della loro raccolta; si iscrisse a un corso sulle piante da fiore presso la Hopkins Marine Station e prese parte alle escursioni organizzate dal Calipso Club, il club degli studenti di botanica. Sicuramente determinante fu l'incoraggiamento di Alice Eastwood, curatrice dell'erbario dell'Accademia della Scienze californiana e capo del dipartimento di botanica, che le insegnò come raccogliere e preparare gli esemplari. La prima spedizione ufficiale arrivò nel luglio 1925; Mexía, che quell'anno compiva 55 anni, si unì a un viaggio botanico nello stato di Sinaloa in Messico organizzato dall'Università di Stanford e guidato da un'altra botanica, Roxanna Ferris. Come oriunda messicana, conosceva bene la lingua e il paese, ma soprattutto rivelò un vero talento come raccoglitrice: aveva un occhio acuto nel riconoscere le piante ed era molto meticolosa e abile nel preparare gli esemplari. Ne aveva già raccolti più di 500, quando cadde da una scogliera, ferendosi una mano e fratturandosi alcune costole. Dovette forzatamente abbandonare la spedizione, ma al suo ritorno negli Stati Uniti, impressionato dalla qualità delle sue raccolte, il capo dell'erbario dell'Università della California le commissionò un secondo viaggio, di nuovo in Messico. Strinse anche amicizia con un'assistente dell'Erbario dell'Accademia delle Scienze della California, Nina Floy Bracelin, che si offrì di aiutarla a catalogare le future raccolte. A questo punto, Ynés Mexía era ormai una raccoglitrice professionista, con un lavoro che dava senso alla sua vita: "Ho un lavoro che produce qualcosa, e qualcosa di duraturo". Nel settembre 1926 si imbarcò alla volta di Mazatlan sulla costa pacifica del Messico, da dove iniziò una spedizione di sei mesi in zone dell'interno poco conosciute; viaggiava sola, servendosi di guide locali, che erano anche ottimi informatori. Muovendosi ora a piedi ora a cavallo, alla fine del viaggio, nell'aprile 1927, aveva raccolto oltre 3000 esemplari, tra cui 50 specie non ancora descritte, e un genere sconosciuto, che in suo onore sarà denominato Mexianthus. Mexía, che non amava il lavoro di scrivania e definiva se stessa più un'avventuriera che una botanica, affidò la "post produzione" a Nina Floy Bracelin, che riordinava le collezioni, etichettava gli esemplari e li inviava ad esperti per l'identificazione; in tal modo divenne anche la sua agente e mantenne i rapporti con una vasta rete di botanici. Nell'estate del 1928, sempre per l'Università della California, si spostò in Alasaka, nel Mount Mc Kinley Park, dove raccolse oltre 6000 esemplari. Alla fine dello stesso anno, fu in Messico per la terza volta. Nell'autunno del 1929, si imbarcò per il Brasile, dove esplorò le terre alte per circa un anno e mezzo; per qualche tempo, si accompagnò con un'altra botanica autodidatta come lei, Mary Agnes Chase, un'esperta di graminacee; ma tutte e due erano troppo testarde per andare d'accordo, tanto più che Mary Agnes preferiva viaggiare in treno e dormire in un albergo decente, mentre Ynés era a suo agio viaggiando a cavallo e dormendo sotto una tenda. Ancora il Brasile fu la meta della spedizione del 1931, quella più celebre; l'obiettivo era risalire il corso del Rio delle Amazzoni. La prima parte della navigazione si svolse a bordo di un comodo piroscafo, un vero lusso rispetto alle abitudini di questa viaggiatrice spartana. Dopo 24 giorni, Mexía sbarcò a Iquitos in Perù, assunse tre guide e quattro rematori, per risalire il Maranon in canoa: era esattamente il percorso fatto da La Condamine nel Settecento, ma al contrario: non lasciarsi trasportare dalla corrente del grande fiume, ma risalirlo remando controcorrente: una scelta audace perfettamente in linea con il carattere di Ynès. Dopo aver superato il temibile Pongo de Manseriche , all'inizio della stagione delle piogge Mexía stabilì la sua base a Rio Santiago; esplorò il fiume e i suoi affluenti, scalò la Sierra del Pongo, senza farsi spaventare dalle pareti a strapiombo. E ovviamente, raccolse piante su piante. L'ingrossamento delle acque rendeva impossibile affrontare il viaggio di ritorno in canoa; Mexía convinse i rematori a costruire una grande zattera di legno di balsa. A bordo di questa imbarcazione scese il fiume fino a Iquitos, da dove spedì le raccolte in California. Lei prese un'altra strada: prima in aereo, poi a dorso di mulo, quindi in automobile, infine in treno, arrivò a Lima dove si imbarcò per San Francisco; era di ritorno nel marzo 1932. Questa spedizione, probabilmente la più importante tra quelle intraprese dall'indomita raccoglitrice, fruttò 65.000 esemplari. Non rimase a casa a lungo. Nel 1933 si accontentò di una breve spedizione casalinga in Nevada, Utah, Arizona e California con Alice Eastwood e il suo assistente, John Thomas Howell, a bordo di una Ford T. Tuttavia già nel 1934 tornò in Sud America per incarico dell'Ufficio per le piante industriali del Dipartimento di Agricoltura che aveva stabilito una stazione sperimentale in Ecuador; il suo compito era raccogliere le diverse specie di Cinchona e soprattutto cercare una rara palma della cera, Ceroxylum ventricusum, che vive a oltre 3000 metri d'altitudine nelle foreste pluviali d'altura tra Colombia e Ecuador. Con un assistente viaggiò in treno da Quito a Ibarra, poi in automobile fino a Tulcàn, dove assunse una guida locale e affittò dei cavalli per risalire le pendici del Chiles, un vulcano al confine tra i due paesi, dove era stata segnalata la pianta. La pioggia incessante li costrinse ad accamparsi in una torbiera, creando una tenda improvvisata con vestiti e bagagli; nel cuore della notte, furono risvegliati da un terremoto. Come se non bastasse, Ynés rischiò di morire per aver ingerito alcune bacche avvelenate. Per fortuna, uno degli accompagnatori riuscì a fargliele rigettare solleticandole la gola con una piuma di gallina. Tutti ormai volevano tornare indietro, tranne l'ostinata cacciatrice di piante, che convinse gli altri a continuare. E alla fine, trovò la sospirata palma. Il suo viaggio proseguì poi attraverso il Perù, la Bolivia, l'Argentina, il Cile fino allo Stretto di Magellano, con la raccolta di altri 15.000 esemplari. Nel 1938, l'ultima spedizione, di nuovo in Messico, questa volta negli Stati di Guerrero e Oaxaca. Ynés, che probabilmente era malata da tempo senza saperlo, incominciò a soffrire di dolori allo stomaco, che la costrinsero riluttante a rientrare negli Stati Uniti, dove le diagnosticarono un cancro ai polmoni; morì appena un mese dopo. Del resto, lei che nelle sue spedizioni preferiva dormire all'aperto anche quando era disponibile una sistemazione più comoda, non si sarebbe rassegnata a una lunga degenza in un ospedale. Nel suo testamento, lasciò un lascito all'Accademia delle Scienze, in modo che la fedele Nina fosse assunta come assistente di Alice Eastwood. Ynés Mexía fu sicuramente il più importante raccoglitore della flora sudamericana della sua epoca. Un risultato tanto più straordinario se si pensa che la sua carriera durò solo tredici anni, dal 1925 al 1938. Percorrendo il continente dall'Alaska alla Terra del fuoco, raccolse oltre 145,000 esemplari, incluse 500 nuove specie, 50 delle quali portano il suo nome. Anche se non si laureò mai, era spesso invitata a parlare dei suoi viaggi, di cui pubblicò resoconti in varie riviste, e il suo nome divenne molto conosciuto tra i botanici. Occasionalmente partecipò a spedizioni di gruppo, ma, come abbiamo già visto, preferiva viaggiare da sola (cosa inaudita per una donna a quei tempi), come spiegò essa stessa: "Un ben noto raccoglitore e esploratore ha asserito che era impossibile per una donna viaggiare da sola nell'America Latina. Io ho deciso che se volevo conoscere meglio il continente sud-americano il modo migliore era aprirmi la strada da me. Bene, perché no?". Una sintesi della sua vita avventurosa nella sezione biografie.  A caccia di piante rare: Mexianthus mexicanus Buona parte delle piante scoperte da Ynés Mexía sono rari endemismi, spesso minacciati. Del resto, come abbiamo visto, preferiva andarle a scovare in territori difficili da raggiungere, ancora inesplorati o almeno poco battuti. Non fa eccezione Mexianthus, il genere che raccolse nella sua prima spedizione solitaria, nel 1925, e che le fu dedicato nel 1928 da Benjamin Lincoln Robinson dell'Erbario di Harvard, con la seguente motivazione: "E' un piacere dedicare questa notevole pianta alla sua scopritrice, la sig.a Ynes Mexia, la cui coraggiosa esplorazione di parti poco note della Sierra Madre ha portato alla luce molte piante sconosciute alla scienza o altrimenti di speciale interesse". Nella flora messicana, che conta ben 30.000 specie, il dieci per cento è costituito da Asteraceae, con circa 3000 specie e ben 1300 endemismi. Tra di essi anche il raro Mexianthus mexicanus, l'unica specie di questo genere endemico dello stato di Jalisco, dove è stato raccolto solo in tre stazioni nei pressi di Puerto Villarta, a circa 500 metri d'altitudine, dove vive su substrato vulcanico nelle foreste subtropicali decidue. Purtroppo in rete sono disponibili solo fotografie di esemplari d'erbario. E' un'alta perenne suffruticosa, con foglie alternate da ovate a ellittiche, con punta acuminata e margini dentati. A renderla speciale sono le infiorescenze, con capolini con un singolo flosculo e corolla bianca, riuniti in sinfiorescenze globose, a loro volta portate in un'infiorescenza secondaria terminale a spiga sparsa. I frutti sono acheni con pappi scagliosi. Una breve presentazione nella scheda. Quando approdarono in Europa a inizio Ottocento, alle orchidee esotiche non mancava nulla per accendere i cuori: erano bellissime, erano rare, si ammantavano di mistero, ed erano pure molto costose, il che alimentava un certo snobismo. Fu così che la fioritura di quella che di lì a poco sarebbe stata battezzata Cattleya labiata segnò l'inizio di una passione collettiva: l'orchidelirium, ovvero il delirio per le orchidee. Nacque persino una nuova professione: quella dei cacciatori di orchidee, inviati a cercarle ai quattro angoli del mondo da ricchi privati o da aziende intraprendenti. Alle aste, le più nuove e le più rare raggiungevano prezzi da capogiro. Per settant'anni la più ambita e ricercata continuò ad essere Cattleya labiata. Fino a fine secolo, molte spedizioni andarono a cercarla a casa sua in Brasile, ma sempre senza esito. Niente di strano che la sua storia sia stata trasformata in leggenda, anzi quasi in una fiaba, con lei, la regina delle orchidee, nelle vesti di Cenerentola e lui, William Cattley, nelle vesti di principe azzurro. Quasi spiace ammettere che la realtà sia molto più prosaica.  Un'imbottitura a sorpresa... o forse no Come tutte le leggende, anche la storia dell'arrivo in Europa e della prima fioritura di Cattleya labiata è stata raccontata in diverse versioni. La più comune vuole che il giovane naturalista John William Swainson (1789-1855) nel 1818 abbia spedito in patria dal Brasile un pacco di piante contenente rari licheni (o felci, secondo un'altra versione); per preservarli nel lungo viaggio, come imbottitura usò una liana o pianta parassita che credeva senza valore. Il destinatario dell'invio era il mercante William Cattley, grande appassionato di piante esotiche che coltivava nella sua serra di Barnet, alla periferia londinese. Aprendo il pacco, in mezzo a quell'ammasso di materiale secco, egli individuò quello che riconobbe come uno pseudobulbo di orchidea; doverosamente coltivato, prosperò e giunse a fioritura, producendo bellissimi fiori lilla, i più belli che mai si fossero visti. Arrivata nelle vesti dimesse di Cenerentola, la sconosciuta si era rivelata una splendida principessa, anzi la regina delle orchidee. Nel 1821, il futuro padre dell'orchidologia John Lindley (1799-1865) la descrisse e la pubblicò con il nome di Cattleya labiata in onore del suo "salvatore". Mi spiace deludervi, ma le cose non sono affatto andate così. Insieme a molte altre piante, tra cui un Oncidium barbatum (oggi Gomesa barbata), la nostra pseudo Cenerentola venne inviata da Swainson non a Cattley, ma a William Jackson Hooker, che all'epoca insegnava botanica all'Università di Glasgow. Swainson l'aveva vista in fioritura e sapeva perfettamente di quale meraviglia si trattasse; appena arrivata, fu trattata con tutte le cure del caso e in quello stesso anno, come riferisce Hooker nel terzo volume di Exotic flora (1827), fiorì nella serra del suo giardino di Halesworth nel Suffolk; Hooker affidò uno o più pseudobulbi all'amico Cattley, noto come infallibile pollice verde, che in effetti riuscì a portarla a fioritura nel novembre 1820; riprodotta per divisione, infine nel 1824 fiorì della serra dell'orto botanico di Glasgow. Benché avessero tutti la stessa origine, la pianta di Cattley emanava un delicato profumo, assente nelle altre. In ogni caso, tanto Lindley quanto Hooker ne erano entusiasti: per il primo era "senza eccezione, la più bella specie del suo ordine che io abbia visto dal vivo", per il secondo "la più splendida, forse, di tutte le orchidacee". Dunque, nella nostra fiaba mancata non c'è né Cenerentola, né principe azzurro: Cattley non salvò la misconosciuta pianta, che non fiorì per la prima volta a casa sua; molto più prosaicamente, era il finanziatore di Collectanea botanica (1821-26), la pubblicazione in cui Lindley la descrisse, dedicandogliela con queste parole: "ho avuto grande piacere a pubblicarla, perché mi ha dato l'opportunità di offrire un omaggio a un gentiluomo il cui ardore nel collezionare e il cui inarrivabile successo nel coltivare la difficile tribù di piante cui appartiene lo rendono da tempo la persona più adatta a questo omaggio". 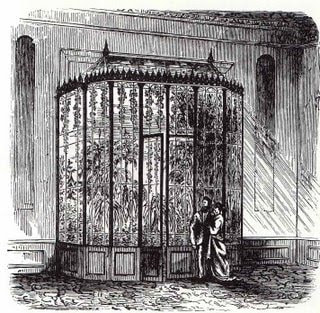 Un collezionista di piante esotiche E' dunque ora di sapere qualcosa di più su di lui. Cattley apparteneva a una grande famiglia di commercianti, con interessi soprattutto in Russia, da dove importava granaglie. Negli anni turbolenti delle guerre napoleoniche, i suoi affari avevano prosperato, permettendogli di dedicare tempo e denaro alla sua grande passione: le piante esotiche. Divenne un collezionista piuttosto noto, il cui nome ricorre in pubblicazioni dell'epoca come Curtis's Botanical Magazine o Edward's Botanical Register, relativamente all'introduzione di nuove specie, che a quanto pare riusciva a far prosperare nella serra della sua casa di Barnet, a nord di Londra. Era membro della Linnean Society e della Horticultural Society, che nel novembre 1820 lo premiò con una medaglia d'argento per la sua abilità nel coltivare le piante esotiche, in particolare per essere riuscito a far fruttificare una nuova specie di guaiava che venne denominata in suo onore Psidium cattleyanum. Anche se le orchidee non erano la sua passione esclusiva, dovettero essere una parte importante della sua collezione: in un'epoca in cui le serre inglesi, secondo le parole dello stesso Hooker, erano la tomba delle orchidee e nulla si sapeva della loro riproduzione e molto poco della loro coltivazione, era uno dei pochi che riusciva a coltivarle con successo. A nostri occhi, il suo merito maggior è di essere stato il mecenate di John Lindley, all'epoca ancora giovanissimo. Poco più che adolescente, il promettente botanico aveva conosciuto Hooker che lo aveva raccomandato a Banks, il quale lo aveva assunto come assistente per il suo erbario. Nel 1820, alla morte di Banks, sempre Hooker - che conosceva bene Cattley perché entrambi erano membri delle stesse società scientifiche nonché accaniti collezionisti che si scambiavano esemplari - gli suggerì di assumere Lindley per riordinare e disegnare le sue collezioni. Per circa un anno, Lindley fu stipendiato da Cattley, che finanziò la pubblicazione di Digitalium Monographia, una monografia sul genere Digitalis illustrata da Bauer, e soprattutto Collectanea Botanica. Contrariamente a quanto si legge in molte fonti anche autorevoli, quest'ultima non è un catalogo delle collezioni di Cattley, ma una rassegna di piante rare coltivate tanto da lui quanto da altri; quelle coltivate a Barnet sono solo 8 su 41. Circa un quarto delle piante trattate sono orchidee (tra di loro la nostra Cattleya labiata); fu proprio grazie a Cattley, alla sua collezione e a questo lavoro che Lindley scoprì il fascino di questa famiglia di piante, cui avrebbe dedicato tutta la vita, divenendo il padre dell'orchidologia. Tuttavia dopo poco più di un anno di collaborazione, la ditta di Cattley ebbe un rovescio di fortuna. Il mercante non poté più finanziare Lindley, e la pubblicazione di Collectanea Botanica venne interrotta; Lindely dovette ridimensionare il progetto e pubblicare gli ultimi fascicoli a sue spese con una notevole dilazione, E' per questa ragione che il fascicolo 7, dove si trova la descrizione di C. labiata, anche se è datato 1821, in realtà fu stampato presumibilmente nel 1824. Quanto a Cattley, sebbene con mezzi ridotti, continuò a curare la sua collezione, visto che il suo nome continua a comparire nei periodici dell'epoca, dove è definito "il più ardente collezionista di piante rare dei nostri giorni". Morì a Londra nel 1835. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Alla ricerca dell'orchidea perduta Nel frattempo, la fioritura di C. labiata aveva destato grande sensazione. Non era certo la prima orchidea esotica a fiorire in Europa (come ho raccontato in questo post, la prima era stata Brasavola nodosa nel 1698), ma non si era mai visto un fiore così appariscente, così raffinato, così esotico, con sepali e petali di un delicatissimo lilla e un grande labello sfrangiato porpora, con la gola giallo profondo. E fu subito orchidelirum, come venne chiamata l'ossessione per le orchidee che travolse l'Inghilterra vittoriana. Vennero organizzate costose e difficili spedizioni nei paesi tropicali (soprattutto in Sud America e nel sudest asiatico) per procurarsi sempre nuove specie. Nacquero ditte specializzate e una nuova professione, quella di cacciatore di orchidee. Alle aste che venivano organizzate a Londra al loro ritorno, quelle più rare raggiungevano prezzi da capogiro, come le 80 ghinee (equivalenti a circa 9000 euro) sborsate da Sigismund Rucker negli anni '40 per una Barkeria spectabilis. Le più ambite erano ovviamente quelle più rare e più difficili da trovare. Ovviamente, in testa alla lista c'era Cattleya labiata, la cui ricerca in natura deluse le aspettative per ben 70 anni. Swainson non aveva rivelato dove l'avesse raccolta e la leggenda fiorita sul suo invio contribuì a confondere i ricercatori. Poiché egli aveva fatto base a Rio, si pensò provenisse da quell'area, dove per anni i cacciatori di orchidee andarono a cercarla senza successo (in realtà, Swainson l'aveva raccolta nel Pernambuco). Nel 1846, destò dunque grande sensazione la pubblicazione di Travels in the Interior of Brazil del chirurgo e naturalista George Gardner (1812-1849) in cui raccontava come l'avesse ritrovata nel 1836 sulle rocce a precipizio sul mare della Pedra de Gavea, a una quindicina di miglia da Rio. Gardener si sbagliava: esaminando i suoi campioni, l'ormai autorevolissimo Lindley decretò che non si trattava di C. labiata, ma di un'altra specie che denominò C. lobata. Nel suo Flower Garden, Joseph Paxton (famoso sopratutto come creatore del Crystal Palace) riprese la notizia, accompagnandola con la versione più nota, potremmo dire ormai ufficiale, del famoso invio di C. labiata come imbottitura. Inutile dire che diverse spedizioni batterono le montagne della foresta di Tujica alla ricerca dell'orchidea perduta, inondando il mercato europeo di centinaia di nuove specie, ma senza mai ritrovarla. Gardner pensò di aver fatto centro durante un secondo viaggio in Brasile, quando credette di averla ritrovata sulle rive del fiume Parabaya, al confine tra gli Stati di Rio e Minas Gerais. Si sbagliava di nuovo: si trattava di C. warneri. Di conseguenza diverse spedizioni setacciarono la regione; inutilmente, tanto che qualche botanico incominciò a pensare che C. labiata fosse ormai estinta in natura. Finalmente, la notizia del ritrovamento, questa volta vero, arrivò nel 1889. E, vero schiaffo all'orgoglio nazionale britannico, il merito andava ai francesi. Monsieur Moreau, un entomologo parigino, aveva finanziato una spedizione entomologica nel Brasile centrale e settentrionale; sapendo che era anche collezionista di orchidee, i raccoglitori gli inviarono anche una cinquantina di piante di un'orchidea dai grandi fiori lavanda raccolte nel Pernambuco. A questo punto, storia e leggenda tornano a mescolarsi: si racconta che, per un'incredibile coincidenza, Frederick Sander (1847-1920), ovvero il re delle orchidee, a capo del vivaio specializzato più importante d'Europa, facesse visita a Moreau proprio mentre le piante iniziavano a fiorire: gli bastò un'occhiata per capire che si trattava della perduta C. labiata. Il francese non ebbe problemi a rivelargli dove era stata raccolta, e Sanders poté inviare i suoi cacciatori a raccoglierla a colpo sicuro. Già nel 1892 fu in grado di immettere sul mercato ben 25.000 esemplari. Ma non manca una versione più romantica, secondo la quale l'orchidea perduta fu ritrovata sempre a Parigi, ma durante una serata mondana, appuntata alla scollatura di una dama.  E infine, Cattleya! Nell'Ottocento, mentre sempre nuovi generi e specie di orchidee si riversavano come un fiume in piena nell'avido mercato europeo, Cattleya mantenne il suo primato di regina delle orchidee. Era il genere più amato, più ricercato, apprezzato soprattutto come fiore reciso per comporre lussuosi bouquet e per ornare scollature. A ostentare una Cattleya non era solo la misteriosa (e presumibilmente inesistente) dama parigina della leggenda, ma anche Odette, la bella demi-mondaine amata da Swann nella Recherche di Proust; il gesto di Swann, che si offre di sistemarle il fiore appuntato sul petto, diventa il preludio al loro primo rapporto sessuale: da quel momento i due amanti lo chiameranno eufemisticamente faire Cattleya, "fare Cattleya". Le circa centoventi specie del genere Cattleya sono orchidee epifite, o più raramente terrestri, originarie delle foreste pluviali dell'America latina, dalla Costa Rica al Brasile. I fiori, raccolti in infiorescenze terminali, hanno sepali e petali liberi; il petalo inferiore è modificato a formare un labello sfrangiato, solitamente di colore contrastante. Sono orchidee simpodiali, con pseudobulbi alla cui estremità si sviluppano una o due foglie. Proprio in base a questa caratteristica, vengono divise in due grandi gruppi: monofoliate e bifoliate. Le prime sono le Cattleyae classiche, piante robuste a forte sviluppo con grandi fiori; le seconde hanno fiori più piccoli, ma spesso forme e colori affascinanti. In coltivazione sono state introdotte almeno una cinquantina di specie, senza contare i numerosissimi ibridi. Il primo si deve a un altro grande collezionista, John Dominy, che nel 1853 incrociò C. loddigesii e C. guttata. Da allora ne sono stati prodotti centinaia e centinaia. Come se non bastasse, Cattleya forma ibridi intergenerici (nothogenera) con altri generi del vasto gruppo di orchidee neotropicali detto Cattleya alliance: i più noti sono Brassavola, Encyclia, Epidendrum, Laelia, Rhyncholaelia, con i quali forma rispettivamente x Brassocattleya, x Catyclia, x Epicattleya, x Laeliocattleya, x Rhyncolaeliocattleya. Tra gli ibridi che coinvolgono tre generi il più noto è senza dubbio Brassolaeliocattleya (Brassavola x Laelia x Cattleya), ma non mancano ibridi ancora più complessi che ne coinvolgono da quattro in su, come Andersonara (Brassavola x Cattleya x Guarianthe x Laelia x Ryncholaelia). Un tempo la coltivazione degli ibridi era rivolta soprattutto al mercato dei fiori recisi, oggi meno importante a favore della vendita come pianta fiorita. Tuttavia Cattleya mantiene un ruolo di una certa importanza anche come fiore reciso grazie alle fioriture indipendenti dalla stagione. Infatti sono piante brevidiurne, che tendono a fiorire quando le giornate si accorciano. Diminuendo artificialmente le ore di luce, possono dunque essere indotte a fiorire in ogni momento dell'anno. Nella scheda notizie sulla classificazione di Cattleya, link selezionati e una selezione di specie notevoli. Approfittando di una breve periodo di pace durante le guerre napoleoniche e della sua amicizia con David Lance, direttore della factory britannica di Canton, Banks decise di inviare nel porto cinese un giardiniere, che soggiornandovi qualche anno, oltre ad inviare in patria le piante più desiderabili, potesse studiare le avanzate tecniche orticole del paese di mezzo. La sua scelta cadde su William Kerr, giovane e abile giardiniere di origine scozzese. Kerr rimase a Canton per otto anni, per poi essere nominato curatore dell'orto botanico di Colombo, nell'isola di Ceylon, dove sarebbe morto poco dopo; se la sua impresa sia stata un successo o meno, è motivo di discussione. Alcune fonti lo dipingono come un instancabile procacciatore di piante, cui si dovrebbe l'introduzione in Europa di 238 nuove specie. La sua morte in giovane età sarebbe dovuta a una di quelle malattie che tanto spesso decimarono gli europei nei paesi tropicali. Secondo John Livingstone, chirurgo della factory, che lo conobbe molto bene, la realtà sarebbe un po' meno rosea. Entusiasta e attivo nei primi tre o quattro anni, poi in seguito ad alcune "cattive abitudini", sarebbe diventato via via sempre più abulico, fino ad essere incapace di assolvere i suoi compiti. Per quanto Livingstone non lo dica in modo esplicito, gli studiosi ne hanno dedotto che Kerr fosse diventato oppiomane (e questa sarebbe anche la causa della sua morte). D'altra parte, i cataloghi di Kew ridimensionano di molto la quantità delle sue introduzioni; tuttavia si tratta quasi sempre di specie molto importanti, di secolare coltivazione in Cina, che egli si era procurato presso i vivai locali. Tra le altre, anche l'arbusto che porta il suo nome, Kerria japonica, di cui introdusse in Europa la forma a fiore doppio.  A caccia di piante nei vivai cinesi Nel 1802 venne firmata la pace di Amiens tra Francia e Gran Bretagna; Joseph Banks, che dieci anni prima aveva dovuto registrare il fallimento dell'ambasciata Macartney, pensò che fosse giunto il momento di tentare un'altra strada per arricchire Kew di piante cinesi. Ogni tanto qualcuna arrivava grazie ai capitani e agli equipaggi delle navi della Compagnia Britannica delle Indie Orientali (British East India Company) che ogni anno facevano il lungo viaggio dal porto di Canton - l'unico aperto pur con molti limiti agli occidentali - ma egli sperava in risultati più eclatanti. Tanto più che il capo dell'emporio inglese (british factory) era un amico, David Lance. L'idea era di inviare a Canton uno dei giardinieri di Kew che, risiedendo sul posto per un periodo relativamente lungo, avrebbe potuto non solo procurarsi le piante più desiderabili (e desiderate), ma anche apprendere le tecniche orticole dei Cinesi, universalmente considerati maestri dell'agricoltura intensiva. Per la delicata missione Banks scelse un giovane giardiniere scozzese, William Kerr, che aveva potuto appezzare per la sua competenza, la sua passione e, cosa non secondaria, la robustezza fisica. Nell'aprile 1803, nell'atto di comunicargli la nomina a Giardiniere reale, nelle sue istruzioni gli raccomandò diligenza, sobrietà, frugalità, facendogli balenare la prospettiva di migliorare di molto il suo destino, se avesse ben meritato. Seguiva una lista minuziosa di richieste: avrebbe dovuto osservare il modo in cui i cinesi coltivano i frutti utili; scoprire il loro metodo per trarre concime dagli escrementi umani; studiare le modalità cinesi per fabbricare corde, le migliori del mondo; apprendere le tecniche per mantenere le piante nane (ovvero coltivare bonsai). Suo compito principale, ovviamente, era arricchire i giardini reali di piante "belle, curiose e utili", con particolare riguardo a quelle del nord della Cina che supponeva più adatte al clima inglese. Banks era ben consapevole che il suo giardiniere non avrebbe avuto libertà di movimento, anzi gli consigliava grande prudenza, vista la sospettosità dei cinesi; era tuttavia convinto che egli avrebbe comunque potuto procurarsi piante interessanti nei mercati e nei vivai aperti agli stranieri. Gli raccomandava, se possibile, di farsi assegnare un giardino, dove propagare le piante e prepararle per gli invii annuali, nel maggior numero possibile e pronte per affrontare il lungo e difficile viaggio in vasi e cassette appositamente allestiti. Seguiva poi una lunga e dettagliata lista di piante più o meno desiderabili, tanto per la loro utilità quanto per la loro bellezza, contrassegnate da un numero crescente di asterischi (da uno a cinque). Kerr dovette partire poco dopo, visto che era a Canton (o, se preferite, Guangzhou) all'inizio del 1804. John Livingstone, chirurgo nella factory britannica (uno dei tredici empori concessi agli europei) che fece il viaggio con lui lo descrive come un giovane entusiasta, un giardiniere e un botanico molto preparato, di notevole vigore fisico, tanto da affrontare scalate sotto il sole a picco, come dimostrò a Macao, l'ultima sosta prima entrare nel Fiume delle perle e unico territorio cinese dove fosse possibile studiare e raccogliere piante in natura, visto che gli stranieri non potevano muoversi liberamente al di fuori della piccola enclave costituita dagli empori. Arrivato in Cina, Kerr si mise subito al lavoro con solerzia, procurandosi piante nei mercati e nei bellissimi vivai che sorgevano sull'altra riva del fiume, a due o tre miglia dalla concessione. Aperti agli stranieri, anzi largamente pensati per soddisfare le loro esigenze, questi vivai di Canton, noti come Fa Tee, erano una delle meraviglie della città. Tra le numerose descrizioni che ce ne sono giunte, la più dettagliata si deve al famoso cacciatore di piante Robert Fortune, che li visitò negli anni '40: di piccole dimensioni, vi si vedevano centinaia e centinaia di piante in vaso, allineate su due file lungo sentieri pavimentati, scelte soprattutto tra quelle più vistose e apprezzate da cinesi e stranieri, come camelie, magnolie, peonie arboree; c'erano anche bonsai e fiori recisi, soprattutto per abbellire le chiatte e le case che sorgevano lungo il fiume durante le feste come il Capodanno. Un'altra possibile fonte di approvvigionamento erano i giardini privati dei grandi hong, i mercanti cinesi autorizzati a commerciare con gli europei; quelli più ricchi possedevano mirabili giardini, dove venivano coltivate piante difficilmente reperibili nei viavai. Sicuramente Kerr visitò quello di Pinkaqua II, cui, tramite Lance, Banks aveva fatto pervenire numerosi doni. Il mercante lo ricambiò con diversi oggetti di raffinato artigianato, un bonsai ultracentenario e alcune rare peonie moutan. A poche settimane dal suo arrivo in Cina, Kerr era già in grado di rispondere ad alcuni degli interrogativi di Banks e di predisporre un primo invio che partì già a febbraio a bordo della nave della compagnia delle Indie Henry Addington, dove era stata allestita una specie di serra viaggiante. Non fu un viaggio facile; infatti nel frattempo tra Francia e Inghilterra erano ricominciate le ostilità e le navi britanniche, che avevano fatto il viaggio di andata in tempo di pace ed erano prive di salvacondotti, il 14 febbraio, mentre incrociavano nel mar della Cina presso Pulo Aura, furono attaccate da un'imponente flotta francese e dovettero aprirsi la strada a cannonate. Dopo la lunga traversata, arrivarono ai Docks di Londra ad agosto; marinai e comandanti furono festeggiati come eroi nazionali e premiati con denaro e oggetti simbolici; quel che più conta per noi, molte piante "belle, interessanti e utili", come si sarebbe espresso Banks, andarono ad arricchire le aiuole di Kew. Ecco l'elenco (tra parentesi i nomi attuali): Gardenia spinosa (Catunaregam spinosa), Gardenia radicans (G. jasminoides), Pittosporum tobira, Lilium japonicum, Lililium tigrinum (L. lancifolium), Nandina domestica, Dianthus japonicus, Crataegus glabra (Photinia glabra), Aster hispidus, Sagittaria obtusifolia (Limnophyton obtusifolium), Begonia discolor (B. grandis subsp. grandis), Pinus lanceolata (Cunninghamia lanceolata), Juniperus chinensis, Taxus macrophylla (Podocarpus macrophyllus). Insieme a loro, viaggiarono le lettere di Kerr per Aiton e Banks (ho potuto consultare l'indice, ma non il testo), contenenti una lista delle piante inviate (che saranno state molto più numerose, se corrisponde al vero l'affermazione di Livingstone che solo una pianta su 100.000 aveva la speranza di arrivare viva in Inghilterra) e note sui bonsai, la fabbricazione di corde, il giardinaggio cinese e il giardino di Pinkaqua, il metodo per preparare il terriccio per la coltivazione in vaso, l'uso del letame. Un altro invio raggiunse l'Inghilterra l'anno successivo, a bordo della Winchelsea; per il 1805 gli invii registrati nel catalogo di Kew sono solo tre: Mussaenda pubescens, Nymphea pigmaea (N. tetragona), Corchorus japonicus (Kerria japonica). 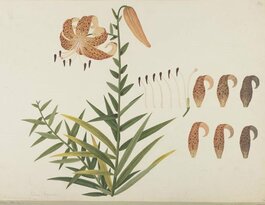 Un destino e una fine misteriosi Un invio tanto modesto sarà da imputare alle vicissitudini del viaggio per mare, ma altri segni ci dicono che qualcosa doveva cominciare a non funzionare. Sappiamo dal diario di viaggio di Kerr, l'unico conservato, che nel febbraio 1805 egli partì da Macao per l'isola di Luzon nelle Filippine, dove si trovò coinvolto in infinite discussioni con le autorità per avere il permesso di inviare in Inghilterra semi e piante vive; si trattenne nell'isola fino alla fine dell'estate, visitando varie località e raccogliendo diversi esemplari, di cui quasi nulla arrivò vivo in patria. Lo stesso anno dovette visitare anche Giava, ma non abbiamo informazioni precise in merito. Questo viaggio potrebbe essere indizio del crescente disagio della sua situazione a Canton, Secondo il dottor Linvingstone, che è la nostra principale fonte sul soggiorno cinese di Kerr, la sua posizione sociale fece di lui un disadattato. La rigida stratificazione in classi della società britannica del tempo vigeva anche nelle factories di Canton; da una parte c'erano i gentiluomini: gli impiegati di alto livello della Compagnia delle Indie, i mercanti accreditati, i capitani e gli ufficiali delle navi, i visitatori ricchi e altolocati; dall'altra c'era la bassa manovalanza di impiegati, nonché uno stuolo di servitori cinesi. Nonostante l'altisonante titolo di Giardiniere di sua Maestà britannica, Kerr era fuori posto con gli uni e con gli altri; inoltre il suo stipendio di 100 sterline annue, buono per un giardiniere in patria, era poca cosa in Cina, dove tutto era carissimo; non gli bastava neppure per rinnovare il guardaroba, tanto che per la sua estrema povertà cominciò ad essere guardato con disprezzo dai suoi stessi servitori cinesi. Sempre secondo Livingstone, dopo tre o quattro anni in cui si mostrò solerte e attivo, incominciò a cambiare carattere; era svogliato, procrastinava ogni cosa; avendo contratto "cattive abitudini estranee al suo carattere" cominciò a incorrere in frequenti cadute, riportando ferite e contusioni che lo rendevano inabile al lavoro per giorni. Qualche studioso ha pensato all'alcool, ma l'indiziato più accreditato è l'oppio. Questa tesi è stata abbracciata con entusiasmo dal romanziere Amitav Ghosh nel suo Il fiume dell'oppio, dove uno dei personaggi, il giardiniere cinese Ah Fey, si vanta di essere stato il fornitore di Kerr tanto per le piante quanto per l'oppio. Quello che è certo è che gli invii documentati dal catalogo di Kew si fanno sempre più magri: nel 1806, a bordo della Hope arrivano Gardenia macrantha (Euclinia longiflora) e Lonicera japonica e a bordo della Wilmer Caske Paederia foetens. Nel 1807, a bordo della Cuffnells è la volta diRosa banksiae, nella forma bianca a fiori doppi, e di una Camellia sasanqua; in date che non è possibile precisare, si aggiungono Cupressus pendula Thun. e Bletia hyacinthina (Bletilla striata). Oltre che in patria, Kerr dovette inviare qualche pianta anche al giardino botanico di Calcutta; sappiamo inoltre che fece eseguire da alcuni artisti cinesi delle illustrazioni di piante, che per qualche anno furono custodite nel Museo della Compagnia delle Indie. Secondo il Gardener Magazine, gli si devono inoltre l'introduzione di diverse varietà di crisantemi, di alcune peonie arboree e di Enkianthus quinqueflorus. Come si vede, siamo lontanissimi dalle 238 specie attribuitegli da molte fonti. Del resto, non risulta alcun invio dopo il 1807, anche se Kerr rimase a Canton fino al 1812. Nel 1810, per volontà di Banks, nell'Isola degli schiavi presso Colombo (Sri Lanka) era stato fondato un giardino botanico e quell'anno Kerr ne venne nominato primo soprintendente. Una decisione che può stupire, se davvero egli era divenuto oppiomane, abbandonando la vita di dedizione al lavoro e sobrietà tanto raccomandata da sir Joseph. Tuttavia è possibile che Banks, sempre molto corretto verso i suoi dipendenti e sollecito verso i suoi protetti, possa aver visto in questo incarico un modo per salvare Kerr, allontanandolo dalle cattive abitudini. Ma ormai era tardi. Il giardiniere morì a Ceylon già nel 1814, poco più di un anno dopo aver assunto l'incarico. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Per concludere, una piccola curiosità: una distilleria di Hawick, il paesino dei Borders scozzesi dove Kerr era nato in una data imprecisata, gli ha dedicato il William Kerr's Border Gin; inutile dire che l'azienda presenta Kerr come un eroe locale, raccoglitore instancabile che introdusse in Europa 238 piante, di cui si vuole celebrare "il coraggio e il senso di avventura, senza menzionare l'esploratore interiore che è in tutti noi".  Kerria, simbolo di primavera e di cadicità Quando ero bambina, nel giardino di mia nonna c'erano grandi cespugli dai fiori gialli che lei chiamava Corchorus. Solo più tardi ho scoperto che si trattava di Kerria japonica (quei cespugli ci sono ancora, e uno lo vedete nella fotografia qui accanto). Nel 1771, sulla base di un esemplare d'erbario, Linneo aveva attribuito questo arbusto di apparente origine giapponese, con fiori bianchi simili a quelle delle fragole, al genere Rubus con il nome R. japonicus. Nel 1784, Thunberg, sulla base di un esemplare d'erbario da lui raccolto in Giappone, presumibilmente mal conservato, lo ribattezzò Corchorus japonicus; una solenne cantonata, se si pensa che i veri Corchorus sono Malvaceae. A rimettere le cose a posto pensò de Candolle che nel 1817 in una comunicazione alla Linnean Society lo assegnò correttamente alla famiglia Rosaceae e lo attribuì a un genere proprio, Kerria, in onore di "William Kerr che, secondo la testimonianza di Robert Brown, ha introdotto in Europa dalla Cina un gran numero di piante, tra cui in particolare proprio quella di cui ci stiamo occupando". Per chissà quale strane ragioni, il vecchio sinonimo di Thunberg si è insinuato nei cataloghi dei vivai, dove a volte è ancora usato. Kerria japonica (L.) DC. è l'unica specie del genere Kerria. E' di origine cinese, ma deve essersi naturalizzata in Corea e in Giappone da tempi immemorabili. Nei giardini è comune soprattutto 'Pleniflora', la varietà a fiori doppi, simili a pon-pon dorati; di origine orticola, era coltivata da secoli in Cina quando Kerr la importò in Europa, avendola presumibilmente acquistata in un Fa-Tee. La forma selvatica ha invece cinque petali e arrivò in Europa qualche decennio più tardi. Meno vigorosa della sorella a fiori doppi, continua ad essere meno comune nei giardini, così come la forma con foglie variegate, 'Variegata' (detta anche 'Picta'). Ne esiste anche una forma con fiori bianchi, 'Alba'; è rara ed è improbabile che l'esemplare su cui lavorò Linneo vi appartenesse; più facilmente, come ipotizzò de Candolle, i fiori originariamente gialli si erano scoloriti seccando (del resto, i fiori di Kerria tendono a sbiadire al sole, motivo che consiglia di scegliere per loro una posizione un poco ombreggiata). In ogni caso, soprattutto nella forma doppia, continua ad essere uno degli arbusti più popolari nei giardini, anche perché è adattabile e capace di prosperare per decenni quasi senza cure. I fiori sono di un colore fin troppo sfacciato, accettabile tuttavia come solare araldo della primavera. Ha un ruolo importante nella cultura giapponese, che con il poetico nome di Yamabuki ("brezza di montagna") la celebra con liriche e dipinti e le ha assegnato connotazioni simboliche contraddittorie. Fiore della primavera dal colore dell'oro, associato dunque al rigoglio e alla ricchezza, è anche simbolo malinconico di caducità, di transitorietà: la sua ricchezza è soltanto un'illusione, poiché i suoi fiori non danno frutto (nella forma doppia è infatti sterile). Nella scheda qualche notizia in più su altre varietà. Subito dopo l'indipendenza, il più bel giardino d'America era Woodlands, alla periferia di Filadelfia, creato dal ricco proprietario terriero e collezionista d'arte William Hamilton che, a quanto pare, vi faceva coltivare circa 10.000 specie tra native ed esotiche. Jefferson, che ammirava Woodlands e lo considerava il solo giardino al di qua dell'Oceano a poter competere con quelli britannici, volle che nelle sue aiuole e nelle sue serre venisse coltivata e moltiplicata una parte delle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Il nostro protagonista, tuttavia, non è Hamilton (gli furono dedicati ben tre generi, ma nessuno oggi valido), bensì il sovrintendente di Woodlands, il giardiniere scozzese John Lyon, che, dopo qualche anno trascorso a lavorare qui, si trasformò in un infaticabile cacciatore di piante indipendente, al quale Aiton in Hortus Kewensis attribuisce l'introduzione in Europa di oltre trenta specie. Tra le più note oggi, Phlox paniculata e Pieris floribunda. Assai affine a Pieris è Lyonia (Ericaceae), il genere che ne preserva il ricordo.  Dalle aiuole alle montagne del Nord America Al ritorno da un viaggio in Europa, in gran parte dedicato a visitare parchi e giardini britannici, il facoltoso proprietario terriero e collezionista William Hamilton (1749-1813) decise di far ricostruire la casa padronale della tenuta di Woodlands, nei pressi di Filadelfia, secondo lo stile di Adam; anche il parco venne ridisegnato secondo i canoni del giardino paesaggistico d'oltre Oceano. In pochi anni, le collezioni di piante, native o fatte venire dall'Europa, dall'Asia e dal Sud Africa, giunsero a comprendere diecimila specie. Nel 1807 Jefferson, grande ammiratore di Hamilton (Woodlands sarà uno dei modelli di Monticello), chiese a McMahon, cui aveva affidato i semi raccolti durante la spedizione di Lewis e Clark, di dividerli equamente con lui, per aumentare le possibilità di riuscita, vista l'esperienza e i mezzi di Hamilton. Quest'ultimo, del resto, era già in relazione con i due esploratori, che nel 1804 gli avevano inviato da Fort Mandan alcune talee di Maclura pomifera (arancio degli Osagi). Sappiamo che Hamilton ricevette i semi di almeno 19 specie, che includevano diverse varietà di Ribes e il tabacco selvatico Nicotiana quadrivalvis. Un anno dopo, egli informava il presidente che non tutti i semi erano germogliati, mentre le piante di Maclura prosperavano. Dopo la morte di Hamilton, quella magnifica collezione andò rapidamente in rovina; una parte del parco fu venduta dagli eredi e intorno al 1840 molto di ciò che rimaneva venne trasformato in un cimitero rurale; è un luogo affascinante e caro ai cittadini di Filadelfia, ma certo molto diverso rispetto ai suoi anni d'oro. Molte informazioni sulla sua storia in questo sito. Ma il nostro protagonista non è Hamilton; certamente questo patrono dei giardini attirò l'attenzione dei botanici che gli dedicarono ben tre generi Hamiltonia: nel 1806 il conterraneo Muhlenberg, nel 1824 Roxburgh, nel 1838 Harvey; nessuno dei tre oggi è però valido. Dunque la nostra attenzione si sposta su una figura forse più interessante, e sicuramente più simpatica: il sovrintendente, o capo giardiniere, di Woodlands, lo scozzese John Lyon. Nulla sappiamo della sua vita prima che fosse assunto da Hamilton nel 1785; ignoriamo persino se si trovasse già in America, o se abbia incontrato il futuro datore di lavoro in patria. Ci mancano notizie anche sul primo decennio trascorso a lavorare a Woodlands; la nostra principale fonte informativa è infatti il suo diario di campo, che inizia nel 1799. E' probabile che in quei sedici anni egli già affiancasse alla cura del giardino - di cui fu evidentemente il principale realizzatore - escursioni nei dintorni, per incrementare le collezioni di piante native. Il primo viaggio documentato è proprio di quell'anno, quando Hamilton lo inviò sugli Allegheny della Pennsylvania alla ricerca di Pyrularia pubera, una pianta emiparassita con semi oleosi e tossici di potenziale interesse farmacologico, che il collezionista non era riuscito fino ad allora a far germinare. La spedizione si concluse con un nulla di fatto. E' possibile che già allora Lyon mordesse il freno; preparato, intelligente, industrioso e di spirito indipendente, incominciava a sentirsi soffocare al servizio di un uomo arrogante, esigente e imperioso, tanto più che la figura sociale del capo giardiniere in America non godeva della stessa considerazione sociale che forse aveva potuto sperimentare in patria. A partire dal 1802, e per i successivi dodici anni, non avrebbe mai cessato di viaggiare, dapprima per conto di Hamilton, poi in proprio. Erano viaggi faticosi e pieni di insidie, in zone spesso poco conosciute e non segnate sulle carte. Lyon si muoveva a cavallo, alloggiava talvolta all'aperto, ma più spesso in locande o presso case ospitali; portava con sé provviste minime, carta per gli esemplari pressati, mentre le collezioni di radici e semi andavano crescendo. Gli incidenti non mancarono: fu morso da un cane rabbioso e dovette curare da sé la ferita infetta cauterizzandola con un ferro rovente; si intossicò gravemente raccogliendo semi del velenoso Rhus michauxii; affrontò una bufera così forte da abbattere gli alberi; perse più volte il cavallo. Viaggiava per lo più da solo, ma spesso faceva tappa presso altri botanici o appassionati, che talvolta gli facevano da guida o lo accompagnavano per qualche tratto. I suoi viaggi, in tutto dieci, lo portarono ad esplorare buona parte degli Stati centrali e meridionali dell'America atlantica, in particolare, oltre alla Pennsylvania e alla Virginia, le due Caroline, la Georgia e la Florida settentrionale, con una predilezione per le montagne che fanno da confine tra North Carolina e Tennessee; solo un viaggio lo portò a Nord, verso i grandi laghi. Tra i luoghi ricorrenti, dove si fermava presso amici, cui spesso affidava le sue raccolte o preparava i materiali per le spedizioni, Silk Hope, in North Carolina, dove abitava l'amico Stephen Elliott, che fu anche suo compagno di viaggio in diverse occasioni; le città portuali di Savannah in Georgia e Charleston nella Carolina del Sud, da dove spediva per nave a Filadelfia le sue raccolte; Nashville e Asheville, rispettivamente in Tennessee e North Carolina, punto di partenza per l'esplorazione delle amate montagne; Lancaster, tappa obbligata sulla via del ritorno per visitare l'amico Henry Muhlenberg. Le spedizioni più ampie e importanti sono probabilmente quelle del 1803-1804 e del 1807. Durante la prima Lyon percorse 2250 miglia, giungendo fino in Florida e esplorando anche, oltre a diverse aree montane, buona parte della costa e delle isole della Georgia. Proprio durante questo viaggio, nel 1803, fu l'ultima persona a vedere in natura alcuni esemplari di Franklinia alatamaha (e potrebbe avere qualche responsabilità nella sua estinzione). Durante la seconda, percorse 2500 miglia, muovendosi lungo le montagne sui confini tra North Carolina e Tennessee (dove sarebbe tornato altre volte e sarebbe morto); tra i suoi ospiti, la colonia morava della Cherokee Country, e tra gli incontri notevoli, quelli con Moses Fisk, pioniere degli insediamenti nel Tennessee, e con il pastore e botanico Samuel Gottlieb Kramsch. Una narrazione più dettagliata dei suoi viaggi nella vita. 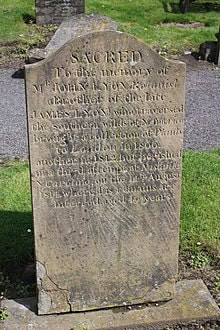 Collezioni di piante e spirito imprenditoriale Lyon è una figura interessante anche perché si distacca dagli altri cacciatori di piante per la sua indipendenza e intraprendenza. Mentre i suoi colleghi erano finanziati da sovrani, istituzioni pubbliche, mecenati oppure, sempre più spesso, lavoravano per qualche ditta commerciale, Lyon era un libero professionista che si assumeva le spese e i rischi e provvedeva da sé alla vendita delle sue raccolte. Probabilmente lasciò Hamilton (per il quale tornò a lavorare occasionalmente anche in seguito, ma solo come giardiniere) nella seconda metà del 1803; nel frattempo era stato sostituito con Frederick Pursh. Da quel momento, Lyon prese a creare una propria collezione, con l'obiettivo di commercializzarla in Inghilterra. In natura raccoglieva piante vive (in quantità che a noi fanno accapponare la pelle, come le 200 radici di Podophyllum di cui fece incetta nel 1804 in Georgia), ma ancora più semi; questi ultimi erano destinati alla vendita, ma anche alla riproduzione. In effetti, alla fine del 1804 il giardiniere avrebbe voluto imbarcarsi per l'Inghilterra, ma non trovando un imbarco si fermò a Filadelfia per quasi un anno, dedicato a seminare e curare le plantule da portare con sé in patria. A tal fine, si appoggiò al vivaista David Landreth (fondatore nel 1784 della più antica ditta sementiera statunitense), da cui affittò una parte del vivaio. Alla fine del 1805 Lyon poté finalmente imbarcarsi per Londra, via Dublino. Nella capitale inglese dimostrò ottime capacità imprenditoriali; per vendere le sue piante, si affidò non solo a una clientela privata, ma a un'asta pubblica, pubblicizzata con annunci su sette giornali e con la stampa di un catalogo, in cui le piante nuove (sp. nova!) sono ben evidenziate. Forte di questo successo, ritornò subito in America, dove investì i guadagni in nuovi viaggi, che si mossero principalmente lungo le predilette montagne tra North Carolina e Tennessee. Dopo cinque anni di fatiche aveva creato una seconda, ancora più ricca, collezione, che portò con sé in Inghilterra nell'inverno 1811-12. La clientela inglese fu impressionata dalla qualità e dalla quantità dell'offerta, anche questa volta venduta con un'asta pubblica (ce n'è rimasto il catalogo). L'infaticabile Lyon tornò quasi immediatamente in America, dove fece ancora due viaggi nei luoghi prediletti; ammalatosi probabilmente di febbre gialla, si spense a Asheville (North Carolina) nel 1814. Non conosciamo il luogo della sua sepoltura, ma i parenti gli eressero una lapide nel cimitero di Dundee, dove è ancora conservata. Nelle testimonianze dei contemporanei, l'importanza del suo contributo all'introduzione delle specie americane in Europa appare imponente. Secondo la seconda edizione di Hortus Kewensis, redatto da William T. Aiton, le specie nuove messe in vendita nel 1806 e nel 1812 sono 31; spesso non si tratta davvero di novità (molte erano già arrivate in Europa, in particolare grazie ai Michaux che avevano raccolto nelle stesse aree), ma piuttosto di reintroduzioni, rese però disponibili da Lyon in modo ben più massiccio. Nell'elenco figurano tra l'altro (uso le denominazioni attuali) Desmanthus illinoensis, Amsonia tabernemontana var. salicifolia, Asclepias pedicellata, Calycanthus floridus var. glaucus, Dicentra eximia, Hamamelis virginiana, Iris fulva, Cliftonia monophylla, Calycocarpum lyonii, Tradescantia subaspera. Ho lasciato volutamente per ultime le introduzioni più importanti e durature: Phlox paniculata, Pieris floribunda e Magnolia macrophylla (ma potrebbe trattarsi di una specie affine che vive nelle stesse aree, Magnolia fraseri var. pyramidata). Entrambe sono oggi considerate relativamente rare in natura, forse anche a causa del contributo di Lyon, che nel suo viaggio del 1809 in North Carolina ne raccolse ben 3600 esemplari. Amabile Lyonia
In questo atteggiamento predatorio verso la natura, Lyon era un figlio del suo tempo, e lo perdoneremo, tanto più che, come abbiamo visto, pagò di persona il suo accanimento di cacciatore di piante indipendente con la fatica, le malattie, la solitudine e infine con la morte precoce. La puntigliosa registrazione delle entrate e delle uscite annotata nel diario ci dice anche che, se la sua impresa non fu in perdita, neppure gli assicurò un largo guadagno. Come al suo datore di lavoro, anche a lui furono dedicati tre omonimi generi Lyonia; nel 1808 da Rafinesque; nel 1817 dall'amico Elliott; nel 1818 da Nuttall. Per una volta ad essere accettato da botanici è il più recente. Questa la dedica: "Per commemorare il nome del fu Mr. John Lyon, un raccoglitore infaticabile del Nord America, che cadde vittima di un'epidemia perniciosa in mezzo a quelle montagne selvagge e romantiche che erano state tanto spesso teatro delle sue fatiche". Numerose sono poi le specie che lo ricordano nel nome specifico, come Chelone lyonii o Rosa carolina var. lyonii. Lyonia Nutt. (famiglia Ericaceae) comprende circa 35 specie di piccoli alberi o arbusti diffusi nelle boscaglie dell'area himalayana, in Asia orientale, nel Nord America e nelle Antille. E' molto affine a Pieris, in cui in passato è anche confluito (oggi studi molecolari ne confermano l'indipendenza). Decidue o sempreverdi, le piante di questo genere hanno foglie alternate, intere, coriacee e lucide e graziosi fiori penduli tubolari o a forma di urna raccolti in racemi terminali, solitamente bianchi. Tra le specie americane vale la pena di ricordare L. ligustrina, nativa degli Stati Uniti orientali dal Maine alla Florida, notevolmente adattabile ad ambienti diversi e capace, grazie ai rizomi, di resistere agli incendi (molto frequenti nelle pinete in cui vive abitualmente); L. mariana, sempre degli Stati Uniti orientali, usata dai Cherokee come pianta medicinale, e oggi minacciata in Pennsylvania e Connecticut; L. lucida, la specie più nota e diffusa, raccolta anche da Lyon, presente nelle pianure costiere degli Stati Uniti orientali dalla Virginia alla Florida e alla Louisiana e nell'isola di Cuba, con graziosi fiori penduli cilindrici portati su rami arcuati, bianchi, ma anche rosa o rossi. Sono tutti arbusti, mentre può diventare un vero albero l'asiatica L. ovalifolia, diffusa nell'India himalayana, in Cina e in Giappone. Una curiosità: un tempo Lyonia viveva anche in Europa. Alcuni frutti fossili di †Lyonia danica, attribuiti al Miocene medio, sono stati infatti trovati nello Jutland centrale (Danimarca). Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
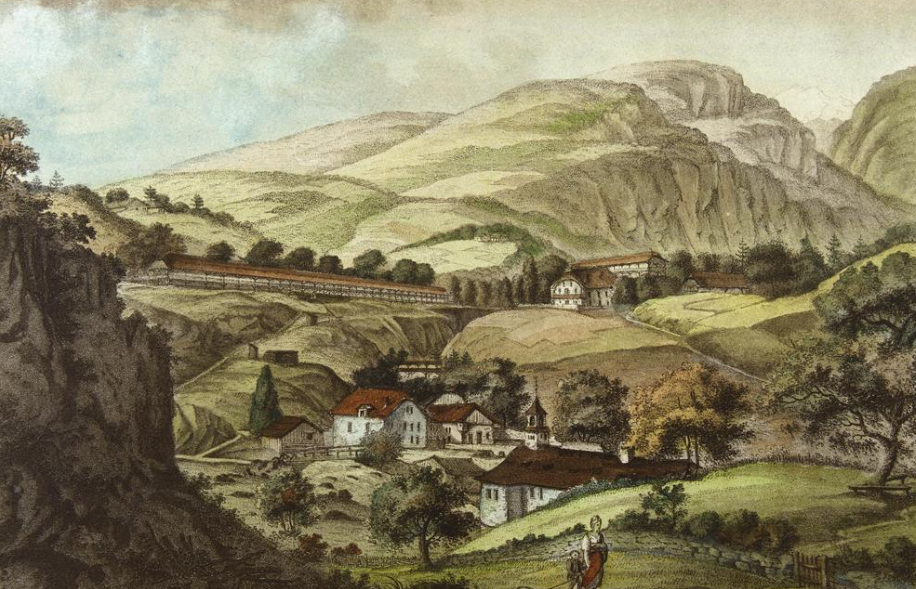


 RSS Feed
RSS Feed