|
Lo svizzero Albrecht von Haller fu una delle personalità più eminenti del secolo dei Lumi. Come poeta, ha mutato il modo di vedere la montagna, ha influenzato il sentimento romantico della natura e lanciato la moda delle escursioni alpine; come medico, ha distinto le funzioni dei nervi da quella dei muscoli e dato la prima descrizione completa delle funzioni del corpo umano; genio universale, poligrafo, giornalista e polemista, i suoi scritti si contano a migliaia, incluse le 9000 recensioni di pubblicazioni su argomenti che vanno dalla filosofia alla religione alla politica alla letteratura alle scienze naturali; ha influenzato il pensiero di personalità tanto diverse tra loro come Kant, Schiller e Hegel. Come botanico, ha donato alla Svizzera la flora più completa del suo tempo. Non era né amabile né modesto, anzi adorava la polemica, e Linneo era uno dei bersagli preferiti dei suoi strali; tuttavia non gli ha fatto mancare la dedica del vistoso genere Halleria. 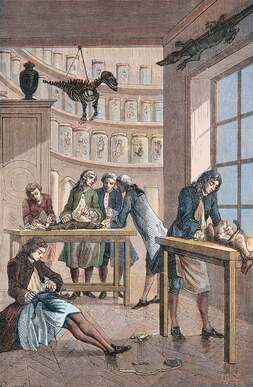 Poeta, fisiologo, bibliografo... Nel luglio 1777, di ritorno da Parigi, dove si era recato anche per risolvere l'imbarazzante situazione matrimoniale della sorella Maria Antonietta (a sette anni dalle nozze, mancava ancora un erede, per una ragione molto semplice: il matrimonio non era mai stato consumato), l'imperatore Giuseppe II passò da Berna. Viaggiava in incognito, sotto il nome di conte di Falkestein, e fece visita a una sola persona: il medico e scienziato Albrecht von Haller (1708-1777); tralasciò invece Ferney, con grande disappunto di Voltaire. Haller era da tempo malato (sarebbe morto pochi mesi dopo) e ricevette l'augusto e inatteso il visitatore in veste da camera e berretto da notte, semisdraiato su una bergère. L'imperatore conversò con lui per oltre un'ora, riconoscendo in quel vecchio piegato dalla malattia almeno lo spirito che l'aveva reso uno degli uomini più ammirati dell'Europa dei Lumi. A commento dell'episodio, nella mostra che il Museo storico di Berna dedicò al più illustre dei bernesi in occasione del trecentenario della nascita leggiamo: "Il segno di ammirazione più prestigioso gli fu tributato dall'imperatore d'Austria Giuseppe II che andò a fargli visita nella sua casa di Berna". E prosegue: "Un erudito universale e enciclopedico: Albrecht von Haller fu uno degli ultimi a poter abbracciare tutte le conoscenze del suo tempo". La sua cultura era vastissima e la sua opera ha lasciato un'impronta profonda nei campi più disparati: come poeta e cantore delle Alpi, mutò la concezione della montagna e lanciò la moda del turismo alpino in Svizzera; come medico, gettò le basi della moderna fisiologia del corpo umano; come botanico, scrisse la prima flora completa della Svizzera. Ma si occupò anche politica, della relazione tra scienza e fede, scrisse tre romanzi, creò una delle biblioteche più importanti d'Europa (ben 23.000 volumi). La sua corrispondenza conta quasi 17.000 lettere, scambiate con 1.139 corrispondenti. Haller (per quarant'anni non ci sarà alcun von davanti al suo cognome) era figlio di un avvocato e funzionario; dopo la formazione iniziale nella città natale, adolescente iniziò gli studi di medicina a Tubinga, poi li continuò a Leida dove fu allievo del grande Boerhaave, che gli trasmise un metodo strettamente sperimentale. A Leida incontrò un altro svizzero affamato di conoscenza, lo zurighese Johannes Gessner, con il quale strinse una fervida amicizia. Dopo la laurea nel 1727, approfondì gli studi di medicina a Londra e a Parigi; qui assistette a molti interventi chirurgici, praticamente tutti mortali, e decise che non sarebbe stato chrirugo, ma anatomista. A Parigi ritrovò anche Gessener, con il quale andò a Basilea per seguire i corsi di matematica di Bernoulli e nell'estate fece un memorabile viaggio a piedi nel Giura e nelle Alpi. Reduce dal soggiorno parigino, fu profondamente colpito dalla maestosità delle Alpi e dalla semplicità della vita dei loro abitanti, che contrapponeva a quella artificiosa e corrotta dei cittadini; sono i sentimenti che ispirarono il più celebre dei suoi poemi, Die Alpen ("Le Alpi"), scritto nel 1729. Come vedremo meglio più avanti, l'incontro con le montagne fu anche quello con la flora alpina. Per qualche anno fu attivo come medico a Berna, dove creò un teatro anatomico, ma non ebbe molto successo; dal 1735 fu bibliotecario della città. Anche se aveva già iniziato le ricerche di fisiologia e botanica che lo avrebbero reso famoso, in questi anni era noto soprattutto come poeta (è del 1732 la raccolta Versuch schweizerischer Gedichte): la sua è una poesia filosofica, in cui riflette sulla fede e sui limiti della ragione, sull'origine del male, sull'eternità. Aspirava a una carriera politica e polemizzò ferocemente contro la corruzione e la degenerazione oligarchica del governo della sua città; ciò finì per chiudergli tutte le porte. Nel 1736, quando le sue candidature a medico cittadino e professore di eloquenza furono respinte, decise di accettare la cattedra di anatomia, chirurgia e botanica all'Università di Gottinga. L'università Georg-August era appena nata (era stata fondata due anni prima dall'elettore di Hannover, ovvero dal re d'Inghilterra Giorgio II), Gottinga era ancora una cittadina di provincia, non mancarono le difficoltà e i lutti privati (la morte delle prime due mogli), ma si respirava un'atmosfera aperta di libera ricerca. Haller creò il teatro anatomico, l'orto botanico e la prima clinica ostetrica di Germania. Come insegnante, attirò frotte di studenti da tutta la Germania. All'insegnamento poté affiancare un'ampissima attività sperimentale; grazie a non meno di 350 autopsie e a esperimenti sistematici sugli animali (purtroppo sì, su di essi praticava la vivisezione) diede una descrizione completa del sistema arterioso, approfondì le conoscenze sulla respirazione e lo sviluppo del feto e dimostrò che l'irritabilità è dovuta ai muscoli e la sensibilità ai nervi. Cominciarono a susseguirsi una serie di opere monumentali, a cominciare dai sette volumi di Erläuterungen zu Boerhaaves Institutiones (1739-1744) e dagli otto fascicolo delle Icones anatomicae (1743-1756), per culminare con gli otto volumi di Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766). In questo testo di riferimento fondamentale, riedito fino all'inizio del Novecento, che lo fece salutare "padre della fisiologia", diede una descrizione completa delle strutture del corpo umano e delle loro funzioni. Non meno importante il suo ruolo come organizzatore culturale. Nel 1747 fu nominato direttore scientifico della rivista Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, che nel 1752 mutò il titolo in Göttingische Gelehrte Anzeigen e dal 1753 divenne l'organo della Società reale delle Scienze di Gottinga. Di quest'ultima, fondata nel 1751 per volontà di Giorgio II, fu uno dei soci fondatori e presidente a vita. La rivista, seguitissima anche al di fuori della Germania, aveva (anzi ha, visto che ancora esiste ed è la più antica rivista scientifica di lingua tedesca ancora in attività) carattere universalistico e pubblicava recensioni critiche delle pubblicazioni tedesche e straniere in campo letterario, scientifico, economico, storico, ecc. Per Haller divenne la palestra dove esercitare il suo sapere enciclopedico e il suo spirito critico (e non di rado la sua vis polemica). Continuò a scrivervi anche dopo il ritorno a Berna, pubblicando più di 9000 recensioni. Inoltre collaborava con moltissime altre riviste scientifiche, sulle quali pubblicava soprattutto articoli di medicina e botanica. La fama e gli onori incominciarono a moltiplicarsi. Nel 1743 fu ammesso alla Royal Society, nel 1747 all'Accademia delle Scienze svedese; le università di Oxford e Utrecht gli offrirono una cattedra, le rifiutò così come l'invito di Federico II a trasferirsi a Berlino. Accolse invece con soddisfazione il cavalierato e il titolo onorifico di medico di corte conferitogli da Giorgio II e il titolo nobiliare che venne dall'imperatore Francesco. Ma il suo vero sogno era tornare in patria e ottenere il meritato riconoscimento di una carriera pubblica. Fin dal 1745, benché risiedesse a Gottinga, era membro del Gran consiglio della città e nel 1753, rifiutato per la seconda volta l'invito di Federico II, tornò a Berna. Come si sa, nemo profeta in patria. I maggiorenti della città non aveva dimenticato le satire politiche dell'età giovanile. Ottenne solo incarichi di secondo piano: dal 1753 al 1757 fu intendente di palazzo della città (Rathausammann); fu eletto presidente della Società economica e cofondatore dell'orfanatrofio. Nel 1758 fu nominato direttore delle saline di Roche nel Vaud e dal 1762 vicegovernatore d'Aigle; fino al 1764, quando l'incarico terminò, visse a Roche, dove ebbe modo di estendere i suoi studi ai modi più economici per ricavare il sale e poté riprendere le ricerche sulla flora alpina. Nel 1764 acquistò la signoria de Goumoens-le-Jux e assunse il nome di Haller von Goumoens. Fece poi ritorno a Berna. Tra il 1764 e il 1773, per ben nove volte, si candidò al Piccolo consiglio, ma non fu mai eletto. Nel 1769, fu richiamato a Gottinga nella veste di cancelliere, ma rifiutò in seguito alla nomina ad assessore perpetuo del Consiglio della sanità di Berna. A trattenerlo a Berna era anche la salute ormai compromessa. Da ragazzo, era stato malaticcio, ma poi le camminate e le scalate lo avevano reso un agile e vigoroso alpinista. A Göttingen, con il superlavoro, vennero l'insonnia, i mal di testa feroci, lo stomaco in disordine. Con l'età si aggiunsero verigini, artrite, gotta, obesità, una tormentosa infezione delle vie urinarie. Per ritrovare il sonno ed alleviare il dolore incominciò a ricorrere all'oppio; ne divenne dipendente e dovette assumerme quantità sempre maggiori. I suoi ultimi anni furono quelli di un valetudinario, precocemente invecchiato. Eppure riuscì ancora a scrivere un'altra opera gigantesca, la quattro Bibliothecae, in parte pubblicate postume: Bibliotheca botanica (1771-72), Bibliotheca anatomica (1774-1777), Bibliotheca chirurgica (1774-1775), Bibliotheca medicinae practicae (1788). Si tratta di una bibliografia completa, e spesso di un esame critico, di tutto ciò che era stato pubblicato su queste materie dall'antichità ai suoi tempi, per un totale di 52.000 titoli. Nei suoi ultimi anni, la maggiore preoccupazione di von Haller andava alla sorte della sua immensa biblioteca. Dopo la sua morte, gli eredi la vendettero al governo austriaco, a condizione che fosse mantenuta intatta; destinata alla Lombardia, fu invece smembrata tra varie biblioteche. I due fondi più consistenti sono conservati alla Braidense di Milano e alla biblioteca universitaria di Pavia, con circa 3000 volumi e altrettante dissertazioni. A Pavia era giunto anche l'immenso erbario di Haller; durante la Campagna d'Italia nel 1796 i francesi se ne appropriarono e fu portato a Parigi; dopo la caduta di Napoleone, il governo austriaco non lo reclamò (scarso interesse per la botanica?) e lì è rimasto. I suoi 59 volumi in folio sono oggi conservati all'Herbier national presso il Museum d'Histoire naturelle. 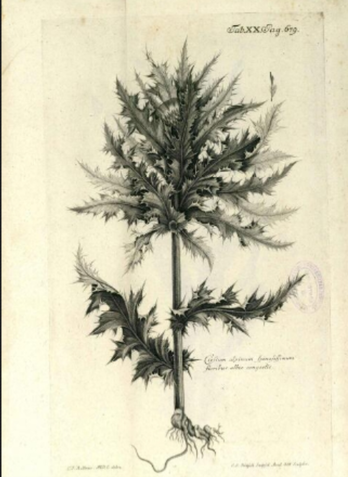 E botanico! Quel gigantesco erbario era frutto degli invii dei suoi numerosissimi corrispondenti, ma in larga parte anche delle raccolte dirette di van Haller che nella sola Svizzera compì almeno 25 escursioni botaniche. Infatti la botanica, dopo la fisiologia e l'anatomia, fu il campo scientifico cui più applicò il suo genio. Egli aveva trascorso l'infanzia in una piccola proprietà a circa cinque km da Berna, sulla riva dell'Aar, tra una collina e una foresta, un paesaggio amato che indirizzò i suoi futuri sentimenti verso la natura. All'epoca la botanica (dalle piante si ricavano gran parte dei medicamenti) faceva parte del bagaglio professionale di ogni medico, e certo Haller l'avrà studiata già a Tubinga, ma il primo contatto documentato avvenne a Leida, dove il venerato maestro Boerhaave nella stagione propizia aveva l'abitudine di iniziare ogni giornata didattica con una rituale visita all'orto botanico, circondato dai suoi studenti. La botanica era già una passione per l'amico Gessner, che prima di spostarsi a Leida aveva raccolto un erbario nello zurighese e sulle Alpi. È possibile che, quando studiavano insieme a Basilea, sia stato lui a proporre di percorrere a piedi i distretti alpini della Svizzera occidentale e centrale durante le vacanze accademiche, anche e soprattutto per raccogliere piante. Se fino ad allora per Haller il loro studio aveva fatto parte del necessario bagaglio professionale, quel viaggio fatidico ebbe il senso di una duplice scoperta: delle Alpi e dei loro abitanti, cantati nel suo celebre poema, e delle piante alpine. Dopo il ritorno a Berna nella primavera del 1729, Halle rcominciò a dedicare il tempo libero agli studi botanici; fece molte spedizioni, brevi o lunghe, in diverse valli alpine e fino alla sua partenza per Gottinga ogni anno dedicò a questi viaggi botanici almeno un mese delle vacanze estive. Per quest'uomo iperattivo e fondamentalmente asociale, che oggi definiremmo senza mezzi termini workaholic, le lunghe escursioni, le scalate anche impegnative, il contatto con la gente semplice della montagna, la raccolta e la metodica preparazione delle piante alpine aveva anche un forte valore terapeutico. Lettore compulsivo, accompagnava la ricerca sul campo con lo studio metodico di tutto ciò che era stato scritto e si andava scrivendo sulla scienza delle piante; aveva grande venerazione per i grandi botanici del passato, e in particolare per Tournefort, la cui opera a suo parere segnava un tale spartiacque che in Bibliotheca botanica intitolerà il primo tomo "Epoche prima di Tournefort" e il secondo "Da Tournefort ai nostri tempi". Tuttavia il suo approccio era totalmente diverso; anche in botanica era essenzialmente un empirico e rifiutava una netta gerarchia tra classi, ordini, generi. Il suo stesso concetto di specie era aperto e sfumato (e sorprendentemente moderno): al contrario di Linneo, che credeva nella fissità delle specie, immutate dal momento della creazione, egli aveva invece constatato che in natura la variabilità è la norma: non solo la vegetazione muta con l'ambiente e l'altitudine, ma la stessa pianta cresciuta in ambienti diversi, oppure in natura o in coltivazione, assume caratteristiche differenti. Strumento essenziale per studiare questa variabilità era l'erbario, dove raccoglieva molti esemplari della stessa pianta in diversi stadi di sviluppo raccolti in più località e habitat. Mentre andava preparando un'opera complessiva sulla flora svizzera, pubblicò su varie riviste scientifiche brevi articoli di argomento botanico o monografie su generi specifici, come De alii genere naturali (1745); infine nel 1742, diede alle stampe la prima versione della sua flora svizzera, Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, in due volumi, corredati da 24 eccellenti tavole disegnate dal pittore ginevrino Jean Huber e incise dall'artista di Gottinga G.D. Heumann. Mentre il suo amico Johannes Gessner fu uno due primi ad adottare il sistema linneano, Haller lo considerava del tutto lontano dalla natura; si sforzò dunque di creare un proprio sistema "naturale" basandosi su un insieme di caratteristiche, e in particolare la mancanza o la presenza di fiori e semi, le caratteristiche dei fiori e quelle dei semi. A inaugurare l'opera sono le tre classi delle "piante apetale prive di stami", ovvero alghe, funghi, licheni, "piante apetale prive di stami cospicui", ovvero muschi, licopodi, marsilie, "piante con semi prive di fiori e apici cospicui", ovvero le felci. Seguono le piante "dotate di petali e stami cospicui", suddivise in un numerose classi, generi e ordini (una categoria inferiore al genere, corrispondente grosso modo al sottogenere). Di ogni specie è data una breve diagnosi, che ne è anche il nome polinomiale, seguita dai sinonimi degli autori precedenti, una descrizione più dettagliata, informazioni sulla localizzazione e l'habitat (mai così attente e dettagliate in nessun autore precedente); concludono, ove noti, gli eventuali usi medici e economici. Rilevante per il gran numero di specie descritte e per l'attenzione riservata a distribuzione e habitat, l'opera è particolarmente notevole per le crittogame, molte delle quali descritte per la prima volta. Essa fu pubblicata a Gottinga, che Haller aveva trasformato in un importante centro di studi botanici con la creazione di un orto botanico che si ispirava a quello di Leida. Presto si arricchì di piante fatte venire dai quattro angoli del mondo e divenne una delle principali attrazioni della città. Haller ne diede anche il catalogo; inoltre completò e pubblicò Flora jenensis di Heinrich Bernhard Ruppius. Intanto continuava ad arricchire il suo erbario grazie agli invii dei suoi corrispondenti, perfezionava il suo sistema e meditava una seconda edizione della sua flora. A dare nuovo impulso alle sue ricerche sulla flora elvetica fu però la nomina a sovrintendente delle saline e il trasferimento a Roche, nel cuore delle montagne del Vaud. Riprese a percorrere le montagne, ma soprattutto ingaggiò, perché raccogliessero per lui, le guardie forestali delle saline; i più attivi ed abili si rivelarono Pierre e Abraham Thomas. Anche altri raccoglievano per lui; citiamo almeno il giovane Horace Bénédict de Saussure che fece la sua prima escursione nella Valle di Chamonix proprio come raccoglitore di von Haller. Il risultato non fu una semplice seconda edizione, ma una nuova opera fortemente ampliata, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, in tre volumi, pubblicata a Berna nel 1768. Secondo Cuvier, "a quei tempi era la più ricca flora d'Europa". Arricchito era anche l'apparato iconografico, con 25 tavole aggiuntive. Complessivamente, tra piante da fiore, felci, muschi, licheni, alghe e funghi, le specie trattate sono circa 2000; le specie descritte per la prima volta, prevalentemente alpine, sono circa 300. Il primo volume si apre con una prefazione di enorme importanza storica, De plantis Helveticis, in cui von Haller illustra le caratteristiche geografiche, climatiche, geologiche del paesaggio elvetico, individua una serie di ambienti naturali e analizza la distribuzione delle specie in base all'altitudine e al clima, giungendo anche a definire diverse associazioni vegatali. È insomma un vero saggio di fitogeografia che non mancherà di influenzare Humbold. Rispetto all'ancora incerto sistema di Enumeratio methodica, Haller ha fatto enormi passi nella ricerca di un sistema naturale; ora le piante sono raggruppate in diciannove classi, a partire da quelle dotate di petali e stami fino ai funghi ("plantae staminibus nullis"), procedendo quindi in ordine inverso rispetto all'opera precedente. Siamo ancora lontani dal sistema naturale basato sul concetto di famiglia (anche se qualche famiglia naturale fa qua e là capolino), ma il sistema di Haller non mancò di esercitare qualche influenza su de Candolle. De Candolle ruppe con il sistema sessuale di Linneo a favore di sistema naturale, ma mantenne la nomenclatura binaria. Invece von Haller rimase ostinatamente legato alla tradizionale nomenclatura polinomia. Le motivazioni sono molteplici; c'entravano il rispetto per la tradizione e i grandi botanici del passato, la rivalità personale con Linneo, ma soprattutto per lui era inaccettabile una nomenclatura basata sui concetti di genere e specie; abbiamo già visto che concepiva le specie in modo diverso da Linneo; quanto al genere, a parte qualche caso evidente, distaccandosi anche dall'ammirato Tournefort, lo riteneva un'unità artificiale, una creazione speculativa dei botanici. Non comprendendo l'importanza di separare la denominazione dalla determinazione, riteneva i nomi binomi inadeguati e imprecisi. Questa scelta gli costò cara: dato che la nomenclatura binomiale è diventata lo standard, le specie da lui scoperte, prive di un nome binomiale valido, oggi portano nomi stabiliti da altri; qualcuno lo recuperò, adattandolo, il suo discepolo de Saussure.  Alle offese, si risponde con un fiore Fin dalla gioventù, quando si alienò i maggiorenti di Berna con le sue satire, von Haller non si tirava indietro quando si trattava di polemizzare. Polemizzò con Voltaire, di cui lui, luterano profondamente religioso, detestava l'irriverenza, il teismo e la filosofia pessimistica della storia; con il materialismo di La Mettrie, che riduceva il corpo umano a una macchina; con le idee politiche di Rousseau, che pure era un grande ammiratore della sua flora. E soprattutto, polemizzò instancabilmente contrò Linneo, il suo sistema, i suoi nomi, la sua pretesa di essere il "principe dei botanici" e il "nuovo Adamo" che aveva ribattezzato piante e animali. Nelle sue lettere a de Saussure, lo chiamava sarcasticamente "il tiranno del Nord". Al di là delle concezioni profondamente diverse della botanica, contavano molto anche tratti caratteriali e il desiderio di entrambi di imporre la propria supremazia sulla "repubblica delle lettere". Un contemporaneo svedese ebbe a dire: "Assomigliavano a Cesare e Pompeo. Uno, il nostro Linneo, non tollerava uguali, e l'altro, Haller, non tollerava superiori. E vice versa". Per qualche anno i due avevano manifestato reciproca stima, furono addirittura amici di penna e corrisposero a lungo. Nonostante le critiche di Haller alla sua Flora svecica (1743), Linneo manifestò grande apprezzamento per la trattazione della crittogame di Enumeratio methodica e nel 1747 favorì l'ammissione di Haller all'Accademia svedese delle scienze. Poi le cose incominciarono a guastarsi, tra insinuazioni e pettegolezzi dei reciproci entourages, e nel 1749 le relazioni si interruppero definitivamente. Nelle sue recensioni per la rivista di Gottinga, lo svizzero demolì sistematicamente le opere dello svedese e addirittura tra il 1750 e il 1753 incaricò il figlio Gottlieb Emanuel di scrivere una serie di pamphlet contro Linneo. Bisogna ammettere che in questo scontro il più signorile fu quest'ultimo: come aveva promesso al comune maestro Boerhaave non interveniva mai di persona nelle polemiche, e in Species plantarum fu abbastanza magnanimo da confermare la dedica al rivale di un genere che aveva istituito ai tempi della loro amicizia, in Hortus Cliffortianus, Halleria "in onore del dottissimo botanico Albrecht Haller, professor di botanica a Gottinga. E non si tratta di una pianta sgradevole e puzzolente, come la Siegesbeckia affibiata all'odiato Siegesbeck, o di un ritratto vegetale per lo meno ambiguo come Milleria per un altro pervicace oppositore delle denominazioni binomiali, Philip Miller. Le sudafricane Halleria lucida e H. elliptica, le due specie note a Linneo, sono infatti piante di sontuosa bellezza, potremmo dire un omaggio regale. Il genere Halleria (Stilbaceae, in precedenza Scrophulariaceae) comprende cinque specie di alberi e arbusti diffusi nell'Africa tropicale e meridionale e in Madagascar. Per i loro fiori spettacolari in inglese sono dette Tree fuchsia, fuchsia arborea, anche se con le vere fucsie non hanno alcuna parentela. Il centro di diversità è il Sudafrica, dove sono presenti tre specie su cinque, una delle quali (H. ovata) endemica; H. ligustrifolia e H. parviflora sono endemiche del Madagscar; H. lucida ha un ampio areale che va dall'Etiopia al Sudafrica, mentre H. elliptica ha distribuzione digiunta ( Malawi, Sudafrica, Madagascar). La specie di maggiore diffusione è anche probabilmente la più attraente. H. lucida è un piccolo albero dalla chioma arrotondata, con rami elegantemente arcuati e foglie lucide persistenti; diventa spettacolare al momento della fioritura, quando si ricopre di fiori tubolari da arancio a rosso mattone, raccolti in infiorescenze a grappolo alle ascelle delle foglie o portate direttamente sul tronco. Molto attraenti anche i frutti, bacche dapprima verdi poi nere a maturazione, eduli, di sapore dolce ma tendenzialmente allappanti. I fiori sono ricchi di nettare e sono impollinati da uccelli nettarini.
0 Comments
Quando il sistema e la reputazione scientifica di Linneo sono ridicolizzati e messi in discussione da Siegesbeck, al suo fianco si schiera inaspettatamente il giovane botanico tedesco Johann Gottlieb Gleditsch, subito ripagato con la dedica di uno dei più begli alberi americani, Gleditsia triacanthos. Ma non è l'unico merito di questo notevolissimo e versatile studioso: dalla rifondazione dell'orto botanico di Berlino agli esperimenti sulla fecondazione e i movimenti delle piante, da un metodo per classificare i funghi alla fondazione della silvicoltura scientifica, sono molti i campi in cui ha lasciato un'impronta significativa. 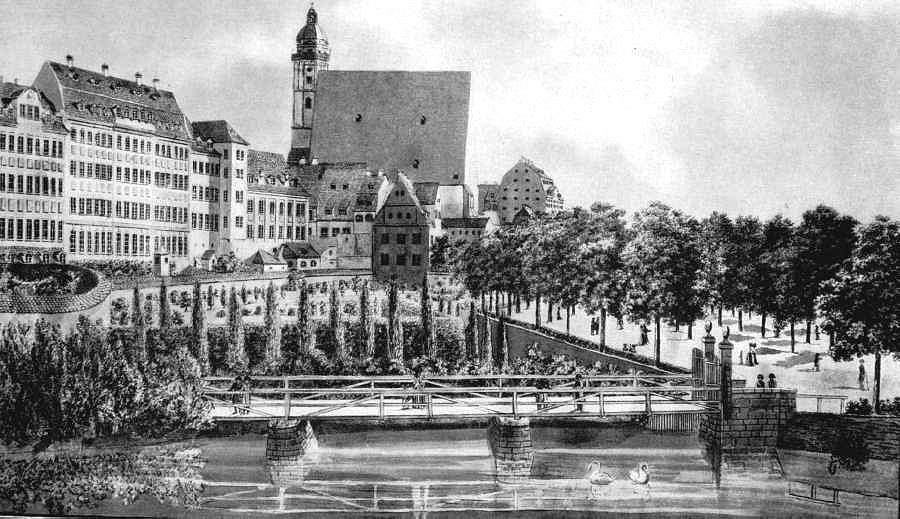 Una lettera inattesa dalla Germania Nella primavera del 1739, Linneo viveva forse il punto più basso della sua carriera. Rientrato in Svezia dall'Olanda alla fine di giugno dell'anno precedente, tre mesi dopo era si stabilito a Stoccolma dove contava di lavorare come medico. Aveva invece scoperto che il libello di Siegesbeck che attaccava il suo sistema sessuale come "pornografia botanica" lo aveva coperto di ridicolo e soprattutto gli aveva alienato i potenziali e timorati clienti, tanto che, come scrisse con qualche esagerazione a von Haller, nessuno era disposto a fargli curare nemmeno un cane. Come ho già raccontato in questo post, avendo promesso a Boerhaave di non farsi trascinare in nessuna disputa scientifica, aveva affidato la sua difesa all'amico Browallius, ma in suo soccorso giunse un aiuto inaspettato, sotto forma di una lettera dalla Germania. A scrivere al "nobilissimo, magnifico, espertissimo e dottissimo botanico e filosofo Carlo Linneo" era il giovane medico Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), all'epoca venticinquenne. Egli esprimeva tutta la sua ammirazione per gli scritti di Linneo, ed in particolare per Fundamenta botanica, in cui aveva ritrovato la sua stessa concezione della botanica come scienza autonoma. Lamentava poi il deplorevole stato della botanica in Germania, dove persisteva la sudditanza alla medicina e i botanici più reputati disquisivano di piante vistose ed esotiche e consideravano felci, muschi, funghi ed alghe alla stregua di escrementi della natura. Raccontava anche di sé, della sua precoce passione per le scienze naturali, osteggiata dalla famiglia e anche all'università di Lipsia dove gli ripetevano che non era degno di uno studente di medicina andare in cerca di erbe per boschi e pantani a sporcarsi le scarpe, i vestiti e la testa ben incipriata. Ma lui non aveva dato loro ascolto: aveva studiato diversi sistemi di classificazione che lo delusero per la mancanza di una chiara definizione di genere; per undici anni aveva esplorata la flora tedesca tenendo un diario di campo, raccolto piante alpine, pietre, fossili, minerali. Poi, proprio come Linneo con George Clifford, da poco aveva trovato un mecenate nel generale von Zieten, che gli aveva affidato la catalogazione del proprio giardino di Trebnitz. Ora sperava in una collaborazione con Linneo e lo stesso Clifford. E forse Linneo gli sarebbe stato utile per realizzare il suo sogno di trasferirsi in America. Lo scopo principale della missiva emerge però solo nel poscritto, in cui Gleditsch scrive: "In autunno ho letto l'Epicrisis di Siegesbeck contro i tuoi scritti [...] Le sue argomentazioni sul tuo sistema e i tuoi fondamenti botanici non sono di alcun valor valore [...] tanto da non meritare risposta". Chiede tuttavia il permesso di pubblicare "le due cosette che ho già concepito" sotto forma di lettera pubblica a Breyne. Dato che del carteggio Gleditsch-Linneo sono conservate solo le nove lettere scritte dal tedesco, non sappiamo cosa abbia risposto Linneo. Ma certo, come si può ricavare da ulteriori due lettere del 1740, diede il permesso e seguì da vicino le vicende della pubblicazione dell'opuscolo promesso, che con il titolo Consideratio epicriseos Siegesbeckianae uscì solo alla fine del 1740 e fu indirizzato non a Breyne ma a Christian Wolf. Siegesbeck rispose con il rabbiosoVaniloquentiae botanicae specimen, a M. Jo. Gottlieb Gleditsch, ma ormai, grazie a Gleditsch, la reputazione di Linneo era ristabilita anche in Germania.  L'Experimentum berolinense Al di là del suo coinvolgimento nella celebre controversia, Johann Gottlieb Gleditsch fu un botanico versatile e di notevole valore che vale la pena di conoscere meglio. Figlio di un musicista di Lipsia, come racconta egli stesso nella sua prima lettera a Linneo, fin dall'infanzia si innamorò della botanica, una passione osteggiata dalla famiglia che voleva destinarlo a più alti studi. Nel 1728, quattordicenne, si immatricolò all'università di Lipsia per studiare filosofia e medicina; fin da quel momento prese ad esplorare la flora di Lipsia, dello Harz e della Turingia. Prima ancora di aver conseguito il primo grado accademico (magister artium) nel 1732, attirò l'attenzione del suo professore di botanica, Johann Ernst Hebenstreit, che nel 1731, nel partire per l'Africa in cerca di rarità per la Wunderkammer di Augusto il forte, nonostante la giovanissima età gli affidò la cura dell'orto botanico universitario e dello spettacolare giardino barocco della famiglia Bose. Scopriamo così che Lipsia non era il deserto botanico dipinto da Gleditsch: Hebenstreit era un botanico sufficientemente stimato da guadagnare la dedica di un genere da parte dello stesso Linneo; ma forse era proprio lui uno di quei botanici che egli stigmatizzava per le loro tassonomie contraddittorie (era un continuatore di Rivinus) e per la predilezione per le piante esotiche. Come che sia, fino al 1735, quando in seguito alla morte del sovrano Hebenstreit fu richiamato, il nostro resse i due giardini e proseguì gli studi di medicina nella città natale. Quindi per breve tempo fu medico pratico a Annaberg, finché si trasferì a Berlino per approfondire lo studio dell'anatomia e della chirurgia presso il Collegium medico-chirurgicum, recentemente fondato e strettamente legato alla Charité. Ebbe così modo di collaborare con il medico cittadino Christian Gottfried Habermaaß nella creazione di barriere, recinzioni e piantumazioni per contrastare la sabbia trasportata dal vento che rendeva aride e non coltivabili intere zone della città. Dovette così attirare l'attenzione del generale Georg Friedrich von Ziethen che gli commissionò un catalogo delle piante del suo vasto giardino di Trebnitz, presso Müncheberg. Pubblicato nel 1737, il Catalogus Plantarum Trebnitzii è la prima opera a stampa di Gleditsch; oggi ne sopravvive un'unica copia nella biblioteca universitaria di Göttingen. Gleditsch si trovava sicuramente a Trebnitz nel marzo 1739 quando scrisse la prima lettera a Linneo, dalla quale scopriamo anche che era in contatto con Pier Antonio Micheli e che la morte di questi nel 1737 lo aveva privato del suo principale corrispondente; forse anche per questo cercava in Linneo un nuovo mentore, o almeno un "fratello maggiore". Poi, invece di partire per l'America, rimase in Prussia, dove percorse una carriera di straordinario successo. Nel 1740 fu nominato "medico rurale" del distretto di Lebus e nel 1742 conseguì il dottorato presso l'Università di Francoforte sull'Oder, dove tenne anche corsi di fisiologia vegetale e materia medica. Nel 1744 Federico il Grande lo chiamò a Berlino come professore di botanica al Collegium medico-chirurgicum, membro effettivo della reale accademia della scienze e botanico reale, ovvero direttore dell'orto botanico. Prima di trasferirsi nella capitale, un viaggio in Turingia gli offrì importanti esperienze botaniche e forestali. Nel 1746, fu invitato a San Pietroburgo con uno stipendio di 2.000 rubli, ma dopo che Federico II gli aumentò lo stipendio di 200 Reichstaler, preferì rimanere a Berlino. Vi sarebbe rimasto fino alla morte, per oltre 40, divenendo di fatto il fondatore di quella scuola botanica. Tra i suoi allievi, va ricordato almeno Willdenow. Professore stimato e molto impegnato nelle lezioni, dedicò molto del suo tempo anche alla ricostruzione dell'orto botanico, che al momento in cui ne assunse la direzione era assai trascurato. Le origini del giardino risalivano al 1679 quando, in seguito alla costruzione di un bastione e di un fossato che tagliava in due il giardino di piacere (Lustgarten) del palazzo elettorale, il grande elettore chiese al suo medico Johann Sigismund Elsholtz di ristrutturare un terreno sito del villaggio di Schöneberg in precedenza adibito alla coltivazione di luppolo per le birrerie reali; dopo la trasformazione, divenne allo stesso tempo una fattoria reale, un giardino di piacere, aperto al pubblico e molto amato dai berlinesi, e un orto botanico con piante medicinali coltivate anche a fini didattici, anche se incominciò a essere chiamato orto botanico solo a partire dal 1718, quando venne affiliato all'Accademia delle scienze. L'area occupata dall'orto botanico era relativamente estesa e offriva una certa varietà di terreni, più o meno fertili e da aridi a umidi, il che permise a Gleditsch di sfruttare la sua vasta conoscenza della flora tedesca puntando sulle piante autoctone rustiche, per cercare le quali fece molti viaggi. Altre se le procurò con scambi con altri orti botanici (nella sua successiva corrispondenza con Linneo, gli chiese ad esempio di inviargli piante siberiane o in genere adatte al freddo clima berlinese). Ovviamente non mancavano le esotiche, per le quali fece costruire nuove serre; venne creato anche un vivaio. Nelle aiuole didattiche le piante furono collocate seguendo il sistema di Linneo (anche se, come vedremo, Gleditsch creò anche un proprio sistema). Per la ricchezza delle collezioni (nell'arco di poco tempo, le piante superarono le 6000) per la prima volta il giardino assunse rinomanza europea. A dargli fama, furono anche gli esperimenti di Gleditsch, in particolar modo il cosiddetto Experimentum berolinense. La sessualità delle piante era già stata dimostrata dagli esperimenti di Camerarius e Vaillant, ma all'epoca era ancora una questione controversa e delicata, come dimostra la stessa polemica Linneo-Siegesbeck. Nell'orto botanico di Berlino c'era un esemplare femminile di Chamaerops humilis che fioriva ma non produceva frutti. Nel 1749 Gleditsch la impollinò con il polline di un esemplare maschile della stessa specie che si fece spedire dall'orto botanico di Lipsia (egli probabilmente lo conosceva fin dagli anni universitari). Ripeté l'esperimento nel 1750 e nel 1751, utilizzando anche polline proveniente da Karlsruhe, sempre con pieno successo. Quell'anno pubblicò i risultati in un saggio in francese sull'inseminazione artificiale. Nel 1752, come controprova e per togliere ogni argomento agli avversari, la palma non venne impollinata e non fruttificò. Fin dal primo anno, i frutti maturi furono interrati e produssero pianticelle vitali di entrambi i sessi, che furono inviate in dono ad altri orti botanici. Una delle prime, un esemplare di due anni, raggiunse Linneo, accompagnata da una lettera di Gleditsch datata 1 febbraio I753. L'esperimento, anche per il modo esemplare con cui venne condotto, fornì la prova definitiva della sessualità delle piante e diede grande fama al suo autore. 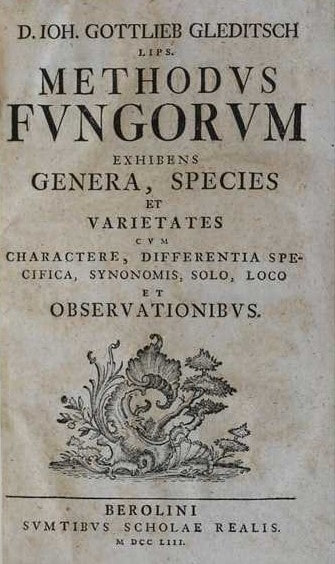 Padre della silvicoltura Gleditsch, oltre a ripetere esperimenti di impollinazione su altre piante dioiche, applicò l'approccio sperimentale ad altri soggetti: il ruolo degli insetti nell'impollinazione, la fecondazione dei funghi, la fecondazione artificiale dei pesci, l'influsso dei fattori meteorologici sui movimenti delle piante. Si occupò anche di sistematica: nel 1753 pubblicò il notevole Methodus Fungorum Exhibens Genera, Species et Varietates, il primo reale trattato di micologia, e nel 1764 in Systema plantarum a staminum situ espose il proprio sistema, basato sul numero e la posizione degli stami. Gleditsch non trascurò le applicazioni pratiche della botanica; nel 1760 fondò la rivista Almanach der Ökonomischen Botanik ("Almanacco di botanica economica") in cui promosse l'introduzione e la diffusione di piante utili e il miglioramento delle pratiche orticole. I suoi contributi degli anni '60 tanto sulla fisiologia vegetale quando sulla botanica economica sono raccolti in Vermischte physicalisch-botanisch-oeconomische Abhandlungen ("Trattati misti di botanica fisica ed economica", 1765). La sua più duratura eredità è però la fondazione della silvicoltura su basi scientifiche. Interessato agli alberi fin dall'adolescenza, a partire dal 1770 fu il primo professore universitario ad insegnare questa materia nella neonata Scuola Superiore di Scienze Forestali di Berlino. Prima di allora, la gestione dei boschi e la coltivazione degli alberi erano trattate in modo puramente empirico; egli le trattò invece in modo scientifico e sistematico, come possiamo riscontrare nella sua opera principale in due volumi, Systematische Einleitung in die neuere, aus ihren eigenthümlichen physikalisch-ökonomischen Gründen hergeleitete Forstwissenschaf ("Introduzione sistematica alla nuova scienza forestale, derivata dalle sue peculiari ragioni fisico-economiche", 1774-75). Proprio come faceva all'orto botanico di Berlino, anche in campo forestale Gleditsch puntò a un equilibrio tra la valorizzazione delle specie autoctone e l'introduzione di specie esotiche. Incoraggiò la piantumazione di alberi di alta qualità come il rovere e il pino; promosse una conoscenza scientifica delle varie specie e delle loro diverse esigenze; introdusse nelle foreste tedesche nuove specie, anche per diversificare le risorse forestali e migliorare la resistenza alle malattie e agli insetti; riconobbe l'importanza della conservazione delle foreste per le generazioni future, evitando l'eccessiva deforestazioni. Il suo insegnamento (cui dedicava da otto a dieci ore al giorno) e i suoi scritti ebbero un'influenza duratura sulla gestione delle foreste tedesche ed europee tanto da fargli riconoscere l'appellativo di "padre della silvicoltura". Membro di istituzioni scientifiche come l'accademia delle scienze di Berlino, della Società berlinese degli amici dei ricercatori naturali, della Leopoldina e delle accademie di Roma, San Pietroburgo e Stoccolma, Gleditsch rivesti anche incarichi pubblici: era supervisore del Gabinetto di Storia Naturale dell'Accademia delle Scienze di Berlino e dal 1780 fu membro della Commissione della Farmacia di Corte. 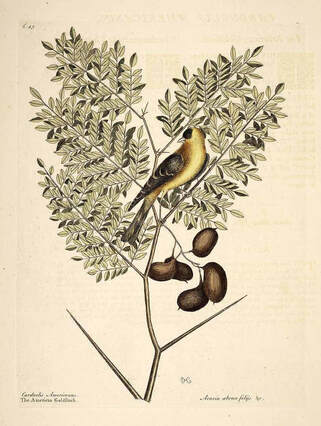 Foglie d'oro e spine minacciose Gleditsch morì nel 1786, a 72, a quanto pare a causa di una malattia insorta vari anni prima in seguito a una brutta caduta mentre esplorava una delle sue amate foreste. Sul suo tumulo fu posta una Gleditsia, ovvero l'albero che Linneo gli aveva dedicato ai tempi della sua giovinezza per ringraziarlo di essersi schierato al suo fianco contro Siegesbeck. La pianta che Linneo avrebbe denominato Gleditsia triacanthos aveva già fatto la sua comparsa in Europa a fine Seicento (è citata in Plukenet come Acacia americana), ma a diffonderne la coltivazione nei giardini inglesi fu soprattutto Catesby; a dispetto delle feroci spine, era (ed è) estremamente apprezzata per il bellissimo fogliame autunnale. Linneo la descrisse in Hortus cliffortianus (1737) ancora come Acacia; la denominazione Gleditsia compare per la prima volta in Flora Virginica del maestro e amico Gronovius, in cui la piante è descritta sulla base della determinazione di Clayton; il nome fu però certamente suggerito da Linneo. Il testo uscì nel 1739, dunque prima dell'effettiva pubblicazione di Consideratio epicriseos Siegesbeckianae. Linneo poi la riprese in Hortus upsaliensis (1748) e la ufficializzò in Species plantarum (1753). Il genere Gleditsia (famiglia Fabaceae) comprende 12-14 specie di alberi decidui, per lo più muniti di spine, con una classica distribuzione disgiunta: il Caucaso, l'Asia orientale, l'America orientale, il Sud America. Si ritiene che il centro evolutivo originario del genere sia l'Asia orientale da cui potrebbe aver raggiunto il Nord America ai tempi in cui i due continenti erano congiunti dal ponte di terra della Beringia. Oggi sono note una specie caucasica, due nordamericane, una sudamericana, mentre tutte le altre sono distribuite dall'Himalaya alle Filippine e al Giappone attraverso la Cina (il maggior centro di diversità con 5 specie). Sono alberi decidui, talvolta arbusti, con fusti e rami spesso armati di spine dure; hanno foglie composte con foglioline dai margini serrati o finemente dentati; fiori unisessuali o poligami solitamente poco vistosi, bianchi o verdastri, raccolti in infiorescenze terminali o ascellari, seguiti da baccelli piatti, dritti, angolati o ritorti. La specie più nota, largamente usata in giardini e alberate, è l'americana Gleditsia triacanthos, originaria degli Stati Uniti sudorientali e del Messico. Molto apprezzata per il veloce ritmo di crescita, la resistenza alla salsedine, al vento e all'inquinamento, la rusticità, la bellezza del portamento e il fogliame autunnale, è spesso utilizzata per piantumare zone di recente urbanizzazione, terreni poveri ed aree esposte. I baccelli, inizialmente verdi, con una polpa dolce (da cui il nome americano honey locust) commestibile, a maturazione diventano legnosi e brunastri. Il fusto e i rami, tortuosi e intricati, sono armati da temibili spine disposte in gruppi di tre. In Italia si è naturalizzata in gran parte delle regioni; in Australia è considerata una delle più pericolose piante invasive. In natura si trovano occasionalmente forme senza spine (Gleditsia triacanthos var. inermis) e spesso senza semi, che sono state selezionate come varietà orticole, solitamente preferite a quelle spinose per situazioni pubbliche come parchi e alberate dove possono costituire un pericolo per bambini e animali. Tra di esse, la più nota è 'Sunburst', con foglie nuove giallo intenso che in estate virano al verde. Altre variet sono elencate nella scheda. L'altra specie nordamericana è G. aquatica che, a differenza della precedente (una specie eliofila a suo agio nei terreni aridi), predilige terreni umidi e un'esposizione semi ombrosa. Produce caratteristici baccelli piatti lenticolari. Forma ibridi naturali con G. triacanthos noti come G. x texana. Più raramente sono coltivate Gleditsia caspica e le altre specie asiatiche, alcune delle quali, come Gleditsia japonica e Gleditsia sinensis hanno una lunga tradizione di usi medicinali tradizionali. All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia). 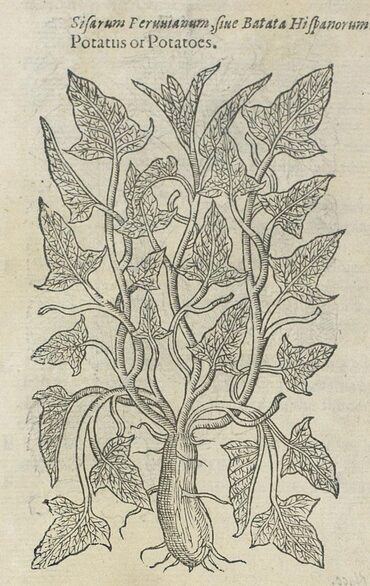 Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa. 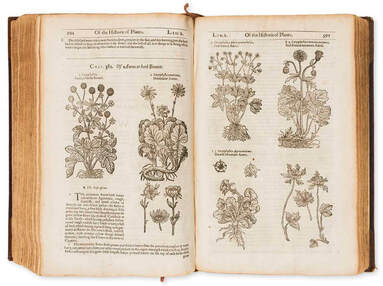 Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice. Nelle riviste inglesi a cavallo tra Settecento e Ottocento, ci si imbatte continuamente nel nome del ricchissimo mercante George Hibbert che nel suo giardino di Clapham possedeva una collezione di piante rare seconda solo a quella dei Kew Gardens; anzi la prima al mondo per le Proteaceae, le sue piante preferite. Nulla di strano che l'editore di una di quelle riviste, che era anche un pittore ed approfittò largamente di quelle raccolte per i suoi libri, lo abbia ringraziato con la dedica di una delle piante che fioriva nel suo giardino. Il problema è che il grazioso genere Hibbertia onora una persona che, dal punto di vista attuale, non merita di essere onorata: come collezionista e promotore dell'introduzione di nuove piante Hibbert fece molto per la botanica, è innegabile; tuttavia egli non solo doveva la sua ingentissima ricchezza allo schiavismo (in questo sarebbe in larga compagnia, a cominciare dai presidenti americani Washington e Jefferson) ma fu probabilmente il nome più in vista della lobby di mercanti, trafficanti e piantatori che cercò di bloccare l'approvazione della legge che mise fine alla tratta degli schiavi in Inghilterra; e alla fine fu anche profumatamente pagato per averlo fatto. Secondo alcuni botanici, la botanica non può lavarsene le mani; secondo altri, mettere in discussione un nome per ragioni che prescindono le regole botaniche apre un vaso di Pandora che fa crollare i principi cardini del Codice internazionale di nomenclatura. Il dibattito è aperto. 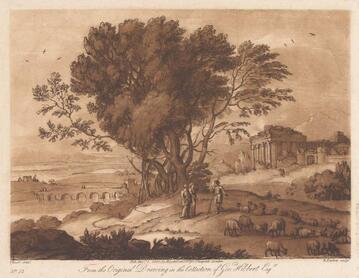 Il volto oscuro: lo schiavista Uno dei nomi che ricorrono con maggiore frequenza nelle pagine di The botanist's repository e del Curtis's botanical magazine nel ventebnnio tra il 1795 e il 1815 è quello di George Hibbert (1757-1837), nel cui giardino di Clapham fiorirono per la prima volta e furono disegnate molte delle novità presentate in quelle riviste. La sua collezione di piante rare provenienti da tutto il mondo rivaleggiava con quella dei Kew Gardens, ed era particolarmente ricca di specie del Capo, dove, come vedremo più avanti, operò per vari anni come cacciatore di piante uno dei suoi giardinieri, James Niven. Hibbert non era un mero collezionista di piante: era considerato un botanico più che dilettante, parlava fluentemente cinque lingue e ne capiva altre due, era un bibliofilo compulsivo e un po' megalomane che non badava a spese per acquisire libri rari, inclusa una copia della Bibbia di Gutenberg. Era membro di molti club e di società scientifiche, inclusa la Royal Society. Nel necrologio pubblicato sulla rivista della Linnean Society, James Main l'ha descritto come una persona che "ispirava fiducia e rispetto per il buon senso, la capacità di giudizio e la sagacia". Eppure questo stimato collezionista e botanofilo non solo doveva tutta la sua ricchezza al lavoro degli schiavi, ma fu anche il leader e il portavoce della lobby di mercanti e piantatori delle Antille britanniche che si oppose con tutte le forze all'abolizione della schiavitù. La famiglia Hibbert era coinvolta da lunga data nel commercio triangolare: il cotonificio del nonno e del padre, due agiati drappieri di Manchester, forniva cotonine e altre forniture ai trafficanti di schiavi; ma il vero salto di qualità si ebbe con lo zio Thomas, che si trasferì in Giamaica per recuperare le obbligazioni di alcuni trafficanti e in vent'anni divenne uno dei più ricchi piantatori dell'isola (possedeva tre estese piantagioni con oltre 900 schiavi); si fece costruire la più bella casa di Kingston, Hibbert House, oggi sede del National Trust della Giamaica. Grazie al successo e ai contatti di Thomas, gli Hibbert rimasti in Inghilterra, da drappieri e fornitori, si trasformarono in mercanti e armatori, specializzati nel commercio con la Giamaica. Nel 1770, un altro Thomas Hibbert, il fratello maggiore di George, si trasferì a Londra e insieme a due altri mercanti, John Purrier e Thomas Horton, fondò la ditta di import-export e trasporti navali Hibbert, Purrier & Horton che importava prodotti coloniali e forniva merci (e prestiti) a piantatori e trafficanti. George si unì alla ditta di famiglia come socio giovane nel 1780 (all'epoca aveva ventitré anni) con un capitale di 1500 £, cui se ne aggiunsero altre 1000 alla morte del padre nel 1784. Meno di dieci anni dopo, era diventato il capo della ditta (ora, con l'ingresso di altri soci si chiamava Hibbert, Fuhr & Hibbert) e un membro eminente della lobby che difendeva gli interessi dei piantatori e dei mercanti delle Indie occidentali, la London Society of West India Planters and Merchants. Nel 1790, nella sua testimonianza davanti alla commissione d'inchiesta sulla tratta degli schiavi, dichiarò di aver importato annualmente merci per un valore compreso tra 200.000 e 250.000 £ e di aver investito molti capitali in Giamaica sotto forma di prestiti ai piantatori. Almeno dal 1793, George Hibbert fu coinvolto in un progetto che stava molto a cuore ai lui e agli altri West Indiamen: la costruzione di una darsena riservata alle loro navi; infine autorizzata nel 1799 dal West India Dock Act, la darsena, collocata sull'Isola dei cani, fu inaugurata nel 1802; l'ingresso principale, posto all'estremità occidentale, presto noto come Hibbert Gate, era largo abbastanza da consentire l'ingresso di carri e vagoni, chiuso da una duplice cancellata di ferro e sormontato da una scultura che riproduceva una delle navi di George e soci, chiamata Hibberts. George Hibbert fu il primo presidente della West India Docks Company e negli anni successivi rivesti ripetutamente questo ruolo. Purtroppo, egli non doveva il suo largo seguito tra i West Indiamen solo alle abilità commerciali (la Hibbert, Fuhr & Hibbert era la prima per giro d'affari con la Giamaica) e alla grinta con cui difendeva i loro interessi: era anche il portavoce degli antiabolizionisti, e seppe muoversi con grande abilità manipolatoria e notevoli capacità dialettiche. Già nel 1790, quando era stato ascoltato dalla commissione parlamentare, aveva evidenziato che l'intera economia delle Antille britanniche - ma anche gran parte dell'industria manifatturiera della stessa Inghilterra - dipendeva dalla schiavitù; se questa fosse stata abolita, si andava incontro alla rovina, e migliaia di famiglie sarebbero state ridotte sul lastrico. Nel maggio 1789, una settimana dopo che Wilberforce ebbe pronunciato in Parlamento il suo celebre discorso abolizionista, i mercanti convocarono una riunione alla London City Tavern; Hibbert vi intervenne con un discorso di 40 minuti intitolato "L'indispensabilità della tratta degli schiavi" in cui cercò di demolire tutti gli argomenti di Wilberforce. L'anno dopo fu di nuovo ascoltato in Parlamento: per lui non era una questione morale, ma economica; la posizione degli abolizionisti era astratta (oggi si direbbe buonista o radical chic), andava contro i diritti e i privilegi acquisiti fin dai tempi di Elisabetta I, quindi la Common Law e il diritto consuetudinario; la schiavitù per altro non era neppure condannata dalla Bibbia, dove gli uomini erano considerati merci come tutte le altre. Proprio per difendere gli interessi dei West Indiamen (ovvero i suoi e dei suoi compari) si gettò anche in politica; già consigliere (alderman) della città di Londra dal 1798, nel 1802 si presentò come deputato per la City, ma non fu eletto; ebbe successo invece nel 1806, quando fu eletto senza opposizione nel collegio di Seaford (uno dei "borghi putridi" controllato dalla lobby dei mercanti delle Indie occidentali); nel suo primo discorso, nel febbraio 1807, dichiarò la sua assoluta ostilità all'abolizione della tratta e durante la discussione che avrebbe portato all'approvazione dello Slave Trade Act, intervenne in ogni passaggio cercando di bloccare la legge. Non ci riuscì, ma ottenne probabilmente ciò a cui mirava fin dall'inizio: l'approvazione di una mozione che garantiva il risarcimento ai piantatori e ai mercanti che traevano le loro ricchezze dalla schiavitù. La compensazione costò alla stato 20 milioni di sterline; Nick Hibbert Steel nel suo saggio sulla famiglia Hibbert l'ha chiamato il "prezzo dello zucchero". E' stato calcolato che agli Hibbert ne andarono 103.000 e allo stesso George Hibbert 16.000. Nel 1812 Hibbert fu nominato agente generale per la Giamaica, una posizione che mantenne fino al 1831, anche se già nel 1829 si ritirò a vita privata; nel 1824, aveva anche avuto modo di illustrarsi e come filantropo, in quanto membro fondatore e finanziatore di una società di soccorso navale, National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, precorritrice della Royal National Lifeboat Institution che ancora oggi nel proprio sito lo ricorda come benemerito fondatore.  Il volto luminoso: il collezionista Negli stessi anni in cui si metteva in luce in questo modo ai nostri occhi abominevole (ma non a quello di molti suoi contemporanei: nel 1812, quando si ritirò dal Parlamento, il leader dei whigs George Tierney lo nominò tra coloro "i cui servizi sarebbero stati rimpianti dalla nazione"), George Hibbert acquisiva grande rinomanza come collezionista di libri e proprietario di uno dei giardini più raffinati del paese. Come sostiene Katie Donington nel suo importante saggio dedicato alla famiglia Hibbert, The Bonds of Family, tra le due cose non c'è alcuna contraddizione: nel momento in cui una parte crescente dell'opinione pubblica incominciava a prendere le distanze dallo schiavismo, su cui si basava la sua ricchezza, il collezionismo era un modo per rendersi socialmente accettabile. Infatti Hibbert divenne un membro riconosciuto della comunità scientifica: nel 1805 lo troviamo tra i fondatori della London Institution, che anticipò l'Università di Londra nel rendere disponibile l'educazione scientifica ai dissidenti religiosi, esclusi dai college di Oxford e Cambridge; già membro della Linnean Society e della Antiquarian Society, nel 1811 fu ammesso alla Royal Society; nel 1816 entrò a far parte del Roxburghe Club, la più antica società di bibliofili del mondo. Non conosciamo con esattezza quando Hibbert abbia cominciato a collezionare libri e piante; nel 1829, quando si ritirò a vita privata e si trasferì a Munden House, una proprietà che la moglie aveva ereditato da uno zio, fu costretto a vendere la biblioteca; secondo il catalogo d'asta, di ben 8711 pezzi, non pochi dei quali rarissimi, la collezione era stata riunita dal proprietario in più di quarant'anni (dunque a partire dalla fine degli anni '80). Per quanto riguarda le piante, la prima data certa è il 1794: quell'anno Hibbert, che già possedeva una residenza a Portland Place, nel distretto di Marylebone, acquistò una casa e una proprietà chiamata The Hollies sul lato nord di Clapham (curiosamente, il distretto noto per essere stato la sede del movimento abolizionista noto come Clapham Sect o Clapham Saints). Allo stesso anno ci riporta il suo primo acquisto datato: alla fine del 1792 un altro ricco mercante e armatore, Gilbert Slater, legato alla Compagnia delle Indie, proprietario di un notevole giardino in Essex, inviò in Cina a caccia di piante il giardiniere scozzese James Main che fece buona caccia, riportando tra l'altro la famosa rosa Slaters' Crimson China; al suo ritorno nel 1794 però Slaters era deceduto da quasi un anno; le raccolte cinesi furono vendute e acquistate in parte dai Kew Gardens, in parte da Hibbert, che assunse Main come giardiniere (è dunque inesatta la notizia che si legge in Wikipedia inglese che già lavorasse per Hibbert in precedenza e che avesse viaggiato in Cina per conto sia di Hibbert sia di Slaters). Hibbert acquistò piante e semi, ma anche disegni cinesi: è dunque possibile che la passione per le piante sia nata indirettamente da quella per i libri e le opere d'arte. In ogni caso la vera passione di Hibbert divennero le Protee, forse perché erano rare, difficili da coltivare, dunque molto prestigiose. I semi delle prime erano state portate in Inghilterra da Masson tra il 1774 e il 1787; nel 1789 d verse specie furono descritte da Aiton in Hortus kewensis, il catalogo dei giardini reali di Kew che ne possedevano un'esclusiva collezione di 24 specie, diverse delle quali oggi assegnate ad altri generi della famiglia. Hibbert non voleva essere da meno e alla fine del 1798 o all'inizio del 1799 inviò in Sudafrica il giardiniere James Niven a fare raccolte di semi ed esemplari d'erbario; Niven rimase al Capo fino al 1803, quindi vi ritornò nel 1805, questa volta per un consorzio che oltre a Hibbert comprendeva il vivaio Lee e Kennedy (di cui secondo N. H. Steel Hibbert era "socio silente") e l'imperatrice Giuseppina, e vi rimase fino al 1812. Grazie alle sue raccolte, cui sia aggiunsero anche molte australiane, la collezione di Proteaceae di Hibbert divenne la più importante del mondo. Secondo le testimonianze del tempo, ne comprendeva circa 200 diverse specie che erano coltivate in vaso in una grande serra, dove trascorrevano i mesi invernali, per essere portate all'esterno nei mesi più caldi. Hibbert le affidò a un abilissimo giardiniere, Joseph Knight (1778-1855), che in precedenza aveva lavorato per il duca di Bedford; egli fu il primo in Europa a moltiplicarle tanto da talea quanto da seme. Hibbert (al contrario generoso con altre piante) era gelosissimo delle sue protee che scambiava solo con re Giorgio III e l'imperatrice Giuseppina. Nel 1809 Knight svelò i segreti della coltivazione delle preziose piante in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, a dispetto del titolo, riserva solo una dozzina di pagine all'argomento, mentre più di 100 sono dedicate a una revisione tassonomica della famiglia; benché non firmata, fu subito noto che l'autore di quest'ultima era Richard Salisbury. Ne seguì una polemica con Robert Brown e l'accusa di plagio rivolta a Salisbury, come ha raccontato in questo post. Qui ci interessa la prima parte, che documenta le tecniche di coltivazione applicate nel giardino e nella serra di Hibbert; inoltre ci rivela un altro aspetto del contraddittorio personaggio: la generosità. Dopo aver accennato alle raccolte di Thunberg e Masson, Knight infatti scrive "Un numero ancora più grande di specie sia note sia ignote sono poi state raccolte da Mr. James Niven, molte delle quali hanno fiorito a lungo in questo paese, ma da nessuna parte in modo così lussureggiante come nella collezione del mio precedente padrone, l'egregio George Hibbert di Clapham, grazie alla cui liberalità molte di esse sono ora in mio possesso". Dunque Hibbert cedette almeno alcune delle sue esclusivissime Proteaceae al suo capo giardiniere e probabilmente lo aiutò a mettersi in proprio; infatti nel 1808 Knight acquistò un terreno a Chelsea e lo trasformò in vivaio; poiché era affacciato sulla trafficata King Road, presto vi aggiunse un negozio (un antenato di un fornito garden center); inoltre nel 1829, quando si ritirò per andare a vivere in campagna, Hibbert passò a Knight tutte le sue piante vive. Con questa formidabile iniezione di rarità, il vivaio di Knight (più tardi Knight & Perry, quando venne gestito dal marito di una nipote del fondatore) divenne uno dei più importanti del paese, nonché il primo a commercializzare le Proteaceae. Ma nel giardino e nella serra di Clapham si coltivava anche molto altro; per scoprirlo basta sfogliare i fascioli di The Gardener's Repository o del Curtis's Botanical Magazine, dove il nome di Hibbert ricorre con grande frequenza; molte delle novità presentate in queste riviste fiorirono e furono ritratte per la prima volta a Clapham. A dominare sono ovviamente le sudafricane, grazie alle raccolte di Niven; ci sono molte bulbose e una ricca selezione di eriche, diverse delle quali sono presentate in Coloured Engravings of Heaths, l'opera più significativa di Henry Cranke Andrews, il genero di John Kennedy, nonché illustratore e editore di The Botanist's Repository; significativamente "G. Hibbert, Esq., Clapham Common, Surrey" è citato per primo nella lista delle sette persone ringraziate per aver permesso all'artista di ritrarre dal vivo le loro collezioni.  Questa pianta profumerebbe di più con un altro nome? Se le sudafricane dominavano, a Clapham c'erano però anche molte australiane; in effetti, anche se commerciava soprattutto con la Giamaica, Hibbert aveva qualche interesse anche nelle nuove rotte del Pacifico aperte dai viaggi di Cook; come armatore fu sicuramente coinvolto in alcuni dei trasporti interoceanici di piante organizzati da Banks (incluso quello degli alberi del pane, fortemente voluto dei piantatori delle Antille) e nel trasporto dei forzati a Botany Bay. Australiano è anche il genere Hibbertia, che gli fu dedicato da Andrews nel secondo numero di The botanist's repository. La motivazione ci dà un quadro illuminante (e magari un po' adulatorio) della reputazione botanica di Hibbert: "In precedenza è stato erroneamente assegnato al genere Dillenia, ma poiché differisce da ogni genere descritto in precedenza, gli ho dato il nome dell'egregio sig. G. Hibbert di Clapham, Surrey, la cui conoscenza e fervore per le ricerche botaniche, così come la sua liberalità nell'arricchire le nostre collezioni da tutti gli angoli del mondo, ma soprattutto dal Capo di Buona Speranza, non sono superate da nessuno; ne sono certo, nessun nome merita un posto nella memoria della botanica più di quello di Hibbert". E lo stesso Andrews (la cosa non stupisce) dedicò a Hibbert anche un'Erica, appunta E. hibbertia. Hibbertia è un grande genere della famiglia Dilleniaceae, anche se il numero di specie è altamente dibattutoi: si va dalle 150 generalmente assegnatogli nei data base australiani alle 350 riconosciute da Plants of the World on line; il centro di diversità è proprio l'Australia, con oltre 100 specie; altre vivono in Nuova Guinea e nelle isole del Pacifico, una in Madagascar. In inglese sono note sotto il nome comune guinea flower, non per la provenienza ma perché il colore e la forma dei loro fiori ricorderebbero quelli di una ghinea d'oro. La cifra del genere è la varietà. Sono per lo più arbusti eretti, ma c'è anche qualche rampicante, come la specie più nota, H. scandens, o arbusti prostrati che formano tappeti, come H. procumbens. Molto variabili le dimensioni: se molti sono piccoli arbusti non più alti di una decina di centimetri, la già citata H. scandens può superare i 5 metri. Le foglie sono intere, alternate, spesso raggruppate lungo brevi rami laterali, e nelle specie che vivono in zone aride sono ridotte; molto variabili le forme. Ancora più variabile la morfologia dei fiori; possono essere o meno protetti da brattee, hanno cinque sepali, quelli esterni leggermente sovrapposti a quelli interni, e cinque petali che possono essere disposti a simmetria radiale o a simmetria bilaterale; variabile pure il numero degli stami, da sei a oltre trenta, in genere raggruppati in gruppi di due o tre, in modo simmetrico o anche da un solo lato dei carpelli. La grande maggioranza delle specie ha fiori giallo vivo, ma in alcune specie i petali come H. stellaris o H. minita sono arancione. Sono indubbiamente piante graziosissime, di grande valore ornamentali, spesso anche profumate. E' giusto che portino il nome di un personaggio le cui idee "erano considerate abominevoli da molti critici già al suo tempo"? Il botanico australiano Kevin Thiele - che per inciso è un esperto di questo genere, una componente importante di molte comunità vegetali del suo paese - pensa di no, tanto più che questo grande genere continua ad essere arricchito da nuove scoperte e nuove denominazioni; e continua: "Proprio come si eliminano statue, nomi di edifici, strade e sobborghi, pensiamo che sia necessario fare i conti con i nomi di specie scientifiche che onorano persone che professavano idee o hanno agito in modi profondamente disonorevoli, altamente problematici o ripugnanti per gli standard moderni". La sua denuncia è stata ripresa da altri autori ed è sfociata nella proposta di modificare l'articolo 51 del Codice internazionale di nomenclatura, in modo che divenga possibile rigettare i nomi formalmente validi che riflettono "il potere coloniale e imperialista" o sono da ritenersi "culturalmente offensivi o inappropriati", compresi quelli che onorano "una persona che la comunità tassonomica ritiene concordemente non debba essere onorata". La proposta è sconvolgente perché mette in discussione i principi stessi su cui si fonda il Codice internazionale di nomenclatura: la stabilità della nomenclatura, la libertà scientifica e la neutralità politica della scienza. Più ancora dell'articolo 51, che recita "un nome legittimo non può essere rigettato solo perché esso, o il suo epiteto, è inappropriato o sgradevole", a traballare è lo stesso primo preambolo, dove si legge: "Lo scopo di questo Codice è fornire un metodo stabile per nominare i gruppi tassonomici, evitando o respingendo l'uso di nomi che possono causare errore o ambiguità o mettere la scienza in confusione. Ogni altra considerazione, come la correttezza grammaticale, la regolarità e l'eufonia dei nomi, le consuetudini più o meno prevalenti, il riguardo per le persone, nonostante la loro innegabile importanza, è relativamente accessoria". Alle considerazioni di Thiele e altri (potete leggere una delle più recenti versioni qui) ha risposto il botanico ucraino Sergei L. Mosyakin (il suo punto di vista qui), che le ha respinte con un'articolata argomentazione. Il dibattito è aperto, e forse avrà nuovi sviluppi in occasione del XX congresso botanico internazionale, che si terrà a Madrid tra il 21 e il 29 luglio 2024. Da parte mia considero queste piante deliziose non dedicate al discutibile Mr. Hibbert, ma a tutte le persone le cui sofferenze furono prolungate per causa sua. Esponente di spicco della scienza, della teologia e della politica svedese e finlandese della prima metà del Settecento, Johannes Browallius è poco noto al di fuori della Svezia e della Finlandia, tranne forse per l'abile difesa del sistema linneano contro gli attacchi di Siegesbeck. Più che per i suoi contributi originali (che scopriamo tutt'altro che secondari) all'estero è soprattutto un amico di Linneo o, magari, un ex-amico. Se sia vero o falso, scopriamolo insieme, anche seguendo le vicende delle denominazioni linneane delle specie del genere Browallia (Solanaceae) che si vuole riflettano gli alti e bassi di quella amicizia.  Linneo innamorato Nel dicembre del 1733, Linneo (all'epoca ventiseienne) fu invitato da uno dei suoi allievi ed amici, Claes Sohlberg, a trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia, a Falun, in Dalarna, dove il padre era ispettore minerario. Era una buona occasione per visitare la miniera di rame, per approfondire gli studi di mineralogia cui si era già accostato durante il viaggio in Lapponia, e magari per fare qualche conoscenza utile alla sua carriera scientifica. Non si sbagliava: strinse amicizia con il giovane teologo Johannes Browallius (1707-1755) con il quale aveva molto in comune: erano coetanei, avevano studiato ad Uppsala e soprattutto erano entrambi assetati di conoscenza. Il nuovo amico lo introdusse presso il governatore del Dalarna Niels Reuterholm, per il quale lavorava come cappellano, informatore scientifico e precettore dei figli. Entusiasta del racconto del viaggio in Lapponia, il governatore commissionò a Linneo una spedizione analoga nella regione, che in effetti avrebbe avuto luogo nell'estate successiva (3 luglio-17 agosto 1734). Fu un’ancora di salvezza per Linneo, che nel frattempo era stato allontanato dall’università di Uppsala in seguito al brutto affare con Niels Rosén. Al rientro dal viaggio, al quale avevano partecipato tra l’altro Sohlberg e i due figli di Reuterholm, si stabilì a Falun, dove il governatore gli concesse di utilizzare il laboratorio della miniera e di aprire una piccola accademia privata, dove insegnava mineralogia; era una soluzione di ripiego e senza grandi prospettive. Secondo Browallius, la vera soluzione era un’altra: doveva andare all’estero, laurearsi in medicina (le università svedesi non erano abilitate a farlo) e, una volta laureato, tornare in Svezia ad esercitare la professione. Non aveva i soldi per il viaggio? Allora era il caso di trovare una fidanzata ricca. Sembra che gli abbia anche proposto vari partiti, ma senza successo. La freccia di Cupido, infatti, aveva già trafitto il cuore di Linneo. Tra coloro che seguivano le sue conferenze, che in quella piccola località di montagna di meno di 7000 abitanti destarono una certa sensazione, c’era anche il medico cittadino Johan Moraeus; Linneo cominciò a frequentarne la casa e si innamorò di una delle sue figlie, la diciassettenne Sara Elizabeth detta Sara Lisa. Squattrinato com’era, è strano che pensasse a sposarsi (anche se il dottor Moraeus era agiato, aveva sette figli, e Sara Lisa non era certo l’ereditiera favoleggiata da Browallius), ma sembra che a deciderlo a quel passo sia stata la morte della madre, deceduta ad appena 44 anni. In ogni caso, intraprese un serrato corteggiamento che conosciamo a grandi linee grazie al suo diario privato (laconico ma esplicito). Il giorno di Natale 1734 Linneo fu invitato a pranzo a casa Moreus. Il 2 gennaio 1735, per fare colpo, vi andò in visita vestito con il famoso costume lappone. Il giorno dopo, ripeté la visita approfittando dell'assenza dei genitori. Seguirono altre visite e incontri in casa di amici comuni, finché il 16 gennaio ("un giorno di immortale commemorazione", scrisse nel suo diario) Linneo fece la sua proposta a Sara Lisa e fu accettato. Il 20 gennaio chiese la mano al padre, che era molto perplesso: lui stesso medico, sperava per la figlia un matrimonio finanziariamente più promettente; ancora più contraria era la madre. Alla fine il dottore cedette, ma pose due condizioni: il matrimonio sarebbe avvenuto entro tre anni e nel frattempo Linneo doveva andare all'estero a laurearsi in medicina, in modo da poter mantenere la futura famiglia (i pareri di Perpetua… ovvero di Browallius). Il 22 gennaio i fidanzati si scambiarono gli anelli e i voti di fedeltà. Fu deciso che Linneo sarebbe andato a laurearsi a Hardwijk, la più economica delle università olandesi; insieme a lui sarebbe partito Claes Sohlberg, il cui padre avrebbe pagato il viaggio del figlio e di Linneo; Sara Lisa gli passò sotto banco i suoi risparmi, un centinaio di corone, e, dopo baci e abbracci il 20 febbraio il neofidanzato lasciò Falun per la Svezia meridionale dove avrebbe salutato la famiglia, per poi partire per l’Olanda.  Una leggenda botanica L'amicizia con Linneo fu determinante anche per Browallius, che da quel momento intensificò i suoi interessi scientifici. Ispirato dalla spedizione lappone dell'amico, nel 1735 e nel 1736 intraprese due viaggi scientifici che dalla Dalarna lo portarono in Norvegia. Si mantenne in corrispondenza con Linneo (che, ad esempio, informò anche lui che si sarebbe trattenuto in Olanda essendo stato assunto come medico personale e curatore del giardino di Clifford) e nel 1737 gli spedì uno suo testo in svedese sulla necessità di introdurre l'insegnamento scientifico nelle scuole superiori, che Linneo tradusse in latino e pubblicò in appendice a Critica botanica, l'opera in cui dettò le regole per la formulazione dei nomi delle piante. Ma a un certo punto, secondo la vulgata, sarebbe successo un fattaccio che avrebbe messo fine alla loro amicizia. La versione più nota è quella del Curtis's Botanical Magazine (1838) che riprende e amplia una notizia del Codex botanicus linnaeanus di Hermann Richter (1837). Ecco dunque i fatti: mentre si trovava all’estero, qualcuno informò Linneo che Browaliius aveva approfittato della sua assenza per corteggiare Sara Lisa ed era quasi riuscito a convincerla a lasciare il fidanzato che, a quando le diceva, non aveva alcuna intenzione di tornare in Svezia. Fu una delusione cocente per Linneo che troverebbe riflesso nelle denominazioni delle tre specie del genere Browallia che egli aveva incautamente dedicato all’ex-amico: B. elata ("alto, elevato, nobile") rappresenterebbe il momento più alto della loro amicizia; B. demissa ("basso, debole, pendente" ma in questo caso "scoraggiato") la rottura, mentre B. alienata, oltre all'incerta natura di questa specie, la successiva separazione tra i due. Un’altra versione meno popolare (la troviamo ad esempio nella Revue scientifique, 1865) sostiene che Linneo chiamò la prima specie di Browalllia a lui nota B. demissa; aveva bei fiori, ma il suo portamento ricadente ben rifletteva l’atteggiamento umile, dimesso, di Browallius nei suoi confronti; egli si mantenne umile e rispettoso anche quando divenne vescovo, così Linneo chiamò B. elata una seconda specie più alta; con il tempo, però, il vecchio amico insuperbì e incominciò a trattare Linneo in modo ingiusto; così, quando venne scoperta una terza specie piena di spine fu la volta di B. alienata, a suggellare la fine di un’amicizia. Quanto c’è di vero in queste storie? Nulla, secondo la biografia di Linneo di Theodor Magnus Fries e Banjamin Daydin Jackson, che ritengono che alla base di questa vera e propria leggenda metropolitana ci sia un equivoco. Effettivamente tra Browallius e Linneo ci fu se non uno scontro, una differenza di vedute, ma non riguardava la mano di Sara Lisa, bensì il livello del mare. In un importante articolo supplicato dall’Accademia svedese delle scienze nel 1743, l’amico di Linneo Anders Celsius (colui che inventò la scala centimetrica delle temperature) spiegò l'innalzamento delle terre emerse con la lenta diminuzione del volume delle acque oceaniche; Linneo appoggiò questa tesi; vi si opposero invece altri studiosi, tra cui appunto Browallius in saggio pubblicato postumo nel 1756 in cui vi contrappose una grande massa di misurazioni che dimostravano il contrario. Ma torniamo a Browallia e proviamo a verificare se il piccolo affaire de coeur regge alla prova dei fatti. Nel 1735 Philip Miller ricevette da Panama i semi di una pianta che coltivò a Chelsea e chiamò Dalea; presumibilmente in occasione del suo viaggio in Inghilterra dell’estate del 1736, ne fece parte a Linneo che decise di dedicare la pianta, appartenente a un nuovo genere, all’amico Browallius; il genere Browallia compare per la prima volta proprio in Critica botanica (maggio 1737) tra le denominazioni dedicate a “celebri botanici” senza altre indicazioni che “a Browallius svedese, 1737”; nessuna indicazione neppure nella prima edizione di Genera plantarum, uscita a Leida lo stesso anno. Contemporaneamente Linneo stava scrivendo Hortus cliffortianus (sul frontespizio compare la data di stampa 1737, ma in realtà uscì nel 1738) dove invece troviamo una lunga e sperticata dedica in cui il “chiarissimo teologo e maestro Johannes Browallius” viene dipinto come un erudito universale, versato in ogni ramo delle scienze naturali dalla litografia alla botanica alla zoologia. Al genere è attribuita una sola specie, di cui viene dato il nome descrizione; il binomiale compare per la prima volta quasi vent’anni dopo, nella prima edizione di Species plantarum (1753) e non è nessuno di quelli citati, ma banalmente Browallia americana. I famosi nomi Browallia demissa, B. elata, B. alienata compaiono in quest’ordine (dunque demissa precede elata) solo nella decima edizione di Systema naturae (1758-59); Linneo si è convinto che ci siano almeno due specie di Browallia, una che reca un solo fiore per peduncolo, che chiama B. demissa; un’altra con fiori riuniti in mazzi, che chiama B. elata; ce n’è poi una terza alquanto differente, B. alienata, che in precedenza aveva classificato come Ruellia paniculata. Non c’è bisogno di evocare né love story né la superbia di Browallius per spiegare questi nomi: B. americana (è tornata a chiamarsi così per la regola della priorità) è una specie molto variabile che può avere portamento ricadente (demissus) o eretto (elatus); quanto a B. alienata, aveva ragione il Linneo del 1753: il nome corretto è Ruellia paniculata (ed appartiene a tutt'altra famiglia). Aggiungiamo ancora un dato: il 12 febbraio 1737 Browallius sposò Elisabet Ehrenholm. Come abbiamo visto, dopo la partenza di Linneo, anche lui si mise in viaggio e ritornò a Falum solo nell'autunno o nella tarda estate del 1736. Quando sarebbe avvento il fattaccio? Possiamo ipotizzare che nell’arco di pochi mesi Browallius abbia corteggiato Sara Lisa, sia stato respinto, per poi fidanzarsi e sposarsi con un’altra, e Linneo sia venuto a saperlo solo nella seconda metà del 1737 o addirittura nel 1738? La biografia di Browallius pubblicata dall'archivio di stato svedese ammette una breve rottura, subito ricomposta, ma le lodi sperticate di Linneo all'amico rendono poco credibile anche questa ipotesi. Tanto meno è credibile che abbia covato il suo astio per vent’anni, dandogli libero sfogo quando ormai Browallius era morto e sepolto. Tanto più che, come vedremo tra poco, aveva un debito di riconoscenza non da poco nei suoi confronti; testimonianze dirette e corrispondenza stanno lì a dimostrare che l'amicizia, magari affievolita dalla distanza e dagli impegni di entrambi, non venne mai meno. 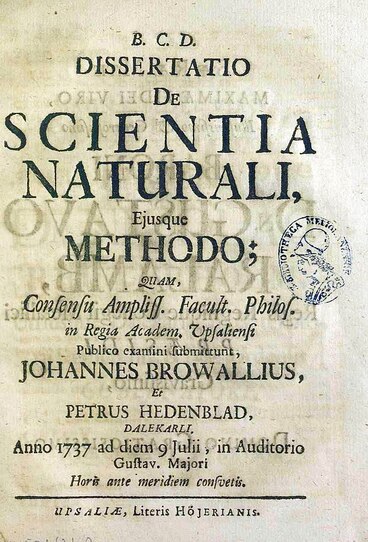 Uno scienziato, insegnante, pastore e politico molto impegnato Dissipata la nebbia delle leggende, veniamo al vero Browallius, una personalità di primo piano dell’Illuminismo svedese. Il 1737 per lui fu un anno di svolta; oltre a sposarsi, scrisse due importanti testi teorici che gli aprirono le porte dell'insegnamento universitario: il trattato De scientia naturali eiusque metodo, dedicato allo statuto e ai metodi delle scienze naturali, e un saggio in svedese di politica educativa in cui sosteneva l’utilità dell’introduzione dell’insegnamento della scienza nelle scuole, in particolare nei ginnasi (quello tradotto in latino da Linneo). Grazie ad essi, il cancelliere dell'Università di Abo/ Turku Ernst Johan Creutz ne caldeggiò la nomina a professore di fisica (un’etichetta che copriva un po’ tutte le scienze naturali): Browallius, versato in molte scienze, con un solido impianto teorico e aperto alla ricerca sperimentale, gli pareva la persona giusta per modernizzare l’insegnamento universitario aprendolo alle scienze esatte e naturali. La nomina di Browallius segnò per la Finlandia l'inizio di quella che è stata chiamata "età dell'utile", ovvero di un illuminismo che vedeva nella scienza lo strumento centrale per rinnovare l'economia e la società. Nominato professore nel novembre 1739, egli inaugurò il suo corso nel 1738 e mantenne la cattedra fino al 1746; le sue lezioni toccarono tutti i rami delle scienze naturali, nonché il loro intreccio con la teologia; seguì (o meglio scrisse, secondo l'uso del tempo) 49 tesi che toccano argomenti che spaziano dalla fisica sperimentale alla mineralogia, dalla chimica alla zoologia e alla botanica. Nelle sue lezioni insistette sull'utilità delle scienze applicate alla tecnica e all'economia; rifacendosi a Bacone, Newton e Linneo, il suo insegnamento aveva un carattere spiccatamente sperimentale. Lo sperimentalismo è particolarmente evidente nel campo della chimica, in cui il suo maggiore contributo furono le ricerche sull'arsenico, il suo ossido e il solfuro, che ne fanno il precursore del nipote Johann Gadolin (figlio di sua figlia Elisabet), considerato il fondatore della chimica finlandese. Riservò molta attenzione anche alla botanica. Come Linneo, accompagnava gli studenti in escursioni botaniche e lasciò manoscritta una flora finlandese; scrisse non meno di dodici trattati di argomento botanico, molti dei quali dedicati alla botanica economica. Ottenne che l'Università finanziasse ogni anno una borsa di studio per esperimenti botanici e coltivazioni sperimentali. Tra i suoi allievi il più noto è Pehr Kalm, che fu in un certo senso anche l'erede di questa impostazione scientifica fortemente ancorata all'economia. Sostenitore della prima ora del sistema linneano, di cui si può dire abbia visto la nascita discutendone con il creatore negli anni di Falun, Browallius esordì come scrittore scientifico nel 1739 con un trattato in sua difesa che gli diede anche una certa rinomanza all'estero, oltre a rendere all'amico un servizio incommensurabile. Linneo era tornato in Svezia alla fine del giugno 1738; andò subito a Falun, ma anziché rimanervi come assistente del suocero, come questi aveva progettato, decise di esercitare la professione a Stoccolma, dove avrebbe avuto più possibilità di lanciare la sua carriera scientifica, forte dei tanti scritti epocali pubblicati in Olanda e della crescente fama europea. Scoprì amaramente che i due pamphlet di Siegesbeck che presentavano il suo sistema come "pornografia botanica" gli avevano fatto intorno terra bruciata; come scrisse a Albrecht von Haller, forse con un po' di esagerazione, era diventato la favola della città, tanto che gli era difficile persino trovare un servitore disposto a lavorare per lui e nessuno gli avrebbe fatto curare neppure un cane. A suo tempo aveva promesso a Boerhaave di non farsi trascinare in una nessun disputa scientifica e non intendeva rispondere di persona; a farlo per lui fu dunque Browallius. In Examen epicriseos in Systema plantarum sexuale Cl. Linnaei, Anno 1737 Petropoli evulgatae, auctore Jo. Georgio Siegesbeck, pubblicato nel 1739, egli smontò punto per punto le critiche di Siegesbeck, dimostrandone l'infondatezza tanto scientifica quanto morale e teologica; un solo rilievo poteva essere mosso al sistema linneano: una medesima classe poteva riunire piante molto diverse; era però un difetto comune a tutti i sistemi artificiali, che sarebbe stato superato solo quando fosse stato possibile stabilire un sistema naturale, verso il quale il sistema di Linneo era un passo avanti, visto che conteneva più gruppi naturali di ogni sistema precedente. La serrata e lucida argomentazione (che certo fu discussa e preparata con lo stesso Linneo) ristabilì l'onore scientifico e personale del "principe dei botanici", tanto più che l'aveva scritta un teologo e un rispettato ecclesiastico. Browallius, infatti, affiancava all'attività scientifica e didattica un forte impegno pastorale: fin dal 1738 fu nominato vicario della parrocchia di Pikis, che forniva le prebende da cui dipendeva la sopravvivenza dell'Università; come predicatore, dovette imparare il finlandese e lo fece così bene e in fretta che presto fu coinvolto nella revisione della nuova Bibbia della chiesa finlandese. Nel 1740 presentò la tesi De coercitione hereticorum e fu dichiarato dottore in teologia; lo stesso anno fu promosso diacono e vicario della parrocchia di Turku. Nel 1746 lascò la facoltà di filosofia per assumere la cattedra di teologia; nel 1749 divenne vescovo della diocesi di Abo/ Turku. L'ascesa nella gerarchia ecclesiastica promosse la sua carriera politica. Benché il suo primo sponsor fosse stato Ernst Johan Creutz, noto esponente del partito dei berretti, Browallius si schierò con i "cappelli", la cui politica culturale includeva la promozione delle scienze ritenute utili e l'estensione dell'uso dello svedese a discapito del latino. Scelto come esponente del clero nel parlamento del 1746-47, sostenne vigorosamente le posizioni del partito dei cappelli, entrando a far parte di varie commissioni. Ancora più rilevante fu il suo ruolo nel parlamento del 1751-52 come membro del comitato segreto; nell'ambito della discussione sui principi dello stato nel memoriale Sui concetti fondamentali della forma del governo sostenne la sovranità popolare espressa in forma repubblicana, rifacendosi ai costituzionalisti inglesi e al pensiero di Locke. Nello stesso spirito, chiese che l'educazione del principe ereditario includesse fin dall'inizio l'avversione per l'autocrazia, "contraria alla legge di natura e all'economicità". Ovviamente, anche se ottenere qualche ascolto, queste posizioni non furono divulgate all'esterno del Consiglio segreto. In ogni caso, Browallius era probabilmente sulla strada di diventare arcivescovo, quando morì improvvisamente nel 1755, a soli 48 anni.  Fiori di zaffiro Browallia L. è un piccolo genere di erbacee annuali o perenni della famiglia Solanaceae, diffuse dall'Arizona alle Ande tropicali, passando per il Messico, l'America centrale e le Antille. Assai discusso il numero di specie attribuite, che a seconda degli autori varia da 6-7 a 19; è affine al genere monotipico Streptosolen, la cui unica specie S. jamesonii era un tempo classificata come B. jamesonii. Il diverso numero delle specie riconosciute è legato alla variabilità morfologica delle specie stesse (che, come abbiamo visto, trasse in inganno già Linneo) ma soprattutto a scoperte recenti in particolare nell'area peruviana, dove a partire dal 1995 alla lista della specie note è venuta ad aggiungersi una dozzina di specie scoperte dal team coordinato da S. Leiva Gonzales, il quale è il primo a riconoscere che "il genere richiede maggiori osservazioni sul campo, studi cito-genetici e molecolari per poter delimitare le specie". Le nuove arrivate non sono solo peruviane, tanto più che qualche specie sembra fatta apposta per eludere le ricerche dei botanici, come è il caso di B. eludens: fu descritta per la prima volta nel 1993 ed oggi ne sono conosciute popolazioni disgiunte in una singola località dell'Arizona sud-orientale e in poche località negli stati messicani di Chihahua e Sonora, dove sembra confinata ad habitat con estati temperate e umide lungo i confini delle boscaglie sempreverdi della Sierra madre occidentale. E' un'annuale strettamente legata al regime delle piogge, con un breve ciclo vitale; il che significa che negli anni di scarsa pioggia può scomparire ed essere più abbondante dove trova l'habitat giusto. Si distingue dalle altre specie per i fusti non ramificati e per i fiori bianchi. Per variabilità la campionessa sembra essere la specie tipo B. americana, che infatti ha collezionato una ventina di sinonimi: variano il portamento, eretto oppure decombente, le dimensioni, la presenza o l'assenza di peli ghiandolari, la forma e la dimensione delle foglie, il colore dei fiori (bianchi, azzurri, azzurri con una macchia bianca, malva, viola) solitari o riuniti in piccoli gruppi. Anche se non sono molto grandi, sono molto numerosi, rendendo questa specie decisamente decorativa; è dunque una pianta da giardino molto apprezzata, soprattutto in una delle sue varietà con fiori più grandi, spesso commercializzata sotto il sinonimo B. grandiflora. Come annuale da giardino, è coltivata anche B. viscosa, caratterizzata da fiori blu con centro bianco La specie più diffusa in case e giardini è però B. speciosa, originaria di Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Perù; è perenne, ma da noi è spesso trattata come annuale. Di portamento piuttosto cespuglioso e ramificato, adatta anche alla coltivazione in vaso e in cestini appesi, sta conoscendo una crescente popolarità per il colore insolito dei fiori blu-viola, cui deve il nome comune fior di zaffiro, l'abbondanza dei fiori, che può essere favorita da opportune cimature, e il lungo periodo di fioritura, che si protrae da giugno a settembre. Tra le varietà più note 'Blue Troll', di portamento compatto con fiori blu e centro bianco, e 'White Troll' con fiori bianchi. Viene anche commercializzata come pianta d'appartamento, spesso trattata con nanizzanti per mantenere il portamento compatto. L'ultima novità sono gli ibridi, caratterizzati da fioriture prolungate e da fiori particolarmente grandi e numerosi, come 'Illumination' (blu scuro) e 'Flirtation' (bianca) della serie Endless, indicati anche per aree in mezz'ombra. Linneo soprannominò eristici, ovvero seguaci di Eris, la dea della discordia, i botanici delle generazioni immediatamente precedenti, impegnati in polemiche tanto feroci quanto sterili a difesa dei rispettivi sistemi di classificazione delle piante. Il più litigioso era indubbiamente lo scozzese Robert Morison, che non si peritava ad attaccare a testa bassa i botanici del passato e del presente, definendo i loro errori "allucinazioni". Da loro pretendeva di non aver appreso nulla e di aver tratto il suo nuovo metodo dalla natura stessa; molto probabilmente a ispirarglielo era stato invece Cesalpino, che però non cita mai. Pagò cara questa arroganza: i botanici successivi lo ripagarono della stessa moneta, attingendo alla sua opera pionieristica sotto traccia e censurando con altrettanta asprezza le sue pretese. Tra i critici più recisi lo stesso Linneo, che tuttavia gli dedicò il genere Morisonia (Capparaceae), che, manco a farlo apposta, suscita polemiche altrettanto roventi. 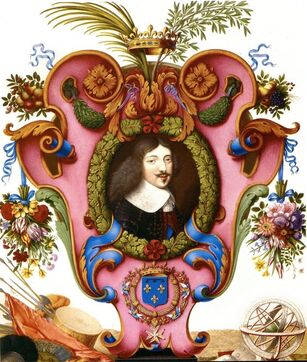 Formazione: Francia, Parigi e Blois Nel 1637, contro la pretesa del re d'Inghilterra Carlo I di imporre vescovi di propria scelta e un nuovo libro di preghiere sul modello anglicano, i presbiteriani scozzesi, con un patto giurato (Covenant) proclamarono che avrebbero difeso la loro fede fino alla morte. Ben presto si arrivò alla guerra aperta (prima e seconda guerra dei vescovi, 1639-1640), preludio alla rivoluzione inglese che avrebbe portato alla decapitazione del re e all'instaurazione del Commonwealth. Il solo fatto militare di una certa importanza della Prima guerra dei vescovi fu la battaglia del Bridge of Dee (18-19 giugno 1639) con la quale i Covenanter riuscirono a strappare alle truppe fedeli al re il controllo del ponte che dava accesso alla città di Aberdeen; tra coloro che militavano nell'esercito realista c'era anche il diciannovenne Robert Morison (1620-1683) che rimase gravemente ferito alla testa. Dopo la guarigione, come altri oppositori dei Covenanter che ormai controllavano la Scozia, decise di lasciare il paese e di rifugiarsi in Francia. Ci sarebbe rimasto vent'anni, cambiando del tutto il proprio destino. Anziché uomo di Chiesa, come avrebbe voluto la famiglia, divenne medico, naturalista e botanico. A Parigi, il suo primo rifugio, oltre a mantenersi come precettore del figlio di un certo consigliere Bizet, poté seguire lezioni di anatomia, zoologia, mineralogia, chimica e botanica, presumibilmente nel neonato Jardin des Plantes, dove fu allievo di Vespasien Robin. Nel 1648 si laureò in medicina a Angers, quindi nel 1649 o 1650, su raccomandazione di Robin, entrò al servizio dello zio del re, il principe Gastone d'Orlèans. Vale la pena di dedicare qualche riga a questo personaggio, che Morison proclamerà "patrono di tutti i botanici e mecenate veramente regale, versatissimo nell'arte botanica", tanto più che gli sono stati dedicati ben due generi di piante (entrambi oggi ridotti a sinonimi): Borbonia da parte di Plumier e Gastonia da parte di Commerson. Come politico, il duca d'Orlèans gode pessima stampa: intrigante e inconcludente, coinvolto in mille congiure tutte finite male, pronto a salvare la pelle abbandonando i suoi seguaci; brilla invece come mecenate delle arti e delle scienze, creatore della più vasta collezione di medaglie e antichità d'Europa, di una prestigiosa biblioteca, di un gabinetto scientifico e di collezioni d'arte. Della botanica era cultore più che dilettante grazie agli insegnamenti del medico che lo seguiva fin dalla nascita, il protestante Abel Brunier (o Brunyer, 1572-1665). Testimonianze del tempo riferiscono che conoscesse a memoria il nome di "tutte le erbe" (i comodi nomi binomiali di Linneo erano al di là da venire: siamo ancora all'epoca dei nomi-descrizione) e che amasse erborizzare, tanto che scoprì una nuova specie di trifoglio. A partire dal 1635, quando si stabilì a Blois al ritorno di un periodo di esilio, egli affidò a Brunyer, assistito dal secondo medico Jean Laugier e dal farmacista Nicolas Marchand (o Marchant), la creazione di un orto botanico, per il quale non lesinò attenzioni e spese. Dal 1644, ne fece anche immortalare le rarità su pergamena dall'abilissimo pittore Nicolas Robert: è l'inizio della spettacolare collezione nota come "Vélins du Roi". Tuttavia, dopo la morte di Richelieu nel 1642, egli si gettò nuovamente nell'agone politico e tornò a vivere a corte, portando con sé Brunyer, che per altro era ormai sulla settantina. Affidato ad altre mani, il giardino fu forzatamente trascurato. Dunque l'ingaggio di Morison, come terzo medico e botanico, era più che opportuno. E tanto più lo diverrà nel 1652, quando Mazzarino confinò il duca a Blois. Collezioni e piante divenivano ora la sola ragione di vita del principe sconfitto. Mentre l'anziano Brunyer rimaneva al suo fianco e allestiva il catalogo del giardino (Hortus Regius Blesensis, 1° ed. 1653, 2° ed. 1655), Laugier, Marchand e Morison venivano sguinzagliati per tutta la Francia alla ricerca di piante rare: come riferisce egli stesso, lo scozzese fu in Borgogna, Poitou, Bretagna (di cui esplorò le coste e le isole), Linguadoca e Provenza. Nel 1657, insieme a Laugier, esplorò l'area di La Rochelle, dove recensì 84 specie. Nel febbraio 1660 Gastone morì all'improvviso, lasciando erede delle sue collezioni il nipote Luigi XIV. Il giardino venne smantellato e Marchand, nominato direttore della coltivazione delle piante del Jardin du roi, fu incaricato di trasferire le piante nell'orto botanico parigino; anche Robert passò al servizio del re Sole, come "pittore ordinario del re per la miniatura". Una sistemazione fu offerta anche a Morison, ma eli preferì seguire in Inghilterra Carlo II, che proprio quell'anno aveva recuperato il trono. Il botanico lo aveva conosciuto proprio a Blois, durante una delle visite del re in esilio allo zio Gastone (Carlo II era figlio di Carlo I e di sua moglie Enrichetta, sorella di Luigi XIII e del duca d'Orlèans). Questa frequentazione altolocata non era l'unico lascito del decennale soggiorno a Blois. Fu quell'ambiente aperto e stimolante a fare nascere l'interesse di Morison per la classificazione delle piante. Tanto Brunyer quanto Laugier erano uomini di Montpellier: il secondo fu il maestro di Magnol, il primo sembra fosse alla ricerca di un metodo di classificazione razionale (non se ne trova però traccia nelle due edizioni del suo catalogo, semplici elenchi alfabetici). Nella fornitissima biblioteca del suo patrono, Morison poté leggere le principali opere dei botanici precedenti: De plantis di Cesalpino, l'Ekphrasis di Colonna, le opere dei fratelli Bauhin; sicuramente gli era nota anche l'opera di Boccone, che poi avrebbe contribuito a far conoscere in Inghilterra. Possiamo ipotizzare che il suo metodo sia nato dalla congiunzione tra queste letture, la ricerca sul campo e il confronto con il suo secondo maestro Abel Brunyer. Più tardi, egli lo negherà recisamente, proclamandolo un "nuovo metodo dato dalla natura, solo da me (senza arroganza) osservata, trovato da nessuno se non da me stesso". 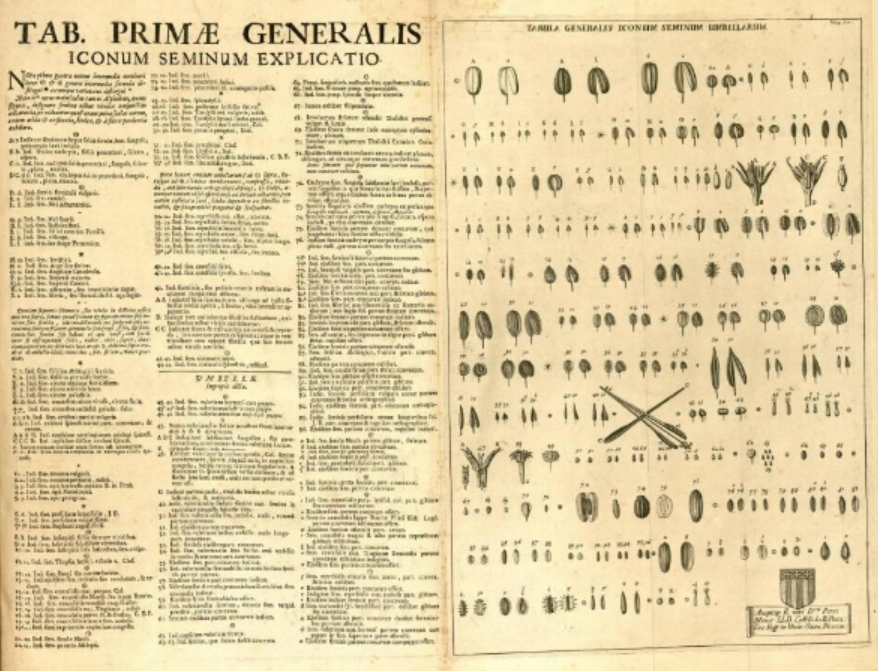 Maturità: Inghilterra, Londra e Oxford Carlo II, che a sua volta era vissuto in esilio quasi dieci anni, non di rado trattato alla stregua di un parente povero, provava ammirazione e riconoscenza per il botanico scozzese che aveva subito un lungo esilio per la causa della sua famiglia; lo nominò proprio medico personale e responsabile dei giardini reali, assegnandogli una casa a Londra e uno stipendio di 200 sterline. All'inizio del 1669, Morison pubblicò la sua prima opera, Praeludia botanica, un volume miscellaneo che riunisce tre lavori probabilmente scritti in momenti diversi. Di un certo interesse la dedica a Carlo II, in cui egli riferisce che, quando era al servizio del duca di Orlèans, aveva delineato un nuovo sistema di classificazione delle piante e che il duca gli aveva promesso di finanziare la pubblicazione di un libro per illustrarlo; ma la morte improvvisa del suo protettore aveva infranto le sue speranze. Ora si rivolgeva al re d'Inghilterra, degno nipote di tanto zio, per realizzare quel progetto che avrebbe d'un colpo reso la botanica inglese più illustre di quella italiana, francese o tedesca. La prima parte (e più cospicua del volume) è la terza edizione del catalogo dell'orto botanico di Blois, un elenco di circa 2600 piante, 260 delle quale sono indicate come nuove e sono descritte dettagliatamente in appendice. La seconda parte, Hallucinationes Caspari Bauhini in Pinace, item Animadversiones in tres Tomos Universalis Historiae Johannis Bauhini, è un feroce attacco contro gli errori di nomenclatura e classificazione dei fratelli Bauhin, puntigliosamente (e spesso non a torto) corretti e qualificati di "allucinazioni". La terza parte, Dialogus inter Socium Collegii Regii Gresham dicti et Botanographum Regium, è un dialogo sulla classificazione della piante tra se stesso e un membro della Royal Society. Morison magnifica la superiorità del proprio metodo, ma non lo descrive, limitandosi ad asserire, sulla scorta di Boccone, che la "nota generica" non deve essere tratta né dalle proprietà medicinali né dalla forma delle foglie, ma dalla fruttificazione, cioè dai fiori e dai frutti; non manca poi di stigmatizzare come "caos e confusione", pur senza citare in modo esplicito né l'opera né l'autore, il sistema elaborato da John Ray per le Tavole botaniche incluse nel saggio del vescovo Wilkin An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (1668). E' l'inizio di una frattura insanabile tra i due padri fondatori della sistematica britannica. Poco dopo l'uscita del libro, l'Università di Oxford gli offrì la cattedra di botanica: voluta da lord Danby all'atto di fondazione dell'Orto botanico di Oxford nel 1621, diventava effettiva solo ora, dopo un'attesa di quasi mezzo secolo. Era la prima in tutto il territorio britannico. Morison accettò e prese il nuovo incarico molto seriamente. I corsi si svolgevano nell'orto botanico per cinque settimane, nella bella stagione; una testimonianza del tempo ricorda che tre volte alla settimana il professore prendeva posto dietro un tavolo, posto al centro del guardino e colmo di piante, e le illustrava a studenti e uditori, che riusciva ad affascinare nonostante il duro accento scozzese. Per il resto dell'anno, tutto il suo impegno andava alla stesura dell'opera sognata per tutta la vita: se erano mancati i finanziamenti di due patroni regali, Gastone e Carlo II, ora Morison aveva trovato nell'Università di Oxford un sponsor disposto a pubblicare la sua opera, grazie soprattutto al sostegno dei fondatori dell'Oxford University Press John Fell del Christ Church e Obadiah Walker dell'University College. La grande opera, intitolata significativamente Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis seu Herbarum distributio Nova per Tabulas Cognationis & Affinitatis ex Libro Naturae Observatae & Detectae, sarebbe stata il fiore all'occhiello della nova casa editrice e sarebbe stata riccamente illustrata. Morison ne diede un primo saggio in Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova, pubblicato dalla casa editrice universitaria nel 1672. E' un fascicolo pilota il cui scopo fondamentare è sollecitare sottoscrizioni e donazioni per Historia universalis, di cui le Umbelliferae costituiranno la sezione IX; ecco perché nella Prefazione vengono finalmente presentati i principi del "nuovo metodo": "Il metodo è l'anima di ogni conoscenza: dunque in questa trattazione delle umbellifere, come pure in quella universale di tutte le piante, che promettiamo, mostreremo le note generiche ed essenziali tratte dai semi e dalla loro somiglianza, disponendo le specie in tavole sulla base di parentele e affinità. Aggiungeremo differenze specifiche tratte dalle parti meno nobili, ovvero radice, foglie, fusti, odore, sapore, colore, raccogliendo le singole specie sotto i singoli generi: in tal modo, specie riconoscibili per il diverso aspetto si schiereranno sotto generi intermedi, generi intermedi sotto generi supremi [ovvero tribù o famiglie], ciascuno distinto dalle proprietà essenziali e sempre nello stesso modo. Questo è l'ordine che la natura stessa ha dato alle piante, da me osservato per primo". Segue la trattazione delle piante con infiorescenza ad umbella, classificate sulla base delle caratteristiche dei semi, integrate con quelle di altri organi come le foglie. Morison distingue le Umbelliferae vere e proprie dalle Umbellae improprie dicto, dove troviamo generi come Valeriana, Filipendula e Thalictrum, e determina con chiarezza generi e gruppi di generi, le cui parentele e affinità sono illustrare da otto diagrammi (tabulas cognationis & affinatatis). La prima delle venti tavole calcografiche (le altre sono dedicate a specie nuove o meno note) raffigura le principali categorie di semi, sintetizzate nelle didascalie esplicative della pagina a fronte. Fin qui, la pars contruens; per non smentirsi, c'è anche la pars destruens, ovvero una quindicina di pagine dedicate alle Hallucinationes Caspari Bauhini, aliorum auctorum. La monografia, la prima dedicata a una famiglia e illustrata da tavole calcografiche, è una brillante riuscita. Del resto, il soggetto del fascicolo di lancio non è stato scelto a caso: da una parte, questa famiglia è stata una delle prime ad essere identificata (da Dodoens nel 1583); dall'altra, anche oggi pnel suo ambito i frutti e i semi sono determinanti per una corretta identificazione. Applicare il metodo all'universo modo delle piante è un'altra faccenda. Più difficile ancora trovare i soldi per continuare l'opera, costosissima proprio per il ruolo essenziale delle immagini. Il progetto prevede tre libri, il primo dedicato agli alberi e agli arbusti, gli altri due alle piante erbacee. Conscio della difficoltà dell'impresa, Morison parte da queste ultime, le più numerose e difficili da classificare, e nel 1680 esce finalmente la Pars secunda dell'Historia universalis, che contiene cinque delle quindici sezioni previste per le erbacee (De bacciferis, De leguminis, De siliquosis tetrapetalis bivalvis, De hexapetalis tricapsularis, De tricapsularis lactescentibus). Il risultato è inferiore alle attese: Morison per primo non si attiene al proprio metodo e le incongruenze abbondano. Non parliamo poi dell'aspetto finanziario: nonostante le sottoscrizioni di alcuni membri della Royal Society e del Collegio reale dei medici, egli è costretto a indebitarsi pesantemente con l'University Press. Comunque continua a lavorare alacremente al terzo volume; ma nel 1683, muore in seguito a un incidente stradale in cui incorre attraversando Charing Cross.  Morisonia: le allucinazioni dei botanici continuano? Come abbiamo visto in questo post, sarà il diligente Jacob Bobart il Giovane a portare a termine il secondo volume. Il primo invece non uscirà mai. La casa editrice universitaria sarà per anni schiacciata dal debito di questa opera innovativa e audace, che non mancherà di influenzare i botanici successivi, mentre l'Università di Oxford si troverà per anni impelagata in una causa legale con la vedova per la proprietà dell'erbario. Il metodo di Morison fa scuola soprattutto in Germania: i suoi seguaci più entusiasti sono i fruttisti (secondo la terminologia di Linneo) Paul Amman, Christoph Knaut e Paul Hermann. In patria, gli nuocciono il carattere terribile e le offese a Ray, il cui metodo ben presto surclasserà il suo. A Morison è invece riservata una vera e propria damnatio memoriae. Più sotterraneo, ma determinante, l'influsso su Joseph Pitton de Tournefort, che dal botanico scozzese trarrà senza dubbio insegnamento per la precisa determinazione dei generi e la distinzione tra genere e specie. Ma la sua arroganza gli spiacerà sommamente, e non gli perdonerà di aver saccheggiato i botanici precedenti senza neppure citarli. Così si esprime in Elemens de botanique: "E' impossibile lodare a sufficienza questo autore. Ma mi sembra che si lodi già troppo da sé; perché invece di accontentarsi della gloria di aver partecipato al più bel progetto che si sia mai fatto in botanica, osa paragonare le proprie scoperte a quelle di Cristoforo Colombo, e senza parlare di Gessner, Cesalpino e Colonna, in molti luoghi delle sue opere afferma di non avere appreso nulla se non dalla natura. Gli si sarebbe potuto credere sulla parola, se non si fosse preso la pena di trascrivere pagine di questi due ultimi autori; dal che si vede che gli erano molto familiari. Il sig. Ray senza fare tanto chiasso è riuscito molto più di lui". I sospetti di Tournefort erano più che fondati; gli studiosi successivi hanno rilevato interi passi presi di peso da Cesalpino, che Morison conosceva benissimo ma non nomina mai: nella biblioteca di Oxford si trova una copia di De plantis fittamente annotata di sua mano. Quanto a Linneo (che guardava con un po' di sufficienza a questi predecessori in eterna lite tra di loro, tanto che li soprannominò Eristici, seguaci di Eris, la dea della discordia), in una lettera a Albrecht von Haller ne riconosce i meriti, ma conclude con una condanna senza appello: "Morison era vanitoso, ma gli va dato il merito di aver rinnovato un sistema mezzo morto. Se si osservano i generi di Tournefort, si deve ammettere quanto debba a Morison, tanto quanto questi doveva a Cesalpino, sebbene Tournefort stesso sia un ricercatore coscienzioso. Tutto ciò che c'è di buono in Morison è preso da Cesalpino, senza la cui guida egli si perde alla ricerca più di affinità naturali che di caratteristiche distintive". In ogni caso, riprendendo un suggerimento di Plumier, riserverà anche a lui la gloria di un genere botanico, Morisonia L., famiglia Capparaceae. E qui finiamo in una polemica non indegna dell'astioso dedicatario. La delimitazione in generi di questa famiglia nelle Americhe ha dato più di un grattacapo ai tassonomisti; tradizionalmente, la maggior parte delle specie erano assegnate a Capparis, affiancato da una serie di generi minori, tra cui appunto Morisonia, con circa otto specie. Questo amplissimo Capparis risultava però artificiale (polifiletico) e da qualche anno la linea prevalente è limitarlo alle specie del Vecchio Mondo. Quanto a quelle americane, alcuni ricercatori hanno iniziato a staccarne una serie di piccoli generi, finché nel 2018 nel quarto volume di The Global Flora è comparsa una nuova trattazione che ha incluso in Morisonia gran parte delle Capparaceae in precedenza assegnate a Capparis, allargandone i confini a oltre ottanta specie. La risposta di Xavier Cornejo (specialista di Capparaceae e principale fautore della divisione di Capparis in molti piccoli generi) non si è fatta attendere: in un articolo comparso lo stesso anno ha criticato aspramente questa soluzione, rilevando che, così inteso, Morisonia presenta una tale varietà di forme e comportamenti da diventare "un genere innaturale e difficile da comprendere". Dopo una pagina di critiche serrate, egli conclude che "la nomenclatura proposta [...] non ha supporto né morfologico né molecolare. Dunque nessuna di queste combinazioni ha valore nomenclatorio e va ridotta a sinonimi". Allucinazioni, avrebbe detto Morison. Ma noi viviamo in un'epoca più cortese (o forse più ipocrita). In attesa di futuri sviluppi che certo non mancheranno, conviene attenersi alle poche certezze: comunque venga inteso (con le ottanta e più specie di Morisonia sensu lato o le otto di Morisonia sensu stricto), si tratta di arbusti o alberelli del sottobosco delle boscaglie e delle foreste stagionalmente aride di Messico, Antille, Centro e Sud America. Sicuramente continuerà a farne parte la specie tipo di Linneo, M. americana; chiamata in inglese Ratapple, "mela dei ratti", nei paesi latino americani è conosciuta con tanti nomi che variano da un luogo all'altro: chocolatillo, zapote blanco, arbol del Diablo. E' un piccolo arbusto del sottobosco delle foreste aride caducifoglie, distribuito dal Messico all'Argentina settentrionale, attraverso le Antille; la caratteristica più notevole sono i piccoli frutti sferici con spessa corteccia marroncina e polpa biancastra edule usata come emolliente, con proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie. Qualche approfondimento nella scheda. Tra le piante più venerabili del Jardin des plantes di Parigi, c'è un albero di pistacchio famoso non solo per la sua età (un po' più tre secoli) ma per aver permesso a Sébastien Vaillant di comprendere i meccanismi della riproduzione sessuale delle piante. Quando egli presentò i risultati in pubblico, le sue parole destarono scandalo, forse anche perché non risparmiò le metafore antropomorfe. Linneo ne aveva invece grande stima e considerava il suo Botanicon parisiense il vero inizio della botanica moderna. Riprendendo una denominazione di Tournefort, lo celebrò con Valantia, un piccolo genere che annovera anche due rari endemismi siciliani.  Scandalose nozze delle piante Il 10 giugno 1717, tra gli studenti che affollavano l'anfiteatro del Jardin royal c'era una certa attesa per la prolusione con la quale Sébastien Vaillant (1669-1722) avrebbe inaugurato il corso di botanica. Vaillant, che lavorava nel giardino già da una quindicina di anni e da una decina era sotto dimostratore (l'insegnante "pratico" che mostrava come riconoscere le piante) non era certo una faccia nuova. Ma quell'anno avrebbe tenuto anche il corso teorico, come supplente del professore titolare, il dimostratore Antoine de Jussieu, in missione botanica nella penisola iberica. Forse in quel che successe quel giorno c'entrò anche un pizzico di spirito di rivalsa. Al contrario di Jussieu, medico e accademico di Francia, Vaillant aveva fatto la gavetta e non aveva titoli accademici. Nato in una famiglia contadina, inizialmente aveva ricevuto una formazione come musicista; poi era divenuto chirurgo (ricordo che all'epoca i chirurghi non erano laureati, ma artigiani che imparavano il mestiere con l'apprendistato), lavorando prima nell'esercito poi all'Hôtel-Dieu di Parigi. Incominciò così a seguire i corsi di botanica, chimica, anatomia del Jardin royal. Appassionato raccoglitore, fu d'aiuto a Tournefort per la sua flora dei dintorni di Parigi Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Fu notato da Fagon che ne fece il suo segretario. Nel 1702 gli fece ottenere il brevetto di «inserviente del laboratorio del Giardino reale», un titolo modesto che ne faceva il responsabile delle coltivazioni. Nel 1708, gli cedette il suo posto di sotto dimostratore di botanica, mentre a Tournefort, morto quell’anno, succedeva come professore il medico Antoine-Tristan Danty d’Isnard. Dopo appena un anno, quest’ultimo diede le dimissioni; Vaillant, che dal 1709 era stato nominato anche direttore del Gabinetto reale delle droghe, sarebbe stato il più qualificato ad assumere la cattedra, ma non era né medico né laureato. Così il posto andò a un outsider, il medico lionese Antoine de Jussieu che aveva solo ventiquattro anni, diciassette meno di lui. Tra i due c'era anche una certa rivalità scientifica: Jussieu era uno stretto seguace di Tournefort, mentre Vaillant aveva espresso da tempo riserve su Institutiones rei herbriae e conduceva ricerche sperimentali che lo stavano portando su strade nuove. E qui entra in scena il famoso pistacchio (Pistacia vera). Era nato nei primi anni del secolo dai semi portati dal Levante da Tournefort, prosperava, fioriva, ma non portava frutti. Vaillant venne a sapere che anche nel Giardino dei farmacisti ce n'era uno, con fiori diversi, che ugualmente fioriva senza fruttificare. Nel 1716 tagliò una fronda fiorita del pistacchio del Jardin e la scosse presso l’altro albero e viceversa. Poco tempo dopo l'albero del Giardino dei farmacisti (un esemplare femminile), così fecondato, diede i primi frutti, cosa che non fece quello del Jardin des plantes, maschio. Era la prova che serviva a Vaillant per spiegare la funzione del polline. Così decise di inaugurare il corso di botanica del 1717 con una prolusione dedicata alla funzione sessuale dei fiori. Che le piante avessero organi sessuali e che una pianta potesse portare solo fiori maschili, solo fiori femminili, oppure fiori sia femminili sia maschili non era un’idea nuova. All'inizio del Seicento, era stata suggerita da Prospero Alpini; nel 1681 Nehemiah Grew ipotizzò che gli stami fossero gli organi maschili e in Historia plantarum (1686) Ray portò numerosi esempi di piante dioiche; nel 1694 il tedesco Rudolph Camerarius in De sexu plantarum epistola diede la dimostrazione sperimentale della funzione del polline. Tuttavia, oltre ad essere ancora inaccettabile per l’opinione pubblica, la sessualità delle piante era stata respinta proprio dal maestro di Vaillant, Joseph Pitton de Tournefort, che riteneva il polline un «escremento» delle piante. Vaillant, oltre tutto, entrò in campo a gamba tesa, usando metafore antropomorfe e sessualmente esplicite, con espressioni come «letto nuziale», «consumare il matrimonio», «questi focosi non sembrano che cercare altro che soddisfare i loro violenti trasporti». Gli studenti furono elettrizzati, i professori dell’Accademia delle scienze un po’ meno. A indignare era anche il fatto che Vaillant avesse osato criticare un mostro sacro come Tournefort, mostrando quella che veniva considerata vera e propria ingratitudine. L'Accademia, alla quale Vaillant era stata ammesso nel 1716 (prima del fattaccio) arrivò addirittura ad ammonirlo ufficialmente di non attaccare più il suo maestro. Nei salotti non si parlava d'altro e quando Jussieu tornò dalla Spagna, le acque erano ancora agitate. Fino a quel momento, egli aveva seguito le idee di Tournefort ma, non essendo un dogmatico, volle capire meglio. Scrisse al farmacista Joan Salvador i Riera, che lo aveva accompagnato in Spagna, di raccogliere esemplari di fiori di piante fruttifere e non fruttifere di palme da dattero, e capì che Vaillant aveva ragione. L'anno successivo, nella prolusione del 1718, abbracciò le sue tesi, anche se le espresse con un prudente linguaggio neutro e distaccato. Vaillant applicò le sue scoperte alla sua opera maggiore Botanicon parisiense, frutto di trent’anni di ricerche, in cui descrisse sistematicamente la flora di Parigi e dintorni delineando un nuovo sistema di classificazione basato sugli organi sessuali, criticò anche con asprezza il sistema di Tournefort e usò per la prima volta nel significato moderno i termini stame, ovario, ovolo. In vista della pubblicazione, fece eseguire accuratissimi disegni a Claude Aubriet, ma si trovò impossibilitato a pagarlo; tanto meno aveva i soldi per la stampa, che certo l'Accademia non avrebbe finanziato. Nel maggio 1721, si risolse a scrivere a Boerhaave, il direttore dell'orto botanico di Leida, che liquidò il debito con Aubriet e insieme a William Sherard, amico comune, curò la pubblicazione. Una prima edizione senza figure uscì nel 1723 e Vaillant, morto nel 1722, non fece in tempo a vederla. Nel 1727, sempre a Leida, seguì una seconda edizione, con trecento tavole di Aubret incise da Jan Wandelaar, che qualche anno dopo avrebbe collaborato con Linneo per Hortus Cliffortianus. Per l'Académie, Vaillant rimase un paria: contrariamente all'uso, alla sua morte non venne commissionato il consueto elogio a Fontenelle. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Endemismi siciliani Non molto tempo prima di morire, Tournefort in una Memoria letta all'Accademia delle scienze aveva dedicato all'allievo il genere Valantia: uno di quelli che lo stesso Vaillant contestava, visto che lo considerava identico a Cruciata; del resto esprimeva le sue riserve anche sull'abitudine di denominazioni ricavate dai nomi dei botanici. Linneo lo recuperò in Species plantarum. Non solo aveva grande stima di Vaillant, in cui vedeva un proprio precursore considerando Botanicon parisiense il vero inizio della botanica moderna, ma riteneva il genere particolarmente adatto. Non certo per la sua bellezza: si tratta di pianticelle minime, che passano inosservate, ma per le singolari caratteristiche dei fiori perfette per celebrare lo studioso della differenziazione sessuale. Questo piccolo genere della famiglia Rubiaceae raggruppa sette specie di minute erbe rupicole diffuse attorno al bacino del Mediterraneo, dalla Macaronesia al Vicino oriente. Hanno minuscole foglie carnose verticillate in gruppi di quattro, da cui il nome comune di «erba croce»; i fiori sono raggruppati in verticilli di tre: quello centrale è bisessuale, i due laterali maschili. Quattro specie (V. calva, V. deltoidea, V. hispida, V. muralis) fanno parte della flora italiana; V. calva è endemica dell’isola di Linosa dove cresce sulle pendici laviche del Monte Vulcano e di Montagna rossa. V. deltoidea è invece un endemismo della Rocca Busambra, il rilievo maggiore dei monti Sicani, dove vive nei pascoli aridi intorno a 1600 metri. Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1784 le collezioni di Linneo trovano casa a Londra grazie a James Edward Smith, e i botanici britannici si convertono nei principali sostenitori del sistema linneano. Eppure, se ci sono gli entusiasti come Erasmus Darwin che scrive addirittura un poema dedicato agli amori delle piante, in genere in Inghilterra le troppo esplicite metafore sessuali di Linneo non piacciono. Già nel 1776 William Withering aveva pubblicato la prima flora britannica basata sul sistema di Linneo, epurandola tuttavia di ogni riferimento alla riproduzione sessuata, nell'intento di proteggere la "modestia femminile" delle lettrici. Un quarto di secolo dopo, almeno da questo punto di vista, le cose non sono cambiate più di tanto se Samuel Goodenough, socio fondatore e tesoriere della Linnean Society, bolla con parole di fuoco la "mente lasciva" di Linneo. D'altra parte, oltre che un buon botanico dilettante, era un educatore di teneri giovinetti e, quel che più conta, un vescovo, una colonna portante della Chiesa d'Inghilterra. Queste critiche, per altro, non le espresse in pubblico, ma in una lettera privata a James Edward Smith, di cui fu probabilmente l'amico più fedele. Fu proprio Smith a creare in suo onore il genere Goodenia, il più numeroso della famiglia Goodeniaceae cui dà il nome.  Nascono un'amicizia e una società scientifica Nel gennaio del 1785, poco dopo essere riuscito ad aggiudicarsi le collezioni di Linneo (ne ho parlato in questo post), James Edward Smith ricevette una lettera di congratulazioni dai toni entusiastici: "Il vostro nobile acquisto del gabinetto di Linneo pone con decisione la Gran Bretagna al di sopra di tutte le altre nazioni nell'impero della botanica; è molto desiderabile che gli studi individuali, nel rispetto della scienza in generale, acquistino tanta vivacità e tanto successo che la Botanica stessa sia indotta a stabilirsi tra di noi". Chi scrive è il reverendo Samuel Goodenough, ecclesiastico, naturalista dilettante e stimato insegnante. E' l'inizio di un'amicizia che cesserà solo con la morte dei due protagonisti, avvenuta a pochi mesi di distanza (Goodenough morì nell'agosto 1827, Smith nel marzo 1828). Goodenough aveva una quindicina di anni più di Smith. Membro di una famiglia di religiosi, prima di abbracciare a sua volta la carriera ecclesiastica aveva seguito ottimi studi, frequentando la prestigiosa Westminster School e il Crist Curch College di Oxford, dove aveva stretto amicizia con Joseph Banks. Dopo aver insegnato qualche anno proprio alla Westminster e aver retto una parrocchia come vicario, nel 1772 aveva aperto una propria scuola a Ealing, nei dintorni di Londra. Era un istituto piccolo, ma di grande prestigio, che ogni anno accoglieva dieci (più tardi dodici) rampolli delle migliori famiglie del regno per prepararli alla Westminster School. Goodenough era un ottimo didatta e seguiva metodi all'avanguardia per l'epoca: nell'insegnamento della lettura e della scrittura, anziché procedere lettera per lettera e regola per regola, privilegiava un approccio globale basato sul riconoscimento di parole intere. Il curriculum prevedeva lettura dei classici, francese, scrittura, storia, danza, scherma e forse aritmetica. I ragazzi erano ospitati in una grande casa di tre piani, con due ali di uno e due piani, immersa in un parco relativamente grande con alberi maturi, arbusti e vasti prati, dove potevano praticare diversi sport, tra cui il cricket. Nel giardino Goodenough coltivava anche piante rare. Infatti, benché la sua formazione fosse classica ed egli fosse un reputato studioso di teologia e di lingue classiche, la sua vera passione erano le scienze naturali, in particolare la botanica. Lo confessa egli stesso a Smith nella lettera che segnò l'esordio della loro amicizia: "La storia naturale per me è oggetto di perpetuo piacere. E forse gradirete sapere che in me trovate qualcuno che non è insensibile alle difficoltà (io stesso ho raccolto personalmente e essiccato 3000 esemplari) e al valore della raccolta di esemplari botanici. Anche altri campi della storia naturale sono stati oggetto dei miei studi". Da questo momento Goodenough divenne il migliore amico di Smith, l'unico - a parte Banks - da cui il suscettibile botanico accettasse qualche critica. Entrambi si iscrissero alla Società per la promozione della storia naturale, dove conobbero tra gli altri l'entomologo Thomas Marsham; l'esperienza si rivelò però deludente e Smith, incoraggiato da Goodenough e Marsham, incominciò a pensare a fondare una nuova società, esplicitamente intitolata a Linneo. Fu così che nel 1788 i tre divennero i soci fondatori della Linnean Society, di cui vennero eletti rispettivamente presidente, tesoriere e segretario. Goodenough mantenne questo ruolo per qualche anno, ma fu più volte anche vicepresidente della Royal Society (in quegli anni retta da Banks) e membro della Society of Antiquaries. Intanto, faceva carriera nella Chiesa anglicana. Nel 1797 ottenne il vicariato di Cropredy; nel 1798 fu nominato canonico della St George Chapel di Windsor, nel 1802 decano di Rochester, e infine nel 1808 vescovo di Carlisle, anche grazie alla protezione del duca di Portland, i cui figli erano stati suoi allievi a Ealing.  Niente sesso... siamo inglesi Come eccellente latinista, Goodenough fu di grande aiuto a Smith per la redazione delle sue opere; ma fu anche un botanico più che dilettante. Il suo maggiore contributo scientifico, pubblicato nelle Transactions della Linnean Society, è un ampio studio sulle specie britanniche di Carex, un genere all'epoca ancora oscuro e poco studiato, comparso in due parti: Observations on the British Species of Carex (1792) e Additional observations on the British Species of Carex (1795). Si occupò anche di alghe, scrivendo una monografia sulle specie britanniche di Fucus (1797), in collaborazione con un altro socio della Linnean Society, Thomas Woodward. Si interessava inoltre di zoologia, e pubblicò alcuni articoli sugli insetti. Oratore facondo e dalla prosa brillante (come possiamo dedurre dalle numerose lettere di Goodenough incluse dalla vedova di Smith in Memoir and Correspondence of the Late Sir James Edward Smith), pubblicò tre sermoni; sappiamo che progettò anche una Botanica metrica, un'opera di grande erudizione in cui il suo talento di latinista avrebbe dovuto fondersi con la passione per la botanica; il suo proposito era infatti di presentare in versi l'etimologia dei nomi botanici. Niente a che vedere dunque con The Loves of the Plants, il poema del nonno di Darwin dedicato alla botanica linneana in cui si esaltano gli amori delle piante. Anzi, per essere un linneano DOC, membro fondatore e tesoriere della Linnean Society, la posizione del vescovo Goodenough nei confronti del sistema linneano è singolarmente pudibonda. Anche se ammirava Linneo come scienziato, era scioccato dalla scelta di usare gli organi sessuali delle piante come criterio di classificazione; ad urtarlo anche maggiormente, era poi il linguaggio di Linneo che giudicava grossolano, anzi lascivo. In una lettera privata a Smith, che non a caso non fu inclusa della vedova nel carteggio, scrive: "E' perfettamente inutile dire che nulla può uguagliare la grossolana lascivia della mente di Linneo. Una traduzione letterale dei primi principi della botanica linneana è sufficiente per offendere la modestia femminile". Più di tutto detestava certi nomi di Linneo, inutilmente scurrili, e a proposito del genere Clitoria scrive: "È possibile che molti studenti virtuosi non siano in grado di comprendere la similitudine di Clitoria". Morto ultraottantenne nel 1827, Goodenough ebbe l'onore di essere sepolto nel transetto settentrionale dell'Abbazia di Westminster. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Un grande genere australiano (ma non solo) A celebrare il buon vescovo, linneano pudico, con la dedica di un genere botanico non poteva che essere l'amico di una vita James Edward Smith, che nel 1793 in A Specimen of the Botany of New Holland battezzò Goodenia (una forma più orecchiabile e "classica" del corretto Goodenoughia) un gruppo di piante recentemente raccolte in Australia. La maggior parte delle specie del vastissimo genere Goodenia (gli sono attribuite oltre 200 specie) è infatti endemica dell'Australia; un piccolissimo numero di specie si estende a Giava, alla Nuova Guinea, all'Indonesia, alle Filippine e alla Cina meridionale. Il genere, che dà il nome alla famiglia Goodeniaceae, comprende soprattutto erbacee perenni che vivono per lo più nel sottobosco in condizioni umide, ma anche arbusti. Hanno foglie molto variabili per forma e collocazione, ma solitamente con margini serrati o dentati, e fiori, solitari o raccolti in infiorescenze, decisamente asimmetrici, con corolla tubolare bilabiata con cinque lobi diseguali, spesso gialli, ma anche bianchi o rosa-malva in poche specie. Molto decorative, alcune specie sono coltivate nei giardini australiani. Tra di esse, G. albiflora, che in primavera si ricopre di una massa di singolari fiori bianchi striati di azzurro; G. hederacea, una robusta coprisuolo che preferisce l'ombra umida e produce fiori giallo oro; G. macmillanii, con foglie pinnate e grandi fiori malva, con i due lobi superiori eretti. Merita una menzione a parte G. ovata, un arbusto diffuso in gran parte dell'Australia dove si adatta a suoli e condizioni diverse. Di veloce crescita, è una pianta pioniera che rinasce a profusione nei terreni devastati dagli incendi; è ampiamente utilizzata nei progetti di recupero paesaggistico perché copre rapidamente il suolo, ostacolando la crescita delle malerbe, offre cibo alle farfalle e altri insetti nonché cibo e protezione agli uccelli. In giardino è utilizzata come tappezzante e ne sono state selezionate diverse cultivar. Altri approfondimenti nella scheda. Talvolta, la giustizia poetica è concessa anche ai nomi botanici. Che a ricordare il grande Michel Adanson, autore di un'opera impossibile per il suo stesso gigantismo, per perseguire la quale egli rinunciò a fama, riconoscimenti materiali e alle stesse elementari necessità della vita per chiudersi nel suo lavoro solitario, sia proprio il baobab, albero gigante che si erge sulla arida savana, vive per migliaia di anni e supera le peggiori siccità accumulando acqua nel fusto e rinunciando alle foglie, ne è la dimostrazione. A guidare la mano dell'inconsapevole Linneo e a ispirargli la creazione del genere Adansonia, molto prima che il destino di Adanson si palesasse, è uno scherzo della sorte o, appunto, un atto di giustizia poetica. 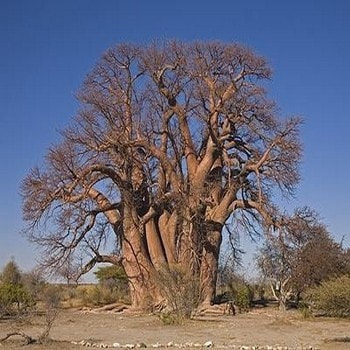 Primo atto: un viaggio in Senegal L'incontro tra i due protagonisti della nostra storia avviene nell'agosto del 1749, nel villaggio senegalese di Sor. Michel Adanson è arrivato in Senegal da circa sei mesi ed è ancora pieno di entusiasmo e di stupore per la ricchezza della natura tropicale. Ha già imparato abbastanza la lingua wolof (tra i suoi tanti talenti c'è anche quello linguistico) da muoversi da solo; chiede indicazioni su un buon terreno da caccia e viene indirizzato sulle tracce di un branco di gazzelle. Ma una visione stupefacente spegne ogni interesse venatorio: è un albero immenso, il più grande che abbia mai visto. Non per l'altezza (forse una ventina di metri), ma per la circonferenza straordinaria; incredulo, Adanson gli gira intorno tredici volte. Cerca di misurarla allargando le braccia, poi con una corda. Calcola una circonferenza di 20 metri, e un diametro di quasi 7. Ciascuno dei rami che forma la chioma, alcuni dei quali toccano terra, è più lungo e spesso del tronco di uno dei maggiori alberi monumentali d'Europa. L'albero in sé non è raro, aggiunge Adanson, appartiene anzi a una delle specie più comuni nel paese, che i francesi chiamano calebassier, o anche pain-de-singe ("pane delle scimmie") e i locali goui. Noi lo conosciamo con il nome di origine araba baobab, ma anche - grazie a Bernard de Jussieu e a Linneo - come Adansonia digitata. Nel momento in cui incontrò l'albero destinato a preservare il suo nome, Adanson aveva 22 anni, ma era già un naturalista ambizioso e singolare. La famiglia lo aveva destinato alla chiesa e durante gli anni di collegio si era distinto come allievo solerte e brillante; quattordicenne, aveva attirato l'attenzione del biologo inglese John Needham che gli donò un microscopio con queste parole: "Dato che avete imparato così bene a conoscere le opere degli uomini, è ora che studiate quelle della natura". Fu una folgorazione. Il ragazzo incominciò a frequentare il Jardin du Roy e le lezioni di Réaumur e Bernard de Jussieu. A diciotto anni conosceva migliaia di specie vegetali e sapeva classificare tutte le piante del giardino. Gli era anche chiaro che il suo destino non era nella Chiesa, ma nello studio della natura. Rinunciò al beneficio ecclesiastico che aveva coperto i costi degli studi e insisté con il padre - scudiero del vescovo di Parigi - perché trovasse il modo di farlo partire per un paese tropicale, se possibile inesplorato. Grazie a Pierre-Barthélemy David, direttore della Compagnia delle Indie, ottenne infine un modesto posto di commesso a Saint-Louis, l'emporio della compagnia sulla costa del Senegal. Malfamato per il suo clima insalubre, era praticamente sconosciuto ai naturalisti. Senza alcun incarico ufficiale, senza alcun titolo di studio formale, fu dunque come "impiegato incaricato di tenere i registri" che Adanson il 3 marzo 1749 si imbarcò a Lorient sul Chevalier marin. Si era preparato con scrupolo al viaggio, raccogliendo tutte le informazioni possibili sul clima, gli animali, le piante, le lingue, i costumi locali. Aveva imparato i metodi più all'avanguardia per conservare piante e animali. Nel suo bagaglio, telescopi, barometri, termometri e altri strumenti scientifici. Il soggiorno di Adanson in Senegal si prolungò per cinque anni (fino al febbraio 1754), fu ricchissimo di risultati scientifici, ma difficile da ogni punto di vista. Si ammalò ripetutamente e la Compagnia si dimostrò ostile; anche se lui cercava di convincere i suoi capi dell'utilità anche economica delle sue ricerche, per loro questo impiegato che si dava troppo da fare e faceva di tutto tranne quello per cui era pagato, era davvero meno che inutile. Solo grazie alle insistenze dei suoi protettori parigini (in particolare Jussieu e Réaumur) riuscì ad ottenere il permesso di coltivare un piccolo giardino, dove sperimentava incroci e coltivava piante rare da introdurre in Francia. Eppure, era attivissimo: oltre a St. Louis e ai suoi dintorni, visitò l'isola di Gorée, Podor, e il bacino del Gambia; annotò dati meteorologici e astronomici, disegnò mappe, imparò lingue e compilò dizionari, raccolse ogni sorta di dati etnografici, geografici, economici. E, ovviamente, campioni di minerali, animali, piante. Spedì centinaia di esemplari ai corrispondenti parigini, e molte migliaia lo avrebbero accompagnato nelle casse che portò con sé nel viaggio di ritorno, insieme a 300 piante vive da acclimatare al Jardin du Roy. 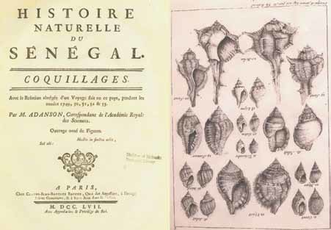 Secondo atto: un'opera pionieristica Provato dal clima tropicale, privo di mezzi e di relazioni, l'uomo che sbarca infine in Francia nel 1754 è molto diverso dal ventunenne di quasi sei anni prima. Da quell'esperienza, oltre all'enorme mole di materiali, ha portato indietro una convinzione profonda: per comprendere la natura, la scienza deve cambiare paradigma. Tutti i sistemi che si è finora data per classificarla, di fronte alla sterminata esuberanza dei tropici, dimostrano la loro inconsistenza: "Appena lasciamo i nostri paesi temperati per entrare nella zona torrida, la botanica sembra mutare totalmente volto: sono sempre piante, ma sono così particolari nelle loro loro forme, hanno caratteristiche così nuove che eludono la maggior parte dei nostri sistemi, i cui limiti non vanno al di là delle piante dei nostri climi". Ma il primo compito è studiare e pubblicare le raccolte senegalesi. Ospitato generosamente dai Jussieu, Adanson elabora il primo dei suoi grandiosi progetti: una storia naturale del Senegal in otto volumi. In realtà, ne scriverà solo il primo: Histoire naturelle du Sénegal (1757) comprende il vivace racconto del suo viaggio e le descrizione delle conchiglie senegalesi, che egli classifica in modo del tutto originale, non più basandosi sulle conchiglie stesse, come si faceva all'epoca, ma sui molluschi che vivono all'interno e le loro strutture. E' il primo saggio di quel metodo globale che tra poco vedremo in azione con le piante. Benché parziale, l'opera gli assicura fama immediata. Adanson è ammesso all'Accademia delle Scienze parigina, seguita qualche anno dopo dalla Royal Society. Ottiene una pensione con il titolo (praticamente una sinecura) di censore reale. Ma ormai sta perseguendo un nuovo progetto. Dal 1759, collabora con il maestro Bernard de Jussieu alla creazione del giardino botanico del Trianon, con le piante disposte in famiglie naturali e incomincia a lavorare a un proprio metodo di classificazione, che esporrà nella sua opera maggiore, Familles naturelles des Plantes (1763). Quando essa uscì, Adanson viveva ancora a casa dei Jussieu ed è impossibile che la frequentazione quotidiana e il lavoro comune non abbiano influito sul suo pensiero; eppure, Adanson cercò di minimizzare il debito con il suo maestro. A suo dire, aveva concepito il progetto di una classificazione naturale fin da ragazzo al Jardin du Roy e la spinta decisiva era venuta dal viaggio in Senegal, con la sua natura tanto diversa da quella europea; quanto a Bernard, lo descriveva come un linneano ortodosso, incapace di allontanarsi dal fallace sistema di Linneo. Di parere opposto sarà Antoine-Laurent de Jussieu, secondo il quale il metodo di Adanson era un plagio delle elaborazioni di suo zio, il solo vero inventore della classificazione naturale. Come avviene quasi sempre, anche in questo caso la verità starà nel mezzo: Bernard aveva cominciato a lavorare a una classificazione naturale e a insegnarla ai suoi allievi quando il giovanissimo Michel seguiva le sue lezioni al Jardin du Roy e sicuramente alla fine degli anni cinquanta era giunto a definire un proprio sistema (non sappiamo quanto coincidente con quello esposto da Antoine-Laurent in Genera Plantarum); d'altra parte, la ricerca di Adanson, se fu stimolata da quella di Bernard de Jussieu, dovette poi seguire un proprio percorso e un proprio metodo.  Terzo atto: manie classificatorie Il primo volume di Familles naturelles des Plantes si apre con un'ampissima disamina di tutti i sistemi di classificazione proposti in precedenza, tutti quanti considerati incapaci di rendere conto del vero ordine della natura. Per giungere a individuarlo, lo studioso non deve concentrasi su uno o pochi elementi, scelti in modo più o meno arbitrario, ma deve analizzare tutte le caratteristiche possibili, senza stabilire una gerarchia: "Non c'è dubbio che in botanica c'è un solo metodo naturale, ed è quello che considera tutte le parti, qualità, proprietà e facoltà delle piante". Adanson individua quindi 595 categorie di caratteri che raggruppa in 66 sistemi "artificiali", fondati ciascuno su un gruppo di caratteri omogenei (ad esempio, caratteristiche delle foglie, delle radici, delle corolle, ecc.); inserendo tutte le piante note in ciascun sistema, è possibile individuare la loro maggiore o minore affinità. Le piante che, in tutti i sistemi, ricadono nella stessa classe, hanno un alto grado di affinità; quelle che si ritrovano insieme solo in alcune classi sono meno prossime; quelle poi che in tutti i sistemi stanno in classi diverse non hanno alcuna affinità. Come si vede, è un metodo altamente complesso che implica un enorme numero di comparazioni, che difficilmente Adanson avrà utilizzato davvero per classificare nel secondo volume ben 1615 generi, assegnati a 58 famiglie naturali (52 delle quali sono piante da fiore), in un'epoca in cui i computer e il calcolo combinatorio erano al di là da venire. Anche lui, non diversamente da Bernard de Jussieu, avrà condotto le sue comparazioni "par tatonnement", per usare le parole di Augustin de Candolle. In ogni caso, il risultato è imponente; il concetto di "famiglia" entra ormai nella storia della botanica e molte delle sue famiglie sono riconosciute ancora oggi, spesso proprio con i nomi che lui stesso diede loro. Fu infatti Adanson a introdurre la convenzione di nominare le famiglie sulla base di un genere tipico, anche se non usava ancora il suffisso che oggi le contraddistingue: ad esempio, Papavera (oggi Papaveraceae), Ranunculi (oggi Ranunculaceae), Cisti (oggi Cistaceae), Solana (oggi Solanaceae). Nel Congresso internazionale di botanica del 1987, Familles naturelle des plantes fu addirittura scelto come punto di partenza per i nomi delle famiglie (attualmente, tuttavia, non lo è più: dal 2003 è sostituito da Genera plantarum di Jusseu). Di Linneo, Adanson rifiutò anche la nomenclatura binomiale, vista a sua volta come un'imposizione. A suo parere i nomi delle piante dovrebbero cambiare il meno possibile e non dovrebbero essere motivati: bisognerebbe evitare sia i nomi figurati sia i termini che rimandano a una qualche etimologia. I nomi migliori sono quelli che esistono già, quindi in primo luogo quelli indigeni. Coerentemente, gli spiacque persino che Linneo avesse dato il suo nome al baobab. Insieme alla personalissima grafia fonetica che Adanson volle adottare per la sua opera (ad esempio scrive Botanik anziché Botanique), anche questa scelta contribuì all'insuccesso dell'opera che la comunità scientifica apprezzò per l'erudizione, ma non per il metodo; fu ovviamente avversata dai linneani; quanto a Linneo, il suo commento fu che non aveva mai visto un simile ammasso di sciocchezze. Da parte sua, Adanson stava già pensando a un nuovo progetto, ancora più ambizioso. Il metodo induttivo e combinatorio da lui scoperto non era forse universale, applicabile all'intero mondo naturale, anzi ad ogni sapere umano? Ci lavorò almeno una dozzina di anni, e nel 1774 (l'anno prima aveva finalmente ottenuto il sospirato titolo accademico, come botanico aggiunto dell'Accademia delle scienze) presentò all'Accademia stessa lo schema del suo L'Ordre universel de la Nature. La commissione incaricata di analizzare la proposta, sgomenta, si trovò di fronte 27 volumi manoscritti dedicati alle relazioni tra tutte le entità; 150 volumi manoscritti con la descrizione di 40.000 specie in ordine alfabetico; un vocabolario di 200.000 parole; 40.000 illustrazione; 24.168 esemplari; in più, note e osservazioni. I commissari gli consigliarono di espungere tutta la parte compilatoria, limitandosi ai suoi contributi originali, da presentare in una serie di memorie separate. Adanson rifiutò, ostinandosi fino alla fine della vita nel suo folle progetto. Il rifiuto lo amareggiò, e lo spinse a chiudersi in se stesso, a sacrificare tutto alla sua "enciclopedia". Non aveva più né amici né allievi, e neppure una famiglia. Nel 1784 lasciò addirittura la moglie, da cui aveva avuto una bambina (Aglaé Adanson, a sua volta botanica), perché la sua presenza lo distraeva dal lavoro. Divenne un eremita; si ritirò in periferia, in una casa sempre più ingombra di collezioni e manoscritti, dove lavorava accanitamente sedici, diciotto ore al giorno; unica pausa dallo studio e dalla scrittura, il piccolo giardino dove sperimentava incroci e coltivava alberi di gelso. Già in condizioni economiche precarie, fu totalmente rovinato dalla Rivoluzione, che soppresse le pensioni reali di cui godeva. Perse anche l'amatissimo giardino e fu ridotto a vivere in condizioni di miseria estrema. Nel 1798, invitato a prendere parte alle sedute dell'Institut national (la nuova denominazione "rivoluzionaria" dell'Accademia delle scienze), rifiutò, dicendo che gli era impossibile andarci perché non aveva neppure un paio di scarpe. Se non altro, il ministro dell'interno provò vergogna e gli assegnò una pensione, poi raddoppiata da Napoleone. Nel testamento, espresse un solo desiderio: che la sua bara fosse ornata da una ghirlanda formata dai fiori delle sue 58 famiglie. Una sintesi di questa vita tutta occupata dallo studio e da progetti sempre più giganteschi e più impossibili nella sezione biografia. 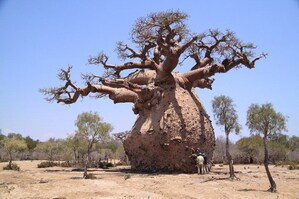 Boabab, giganti minacciati Tra le scoperte di Adanson in Senegal, sicuramente quella che destò maggiore interesse fu proprio l'albero gigante che tanto aveva ammirato. Poco dopo il suo ritorno, nel 1757, egli lesse all'Accademia delle scienze una memoria in cui lo descriveva e ne ricostruiva la storia. Prima di allora, nessun europeo l'aveva mai visto, anche se se ne conoscevano i frutti, che venivano venduti nei mercati egiziani, dove li vide Alpini. Jussieu ritenne che sarebbe stato un doveroso omaggio dedicare allo scopritore il nuovo genere e si affrettò a scrivere in proposito a Linneo. Il tempo dell'inimicizia e delle polemiche era ancora lontano, e lo svedese lo accontentò volentieri, ufficializzando la denominazione nella decima edizione di Systema naturae (1759). Così, con dispetto del dedicatario, il baobab (parola di origine araba che significa "padre di molti semi"), divenne Adansonia digitata. E' la più nota delle otto-nove specie del genere Adansonia, della famiglia Malvaceae (precedentemente Bombacaceae). Uno dei suoi esemplari, il baobab di Glencoe, un albero monumentale della provincia di Limpopo in Sud Africa, era considerato l'essere vivente più grande del mondo, con una circonferenza di 47 metri e un diametro di 15,9. Purtroppo nel novembre del 2009 si è spaccato in due parti e il primato è passato al baobab di Sunland, sempre in Sud Africa, con una circonferenza di 34 metri. Nativi di aree stagionalmente aride, i baobab africani sono in grado di immagazzinare nel tronco enormi quantità di acqua (fino a 120.000 litri); inoltre nella stagione secca, riducono la dispersione lasciando cadere le foglie. Tuttavia, oggi in varie zone dell'Africa sono in grande pericolo: a partire dall'inizio del secolo, proprio gli esemplari maggiori, che vantano un'età tra 1000 e 2500 anni, hanno incominciato a collassare e a morire uno dopo l'altro. Secondo gli studiosi, è una conseguenza del cambiamento climatico, in particolare della combinazione tra siccità e innalzamento della temperatura: gli alberi si disidratano e non riescono più alimentare i loro enormi tronchi. E non possiamo neanche sperare in un Napoleone che sollevi questi giganti dalla loro miseria. Ma non c'è solo A. digitata. Il Madagascar ospita ben sei specie endemiche, tra cui A. grosdidieri, considerata la più bella per il tronco slanciato. Vive invece in Australia A. gregorii, non meno affascinate delle cugine africane. Qualche approfondimento nella scheda. Con la sua pretesa di rinominare gli esseri viventi secondo il nuovo sistema binominale, Linneo si attirò l'accusa di sfrontatezza e arroganza. Tuttavia, mano a mano che crescevano le adesioni e i seguaci, essere immortalati dal nome di una pianta, ricevendo da Linneo in persona la dedica di un genere, divenne l'aspirazione principale di botanici e "curiosi", come venivano chiamato i dilettanti che sempre più numerosi si innamoravano della botanica grazie alla semplicità del sistema linneano. Ma anche su questo punto le critiche non mancarono: il principe dei naturalisti venne accusato di elargire nomi ad amici e studenti con eccessiva parzialità, sicché si fece assai prudente. Anzi talvolta riluttante, come nel caso del dottor Alexander Garden, medico scozzese trapiantato in South Carolina, che riuscì da aggiudicarsi il prestigioso genere Gardenia solo in seguito a una vera e propria manovra di accerchiamento di un altro linneano, John Ellis. 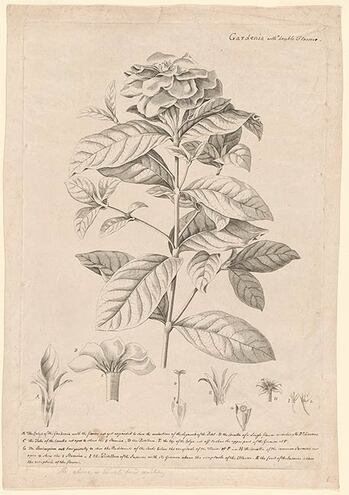 Come una pianta cinese fu scambiata per un gelsomino sudafricano e ebbe il nome di un medico americano I cinesi la chiamavano zhi-zi e la coltivavano da secoli. Con viaggi complicati, che comprendono una tappa nella colonia del Capo in Sud Africa, nel 1754 la varietà a fiori doppi arrivò in Inghilterra e nel 1758 fiorì per la prima volta nella serra del botanico Richard Warner (ca. 1711-1775). Con le lussureggianti foglie verde scuro e i candidi fiori stradoppi dal pervasivo profumo, divenne l'idolo del momento e attorno alla sua classificazione e denominazione scoppiò una disputa botanica. Philip Miller, il cocciuto capo giardiniere del Chelsea Physic Garden, pensò si trattasse di un gelsomino, e la battezzò Jasminum capense, ovvero "gelsomino del Capo di Buona Speranza". John Ellis, mercante e naturalista più che dilettante, non ne era convinto: pensava appartenesse a un genere sconosciuto, e ne inviò un esemplare essiccato a Linneo che confermò il suo parere. Intanto l'abilissimo vivaista James Gordon era riuscito ad averne quattro talee e le aveva moltiplicate con tanto successo che nel giro di pochi anni riuscì a guadagnare 500 sterline, rivendendo le cento piante che ne aveva ricavato. Nel suo vivaio di Miles End la ritrasse il più famoso artista botanico dell'epoca, Georg Dionysius Ehret, etichettandola provvisoriamente con il nome proposto da Miller. Ricevuta la conferma da Linneo, Ellis gli riscrisse proponendogli di battezzare il nuovo genere Warneria in onore del primo proprietario. Questa proposta imbarazzava enormemente Warner, che era amico di Miller e non desiderava contraddirlo; perciò si affrettò a scrivere a sua volta a Linneo, chiedendogli di rifiutarla. Ellis non demordeva e, dopo qualche esitazione, nel 1760 propose a Linneo un nuovo nome: Gardenia, in onore di un amico comune, il medico scozzese Alexander Garden. Anche questa volta Linneo rifiutò: non aveva nessuna intenzione di farsi coinvolgere in queste dispute tra botanici inglesi, inoltre non capiva qualche nesso ci fosse tra Garden e la pianta: non l'aveva né scoperta né coltivata, anzi neppure mai vista. Era disponibile a dedicargli a una pianta americana, ma che aveva mai a che fare con questa sudafricana (che, come noi sappiamo, in realtà era cinese)? Per mesi si dimostrò irremovibile, scrivendo tra l'altro: "Desidero tutelarmi dalle malevole obiezioni, tanto spesso sollevate contro di me, di chi mi accusa di battezzare le piante con i nomi di miei amici che non hanno dato alcun pubblico contributo al progresso della scienza". Alla fine Ellis mise Linneo di fronte al fatto compiuto: gli scrisse che Garden era già stato messo al corrente della dedica e che, al di là dell'Atlantico, la pianta era ormai nota come Gardenia. Poi la pubblicò lui stesso nelle Transactions della Royal Society. Linneo, che non desiderava esautorare il suo principale sostenitore in Inghilterra, che oltre tutto proprio in quei mesi aveva accolto ospitalmente Solander, dovette abbozzare, In questo modo contorto la bella zhi-zi ricevette il nome botanico Gardenia jasminoides J. Ellis.  Uno scrupoloso ricercatore linneano E' ora di fare la conoscenza con l'inconsapevole oggetto umano di quella disputa, il dottor Alexander Garden, che - a posteriori - confermò che tanto onore non era stato immeritato. Scozzese, aveva studiato medicina a Edimburgo; nel 1752, essendosi ammalato di tubercolosi, nella speranza di un clima più propizio si trasferì a Charleston in South Carolina, dove esercitò la professione medica per molti anni. Come studente di medicina, aveva cominciato a studiare botanica in patria seguendo i sistemi di Ray e Tournefort; ma quando arrivò in Carolina, da una parte fu affascinato dalla varietà della flora di quella regione benedetta dalla natura, dall'altra fu frustrato dalla sua incapacità di ricondurre le specie non ancora descritte a quei complicati sistemi. In queste ricerche, dichiarerà più tardi, gettò via tre anni. Anche la sua salute non trovò il giovamento sperato. Dopo un anno di clima particolarmente avverso, nel 1754 decise di fare un viaggio a nord. Capitò così a New York, dove fu ospite Cadwallader Colden e di sua figlia Jane (la prima botanica americana), che gli misero a disposizione la loro biblioteca; su quegli scaffali, Garden trovò il suo santo Graal: Flora virginica di Gronovius, nonché Classes plantarum e Fundamenta botanica, due delle prime opere di Linneo. Passò poi da Philadelphia, dove incontrò John Bartram appena rientrato dalla sua escursione nelle Catskill mountains. Al suo ritorno in Carolina, Garden ebbe egli stesso occasione di conoscere più da vicino la selvaggia natura americana, visitando le Blue Montains in qualità di medico della missione incaricata di cercare l'alleanza dei Cherokee contro la Francia. Tornato poi a Charleston, si mise a studiare le opere di Linneo, e, come d'incanto, tutto quello che gli era rimasto oscuro, si chiarì: il cristallino sistema sessuale gli fornì il filo d'Arianna che cercava e si convertì in un fervente seguace del luminare svedese. Nel marzo 1755 osò scrivere al suo idolo una prima lettera, che rimase senza risposta. Solo dopo tre anni (e dopo molte lettere senza risposta) Linneo si degnò infine di rispondergli, iniziando una duratura e feconda corrispondenza. Il grande svedese non era l'unico corrispondente di Garden; l'ambiente in cui viveva, così ricco di specie da scoprire, era invece assai povero di naturalisti, tanto da fargli scrivere: "qui non c'è anima viva che conosca anche solo una iota di storia naturale". Iniziò così a corrispondere con moltissimi naturalisti al di qua e al di là dell'Oceano, come Colden, Bartram, Gronovius, Collinson, e soprattutto John Ellis, che divenne anche il suo principale intermediario con Linneo. Era a lui che inviava gli esemplari di piante e animali che andava raccogliendo nelle escursioni che alternava alla pur molto impegnativa attività di medico. Era un linneano così fervente che, quando Ellis gli propose di pubblicare alcune specie da lui scoperte sulle Transactions della Royal Society, rifiutò, perché avrebbe dovuto scriverle in inglese, mentre Linneo usava solo il latino. Il suo sogno era scoprire un genere sconosciuto, e che magari Linneo gli desse il suo nome. Dapprima credette di aver fatto centro quando gli inviò una pianta che propose di denominare Ellisia in onore dell'amico comune; ma Linneo lo disilluse, determinandola come Swertia difformis (oggi Sabatia difformis). E quando fu il turno di un nuovo tipo di storace, lo deluse di nuovo preferendo dedicarla, su suggerimento di Ellis, con il nome di Halesia a uno studioso ben più illustre di lui, il reverendo Stephen Hales. Il successo sarebbe arrivato solo nel 1765, con la scoperta di ben due nuovi generi; ma ormai Gardenia gli era già dedicato, ed essi furono battezzati Fothergilla e Stillingia, in onore rispettivamente di John Fothergill e Benjamin Stilling-Fleet. Il suo contributo alla scoperta del primo è comunque ricordato dal nome specifico Fothergilla gardenii. Più ancora che alle piante della Carolina, Linneo era però interessato agli insetti, ai rettili e agli anfibi di quella regione che sapeva ricca di specie sconosciute. Garden accondiscese alle sue richieste e da botanico diventò zoologo, inviando a Uppsala le sue eccellenti descrizioni dal vivo e dozzine di esemplari perfettamente conservati nel rum. Sono così almeno una trentina le specie di anfibi, rettili e pesci descritti in Systema naturae la cui scoperta si deve a Garden. La più nota di tutte è Siren lucertina, un anfibio anguiforme che gli sembrava intermedio tra una lucertola e un'anguilla. Qualche anno più tardi, nel 1774, Garden ebbe occasione di studiare le proprietà elettriche di alcune "anguille" giunte vive a Charleston dal Suriname. Le sottopose ad esperimenti ed inviò le sue osservazioni alla Royal Society di Londra, insieme a un esemplare vivo e ad alcuni esemplari perfettamente conservati sotto alcool, di cui John Hunter poté così studiare gli organi elettrici. L'anno prima, Garden aveva ottenuto l'ammissione alla Royal Society. Allo scoppio delle ostilità tra la Gran Bretagna e le colonie, si schierò con i lealisti. Nel 1781 le sue proprietà furono confiscate e due anni dopo ritornò in patria, stabilendosi nei pressi di Londra. Molto rispettato per "la sua benevolenza, la sua allegria, e le sue buone maniere", divenne vicepresidente della Royal Society. Morì di tubercolosi nel 1791. Una sintesi biografica nella sezione biografie.  Gardenia, un fiore da leggenda Con circa 150-200 specie di arbusti e alberi sempreverdi diffusi nell'Africa e nell'Asia tropicale e subtropicale, il genere Gardenia è uno dei più notevoli della famiglia Rubiaceae. La specie più nota è indubbiamente G. jasminoides, tanto apprezzata per la sua bellezza e il suo profumo, quanto famigerata per la sua capricciosità. Croce e delizia dei giardinieri, è una pianta mitica, simbolo di bellezza, lusso e seduzione: era il fiore preferito di Sigmund Freud, i dandies francesi della fin du siècle la portavano all'occhiello e Billie Holiday ne appuntava tre alla chioma, tanto da essere soprannominata la "gardenia bianca del jazz"; la scelgono le spose per i loro bouquet, i bar Tiki la ostentano riunite in corone e le usano come ingrediente segreto dei cocktail. Oltre a una celebre rivista di giardinaggio, presta il suo nome a decine di ditte, esercizi commerciali, prodotti di bellezza, associazioni sui temi più vari. In giardino ne sono state selezionate innumerevoli varietà; già la forma doppia a tutti famigliare è frutto della selezione orticola millenaria in Cina, dove è stata preferita alla originaria forma a fiore semplice. Oggi si punta sempre più su quelle un po' più rustiche e meno schizzinose, come G. jasminoides radicans, di dimensioni minori, capace di sopportare l'inverno all'esterno, oppure 'Crown jewel', rustica fino a -10 gradi. Tuttavia, non c'è solo G. jasminoides. Al contrario di questa cinese entrata nella storia della botanica travestita da sudafricana, arriva davvero dalle foreste della regione del Capo G. thumbergia, la seconda specie a giungere in Europa intorno al 1773 grazie a Thunberg e al suo amico Masson. Arriva invece dall'India G. latifolia, un vero piccolo albero, apprezzato non solo per l'ombra offerta dalla densa chioma sempreverde e i fiori, ma anche per i frutti eduli, ampiamente coltivato nel subcontinente e introdotto in molte zone dell'Africa. Numerose sono le specie originarie delle isole del Pacifico, uno dei principali centri di diversità; tra di esse G. taitensis, che fu raccolta per la prima volta a Tahiti durante la seconda spedizione di Cook, uno dei fiori simbolo delle isole, molto apprezzato in profumeria. E non tutte le gardenie hanno fiori bianchi: ad esempio, l'asiatica G. tubifera ha corolle giallo oro. Qualche approfondimento sulle "altre gardenie" nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed