|
Schiller ne fece il protagonista di una novella romantica, Carl Peter Thunberg lo ebbe a compagno delle sue escursioni naturalistiche a Giava, la Società delle Scienze e delle arti di Batavia lo ebbe come primo segretario. E' Friedrich von Wurmb, nobiluomo tedesco e funzionario della VOC a Batavia, promettente naturalista morto troppo presto lasciando una manciata di articoli, uno dei quali dedicato alle palme, con la prima pubblicazione di un nuovo genere e due nuove specie. A ricordarlo provvide Thunberg con l'interessante genere Wurmbea,  Eroe romantico o naturalista? Nel 1782 nella rivista Wurtembergisches Repertorium der Literatur comparve un racconto anonimo intitolato Eine großmütige Handlung, aus der neuesten Geschichte (Un gesto magnanimo, da una storia recente). La trama racconta di due fratelli che amano la stessa donna. Quando se ne rendono conto, grande è la costernazione loro e della fanciulla, che rifiuta di scegliere l'uno piuttosto che l'altro. I fratelli fanno allora un patto: il maggiore andrà all'estero e se riuscirà a resistere lontano dall'amata, il minore sarà libero di sposarla. Egli va ad Amsterdam, ma presto si ammala ed è costretto a tornare. Ora è l'altro fratello a partire: va addirittura a Batavia in Indonesia, e da lì scrive che si sente abbastanza forte per superare la separazione e rinunciare al suo amore. Il fratello maggiore e la ragazza si sposano, ma appena un anno dopo lei muore e sul letto di morte rivela che il suo preferito era il fratello minore. Il marito si risposa mentre l'amato promette che rimarrà per sempre celibe. L'autore del racconto era lo scrittore Friedrich Schiller che si era ispirato a una storia vera, quella dei fratelli Ludwig e Friedrich von Wurmb, che gli era stata riferita dall'unica sorella dei due, sua suocera Louise von Lengefeld nata von Wurmb. Anche se la fonte era diretta e il racconto rispettava a grandi linee lo svolgimento dei fatti (i fratelli von Wurmb si erano davvero innamorati della stessa donna, Christiane von Werthern, Friedrich era davvero immigrato a Batavia, Ludwig aveva davvero sposato Christiane, ne era rimasto presto vedovo e si era risposato) ma Schiller si era permesso qualche licenza poetica. A spingere Christoph Carl Friedrich von Wurmb (1742-1781, questo il suo nome completo), a lasciare la Germania ed ad arruolarsi della VOC (la Compagnia olandese delle Indie orientali) forse più che l'amore impossibile, furono gli scarsi mezzi della famiglia, nobile ma impoverita. Non era inconsueto che giovani tedeschi cercassero fortuna nelle file della VOC come militari o come funzionari civili, tanto che, dopo gli olandesi, costituivano il gruppo nazionale più numeroso sia in Sudafrica sia in Indonesia. Dopo il suo arrivo a Batavia, Friedrich mantenne una regolare corrispondenza con Ludwig, a cui spedì anche qualche materiale naturalistico, ricevendone in cambio libri e riviste. In una di queste lettere, che furono pubblicate dal fratello dopo la sua morte, espresse il desiderio di tornare in patria e di risposarsi. Friedrich von Wurmb arrivò a Batavia via Amsterdam nel giugno 1775; all'epoca aveva 33 anni. Inizialmente era sotto mercante, il rango più basso nella gerarchia dei funzionari civili della VOC; poi fece una modestissima carriera: per due anni (1776-1778) fu contabile presso l'ospedale, quindi dal 1779 fino alla morte secondo amministratore del Waterpoort. Era dunque uno dei funzionari più umili tra coloro che prestavano servizio a Batavia e come tale figura all'ultimo posto nella lista dei membri della Società delle scienze e delle arti di Batavia, di cui nell'aprile del 1778 fu uno dei soci fondatori. Le sue competenze come naturalista (botanico ma anche zoologo) dovettero emergere in occasione del secondo soggiorno di Thunberg a Giava (dicembre 1776-giugno 1777); il tedesco gli fu compagno in una serie di escursioni nelle zone montuose dell'interno, muovendo da Batavia e Buitenzorg. Fu forse tramite lo svedese che von Wurmb entrò in contatto con il presidente della futura società Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher, che lo volle nel comitato direttivo ristretto; inoltre lo raccomandò come membro corrispondente della Società delle scienze e delle arti di Haarlem e lo scelse come secondo segretario, accanto al reverendo Joshua van Iperen; alla morte di questi nel 1780 von Wurmb gli subentrò come primo segretario. In questo ruolo svolgeva compiti amministrativi; seguiva la preparazione e la stampa del bollettino della Società; teneva in ordine e classificava le collezioni; inoltre, quando l'assessore Sirardus Bartlo donò una parte del suo giardino, venne incaricato di allestirvi un piccolo orto botanico. Nei primi tre numeri dei rendiconti della società Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen furono pubblicati sette suoi articoli; grazie al fratello Ludwig dopo la sua morte furono ripubblicati in tedesco sulla rivista di Gotha Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte dove comparvero anche due articoli postumi. Tralasciando un articolo su un minuscolo nano di Bali, domina la zoologia con brevi testi su un esemplare di orango del Borneo ucciso di recente, sul kahau o scimmia dal lungo naso (Nasalis larvatus) che von Wurmb fu probabilmente il primo a descrivere, sul cervo nano di Giava, su alcune specie di uccelli, sui nidi di rondine e altri nidi commestibili. Wurmb scrisse invece un solo articolo di botanica, De orde der palmboomen (L'ordine delle palme), comparso nel 1779 nel primo numero dei rendiconti. Egli vi tratta 17 generi e una ventina di specie di palme; i riferimenti più diretti sono Systema naturae e Species plantarum di Linneo, nonché la trattazione di Houttuyn nel primo volume della seconda parte di Natuurlyke Historie, ma ampi sono i riferimenti a Rumphius, Hortus malabaricus e altre pubblicazioni di autori olandesi. Il merito maggiore è aver introdotto il genere Licuala e due nuove specie Nypa fruticans e Saguerus pinnatus, oggi Arenga pinnata. Come succedeva a una percentuale impressionante di funzionari della VOC, il clima e le pessime condizioni igieniche di Batavia ebbero presto la meglio su Friedrich von Wurmb che morì nel marzo 1781, meno di cinque anni dopo essere arrivato a Giava. Non aveva ancora compiuto 39 anni. La sua morte fu un colpo durissimo per Radermacher, che contava su di lui per studiare sistematicamente la natura di Giava. Si rivolse così a Thunberg chiedendogli di inviare a Batavia uno dei suoi allievi come degno successore. Ciò non avvenne mai e lo stesso Radermacher sarebbe morto tragicamente appena due anni dopo, determinando quasi una paralisi della Società scientifica di Batavia che tanto si era battuto per creare.  Bellezze non sempre profumate Qualche mese prima di venire informato della morte di Friedrich von Wurmb Thunberg aveva già provveduto a celebrarlo con la dedica di uno dei nuovi generi da lui scoperti in Sudafrica, Wurmbea, con parole di grande elogio: "Gli ho dato il nome in onore del sig. barone Friedrich von Wurmb, ora mercante della Compagnia delle Indie orientali e segretario della celebre Società delle scienze di Batavia, espertissimo conoscitore della storia naturale e di altre scienze e generoso patrono dei loro cultori". Il genere Wurmbea (famiglia Colchicaceae) con una cinquantina di specie, è caratterizzato da un areale nettamente disgiunto: circa metà delle specie sono distribuite nell'Africa subsahariana, con centro di diversità in Sudafrica, l'altra metà tra Australia e Nuova Zelanda. Sono erbacee perenni geofite dotate di cormi tunicati simili a bulbi, con foglie lineari e fiori a stella riuniti in infiorescenze a spiga. In Sudafrica sono presenti sia nell'area con piogge invernali, sia in quella con piogge estive. La specie probabilmente più diffusa è W. stricta (in precedenza Onixotis stricta), che vive in paludi e stagni stagionalmente allagati del Capo occidentale e del Namaqualand, dove forma comunità molto numerose che fioriscono in massa tra il tardo inverno e la primavera per due o settimane. Poi la pianta perde le foglie e durante la stagione estiva arida va in riposo, per risvegliarsi alle prime piogge autunnali. I fiori, da bianchi a rosati, con due ghiandole nettarifere alla base, sono impollinati da api e piacevolmente profumati, al contrario di quelli di altri rappresentanti del genere che sono impollinati da mosche ed emanano un odore sgradevole. È il caso di W. marginata, una specie dei flats calcarei e limosi del Capo occidentale, che produce impressionanti spighe di fiori viola scuro quasi nero che contrastano con le antere gialle. Poco piacevole anche l'odore di sterco (ma è stato paragonato anche a mischio) dei fiori di W. elatior, che cresce lungo i margini dei corsi d'acqua e nelle paludi di Capo orientale, KwaZulu Nathal e Lesotho intorno ai 1200 metri, dunque nell'area a piogge estive; fiorisce a fine estate va in riposo in inverno. I fiori, bellissimi, hanno tepali bianchi macchiati al centro di rosso o di viola. Per venire alle specie australiane, vorrei segnalare almeno W. dioica, comune in gran parte del paese; che come dice il nome porta fiori maschili e femminili (e occasionalmente bisessuali) su individui diversi. Ha dimensioni molti più contenute delle cugine africane e fiori bianchi con una macchia viola alla base del nettario. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
Il mercante e alto funzionario della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher si rese benemerito come fondatore e animatore di una delle prime società erudite dell'Asia orientale, la Reale società delle Arti e delle Scienze di Batavia, alla quale donò la prima sede, la propria biblioteca e la propria collezione di curiosità naturali, oggetti etnografici, strumenti musicali, opere d'arte. Anche se non sono giunti fino a noi, c'erano sicuramente anche fogli d'erbario, dato che sappiamo che ricevette campioni dal Giappone da Thunberg ed egli stesso fece raccolte a Giava e inviò exssiccata a Houttuyn. Tra i suoi vasti e variegati interessi c'era infatti anche la botanica, come testimonia una delle sue opere, una lista delle piante dell'isola. A ricordarlo il genere Radermachera, che fu inizialmente descritto proprio sulla base di una specie presente anche in Indonesia. Un dilettante curioso e la nascita di una società scientifica Quando lasciò per la prima volta l'Olanda alla volta dell'Indonesia (le Indie orientali olandesi, come le chiamavano allora), Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783) aveva appena sedici anni. Se non fosse rimasto orfano di padre a sette anni forse non avrebbe avuto bisogno di cercare fortuna in Oriente. La sua era una infatti famiglia influente. Il bisnonno Johan Radermacher era stato balivo di Middelburg e direttore della WIC (la Compagnia olandese delle Indie Occidentali), il padre Johan Cornelis tesoriere generale del principe e primo grande maestro della loggia massonica L'Union. La decisione di mandarlo a Batavia ad imparare il mestiere di mercante nonostante la giovanissima età probabilmente fu presa dallo zio Samuel Radermacher che era uno dei direttori della VOC, come lo sarebbe stato dopo di lui il figlio Daniel. Così il 30 dicembre Jacobus (d'ora in avanti lo chiameremo con il primo nome, come del resto era d'uso) si imbarcò con il grado di sottomercante sulla nave "Middelburg" diretta a Batavia. Qui fece rapidamente carriera, certamente anche grazie alla protezione dello zio e del cugino: un anno dopo era secondo amministratore del Groote Winkel ("grande negozio") e pochi mesi dopo secondo amministratore del Graanmagazijn (il magazzino principale). Il 10 gennaio 1761 gli fu conferito il grado di mercante e il 6 aprile 1762, quando aveva appena 21 anni, fu nominato capo commerciante e contemporaneamente capitano di porto per la popolazione nativa non cristiana. Lo stesso anno, seguendo la tradizione familiare, fondò la loggia massonica La Choisie, la più antica dell'Asia orientale. Nel frattempo si era sposato con Margaretha Verijssel, figlia di un consigliere delle Indie Orientali, e di Sophia Francisca Westpalm, che, rimasta vedova, si era risposata con Reinier de Klerk, all'epoca consigliere straordinario del Consiglio delle Indie. Nonostante la rapida e brillante carriera, Jacobus doveva essere insoddisfatto e chiese di rientrare in patria. Ottenuta l'autorizzazione, nell'ottobre 1763 si imbarcò alla volta dell'Olanda con la moglie. Si stabilì all'Aja e incominciò a studiare legge privatamente; per conseguire la laurea, si iscrisse all'Università di Harderwijk, un diplomificio noto per per conferire diplomi lampo (lo stesso dove una trentina di anni prima si era laureato Linneo): nel suo caso, dall'iscrizione alla laurea passò appena un giorno! Quindi prestò giuramento all'avvocatura di Arnheim, ma qualcosa dovette andare storto e dopo appena sei mesi incominciò a fare pressione sulla direzione della VOC per essere richiamato a Batavia. Incontrò ripetuti rifiuti, forse dovuti all'ostilità che gli aveva procurato il suo scritto "Riflessioni sullo stato attuale dei Paesi Bassi", in cui prendeva atto della crisi della Compagnia, ne criticava le scelte nei confronti dei dipendenti e dei nativi e proponeva una serie di riforme. Aveva idee progressiste anche in altri campi: era contrario alla pena di morte, con l'argomentazione "economicista" che uccidere un reo non portava vantaggio a nessuno, mentre un reo rieducato avrebbe potuto essere utile alla società anche per mezzo secolo. Infine gli fu accordato il permesso di partire, ma a proprie spese e senza alcun incarico ufficiale. Il 20 dicembre la famiglia Radermacher (nel frattempo erano nati due bimbi) si imbarcò sulla nave "Tulpenburg"; il giorno di Natale, mentre erano ancora nella rada di Texel in attesa di un tempo più propizio, il più piccolo dei bimbi morì. Era il mesto inizio di un viaggio difficile, che si protrasse per più di otto mesi e fu segnato dalla morte di un quinto dei passeggeri. Al suo arrivo a Batavia il 21 agosto 1767, Radermarcher, che aveva annotato scrupolosamente gli eventi nel proprio diario di viaggio e aveva incominciato ad interessarsi di cartografia come reazione alle ripetute perdite di rotta, scoprì che nel frattempo era stato nuovamente assunto dalla VOC. La seconda parte della sua carriera non fu più quella di un mercante, ma di un amministratore e alto funzionario. Nel 1768 fu nominato balivo di Batavia, ufficiale giudiziario e curatore della chiesa; nel 1775 consigliere straordinario delle Indie orientali; nel 1777 presidente degli assessori, colonnello della borghesia, presidente del consiglio di amministrazione delle scuole cittadine e commissario delle Terre Alte. Contemporaneamente era diventato uno degli animatori della vita culturale di Batavia; si interessava di tutto (amministrazione, cartografia, geografia, letteratura e linguistica, religione, navigazione, scienze naturali), collezionava curiosità naturali e possedeva una biblioteca aggiornata con libri in varie lingue, un Dictionaire Encyclopedique in 17 volumi e 68 volumi delle opere di Voltaire, di cui evidentemente era ammiratore. Fin dagli anni '60 con alcuni amici, ispirandosi al modello della Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Reale società olandese delle scienze e delle arti) di Haarlem, la più antica e prestigiosa società scientifica olandese, propose di creare a Batavia una società erudita, ma il progetto fu messo da parte per il totale disinteresse dei vertici della società e dei governatori van der Parra e van Riemsdijk. Una svolta si ebbe nel 1777, anno in cui si celebrava il 25esimo anniversario della società di Haarlem; probabilmente grazie al cugino Daniel, che presiedeva diverse società, sia Radermacher sia Reinier de Klerk, il patrigno della moglie Margharete, ne furono nominati amministratori. Poco dopo il governatore van Riemsdijk morì e fu sostituito proprio da de Klerk, che condivideva gli interessi culturali del genero. La strada per la fondazione della Reale società delle scienze e delle arti Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) era spianata. Essa nacque ufficialmente il 24 aprile 1778, con il motto "A beneficio della comunità"; non era un ramo della società di Haarlem, ma una società scientifica indipendente, interessata "alla storia naturale, alle antichità, alla morale e ai costumi del popolo". Ne facevano parte di diritto il governatore generale e alti ufficiali della VOC, tra i quali venne scelto un comitato che si riuniva il primo lunedì di ogni mese al casa di Radermacher. Un anno dopo nel palazzo del governatore si tenne la prima riunione generale in cui Radermacher annunziò tra l'altro la sua intenzione di donare alla società un edificio, i propri libri e le proprie collezioni per allestire una biblioteca e un museo. Suggerì anche di acquistare un giardino dove coltivare le piante native: è considerato il precursore dell'orto botanico di Buitenzorg. La società si diede anche un organo, la rivista Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, che iniziò le pubblicazioni nel 1779. Lo stesso anno il museo venne aperto al pubblico, anche se solo per due ore la settimana, la mattina del mercoledì. Radermacher era il vero animatore sia della società sia della rivista, sulla quale pubblicò una serie di articoli sugli argomenti più diversi; per fare un solo esempio, nel numero del 1780, oltre alla relazione sulle attività annuali, leggiamo suoi saggi sul Borneo, sulla cura della gotta, sulle carte nautiche. Intanto egli aveva raggiunto il culmine della carriera: nel marzo del 1781 in occasione dello scoppio della guerra con l'Inghilterra fu nominato commissario delle opere difensive (ovvero responsabile della difesa di Batavia in caso di attacco inglese) e poco dopo commissario della flotta e dell'esercito, Lo stesso anno subì il grave lutto della perdita della moglie; tuttavia già nel 1783 si risposò con l'adolescente Anna Bosch (lui aveva 42 anni, lei 15). Poco dopo gli giunse la notizia che era stato nominato consigliere ordinario del Consiglio delle Indie orientali. Ma Jacobus aveva altri piani: sempre più sofferente per la gotta che lo tormentava da anni, aveva chiesto di tornare in patria, dove contava di vivere di rendita grazie alla dote della ricca moglie. Il permesso gli venne accordato, anzi venne nominato ammiraglio della flotta di ritorno. Così lui e Anna si imbarcarono sulla nave "Java"; il 24 dicembre, mentre si trovavano al largo, una ventina di marinai cinesi assalì gli ufficiali. Jacobus venne accoltellato a morte, Anna fu ferita ma si salvò. La rivolta fu quasi immediatamente soffocata, gli ammutinati furono rinchiusi nella stiva e il giorno di Natale eliminati uno dopo l'altro con un atto di giustizia sommaria. Per sua fortuna, Frans Reinier, l'unico figlio superstite di Radermacher, era rimasto a Batavia.  Una lista di piante di Giava e una pianta cinese Tra i molteplici interessi di Radermacher c'era anche la botanica. Come commissario delle Terre alte visitò diverse aree dell'isola; conosciamo l'itinerario di due di queste ispezioni: nell'agosto 1776 da Batavia mosse per Krawang, Klapanungal, Buitenzorg, Pondokgede, Tjipanas; nel novembre dell'anno successivo ripercorse la medesima via, per poi proseguire per Megamendung, Telaga Warna, Tjiandjoer e rientrare via Tangerang; nel maggio 1777 fu la volta delle regioni occidentali. Sicuramente approfittò di questi viaggi nell'interno per fare raccolte botaniche e raccogliere informazioni sui nomi e sugli usi tradizionali delle piante di Giava. Anche se non ci è giunto, certamente creò un erbario che entrò a far parte delle collezioni del museo della Società batava delle scienze e delle arti; non a caso, nel primo volume della rivista volle includere istruzioni su come essiccare e conservare i vegetali. Oltre alle raccolte fatte da Radermacher a Giava (e forse a Sumatra), l'erbario presumibilmente comprendeva campioni inviati da Thunberg dal Giappone. Radermacher e Thunberg si erano conosciuti nell'estate del 1775, quando lo svedese era arrivato a Batavia dal Sudafrica; aveva poi proseguito quasi immediatamente per il Giappone, non senza aver preso accordi con Radermacher perché facesse da intermediario con uno dei suoi sponsor, il naturalista Martinus Houttuyn. Il primo di questi invii, spedito da Thunberg a Radermacher a Batavia e da questi inoltrato a Houttuyn ad Amsterdam, dovette raggiungere i Paesi Bassi nel maggio-giugno 1777, come dimostra la nota editoriale dell'ottavo volume della seconda parte di Natuurlijke historie (31 Dicembre 1777) di Houttuyn dove compaiono le prime specie giapponesi. Altre raccolte Thunberg le consegnò di persona quando tornò a Giava da Dejima, nel dicembre 1776. Tra l'altro gli affidò una collezione di pesci, che Radermacher si affrettò a inoltrare ad Houttuyn il quale nel 1782 avrebbe pubblicato 36 specie di pesci giapponesi (21 dei quali nuovi per la scienza) nell'articolo Beschrijving van eenige japansche visschen en andere zee-schepselen (Descrizione di alcuni pesci giapponesi e di alcune altre creature marine). Al secondo passaggio, Thunberg si trattenne a Giava per circa sei mesi e fece estese esplorazioni dell'interno; Radermacher cercò inutilmente di convincerlo a rimanere nell'isola. Anche se non accettò, lo svedese fu profondamente colpito dalla sua personalità e generosità, tanto da dedicargli il genere Radermachia (oggi sinonimo di Artocarpus) con parole di sincera riconoscenza: "Il nome è in onore del sommo mecenate, patrono e massimo fautore delle scienze naturali Jacobus Cornelis Matteus Radermacher, consigliere del Consiglio delle Indie e illustre presidente dell'Accademia delle Scienze di Batavia". Non sappiamo se Radermacher e Houttuyn si conoscessero già in precedenza (è possibile, visto che entrambi erano membri delle società scientifiche di Haarlem e di Vlessingen), ma, oltre a fare "da postino" per gli invii di Thunberg, Radermacher ne aggiunse anche di propri, permettendo al suo corrispondente di pubblicare per primo piante indonesiane come l'albero della canfora di Sumatra Dryobalanops aromaticus. Il suo interesse per la botanica per altro andava oltre i ruoli di mecenate e raccoglitore-collezionista; gli si deve infatti almeno un'opera di botanica, Naamlijst der planten die gevonden worden op het eiland Java (Elenco delle piante trovate sull'isola di Giava) in tre volumi. Il primo, dopo un'introduzione di carattere generale che è anche un omaggio a Linneo di cui viene illustrato sinteticamente il sistema, è costituito dalla descrizione di 99 piante giavanesi, in ordine alfabetico secondo il nome locale. Le descrizioni sono sempre molto sintetiche, ma abbastanza precise. Ad esempio, alla voce Sampar o Tinguli (una delle poche per le quali è fornito anche il nome botanico Cassia fistula), si legge: "Un grande albero con foglie ovali lunghe quattro pollici; fiore con calice a cinque sepali, cinque petali gialli, dieci stami; frutto retto da un gambo rotondo marrone lungo 30 cm che contiene una polpa bianca usata in medicina. Appartiene alla 1a classe Decandria. Il Tingulong descritto da Rumphius è un'altra pianta". Segue un indice in cui, salvo eccezioni, ad ogni specie si fa corrispondere il genere botanico. Da indici sono costituiti anche il secondo e il terzo volume che elencano le piante in olandese, latino, malay (trascritto in caratteri latini). C'è anche una lista dei nomi di Rumphius con i supposti equivalenti latini. Stampata a Batavia nella tipografia della VOC tra il 1780 e il 1782, l'opera ebbe scarsa circolazione ed è stata quasi totalmente ignorata dai botanici successivi. Era tuttavia nota a H. Zollinger e A. Moritzi che proprio in ragione di quest'opera gli dedicarono il genere Radermachera scrivendo: "In onore del sig. J. C. M. Radermacher, che scrisse Naamlyst der planten op het eiland Java e altre opere simili, Batavia 1780-4, amico e protettore di Thunberg, membro del Consiglio delle Indie". La specie sulla base della quale i due botanici svizzeri crearono il genere è R. stricta, oggi R. glandulosa, in precedenza descritta da Blume come Spathoidea glandulosa. È una delle poche specie presenti anche in Indonesia. Infatti il centro di diversità di questo genere dell'Asia tropicale di circa 17 specie delle famiglia Bignoniaceae è la Cina, con sette specie. E alla Cina (anche se il suo areale è molto più vasto) fa riferimento l'eponimo della specie più nota, R. sinica, che da qualche anno ha incominciato ad acquisire in certa popolarità come pianta da appartamento magari in forma di bonsai. Le Radermachera in effetti sono alberi, anche di grandi dimensioni (alcune specie possono raggiungere in 40 metri) con foglie composte sempreverdi e grandi fiori a tromba bianchi, viola o gialli, raccolti in infiorescenze a pannocchia. R. sinica però si adatta anche alla coltivazione in vaso; in queste condizioni mantiene dimensioni contenute (al massimo mezzo metro) e si fa apprezzare per il bellissimo fogliame lucido verde smeraldo, mentre raramente fiorisce. Invece in natura è un albero che può raggiungere i 30 metri con grandi fiori bianchi che si aprono al tramonto e al mattino già sfioriscono. È a questi fiori candidi che deve uno dei suoi numerosi nomignoli "bambola di porcellana"; si riferisce invece ai frutti, lunghe e strette capsule che possono ricordare serpentelli, il soprannome "albero serpente" e al colore delle foglie "albero smeraldo". Per la vastità e la diversità degli argomenti toccati, la Storia naturale (Natuurlyke Historie) dell'olandese Martinus Houttuyn, con i suoi 37 volumi, può essere paragonata solo all'Histoire naturelle di Bouffon, che ne comprende 36. Certamente è meno originale e brillante, ma è stato osservato che, per quanto riguarda gli animali, il francese non andò oltre gli uccelli e i quadrupedi e omise le piante, mentre l'olandese trattò in modo completo il regno animale, inclusi gli insetti e altri invertebrati, e non trascurò quello vegetale. Inoltre, mentre Buffon poté avvalersi dell'assistenza di Daubenton e Gueneau de Montbeillard, Houttuyn lavorò completamente da solo, realizzando uno straordinario one's man work, che lo impegnò per un trentennio. Senza dimenticare che, per le sue ricerche, il conte di Buffon poteva disporre delle raccolte del Jardin du Roi, delle collezioni, delle biblioteche e dei laboratori della capitale culturale d'Europa, nonché di un notevole patrimonio personale, mentre Martinus Houttuyn viveva in una Amsterdam orami relativamente provinciale e poteva contare solo sui gabinetti di curiosità di alcuni amici, e soprattutto sul suo, messo insieme barcamenandosi tra un lavoro editoriale e l'altro. Membro di due società scientifiche e corrispondente di diversi naturalisti di primo piano, tra cui Carl Peter Thunberg, in vita Houttuyn godette di una certa fama, ma poi fu quasi totalmente dimenticato. Il motivo principale è che aveva scritto in olandese, limitando fortemente la diffusione di quell'opera gigantesca, già di per sé costosa e adatta a poche tasche. Al di fuori degli specialisti, a mantenere vivo il suo ricordo è dunque soprattutto il genere Houttuynia che gli fu dedicato appunto da Thunberg.  L'one man's work di un naturalista olandese Dopo trent'anni di lavoro, dovette essere certamente con sollievo che Martinus Houttuyn (1720-1798) scrisse l'ultima parola della sua Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus (Storia naturale o descrizione dettagliata di animali, piante e minerali, secondo la classificazione del signor Linneo). Un sollievo che traspare nei versi commossi (e commoventi) che chiudono il 37esimo e ultimo volume; l'opera di una vita è terminata e il sessantacinquenne Houttuyn può pensare all'eternità: "O Creatore della natura la cui meravigliosa mano ha portato il mondo a una condizione così bella, ha ornato il Regno terrestre di persone, animali e piante e il suo interno di metalli e diamanti preziosi, tu che tutto mantieni, tu, o buon Signore, che hai avuto la compiacenza di assistermi per più di trent'anni dedicati ad osservare le tue creature per rafforzare il sapere dei miei connazionali, ora che - sei volte dieci più cinque - il ciclo dei miei anni si chiude, concedi che, dopo questo, il mio nobile spirito nell'eternità si avvicini meglio alla tua sapienza, si diverta con le creature celesti nel coro degli angeli, mentre il Paradiso mi offre i suoi frutti". Traspare anche una profonda religiosità, che Martinus (Maarten nella forma olandese, che però il naturalista non usò mai nei suoi scritti) dovette assorbire fin dalla nascita nella piccola congregazione mennonita di Hoorn, di cui il padre Willem era allo stesso tempo medico e predicatore laico. Fu il padre ad impartirgli una accurata educazione, che, oltre alla medicina, comprendeva matematica, geometria, fisica, astronomia, botanica sistematica (secondo il sistema di Tournefort) e "l'enorme diversità della natura". Nel 1647, a 27 anni, si iscrisse alla facoltà di medicina di Leida e conseguì la laurea due anni dopo; era un'età avanzata per l'epoca, probabilmente spiegata dalla scarsa disponibilità economica della famiglia, e quindi dal desiderio di abbreviare il più possibile il soggiorno nella costosa città universitaria. Dopo la laurea Martinus Houttuyn tornò per breve tempo ad Hoorn, per poi trasferirsi con la famiglia (nel frattempo si era sposato e aveva un figlio) a Amsterdam dove dal 1753 risulta registrato come cittadino e medico; secondo alcune fonti, prestò servizio come medico della comunità mennonita di Amsterdam, ma presto il suo lavoro principale divenne quello editoriale. Incominciò infatti a lavorare per il secondo cugino Frans Houttuyn, un editore stampatore che, probabilmente proprio approfittando del talento linguistico e delle vaste competenze di Martinus, a partire dal 1755 cominciò pubblicare "Uitgezogte Verhandelingen" (Articoli selezionati), una rivista trimestrale che presentava al pubblico olandese traduzioni o recensioni delle migliori e più importanti pubblicazioni delle principali società scientifiche straniere. Come capo redattore Martinus Houttuyn, oltre a coordinare il lavoro degli altri collaboratori (non tutti sono stati identificati, visto che firmavano solo con l'iniziale; uno di loro però era lo zoologo Cornelius Nozeman), forniva la maggior parte delle traduzioni e anche qualche articolo originale; all'inizio si concentrò sui testi medici, ma poi allargò sempre più il suo interesse alle scienze naturali. La rivista proseguì le pubblicazioni per dieci anni, fino al 1765, quando lo stesso Houttuyn decise di mettervi fine, sia in seguito alla morte del cugino (gli ultimi numeri furono pubblicati dagli eredi - De erven van F. Houttuyn - o meglio dai tutori o dagli esecutori testamentari dei figli bambini di Frans) sia per l'ingentissimo impegno della pubblicazione di Natuurlyke Historie, di cui nel frattempo erano usciti i primi volumi. Fu certamente l'esperienza della rivista a convincere Martinus Houttuyn dell'urgenza di un'ampia trattazione enciclopedica che presentasse in lingua olandese l'intero campo delle scienze naturali a un pubblico di media cultura che non leggeva il latino. Si imbarcò così nell'impresa di descrivere animali, piante, minerali, usando come punto di riferimento la dodicesima e ultima edizione di Systema naturae di Linneo. Il primo volume di Natuurlyke Historie "Sull'uomo e alcuni mammiferi" uscì per i tipi di Frans Houttuyn nel 1761; i volumi successivi uscirono con cadenza regolare nell'arco di quasi 25 anni (il volume 37 uscì infatti nel 1785). Dopo la morte di Frans Houttuyn, avvenuta come abbiamo già detto nel 1765, la pubblicazione fu continuata dai suoi eredi, per poi essere completata dall'editore J. van der Burgh che stampò gli ultimi quattro volumi (1784-85). Come vedremo meglio più avanti, quell'opera monumentale non fu certo un successo commerciale. Per mantenere sé stesso e la famiglia, Houttuyn dovette continuare a lavorare come traduttore (tradusse tra l'altro dal francese Description des expériences de la machine aérostatique de MM. Montgolfier et celles auxquelles cette découverte a donné lieu di Barthélemy Faujas de Saint-Fond, facendolo precedere da un'ampia introduzione e arricchendolo con numerose note); continuava anche a collaborare a diverse riviste e a scrivere contributi di varia estensione e argomento. La pubblicazione di Natuurlyke Historie e il possesso di un ricco gabinetto di curiosità, che aveva creato essenzialmente come strumento di studio per la compilazione della sua enciclopedia, gli diedero una certa fama in patria e all'estero. Nel 1775 fu ammesso alla Società scientifica della Zelanda di Vlissingen e nel 1780 alla Società scientifica olandese di Haarlem. Corrispondeva regolarmente con la prima, frequentava attivamente le riunioni della seconda e collaborava alle riviste di entrambe con articoli di zoologia, botanica e mineralogia e traduzioni di articoli di scienziati stranieri (tra cui Carl Peter Thunberg, che aveva conosciuto quando questi viveva in Olanda, divenendo probabilmente uno degli sponsor del suo viaggio in Sudafrica e Giappone). Dopo la conclusione di Natuurlyke Historie, Houttuyn fu coinvolto in un'altra importante impresa editoriale: nel 1786 gli fu richiesto di continuare Nederlandsche Vogelen (Gli uccelli olandesi), rimasto incompleto per la morte dell'autore Cornelius Nozeman; sfortunatamente neppure lui poté ultimarlo; morì infatti nel 1798 senza aver concluso il compito. Il suo ricco gabinetto di curiosità era già stato venduto qualche anno prima, in due aste tenutesi rispettivamente nel 1787 e nel 1789.  Non solo "divulgatore" di Linneo Riccamente illustrata (le tavole calcografiche, di eccellente qualità, si devono a Jan Caspar e Caspar Philips) e graficamente curata, Natuurlyke Historie era un'opera di proporzioni monumentali estremamente costosa. Da questo punto di vista mancò l'obiettivo di Houttuyn di divulgare la storia naturale presso il largo pubblico, che non poteva permettersi di acquistarla e incominciava a trovare anche in lingua olandese opere molto più maneggevoli ed economiche. Incontrò invece una discreta accoglienza e giudizi positivi da parte degli addetti ai lavori. Tuttavia il fatto che fosse scritta in olandese ne limitò la diffusione al di fuori dei Paesi Bassi. Unica eccezione, la Germania, dove a partire dal 1777 ne venne pubblicata una traduzione riveduta e corretta a cura di Statius Müller per la parte zoologica e di Christmann & Panzer per quella botanica. Gli editori tedeschi, per ragioni puramente commerciali, la presentarono non come un'opera originale ma come una riedizione di Systema naturae: nel frontespizio Linneo figura come autore, mentre Houttuyn come semplice curatore: "Del cavaliere Carl von Linné Sistema naturale completo preparato secondo la dodicesima edizione e secondo le istruzioni dell'opera olandese di Houttuyn". D'altra parte, anche nel frontespizio dell'edizione olandese figurava solo il nome di Linneo e bisognava andare a cercare il nome del modestissimo Houttuyn nelle pagine interne, in calce alle prefazioni ai singoli volumi. Ciò ha fatto sì che anche oggi il naturalista olandese sia conosciuto più come divulgatore di Linneo che come studioso indipendente, contro ogni evidenza: Natuurlyke Historie comprende 21.500 pagine di testo e 296 tavole calcografiche, contro 2370 pagine e 3 tavole della dodicesima edizione di Systema naturae. Del resto, l'intento era totalmente diverso: non classificare l'intero mondo naturale in ordine gerarchico, ma illustrare approfonditamente un numero ridotto di specie significative, raccogliendo tutte le informazioni disponibili nella letteratura scientifica, se possibile integrandole con l'osservazione diretta. Così, per limitarci al regno vegetale, contro le 6000 specie elencate da Linneo e descritte con una succinta diagnosi che raramente supera le dieci parole, ecco le 275 specie esaminate da Houttuyn in capitoli che quasi sempre si dilungano per più pagine, con puntuali riferimenti e spesso citazioni della letteratura botanica contemporanea, che ci riportano al taglio enciclopedico e al sapere erudito dei naturalisti rinascimentali. Houttuyn divise il suo magnum opus in tre parti: zoologia (prima parte, 18 volumi), botanica (seconda parte, 14 volumi), mineralogia (terza parte, 5 volumi). La parte (Deel) di botanica uscì tra il 1773 e il 1783. Estesa per 8600 pagine e illustrata da 105 tavole calcografiche, presenta 275 specie, un centinaio delle quali nuove o poco note. Il primo volume inizia con una estesa trattazione dei principi generali della botanica, seguita da un profilo storico che dà ampio spazio ai sistemi di classificazione, da quello classico di Tournefort a quello recente di Michel Adanson. Si passa poi al primo gruppo di piante, le palme (anche in Linneo sono una categoria tassonomica a sé) con 12 specie. Nei volumi successivi le piante sono sì classificate nelle 24 classi linneane, ma anche raggruppate in più vaste e tradizionali categorie: ecco dunque gli alberi (vol. 2-3), gli arbusti (vol. 4-6), le erbacee (vol. 7-11), le bulbose (vol. 12), le graminacee (vol. 13) e, a concludere il tutto, le crittogame (felci, alghe, muschi e funghi). Come sappiamo dai cataloghi che Houttuyn redasse per le aste del 1787 e del 1789, lo studioso olandese possedeva un vasto erbario di piante esotiche (oggi in parte conservato pressoml'erbariomdi Ginevra); anche se egli stesso non si era mai allontanato dai Paesi Bassi, poté arricchirlo grazie a campioni raccolti da altri e in particolare da Carl Peter Thunberg, di cui, nonostante le scarse disponibilità economiche, dovette essere uno dei finanziatori se lo svedese si premurò di fargli arrivare esemplari di piante inedite dal Sudafrica, da Ceylon, dal Giappone e da Giava, spesso accompagnati da qualche nota e talvolta da un nome. Un altro dei fornitori di Houttuyn fu l'alto funzionario della VOC e botanico dilettante Jacobus Cornelius Matheus Radermacher che, oltre a fare da tramite tra Houttuyn e Thunberg (gli inviò piante giapponesi che lo svedese aveva mandato a Batavia), contribuì egli stesso con almeno due invii di piante raccolte a Giava. In Natuurlyke Historie Houttuyn propose 11 nuovi generi e circa 140 nuove specie o combinazioni. Anche se la loro pubblicazione precede le descrizioni dello stesso Thunberg o del figlio di Linneo, vista la scarsa circolazione dell'opera, poche delle sue denominazioni furono accolte dai botanici successivi. Tra i generi l'unico accettato è Reynoutria; venti invece sono le specie, e tra di esse piante notevoli come le sudafricane Massonia depressa, Ornithogalum dubium, Ixia campanulata, le giapponesi Leonuros japonicus e Reynoutria japonica, e soprattutto Myristica fragrans, l'albero che produce le noci moscate.  La pianta camaleonte La morte di Houttuyn (avvenuta, come si è detto, nel 1798), coincise con il tramonto della potenza mercantile dei Paesi Bassi e con la perdita della stessa indipendenza politica, con la trasformazione in uno dei paesi satelliti della Francia rivoluzionaria prima, napoleonica poi. Anche queste circostanze contribuirono ad offuscare la memoria del naturalista olandese, che nell'Ottocento era al massimo ricordato - come abbiamo visto, a torto - come divulgatore di Linneo. A ricordarlo è dunque rimasto soprattutto il genere Houttuynia, pubblicato da Thunberg in Flora japonica nel 1784, con una dedica laconica: "Ho imposto al genere questo nome in onore del sig. Houttuyn, olandese, botanico meritevole e dottore in medicina". Houttuynia Thunb. (famiglia Saururaceae) è un genere monospecifico rappresentato da una nota pianta da giardino, H. cordata. Originaria del sudest asiatico (e in particolare della Cina e del Giappone), è una vigorosa tappezzante amante dei terreni umidi e delle posizione ombrose. Più che per i modesti fiori bianchi, è apprezzata per le belle foglie cordate, soprattutto nella varietà 'Chameleon' (nota anche con i sinonimi 'Variegata' e Tricolor'), con vivaci variegature crema e rosso-rosate più vivide se esposta al sole. Le foglie sono aromatiche e in Giappone e in Corea sono usate secche per preparare tisane, mentre fresche sono un ingrediente della cucina vietnamita. Anche i rizomi sono eduli e sono particolarmente apprezzati nella cucina della Cina sudorientale. Talvolta i nomi botanici di piante diversissime sono così simili che si tende a confonderli. È il caso di Hottonia e Houttuynia, tanto più che la prima è una pianta acquatica e la seconda non disdegna i terreni intrisi d'acqua. La confusione è anche maggiore se guardiamo ai dedicatari: Hottonia ricorda Petrus Hotton o Hottonus, noto anche come Pieter Houttuyn, mentre Houttuynia è dedicata a Martinus Houttuyn. Entrambi olandesi, sono vissuti a circa un secolo di distanza e, a quanto risulta, non hanno alcuna parentela. In ordine di apparizione, iniziamo dunque con Petrus Hotton e la sua Hottonia.  Un botanico illustre, ma quasi dimenticato In un passo della prolusione con la quale inaugurava il corso di botanica all'università di Leida, il medico, botanico e professore universitario Petrus Hotton (1648-1709), a proposito dell'antico rizotomo Crateva, lamenta che "il tempo vorace ci invidia gli scritti degli uomini più celebri", tanto che di quell'uomo citato con elogio dai maggiori scittori antichi non rimane neppure un frammento. A Crateva Hotton doveva essere affezionato, visto che ne prese il nome quando fu eletto all'Accademia leopoldina, e, a posteriori, possiamo dire che quelle parole calzano perfettamente anche a lui. Celebre al suo tempo, anch'egli è oggi quasi dimenticato, anche se ce n'è giunta almeno qualche riga. Era figlio di Godefroy Hotton, un predicatore ugonotto di origine francese o vallona, e di sua moglie Anna Maria Ros. Non conosciamo il luogo di nascita di Hotton padre; il cognome ci riporta o alla Francia del Nord o alla Vallonia. Sappiamo invece che studiò a Heidelberg, quindi fu successivamente predicatore a Frankenthal, Aquisgrana e Brema; quando il Limburgo fu riconquistato dai Paesi Bassi, fu nominato predicatore prima delle comunità rurali poi della città di Limburgo. Intorno al 1634 si trasferì ad Amsterdam, dove divenne pastore della comunità vallona, i cui sinodi presiedette più volte. Ha lasciato una raccolta di omelie, tradotte in francese, e l'interessante De Christiana inter Europaeos Evangelicos concordia, in cui propugna la necessità di superare i contrasti tra le diverse confessioni riformate. Alla nascita del figlio Pieter (forse in famiglia sarà stato chiamato Pierre) aveva già superato la cinquantina, e il bimbo rimase orfano di padre ad appena otto anni. Della sua educazione si sarà occupata la madre, o anche la comunità vallona. In ogni caso nel 1665, a diciassette anni, lo troviamo immatricolato alla facoltà di medicina di Leida, dove nel 1672 divenne dottore in medicina con la tesi Positiones quaedam medicae. Tornò quindi ad Amsterdam dove lavorò come medico; trascorso anche qualche tempo in Danimarca, in viaggio di studio. Allievo di Arnold Syen, che probabilmente lo avviò all'uso del microscopio e orientò il suo interesse per le piante esotiche, era profondamente interessato alla botanica. Dopo la morte del maestro, fu chiamato per breve tempo (1678-1680) a insegnare botanica e dirigere l'orto botanico di Leida come supplente di Paul Hermann, che al momento si trovava ancora a Ceylon. Ritornò poi al suo lavoro medico ad Amsterdam e per qualche tempo non sappiamo nulla della sua attività come botanico. Intorno al 1684 gli fu offerta la cattedra di botanica a Groninga che rifiutò. Nel 1692 il consiglio cittadino di Amsterdam lo nominò assistente di Frederik Ruysch, che affiancava nelle lezioni di botanica farmaceutica presso l'Hortus della città (l'altro assistente era Caspar Commelin, che si occupava delle piante esotiche), con il titolo di Horti Medici botanicus. Mantenne l'incarico fino al 1696, quando, in seguito alla morte di Paul Hermann, fu nominato professore di botanica e direttore dell'orto botanico di Leida, incarico che resse fino alla morte nel 1709. Questa la sua carriera accademica. Era stimato dai suoi contemporanei, frequentava i circoli eruditi olandesi, aveva una vasta rete di corrispondenti (tra gli altri, Anton van Leeuwenhoek, John Ray, Joseph Pitton de Tournefort e gli italiani Giorgio Baglivi, Michelangelo Tilli e Giovan Battistia Trionfetti) e fu membro della Royal Society e dell'Accademia curiosorum leopoldina, nonché socio corrispondente dell'Academia delle scienze parigina. Eppure scrisse pochissimo. A parte la tesi di laurea e qualche lettera, di lui ci rimane come maggiore opera certa proprio la già citata prolusione, pronunciata il 9 maggio 1695 al momento di assumere la cattedra di botanica a Leida. Intitolata Sermo accademicus quo rei Herbariae historia et fata adumbrantur, nella prima parte è una sintetica storia della botanica, dagli antichi fino ai contemporanei che dimostra di conoscere bene, nella seconda un elogio della botanica e delle sue "magnifiche sorti e progressive". È datato marzo 1701 il suo unico contributo alle "Transactions della Royal society", De acemella et ejus facultate lithontriptica, sotto forma di lettera in cui presenta una pianta i cui semi era giunti da Ceylon all'orto botanico di Amsterdam nel 1691 (oggi Acmella paniculata, un'annuale con proprietà mediche e insetticide). Hotton conosceva bene e ammirava l'opera di Rumphius e del suo predecessore Hermann ed era entusiasta dalle prospettive mediche, farmaceutiche, economiche delle piante esotiche che sempre più copiose giungevano dai quattro angoli del mondo agli orti botanici di Leida e Amsterdam, e scambiava volentieri i loro semi con i suoi corrispondenti. Coltivava però anche interessi teorici e tassonomici e tra tutti i botanici contemporanei ammirava in massimo grado John Ray, di cui curò l'edizione olandese di Methodus plantarum emendata et aucta, rifiutata dagli editori britannici. L'interesse per la tassonomia è confermato da Hermann Boerhaave, suo allievo e successore, che ne traccia un commosso elogio nella breve storia dell'orto botanico di Leida inclusa nella sua seconda edizione del catalogo del giardino (Index alter plantarum quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, 1719). Secondo la sua testimonianza, Hotton avrebbe elaborato un proprio metodo (che egli definisce "Syntaxis herbaria perfectissima") che, pur movendo dalla lezione di Pitton de Tornefort, la integrava con una profonda conoscenza della letteratura botanica. Uomo prudente e metodico, secondo Boerhaave Hotton si muoveva con lentezza, tutto esaminando e considerando, senza fermarsi alla prima impressione. Con tanta lentezza che, ucciso a soli sessant'anni dal freddissimo inverno del 1709, non poté né completare né pubblicare il proprio metodo "con sommo detrimento della botanica". Qualche mese dopo la sua morte la sua vasta biblioteca fu messa all'asta. Contava più di 4000 volumi; oltre metà era costituita da testi di medicina ed anatomia, ma erano ricchissime anche le sezioni di scienze naturali e botanica, dove non sembra mancare nessuna opera significativa; la presenza di opere costosissime come Hortus eystettensis o i tredici volumi di Hortus malabaricus attesta poi una notevole disponibilità economica. Ma la biblioteca di Hotton non si limitava a quella che potremmo considerare letteratura professionale; troviamo infatti copiose sezioni di filosofia (ma all'epoca sotto questa etichetta finivano anche la fisica, l'astronomia, la matematica e la chimica), teologia, diritto, lessicografia, poesia e storia, che ci parlano di un uomo colto e di vasti e variegati interessi. Nonché poliglotta (sempre che quei libri li abbia letti davvero): la maggior parte delle opere è ovviamente scritta in latino (all'epoca ancora la lingua universale della scienza e della cultura), ma, tra le lingue moderne, oltre all'olandese e al francese (che, viste le origini familiari, forse era la sua lingua madre) non mancano testi in italiano (compresa la Gerusalemme liberata di Tasso e le opere complete di Machiavelli), inglese e tedesco. Quasi trent'anni dopo la morte di Hotton, proprio in Germania e in lingua tedesca uscì un'opera postuma attribuita al botanico olandese. Al piede del frontespizio di Thesaurus phytologicus, pubblicato a Norimberga nel 1738, leggiamo infatti: "di Petrus Hotton, dottore in medicina e prefetto dell'orto botanico dell'Università di Leida". Come chiarisce il chilometrico sottotitolo, è un Kräuterbuch, un erbario farmaceutico, che offre ai lettori la descrizione dettagliata e le "strane qualità, virtù ed eccellenti capacità" delle erbe medicinali provenienti dalle quattro parti del mondo, ma specialmente dall'Europa, con il modo più sicuro di usarle, rivolgendosi non solo a medici e farmacisti, ma anche a guaritori, giardinieri, padri di famiglia, casalinghe e "quei malati che vivono in campagna". Insomma, quanto di più divulgativo possibile, e anche quanto di più lontano dall'immagine di Hotton prudente, lento e metodico autore di una perfettissima Synthaxis herbaria presentatoci da Boerhaave. Più che a Ray o Tournefort e agli altri tassonomisti ammirati da Hotton, l'opera sembra guardare alla tradizione rinascimentale, se non medievale, dei Kräuterbücher, anche se rinnovata con l'inserimento di qualche esotica, come il tabacco e il caffé, con le piante elencate in ordine alfabetico e l'unica divisione in erbacee (prima parte) e arboree o arbustive (seconda parte). Che l'abbia scritta davvero Hotton non è affatto certo; come ipotizza Wijnands, egli potrebbe essere il responsabile dei soli indici, latino e tedesco; in tal caso, il suo nome in copertina è una semplice operazione pubblicitaria dei disinvolti editori-stampatori Johan Leonhard Buggel e Johann Seitz.  Piante acquatiche in pericolo Il nostro è talvolta noto con il nome olandesizzato Pieter Houttuyn, ma si firmò sempre Petrus Hotton o alla latina Hottonus. E come tale Boerhaave gli rese omaggio con la dedica del genere Hottonia, accompagnata da parole commosse: "È giusto affidare con animo pio la memoria, a me sacra, dell'uomo illustre Petrus Hotton, mio predecessore, a tutti coloro che amano e coltivano la sapienza, la virtù e la botanica. Fu infatti egli stesso quanto mai illustre in tutte queste cose. Sottratto ai loro occhi, possano i Mani percepire che sopravvive il grato ricordo di un uomo buono ed insigne". Il genere fu recepito da Linneo fin da Hortus Cliffortianus e poi ufficializzato in Species plantarum. Questo piccolo genere della famiglia Primulaceae comprende solo due specie di piante acquatiche: l'europea ed asiatica H. palustris e la nord americana H. inflata. Chiamata volgarmente violetta d'acqua per i fiori bianchi sfumati di lilla, H. palustris è l'unica primulacea completamente acquatica della nostra flora. Cresce principalmente sommersa, con fusti verde pallido che immettono ad intervalli regolari lunghe radici bianco-argentee che fluttuano nell'acqua e si radicano nel fango del fondo. Le foglie lineari, anch'esse sommerse, si dispongono a pettine su verticilli molto ravvicinati; tra maggio e giugno, emerge dall'acqua lo scapo florale eretto, alto da 20 a 40 cm, che reca un'infiorescenza con verticilli sovrapposti di 3-9 fiori; piuttosto grandi e vistosi, hanno corolle con breve tubo e cinque lobi fusi alla base, da bianche a lilla, con una macchia gialla alla fauce. È presente prevalentemente nell'Europa centrale e settentrionale e ai margini dell'area mediterranea, con colonie disgiunte in Siberia. Vive in acque stagnanti, poco profonde e povere di sostanze nutritive; ovunque è minacciata dalla riduzione dell'habitat naturale, dal drenaggio e dall'eutrofizzazione delle acque. Altro fattore negativo è la distanza tra le diverse colonie, che spesso sono formate da cloni della medesima pianta; in assenza di impollinazione incrociata, garantita da bombi, api o sirfidi, H. palustris può autofecondarsi, ma tende a produrre pochi semi. In Italia è rara e presente occasionalmente nelle regioni centro-settentrionali; è inclusa nella liste delle piante a protezione assoluta delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. È in corso un progetto di reintroduzione in alcune aree piemontesi promosso da A.Di.P.A. Piemonte, che al momento incontra difficoltà per i danni provocati dalle nutrie o castorini. H. palustris è talvolta coltivata come pianta da acquario. Per quest'uso è più frequente la specie americana H. inflata, che sopporta temperature più elevate, essendo originaria degli Stati Uniti sudorientali. Ha fiori minuscoli portati al sommo di una rachide rigonfia, da cui l'epiteto; a differenza della specie europea, che come abbiamo visto è può essere impollinata da vari insetti, è probilmente esclusivamente autogama, con conseguente impoverimento della varietà genetica. Anch'essa è fortemente minacciata dalla distruzione di gran parte dei suoi habitat storici. Si spera tuttavia che, con la reintroduzione dei castori negli Stati uniti orientali, possa esserci una ripresa anche per H. inflata che trova il suo habitat di elezione negli stagni di castori, caratterizzati da acque poco profonde con un livello di acqua costante. Si ritiene anche che i castori, raccogliendo per loro tane il fango di fondo che ne contiene i semi, ne facilitino la dispersione. Nel 1626, poco dopo essersi insediata a Batavia, di fronte alle malattie e alle epidemie che decimavano i suoi uomini nelle Indie orientali, la VOC decise di inviare in Indonesia un medico capo che coordinasse tutto il settore saniatario. La scelta cadde su Jacob de Bondt (Jacobus Bontius). Prima di cadere vittima egli stesso delle malattie che affliggevano la colonia olandese, lavorò a Giava per appena quattro anni, molto fruttuosi per le sue ricerche sulle malattie tropicali e sulla storia naturale dell'isola. Lo si ricorda soprattutto per aver descritto per primo malattie come il beriberi e la framboesia e animali come il rinoceronte di Giava e l'orango. Plumier e Linneo gli dedicarono il genere montipico Bontia, che però, dalle Indie orientali, ci porta in quelle occidentali.  Un medico olandese nell'insalubre Batavia Nel 1619 la Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC) prende il controllo della regione di Jayakarta, nel settentrione dell'isola di Giava, e sulle rovine dell'antica capitale edifica un insediamento fortificato che da quel momento ospiterà il suo quartier generale. All'inizio del 1621, con una solenne cerimonia, viene battezzato Batavia (in ricordo dei Batavi, l'antica tribù che abitava l'Olanda all'epoca romana, in cui gli olandesi riconoscono i propri antenati). Per la sua posizione, Batavia era perfetta per essere il centro amministrativo, mercantile e militare della VOC, ma pessima dal punto di vista sanitario. È stato calcolato che nel periodo che va dalla fondazione al 1739 ogni anno tra 500 e 700 dipendenti della Compagnia vi soccombessero di tifo, malaria, dissenteria, beriberi e altre malattie; la cifra si accrebbe drammaticamente dopo questa data, con 2000-3000 perdite annue. Inizialmente l'assistenza sanitaria fu affidata ai chirurghi di bordo delle navi della Compagnia e furono anche inviati alcuni medici nelle stazioni commerciali più grandi, ma nel 1626 i "17 signori" (ovvero la direzione della VOC) decisero di inviare a Batavia un medico capo che dirigesse e coordinasse tutto il settore. La scelta cadde su Jacob de Bondt (o alla latina Jacobus Bontius, 1592-1631). Bondt aveva tutte le carte in regola per assolvere pienamente il compito di medico, farmacista e ispettore dei chirurghi delle Indie orientali. Laureato in medicina all'università di Leida nel 1614, apparteneva a una famiglia di medici e docenti universitari. Suo padre Geraert de Bondt (Gerardus Bontius) fu il primo professore di medicina, matematica e astronomia dell'ateneo, e dal 1587 fu il primo titolare della cattedra di anatomia e botanica, cui nel 1598 si aggiunse la direzione dell'orto botanico. Celebre per la sua erudizione, dell'università di Leida fu anche rettore. Tre dei suoi quattro figli maschi, Reiner, Johannes e Jacob, furono medici. Il maggiore Reiner (o Reynerius Bontius) fu a sua volta professore di medicina e rettore dell'Università di Leida, nonché medico personale di Maurizio d'Orange. Il quarto fratello Willem era invece un giurista ed ebbe ruoli pubblici, incluso quello di borgomastro di Leida e si rese celebre, più che per le sue posizioni religiose ostili ai rimostranti, per aver inscenato un solenne funerale del suo cane che causò grave scandalo. Ma ciò avvenne alcuni anni dopo la morte del nostro Jacob. Quest'ultimo era il più giovane degli otto figli (c'erano anche quattro sorelle) del professor Geraert, e accettò con entusiasmo la proposta dei 17 signori, deluso delle sue prospettive di carriera in patria e convinto che un soggiorno di qualche anno nelle Indie gli avrebbe aperto la strada di una cattedra universitaria. Era talmente fiducioso di questo brillante futuro che decise di portare con sè in Indonesia la moglie e i due figli bambini. Nel marzo 1627 la famiglia Bondt si imbarcò per Giava; sulla stessa nave viaggiava in incognito, a sua volta accompagnato dalla moglie, da un figlio neonato e da altri parenti, il governatore generale delle Indie olandesi Jan Pieterszoon Coen. Bondt portava con sè anche la sua biblioteca di oltre 2000 volumi. Durante il viaggio, che si protrasse fino al 13 settembre, la moglie di Bondt morì. Era il primo dei lutti che avrebbero funestato l'avventura del medico nelle Indie olandesi. Risposatosi poco dopo l'arrivo a Batavia, nel giugno 1630 perse anche la seconda moglie, morta di colera; all'inizio del 1631, fu la volta del figlio maggiore, morto di una malattia infantile (forse morbillo). La menzione della morte di amici e conoscenti punteggia le sue opere ed egli stesso, soprattutto durante i due assedi di Batavia del 1628 e del 1629, si ammalò gravemente e per due volte fu in punto di morte. Indebolito nel corpo e nello spirito, si spense infine a soli 39 anni il 30 novembre 1631. I compiti professionali affidati a Bondt erano gravosi: come medico capo, doveva soprasiedere all'ospedale di Batavia, verificare l'equipaggiamento medico delle navi della Compagnia, ispezionare l'attività di medici e chirurghi (è possibile che a tal fine abbia fatto un viaggio di ispezione nelle Molucche e a Timor), praticare autopsie, prestare assistenza medica ai dirigenti della VOC, a cominciare dal governatore Coen (questi morì di colera durante il secondo assedio di Batavia, e Bondt nella sua opera ne descrive la malattia e la morte). Inoltre durante i due assedi fu nominato membro della corte di giustizia, nel 1630 fu advocaat fiscal e dal 1630 alla morte balivo di Batavia. Nonostante tutti questi impegni, la cattiva salute e i lutti, dedicò moltissimo tempo a investigare la medicina e la natura delle Indie olandesi, con fini sia medici sia più generali. Poco dopo il suo arrivo a Batavia, scrisse a uno dei suoi fratelli: "Mi sto applicando per raggiungere non solo la conoscenza delle erbe che crescono qui a Giava, ma soprattutto per acquisire un'idea più perfetta delle spezie di cui la nostra parte del paese è più fruttuosa". Immediatamente dopo la conclusione del secondo assedio di Batavia (maggio-settembre 1629), completò Methodus Medendi qua in Indiis Orientalibus oportet in cui descrisse 19 malattie del ventre, del torace e della pelle comuni nelle Indie ma sconosciute nei Paesi Bassi, tra cui il beriberi e la framboesia. Dimostrò anche grande ammirazione per i guaritori locali, in particolare per la loro abilità nel curare la dissenteria e altre affezioni intestinali. Ne fece i suoi informatori per conoscere le virtù delle erbe medicinali, nelle quali riconosceva il rimedio sovrano: "Dove le malattie sono endemiche, la mano generosa della natura ha piantato a profusione erbe le cui virtù sono adatte a contrastarle". Nella dedicatoria a Methodus Medendi, dedicato ai 17 signori, egli afferma di star componendo un'opera sulla storia naturale della regione e quando sarà finita promette "un commento sugli alberi, arbusti ed erbe che crescono a Giava". Lamenta anche che la malattia, che lo ha bloccato per quattro mesi gli abbia impedito di "viaggiare nel paese per esplorare liberamente le deliziose foreste di Giava e acquisire una conoscenza esatta delle erbe più nobili che vi vivono". Per scrivere quest'opera, da tempo doveva aver cominciato a raccogliere note di campo e disegni. Nel gennaio 1631 Bondt completò una seconda opera, De conservanda valetudine; si tratta di un dialogo sul modo migliore per conservare la salute nel clima difficile delle Indie, ispirato ai Coloquios dos simples e drogas da India di Garcia da Orta, che Bondt conosceva grazie all'edizione di Clusius. Gli interlocutori sono lo stesso Bondt (Bontius) e Duraeus, ovvero lo scozzese Andrew Durie, capo chirurgo del Castello e più tardi del secondo ospedale di Batavia. Fu compagno di escursioni di Bondt che lo definisce "chirurgus expertissimus". Subito dopo aver completato questo breve lavoro, in cui in vari punti si discosta da Garcia da Orta, Bondt ne analizzò più compiutamente l'opera in Animadversiones in Garciam da Orta, in cui, secondo Cook, "offre gentili correttivi e supplementi all'opera di da Orta"; al suo predecessore si ispira come metodo, ma aggiunge molte informazoni di prima mano. Così descrive Assa foetida che il portoghese conosce solo di nome e a proposto del rinoceronte che da Orta confessa di non aver mai visto, Bondt scrive: "Non solo l'ho visto un centinaio di volte nascosto nelle sue tane, ma anche mentre vaga nella foresta", per poi raccontare un incontro alquanto pauroso. Era un assaggio della quarta e ultima opera di Bondt, quella sulla storia naturale di Giava, che considerava il suo compito principale ma non riuscì a completare a causa della morte. Più di dieci anni dopo la sua scomparsa, i tre saggi completati, preceduti dalla dedicatoria a mo' di prefazione, andarono a costituire De medicina Indorum (Leida, 1642). pubblicata a cura del fratello Willem. Più tardi. non sappiamo per quali vie, il manoscritto dell'incompleta storia naturale pervenne a Willem Piso, che decise di pubblicarlo nella sua De Indiae Utriusque re naturali et medica (Amsterdam, 1658). L'opera di Bondt ne costituisce la seconda parte, Historia naturalis et medica Indiae orientalis, in sei libri; i primi quattro sono una riedizione di De medicina indorum, il quinto ("De quadrupedibus, avibus et piscibus") e il sesto ("De plantis et aromatibus") sono tratti dal manoscritto inedito. Gli animali presentati sono 33 e le piante 62. Cook, che ha riscoperto ed esaminato il manoscritto originale, conservato tra le carte appartenute al collezionista William Sherard, ha constatato che esso contiene le descrizioni, senza ordine apparente, di 16 animali e 42 piante; molte sono accompagnate da illustrazioni, note e commenti. Presumibilmente c'era un secondo volume, oggi perduto. Confrontando il manoscritto con il testo a stampa, risulta che Piso ha dato un ordine ai materiali, ha ritoccato il latino, aggiunto poemi introduttivi e informazioni occasionali, e anche introdotto qualche argomento nuovo, basandosi su informazioni ricevute da persone che erano state nelle Indie dopo Bondt. Insomma, si comportò da editor relativamente rispettoso, come abbiamo già visto per i materiali sulla flora e la fauna brasiliane ricavati da Marcgraf. Stando alle lettere di Bondt. un certo numero di immagini dovettero essere disegnate da un suo cugino, Adriaen Minten. Altre da lui stesso, ricorrendo al metodo dell'imprinting (cioè ricalcando l'impronta del soggetto). Tra quelle di animali, alcune sono notevoli. Non solo troviamo la prima immagine credibile del rinoceronte di Giava (Rhinoceros sondaicus), diverso da quello indiano, ma anche un babirussa di Sulawesi, una tigre vista presumibilmente a Bali, e persino un dodo, non ancora estinto quando il medico, in viaggio per l'Indonesia, fece scalo a Mauritius. L'immagine più intrigante è però quella dell'organo, che chiaramente Bondt non aveva mai visto di persona, ma di cui aveva sentito parlare dai locali in termini più o meno favolosi come di un "uomo dei boschi" forse persino dotato di parola. E come un uomo selvatico è raffigurato, non sappiamo per iniziativa di chi (forse di Piso o dell'editore Elzevir). Quanto alle piante, quelle descritte sono quasi tutte medicinali, più qualcuna culinaria, per le quali Bondt raccolse informazioni da donne locali. C'è anche un capitolo sul tè e le sue virtù medicinali, ma non un'immagine, perché Bondt lo conosceva solo nella forma essiccata che era commercializzata a Giava e le informazioni che aveva raccolto da più parti, tra cui Jacques Specx, che prima di essere nominato governatore generale aveva vissuto in Giappone, erano contraddittorie.  Un olivo... americano Si deve nuovamente a Plumier la dedica a Bondt di uno dei suoi generi americani, Bontia, poi fatto proprio da Linneo. Molto sobriamente, Plumier lo ricorda come "medico ordinario" della città di Batavia a Giava e come autore dei sei libri di Historia naturalis et medica Indiae orientalis, pubblicati da Piso. Egli scrive anche di conoscere una sola specie di questo genere. Ed è così anche oggi. Bontia (Scrophulariaceae) è infatti un genere monospecifico, il cui unico rappresentante è B. daphnoides, un arbusto o piccolo albero che cresce nella maggior parte delle isole dei Caraibi e lungo le coste del Venezuela e della Guyana, soprattutto nei boschi di mangrovie. Ha foglie coriacee, ellittiche, con accentuata nervatura sulla faccia inferiore, che possono ricordare quelle del genere Daphne (da qui l'eponimo), cosparse di ghiandole oleose. Ma forse l'allusiome è all'olivo, come farebbero pensare alcuni nomi volgari, come wild olive (Barbados) olivier bord de mer (Martinica) o aceituna americana (Cuba), che fanno riferimento non alle foglie, ma ai frutti, drupe grossolanamente sferiche dapprima verdi poi nere a maturazione. Curiosi i fiori, che sbocciano solitari all'ascella delle foglie. Retti da un lungo picciolo, hanno cinque sepali verdi appuntiti a forma d'uovo e cinque petali uniti alla base a formare un lungo tubo bruno-giallastro ricoperto da numerose ghiandole che poi si apre in due lobi diseguali diffusi e retroflessi. Essendo piuttosto ramificato e sempreverde, nei Caraibi è spesso utilizzato come frangivento e per siepi difensive; è stato introdotto in Florida e alle Hawaii. Decotti delle foglie sono utilizzati nella medicina tradizionale per curare varie affezione e le ricerche ne hanno confermato le proprietà antivirali, Il medico Willem Piso, che aveva scritto la sezione medica di Historia naturalis Brasiliae, dieci anni dopo pubblicò sotto il proprio nome un'opera sulla storia naturale e medica delle Indie occidentali e orientali, per la quale utilizzò tra l'altro materiali tratti dalla sezione sulla storia naturale scritta da Georg Marcgraf. Il fratello di questi lo accusò di plagio, compromettendo fortemente la sua reputazione scientifica. L'accusa era fondamentalmente infondata ma influenzò anche Linneo che, nel confermare il genere Pisonia creato da Plumier a partire da una pianta spinosissima, scrisse che quella orrida pianta ben si confaceva all'orrida fama di Piso. In realtà, è quasi l'unica specie spinosa del genere, ma, per altre ragioni, su almeno una delle sue consorelle aleggia una fama molto più sinistra.  Un medico nel Brasile olandese Nel 1658, dieci anni dopo Historia naturalis Brasiliae, presso l'editore Elzevir di Amsterdam usciva De Indiae utriusque re naturali et medica, che solitamente ne è considerata la seconda edizione. In realtà non è esattamente così, anche se i due volumi hanno in comune diversi materiali e sono strettamente legati, fin dal frontespizio. Quello della seconda è ricavato da quello della prima, sostituendo la figura femminile sulla destra con un uomo che indossa un turbante e la figura allegorica al centro e vari particolari in secondo piano e sullo sfondo con animali dell'Asia e dell'Oceano indiano, per adattarlo al nuovo contenuto: non più la storia naturale del Brasile, ma la storia naturale e medica di entrambe le Indie, quelle occidentali (le Americhe) e quelle orientali (il Sudest asiatico). In entrambi i volumi il titolo è racchiuso in un ricco cartiglio, retto da due scimmie quello sul Brasile, da due uccelli (forse cigni) quello sulle due Indie. Ma la differenza più significativa è un'altra. Nel volume del 1648 leggiamo "Storia naturale del Brasile, per auspicio e beneficio dell'illustrissimo conte Maurizio di Nassau"; dunque non è indicato alcun autore, ma unicamente lo sponsor. Nel volume del 1658 invece leggiamo "Storia naturale e medica di entrambe le Indie, di Willem Piso, medico di Amsterdam". Benché continui a trattarsi di un'opera collettiva, ora c'è un autore che avoca a sè la paternità dell'intero volume. Anche se i concetti di paternità e proprietà letteraria erano all'epoca ancora molto sfumati, il fatti che Piso apparisse come unico autore gli attirò l'accusa di plagio da parte di Christian Marcgraf, che nella sua biografia del fratello Georg denunciò anche il tentativo di Piso di sminuirne la reputazione scientifica, presentandolo come un proprio servitore ("servus meus") e accusandolo di ubriachezza e di irregolarità finanziarie. Linneo sposò questa tesi e rincarò la dose, accusando il medico olandese non solo di essersi impadronito del lavoro scientifico di Marcgraf, ma di averlo rovinato infarcendolo di errori. Se questa è stata a lungo la posizione dominante tra i naturalisti, sono stati piuttosto gli studiosi di storia della medicina a rivalutare Piso, dimostrando che il suo contributo scientifico non è affatto inferiore a quello del collega e rivale. I due erano praticamente coetanei, ma differivano profondamente per background culturale e posizione accademica. Marcgraf aveva avuto una formazione molto ricca e varia, ma a Leida era solamente uno studente straniero, magari molto versato e promettente, ma privo di ogni grado accademico. Al contrario Piso, nativo della città, era un medico laureato e già ben inserito negli ambienti scientifici. Willem o Gulielmus Piso (1611-1678) è lo pseudonimo latinizzato di Willem Pies, nato a Leida da padre tedesco e madre olandese; il padre Härmen Pies, originario del ducato di Cleve, si era trasferito a Leida per studiare medicina, ma, oberato da una famiglia numerosa, aveva abbandonato gli studi per diventare cantore e organista. Willem già a 12 anni risulta iscritto alla facoltà di medicina, un'iscrizione precoce forse finalizzata a ottenere l'esenzione da alcune tasse; fu poi allievo di Otto Heurnius, acquisendo un'eccellente preparazione clinica e anatomica nonché la propensione alla verifica sperimentale. Per evitare le ingenti tasse di dottorato a Leida, concluse gli studi all'università di Caen in Normandia, dove nel 1633, all'età di 22 anni, conseguì il dottorato in medicina. Poco dopo si trasferì ad Amsterdam, dove incominciò a farsi conoscere per la sua competenza clinica. Forse già in questi anni era interessato alla medicina tropicale e potrebbe essere stato in contatto con il medico della VOC Jacobus Bontius. Nel 1638, essendo morto in Brasile poco dopo il suo arrivo il primo medico personale del governatore Johann Maurits di Nassau Siegen, la Compagnia olandese delle Indie occidentali (WIC) lo chiamò a sostituirlo. Come tale, oltre ad accompagnare il conte in pace e in guerra, doveva presiedere allo sviluppo del sistema sanitario della colonia, fungere da chirurgo dell'esercito e della WIC ed esplorare le risorse mediche e alimentari del Brasile olandese. Erano compiti complessi e gravosi per una persona sola, gli furono perciò affiancati due assistenti, prima Heinrich Cralitz, poi, dopo la morte di questi, Georg Marcgraf. È esattamente questo il significato del "servus" tanto deprecato dal fratello del naturalista. Certo tra i due dovettero sorgere rivalità e incomprensioni; non sappiamo in quale momento, Marcgraf cessò di dipendere dalla WIC come assistente di Piso, e passò direttamente al servizio del conte. Fosse paranoia, o fosse giustificato, scrisse le sue note di campo in cifra, per impedire a Piso di accedervi. Al contrario del versatile Marcgraf, l'interesse di Piso era eminentemente pratico e focalizzato sulla medicina e l'alimentazione. Era stato educato alla scuola ippocratica, secondo la quale i costumi e gli stili di vita sono influenzati dall'ambiente; studiò dunque con particolare attenzione in quale modo le condizioni ambientali influissero sulla salute e capì che la cosa più sbagliata era mantenere ai tropici le abitudini, i comportamenti e l'alimentazione di casa. Anche in Brasile, gli olandesi continuavano a costruire case in mattoni, ad indossare abiti scuri e pesanti, a indulgere al cibo e all'alcool, tutti comportamenti che logairavano la salute. Tra i coloninolandesi, la mortalità infantile era altissima, molto maggiore di quella dei neonati nativi; secondo Piso, ciò era dovuto all'abitudine di fasciare i neonati, pratica utile in Olanda, ma dannosissima ai tropici. Allo stesso modo, notò che una serie di disturbi della vista colpivano solo gli olandesi, in particolare quelli più poveri, e li collegò all'alimentazione, confrontando la loro dieta con quella dei nativi: quest'ultima era basata soprattutto su pesce fresco e vegetali, che invece spesso mancavano sulle tavole olandesi. Consigliò poi vivamente il consumo di arance e limoni per evitare lo scorbuto. Per vivere (e sopravvivere) ai tropici la ricetta giusta era adeguarsi alle abitudini della popolazione locale e fare tesoro della loro conoscenza dell'ambiente naturale, con le sue insidie e i suoi doni, in particolare per quanto riguarda le proprietà delle piante medicinali e alimentari. Anche se nella sua opera non manca una certa spocchia eurocentrica, gli era chiaro che i nativi erano depositari di un sapere la cui conoscenza era imprescindibile: "Sebbene in un ambiente tanto barbaro si possano osservare molte usanze false, rozze e indegne dell'arte di Ippocrate, ce ne sono tuttavia alcune che sono molto efficaci e meritano un posto nella medicina classica [...] Se, come si è detto, i fondamenti di molte arti ci sono pervenuti da popoli primitivi, ai quali la benevola Madre Natura diede l’innato istinto di guarigione, chi può dubitare che questi esseri umani – pur non avendo alcun legame con la dotta scienza dell'arte medica - abbiano trasmesso ai loro discendenti molte medicine e antidoti nobili e segreti, sconosciuti ai medici classici?" Fu dunque osservando le pratiche mediche indigene e sperimentandole egli stesso cure e farmaci con i suoi pazienti che Piso poté riconoscere le proprietà di molti dei medicamenti esposti nelle sue opere. Studiò poi attentamente sia le malattie importate dall'Europa e dall'Africa sia quelle endemiche del Brasile, cercando di capirne le cause e suggerendo possibili rimedi. Da questo punto di vista, il suo contributo maggiore è considerato l'introduzione dell'ipecacuana, che aveva appreso dai guaritori indigeni. Piso rimase in Brasile circa sette anni e tornò in Olanda con il conte di Nassau Siegen nel 1644, Restò al suo servizio ancora per qualche tempo e nel 1645, benché fosse già dottore in medicina, si iscrisse nuovamente all'Università di Leida, allo scopo di avere libero accesso alla biblioteca per consultare i libri necessari al completamento della prima parte di Historia naturalis Brasiliae, i quattro libri di "Medicina brasiliensis". Intorno al 1647, si trasferì ad Amsterdam dove divenne un medico di successo e un membro riconosciuto della comunità scientifica; nel 1655 fu nominato ispettore del Collegium medicum di Amsterdam, di cui più tardi divenne il decano. Era abbastanza ricco da permettersi una casa sul centralissimo Keizergracht e si inserì nell'élite cittadina anche attraverso i legami familiari: sposò la figlia di uno dei direttori della WIC e poco prima della sua morte, sua figlia Maria, l'unica dei suoi figli a raggiungere l'età adulta, a sua volta sposò Cornelis Munter, futuro direttore della VOC e sindaco di Amsterdam. Insomma, una riuscita scalata al successo sociale. Morto nel 1678, fu sepolto nella Westerkerk, dove da qualche anno riposava Rembrandt.  Plagiario o editor disinvolto? Veniamo dunque all'opera incriminata, De Indiae utriusque re naturali et medica; chiariamo subito che non è propriamente la seconda edizione di Historia naturalis Brasiliae, ma un'opera in gran parte diversa, anche negli scopi. Non è più un libro sul Brasile, ma una sorta di manuale di medicina tropicale, che unisce alle esperienze di Piso in Brasile quelle del medico della VOC Jacobus Bontius in Indonesia. Come Historia naturalis Brasiliae è dunque anch'essa un'opera collettiva e il nome di Piso sul fontespizio va inteso, più che come unico autore o anche autore principale, come editor o curatore di un progetto editoriale complesso. Senza dimenticare che Marcgraf, oltre a comparire come autore di uno dei contributi, è citato nella prefazione come fonte di molte informazioni sulla flora e la fauna del Brasile. Si tratta nuovamente di un corposo in folio riccamente illustrato (oltre 500 pagine e 522 xilografie di piante e animali), diviso in tre sezioni principali più un'appendice. La prima sezione, che occupa due quinti del volume con quasi 330 pagine, è costituita da "Historia naturalis et medica Indiae occidentalis" dello stesso Piso, in cinque libri; la seconda dal "Tractatus topographicus et metereologicus Brasiliae" di Georg Marcgraf (40 pagine); la terza da "Historia naturalis et medica Indiae orientalis" di Jacobus Bontius in sei libri (160 pagine), seguita da "Mantissa aromatica, sive "De aromatum cardinalibus quatuor", nuovamente di Piso (60 pagine circa). Oltre a scrivere la prima parte e l'appendice, Piso è intervenuto come editor anche sui contributi di Marcgraf e Bontius. Nel primo caso, ha aggiunto alle osservazioni meteorologiche informazioni sulle lingue e i popoli del Brasile e del Cile attinte da Historia naturalis Brasiliae; nel secondo, ha aggiunto ai quattro libri dell'opera di Bontius De medicina Indorum due libri sulla flora e la fauna delle Indie orientali, basandosi su manoscritti lasciati dall'autore integrati con le proprie ricerche. Il plagio, se plagio c'è, potrebbe annidarsi nella prima parte, per la quale Piso ha integrato la propria "De medicina brasiliensi" (prima sezione di Historia naturalis Brasiliae) con informazioni sulla fauna e la flora attinte dalla sezione di Marcgraf. Ma da questa accusa il nostro è già stato assolto da Cuvier, che pure era un grande ammiratore di Marcgraf: "Alcuni autori, che non hanno letto entrambe le edizioni di Piso, lo hanno considerato un plagiario di Marcgraf, ma non è così perché nella prefazione e ovunque nel libro lo loda come proprio ex collega e lo cita in modo tale che è impossibile dire che abbia cercato di presentare come propria la sua opera". In effetti, Piso non ha copiato il testo di Marcgraf, ma ne ha attinto informazioni e le ha sintetizzate e riorganizzante in base al proprio disegno, che non è più una storia naturale del Brasile, ma una storia medica delle Indie occidentali. I quattro libri di "De medicina brasiliensi" (circa 120 pagine) si trasformano nei cinque di "Historia naturalis et medica Indiae occidentalis" (circa 330 pagine), in cui Piso, pur basandosi principalmente sulla propria esperienza diretta, cerca di allargare il campo di indagine dal Brasile all'intera America tropicale, facendo riferimento alla letteratura disponibile. Il primo libro continua ad intitolarsi "Sull'aria, sull'acqua, sui luoghi", ma passa da 14 a 22 pagine; il secondo libro non esamina più le malattie sia endemiche sia introdotte del Brasile, ma "La natura e la cura delle malattie comuni nelle Indie occidentali, e in particolare in Brasile" e, con l'eliminazione dei morbi importati, si riduce da 39 a 18 capitoli; il terzo libro sui veleni e gli antidoti viene spostato alla fine (diventa il quinto libro) e sostituito dall'amplissimo libro in tre sezioni "Sugli animali americani acquatici, aerei e terrestri commestibili"; il quarto libro, da analisi dei semplici e delle loro virtù, si trasforma in "Sugli alberi, gli arbusti e le erbe medicinali e alimentari che nascono in Brasile e nelle terre circostanti delle Indie occidentali". L'unico libro totalmente nuovo è dunque il terzo, quello sugli animali, per il quale Piso ha usato come fonte principale i libri 4-6 di Historia rerum naturalium Brasiliae di Marcgraf. Anche qui, nessun plagio: come fa notare Cuvier, Piso "ha organizzato [i materiali] in modo diverso; tutte le informazioni su piante e animali fornite da Marcgraf non vengono organizzate in base a classi come ha fatto Marcgraf, ma sulla base di considerazioni mediche: in una sezione, i prodotti eduli; in una seconda, quelli velenosi; in una terza le sostanze medicinali". Inoltre, ci sono anche un certo numero di animali non presenti nei libri di Marcgraf, segno che, anche se la zoologia non faceva parte dei suoi interessi principali, non gli era totalmente estranea. Veniamo ora all'accusa di Linneo, quello di aver alterato i materiali di Marcgraf con aggiunte arbitrarie commettendo molti errori. E qui c'è del vero: Marcgraf era un naturalista più completo e accurato di Piso che, non dimentichiamolo, era essenzialmente un medico ed ha dato i suoi maggiori contributi nel campo suo proprio, quello della medicina (e dell'igiene) tropicale. Indubbiamente commise errori e confusioni, ma il peggiore non è imputabile a lui e non riguarda la sezione sulle Indie occidentali, ma quella sulle Indie orientali. In quest'ultima, mentre sono eccellenti le figure dei mammiferi, quelle dei pesci e dei rettili sono riprese dal libro sulla fauna brasiliana; la colpa non è di Piso, ma dell'editore, che voleva risparmiarsi la spesa di un secondo set di xilografie, pensando erroneamente che, in fondo, pesci e rettili sono più o meno uguali dappertutto. Ma il libro di Bontius, e Bontius stesso, meritano un post tutto per loro.  L'albero che uccide gli uccelli Nel suo libro Matters of Exchange, H. J. Cook ricorda che per la sua disinvolta abitudine di aggiungere materiali presi da autori diversi senza citarli in modo trasparente, molti contemporanei consideravano Piso uno scrittore poco affidabile, quindi aggiunge: "Ancora decenni dopo, Linneo venne coinvolto, chiamando Pisonia, da Piso, un genere di piante molto spinose e sottolineando quando lo fece che le loro spine erano sgradevoli quanto la reputazione di Piso". Cook si riferisce a Critica botanica (1737) in cui Linneo scrive: "Pisonia è un albero orrendo (= horridus) per le sue spine; e orrenda è certamente anche la memoria dell'uomo [da cui prende nome] se è vera l'accusa mossa a Piso da un parente di Marcgraf di essersi appropriato degli scritti di Marcgraf dopo la sua morte". Poi aggiunge, più cautamente, rivolgendosi al lettore: "Vedi e confronta tu stesso le obiezioni, confronta poi gli scritti di Marcgraf con quelli di Piso". È esattamente quello che hanno fatto Cuvier e dopo di lui altri studiosi, assolvendo pienamente Piso dall'accusa di plagio. È bene tuttavia precisare che il significato primario di horridus è "spinoso", e applicandola alla memoria del povero Piso Linneo fa un gioco di parole, usandolo nel significato traslato "sgradevole, odioso, orribile" Certo non aveva in mente niente di simile il primo creatore del genere Pisonia, il buon padre Plumier che anzi si espresse in termini pacatamente oggettivi nei confronti del medico olandese: "Gulielmus Piso di Leida percorse il Brasile con i suoi assistenti, gli studenti di medicina tedeschi Georg Marcgraf e H. Cralitz; quindi scrisse e completò quattro libri sulla medicina del Brasile, il quarto dei quali tratta delle proprietà dei semplici brasiliani [...]. È un'opera veramente utile per gli americani e degna dell'interesse dei curiosi". E subito dopo rese omaggio anche a Marcgraf con il genere Marcgravia. Linneo elenca e descrive solo due specie, la spinosissima Pisonia aculeata, che si credeva originaria delle Indie occidentali, e l'inerme Pisonia mitis originaria delle Indie orientali. Oggi sappiamo che la seconda è solo una forma senza spine della prima, una specie pantropicale diffusa in America, in Africa, in Asia e in Oceania. Via via si sono aggiunte altre specie e il genere (famiglia Nyctaginaceae) è giunto ad annoverarne una quarantina, con distribuzione prevalentemente americana, ma con rappresentanti anche in Africa, nel Sud est asiatico e nel Pacifico. Studi recenti hanno però dimostrato che il genere così inteso è polifiletico; di conseguenza ne sono state staccate una ventina di specie indo-pacifiche (genere Ceodes), una specie endemica delle Hawaii (genere Rockia)ù mentre varie specie brasiliane sono state spostate in Guapira. Pisonia in senso stretto comprende ora 27 specie, quasi tutte americane, con centro di diversità nelle Antille; fanno eccezione la pantropicale P. aculeata, P. grandis, distribuita tra Africa, Oceano indiano e Oceano Pacifico, e P. costata, endemica di Mauritius. La maggior parte delle specie ha limitata diffusione ed è strettamente endemica; ad esempio, troviamo tre specie endemiche a Cuba, tre a Portorico, due in Giamaica, una nelle Galapagos, una in Belize, ecc. Sono per lo più arbusti o piccoli alberi; P. aculeata (oltre ad essere quasi l'unica specie spinosa) può essere sia un piccolo albero sia una liana legnosa; P. grandis è un grande albero che può superare i 30 metri. Hanno foglie opposte, alternate o in verticilli terminali, piccoli fiori privi di petali raccolti in cime composte con fiori maschili e femminili su individui diversi. Ma la caratteristica più particolare è data dai frutti o meglio falsi frutti (antocarpi); da oblunghi a clavati, presentano cinque costole arrotondate o angolate con una o più file di ghiandole; estrememente appicicosi, tendono ad aderire alle penne degli uccelli, favorendo la dispersione dei semi. Talvolta però lo fanno in modo troppo efficace: se troppi frutti rimangono appiccicati, gli uccelli malcapitati, soprattutto quelli delle specie più piccole, ne possono essere appesantiti al punto da non riuscire più a volare; così intrappolati, finiscono per essere preda di ratti o altri predatori o per morire di inedia. Questo fenomeno è stato segnalato per P. grandis e per altre specie ora passate al genere Ceodes (in particolare C. umbellifera e C. brunoniana), conosciute in inglese con il nome volgare birdcatcher "uccellatore", che vivono prevalentemente o esclusivamente in isole della regione indo-pacifica che ospitano grandi colonie di uccelli marini. Gli effetti possono essere devastanti: uno studio condotto nella isola di Cousin nelle Seychelles ha dimostrato che Pisonia grandis ha causato la morte di un quarto delle sterne bianche e quasi un decimo delle berte tropicali. Anche se su scala infinitamente minore, l'intrappolamento occasionale di uccelli è stato segnalato anche per P. zapallo, una specie dell'Argentina settentrionale. Il fenomeno rimane enigmatico: per specie che vivono in piccole isole la dispersione dei semi garantita dagli uccelli è certo vantaggiosa, mentre per l'intrappolamento e la morte degli uccelli non è stato dimostrato alcun vantaggio. Esperimenti condotti alle Seychelles hanno dimostrato che è infondata l'ipotesi che la decomposizione degli uccelli morti alla base degli alberi apporti nutrimento aggiuntivo. D'altra parte, sarebbe scorretto demonizzare P. grandis: studi condotti in Australia, dove nella Grande barriera corallina le foreste dense di Pisonia sono sempre più ridotte, hanno dimostrato che la loro perdita incide negativamente sulla sopravvivenza degli uccelli marini che un tempo vi nidificavano in gran numero, Nel 1911 un secondo genere è venuto a onorare, sebbene indirettamente, Willem Piso. È il monotipico Pisoniella, creato da Standley per Pisoniella arborescens, un arbusto con distribuzione disgiunta in Messico e in Bolivia. Precedentemente faceva parte del genere Boerhavia, tuttavia Standley osservò che il suo frutto è simile a quello di Pisonia, ma la pianta ne differisce per l'aspetto generale e l'infiorescenza, un'umbella semplice anziché una cima composta. Per un periodo brevissimo, dal 1630 al 1654, gli olandesi controllarono la costa nord orientale dell'attuale Brasile, ponendo la loro capitale dove oggi si trova Recife. Ad attirarli era la ricchezza promessa dalle piantagioni di canna da zucchero, ma grazie al governatore Johan Maurits di Nassau Siegen, che aveva portato con sè un'équipe di artisti e scienziati, diedero vita a un'avvincente avventura scientifica, con la creazione del primo osservatorio astronomico, del primo orto botanico e del primo zoo del Sudamerica e la prima esplorazione organizzata della fauna e della flora brasiliane. Protagonista ne fu il poliedrico naturalista tedesco Georg Marcgraf, autore insieme al rivale Willem Piso di Historia naturalis Brasiliae, una pietra miliare dell'etnografia, della botanica e della zoologia, rimasta un testo di riferimento per circa duecento anni. Lo ricordano il genere Marcgravia e, indirettamente, Marcgraviastrum.  Un po' di storia: il Brasile olandese Fu lo zucchero ad accendere l'interesse olandese per il Brasile. Fin dal Quattrocento, quando i portoghesi avevano introdotto la coltivazione della canna da zucchero a Madera e nelle Azzorre, i fiamminghi aveva giocato un ruolo importante come finanziatori e mediatori con il mercato europeo, che era continuato e si era intensificato quando, a partire dal 1530, la coltivazione era stata estesa al Brasile. Anversa si era sostituita a Venezia come maggiore centro mondiale di raffinazione dello zucchero, primato che avrebbe mantenuto fino all'assedio del 1579. In seguito a quell'evento traumatico, persone e capitali si trasferirono a nord, nella Repubblica delle Province unite, e Amsterdam ereditò da Anversa il ruolo di capitale della raffinazione della zucchero. A fare da sfondo, la "guerra degli Ottant'anni", come nei Paesi Bassi è chiamata la rivolta contro la Spagna. Per piegare la resistenza delle province ribelli, nel 1579 Filippo ll chiuse i porti della Spagna e delle sue colonie ai mercanti dei Paesi Bassi; l'anno successivo il Portogallo passò sotto la corona spagnola e i porti brasiliani furono automaticamente preclusi alle navi olandesi. Una parziale mitigazione si ebbe nel 1594, quando il commercio con il Brasile fu concesso una volta all'anno a una singola flotta olandese di non più di venti navi. La "Tregua dei dodici anni", firmata da Spagna e Repubblica delle Province unite nel 1609, permise nuovamente il libero accesso delle navi olandesi ai porti del Brasile; in cambio, gli olandesi si impegnarono a non commerciare con le altre colonie spsgnole e a sospendere la creazione di una Compagnia delle Indie occidentali, analoga alla Compagnia delle Indie Orientali. Allo scadere della tregua, i traffici olandesi si erano enormemente accresciuti; ora le navi olandesi controllavano oltre metà degli scambi tra Brasile ed Europa, e le raffinereie di zucchero dei Paesi Bassi erano passate da tre a 29. Nell'estate del 1621, appena spirata la tregua, fu creata la Compagnia olandese delle Indie occidentali (WIC), che ottenne dagli Stati generali il monopolio dei traffici nell'Atlantico. Nel 1623 la WIC varò il Groot Dessein (grande disegno), che prevedeva di impadronirsi da una parte della capitale del Brasile portoghese, San Salvador de Bahia, e dall'altra del principale forte portoghese in Angola, Luanda. In tal modo, la WIC avrebbe controllato sia le piantagioni brasiliane, sia il traffico degli schiavi neri, e tagliato fortemente le risorse economiche della monarchia spagnola. Nel maggio 1624 una spedizione olandese riuscì effettivamente ad impadronirsi di Salvador, ma poco meno di un anno dopo una flotta di soccorso riconquistò la città. Anche l'attacco a Luanda fallì. Tuttavia, nel 1628 il vice ammiraglio della WIC Piet Hein riuscì a catturare nella baia di Matanzas la flotta spagnola del tesoro, portando l'intero carico con sè in Olanda. Ciò diede alla WIC i capitali per un secondo tentativo in Brasile. Tra l'estate del 1629 e il febbraio 1630, gli olandesi riuscirono a conquistare Olinda e Recife (la capitale del Pernambuco); entro il 1634 controllavano la costa del nordest brasiliano dal Rio Grande do Norte al Cabo de Santo Agostinho. Era così nato il Brasile olandese, anche conosciuto come Nuova Olanda (Nieuw Holland). Il dominio olandese ebbe vita breve - poco più di vent'anni, fino al 1654 - ma fu ricco di conseguenze anche per la storia della scienza. Inizialmente la nuova colonia fu amministrata da commissari della WIC, finché nel 1634 venne nominato governatore il conte Johan Maurits di Nassau-Siegen (1604-1679); nipote di un fratello di Guglielmo il Taciturno, era cugino dello stadtholder Federico Enrico di Nassau-Orange e fin da giovanissimo aveva militato nell'esercito della Repubblica delle Province unite, dimostrando notevoli qualità militari. Le confermò nel nuovo incarico, sconfiggendo più volte le forze ispano-portoghesi; nel 1637 inviò in Africa una spedizione che riuscì a impadronirsi dell'importante base commerciale di Elmina (gli olandesi l'avrebbero controllata fino al 1872); fallirono invece due tentativi di prendere Salvador. Oltre che un eccellente uomo d'armi, Johan Maurits era un umanista appassionato di scienze ed arti, un politico lungimirante e un ottimo amministratore; fece costruire infrastrutture come strade e ponti, incoraggiò l'immigrazione di coloni olandesi ma allo stesso tempo cercò la collaborazione dei proprietari portoghesi creando consigli municipali cui portoghesi e olandesi partecipavano fianco a fianco. Nel 1638, sull'isola di Antônio Vaz, posta di fronte a Recife, fondò la città di Mauritsstad, che divenne la capitale del Brasile olandese, affidandone la progettazione all'architetto Pieter Post. La residenza del governatore era la sontuosa Vrijburgh (Huis Vrijburgh), nota anche come palazzo delle torri per le due alte torri che ne ornavano la facciata; una era usata come faro, mentre l'altra ospitava un osservatorio astronomico, il primo dell'emisfero sud. Le sale erano ornate di dipinti, tappezzerie, arredi raffinati e collezioni di oggetti artistici e naturali. Il palazzo era circondato da giardini con parterre formali, un'ampia peschiera, un'arboreto dove furono trapiantate 200 piante di palma da cocco e altri alberi da frutto - tanto portati dall'Europa come melograni, limoni, aranci, quanto tropicali. Per la flora e la fauna brasiliane c'era un orto botanico e uno zoo, anch'essi i primi del genere nelle Americhe. Molti degli animali che ne popolavano le gabbie e le voliere era doni di locali che desideravano in tal modo ingraziarsi il governatore, ma erano anche il frutto delle vere e proprie spedizioni scientifiche da lui promosse.  Un'opera a quattro mani - anzi sei Egli infatti aveva portato con sè una piccola équipe di pittori e scienziati che mise al lavoro per esplorare e documentare le ricchezze naturali della nuova colonia. Tra i primi, troviamo Frans Post, che si specializzò in paesaggi e scene esotiche e Albert Eckhout, che dipinse scene del Nuovo mondo, ritratti di indigeni e nature morte e presumibilmente gran parte degli oli di animali e piante poi donati al Grande elettore di Brandeburgo e inclusi in Theatrum rerum naturae Brasiliae; tra i secondi il suo medico personale e chirurgo dell'esercito Willem Piso (1611-1668), il geografo e astronomo Georg Marcgraf (1610-1644) e lo studente di medicina e matematica Heinrich Cralitz che sfortunatamente morì di febbri tropicali entro un anno dal suo arrivo. Piso e Marcgraf parteciparono a diverse spedizioni nell'interno, che avevano allo stesso tempo scopi militari, economici e scientifici. Come medico, Piso era soprattutto interessato alle malattie tropicali e alle piante medicinali, la cui conoscenza era essenziale per mantenere in salute il personale della compagnia e i coloni, mentre il compito principale di Marcgraf, come astronomo e cartografo, era disegnare una mappa della colonia il più completa possibile. Oltre ad essere un eccellente disegnatore, era tuttavia uno scienziato a tutto campo, i cui interessi spaziavano dall'astronomia alla meteorologia, dalla zoologia e alla botanica e all'etnografia. Anche se scindere l'opera dei due che, come vedremo, furono coatori di Historia naturalis Brasiliae, è problematico, in questo primo post vorrei concentrarmi su Marcgraf, per poi ritornare su Piso in un secondo post. Georg Marcgraf (ma il cognome viene scritto anche Markgraff, Marggraf, in olandese Marggrafe, in inglese e francese Marcgrave e in latino Marcgravius) era tedesco, essendo nato a Liebstadt nei pressi di Meissen; iniziò gli studi all'università di Wittenberg, ma in seguito alla Guerra dei Trent'anni dovette spostarsi in vari atenei, tra cui Strasburgo e Basilea. Tornato a Wittenberg, nel 1634 ottenne il grado di "candidato in medicina" con una disputa alchemico-medica; si spostò prima a Rostock, dove seguì le lezioni di botanica di Simon Paulli, poi a Stettino, dove collaborò alla compilazione delle tavole astronomiche di Lorenz Eichstaedt. Nel 1636 decise di iscriversi alla facoltà di medicina di Leida, dove avrebbe avuto la possibilità di dedicarsi contemporaneamente alla botanica e all'astronomia (tra il 1633 e il 1634 vi era stato infatti allestito un osservatorio astronomico all'avanguardia). Allievo di Golius per l'astronomia e di Vortius per botanica, vi trascorreva le sere in osservazioni, mentre le giornate erano dedicate principalmente all'orto botanico e alle raccolte sul campo. Nel novembre 1637, dietro raccomandazione di Jan de Laet, uno dei dirigenti della WIC, fu assunto come assistente di Piso, probabilmente in seguito alla morte di Cralitz, e raggiunse Recife all'inizio del 1638. Forse fu lui a convincere Johann Maurits a trasformare in osservatorio una delle torri del Vrijburgh; qui Marcgraf, con il progetto di mappare il cielo australe, fece osservazioni astronomiche e meteorologiche fino al giugno 1643, quando il governatore, che ora lo aveva assunto al proprio servizio, gli affidò il compito di mappare il Brasile olandese. Marcgraf aveva già disegnato una mappa della città e delle sue fortificazioni, e ora mappò la regione dal Rio Saô Francisco al Cearà e al Maranhão. Durante le sue esplorazioni, raccolse esemplari di piante e animali per l'orto botanico e lo zoo del Vrijburgh, creò un erbario e scrisse osservazioni naturalistiche integrate con schizzi ed acquarelli. La precisione e l'accuratezza delle sue descrizioni botaniche e zoologiche saranno lodate da Cuvier, come l'estremo discernimento da lui mostrato nell'assegnare le specie da lui scoperte (in gran parte ignote alla scienza) al genere corretto. All'epoca, i naturalisti non usavano ancora il microscopio, e non si può attendere il successivo livello di accuratezza per particolari minuti come "gli stami e i pistilli dei fiori [...] ma tutto ciò che ha a che fare con le dimensioni, la forma, il colore e, ancor più particolarmente, agli usi domestici e medicinali, è annotato con grande accuratezza e cura". Marcgraf era dunque un eccellente osservatore, inoltre, come ricorda ancora Cuvier, gli era familiare la letteratura zoologica precedente, come dimostrano i riferimenti alle opere di Belon, Aldrovandi, Salviani, Rondolet e Gessner. Nel 1644 il conte lo inviò a Luanda, che nel 1641 era stata conquistata dagli olandesi. Poco dopo l'arrivo in Africa, il naturalista morì di qualche malattia tropicale. Prima di partire, aveva però affidato due ceste con i materiali raccolti in Brasile a Johann Maurits che nel 1644, quando fu richiamato, portò con sè in Olanda. La situazione politica era infatti profondamente mutata. Nel 1640 il Portogallo aveva recuperato l'indipendenza, mettendo fine alle minacce di intervento spagnolo contro il Brasile olandese. Con la cessazione delle ostilità, ai vertici della WIC le spese militari apparivano eccessive, e le iniziative del conte fin troppo indipendenti; pesò anche il fallimento del tentativo di impadronirsi di Valdivia in Cile (1643). Che la scelta di allontanare Nassau-Siegen, di abbandonare la sua politca di conciliazione e di sguarnire le difese fosse frettolosa lo dimostra il fatto che appena un anno dopo la sua partenza scoppiò una rivolta generale dei piantatori portoghesi, innescando il conflitto con il Portogallo che nell'arco di pochi anni avrebbe portato alla perdita della colonia. Il conte di Nassau-Siegen si stabilì all'Aja dove, mentre ancora si trovava in Brasile, aveva fatto costruire una splendida dimora nota come Mauritshuis, oggi uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi; all'epoca, però, dato che a finanziarne la costruzione erano stati i proventi del commercio dello zucchero, era chiamata con disprezzo anche "Casa dello zucchero". Johann Maurits vi espose gli oggetti etnografici, gli animali impagliati, i dipinti che aveva fatto eseguire in Brasile. Ma utilizzò anche le sue preziose collezioni come doni diplomatici per garantirsi un futuro politico in Europa. Così, una serie di pezzi scelti finirono nelle "camere delle meraviglie" del re di Danimarca (che ricevette, oltre a oggetti etnografici, 26 splendidi quadri di Eckhout, e si sdebitò decorando Nassau-Siegen con l'Ordine dell'elefante), del re Sole e del Grande elettore, un amico di lunga data che ricompensò il munifico dono di quello che sarebbe diventato il Theatrum rerum naturae Brasiliae (ne ho parlato qui) con il governatorato di Mark e Cleves e probabilmente intercedette presso l'imperatore per fargli ottenere il titolo di principe dell'impero (concesso nel 1653). Johann Maurits non dimenticava però la scienza; donò molti esemplari tassodermici al teatro anatomico dell'Università di Leida e promosse la pubblicazione degli scritti brasiliani di Piso e Marcgraf. Mentre il primo, che era tornato in Olanda insieme al principe, poteva occuparsi di persona dell'edizione della propria opera, non così il secondo che, come abbiamo visto, era morto in Angola. Il suo lascito era complesso e non immediatemente fruibile. I documenti cartografici furono affidati a Joan Bleau, dal 1638 cartografo ufficiale della VOC, che ne trasse quattro splendide mappe pubblicate per la prima volta nel 1647 in Rerum in Brasilia et alibi gestarum del poligrafo Caspar Barlaeus, un libro sul Brasile olandese e sull'amministrazione del conte di Nassau Siegen commissionatogli dallo stesso. Le osservazioni astronomiche furono consegnate al matematico, astronomo e orientalista dell'Università di Leida Jacobus Golius (come abbiamo visto, maestro di Marcgraf) che tuttavia morì senza pubblicarle. Rimanevano i testi e i disegni di zoologia, botanica e meteorologia; era un materiale ricchissimo, ma disorganizzato, un insieme caotico di note, e soprattutto era scritto in codice. Si ritiene che Marcgraf avesse fatto ricorso a un codice segreto per evitare plagi da parte di Piso, con il quale non correva buon sangue. Ad assumersi il compito di decodificare e preparare per la stampa il manoscritto di Marcgraf fu Johannes de Laet (1581-1649) che, oltre ad essere uno dei soci fondatori della WIC, era anche un bibliofilo, un collezionista, un geografo, un cartografo e un esperto di cose americane, avendo pubblicato nel 1625 Nieuwe Wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien (Storia del Nuovo mondo o descrizione delle Indie occidentali). De Laet, oltre a decifrare il manoscritto, riorganizzò il testo, lo integrò con le proprie note e un'appendice, curò la scelta e l'inserimento delle immagini, allestendo o facendo allestire quelle mancanti; insomma fu il vero e proprio editor di Historia naturalis Brasiliae, che nel 1648 fu pubblicata in edizione congiunta ad Amsterdam e Leida da Hackius e Elzevir. Si tratta di un robusto in folio, alto ben 40 cm, aperto da un sontuoso frontespizio: sullo sfondo di una foresta lussureggiante e ricca di animali, quasi a presidiarne l'accesso a mo' di guardiani, si stagliano un nativo e una nativa; ai loro piedi un vecchio, sdraiato su una conchiglia, offre un vaso da cui fuoriescono pesci e altri animali marini, presumibilmente un'allegoria del fiume Capibaribe. Seguono una dedica allo statolder Guglielmo II, scritta da Piso, e la prefazione Benevolo lectori, scritta da de Laet. Il testo vero e proprio è suddiviso in 14 libri. I primi quattro, intitolati De medicina brasiliensi, si devono a Piso; occupano circa un quarto del volume (132 fogli) e sono illustrati da 104 xilografie; la maggior parte si concentrano nel Libro IV e ritraggono 92 piante; le altre si trovano nel libro III: tre illustrano la preparazione della manioca e dello zucchero, 9 sono di animali velenosi. Dopo aver illustrato nel primo libro le condizioni generali ("l'aria, l'acqua, i luoghi"), nel secondo Piso passa in rassegna le malattie proprie del Brasile (tra di esse la framboesia - per la prima volta distinta dalla sifilide) o importate; il terzo libro, dedicato ai veleni e agli antidoti, presenta tra l'altro la prima descrizione e la prima raffigurazioni di serpenti come la boicininga (presumibilmente Crotalus durissimus) o l'ibiboboca (Macrurus ibiboboca). Propriamente botanico è il quarto libro, in cui Piso esamina 104 semplici e le loro proprietà; accanto alle piante medicinali, come l'ipecucuana Carapichea ipecacuanha, le cui proprietà emetiche sono illustrate per la prima volta, ci sono anche piante alimentari come l'anacardio Anacardium occidentale, il falso pepe Schinus terebinthifolia, la noce del paradiso Lecythis zabucajo. La seconda sezione del volume è costituita dagli otto libri di Marcgraf (Historiae rerum naturalium Brasiliae libri octo), occupa 303 pagine ed è illustrata da 429 xilografie; i primi tre libri trattano le piante, divise in erbe, piante da frutto e arbusti, alberi, per un totale di 301 piante descritte e 200 raffigurate; il quarto i pesci; il quinto gli uccelli; il sesto i quadrupedi e i serpenti; il settimo gli insetti (gli animali trattati sono i totale 367, di cui 222 illustrati); l'ottavo e ultimo libro, di argomento etnografico, è una descrizione delle diverse regioni geografiche e dei loro abitanti. La quasi totalità delle specie descritte erano nuove per la scienza. Grazie soprattutto alla profondità e all'accuratezza del lavoro di Marcgraf, Historia naturalis Brasiliae divenne una pietra miliare, insuperata fino alle opere sulla fauna e la flora brasiliane di Spix e von Martius. Molto del fascino dei capitoli sugli animali si deve alle bellissime xilografie, quasi certamente di mano dello stesso Marcgraf; un certo numero di disegni botanici fu invece presumibilmente disegnato in Olanda. Preparando il volume, de Laet si rese infatti conto che diverse piante non erano illustrate; le disegnò o le fece disegnare sulla base di campioni d'erbario raccolti dallo stesso Marcgraf o inviati da altre persone residenti in Brasile. Aggiunse poi un certo numero di note, tratte per lo più dai Quatro libros de la naturaleza del monaco Francisco Ximenez che egli stesso aveva già citato nella sua Nieuwe Wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien, e un'appendice sui nativi del Cile, basata sulle relazioni della spedizione olandese a Valdivia. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1649, l'erbario di Marcgraf, che si trovava evidentemente a casa sua, fu acquistato dal danese Willum Worm, e inviato a suo padre Ole, professore di medicina dell'Università di Copenhagen e proprietario di una celebre wunderkammer (Museum Wormianum). Alla morte di Ole Wurm, le sue collezioni, incluso l'erbario di Marcgraf, furono vendute dalla famiglia al re Federico III e più tardi passarono al Museo botanico, dove esso è attualmente conservato. Consta di 173 fogli con 177 campioni; è di enorme importanza storica perché, oltre ad essere la fonte evidente di alcune delle tavole botaniche di Historia naturalis Brasiliae, è probabilmente il più antico erbario dell'America tropicale.  Come farsi notare dai pipistrelli Primo studio scientifico sull'etnografia, la medicina, la flora e la fauna di una regione del Sudamerica, Historia naturalis Brasiliae ebbe un'ampia circolazione ed esercitò una profonda influenza. A suscitare ammirazione, senza nulla togliere ai libri di Piso, che ebbero comunque un ruolo pionieristico nel campo della medicina tropicale, furono soprattutto i libri di Marcgraf sulla flora e sulla fauna. Tra i loro estimatori, Linneo, che li utilizzò come testo di riferimento e ne trasse molte denominazioni, e Aublet, che se ne servì per le sue ricerche in Guiana. È di Linneo (che però, come spesso capita, si rifà al precedente di Plumier) la dedica all'astronomo e naturalista tedesco del genere Marcgravia, che è anche il genere tipo e più numeroso della famiglia Marcgraviaceae; esclusiva dell'America tropicale, quest'ultima comprende sette generi e circa 130 specie, per la maggior parte liane o rampicanti. Marcgravia comprende una sessantina di specie, distribuite dal Messico meridionale al Brasile attraverso le Antille e l'America centrale; sono liane e rampicanti terrestri delle foreste tropicali umide, caretterizzate da diverse interessanti particolarità. La prima è l'accentuata eterofillia: le Margravia si arrampicano mediante radici avventizie che si abbarbicano alla corteccia dell'albero ospite, presenti solo nella fase giovanile, durante la quale la pianta ha steli piatti o quadrangolari e piccole foglie sessili alternate distiche; nella fase adulta troviamo lunghi rami eretti, privi di radici avventizie, e foglie completamente sviluppate, molto più grandi, picciolate e disposte a spirale. Alcune specie, dopo aver perso il contatto con il suolo, possono diventare epifite, ma tendono comunque a sviluppare lunghi rami ascendenti, all'apice delle quali si sviluppano le infiorescenze, spesso a decine di metri dal suolo, emergendo dalla canopia della foresta. Un'altra particolarità riguarda appunto le infiorescenze. Come tutte le Margraviaceae, quelle del genere Marcgravia posseggono bratteole modificate in nettari; pendule, sono poste all'apice dei rami e sono rette da un lunghissimo stelo; i fiori, che irradiano da un unico punto, sono disposti in un singolo giro a umbella piatta; quelli centrali sono sterili e dotati di bratteole modificate in nettari - dalla forma simile a quella dei fiori di Nepenthes - che pendono al di sotto dei fiori periferici fertili. In tal modo, gli impollinatori, attirati dal nettare, mentre si cibano si imbrattano il dorso di polline; si tratta di colibrì, opossum e per diverse specie di piccoli chirotteri. Tra le specie impollinate da pipistrelli troviamo la stupefacente M. evenia, una rara liana delle foreste cubane; oltre alle bratteole modificate in nettari, poste al di sotto, al sopra dell'infiorescenza si trovano diverse brattee simili a una foglia concava; i ricercatori hanno dimostrato che riflettono e rimandano gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli del genere Monophyllus aiutandoli a dirigersi velocemente verso i fiori che così vengono impollinati con maggiore frequenza. Varie specie di Marcgravia (tra le altre, M. umbellata, M. sintenisii, M. rectiflora) sono ricercate dai collezionisti come piante da terrario o da serra calda. Vengono coltivate soprattutto per il fogliame, sia in cestini appesi, sia come rampicanti su supporti in legno o sfagno, soprattutto in terrario, dato che richiedono umidità elevata e una temperatura calda e costante. Proprio per le particolarità delle foglie e delle infiorescenze differisce da Marcgravia il genere Marcgraviastrum, che ne è stato separato nel 1997. Distribuito dall'America centrale (Nicaragua e Honduras) al Brasile nelle foreste pluviali o nebulose, comprende una quindicina di specie di arbusti e liane epifite, semiepifite o terrestri; hanno foglie sessili o picciolate disposte a spirale e non differenziate in una fase giovanile e in una fase adulta e fiori raccolti in un'infiorescenza umbelliforme eretta anziché pendula; in alcune specie diventano invece pendule quando maturano i frutti. Inoltre, mentre i fiori di Marcgravia sono tetrameri, quelli di Marcgraviastrum sono pentameri e tutti sviluppano un nettario, non solo quelli centrali sterili. Tra le sue specie, vorrei segnalare almeno M. sodiroi, endemica della Colombia e dell'Ecuador, il cui epiteto ricorda il sacerdote italiano Luigi Sodiro (1836-1909), pioniere dello studio della flora dell'Ecuador. Nel 2022, in occasione dei 400 anni dalla nascita, la città natale e il Land Brandeburgo hanno dedicato un convegno internazionale e una serie di pubblicazioni a Christian Mentzel, medico personale del Grande Elettore Federico Guglielmo. Personaggio poliedrico, come medico ebbe un ruolo centrale nella creazione delle strutture sanitarie dello stato prussiano, come botanico fu autore di una flora locale di Danzica e di uno dei primi dizionari universali dei nomi delle piante, come chimico si occupò della pietra fosforica bolognese, come bibliotecario curò la redazione di alcune magnifiche opere illustrate; negli ultimi anni della sua vita fu in relazione con vari studiosi che vivevano o avevano vissuto in Asia e divenne uno dei padri fondatori dello studio della lingua e della civiltà cinesi. Plumier gli dedicò il genere Mentzelia, poi ufficializzato da Linneo. 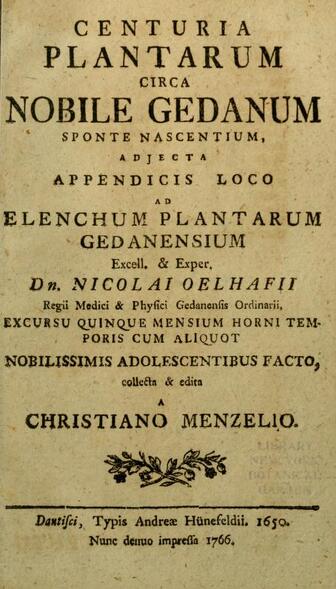 Una flora locale e un grande viaggio d'istruzione Il quattrocentesimo compleanno del medico, botanico e sinologo Christian Mentzel (1622-1701) è stato celebrato a Fürstenwalde, la sua città natale, con un simposio internazionale - culmine di una serie di iniziative in ricordo del poliedrico personaggio. La città sorge sul fiume Sprea, quasi a metà strada tra Berlino e Francoforte sull'Oder, e nel Seicento, grazie alla sua posizione sul fiume, era un importante nodo commerciale, rinomato anche come centro scolastico. Mentzel, che era figlio del sindaco, ricevette la prima eduicazione in casa poi nel 1630 fu ammesso al Ginnasio di Joachimsthal, una scuola d'élite da poco fondata e finanziata dall'elettore di Brandeburgo. Nel frattempo però era scoppiata la guerra dei Trent'anni; nel 1636 studenti e professori furono costretti a mettersi in salvo da un'incursione svedese durante la quale la scuola andò distrutta. Christian dovette interrompere gli studi e nel 1639 perse anche il padre, morto di peste. Si trasferì allora a Berlino per studiare al Köllnisches Gymnasium; studiò quindi medicina prima a Francoforte sull'Oder poi a Königsberg. Nel 1647 accompagnò l'ambasciatore del Brandeburgo a Varsavia e a Cracovia e nel 1648 fu assunto come lettore di anatomia e botanica presso il ginnasio accademico di Danzica. Si trovò così a collaborare ai progetti di riforma scolastica di Johann Raue (Ravius), ammiratore e seguace di Comenio, che davano maggiore spazio a uno studio non libresco della natura. Così le sue lezioni di botanica non si svolgevano solo in aula, ma anche nei prati, nei campi e nei boschi. Proprio come supporto didattico per i suoi studenti Mentzel scrisse il suo primo libro, Centuria plantarum circa nobile Gedanum ad elenchum plantarum gedanensis dom. Nicolai Oelhafii. L'esilissimo libretto (poco più di 20 pagine) elenca in ordine alfabetico 100 piante reperibili nell'area di Danzica; secondo quanto scrive l'autore, è il frutto di cinque mesi di escursioni: "Condussi per campi e foreste la più nobile adolescenza e quanto da ogni lato si offriva fiorente, lo sottoponevo ai loro occhi fedeli". Uno di quei nobili adolescenti era Jakob Breyne che proprio grazie a Mentzel si appassionò alle scienze naturali, Mentzel per lo più si rifà al precedente della prima flora di Danzica, anzi dell'intera area compresa tra Prussia e Polonia, Elenchus plantarum circa nobile Borussorum Dantiscum sua sponte nascentium (1643), del medico (e suo predecessore come insegnante di anatomia e botanica al ginnasio accademico) Nikolaus Oelhafen, estraendone solo le piante che ha effettivamente incontrato e presentandole in modo più sintetico, adatto a un "quaderno di campo" per adolescenti; elimina tra l'altro le indicazioni sugli usi medici. Ogni voce, brevissima, inizia con il nome latino per lo più ripreso dal Pinax di Caspar Bauhin, seguito dal nome tedesco e dai sinonimi in altri autori, dall'epoca di fioritura e dalla localizzazione (generica in latino, specifica in tedesco, ad esempio in littoris maris bei Zoppot). Nel 1650, forse poco dopo aver pubblicato il libro, Mentzel lasciò Danzica per un lungo viaggio di istruzione; imbarcatosi ad Amburgo, visitò l'Olanda, dove fu ad Amsterdam e Leida e forse strinse alcuni dei legami che gli sarebbero stati utili nella sua futura carriera; quindi continuò il suo viaggiò in nave, toccando le coste della Francia, del Portogallo e della Spagna. Proseguì nel Mediterraneo, toccando successivamente Maiorca, la Corsica, la Sardegna, le Isole Eolie, la Sicilia, Malta, Creta e Corfù, dalla quale raggiunse Venezia. Visitò Pisa, Firenze, Roma, Napoli, dove scalò il Vesuvio, quindi riprese gli studi di medicina a Bologna e a Padova, dove nel 1654 ottenne il dottorato in filosofia e medicina. Sulla via del ritorno, visitò ancora Verona, Vicenza, Trento, Innsbruck, Vienna, Augusta e Norimberga, dove incontrò il futuro presidente dell'Academia Naturae Curiosorum, Johann Georg Volkamer. Quindi si stabilì come medico prima a Fürstenwalde, poi a Berlino. Qui attirò l'attenzione del grande elettore Federico Guglielmo che lo nominò aiutante medico di corte e medico di campo. In questa veste partecipò alla campagna contro gli svedesi in Holstein; quindi accompagnò a Cleves e Königsberg l'elettore che nel 1660 lo promosse a proprio medico personale e membro del consiglio di corte. 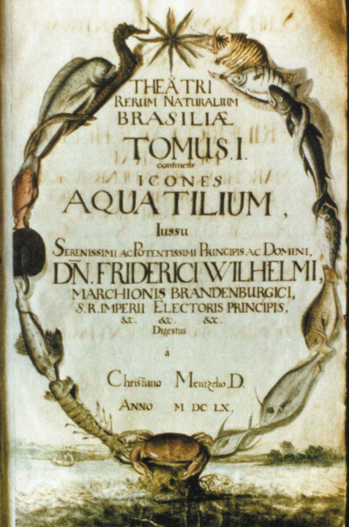 Bibliotecario e... editor Era un compito faticoso che spesso imponeva a Mentzel lunghi viaggi lontano da Berlino per accompagnare l'elettore nelle campagne militari e nelle visite diplomatiche o per assistere lui o i suoi famigliari in caso di malattia, come nel 1667, quando andò nei Paesi Bassi per recuperare la principessa Luise ammalata di tisi e riportarla in patria o nel 1674 quando non poté salvare dalla morte il giovanissimo principe Carl Emil, ammalatosi di febbri perniciose durante una campagna in Alsazia. Dal 1661 fu anche impegnato, con altri medici di corte tra cui Elsholtz, nella riforma del settore sanitario che sarebbe sfociata nell'editto medico del 1685. Per molti anni a causa di questi impegni pressanti e dei continui spostamenti non poté scrivere né soddisfare la sua passione per la botanica, anche se sappiamo che continuò ad osservare la flora e a probabilmente tenne un diario di campo dei propri ritrovamenti. L'elettore gli aveva affidato anche la sua biblioteca e intorno al 1660 gli chiese di occuparsi di una collezione di immagini di animali, piante e persone del Brasile olandese che gli era stata donata da Johan Maurits di Nassau Siegen in cambio della nomina a governatore di Mark e Cleves. Si trattava di due libri rilegati con immagini ad acquarello, noti come Libri principis, e di alcune centinaia di fogli sciolti, dipinti sia ad acquarello sia ad olio, questi ultimi presumibilmente opera di Albert Eckhout, oltre a diversi disegni e schizzi. Su richiesta dell'elettore, Mentzel riorganizzò gli oli in quattro volumi in folio con animali e piante; ciascuno è aperto da un frontespizio, con il titolo manoscritto Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae e un sottotitolo specifico, racchiusi in una cornice miniata formata da animali; Mentzel figura come autore. Come dimostrano i numerosi fogli bianchi intercalati ai dipinti, egli progettò una rassegna completa della fauna e della flora del Brasile olandese (o Nuova Olanda); infatti anche i fogli bianchi sono numerati, hanno un titolo vernacolare brasiliano e spesso un rimando alle due principali opere scaturite dalla breve occupazione olandese del Nord est brasiliano: Historia Naturalis Brasiliae di Willem Piso e Georg Marcgraf e De Indiae utriusque re naturali et medica di Piso. Chiaramente, Mentzel aveva intenzioni di completare l'opera con ulteriori immagini, in gran parte copiate da queste opere. ma ciò non si realizzò mai, vuoi per i troppi impegni, vuoi per il costo insostenibile, vuoi per insormontabili problemi tecnici. Le immagini sono organizzate secondo un ordine che si vuole "naturale". Nel primo volume troviamo i pesci perché furono i primi ad apparire; nel secondo gli uccelli perché "proprio come i pesci tagliano l'acqua con le pinne, gli uccelli tagliano l'aria con le ali [...] e le somiglianze e le relazioni tra loro indicano chiaramente che Dio onnipotente li ha creati lo stesso giorno"; nel terzo gli indiani e altri abitanti del Brasile olandese perché "l'uomo è il padrone di tutta la creazione e deve essere il primo", seguiti da scimmie, gatti, conigli, volpi, per concludere con insetti e anfibi, la cui natura è considerata intermedia tra animali e piante. Queste ultime occupano il quarto volume, ma Mentzel non diede loro un particolare ordine, anzi sottolineò che ordinarle e classificarle era impossibile. I fogli di piante sono 106, intercalati con 206 fogli bianchi, ma titolati con nomi vernacolari brasiliani e con rimandi alle opere di Piso e Marcgraf; gli studiosi hanno identificato 162 piante vascolari e il fungo Copelandia cyanescens, cui se ne aggiungono altre 196 per i fogli intercalati. Nella maggior parte dei casi, si tratta di piante native del Brasile, ma ci sono anche una trentina di specie introdotte. Le date dei frontespizi dei quattro volumi ci dicono che Mentzel lavorò al Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae tra il 1660 e il 1664, poi abbandonò il progetto e i volumi vennero riposti così come si trovavano nella biblioteca dell'elettore. Del resto era iniziato un nuovo ciclo di guerre, conclusosi solo nel 1679 con la pace di Saint Germain. Ora Mentezel non doveva più trascorrere lunghi periodi lontano da Berlino e poteva tornare a studiare e a scrivere. Nel 1675, mentre la seconda moglie dell,'elettore era in travaglio, approfittò dell'attesa per scrivere un saggio sulla cosiddetta pietra di Bologna, ovvero una pietra fosforescente di barite che nel Seicento attirò l'attenzione di molti studiosi, tra cui Fortunio Liceti, che era stato suo professore a Padova. Con questo saggio Mentzel iniziò una regolare collaborazione con l'accademia Leopoldina, cui fu ammesso quello stesso anno. 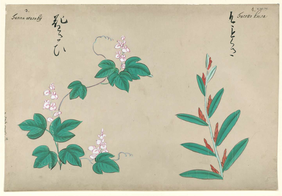 Un lessico botanico e molte opere "cinesi" Tornò anche a occuparsi di piante, con un'opera singolare che fonde l'interesse per la botanica con quella per le lingue: un dizionario universale dei nomi delle piante. Proprio come la piccola flora di Danzica che aveva scritto da giovane, anche quest'opera della vecchiaia nacque da un intento didattico. Mentzel aveva tre figli maschi, ma, come scrisse - metà rassegnato metà sconsolato - all'amico Volkamer, nessuno dei tre aveva voglia di studiare. Infine però Johann Christian si convinse a seguire le orme paterne e a studiare medicina. Per avviarlo alla botanica, che continuava a considerare una competenza di base indispensabile per ogni medico, il padre gli assegnò il compito di leggere tutti i testi di botanica che gli capitassero sotto mano e compilare una lista alfabetica di tutti in nomi delle piante via via citate, in tutte le lingue. Da esercizio scolastico, l'idea si trasformò in un progetto editoriale cui padre e figlio lavorarono insieme a quattro mani; nel 1682 fu pubblicato sotto il titolo Pinax Botanōnymos Polyglōttos Katholikos o Index Nominum Plantarum Universalis. Come ci informa il chilometrico frontespizio, contiene i nomi delle piante in dozzine di lingue e dialetti, a iniziare dal latino e dal greco, per proseguire con le principali lingue europee, ma anche con idiomi più esotici dei quattri continenti: ebraico, caldeo, arabo, siriano, turco, tataro, malabarico, bramino e cinese per l'Asia, egizio, etiopico, mauritano, malgascio ecc. per l'Africa, brasiliano, virginico e messicano per le Americhe. In appendice, Mentzel volle aggiungere una breve selezione di piante rare (Pugillus rariorum plantarum), tanto appartenenti alle collezioni dall'ex allievo Jacob Breyne quanto incontrate nei suoi viaggi, illustrate da tavole calcografiche di buona qualità; aggiunse infine un indice delle piante del manoscritto brasiliano. L'opera era la prima nel suo genere e conobbe un certo successo, venendo ristampata nel 1696. Dal 1685 con la promulgazione dell'editto medico, come medico personale dell'elettore Mentzel entrò a fare parte di diritto del Collegium medicum. Più o meno nello stesso periodo l'elettore gli affidò la cura della sua biblioteca di libri cinesi. In quegli anni, in Europa l'interesse per la Cina, che incominciava ad essere conosciuta soprattutto grazie ai missionari gesuiti, era vivissimo. Molto vi aveva contribuito la recente pubblicazione di China illustrata di padre Athanasius Kircher (1667) che, con l'incoraggiamento dell'elettore, aveva spinto l'orientalista prussiano Andreas Müller a intraprendere lo studio del cinese e la stesura di una serie di opere, tra cui una Clavis sinica che avrebbe dovuto facilitare l'apprendimento degli ideogrammi e della lingua cinese. Federico Guglielmo incaricò Müller di catalogare i manoscritti orientali della biblioteca elettorale ma fu deluso dalla mancata consegna della Clavis sinica che aveva finanzaito e l'orientalista prometteva da diversi anni; nel 1685, quando Müller lasciò Berlino, l'elettore passò l'incarico a Mentzel. Quest'ultimo all'epoca era già sulla sessantina e non aveva alcuna conoscenza del cinese, ma ne affrontò lo studio con energia e entusiasmo. Inoltre, attraverso l'Accademia curiosorum leopoldina, era già in contatto con alcuni membri della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC) da cui poté per ottenere informazioni di prima mano, manoscritti e altri materiali, che andarono ad arricchure la biblioteca elettorale. I suoi corrispondenti più importanti furono Georg Eberhardt Rumpf (Rumphius) e Andreas Cleyer. Con il primo, naturalista al servizio della VOC nella remota Ambon nelle Molucche e come lui membro della Leopoldina, cominciò a corrispondere nel 1682 e scambiò numerose lettere, che poi pubblicò in forma di brevi articoli o notizie tra il 1682 e il 1698 nella Miscellanea curiosa sive Ephemerides dell'Accademia. Ancora più fruttuosa la corrispondenza con l'intraprendente Cleyer. Anche lui era membro dell'Accademia curiosorum ed era in contatto con l'orto botanico di Amsterdam. Durante in suoi due mandati come mercante-capo della factory di Dejima (1683-84 e 1685-86) riuscì ad acquistare uno splendido manoscritto con disegni di uccelli e piante e altri li fece eseguire da un pittore europeo; inviò i materiali a Mentzel che riunì le circa 1300 illustrazioni, precedute da un dedica all'elettore Federico III (era succeduto al padre nel 1688) e da una breve introduzione, in una Flora japonica in due tomi rilegati. Mai pubblicati, entrarono a far parte della collezione di illustrazioni naturalistiche della Biblioteca di stato di Berlino nota come Libri picturati con la sigla A41. L'edizione digitale della magnifica opera è consultabile qui. Egli stesso interessato alla farmacopea e alla medicina cinesi, oltre a contribuire di persona alla rivista dell'Accademia curiosorum con numerose osservazioni su questi argomenti, Cleyer fece pervenire a Mentzel testi medici cinesi per la biblioteca elettorale e altri materiali, che furono da lui uniti agli acquarelli e agli schizzi del dono brasiliano del principe di Nassau Siegen nel volume manoscritto noto come Miscellanea Cleyeri (Liber picturatus A38) e probabilmente custoditi nella sua casa. Confluito nella Biblioteca elettorale di Berlino, insieme ai Libri principis e al Theatrum rerum naturalium Braziliae, fa parte dei Libri picturati scomparsi durante la Seconda Guerra mondiale e ritrovati presso la Biblioteca Jagellonska di Cracovia. Ho già racconta questa storia in questo post. Già nel 1685 Mentzel fu in grado di pubblicare un piccolo lessico latino-cinese (Sylloge minutiarum lexici Latino-Sinico-Characteristici), in cui gli ideogrammi cinesi sono accompagnati dalla traslitterazione fonetica in caratteri latini. Entrato poi in contatto con il missionario gesuita belga Philippe Couplet, l'anno successivo pubblicò una cronologia della storia cinese (Kurtze chinesische Chronologia oder Zeit-Register), basata sulla Tabula chronologica dello stesso Couplet e su Sinicæ historiæ decas prima del gesuita italiano Martino Martini. Su consiglio di Couplet, riprese poi il progetto di Müller di una chiave per l'apprendimento del cinese (Müller da parte sua vi aveva rinunciato e prima di morire fece bruciare i propri manoscritti), basandosi per la grammatica su un manoscritto di Martini, per la pronuncia sul Vocabulario de letra China del domenicano spagnolo Francisco Díaz e per l'impostazione generale sul lessico cinese Zihui che organizzava gli ideogrammi in 214 radici. Tuttavia, non andò oltre prefazione (Clavis Sinica, ad Chinensium scripturam et pronunciotionem Mandarinicam) pubblicata nel 1698. Infatti Mentzel si era già imbarcato in un progetto ancora ambizioso: un dizionario cinese-latino (Chinensium Lexici characteristici inscripti 字彙 Cú-guéi) di cui redasse nove volumi, rimasti però inediti. Per l'intensità e la ricchezza di risultati, l'attività di Metzel come sinologo è tanto più stupefacente se pensiamo che negli ultimi anni della sua vita egli era gravemente malato. Nel 1686 fu colpito da un'emiparesi che gli lasciò un tremore costante degli arti; non poteva più scrivere e poté continuare a studiare e lavorare solo grazie al figlio, che poi gli succedette come medico di corte. Morì a Berlino nel 1701.  Mentzelia, fiori notturni dalle Americhe Come botanico, ad assicurare una certa fama postuma a Mentzel fu soprattutto il suo Index Nominum Plantarum Universalis; in Nova plantarum americanarum genera Plumier lo onorò con la dedica del genere Mentzelia proprio ricordando quest'opera; quanto a Linneo, che riprese il genere fin da Hortus cliffortianus, in Bibliotheca botanica elenca il medico dell'elettore sia tra gli autori di flore locali (riferendosi ovviamente alla sua centuria sulla flora di Danzica) sia tra i lessicografi, e utilizzò ampiamente il dizionario di Mentzel come opera di riferimento. Menzelia L. (famiglia Loasaceae) è un genere di un cdntinaio di specie originarie delle Americhe, con centro di diffusione nell'America nord-occidentale; sono soprattutto erbacee annuali, biennali e perenni di breve vita, con qualche arbusto. La grande maggioranza vive in ambienti aridi o subdesertici, spesso disturbati o poveri. La caratteristica più costante sono le foglie munite di peli uncinati che per la loro capacità di attaccarsi a ogni cosa sono stati paragonati al velcro; presumibilmente hanno funzione difensiva, ma è stato anche ipotizzato che i numerosi insetti che vi vengono intrappolati, cadendo poi ai piedi della pianta, contribuiscano ad arricchire il suolo povero di nutrienti. Per la grande variabilità di forme tanto del genere quanto delle specie e per le affinitàmtra queste ultime, è considerato un genere tassonomicamente difficile. Tanto la forma delle foglie, in genere caratterizzate da margini ondulati, dentati o serrati, quanto la struttura dei fiori sono alquanto varie. I fiori, singoli o riuniti in infiorescenze termiali, possono avere da 5 a 10 petali, talvolta intervallati da brattee, stretti in alcune specie, ampi in altre, mucronati in altre ancora; le corolle sono biache, bianco crema, gialle, a volte rosse alla gola. Molto decorativi gli stami, molto numerosi. I fiori si aprono nel tardo pomeriggio o di sera per essere impollinati da falene e altri insetti notturni. Tra i caratteri distintivi più importanti, anche la superficie dei semi. Ad esempio, quelli di M. affinis, un'annuale distribuita tra California meridionale, Arizona, Nevada e a Baja California, hanno forma prismatica, quello di M. congesta sono angolati con lati concavi ricoperti di minute protuberanze, quelli di M. involucrata sono minuscoli, ruvidi e bianco-cenere. Il genere è particolarmente rappresentato negli Stati Uniti; porta il suo nome la rivista "Mentzelia", organo della Northern Nevada Native Plant Society. Alcune specie, in particolare la californiana M. lindley, sono talvolta coltivate come annuali da giardino. Una scelta di specie nella scheda. Il medico pomerano Peter Lauremberg, vissuto a cavallo fra Cinquecento e Seicento, è ancora un uomo rinascimentale per la cultura enciclopedica; ma come studioso aperto alla sperimentazione e alla verifica diretta è anche un figlio del secolo di Galileo. Insegnò molte materie in varie università e di molte materie scrisse nelle sue numerose opere. Ritornato nella città natale Rostock, ebbe diversi giardini e si appassionò di piante e orticoltura, cui dedicò un influente trattato. Prevedeva di completarlo con una trattazione approfondita delle piante da coltivare, ma poté scriverne e pubblicarne solo un volume, dedicato alle piante bulbose e tuberose. È il dedicatario del piccolo genere Laurembergia (Haloragaceae). 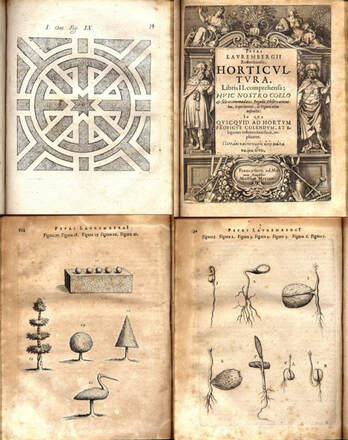 Un influente trattato sulla coltivazione dei giardini Medico, professore universitario, poligrafo ed erudito universale, Peter Lauremberg (1585-1639) era nato in una famiglia di intellettuali della città baltica di Rostock. La madre Johanna Longolia era figlia dell'umanista Gisbert Longolius (Gijsbert van Langerack), il padre Wilhelm fu medico, matematico, professore universitario, più volte rettore del'università di Rostock, così come lo sarebbero stati Peter e due dei suoi fratelli, il più celebre dei quali fu Johann, matematico, cartografo, pedagogista e autore di poesie in latino e basso tedesco. Con questo background culturale, non c'è da stupirsi che già a undici anni Peter traducesse dal greco e dal latino e scrivesse poesie latine. Vissuto nell'epoca che Peter Burke ha definito "dei mostri di erudizione", adulto, dopo essersi laureato in medicina, avrebbe insegnato in varie università filosofia, matematica, fisica, medicina, retorica e poetica e scritto decine di trattati che spaziano dall'anatomia (tra l'altro, precedette Harvey nella descrizione della circolazione del sangue) all'astronomia, dalla matematica alla pedagogia. Fu autore di un'enciclopedia e degli Acerra Philosophica, una raccolta di 400 aneddoti o storie morali ed educative. Scrisse persino di musica e compose cinque brani per liuto. Dopo aver vissuto ed insegnato per molti anni ad Amburgo, nel 1624 Peter Lauremberg accettò la cattedra di poesia all'Università di Rostock e tornò nella città natale. Qui possedeva un giardino urbano e diverse proprietà suburbane; si occupava anche dei giardini degli amici e iniziò a corrispondere e a scambiare piante con altri appassionati di Rostock e altre città baltiche, fino a Lubecca e Stralsund, e a farsene arrivare da commercianti che operavano in Germania e in Olanda, nonostante lo stato di guerra che investì pesantemente la regione. Nel 1628 Rostock fu presa dalle truppe imperiali di Wallenstein e i giardini suburbani di Lauremberg furono devastati; nel 1631 toccò alla casa di città, saccheggiata dagli svedesi; il professore fu ben felice di essere riuscito a salvare almeno un rosmarino e dei cipressi portandoli a casa di un cognato. Per quest'uomo abituato a tradurre ogni esperienza in pagine scritte, anche la passione per piante e giardini si trasformò in occasione di scrittura. Nacque così Horticultura, stampato a Francoforte sul Meno senza data, forse nel 1631, come si evince dalla dedica, o l'anno successivo. L'opera è di grande importanza storica per essere la seconda dedicata alla progettazione e alla coltivazione dei giardini in terra tedesca, preceduta unicamente da Garten-Ordnung del pastore turingio Johann Peschel (1597). E' anche una delle fonti di Von Garten Bau di Elsholtz che ne riprese alcune illustrazioni e lodò Lauremberg per aver cercato di dare ordine alla materia, ma lo criticò per aver scritto in latino. La lingua non è il solo tratto tipicamente rinascimentale del trattato di Lauremberg; a quella civiltà ci riportano l'erudizione, i continui riferimenti al mondo classico, le numerosissime citazioni di autori antichi, il taglio speculativo-filosofico di alcuni capitoli; l'esempio più evidente sono i capitoli 6-9 del primo libro sulla natura delle piante in cui Lauremberg, rifacendosi a Cesalpino e più in generale alla scuola filosofica aristotelica, discute se le piante abbiano o no un'anima, e in tal caso quale sia la sua sede. D'altra parte Lauremberg è anche un figlio del Seicento per la propensione alla sperimentazione e per il taglio pratico, direi manualistico, dei capitoli sulle tecniche di coltivazione, che per altro occupano la maggior parte del testo. Il volume, di poco meno di 200 pagine, dopo la dedicatoria al medico personale di Gustavo Adolfo, è aperto da un'ampia prefazione in cui Lauremberg espone i benefici donati dalle piante, dal cibo agli abiti al materiale da costruzione alle medicine fino al ristoro dei sensi e dell'animo. La prevalenza dell'utilità (commodum) sul mero piacere è ribadita dal capitolo iniziale del primo libro, in cui - proprio mentre in Olanda imperversa la tulipomania - Lauremberg scrive "E' sciocco spendere 500 o 1000 fiorini per un solo fiore che non si caratterizza né per profumo né per utilità, ma solo per l'apparenza e la novità, e dura appena otto giorni". Con il secondo capitolo si entra nel merito delle tecniche di coltivazione, trattate in modo più o meno analitico: la conoscenza e il miglioramento del suolo (Cap. 2); gli attrezzi (Cap. 3, con una bella tavola che sarà ripresa da Elsholtz); la vangatura (Cap. 4); la concimazione (Cap. 5); la natura e la fisiologia delle piante, viste in termini ancora essenzialmente filosofici (Capp. 6-13); la propagazione, trattata in modo molto dettagliato (Capp. 14-27); i trapianti (Cap. 28); la potatura (Capp. 29-30); l'irrigazione (Cap. 31); il diserbo, la cura degli alberi e le sarchiatura (Capp. 32-34); avversità e parassiti (Cap. 35-36); siepi, pergolati e topiaria (Cap. 37); i pulvilli (gli spazi destinati a una singola pianta e quindinl'organizzazione delle aiuole, Cap. 38). Di particolare interesse, il Cap. 9 ("La simpatia e l'antipatia tra le piante") in cui Lauremberg è tra i primissimi a trattare le consociazioni vegetali e il fenomeno che oggi chiamiamo allelopatia; e i diversi capitoli dedicati alla potatura e alla topiaria, arricchiti anche da bellissime tavole. Il secondo libro, articolato in appena otto capitoli e molto più breve del primo, è dedicato alle quattro parti del giardino: il frutteto e l'arboreto (pomarium, Capp. 1-4), il giardino dei fiori (florilegium, Capp. 5-6), l'orto (olitorium, Cap. 7), l'orto dei semplici (phytiatricum, Cap. 8). Come si vede anche da questo schema, la funzione ornamentale del giardino è ancora in secondo piano rispetto a quella produttiva, garantita da frutteto, orto e giardino dei semplici. 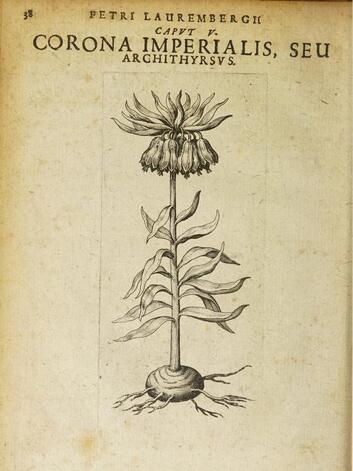 Bulbi e tuberi in giardino e nell'orto Lauremberg ha allegato a ciascuna delle quattro parti del giardino liste di piante consigliate; si tratta però di semplici elenchi senza altre indicazioni. Progettava infatti di approfondire la trattazione delle singole piante in almeno altri due volumi, intitolati Apparatus plantarius e concepiti come parte integrante di Horticultura, di cui l'unico volume pubblicato riprende infatti il frontespizio. Per varie ragioni, inclusa la morte, sopravvenuta nel 1639, egli riuscì a completare e pubblicare un solo volume (Apparatus plantarius Primus, 1632), diviso in due parti o libri, dedicati rispettivamente alle piante bulbose e tuberose; si tratta presumibilmente della prima monografia su questo gruppo di piante. Graficamente molto curato, il volume è diviso in 38 capitoli (24 sulle bulbose, 14 sulle tuberose), molti dei quali sono preceduti da una tavola con il titolo e un'incisione di ottima fattura di Matthäus Merian, che aveva disegnato e inciso anche le tavole di Horticultura; questo famoso pittore e incisore era il padre di Maria Sybilla Merian. I capitoli seguono una struttura ordinata: nomen, la denominazione latina e tedesca; differentia, le varietà o meglio i cruteri di differenziazione; species, le specie o meglio i tipi; vires et usus: le virtù e gli usi, distinti in familiari (culinari o di altra natura) e medici; cultura: la coltivazione; corollarium: una sorta di appendice, in cui Lauremburg inserisce ogni sorta di informazioni erudite, soprattutte tratte dagli autori antichi. Anche per i nomi si attiene per lo più a quelli antichi, veri o presunti, e per le specie di nuova introduzione talvolta ne crea di propri, ad esempio chiama Adenes canadensis il topinambur Helianthus tuberosus e Adenes virginianus la patata Solanum tuberosum, ricavando il nome dal greco adén "ghiandola". Tuttavia nessuna della sue denominazioni è stata ripresa da altri botanici. Per compilare il suo volume, Lauremberg si rifà ai botanici precedenti, in particolare Dodoens e Clusius ma, soprattutto per la coltivazione, anche alle esperienze personali, anche se certamente non coltivò tutte le piante citate, molte delle quali anche per lui dovevano essere puri nomi citati da questo o quell'autore. Nel primo libro, dedicato ai bulbi, dopo una capitolo iniziale sulle caratteristiche generali delle piante bulbose, tratta 23 generi o meglio gruppi di piante, in ordine alfabetico. Si inizia con Allium, l'aglio, di cui, oltre a Allium sativum, l'aglio comune, elenca altri 9 tipi; non sempre è facile identificarli, visto che qui come nei capitoli successivi solitamente Lauremberg si limita ai nomi, talvolta accompagnati da qualche epiteto descrittivo; ad esempio, Allium campestre tenufolium caninum. Grazie a una descrizione per una volta più precisa, riconosciamo però in Allium aegyptiacum la cipolla egiziana Allium x proliferum. Dopo l'aglio, viene Cepa, la cipolla, con 5 varietà. Segue Colchicum, il colchico, che, oltre ad essere coltivato per le proprietà mediche (e temuto per la tossicità letale) nei giardini rinascimentali e barocchi era apprezzato per il "fiore elegantissimo"; Lauremberg cita tre varietà primaverili, due delle quali potrebbero corrispondere a Bulbocodium vernum, e dieci varietà autunnali, presumibilmente corrispondenti a Colchicum autumnale e forse C. bizantinum. E' poi la volta della Corona imperiale (Fritillaria imperialis) che Lauremberg vorrebbe ribattezzare Archityrsus, ovvero "scettro regio"; provenente dall'impero ottomano, era ancora una novità, ma egli ne conosce sei varietà, con corolle gialle (la più comune), rosse ("molto più elegante della precedente"), aranciate, con corona duplice (è la varietà 'Prolifera' o 'Crown on Crown') o triplice ("è comune a Costantinopoli, da noi è rarissima"). Egli osserva che le ultime due non sono specie a sè, ma "un divertimento della natura scherzosa"; al secondo o al terzo anno di coltivazione la corona ritorna infatti semplice. Molto ampia è la rassegna di Crocus, suddivisi in vero (lo zafferano, Crocus sativus, "amico delle cucine, non solo per il profumo e il sapore, ma perché rallegra il cuore e corregge il cibo cattivo"), autunnale (4 varietà), primaverile a foglia larga e stretta (rispettivamente 9 e 7 varietà, con fiori bianchi, viola, gialli, unicolori o striati). Del dente di cane (Dens Caninus, ovvero Erythronium dens-canis), cui dedica un capitolo brevissimo, conosce invece due sole varietà, violetta e bianca. Erano al contrario molto popolari nei giardini rinascimentali e barocchi le Fritillaria, nome che Lauremberg condanna ("non è neppure latino, e non lo usa nessuno degli eleganti scrittori antichi") e vorrebbe sostituire con Gaviana o "fiore dei gabbiani" perché i fiori macchiettati di Fritillaria meleagris ricorderebbero le uova di questi uccelli. Anch'essa era un'introduzione recente (la prima descrizione di F. meleagris risale al 1554 e si deve a Dodoens), ma già fioriva un vivace mercato di importazioni dall'impero ottomano e dai Pirenei e dalla Francia, dove secondo Lauremberg ne erano abbondantissime le campagne di Orange e La Rochelle. Egli ne elenca 14 varietà, distinte in primaverili e tardive; oltre a F. melegaris con fiori viola e bianchi, riconosciamo F. persica "Gaviana ramificata, massima, purpurea, con steli plurimi e molti fiori" e F. pyrenaica "giunta dai monti, piccola e con piccoli fiori di colore verde cinerino". Del gladiolo Gladiolus Lauremberg elenca 10 varietà, distinte per il colore dei fiori viola o bianco, i fiori semplici o doppi, la provenienza; le specie citate provengono da varie parti del continente europeo (Francia, Italia, Austria, Creta), ma c'è già un gladiolo sudafricano ("Gladiolo massimo del Capo di Buona Speranza"), già presente con lo stesso nome nel catalogo di Swertius (1612). Sorvola invece su Hermodactylus ("non ne conosco né varietà né specie, perché gli autori differiscono pesantemente e disputano su quale pianta possa essere") e passa al grande capitolo di Hyacinthus, di cui elenca 67 tipi. Va considerato però che all'epoca sotto questa etichetta erano classificati diversi generi della famiglia Hyacinthaceae (o sottofamiglia Scilloideae delle Asparagaceae). Oltre ai veri e propri giacinti (Hyacinthus orientalis), che Lauremberg invita ad usare per "aumentare la bellezza e il decoro dei giardini", troviamo dunque specie oggi assegnate ai generi Leopoldia, Muscari, Dipcadi, Scilla, Hyacinthoides e anche qualche Allium. Nel capitolo successivo, Lauremberg tratta insieme le Iris bulbose (21 varietà, distinte in a foglia larga e a foglia stretta; tra queste ultime, Iris tuberosa praecox, che "alcuni ritegono il vero Hermodactylus"; è la bellavedova che oggi, dopo essersi chiamato Hermodactylus tuberosus, è Iris tuberosa) e non bulbose "innumerevoli per varietà, da raccomandare non solo per la varietà di colori e il bellissimo aspetto, ma anche per le virtù e la grandissima efficacia"; distinguendole di nuovo in a foglia stretta e a foglia larga, ne elenca 48 specie o varietà. Segue Leucojum (che Lauremberg scrive Leucoion) con 8 varietà distinte in primaverili ed estive. Ai gigli (Lilium), piante importanti oltre che la loro bellezza e maestosità, per i valori simbolici, Lauremberg riserva tre capitoli, dedicati rispettivamente a Lilium candidum, Lilium cruentum (ovvero L. croceum e altre specie a fiori rossi, in 10 varietà) e Lilium intortum seu cymbalum, ovvero L. martagon e altre specie con i petali retroflessi (15 varietà). Sotto la denominazione omerica e mitica di Moly egli riunisce invece 14 piccole bulbose sia indigene sia esotiche di difficile identificazione che potrebbero essere degli Allium mentre in Moly novum Hondianum (cioè ripreso da Petrus Hondius), grazie alla descrizione per una volta più precisa, riconosciamo la sudafricana Albuca bracteata. Ed eccoci giunti al vastissimo capitolo sui narcisi Narcissus, un altro dei grandi protagonisti dei giardini rinascimentali e barocchi; Lauremberg mettele mani avanti premettendo "le varietà di narcisi sono tante che è difficile individuare criteri di differenziazione certi e includere tutte le specie. Mi limiterò unicamente alle principali". Quindi ne elenca 50, divisi in a foglia larga semplici e doppi, a foglie di giunco semplici e doppi, esotici. In quest'ultimo gruppo troviamo specie oggi assegnate ad altri generi, come Narcissus indicus [...] Jacobaeus ovvero Sprekelia formosissima. Numerose anche le orchidee (Orchis seu Satyrion) che Lauremberg, seguendo Dioscorde, Gerard e Dodoens, divide in Cynosorchis ("con testicoli di cane"), Tragorchis ("con testicoli di capra"), Serapias, Moriones, profumate e nuove. L'interesse per queste piante (le specie o varietà elencate sono 33) non è orticolo - per la coltivazione Lauremberg si limita a scrivere "niente di particolare rispetto ad altri bulbi" - ma medico; avevano infatti fama di potente afrodisiaco. E proprio per condividere le stesse proprietà, oltre che una qualche affinità nelle infiorescenze a pannocchia, il medico tedesco aggiunge alla fine del capitolo quelle che chiama Orchides palmatae, orchidee con foglie palmate, pur ammettendo che non sono piante bulbose. Così, accanto a orchidee vere e proprie come Satyrion basilicum major, che dovrebbe essere Gymnadenia conopsea, troviamo Palma Christi, ovvero il ricino. Nel capitolo su Ornithogalum sono elencati 14 tipi con infiorescenza ombellata o spicata; è di nuovo un gruppo misto, dove accanto a Ornithigalum veri e propri come O. arabicum, già con questo nome, e "ornitogalo a foglie larghe etiopico del Capo di Buona Speranza", che potrebbe essere O. dubium, troviamo Gagea lutea e Drimia maritima. Veniamo poi a Orobanche (7 varietà) di cui Lauremberg conosce la natura parassita: "La natura di queste erbe è tale che raramente nascono da sole; per lo più richiedono la vicinanza di altre piante, cui si uniscono; spesso emergono dalle radici di altre piante, come fa la cuscuta o l'ipocisto [...] soffocandole o strangolandole". Con Porrum il porro (7 varietà) torniamo nell'orto. Solo tre le varietà di Scilla, piante tossiche con vari usi medici, tra cui riconosciamo Drimia (o Squilla) pancration. Ed eccoci finalmente giunti all'ultimo capitolo del libro sui bulbi con la superstar Tulipa, il tulipano. Erano gli anni cui già infuriava la tulipomania e Laurenberg non si sottrae e dopo aver dichiarato "le varietà di tulipani sono indicibili sia per la bellezza dei colori sia per il numero" ne elenca 144, precoci, tardivi, di uno o due colori, variegati, di colore misto, e dedica due pagine alle indicazioni di coltivazione, rifacendosi a una larga esperienza personale. Teminato l'ampio libro sui bulbi (più di 100 pagine), si passa all'assai più breve libro sulle piante tuberose. Dopo un capitolo introduttivo, si inizia con i tuberi propriamente detti, ovvero i tartufi, che per noi non sono piante, ma tali sono stati considerati per secoli, fino a Linneo ed oltre. Quindi, in ordine alfabetico, gruppi di piante tanto esotiche quando indigene, talvolta coltivate per bellezza, ma più spesso come orticole: Adenes canadiensis seu Flos solis glandulosus, ovvero il topinambur Helianthus tuberosus, apprezzatissimo in cucina; Adenes virginianum seu Halicacabus glandulifer, ovvero la patata Solanum tuberosum, che all'epoca non si era ancora imposta nelle tavole tedesche e Lauremberg guarda quasi come una curiosità; Arisarum (2 specie); Arum (4 specie); Asphodelus (6 specie, non tutte oggi assegnate a quel genere; in Asphodelus minor Phalangium narbonense riconosciamo infatti Ornithogalum narbonense); Asphodelus liliaceus o Liliasphodelus, ovvero Hemerocallis (3 varietà differenti per colore; nella Germania settentrionale era di recentissima introduzione, ma già mostrava "di moltiplicarsi spontaneamente grazie ai tuberi, e spesso più del desiderabile"); Bulbocastanum, ovvero Bunium bulbocastanum o castagna di terra, all'epoca coltivato per i tuberi; Cyclamen, il ciclamino (17 varietà, distinte per dimensioni, colore dei fiori e epoca di fioritura; erano apprezzati in giardino, ma avevano anche usi officinali); Glans terrestris ovvero Lathyrus tuberosus, che, fino al Settecento, prima della affermazione della patata, era coltivato in larga scala in Olanda e nella Germania settentriinale; Glans terrestris malacensis ovvero la batata Ipomoea batatas, detta malacensis perché introdotta attraverso Malaga; Gramen amigdalosum, ovvero Cyper esculentus, che Lauremberg è orgoglioso di coltivare nel suo orto ottenendone tuberi "di non minore perfezione di quelli di Verona", l'unico luogo in cui avrebbero prosperato secondo alcuni botanici; Radix cava ovvero Corydalis cava (6 varietà, distinte per dimensioni e colore dei fiori; era coltivata come ornamentale ma aveva anche usi medici) chiude la serie e il volume.  Il genere Laurembergia Come abbiamo visto, Lauremberg dedicò Horticultura al medico di Gustavo Adolfo, Johannes Salvius. Era un gesto di opportunità politica, visto che Rostock nel 1630 era passata sotto il dominio della corona svedese. Anche se a differenza di altre città della Pomerania orientale, rimaste sotto il controllo svedese fino al Congresso di Vienna, dopo la pace di Westfalia recuperò la sua indipendenza, i legami commerciali e culturali con la Scandinavia rimasero vivi. Il trattato sull'orticoltuta di Lauremberg ebbe un notevole successo e dovette circolare anche in Svezia; se ne ricordò l'allievo di Linneo Peter Jonas Bergius che in Descriptiones plantarum ex Capite Bonae Spei (1767) creò in suo onore il genere Laurembergia con queste parole d'elogio: "Ho imposto al genere questo nome in onore di Peter Lauremberg, un tempo botanico esimio e restauratore di un'orticoltura più sana". Laurembergia è un piccolo genere della famiglia Haloragaceae (la stessa di Myriophyllum), con sette specie distribuite tra Sud America, Africa, Madagascar, Malesia e Giappone. Di piccole dimensioni e con fiori non cospicui, sono erbacee perenni, spesso decombenti, con rizomi striscianti che radicano ai nodi. Hanno foglie semplici, opposte o più raramente unite in verticilli di due o quattro, intere o dentate; i minuscoli fiori, con calice con quattro lobi e quattro petali, si ammassano in compatte infiorescenze ascellari di 3-11; quello centrale con picciolo più lungo è maschile o androgino, gli altri femminili. I frutti sono nucole. Vivono di solito in ambienti umidi, talvolta stagionalmente allagati. L. repens, una specie ampiamente diffusa nell'Africa tropicale e subtropicale e in Sudafrica, è presente in una varietà di ambienti che vanno dalla savana al Karoo al fynbos di succulente, specialmente ai margini dei corsi d'acqua, ma può adattarsi a una maggiore aridità grazie alle foglie succulente. L. coccinea, nativa di India, Sri Lanka e Indonesia, è invece una pianta montana (sopra a 1400 e fino a 3100 metri) che vive nelle praterie, lungo i margini delle strade e talvolta, come semiacquatica, lungo le rive lacustri d può essere semisommersa per una parte dell'anno. Von Garten Bau di Johann Sigismund Elsholtz ovvero come coltivare un giardino nel freddo Brandeburgo13/4/2024 Il medico Johann Sigismund Elsholtz fu una delle figure più versatili della scienza tedesca del secondo Seicento; scrisse infatti di chimica (a lui si deve la creazione del termine "fosforo"), di medicina, di dietetica - di cui fu un precursore -, di botanica... e di giardinaggio. Come direttore dei giardini di corte del grande elettore di Brandeburgo, dovette affrontare la sfida del difficile clima della regione di Berlino, caratterizzato da lunghi inverni dalle temperature molto basse (senza dimenticare i suoli poco fertili e la ventosità); fece tesoro di questa esperienza per scrivere Von Garten-Bau, probabilmente il più importando libro di giardinaggio dell'epoca, insuperato fino al dizionario di Miller. Nel trattato, così come nei giardini del tempo, che possono essere esemplificati dal Lustgarten ("giardino di piacere") di Berlino, si affiancano quattro tipi di piante, secondo il duplice criterio dell'utile e del diletto: le piante officinali, coltivate nell'hortus medicus, insieme a una selezione di specie del territorio; le piante orticole, coltivate nell'hortus culinarius, ovvero nell'orto vero e proprio; gli alberi, coltivati nell'arboreto e nel pomarius, il frutteto; le piante da fiore dell'hortus floridus, coltivate in piena terra nei parterre a ramages del giardino di piacere se rustiche o in vaso e protette dai rigori invernali nell'orangerie se delicate. Tra i diversi giardini di corte diretti da Elsholtz come praefectus hortorum c'era anche il primo nucleo del futuro orto botanico di Berlino; in ricordo del suo ruolo di padre fondatore, Carl Ludwig Willdenow, che avrebbe rifondato quel giardino, gli dedicò l'interessante genere Elsholtzia. 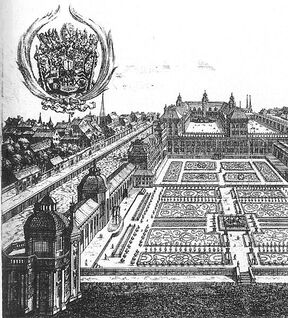 Il Lustgarten di Berlino Nel 1646, mentre volge al termine la terribile Guerra dei trent'anni, che ha devastato la Germania ma ha anche segnato l'ascesa della Prussia come potenza regionale, il Grande elettore Federico Guglielmo ordina di trasformare l'orto adiacente al Palazzo di città di Berlino (Berliner Stadtschloss) in un giardino di piacere (Lustgarten). E' in un certo senso il suo regalo di nozze alla moglie Louise Henriette di Nassau che ha sposato proprio quell'anno; figlia di Guglielmo il Taciturno, intelligente e colta, è lei, con l'aiuto dell'ingegnere militare Johann Mauritz e del giardiniere di corte Michael Hanff, a presiedere alla trasformazione, inspirandosi ai giardini della sua patria, l'Olanda. Collocato a nord del palazzo residenziale, su terrazze in lieve pendenza e fiancheggiato da un porticato monumentale, il Lustgarten comprendeva eleganti parterre con siepi a ramages e piante da fiore (hortus floridus), voliere, statue e sculture affidate a artisti di fama, un pergolato, un arboreto e un frutteto (pomarius); a nord c'era un hortus medicus dove si coltivavano piante medicinali e un hortus culinarius sive olitorius per la coltivazione degli ortaggi destinati alla tavola del principe. Vi si coltivavano anche piante esotiche, tra cui la patata, che fu coltivata qui per la prima volta in Prussia nel 1649, grazie ad alcuni tuberi importati dall'Olanda; all'epoca era considerata una curiosità ed era coltivata per la bellezza dei suoi fiori, così come i pomodori. Nel 1650 l'architetto Johann Gregor Memhardt costruì un padiglione in stile olandese, che comprendeva anche una grotta artificiale seminterrata, e disegnò un giardino d'acqua con fontane, giochi d'acqua e peschiere. Per proteggere dai rigori invernali gli agrumi, i melograni e le altre piante esotiche che, coltivate in vaso, nella bella stagione, erano esposte all'esterno, nel 1652 fu costruita una limonaia che tuttavia nel 1655 andò distrutta in un incendio causato da un difetto dell'impianto di riscaldamento. Ricostruita l'anno dopo, fu demolita nel 1658, per fare posto a un bastione difensivo e a un fossato che collegava i due bracci della Sprea, tagliando in due il giardino. Di conseguenza, il Lustgraten dovette in parte essere ridisegnato. Come si presentasse nel breve intervallo tra la sua creazione e la trasformazione successiva al 1658, lo sappiamo grazie a Hortus berolinensis, opera scritta dal medico e naturalista Johann Sigmund Elsholtz (1623-1688) tra il 1656 e il 1657. Trasferitosi a Berlino nel 1653, nel 1656 egli ottenne il libero accesso al Lustgarten per le sue ricerche scientifiche e scrisse quest'opera a mo' di ringraziamento; divisa in due parti, comprende un'accurata descrizione del giardino e un catalogo delle piante che vi erano coltivate. Forse proprio perchè resa obsoleta dalla ristrutturazione del Lustgarten, non fu mai pubblicata, ma valse a Elsholtz la nomina a medico di corte, botanico di corte e prefectus hortorum, ovvero direttore del Lustgarten e dei giardini di corte. Studioso versatile e di vasti interessi, Elsholtz ha lasciato opere significative nei campi della botanica, della chimica, della medicina e dell'igiene, di cui è consideraro un precursore. Nato a Francoforte sull'Oder, inizò gli studi presso l'università della città natale, quindi li proseguì a Wittenberg e a Königsberg. Viaggiò poi nei Paesi Bassi, in Francia e in Italia. Nel 1653 conseguì il dottorato in medicina a Padova con una tesi in cui riassunse la letteratura contemporanea sulle proporzioni del corpo umano in termini di peso, massa e dimensioni; pubblicata nel 1654 sotto il titolo Anthropometria, l'opera contiene tra l'altro la più antica illustrazione nota di un dispositivo per misurare l'altezza degli esseri umani, detto anthropometron. Subito dopo la laurea, Elsholtz ritornò in Germania e si stabilì a Berlino dove aprì uno studio medico; dopo la nomina a medico di corte e botanico regio (1657), si fece un nome tra gli scienziati tedeschi per le sue ricerche di vario argomento; nel 1674 fu ammesso alla Leopoldina, sulla cui rivista Miscellanea curiosa pubblicò una quindicina di articoli di argomento medico. In tutti i campi di cui si occupò, fu caratterizzato dalla propensione a sperimentare e a percorerre nuove strade. Come chimico, si occupò della distillazione dei coloranti e delle proprietà luminose del fosforo (del cui nome, letteralmente "portatore di luce", gli si attribisce l'invenzione). Come medico, è noto per i suoi esperimenti sulle iniezioni endovenose e sulle trasfusioni di sangue, esposti in Clysmatica nova (1667). Ma soprattutto è consideraro un precursore della dietetica e dell'igiene, grazie a Diaeteticon, pubblicata nel 1682, in cui compare per la prima volta in Germania il termine Hygiene ("igiene"). Ricca di suggerimenti pratici, comprese alcune ricette culinarie, come esplicita il sottotitolo fornisce istruzioni per mantenersi in salute attraverso una corretta alimentazione; inoltre Elsholtz vi sottolinea l'importanza di acqua e aria pulite e dell'igiene personale. Il libro incrocia anche la botanica, visto che cibi e bevante erano largamente ricavati da piante, di cui si analizzano le proprietà, facendo riferimento sia alla tradizionale teoria degli umori, sia all'analisi chimica. Va infine ricordato che, come medico dell'elettore, insieme al collega Mentzel ebbe un ruolo centrale nella stesura dell'Editto medico di Brandeburgo (1685) che poneva il settore sanitario sotto il controllo di un Collegium medicum e regolava professioni sanitarie e tariffe. 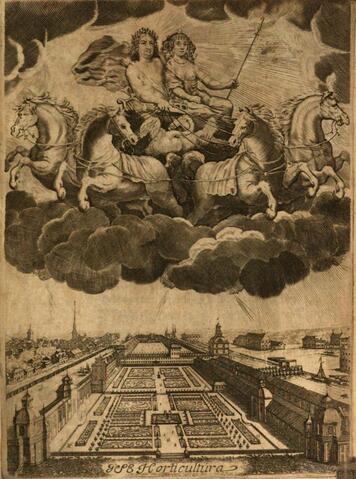 Dalla botanica al giardinaggio Nella variegata ed eclettica opera di Elsholtz, le piante e i giardini occupano uno spazio privilegiato. Per circa trent'anni (dal 1657 alla morte) come prafectus hortorum presiedette ai giardini di corte, acquisendo una notevole esperienza anche pratica. Durante la sua gestione, il Lustgarten di Berlino si arricchì di molte piante, raggiungendo le mille specie, e fu aperto alla fruizione dei berlinesi, divenendo un popolare luogo d'incontro. Era il primo giardino pubblico della città che fino ad allora, come luoghi all'aperto, aveva conosciuto solo i mercati e le piazze d'armi. Dal 1685, il giardino ebbe nuovamente una limonaia (Pomeranzen Haus); costruita dall'architetto Johann Arnold Nering, era un imponente edificio con pianta semi circolare. Probabilmente uno dei primi compiti di Elsholtz appena assunto l'incarico fu il trasferimento dell'hortus medicus e dell'hortus culinarius, che occupavano l'area smantellata per fare posto al bastione e al fossato. Nel 1679 il Grande elettore ordinò di trasferirli a Schöneberg, in un'area precedentemente nota come Hopfengarten ("giardino del luppolo") perché fino a quel momento era adibita a questa produzione; si trattava soprattuto di un vasto orto e frutteto, ma poiché ospitava anche le piante medicinali, questa data viene di solito considerata quella di nascita del primo orto botanico di Berlino. In realtà, cominciò ad essere chiamato così e ad assumere realmente questa funzione molto più tardi, nel 1718, quando Elsholtz era morto da un pezzo e anche il Lustgarten di Berlino non esisteva più, spianato e trasformato in una piazza d'armi per ordine del re sergente Federico Guglielmo I. Oltre ai due giardini berlinesi, Elsholtz curava anche i giardini della residenza di Potsdam (anch'esso era dotato di una Pomeranzen Haus, l'unica struttura ancora esistente di quel periodo, anche se il solito re sergente ordinò di trasformarla in una stalla per un reggimento di cavalleria) e il giardino di piacere di Oranienburg. La storia di quest'ultimo merita qualche riga. Nell'estate del 1650, durante una battuta di caccia l'elettrice Louisa Henriette soggiornò a Bötzow, a nord di Berlino, e si innamorò del suo paesaggio che le ricordava l'Olanda. Qualche mese dopo, il marito le fece dono dell'uffico (Amt) di Bötzow con la tenuta e i villaggi annessi; al posto del vecchio casino di caccia venne costruito un castello completamente circondato da un fossato e, accanto ad esso, un giardino di piacere, entrambi in stile prettamente olandese. Preceduto da un elegante portico e fiancheggiato su due lati da un ambulacrum, che doveva fungere anche da limonaia, il giardino vero e proprio era rettangolare e comprendeva otto parterre a ramages; al centro, su una collinetta, sorgeva una casa di delizie, detta anche grotto. Lo spazio tra il giardino e il fossato del castello era occupato da un arboreto. In onore di Louisa Henriette, appartenente al casato Nassau Orange, il castello venne battezzato Oranienberg, nome poi esteso al villaggio e all'intero Amt. Nel 1663, Elsholtz pubblicò Flora marchica che è contemporaneamente il catalogo collettivo dei giardini di corte di Berlino, Potsdam e Oranienburg e una flora della marca di Brandeburgo. Le piante sono elencate in ordine alfabetico con il nome latino per lo più tratto dal Pinax di Caspar Bauhin, seguito dal nome volgare tedesco e spesso da sinonimi di altri autori; i più frequenti sono Clusius, Dodoens e Lobel, ma i testi citati sono moltissimi, dal vecchio Dioscoride fino al recente Hortus Eystettensis, a dimostrare un'ottima conoscenza della letteratura botanica e della pubblicistica sui giardini, ampiamente analizzata nella prefazione. Salvo qualche breve notazione occasionale (ad esempio, a proposito di Alnus nigra polycarpos, "L'ho trovato la prima volta sulle rive del fiume Stepenitz presso la città di Perleberg nel distretto di Prignitz"), Elsholtz si limita a un mero elenco: fa eccezione la voce dedicata a Agave americana (chiamata Aloe aculeata e amerikanische Aloe), che occupa quasi due pagine. Elsholtz racconta di averla vista in fioritura nel 1658 in un giardino di Stoccarda, rimanendo stupefatto per l'infiorescenza alta 23 piedi con un totale di 12.000 fiori. Su questa pianta che lo aveva tanto colpito e sulla storia delle sue fioriture in Europa, Elsholtz sarebbe tornato in Von Garten Bau ("Sull'orticultura"), in cui profuse tutto ciò che aveva imparato gestendo i giardini dell'elettore. Pubblicato in prima edizione nel 1666, è un vero e proprio trattato teorico-pratico sull'arte di disegnare e gestire un giardino, che fonde una profonda conoscenza della letteratura sull'argomento con una altrettanto profonda e vasta conoscenza pratica acquisita attraverso l'esperienza diretta. Come chiarisce il sottotitolo, "Lezioni di giardinaggio adatte al clima della Marca elettorale-Brandeburgo e agli stati tedeschli limitrofi", l'intento principale di Elsholtz è fornire indicazioni per affrontare in modo vincente la sfida costituita dal difficile clima della Germania settentrionale, con i suoi lunghi inverni resi ancora più rigidi dal vento. A differenza di De hortis Germaniae di Gessner, che pure è un precedente largamente citato, il trattato è scritto in tedesco; non si rivolge infatti a botanici e dotti, ma a giardinieri e progettisti. Fanno eccezione solo gli schemi riassuntivi che percorrono qua e là il libro, rendendolo parzialmente fruibile anche al di fuori della Germania. Ad aprirlo è una duplice dedica al Grande elettore e alla sua sposa, che però non è più Louisa Henriette, morta quarantenne sfiancata da innumerevoli parti ed aborti, ma la seconda moglie Sofia Dorotea di Schleswig-Holstein; la coppia è raffigurato nel frotespizio in veste di Apollo e Diana, mentre assisi sul carro del sole sorvolano il Lustgarten. Il trattato si articola in sei libri. Il primo è a sua volta un vero e proprio trattato generale sul giardinaggio; è aperto da un'introduzione che, dopo aver definito brevemente il ruolo e i compiti del giardiniere, presenta una breve storia del giardinaggio. Il primo capitolo, sulla scelta del luogo e della forma, è articolato attorno alla duplice funzione del giardino, il diletto e l'utile; la prima è assolta dall'hortus floridus (Blumen Garten) "con la Natura educata in modo che anche d'inverno mostri i fiori più belli", la seconda dall'orto vero e proprio (Kuchen-Garten), dal frutteto e dalla vigna per l'"utilitas alimentaria" e dall'hortus medicus per l'"utilitas medicamentaria". Seguono capitoli sulle strutture, compresa la limonaia (Pomeranzen Haus), gli attrezzi, i vari tipi di coperture (dalle campane alle serrette ai lettorini), le tecniche di propagazione, i lavori e le tecniche colturali, gli accorgimenti per affrontare avversità meteoriche, parassiti e malattie. A partire dal secondo libro, Elsholtz analizza i cinque settori del giardino già individuati nell'introduzione, dedicando un singolo libro a ciascuno: l'hortus floridus (libro II); l'orto (libro III); l'arboreto e il pomario (libro IV); il vigneto (libro V); l'hortus medicus (libro VI). Ogni libro è solitamente diviso in due parti, la prima dedicata alla progettazione e alle attrezzature specifiche, la seconda a un'ampia scelta di piante consigliate, seguita talvolta da un calendario delle attività mese per mese. Ad esempio, relativamente al giardino dei fiori, vengono trattati argomenti come i pergolati, le piramidi, il disegno di aiuole, parterre, viali e sentieri, la disposizione delle piante nelle aiuole; segue poi il catalogo delle erbacee da fiore, distinte in "erbacee perenni che vanno protette d'inverno", "erbacee perenni con radici bulbose o rizomatose che sopportano l'inverno", "erbacee con radici fibrose che sopportano l'inverno", "erbacee annuali o da seme". Se in questo libro le piante sono di fatto organizzate sulla base della rusticità, le orticole, protagoniste del libro successivo, sono invece divise sulla base dell'utilità in "utili per le radici", "utili per le foglie", "utili per i frutti". Il criterio della rusticità ritorna nel libro su alberi e arbusti, divisi in "da proteggere in inverno", "che sopportano l'inverno", "spontanei". Il libro sulla vigna è forse il più dotto, con un excursus sulla sua coltivazione in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Ungheria; ma poi nella scelta delle varietà si privilegiano quelle rustiche "nostrali" e non mancano capitoli sulla vinificazione. Il libro sull'hortus medicus, a parte una breve introduzione, è quasi integralmente costituito da un catalogo di piante non necessariamente officinali; dopo le piante medicinali dei giardini e le specie officinali spontanee, troviamo infatti un capitolo sulle piante spontanee senza proprietà medicinali e un'appendice sui cereali; questa presenza apparentemente incongrua è probabilmente spiegata dalla grande attenzione riservata alla flora locale dagli orti botanici tedeschi, che all'epoca erano ancora chiamati horti medici. Questo libro è dunque quello che assomiglia di più a Flora marchica; anche qui troviamo voci, solitamente brevissime, costituite dal nome latino, per lo più tratto dal Pinax, seguito dal nome tedesco, dai sinonimi in altri autori e, almeno per le specie officinali, da sintetiche indicazioni sugli usi, che solitamente non superano due o tre righe. Tra le poche eccezioni la voce Nicotiana major latifolia, ovvero il tabacco, che occupa circa due pagine. Come Agave americana, era ancora una novità e destava molta curiosità, senza dimenticare che all'epoca era ritenuta quasi una panacea. Il volume, di oltre 400 pagine, si conclude con un calendario riassuntivo dei lavori mese per mese e con gli indici latino e tedesco delle piante trattate. Scritto da un botanico che amava profondamente le piante e aveva una larga esperienza diretta di progettazione e gestione di giardini, Von Garten-Bau segna l'incontro tra la botanica e il giardinaggio; per la prima volta le piante da giardino sono determinate con precisione con il loro nome botanico. Anche se Elsholtz fa ampio riferimento alla letteratura specialistica contemporeanea, come il trattato di Ferrari sugli agrumi o quello di Lauremberg sulle bulbose, il suo trattato supera tutto ciò che è stato scritto in precedenza, con una profondità e una ricchezza di informazioni ineguagliata fino al The Gardeners Dictionary di Miller; Teichert lo ha definito "il miglior libro sui giardini del XVI secolo". Il libro colmava una lacuna e ottenne un notevole successo; già nel 1672 uscì una seconda edizione, sostanzialmente identica a parte l'aggiunta di alcune tabelle riassuntive in latino, seguita da una terza nel 1684. Una quarta edizione ampliata, intitolata Neu Angelegter Garten Bau, benché predisposta dall'autore, uscì postuma nel 1690. Elsholtz era infatti morto all'inizio del 1688, senza poterne curare di persona la pubblicazione.  Piante utili e dilettevoli Anche se, come abbiamo visto, il giardino di Schöneberg ospitava anche piante medicinali, all'epoca di Elsholtz non era propriamente un orto botanico. Solitamente però il botanico prussiano è considerato il fondatore dell'orto botanico di Berlino e come tale nel 1790 è stato onorato da Willdenow, che di quel giardino sarebbe stato il rifondatore, con la dedica del genere Elsholtzia (Lamiaceae). Lo stesso anno, ma in data successiva, un secondo genere Elsholtzia (Lecythidaceae) venne creato da Necker; non valido, è oggi sinonimo di Couroupita. Elsholtzia Willd. è un genere di una quarantina di specie, distribuite prevalentemente nell'Asia orientale temperata o subtropicale, con centro di diversità nello Yunnan in Cina; sono per lo più erbacee annuali o perenni, ma non mancano suffrutici. Se il dedicatario l'avesse conosciuto, certamente l'avrebbe apprezzato dal punto di vista tanto dell'utilità quanto del diletto. Come altri generi della famiglia Lamiaceae, le Elsholtziae hanno foglie aromatiche, ricche di oli essenziali e diverse specie hanno usi officinali nella medicina tradizionale, come antibatterici, antivirali, antinfiammatori. Ad esempio, E. pendulifolia in Vietnam è utilizzata per curare febbri e raffreddori; E. rugulosa in Cina ha una lunga storia come pianta mellifera e come pianta officinale da cui si ricava un reputato tè di erbe usato per curare molteplici affezioni. Ma, per usare i termini di Elsholtz, oltre all'utilitas medicamentaria, a varie specie si aggiunge l'utilitas alimentaria: molte trovano impiego in cucina come erbe aromatiche; i semi di E. fruticosa sono utilizzati per aromatizzare il cibo e se ne ricava anche un olio alimentare. E non mancano altri usi: varie specie sono impiegate in profumeria e E. splendens, per la sua alta tolleranza al rame, in Cina viene piantata come pianta pioniera per bonificare i terreni contaminati delle miniere dismesse. Venendo poi al diletto, alcune specie sono coltivate per la bellezza della loro fioritura. La più notevole è indubbiamente E. stauntonii, un'alta erbacea perenne o un piccolo arbusto con belle foglie dentate e infiorescenze a spiga da rosa a viola pallido che si aprono dalla tarda estate all'autunno; come le sue consorelle, ha foglie aromatiche che ricordano la menta, ma con sentori agrumati e di cannella che possono essere usate per preparare una piacevole tisana o per aromatizzare piatti della cucina asiatica. Dopo tante lodi, una nota dolente. E. ciliata, un'erbacea annuale originaria della Cina e del Sud est asiatico (le sue foglie profumate di limone sono un ingrediente della cucina vietnamita), è stata introdotta come officinale e pianta da giardino in vari paesi europei e negli Stati Uniti; poiché produce molti semi e ha un alto tasso di germinazione, può formare rapidamente estese popolazioni a danno delle specie autoctone, soprattutto in aree disturbate. Per questo è stata inclusa in liste di piante potenzialmente invasive e il Connecticut ne ha proibito la coltivazione, la vendita e la diffusione. In Italia, dove potrebbe essere stata introdotta come specie officinale usata in erboristera, è stata segnalata la prima volta in Friuli Venezia Giulia nel 1991; in Lombardia è stata osservata a partire dal 2002 ed è considerata naturalizzata in incolti ruderali; non è inclusa in nessuna lista e il suo impatto sulla flora autoctona è considerato irrilevante. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed