|
In un articolo pubblicato qualche anno fa, Paolo Pejrone ha definito Beaumontia grandiflora "una dominatrice come la Lady che per prima la coltivò". Il riferimento è a Diana Wentworth Beaumont che, anche se si atteggiava a gran dama, non era affatto una lady; anche il fatto che fosse una dominatrice non è per nulla certo. Vicini malevoli ce ne hanno consegnato un ritratto caricaturale che forse è solo il frutto di risentimenti e pregiudizi sociali; anche se il personaggio era indubbiamente sopra le righe, le testimonianze di Loudon, Wallich e del giardiniere Marnock vanno in senso totalmente diverso. Certo amava la grandiosità e l'ostentazione, e lo dimostra anche la sua maggiore realizzazione come "donna di piante": la spettacolare serra tropicale a cupola, la più grande del suo tempo. Poco dopo la sua morte fu smantellata e la conosciamo solo da qualche disegno.  Una discutibile leggenda nera Oggi è quasi dimenticato, ma al momento della sua uscita nel 1826 il romanzo satirico Almack's ebbe un certo successo. Prendeva infatti di mira una delle istituzioni dell'età della reggenza, Almack’s Assembly Rooms, che fu uno dei primissimi club ad ammettere sia uomini sia donne e divenne uno dei luoghi di ritrovo più prestigiosi ed esclusivi della capitale, con i suoi balli del mercoledì cui si poteva accedere solo dietro invito, a insindacabile giudizio delle patronesse, un gruppo di dame dell'alta società. Tra i personaggi figura una certa Lady Birmingham, descritta come una donna di bassa nascita, volgare e piena di pretese, che ostenta le sue ricchzze e i suoi diamanti. E' orgogliosisima del suo giardino; in una scena, a proposito delle piante americane della sua residenza di campagna, si vanta così: "Lee e Kennedy mi hanno detto che ho la collezione più bella dell'intero regno. Sono sicura che ben poche persone ne hanno così tante come me [...]. Al momento sono impegnatissima con gli arbusti, sto ampliando i miei impianti americani e sto creando un nuovo roseto; ne ho 180 nuove varietà". Dietro questo ritratto velenoso, i contemporanei riconoscevano facilmente una persona reale: Diana Wentworth Beaumont (1765–1831). Il romanzo fu pubblicato anonimo, ma era ben noto che l'autrice era Marianne Spencer-Stanhope Hudson. Gli Spencer-Stanhope erano vicini di casa dei Wentworth nello Yorkshire e, mentre i membri la vecchia generazione, rappresentata da sir Thomas Wentworth (1726-1792) di Bretton Hall e John Spencer di Cannon Hall, erano grandi amici, i giovani Spencer-Stanhope non perdevano occasione per prendere in giro la figlia maggiore ed erede Diana e le sue arie da gran dama e tra di loro la chiamavano sarcasticamente Madame Beaumont. Un'altra delle Spencer-Stanhope, Mrs Pickering, nata Anna Maria Wilhelmia Spencer-Stanhope, nelle sue memorie descrisse la giovane Diana come una serva di cucina che vendeva le uova al mercato di Pensitone; bambina al momento della morte di lei, doveva aver raccolto questa diceria dalla bocca di qualcuno dei suoi parenti. Si trattava certamente di una grossolana calunnia, che però in qualche modo rifletteva la nascita irregolare di Diana Wentworth. Suo padre, sir Thomas Wentworth, era stato uno scapolo impenitente e libertino che aveva sempre rifiutato di sposarsi, benché avesse avuto numerosi figli illegittimi da varie amanti. Un figlio e tre figlie, nate tra il 1765 e i 1775, di cui Diana era la maggiore, vennero riconosciuti e le ragazze, anziché servire in cucina, ebbero un'ottima educazione in collegi femminili. Sorprendentemente, nel suo ultimo testamento, scritto poche settimane prima della morte, sir Thomas, tranne un piccolo lascito e una rendita annuale, diseredò il maschio, lasciò cospicui lasciti alle figlie minori e le terre e il grosso del patrimonio a Diana. Non conosciamo il motivo di questa decisione controcorrente; Karen Lynch ipotizza che non ci fossero migliori mani di quelle di lei cui affidare l'amatissimo Bretton Hall; in effetti, una clausola del testamento stabiliva che la casa doveva continuare ad essere abitata dalla famiglia e che essa e i giardini dovevano essere mantenuti in perfetto ordine. Sir Thomas è stato descritto come un personaggio eccentrico i cui unici interessi dichiarati erano la caccia, i cavalli, le bevute, le donne e la tenuta di Bretton Hall; erede per parte materna della famiglia Blackett, proprietaria di miniere di carbone e piombo presso Durham, aveva investito grosse somme per rimodellare il parco. Inizialmente si affidò all'architetto Richard Woods, che creò un lago artificiale interrompendo il corso del fiume Dearne con una diga. Dopo il crollo della diga in seguito a una piena, preferì fare da solo "senza ricorrre a Capability [Brown] o a simili pretenziosi bricconi"; qualche anno dopo, volle un secondo lago "grande abbastanza per Giona e la sua balena". Nel parco, percorso da piacevoli viali, fece piantare molti alberi e creò diversi edifici di gusto gotico; uno degli isolotti ospitava addirittura un piccolo zoo. Diana condivideva con il padre l'amore per le piante e la natura, e probabilmente ne aveva ereditato anche l'eccentricità, la testardaggine e il gusto per l'eccesso. Nel 1786, a circa 20 anni, sposò un proprietario terriero dello Yorkshire di modesta fortuna, Thomas Richard Beaumont; nel 1792, dopo la morte di sir Thomas, la coppia fece di Bretton Hall la sua residenza principale, anche se soggiornava spesso anche a Hexam Abbey e in altre proprietà e durante la stagione mondana viveva a Londra. Grazie alle proprietà ereditate dal padre nello Yorkshire e nel Northumberland, Diana Wentworth Beaumont era già molto ricca; intelligente e dotata di un grande senso degli affari, durante la sua gestione raddoppiò il patrimonio, tanto che al momento della morte era considerata la commoner più ricca del paese. Il marito, che i contemporanei descrivono come una "testa debole" succube della moglie, forse era semplicemente abbastanza intelligente da delegare l'amministrazione a Diana, molto più abile di lui, che per altro spesso era lontano da casa come militare; tra il 1794 e il 1803 fu infatti colonnello di un reggimento di cavalleria. Thomas Richard intraprese anche una carriera politica; fu deputato per il Northumberland ininterrottamente dal 1795 al 1818. Era schierato con i Tory e con il governo e in questo lungo periodo non è noto che abbia preso la parola nemmeno una volta. La sua massima aspirazione - sicuramente condivisa dalla moglie - era ottenere un titolo nobiliare; corteggiava regolarmente il primo ministro di turno nella speranza di una baronia, ma nessun ministro gliela concesse mai, sicuro di avere comunque il suo voto. Il titolo non c'era, ma tanto nelle tenute di campagna quanto a Londra, i Beaumont vivevano in modo assai sfarzoso, secondo lo stile degli aristocratici; ma poiché non lo erano, suscitavano il riso di quella società intrisa di pregiudizi sociali. Gli Spencer-Stanhope si sbellicavano quando vedevano "Madame Beaumont" attraversare il villaggio con una carrozza trainata da due pariglie di cavalli neri e guidata da postiglioni in livrea di velluto; Lady Aynsley arricciva il naso ascoltandola vantare le rendite delle sue miniere di piombo. Certamente Diana era una donna imperiosa, tenace nel perseguire i suoi obiettivi, che aveva fama di litigare con tutti, compreso il figlio maggiore. Eppure, se ascoltiamo altre campane. il ritratto muta colore: non più una "dominatrice" soffocante, come l'ha definita anche Paolo Peirone, ma un'amministratrice puntuale, precisa e attenta ai bisogni e alla dignità dei suoi dipendenti. L'architetto paesaggista John Claudius Loudon. che visitò più volte Bretton Hall, ha scritto di lei: "Nessuna signora è stata una padrona più liberale e sollecita verso i suoi dipendenti, né una migliore proprietaria terriera rispetto ai suoi affittuari"; il ritratto tracciato dal capo giardiniere Robert Marnock - scritto vari anni dopo la morte di lei e quindi senza alcuna piaggeria interessata - è addirittura un peana: "Mrs Beaumont per la sua consuetudine con gli affari e l'ordine possedeva una mente dal potere gigantesco. Quando lavoravo come giardinere, mi dava spesso appuntamento presso un determinato albero, a un'ora e un minuto specifico e, sebbene questi appuntamenti fossero frequenti e a volte fissati una settimana o dieci giorni in anticipio, non ricordo una singola occasione in cui abbia mancato di presentarsi all'esatto minuto fissato; la sua puntualità e precisione non erano riservati alla sistemazione del giardino ma emergevano nella sua condotta nell'intera tenuta. Era un esempio ammirevole per i domestici, che dovrebbe essere seguito da padrone e padroni dei nostri giorni. Non si permise mai di entrare nell'orto durante l'orario di lavoro senza aver prima suonato la campana del giardino [...]. Proprio perché era così scrupolosa ed esatta nel disbrigo dei suoi affari, riusciva a trovare il tempo di dedicarsi al giardino e alla botanica, e all'occasione patrocinare meriti altrimenti senza sostegno". 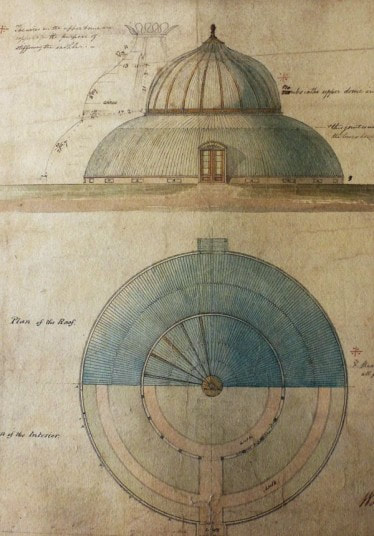 Un giardino senza rivali E' ora dunque di parlare di Mrs Beaumont come giardiniera e collezionista. La sua passione si esercitò soprattutto nel giardino di Bretton Hall che ereditò dal padre nel 1792 e continuò ad abbellire con interventi costanti per quarant'anni. Questi lavori, che non sembrano obbedire a un progetto coerente, ma piuttosto alle necessità e all'estro del momento, furono affidati di volta in volta ad architetti sempre diversi (che Diana litigasse con tutti non era forse così infondato). Il primo fu John Carr che già nel 1793 fu incaricato di ristrutturare la sala da pranzo e la biblioteca; nel 1803 un certo Mr Mickle disegnò le ringhiere del parco; nel 1804 un altro noto architetto, Willian Atkinson, disegnò un'aranciera, un museo per le collezioni naturalistiche, una latteria e l'Archway Lodge, una sorta di ingresso monumentale fiancheggiato da colonne con un arco abbastanza ampio da consetire l'ingresso di una carrozza. Fu poi la volta di William Lindley, cui si devono nuove cucine, la scuderia e una grotta con conchiglie; nel 1811 Jeffry Wyatt disegnò una voliera, alcuni cottage e la serra delle camelie che è uno dei pochi manufatti dell'epoca di Diana oggi conservato. Destinata ad ospitare la collezione di piante semirutiche provenienti dall'Asia, è un luminoso edifico in pietra ma con grandi finestre ad arco e un tetto in vetro e ghisa. I Beaumont ricevevano spesso (Mary Russell Mitford che fu loro ospite nel 1806 ricorda che ai loro pranzi partecipavano trenta o quaranta persone); si prestava dunque grande attenzione all'orto e al frutteto che dovevano provvedere una quantità sufficiente di verdure e frutti per la tavola della famiglia, del personale e degli ospiti. Fino al 1825 a occuparsene fu Christie Duff, rinomato per la coltivazione dei mirtilli rossi, del crescione, dei peschi a spalliera e la moltiplicazione dei rizomi di zenzero. Quando questi si licenziò, venne assunto come "caposquadra dell'orto" il già citato Robert Marnock (1800-1889) che quattro anni dopo sarebbe stato promosso capo giardiniere. I suoi ricordi, scritti una ventina di anni dopo, quando Marnock dirigeva l'orto botanico di Sheffield ed era una delle figure di punta del movimento Gardenesque, fanno rivivere i giardini di Bretton Hall negli anni d'oro: "Circa vent'anni fa, quando lo vidi la prima volta. Bretton Hall non aveva rivali per i suoi giardini, tanto per l'estensione quanto per la varietà. La forzatura di uva, ananas, pesche, fichi ecc. era praticata estesamente; c'era anche un'estesa collezione di piante da serra fredda e calda, un assortimento di piante erbacee rustiche che occupavano un'area circolare di non meno di tre acri, con le piante sistemate secondo il sistema di Linneo. Oltre a tutto questo, c'era un orto murato di sei o otto acri per la coltivazione delle verdure e la produzione di frutti rustici. All'epoca alla quale mi riferisco, c'erano sei grandi serre per la forzatura di pesche e nettarine; due vigne protette; una serra per i fichi; nove serre riscaldate per gli ananas con innumerevoli buche; due grandi aranciere e altrettante serre riscaldate. Infine un'immensa serra eretta dai Bailey di Holborn con una spesa 8.000 o 10.000 £, riscaldata con un complicato e costoso apparecchio a vapore". Siamo così arrivati alla celebre serra di Bretton Hall. Iniziata nel 1826, ma non completata fino al 1829 - non senza una causa legale che contrappose i coniugi Beaumont alla ditta londinese Bailey - era un edificio avveniristico, interamente costruito in vetro e ghisa; circolare, con un diametro di circa 18 metri, aveva un'alta volta a cupola, che raggiungeva l'altezza massima di circa 14 metri. Poco dopo il completamento della serra, il colonnello morì e la moglie lo seguì poco più di due anni dopo, nell'agosto del 1831. Il figlio ed erede, Thomas Wentworth Beaumont, in rotta con la madre che, dopo la sua maggiore età, aveva rifiutato di anticipargli l'eredità e aveva mantenuto il pieno controllo dei propri beni, non partecipò al funerale e si afffrettò a vendere all'asta tutto ciò che le ricordava la madre, di cui (lui educato a Eton e Cambridge) disapprovava gli eccessi. Almeno, questa è la versione che circolò. Forse, più prosaicamente, benché divenuto a sua volta il commoner più ricco del regno, aveva bisogno di liquidità per saldare i fornitori e i debiti in sospeso, e soprattutto per versare i cospicui lasciti testamentari che la madre aveva diposto per i figli e le figlie minori, dimostrando ancora una volta la sua indipendenza di pensiero. Tra i beni alienati, anche la serra circolare che fu svenduta a un fabbricante di birra, più interessato al sistema di riscaldamento che all'edificio in sè, che fu totalmente smantellato. Ne rimane solo qualche disegno.  Un'amicizia botanica e uno scambio intercontinentale Sia Marnock sia Loudon lamentarono che i vari interventi nel parco di Bretton Hall si erano succeduti senza un disegno unificante; in effetti, più che al parco in sè, Mrs Beaumont era interessata alla sua collezione di piante rare, per la quale aveva fatto costruire successivamente la grande aranciera vetrata e la serra circolare. Al contrario del suo doppio letterario, lady Birmingham, non raccoglieva piante americane, ma soprattutto asiatiche che le furono spedite con una certa frequenza da Nathaniel Wallich a partire dal 1815. Mrs Beaumont era interessata alle scienze naturali (abbiamo visto che aveva allestito un piccolo museo, con una collezione soprattutto di minerali, e che in una parte del suo giardino le piante erano sistemate in modo sistematico, come in un orto botanico); era abbonata alle Transactions della Linnean Society alla quale inviava regolarmente esemplari delle sue piante più rare. In tal modo era entrata in contatto con Smith, Lambert e Banks. Permetteva anche agli artisti botanici di frequentare il suo giardino per ritrarre le piante dal vivo. In tal modo si era fatta una certa fama di protettrice della botanica. Nathaniel Wallich che - ricordiamolo - era suddito danese e per questa ragione era stato anche imprigionato come cittadino di una potenza ostile - nel 1815 era entrato al servizio della Compagnia delle Indie e cercava un patrono influente. Ovviamente aveva pensato a Banks e si era messo in contatto con lui attraverso Thomas Hardwicke, suo amico e membro dell'Asiatic Society. Hardwicke gli suggerì di rivolgersi anche a Mrs Beaumont che, come moglie di un membro della Camera dei Comuni e proprietaria di estesi giardini, avrebbe potuto a sua volte offrire una via d'accesso a Banks, Lambert e i vertici della Compagnia delle Indie. Così Wallich nel dicembre 1815 le scrisse e le spedì piante vive e semi. Fu l'inizio di uno scambio botanico nelle due direzioni; confermandosi una donna concreta, sollecita e cortese, Diana non si accontentò di ringraziare ma ricambiò il dono, scrivendo: "Quest'autunno chiederò al mio giardiniere di raccogliere tutti i semi che egli riterrà accettabili per voi, per l'orto botanico di Calcutta; ne ho parlato ai direttori della Compagnia, chiedendo che vi vengano spediti. Ciò mi ha dato l'opportunità di menzionare i vostri propositi e di sostenerli con le mie più forti raccomandazioni, come ho fatto con sir Joseph Banks e Mr Lambert, e ho ogni ragione di sperare che se ne cureranno". Da quel momento Mrs Beaumont per Wallich divenne un punto di riferimento, una protettrice e un'amica. Dello scambio si arricchirono tanto Bretton Hall quanto l'orto botanico di Calcutta - anche se non sappiamo di quali piante; l'unico campione dell'erbario di Wallich indicato come "Beaumont" e proveniente da Bretton Hall è la leguminosa Senna multijuga, nativa del Messico e dell'America subtropicale. Wallich provvide Bretton Hall di molte piante raccolte in varie parti dell'India e in Nepal, e proprio per accoglierle al meglio Mrs Beaumont fece costruire la grande serra a cupola. Tra le piante introdotte da Mrs Beaumont attraverso Wallich e coltivate per la prima volta a Bretton Hall, possiamo citare Wallichia caryotoides, Callianthe striata, Garcinia dulcis, Clerodendrum nutans, Hovwa pannosa, Tupistra nutans, Tetracera sarmentosa. Senza dimenticare Beaumontia grandiflora, su cui torneremo tra poco, e lo splendido Rhododendron arboreum, di cui Mrs Beaumont aveva trasmesso i semi al vivaio di piante esotiche di Joseph Knight. In effetti, Diana fu utile a Wallich anche mettendolo in contatto con vivai che potevano essere interessati a commercializzare le sue piante. Nel 1829, qundo venne in Inghilterra, visitò Mrs Beaumont a Bretton Hall e visitò con lei proprio il vivaio di Knight. Eccoci dunque giunti a Beaumontia, il piccolo genere di rampicanti dell'Asia tropicale dedicato alla amica e protettrice nel 1824 con questa motivazione: "L'ho nominato in onore della Sig.a Diana Beaumont, devotissima all'orticoltura e alla scienza botanica in Inghilterra e munifica fautrice di entrambe, alla cui benevolenza il giardino di Calcutta deve molte piante esotiche soprattutto europee". Beaumontia (famiglia Apocynaceae) comprende otto-dieci specie di rampicanti e liane nativi della Cina, del subcontinente indiano e del sudest asiatico. La specie più coltivata è B. grandiflora, un vigoroso rampicante sempreverde (anche se può perdere le foglie nella stagione secca) che produce un lussureggiante fogliame verde lucido e profumatissimi fiori bianchi campanulati raccolti in infiorescenze terminali. Resistendo per brevi periodi a temperature prossime allo 0, può essere coltivata anche in parte del nostro paese, in pieno sole e in posizione protetta, ma senza dimenticare che può raggiungere dimensioni ragguardevoli e richiede un supporto robusto.
0 Comments
Joséphine de Beauharnais, ovvero l'imperatrice Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, è nota per la passione per la botanica, che profuse nella creazione dello splendido parco del castello di Malmaison, successivamente residenza dei Bonaparte negli anni del consolato, poi casa di campagna e rifugio in quelli dell'impero, infine, dopo il divorzio, la sua casa, la sua consolazione, il luogo dove morì. Dotato di una serra calda all'avanguardia, fu funzionale all'introduzione in Francia di quasi duecento specie esotiche, soprattutto australiane. Per tutti, Joséphine è anche l'imperatrice delle rose, che certamente amava, ma probabilmente non di quell'amore esclusivo che le attribuisce il mito. A ricordarla contribuisce anche la splendida e capricciosa Lapageria (dal suo nome da ragazza, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie). Un parco all'inglese Il noto motto latino nomen omen, "nel nome c'è il destino", almeno a Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (1763-1814) parrebbe calzare. Fino a quando Napoleone Bonaparte la ribattezzò con il nome con cui è passata alla storia, per tutti fu Rose, un nome che preannunciava l'importanza che nella sua vita ebbero le piante, comprese le rose. Quando si incontarono per la prima volta in un salotto parigino, lei era Mme Rose de Beauharnais. Lui aveva 26 anni, lei 32, e aveva già alle spalle una vita tumultuosa e molto chiacchierata. Era nata in Martinica nella piantagione di una famiglia nobile ma impoverita; poi, ad appena 16 anni, erano arrivati il matrimonio con un nobile dissipatore e femminiere, prima dei vent'anni un figlio e una figlia, quindi la separazione, il carcere durante il terrore, la vedovanza in seguito all'esecuzione del marito Alexandre de Beauharnais. E debiti, tanti debiti, e amanti veri o presunti. L'ultimo, quello in carica al momento, si diceva fosse Paul Barras, uno dei cinque direttori. Che, secondo una delle varie versioni, sarebbe anche colui che presentò ufficialmente la bella vedova a Napoleone, che aveva appena nominato generale per essersi distinto nella repressione di un'insurrezione monarchica. Fu l'inizio di un amore appassionato da parte di lui - un po' meno da parte di lei - che sfociò nel matrimonio il 9 marzo 1796, due giorni prima che Bonaparte partisse per la Campagna d'Italia. Rose non era più Rose, ma Joséphine, come Napoleone l'aveva ribattezzata a partire dal suo secondo nome, forse per rifarla propria e cancellare quel passato tanto chiacchierato. E mentre Napoleone diventava Napoleone, Joséphine aveva finalmente un giardino. Nell'aprile 1799, mentre il marito era impegnato nella Campagna d'Egitto, ricorrendo a un prestito - era abituata a fare debiti - acquistò per 325.00 franchi il castello e la tenuta di Malmaison, a una dozzina di km da Parigi. Al suo ritorno Bonaparte andò su tutte le furie per quella spesa folle, ma, dopo il colpo di stato del 18 brumaio che lo rese padrone della Francia, si addossò il debito, forse attingendo al denaro predato in Italia ed estese addirittura il parco dagli iniziali 60 a 260 ettari. Anche per lui, Malmaison divenne la casa del cuore e per tutto il consolato ne fece la propria residenza; tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuilerie, fu addirittura la sede del governo. Joséphine era decisa a trasformare la tenuta "nel giardino più bello e curioso d'Europa, un modello di buona coltivazione". Inizialmente i lavori vennero affidati agli architetti Percier e Fontaine, che, oltre a restaurare il castello (loro avrebbero voluto abbatterlo e ricostruirlo, ma Napoleone optò per una più economica ristrutturazione), nel 1801 incominciano a recintare il parco, costruirono strutture di servizio come stalle per i cavalli e padiglioni di guardia, eressero il cancello principale e, per le piante di Joséphine, una orangerie riscaldata in grado di produrre 300 piante di ananas. Tuttavia presto emersero contrasti con Mme Bonaparte, che considerava il loro gusto in fatto di giardini troppo classico; desiderava un giardino all'inglese di gusto romantico e paesaggistico. Si rivolse così ai due guru del giardino all'inglese in Francia, lo scozzese Thomas Blaikie, che aveva disegnato il giardino di Bagatelle per il conte d'Artois, e Jean-Marie Morel, autore dell'influente Théorie des Jardin (1777). Morel costruì uno chalet svizzero, una stalla per le mucche, una latteria e una casa per i vaccari fatti venire dalla Svizzera e iniziò la costruzione della serra riscaldata (Grande serre chaude), completata nel 1805 da Thibault e Vignon. Costruita secondo i criteri più avanzati dell'epoca, era la prima in Francia a prevedere una così ampia superficie in vetro; lunga circa 50 metri e larga 19, era riscaldata da 12 stufe e poteva ospitare piante alte fino a 5 metri. La serra era addossata a un elegantissimo padiglione con una serie di salotti e una rotonda centrale raffinatamente arredati in cui era possibile riposarsi, intrattenersi ed ammirare piante rare e una collezione di vasi greci. Neppure Morel soddisfaceva del tutto il gusto romantico della ormai imperatrice (fu incoronata dallo stesso marito e congiuntamente a lui il 2 dicembre 1804); alla fine del 1805 gli subentrò Louis-Martin Berthault, in cui Joséphine trovò quasi un'anima gemella che l'avrebbe servita fino alla morte. Egli costruì una nuova galleria per ospitare le collezioni d'arte e a partire dal 1807 ridisegnò completamente il parco, creando un parco chiuso di 70 ettari perfettamente integrato nel paesaggio, con gli alberi disposti in modo da permettere allo sguardo di spaziare su monumenti già esistenti come l'acquedotto di Marly o il castello di Saint Germain. Berthault disegnò sentieri serpeggianti, fece scavare un corso d'acqua sinuoso che si allargava a formare un laghetto e disseminò il parco di edifici di gusto romantico: il Tempio dell'amore, il tumulo funerario della Malinconia, una grotta con rocce fatte venire da Fontainbleau. Tutte cose che facevano impazzire l'imperatrice, ma non l'imperatore, che le definiva sprezzantemente niaiseries "stupidaggini", e volle per sè un angolo di gusto più classico. Per ospitare gli animali giunti dall'Australia - li ritroveremo tra poco - c'erano una voliera e uno zoo; alla fattoria si aggiuns un allevamento modello di pecore merino. 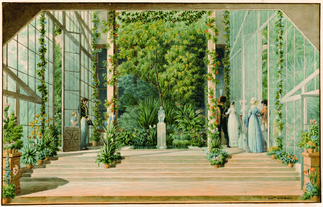 Le piante e gli uomini di Malmaison Fin dall'acquisto di Malmaison, Joshéphine era intenzionata a popolarne il parco e le serre con una collezione unica di piante esotiche. In primo luogo, forse già dalla primavera del 1800, si rivolse a André Thouin, il capo giardiniere del Jardins des Plantes che, oltre ad essere il massimo esperto di acclimatazione di esotiche in terra di Francia, negli anni aveva costruito un'immensa rete di corrispondenti che includeva botanici, giardinieri, vivaisti e collezionisti sia nel paese sia all'estero. In una lettera dell'agosto 1800, firmata Lapagerie Bonaparte, la futura imperatrice lo ringrazia per l'invio di frutti di fico-banana (Ficus pleurocarpa) che "mi hanno ricordato il paese natale e mi hanno dimostrato che siete capace di trionfare di ogni clima e di portare ogni cosa a perfezione". Scrisse anche alla madre, che continuava a vivere in Martinica; in una lettera del 1802 leggiamo: "Mandatemi tutti i semi d'America e tutti i frutti: batate, babane, aranci, manghi, infine tutto ciò che potrete". Thouin la mise in contatto con Jacques Martin Cels (1740-1806), un collezionista che, rovinato dalla rivoluzione, aveva trasformato la sua passione in professione, aprendo a Montrouge, nella periferia sud di Parigi, un vivaio in cui coltivava soprattutto piante americane introdotte da André Michaux. Il suo lavoro fu continuato dal figlio François (1771-1832) che allargò il vivaio e si specializzò nella coltivazione di esotiche ornamentali; nel suo catalogo del 1817 troviamo, accanto alle americane, anche molte sudafricane, dalie, e una notevole collezione di rose, circa 200 varietà, principalmente Gallica. Sicuramente il vivaio Cels fu uno dei principali fornitori di Malmaison, anche per le rose (ma su questo tornerò più avanti), insieme a quello di un altro contatto di Thouin, Louis Claude Noisette (1772-1849). Figlio di un giardiniere del conte di Provenza, intorno al 1798 aveva aperto un vivaio dove coltivava soprattutto piante americane, ottenute attraverso uno dei suoi fratelli, Philippe Stanislas, che viveva a Charleston. Uno dei suoi invii è Old Blush Noisette, la prima delle rose Noisette; ma giunse in Francia nel 1814, troppo tardi per essere coltivata a Malmaison. Joséphine ottenne molte piante dal Jardin des Plantes, e molto lo acquistò dai vivai, spendendo somme folli; è del marzo 1804 una consegna di 2014 tra erbacee, alberi e arbusti. Seppe inoltre approfittare del potere del marito; piante le giunsero dai botanici che accompagnarono Napoleone in Egitto e durante le campagne napoleoniche; in Italia come a Vienna, piante furono requisite dai giardini degli sconfitti per essere inviate a Malmaison. L'imperatore sollecitava diplomatici, ufficiali di marina e funzionari ad approfittare di ogni occasione per soddisfare la passione botanica della moglie e Joséphine stessa faceva pressione su ministri, dignitari, agenti francesi all'estero. Ad arricchirne il parco e le serre di piante in precedenza mai viste in Europa fu però soprattutto la sventurata spedizione Baudin, sponsorizzata da Napoleone primo console, ed in particolare il ricco carico del Géographe, che raggiunse Lorient nel marzo 1804. Napoleone aveva ordinato che il giardino di Malmaison avesse la precedenza sul Jardin des Plantes e quando Thouin ispezionò il carico, scoprì di essere già stato preceduto da Mirbel, il sovrintendente di Malmaison; così, delle 230 piante sopravvissute al tumultuoso viaggio, le 98 più sane presero direttamente la strada delle serre di Joséphine. Insieme a loro viaggiavano anche canguri, emù e una coppia di cigni neri, che divennero quasi un simbolo del giardino dell'imperatrice. Da quel momento, d'un colpo le serre di Malmaison ospitarono la più importante collezione europea di piante australiane, più ricca di quella degli stessi Kew Gardens. Per altro, le piante inglesi o importate dai britannici non mancavano. Come ho già raccontato parlando del vivaio Lee & Kennedy, a partire dal 1803 The Vineyard divenne il maggiore fornitore dei giardini dell'imperatrice; grazie alla compiacenza di Banks, con il quale Joséphine era in contatto attraverso il botanico Etienne Ventenat, ottenne anche alcune piante di Kew e soprattutto un passaporto che permise a Kennedy di continuare a fare la spola tra Francia e Inghilterra con i suoi carichi di piante nonostante lo stato di guerra e il blocco continentale. Con Kennedy, Joséphine creò addirittura un consorzio per inviare in Sudafrica il cacciatore di piante James Niven. Joséphine seppe anche circondarsi di personale molto qualificato. Nel 1801 ingaggiò un giardiniere scozzese, Alexander Howatson; in tempo di guerra, avere un dipendente britannico spiaceva assai a Napoleone, che nel 1805 approfittò del conto troppo salato di un trasporto di piante per licenziarlo. Egli fu così sostituito da Felix Delahaye, che era stato il giadiniere della spedizione Entrecasteaux, durante la quale aveva fatto estese raccolte; aveva poi lavorato per un certo periodo nel giardino di Pamplemousses a Mauritius e dopo il ritorno in Francia aveva restaurato i giardini del Trainon e il vecchio giardino di Maria Antonietta a Versailles. Era dunque un esperto di coltivazione di esotiche e, soprattutto, era forse l'unico giardiniere europeo ad avere visto le piante australiane in natura e molte le aveva raccolte lui stesso. Abbiamo già incontrato di passaggio due dei botanici che lavorarono per Joséphine a Malmaison, Mirbel e Ventenat. Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854) ad appena vent'anni era diventato assistente naturalista al Muséum ed era un promettente scienziato, destinato a diventare il padre fondatore della citologia; nel 1803 Mme Bonaparte lo assunse come sovrintendente di Malmaison, dove poté continuare i suoi studi sui tessuti vegetali, l'evoluzione degli organi delle piante e le epatiche del genere Marchantia. Nel 1806 però egli lasciò Malmaison per entrare al servizio del re d'Olanda Luigi Bonaparte, che oltre ad essere fratello di Napoleone, era anche genero di Joséphine in quanto marito di sua figlia Hortense Beauharnais. A sostituirlo fu Etienne Pierre Ventenat (1757-1808). Fratello di Louis Ventenat, cappellano e naturalista morto durante la spedizione Entrecasteaux, era entrato nell'orbita dell'imperatrice grazie a Cels. Allievo e collaboratore di L'Héritier de Brutelle, in gioventù si era segnalato per la traduzione in francese di Genera plantarum di Antoine Laurent de Jussieu, poi, come il suo maestro, aveva focalizzato la sua attenzione sulla pubblicazione di piante nuove per la scienza. Nel 1799 pubblicò Descriptions des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels, illustrato da 100 tavole in gran parte dovute ai fratelli Pierre-Joseph e Henri-Joseph Redouté. La raffinatezza di quest'opera attirò l'attenzione di Joséphine che volle qualcosa di simile per far conoscere al mondo le proprie collezioni di cui era estremamente fiera. Commissionò così a Ventenat i testi e Pierre-Joseph le illustrazioni del magnifico Jardin de Malmaison; in due tomi, usciti in 20 fascicoli tra l'aprile 1803 e il novembre 1805, comprendo 120 calcografie a colori incise da Allain a partire da acquarelli di Redouté e la descrizione di 161 specie, molte delle quali nuove per la scienza, scritta da Ventenat. Come ho anticipato, nel 1806 Ventenat fu nominato intendente e prese così sul serio l'incarico da morire, esausto di fatica, appena due anni dopo. A succedergli fu Aimé Bonpland, che era stato compagno di Humboldt nel suo viaggio sudamericano. Egli curò tra l'altro i testi di Descriptions des Plantes Rares Cultivées à la Malmaison (1812-1817), anch'esso illustrato da Redouté. Anche questo grande artista, soprannominato il "Raffaello dei fiori", può essere annoverato tra gli uomini di Joséphine. Oltre alle due opere già citate, i fiori di Malmaison ispirarono il suo capolavoro, Les Liliacées; pubblicato in 8 volumi di grande formato, usciti tra il 1802 e il 1816, comprende 486 incisioni a colori di altrettante specie di bulbose e monocotiledoni (non solo Liliaceae in senso stretto). Joséphine riuscì a convincere il ministro dell'interno Chaptal ad acquistarne 80 copie che furono distribuite tra dignitari e biblioteche in tutto il paese e all'estero. L'altro libro più noto di Redouté, Les Roses (1817-1824) fu creato dopo la morte dell'Imperatrice e ritrae rose coltivate in vari giardini francesi, non solo a Malmaison. Furono invece commissionate da Joséphine intorno al 1812 al pittore Auguste Garneray le 12 vedute del parco e della serra, oggi un documento inestimabile per ricostruirne l'aspetto. Essi infatti non sopravvissero a lungo alla loro creatrice, Nel 1809, essendo chiaro che, per la sua età, Joséphine non gli avrebbe mai dato un erede, Napoleone si decise a chiedere l'annullamento del matrimonio, sancito nel gennaio 1810. Fu però generoso con la ex moglie, con cui mantenne rapporti cordiali: essa conservò il titolo di imperatrice, cui si aggiunse quello di duchessa di Navarre (dal castello in Normandia che le donò dopo il divorzio, un po' per compensarla, un po' per tenerla lontana da Parigi mentre si celebrava il suo matrimonio con Maria Luigia d'Asbrugo), ottenne la piena proprietà di Malmaison e una pensione di 5 milioni di franchi. Mentre si completavano i lavori di adattamento per ospitare la sua piccola corte di quasi 200 persone, Joséphine visse a Navarre, poi tornò a Malmaison, che continuò ad accrescere ed abbellire fino alla morte. Il 29 maggio 1814 vi morì di polmonite. Si dice l'avesse contratta passeggiando nel parco con lo zar Alessandro, che avrebbe implorato di permetterle di unirsi al marito nell'esilio all'Elba. Quando Napoleone seppe della sua morte, si chiuse per due giorni nella sua camera; dopo la disfatta di Waterloo, prima di consegnarsi agli inglesi, risiedette a Malmaison che, però, senza la sua Joséphine, non era più la stessa. Poi iniziò la decadenza. L'imperatrice aveva lasciato debiti imponenti, riscaldare la serra era troppo costoso e le piante esotiche, abbandonate a se stesse, morirono; la casa e il giardino furono saccheggiati e vandalizzati; la proprietà fu parcellizzata e messa in vendita. Dopo diverse vicissitudini, nel 1903 il castello e il parco, ridotto a 6 ettari, passarono allo stato e divennero un museo. 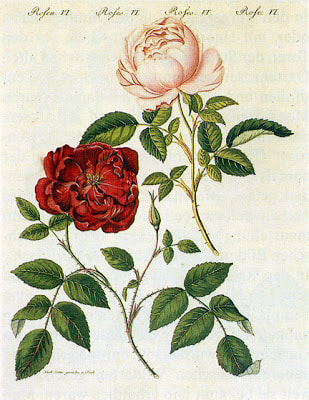 E finalmente... le rose Il parco di Malmaison non era un orto botanico, con le piante disposte in modo sistematico, ma un giardino di piacere. Era anche un giardino sperimentale dove vennero acclimatate piante che poi avrebbero profondamentro modificato i giardini e il paesaggio francese. Secondo L'impératrice Joséphine et les sciences naturelles (catalogo della mostra tenutasi a Malmaison nel 1997), le piante che vi furono coltivate per la prima volta in Francia tra il 1804 e il 1814 ammontano a 184. La corrispondenza tra l'intendente Mirbel e il prefetto delle Alpi Marittime Marc Joseph Dubouchage attesta l'invio in Costa azzurra di numerose piante soprattutto australiane acclimatate a Malmaison; tra di esse, Casuarina equisetifolia, Phormium tenax, varie specie dei generi Eucalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, cui forse va aggiunta Acacia dealbata, la mimosa oggi onnipresente, che fiorì per la prima volta a Malmaison nel 1811. A fare da tramite all'introduzione di queste e altre specie esotiche nella Francia meridionale, il cui clima mite era considerato il più propizio all'acclimatazione di piante tropicali e subtropicali, fu il giardino di acclimatazione creato nel settembre 1801 nel recinto della Scuola centrale del dipartimento delle Alpi marittime a Nizza. E poi, naturalmente, c'è il capitolo rose. Ne ho già parlato in questo post, e qui mi limito a riassumere le informazioni principali. Secondo la vulgata erano le piante preferite di Joséphine che ne avrebbe fatte coltivare ben 250 varietà; molti si spingono anche a dire che, insoddisfatta delle rose europee non rifiorenti, avrebbe incoraggiato l'introduzione di rose cinesi e le ibridazioni che avrebbero portato alla nascita delle rose moderne. Altri parlano di migliaia di rose (peccato che nessuno delle persone che visitò quel giardino poco dopo la morte della imperatrice ne faccia parola e proprio le rose manchino le vedute di Garneray). In realtà, Joséphine era interessata in generale alle piante, specialmente esotiche, e non aveva una speciale predilezione per le rose; certamente a Malmaison non mancavano, ma non è neppure certo che ci fosse un roseto; molte delle piante più preziose erano infatti coltivate in vaso, ed esposte all'esterno al momento della fioritura. Purtroppo, mentre i cataloghi di Ventenat e Bompland documentano bene le esotiche coltivate nella serra e in giardino, non possediamo niente di simile per le rose. Come ho anticipato, Les roses di Redouté, che molti considerano un catalogo delle rose di Malmaison, fu scritto solo dopo la morte dell'imperatrice e ritrae le rose coltivate in vari giardini e vivai francesi che Redouté e Thory, l'autore dei testi, visitarono e citarono scrupolosamente; i giardini dp Malmaison sono ricordati solo per due rose, R. berberifolia e R. gallica. Questo equivoco è probabilmente all'origine della leggenda del roseto di Malmaison, nonchè dei vari pretesi elenchi delle rose che vi erano coltivate. Rimandando al post già citato per le specie sicuramente identificate, molte delle quali importate dall'Inghilterra attraverso Kennedy e altri vivai, vorrei qui aggiungere solo qualche informazione sui fornitori parigini. Presumibilmente il principale era André Dupont, che non fu mai un giardiniere di Malmaison come spesso si legge, anzi neppure un vivaista, ma un collezionista privato; prima della rivoluzione era il custode (e non il giardinere) del palazzo di Lussemburgo. Secondo il suo biografo V. Darkenne, incominciò a interessarsi di rose intorno al 1785, quando affittò un piccolo terreno dai monaci cerctosini nel pressi del Lussemburgo. Durante il Terrore fu imprigionato due volte e per quattro volte, per salvarla, dovette spostare la sua collezione di rose. Nel 1796, la sistemò nell'amgolo orientale del giardino del Lussemburgo, con le rose classificate per specie; nel 1801, la sua collezione (la chimava "éecole de roses"), di specie tanto native quanto esotiche, era la più completa d'Europa. Secondo la testimonianza di Antoine Laurent de Jussieu, Joséphine si rivolse a Dupont per chiedergli di rifornire di rose Malmaison ed egli accettò, come attestano le fatture (che purtroppo non indicano di quali vareità si trattasse). Darkenne stima che nel 1806 gliene abbia fornite da 200 a 500, presumibilmente più di un esemplare per varietà, visto che nel catalogo delle rose coltivate da Dupont nel 1813 (pubblicato da Thory nel 1819, Catalogo inedito Rosarum quas Andreas Du Pont in horto suo studiose colebat anno 1813) ne sono elencate 218. La collezione di Dupont comprendeva numerose rose botaniche europee, un'ampia selezione di alba, centifolia, damascena e soprattutto gallica (una sessatina, pochissime esotiche e qualche cinese, l'unica delle quali identificabile con certezza è la rosa di Macartney (R. bracteata, introdotta in Europa intorno al 1795). Dupont è considerato un pioniere dell'ibridazione artificiale delle rose e a volte gli viene attribuita la creazione di un numero impressionante di ibridi. In realtà nel catalogo compaiono solo 19 ibridi di gallica, non necessariamente tutti creati da lui. Come collezionista, riceveva rose da tutta Europa; come abbiamo visto in questo post, fu lui a introdurre la rosa Portland dall'Inghilterra; potremmo aggiungere 'Belle Sultane', che invece importò dall'Olanda. Gli ibridi di Gallica erano all'epoca le rose più alla moda ed è probabile che ce ne fossero parecchi tra quelle fornite all'imperatrice; lo stesso varrà anche per un altro probabile fornitore, Cels; il catalogo pubblicato da Cels figlio nel 1817 (Catalogue des arbres, arbustes, et autre plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre) offre circa 170 varietà di rose; una buona percentuale sono ibridi recenti dai nomi evocativi ('Belle sans flatterie', 'Panachée admirable'. 'Roi des pourpres') di cui si è per lo più persa ogni traccia. Ovviamente non ne conosciamo il pedigree; è invece giunta fino a noi R. celsiana (nel catalogo figura come grande Cels), un vigoroso ibrido di damascena. Abbiamo già visto che a Malmaison non potevano esserci rose Noisette, essendo la prima giunta in Francia dopo la morte dell'imperatrice. E lo stesso vale per le rose Boursault. Jean-François Boursault detto Malherbe era un ex attore che con la rivoluzione si era dato alla politica e agli affari, accumulando una grande ricchezza che investì tra l'altro in uno splendido giardino con tanto di serre calde. Forse potrebbe aver ceduto a Joséphine una talea della cinese Rosa multiflora carnea, che fu il primo a introdurre in Francia nel 1808, ma non Rosa banksiae 'Alba plena', giuntagli nel 1817, nè il primo ibrido Boursault, ottenuto nel 1818 incrociando R. pendulina non con una cinese, come si è creduto a lungo, ma con la nordamericana R. blanda. Quali e quante fossero le rose coltivate a Malmaison, in assenza di documenti, non lo sapremo mai. Ma anche se il roseto di Joséphine fosse un mito, da più di un secolo è diventato realtà. Nel 1911, dopo che quanto rimaneva del parco era stato donato allo stato, il compito di ri-crearlo venne affidato a Jules Graveraux, il creatore della Roseraie de L'Haÿ; egli, consultando i cataloghi dell'epoca, individuò 197 specie e cultivar disponibili ai tempi dell'imperatrice e ne fece dono al giardino; il suo elenco comprendeva 107 galliche, 27 centifolia, 3 muscose, 9 damascene, 22 bengalesi (ovvero cultivar di R. chinensis), 4 spinosissime, 8 alba, 3 lutee, 1 moscata e le specie alpina, arvensis, banksiae, carolina, cinnamomaea, clinophylla, glauca, laevigata, rugosa, sempervirens e setigera. Certamente è un falso storico, ma almeno su un punto anche oggi siamo d'accordo: Gravereux correttamente privilegiò le galliche, che erano ancora le rose più coltivate, come risulta anche dai cataloghi di Dupont e Cels. In occasione del bicentenario della scomparsa dell'imperatrice, il roseto è stato restaurato e ospita oggi 750 rose del Primo e del Secondo Impero.  Una bella capricciosa A Joséphine de Beauharnais, creatrice di un magnifico giardino, patrona delle arti e della scienza, ma soprattutto moglie di un uomo che per un quindicennio fu il più potente d'Europa, non mancarono gli omaggi botanici, di sapore innegabilmente cortigiano. Nel 1802, quando Mme Bonaparte era ancora la "consulesse", Ruiz e Pavon dedicarono congiuntamente a marito e moglie, rispettivamente, Bonapartea e Lapageria; mentre la dedica a Napoleone (ne parlo qui) è un capolavoro di adulazione, quella a Joséphine è relativamente sobria: "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Ventenat volle anche lui omaggiare con la dedica di un genere colei che in definitiva era la sua datrice di lavoro; per farlo scelse una delle quattro piante australiane nate dai semi portati in patria dalla prima nave della spedizione Baudin a rientrare, il Naturaliste, che precedette il Géographe di circa un anno. Era una pianta modestissima, per nulla imperiale, ma aveva il fascino della primizia, e. dato che Joséphine era appena stata incoronata imperatrice, la battezzò Josephinia imperatricis. Certo era sinceramente legato a colei che lo chiamava il "suo botanico" e lo aveva scelto come intendente del suo amato giardino, ma la sua dedica è decisamente meno moderata rispetto a quella dei due spagnoli: "L'onore di dedicare un genere all'illustre Imperatrice di Francesi dovrebbe essere ambito dall'autore del Jardin de la Malmaison. Possa questo debole omaggio ricordare al posteri la protezione illuminata che essa accorda alla scienza e lo splendore con cui la abbellisce". Il genere Josephinia fu ridotto a sinonimo di Sesamum, e il suo nome attuale della piante è Sesamum imperatricis che, più che i fasti imperiali, evoca la cucina. Sopravvive invece il genere creato da Ruiz e Pavon, che per bellezza e fascino esotico calza perfettamente alla dedicataria. Lapageria (famiglia Philesiaceae) è un genere monospecifico endemico del Cile, di cui l'unico rappresentante, L. rosea, è il fiore nazionale. Originaria delle foreste sclerofile e caducifolie dell'area centrale e centro-meridionale, dalla regione di Valparaiso a quello di Los Lagos, questa splendida pianta è un rampicante sempreverde con fusti contorti e sottili, foglie semplici, lanceolate, coriacee, lucide e grandi fiori solitari penduli a campana formati da sei tepali cerosi. Il colore delle corolle (tra selvatiche e coltivate, se ne conoscono 25 varietà) varia dal bianco purissimo fino al rosso passando da varie sfumature di rosa. I fiori sono impollinati da insetti, altri animali, ma soprattutto colibrì, e sono seguiti da bacche allungate eduli. La coltivazione è considerata piuttosto difficile. Da noi viene solitamente coltivata in vaso; necessita di ombra luminosa, ottima areazione (ma senza correnti d'aria) e un ambiente umido. Non sopporta né il freddo né il caldo eccessivo. Ama essere frequentemente nebulizzata e, poiché non tollera il calcare, va annaffiata con acqua demineralizzata. Insomma, coltivarla è una vera sfida, ma se trova le condizioni giuste può arrivare a 4-5 metri d'altezza e regalare sontuose fioriture. Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland, fu una formidabile collezionista; collezionava oggetti naturali, in particolare conchiglie, ma anche procellane e altri manufatti. Se il suo nome oggi non è ricordato come quello di personaggi come Sloane, è perché dopo la sua morte la sua collezione di oltre 60.000 pezzi fu venduta all'asta e andò interamente dispersa. La famiglia poté riacquistare solo alcuni dei pezzi più preziosi, tra cui il celebre vaso Portland. Era anche un'abile giardiniera e aveva una notevole competenza botanica; dopo i decisivi incontri con Rousseau, Banks e Solander, questa passione raggiunse il culmine con la trasformazione di una parte del parco della sua residenza, Bulstrode Park, in orto botanico i cui fiori furono immortalati da Dionysius Ehret e dall'amica di lunga data Mrs Delany. Alcune delle vere e proprie leggende nate attorno alle rose Portland, un gruppo di rose antiche rifiorenti, le attribuiscono anche l'introduzione della prima rosa di questo gruppo. Ma la loro origine e la loro ascendenza costituiscono un duplice enigma, che è stato sciolto solo di recente. Nessun mistero invece nella dedica del genere Portlandia, con vistose fioriture che evocano i Tropici. La duchessa delle collezioni Per gli amanti dell'antichità, il nome Portland è richiama indubbamente il favoloso "vaso Portland", un vaso vitreo di epoca augustea oggi custodito al British Museum. Per gli amanti delle rose, evoca invece un gruppo di rose antiche rifiorenti. L'uno e le altre sono in qualche modo associati a Margaret Cavendish Bentinck, seconda duchessa di Portland (1715-1785), la donna più ricca della Gran Bretagna dei suoi tempi, nonché la massima collezionista. Era nata come Margaret Harley e in lei, come unica erede sopravvissuta, si concentrarono i patrimoni del padre, Edward Harley, secondo conte di Oxford e Mortimer, e della madre Henrietta Holles, a sua volta ricchissima erede dei Newcastle e dei Cavendish. La piccola Maria (così veniva chiamata in famiglia) crebbe a Wimpole Hall, la principale residenza di famiglia, circondata da libri, dipinti, sculture e fin da bambina fu incoraggiata a collezionare animali, conchiglie e altri oggetti naturali; sia il nonno paterno (un importante uomo politico) sia il padre erano a loro volta collezionisti, bibliofili e protettori delle arti. Nel 1734, diciannovenne, sposò William Bentinck, secondo duca di Portland, che, al contrario del padre, il primo duca, braccio destro di Gugliemo III, non occupò alcun incarico pubblico e preferì concentrarsi nella vita di famiglia. La coppia ebbe sei figli, quattro dei quali raggiunsero l'età adulta; tra di essi, il terzo duca di Portland, due volte primo ministro, uno dei principali uomini politici britannici della sua epoca. La famiglia divideva il suo tempo tra Londra, dove possedeva una casa a Whitehall e frequentava la corte, i concerti e gli eventi della stagione mondana, e la tenuta di Bulstrode circondata da un vastissimo parco dove già il nonno dell'attuale duca aveva creato un magnifico giardino - di origini olandesi, aveva portato dalla sua patria il gusto per i "paradisi" che costituivano l'orgoglio dell'élite della Repubblica delle province unite - e una notevole Menagerie con voliere di uccelli esotici. Anche se Maria, come abbiamo visto, collezionava conchiglie fin da bambina e aveva ereditato almeno una parte delle collezioni paterne, la passione per il collezionismo esplose negli anni '60, quando rimase vedova (l'amato marito Will morì nel 1761); grazie a una dote di 20.000 sterline, cui, dopo la morte della madre nel 1755, si aggiunsero la proprietà di Welbeck Abbey e una rendita annuale di ulteriori 8000 sterline, era una donna indipendente di larghissimi mezzi che poteva permettersi, letteralmente, ogni capriccio. Amante degli animali fin dall'infanzia, rifondò la menagerie, arricchendola di moltissimi animali; spiritosamente, in una lettera una delle sue più care amiche, Mrs Delany, scrisse: "La duchessa è ansiosa di collezionare animali come se prevedesse un altro diluvio e ne radunasse di ogni tipo per preservarne la specie". Arricchì il parco di varie strutture, tra cui una grotta artificiale (Grotto) che adornò lei stessa di conchiglie con l'aiuto di Mrs Delany. Collezionava soprattutto oggetti naturali, ma anche dipinti, smalti, porcellane, manufatti di varia natura, ogni cosa colpisse la sua curiosità, che, a quanto pare, andavano a mescolarsi in allegra confusione nei corridoi e nelle stanze di Bulstrode Hall, ormai trasformato in un vero e proprio museo aperto ai visitatori. Colta e raffinata, la duchessa di Portland frequentava altre dame con interessi simili (inclusa la regina Carlotta); tra le amiche più strette troviamo Elizabeth Montagu, la creatrice della cosidetta Blue Stockings Society, un club informale che incoraggiava l'educazione e l'espressione artistica delle donne, con la quale iniziò una scambio epistolare nel 1731, quando era appena sedicenne. Un'altra amica di lunga data era la già citata Mary Delany, che la duchessa aveva conosciuto poco dopo il matrimonio, quando ancora si chiamava Mrs Pendarves (dal nome del primo marito); le accumunavano molti interessi e hobby: entrambe parlavano fluentemente italiano e francese, suonavano il clavicembalo, erano abili nel ricamo e in lavori in legno o con conchiglie, amavano la natura, gli animali, le piante, le lunghe passeggiate nel parco. Poi l'amica rimase vedova, si risposò con Mr Delany e si trasferì in Irlanda. Tornò in Inghilterra dopo il 1770, quando rimase vedova per la seconda volta e da quel momento trascorse circa sei mesi all'anno a Bulstrode; ormai sulla settantina, si era perfezionata nell'arte del découpage e il suo soggetto preferito divennero i fiori: formati anche di centinaia di pezzi, i suoi accuratissimi collage ritraggono con precisione anche i particolari più minuti, come gli stami, il pistillo, le nervature delle foglie. Per consentirle un minimo di indipendenza economica, la duchessa le assegnò una piccola casa a Windsor e una pensione di 300 sterline. Un altro artista protetto dalla duchessa di Portland fu Dyonisius Ehret. che probabilmente ella conobbe nel giardino di Chelsea oppure le fu presentato da Miller (di cui Ehret aveva sposato la cognata). Il pittore dipinse per lei su pergamena circa 300 piante esotiche e 500 inglesi, e insegnò disegno alle sue figlie. Possiamo considerarlo un membro a tutti gli effetti della vera e propria équipe scientifica che aiutava la duchessa ad organizzare, catalogare e documentare la sua collezione. A presiederla era il pastore John Lightfoot; nominato cappellano dal duca, due volte la settimana celebrava nella cappella di Bulstrode, dove trascorreva tutto il tempo lasciatogli libero dalla sua attività come pastore di Uxbridge, insegnando botanica alla duchessa, curando la biblioteca e aiutandola con le collezioni. Ottimo botanico, autore di Flora scotica, corrispondeva con Linneo e introdusse la nobile allieva al sistema linneano. Fino al 1770, la botanica, alla quale, come abbiamo visto, era stata avviata da Lightfoot, era un interesse relativamente secondario per la duchessa, anche se amava le piante, teneva un erbario ed era un'appassionata giardiniera, particolarmente abile nella propagazione mediante propaggine. Un incontro importante fu quello con il filosofo Jean Jacques Rousseau, che nel 1766 visse per qualche tempo a Wootton Hall nello Staffordshire, dove intraprese addirittura un inventario della flora locale. Fu presumibilmente introdotto presso la duchessa di Portland da un vicino, Bernard Granville, fratello di Mary Delaney (nata Mary Granville). Rousseau si offrì di diventare il suo "erborista", ovvero di raccogliere per lei semi e campioni d'erbario, cosa che poi fece. Anche se espresse idee francamente maschiliste sulla predisposizione scientifica delle donne, il filosofo ammirava la competenza botanica della duchessa che riteneva ben superiore alla sua. Per più di dieci anni il ginevrino e la nobildonna scambiarono lettere, esemplari, libri, finché nel 1775 o nel 1776 la duchessa commise l'errore di inviargli una copia di Herbarium amboinense di Rumphius. Rousseau tollerava appena la coltivazione dei giardini e aborriva quella delle piante esotiche, che considerava una violenza contro la natura; dunque restituì il dono e interruppe la corrispondenza. La vera svolta si produsse però qualche anno dopo. La duchessa aveva conosciuto Daniel Solander, forse presentatogli da Collinson, poco tempo dopo il suo arrivo dalla Svezia. Nel novembre 1771, dopo il ritorno dall'Australia, egli si recò con Banks a Bulstrode per farle omaggio di semi e campioni d'erbario. Seguirono dotte discussioni in cui fu coinvolto Lightfoot. Pochi giorni dopo, la duchessa e Mrs Delany visitarono il British Museum, con Solander a fare loro da cicerone. Si spostarono poi a casa di Banks che mostrò loro altri esemplari. Questi eventi acutizzarono l'interesse della duchessa per la botanica, e ne nacquero probabilmente l'erbario dipinto affidato a Ehret e l'erbario a decoupage creato da Mrs Delany. Ma la conseguenza principale fu la trasformazione di una parte del giardino in vasto orto botanico secondo il modello del giardino dei farmacisti di Chelsea, con le piante "piantate separatamente secondo la loro specie". Fu probabilmente in questo stesso periodo che, per usare le parole di Lightfoot, la duchessa concepì il progetto di "far descrivere e pubbicare tutte le specie sconosciute dei tre regni della natura". Incaricò Solander di occuparsi delle conchiglie; secondo la testimoniamza di Banks, egli dedicava a questo compito un giorno alla settimana. Tuttavia le morti di Solander nel 1782 e quella della stessa duchessa tre anni dopo, misero fine a questo sogno tanto ambizioso quanto impossibile. Poco dopo la sua scomparsa, il figlio, il terzo duca di Portland, decise di mettere in vendita l'enorme collezione creata dalla madre (erano almeno 60.000 oggetti): c'erano creditori da pagare ed egli stesso aveva bisogno di denaro per la sua carriera poltica. Lightfoot dovette trasformare il catalogo della collezione cui lavorava da anni in catalogo d'asta; quest'ultima, tenuta nella residenza di Whitehall, si aprì il 24 aprile 1786 e si protrasse per oltre due mesi, terminando il 3 luglio. Vi parteciparono centinaia di londinesi e la collezione, divisa in 4000 lotti, fu interamente dissolta. La famiglia riacquistò solo alcuni pezzi di interesse artististico, tra cui un prezioso vaso vitreo di epoca augustea con decorazioni a cammeo; la duchessa l'aveva acquistato nel 1784 da sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli; in precedenza per 150 anni era appartenuto alla famiglia Barberini. Era il pezzo più prezioso, fu messo in vendita il penultimo giorno dell'asta e per aggiudicarselo il duca dovette sborsare 1,029 sterline, una somma enorme per l'epoca. Oggi è una delle gemme del British Museum ed è noto come Vaso Portland.  Un enigma botanico Quanto alle "rose Portland", la loro storia è molto meno lineare, anzi è tanto contraddittoria e intricata da costituire un vero mistero. La versione a lungo dominante è quella riportata da Graham Stuart Thomas in Le rose antiche da giardino (data originale 1979): la progenitrice di questo gruppo di rose era presente nel vivaio Dupont di Parigi nel 1809; Dupont l'avrebbe ottenuta dall'Inghilterra e le avrebbe dato il nome della duchessa di Portland "che probabilmente la trovò o la ottenne dall'Italia all'inizio del secolo". In Inghilterra fu chiamata Rosa paestana, perché si riteneva fosse originaria della zona di Paestum, oppure "Scarlet four season Rose" perché era rosso vivido e ripeteva la fioritura in autunno. Se questa versione è corretta, dato che, come abbiamo visto, la nostra duchessa di Portland morì nel 1785, l'introduttrice non sarebbe lei, ma un'altra duchessa. Beales in Le rose classiche (data originale 1985) si rifà sostanzialmente alla medesima versione, ma si discosta da Thomas affermando che giù in Inghilterra era chiamata Rosa portlandica; aggiunge poi in nota che Sally Festing, autrice di una biografia della seconda duchessa, ha evidenziato che era già elencata nel catalogo di un vivaio inglese nel 1784, il che "deve pure mettere in dubbio l'Italia come suo paese d'origine". E, aggiungo io, rimettere in gioco la nostra duchessa. Ulteriore enigma è l'ascendenza di questa rosa. Nell'opera già citata, Thomas riporta che "era considerata come un incrocio tra la rosa francese (Gallica) e la Damascena autunnale"; egli però la ritiene piuttosto "una ibrido rosa Cinese - Damascena - rosa Francese" e aggiunge: "Dal colore e dal comportamento nano [...] si può presumere che la rosa Cinese progenitrice in questione fosse la cremisi Cinese di Slater" (Slater's Crimson China). Beales è invece convinto che "nessuna rosa cinese sia comunuqe coinvolta" ma che vi abbiano avuto parte attiva la Rosa x damascena bifera ('Quatre Saisons') per la rifiorenza e la R. gallica officinalis ('Rosa del farmacista') per il portamento ordinato e compatto. Il mistero ha ovviamente sollecitato la curiosità dei rodologhi e suscitato ulteriori ricerche. A fare il punto, e dare la risposta definitiva, è Peter Harkness in The Rose. A Colourful Inheritance (2005). In primo luogo egli ricorda che la rosa Portland è conosciuta sotto ben otto nomi: Rosa paestana, R. 'Portlandica', 'Duchess of Portland', Portland Crimson, 'Monthly Rose', 'Portlandia', 'Portlandica', 'Rosier de Portland'. Quindi riassume lo stato dell'arte così: "Le descrizioni di questa rosa nella letteratura non si contano. Si dice che sia originaria del Dorset, o di Beaconsfield, o forse di Napoli, negli anni '70 o '90 del 1700. Quanto alla sua ascendenza, si dice che coivolga unicamente gallica, oppure una damascena e una gallica, o una cinese e una damascena". Secondo Harkness, tutto questo garbuglio nasce dal fatto che "in realtà ci sono due diverse Portland", una nata in Inghilterra negli anni '70 del Settecento, l'altra introdotta da Dupont, giardiniere dell'imperatrice Giuseppina, all'inizio dell'Ottocento. La differenza salta all'occhio osservando la prima nel giardino della Royal National Rose Society, dove è coltivata sotto l'etichetta 'Duchess of Portland', e la seconda nel giardino parigino della Bagatelle, dove è coltivata come R. paestana. La rosa "inglese" (chiamiamola così per comodità), come risulta da cataloghi di vivai e da testi dell'epoca (come la monografia Roses, pubblicata da Henry C. Andrews nel 1805) nacque nei giardini del duca di Portland a Bulstrode prima del 1775, data in cui è elencata da Weston tra le rose "facilmente reperibili" sotto il nome 'Portland Crimson Monthly Rose'; la stessa data è riportata da Trees & Shrubs Hardy in the British Isles che però la chiama 'Portlandica'. Nel 1782, come ‘Portland’ era presente nel catalogo del vivaio Brunton e Forbes di Birmingham; veniva venduta a uno scellino, prezzo che, secondo Harkness, "suggerisce che non si trattasse di una novità". Intorno al 1785, fece la sua comparsa in Francia. E' identificabile nella rosa della Royal National Rose Society; l'aspetto generale, le foglie, i fiori rosa profondo indicano la parentela con la gallica, mentre la modesta rifiorenza riflette quella con la damascena. Veniamo invece a quella "francese"; l'unica certezza è che André Dupont iniziò a coltivarla nel 1803, quando la ricevette dall'Inghilterra. Nel 1809 era chiamata Rosier de Portland e Redouté la dipinse sotto questo nome. Nel 1811 Claude-Thomas Guerrepain nell'Almanach des Roses ne diede una precisa descrizione esaltandone "la preziosa qualità di fiorire dalla primavera all'autunno" e il bellissimo punto di rosso. E' la rosa di Bagatelle. Il brillante colore scarlatto e la rifiorenza hanno fatto a lungo pensare che uno dei genitori fosse una rosa rossa cinese, anche se l'aspetto generale, le foglie e i cinorrodi mostrano maggiori affinità con la Damascena. Le analisi del DNA di cinque rose Portland, condotte da Olivier Raymond dell'università di Lione, ha mostrato parentele con Damascena, Gallica e Centifolia, ma non con le cinesi. Rimane da capire la ragione del nome Portland e l'eventuale connessione con la seconda o la terza duchessa. Nel 1805, parlando della rosa di Bulstrode, Andrews riferisce che sarebbe stata chiamata così "in onore della defunta duchessa di Portland"; Harkness contesta questa affermazione: a suo parere nel Settecento non era ancora invalsa l'abitudine di dare alle rose il nome di una persona; gli sembra più probabile che i nomi 'Portland' o 'Portlandica' si riferiscano al luogo di origine, la tenuta di Bulstrode dei duchi di Portland. Quanto alla rosa "francese", abbiamo due versioni: una, che abbiamo già visto sotto la penna di Graham Stuart Thomas, pretende che una duchessa di Portland l'abbia portata o ottenuta dall'Italia attorno al 1800; l'altra che Dupont l'abbia ottenuta dall'Inghilterra nel 1803 e battezzata 'Rosier de Portland' in segno gratitudine per la terza duchessa di Portland per averlo aiutato a persuadere l'Ammirigliato, nonostante il blocco continentale, a concedere un passaporto al vivaista John Kennedy per trasportare in Francia questa e altre rose destinate ai giardini della Malmaison . Nessuna delle due storie può essere vera, per la semplice ragione che né nel 1800 né nel 1803 viveva una qualche duchessa di Portland. Sappiamo già che la seconda duchessa, ovvero Margaret Cavendish Bentinck, morì nel 1785. La terza duchessa, ovvero sua nuora Dorothy Bentinck nata Cavendish, morì a sua volta nel 1794, e non ci sarebbe stata una quarta duchessa fino al 1809, quando, con la morte del terzo duca, che non si risposò, il titolo passò al quarto duca e a sua moglie. Inoltre, Dupont non chiamò la rosa 'Duchess de Portland', ma 'Rosier de Portland'; l'ipotesi di Harkness è che l'omaggio fosse diretto al terzo duca di Portland il quale, come Segretario di stato ininterrottamente dal 1794 al 1801, quindi, dopo un breve periodo all'opposizione, dal 1803 Presidente del Consiglio privato e poi Primo ministro, "era certamente nella posizione di aiutarlo a ottenere un passaporto per le sue rose". Anche il nome R. paestana probabilmente non ha alcun rapporto diretto con l'Italia e Paestum; si tratta piuttosto di una semplice reminescenza della letteratura classica in cui le rose di Paestum erano celebrate per la loro bellezza, il profumo, il vivace colore rosso e la rifiorenza autunnale. 
La prima metà del Cinquecento, prima che le divisioni religiose e la guerra insanguinassero il paese, fu per le Fiandre un'età d'oro, con un'eccezionale fioritura economica ed artistica. In questo contesto si svilippò anche il gusto per i giardini e le piante rare ed esotiche. Nella progettazione di alcuni di essi fu coinvolto il botanico Carolus Clusius. Dopo aver lavorato come "consulente botanico" per Charles de Saint Omer nel castello di Moerkerke, intorno al 1567 si trasferì a Malines, dove creò e curò il giardino del ricco collezionista Jean de Brancion; forse proprio qui incontrò per la prima volta la giovane nobildonna Marie de Brimeu. Poi la vita (e la guerra) li divisero. Si ritrovarono vent'anni dopo, quando il botanico, lasciata la corte imperiale, viveva a Francoforte, aveva pubblicato molti libri ed era il massimo esperto riconosciuto di piante esotiche, e Marie era diventata la principessa di Chimay e per non rinunciare alla sua fede protestate aveva scelto una vita d'esilio e avea lasciato il marito traditore di quegli ideali. Ora viveva a Leida, dove c'erano molti appassionati di giardini; riprese a scrivere a Clusius, usò tutta la sua influenza per farlo venire a Leida come prefetto dell'orto botanico e non cessò di scambiare con lui lettere e piante anche quando dovette lasciare prima Leida poi i Paesi Bassi. Le sue 27 lettere a Clusius costituiscono una testimonianza storica ed umana eccezionale. A ricordarla (nonostante un piccolo errore) il genere Brimeura, rappresentato anche nella flora sarda. 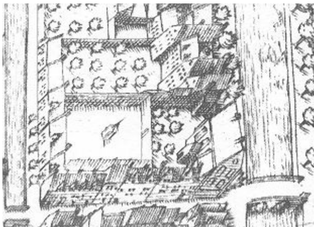 Una donna coraggiosa e un amico ritrovato Con le sue circa 1600 lettere superstiti, l'epistolario di Carolus Clusius costituisce una testimonianza unica della rete che nel secondo Cinquecento univa botanici e amatori di tutta Europa, al di là di ogni frattura politica e religiosa. 377 sono state scritte da Clusius stesso, le rimanenti 1200 gli sono state inviate da circa 335 corrispondenti sparsi in undici paesi; tra di loro, adetti ai lavori come botanici, medici, farmacisti, ma anche un gran numero di appassionati. E appassionate: 110 lettere sono state scritte da 25 donne che, nella maggior parte dei casi, lo interpellavano come esperto di piante rare, chiedevano consigli su come procurarsele e scambiavano con lui semi, talee, bulbi e frutti. Appartenevano tutte all'alta società; le loro lettere sono scritte in francese, tedesco, olandese, mai in latino, la lingua della scienza da cui le donne erano escluse, così come dalle università. Tra queste corrispondenti, per il numero di lettere spiccano l'aristocratica viennese Anna Maria von Heusenstain, con 25 lettere scambiate tra il 1588 e il 1606, e la nobildonna fiamminga Marie de Brimeu principessa di Chimay (ca. 1550-1605) con 27 lettere inviate (nessuna delle risposte di Clusius è conservata). Per l'eccezionalità della sua figura, questa donna, che giocò anche un ruolo politico non irrilevante nelle tormentate vicende dai cui nacque la Repubblica delle Province unite, è sicuramente la più nota e studiata tra le correspondenti di Clusius. Marie apparteneva a una delle principali famiglie dell'aristocrazia francofona delle Fiandre meridionali. La sua prima lettera a Clusius, accompagnata da un dono di melograni e radici di rose muschiate e agrumi, risale al 23 febbraio 1571, quando aveva circa vent'anni e non era ancora sposata; tra le altre cose, la giovane donna ringrazia per l'invio di alcuni semi e ricorda a Clusius la sua promessa di aiutarla a restaurare il suo giardino danneggiato dal maltempo. All'epoca è dunque già appassionata di piante e giardini, e si rivolge al già celebre Clusius - che ha più del doppio dei suoi anni - in tono allo stesso tempo rispettoso ed affettuoso. Probabilmente i due si erano conosciuti a Malines, dove la famiglia di Marie possedeva una casa (e forse il giardino di cui si parla nella lettera), tramite il collezionista Jean de Brancion, presso cui Clusius abitava curandone il giardino. Poi, per vent'anni, la corrispondenza si interrompe. Le lettere intermedie potrebbero essere andate perdute, ma è più probabile che i due si fossero persi di vista. Nel 1573 Clusius fu nominato medico imperiale e lasciò definitivamente le Fiandre; per quasi quindici anni visse tra Vienna e l'Ungheria, per poi spostarsi a Francoforte. Quanto a Marie, nel 1572 ereditò da uno zio la contea di Megen nel Brabante settentrionale; lo stesso anno, o forse alla fine di quello precedente, sposò un esponente dell'aristocrazia militare, Lancelot de Barlaymont; forse visse con lui nel castello di Beauraing nelle Ardenne e ne ebbe due figli, morti nell'infanzia. Intanto era scoppiata la rivolta contro la Spagna; il marito combattè contro i ribelli, si distinse all'assedio di Zichem, ma durante l'assedio di Philippeville si ammalò e morì in giovane età nel 1578. La vedova stava maturando convinzioni politiche e religiose opposte. Fosse l'indignazione per la brutalità delle azioni militari del duca d'Alba (soprannominato il "macellaio delle Fiandre"), oppure lo sgomento per la distruzione delle sue stesse terre - dal 1572 la contea di Megen fu teatro di pesanti combattimenti; il castello, dove probabilmente era nata, fu arso e demolito, e se c'era un giardino, certo non sopravvisse; fatto sta che Marie abbracciò pienamente la causa dei ribelli e si convertì alla fede protestante. Le terre di cui era signora e ciò che aveva ereditato dal marito la rendevano ricchissima; nel 1580 si risposò con Charles III de Croÿ principe di Chimay; il giovane aristocratico aveva dieci anni meno di lei e ne subì a tal punto il fascino da adottarne le scelte politiche e religiose; condivideva anche il suo interesse per le piante e la natura. Per qualche tempo la coppia visse nel castello dei principi di Croy nell'Hainaut, ma anche questo fu danneggiato dalla guerra e, se c'era un giardino, andò certamente distrutto. Intanto la situazione politica andava evolvendo; il nuovo governatore Alessandro Farnese riuscì a riprendere il controllo delle province meridionali che scesero a patti con la Spagna e firmarono l'Unione di Arras che ribadiva la lealtà a Filippo II e al cattolicesimo. Marie e il marito decisero di lasciare segretamente il paese e nel giugno 1582, sfuggendo di misura a un gruppo di cavalieri spagnoli, riuscirono a raggiungere prima Sedan poi l'Olanda. Nel 1583 Charles de Croÿ venne nominato stadtholder delle Fiandre, ma la sua politica moderata lo portò in conflitto con Guglielmo d'Orange; nel maggio 1584 consegnò la città di Bruges ad Alessandro Farnese e ritornò alla fede cattolica. Marie visse queste vicende come un tradimento e decise di separarsi dal marito. Rimase nelle Province unite e visse successivamente in varie città (Middelburg, Delft, Utrecht) finché nel 1590 si stabilì a Leida. Nel 1584, contro le consuetudini, gli Stati Generali stabilirono che la nobildonna - e non suo marito - conservava il pieno controllo dei propri beni. Anche se questa decisione fu all'origine di una controversia legale senza fine con il principe, grazie ad essa Marie poté vivere come donna ricca ed indipendente. Nelle varie case in cui visse successivamente, aveva con sè parenti, amici, dame di compagnia, molti servitori, e per amministrare i suoi beni si avvaleva di segretari, tra cui l'ex predicatore Lieven Calvaert; il fatto che vivesse con lei diede adito a pettegolezzi, scientemente raccolti dal marito che nel 1586 giunse ad organizzare un tentativo di avvelenamento per liberarsene. Non sappiamo se Marie avesse un giardino nelle varie citt olandesi dove visse prima di Leida; probabilmente no, visto che si trattò sempre di sistemazioni precarie e di breve durata. A Leida invece si stabilì in una spaziosa casa sul Rapenburg dotata di un doppio giardino posteriore; solo un muro lo separava dal terreno incolto dove di lì a poco sarebbe sorto l'orto botanico. Qui Marie poté coltivare le piante che tanto amava e strinse amicizia con un gruppo di colte dame che condividevano la stessa passione, tra cui Louise de Coligny, vedova di Guglielmo il Taciturno. Questo circolo prescindeva da differenze religiose: tra le sue più intime amiche c'era anche Stephana van Rossem, che era stata l'ultima badessa del monastero di Rijnsburg smantellato dai protestanti. Marie aveva altri amici con l'hobby del giardinaggio: frequentava le case del mercante Daniel van der Meulen, che come lei aveva un giardino sul Rapenburg, e del patrizio della Zelanda Johannes van Hoghelande, intimo amico e corrispondente di Clusius. Fu probabilmente grazie a queste frequentazioni che nel 1591 riprese a scrivere a quest'ultimo, che le inviò bulbi e semi da Francoforte. La principessa di Chimay giocò indubbiamente un ruolo importante nella venuta di Clusius a Leida. Dovette usare tutta la sua influenza alla corte dell'Aja e negli ambienti universitari per far accettare le condizioni da lui poste - nessun incarico di insegnamento, la disponibilità di un servitore, l'assistenza di un giardiniere -, ma soprattutto fu determinante nel convincere il riluttante botanico ad accettare, nonostante l'età avanzata e i numerosi acciacchi. La nobildonna promise persino di ospitarlo e di mettergli a disposizione metà del suo giardino; e sarà stato forse qui che, in attesa che l'orto botanico fosse pronto ad accoglierli, vennero temporaneamente scaricati i bulbi di tulipano e le piante che Clusius aveva portato con sè da Francoforte. Ammettendo che sia andata così, si trattò di una sistemazione temporanea; poco dopo il suo arrivo, Clusius si stabilì presso una vedova nel Pieterskerkgracht, une via perpendicolare del Rapenburg, dove avrebbe abitato fino alla morte. Egli teneva molto alla propria indipendenza; in una lettera a Camerarius di pochi anni prima scrisse infatti: "A essere sincero, non mi auguro di entrare al servizio di un principe finché sono in grado di mantenermi con le mie entrate, per modeste che siano; perché una persona abituata alla libertà fin dalla prima giovinezza farebbe fatica a dipendere da qualcuno da vecchio". La relazione tra Clusius e la principessa di Chimay non è quella classica protetto-protettore, ma piuttosto un'amicizia tra due persone che condividono la stessa passione. Inoltre, poco dopo l'arrivo del botanico a Leida, Marie dovette trasferirsi a Loo presso all'Aja per essere più vicina alla corte; l'Aja e Leida non sono troppo lontane e non mancarono le visite reciproche, ma soprattutto si intensificò la corrispondenza. Marie scriveva regolarmente a Carolus; le sue lettere seguono per lo più un modello ricorrente: la principessa ringrazia per le piante ricevute, ne chiede altre, riferisce di quelle che non hanno resistito al freddo dell'inverno, racconta dei visitatori che hanno ammirato il suo giardino, si lamenta dei furti (sia lei sia Clusius furono spesso vittime di ladri di piante). Spesso parla della sua salute, sempre più malferma, e si preoccupa di quella dell'amico. Il giardino, di cui è estremamente fiera, è una gioia, anzi "l'unico piacere che oggi ho al mondo". Poi, nel 1600, il distacco più doloroso. Dopo lunghe trattative, Marie si lasciò infine convincere a riconciliarsi con il marito, a patto di mantenere la propria fede e la propria indipendenza. Lasciò dunque i Paesi Bassi per trasferirsi a Liegi, dove però non visse con il marito. Continuò a corrispondere con Clusius, a ricevere piante da lui, a creare giardini. Ma la sua salute, da tempo fragile, continuò a peggiorare, costringendola a trascorrere sempre più tempo in località termali, finché si spense nel 1605, a circa cinquantacinque anni. Clusius, che di anni ormai ne aveva ottanta, le sopravvisse di quasi cinque anni, Com'erano i giardini di Marie de Brimeu? Poiché non li fece mai ritrarre, possiamo ricostruirli soltanto attarverso i cenni contenuti nelle sue lettere a Clusius e le pochissime menzioni che ne fa quest'ultimo nelle sue opere. Secondo Anne Mieke Backer, che ha tentato questa difficile impresa, riflettevano una nuova concezione della natura in cui, all'interesse quasi esclusivo per le piante officinali e a una lora visione dominata dal simbolismo religioso, incominciava a sostituirsi l'interesse per le piante in sè e il godimento per la loro bellezza. Backer fa l'esempio del giglio (Lilium candidum): Clusius gli assegnava un posto centrale nella composizione dei giardini, ma solo per la sua "distinta grandezza e i suoi bei fiori" e non perché fosse una pianta consacrata alla Vergine Maria. Marie, più che una collezionista che si compiaceva di possedere una pianta per la sua rarità - era esattemente l'atteggiamentro del marito principe, che era anche collezionista d'arte e a Beaumont costruì un prestigioso giardino -, era un'amante delle piante, che ricercava per la loro bellezza e per la gioia di disporle nel modo più armonico, in base all'altezza, alla dimensione, al colore e tenendo conto del succedersi delle fioriture. Non si pensi però a un moderno mixed border: il modello cui guardava la principessa era piuttosto quelle delle tapezzerie mille fleurs, nelle quali ciascun fiore spicca sul fondo scuro (quello della terra nuda) e ogni fiore può essere ammirato sia in sè sia come parte di un insieme. Backer propone anche un elenco: ovviamente tulipani e altre bulbose (narcisi, giacinti, Frittilaria meleagris e Fritillaria imperialis, anemoni, ranuncoli,Erythronium dens canis), peonie, diversi tipi di rose, tra cui le rose muschiate, diversi tipi di gigli, Delphinium, cui si aggiungevano piante più comuni e da tempo coltivate, come iris, primule, mughetti, violette, garofani, nontiscordardimé, fiori di trifoglio, pervinche e margherite. C'erano anche piccoli alberi in vaso (melograni e agrumi) che d'inverno venivano portati all'interno. Non c'erano invece fontane, statue, padiglioni, siepi, viali alberati. Quelli di Marie, esule sempre in viaggio, erano giardini temporanei, in cui i fiori e la loro disposizione mutavano da un anno all'altro.  Una piccola bulbosa per le fioriture di primavera Questa donna indubbiamente eccezionale è entrata nel numero purtroppo modesto delle dedicatarie di generi di piante grazie a Salisbury, che però incappò in una curiosa confusione. Nel protologo scrive di aver dedicato il genere Brimeura "a Marie de Brimeur, celebre all'epoca di Clusius per l'amore e la coltivazione dei fiori". Ebbene, tra le corrispondenti di Clusius c'erano due donne dal nome quasi uguale: la nobildonna Marie di Brimeu, che già conosciamo, e Marie de Brimeur, moglie del mercante di Anversa Coenraad Schets, che aveva un bel giardino in questa città negli anni '80 ed è citata due volte da Clusius in Rariorum plantarum historia. Per quanto posedesse un giardino con qualche pianta esotica, non era certo "celebre per l'amore e la coltivazione dei fiori"; dunque è indubbio che Salisbury pensasse alla nostra Marie, ma la confuse con la quasi omonima e aggiunse una r di troppo. Brimeura (Asparagaceae) è un piccolo genere di bulbose endemiche della penisola iberica, della Francia meridionale, delle isole del Mediterraneo occidentale, che comprende tre specie: B. amethystina, B. duvigneaudii, B. fastigiata. Hanno strette foglie lineari e fiori a campana con sei lobi, solitamente azzurri. La più coltivata è B. amethystina (talvolta commercializzata con il sinonimo Hyacinthus amethystinus); ricorda abbastanza da vicino Hyacinthoides hispanica e in primavera produce racemi laschi di fiori campanulati in varie sfumature di azzurro e violetto; la forma 'Alba' è bianca. B. duvigneaudii è un endemismo dell'isola di Maiorca. B. fastigiata, la sola specie della nostra flora, è endemica di Sardegna, Corsica e Baleari. Ogni bulbo produce da due a quattro foglie lineari e canicolate più lunghe degli scapi fiorali; i fiori sono raccolti da due a sei in infioresceze subcorimbose con steli cilindrici di colore rossiccio; dal diametro di circa 6 mm, hanno forma campanulata con tepali divisi fino a poco più della metà in sei lacinie con apici acuti. Il colore varia dal bianco al lilacino più o meno intenso con striature longitudinali più scure. Fiorisce da marzo a maggio. In Sardegna è piuttosto comune, ma spesso passa inosservata sia per le piccole dimensioni sia per l'habitat tipico: vive infatti tra gli arbusti al limitare della boscaglia o della macchia mediterranea. I primi orti botanici tedeschi nascono sul modello di Padova a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Tra i massimi protagonisti della loro nascita, il medico e botanico Ludwig Jungermann, che disegnò e curò successivamente l'orto botanico di Gießen, il primo ad occupare ancora parzialmente la sede originale, e quello di Altdorf, celebre per la bellezza e la ricchezza di piante rare. Jungermann fu anche il primo in Germania a scrivere flore locali e a tenere ufficialmente una cattedra di anatomia e botanica. Nella sua prassi didattica, poterono così integrarsi le lezioni teoriche, la dimostrazione delle piante nell'orto botanico e le escursioni nel territorio. È ricordato dal genere di epatiche Jungermannia, dalla storia tassonimica alquanto travagliata.  Flore locali ed orti botanici Tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in Germania vennero fondati diversi orti botanici universitari che si rifacevano direttamente al modello di Padova. Il primo fu quello di Lipsia, nato nel 1580 forse dalla trasformazione di un precedente giardino monastico, seguito nel 1586 da quello di Jena e nel 1593 da quello di Heidelberg. Travolti dalla guerra dei Trent'anni, nessuno di questi giardini è sopravvissuto. Il primo a trovarsi ancora almeno in parte nella collocazione originale - anche se assai ingrandito e con un aspetto totalmente mutato - è quello di Gießen, la cui fondazione ufficiale risale al 1609. L'università di Gießen (oggi Justus-Liebig-Universität Gießen) era recentissima; nel 1605 alcuni professori luterani del vicino ateneo di Marburg, da poco passato al calvinismo, si spostarono a Gießen dove, auspice il langravio Ludovico V di Assia-Darmstadt, fondarono l'Illustre et principale Gymansium Giessense che nel 1607, ottenuto il brevetto imperiale, si trasformò appunto in università. Come ateneo luterano, il suo scopo principale era formare pastori e funzionari, ma fin dall'inizio ci fu una facoltà di medicina che appunto nel 1609 fu dotata di un hortus medicus, grazie ancora al langravio che a tal fine aveva donato all'università un piccolo giardino di piacere situato presso la torre del castello. A presiederlo e di fatto a crearlo fu chiamato, con un salario di 50 talleri, il candidatus, ovvero dottorando in medicina, Ludwig Jungermann (1572-1653); allievo dell'anatomista Gregor Horstius, egli fu uno dei primi laureati in medicina della facoltà, ottenendo la licenza "summos honores in arte medica" con la tesi Assertiones medicae de catarrho nel dicembre 1610 e il dottorato nell'aprile 1611, con una tesi in cui si esaminava l'efficacia dei decotti di lattuga e ruta per curare l'"amore insano". Jungermann veniva da una famiglia doppiamente illustre. Il padre Caspar Jungermann fu professore di diritto e per ben sette volte rettore dell'università di Lipsia; la madre Ursula Camerarius era figlia dell'illustre umanista e collaboratore di Melantone Joachim Camerarius il Vecchio e sorella del medico e botanico Joachim Camerarius il Giovane. Mentre il padre avrebbe voluto avviarlo a studi giuridici, Ludwig scelse la medicina e la botanica, seguendo l'esempio dello zio materno nonché del compianto fratello maggiore Joachim. Joachim Camerarius (1531-1561) era stato un giovane estremamente brillante; dotato disegnatore, è il più accreditato autore del Camerarius florilegium, lo spettacolare erbario figurato fatto eseguire dallo zio, che lo considerava il suo erede scientifico, ancora più del figlio Joachim Camerarius III. Nel 1588 venne a studiare in Italia e si fece conoscere nell'ambiente dei naturalisti della penisola con il nome italianizzato Gioacchino Giovenio. Visitò Napoli dove fu tra i pochi a vedere il manoscritto di Hernández portato in Italia da Nardo Antonio Recchi e riuscì anche a copiare "con destrezza" alcune figure. Oltre che con lo zio (ci rimane un espistolario di oltre 100 lettere), corrispondeva con altri botanici tra cui Clusius cui inviò numerosi esemplari. Mentre studiava a Padova, fece diverse escursioni botaniche; tra l'altro fu in Tirolo con un altro corrispondente di Clusius, Tobias Roels. Nel 1590 Casabona lo inviò ad accompagnarlo a Creta, ma Jungermann rifiutò. L'anno successivo tuttavia si imbarcò a sua volta per Costantinopoli con quattro connazionali; durante il viaggio, a bordo scoppiò un'epidemia che gli fu fatale. Ludwig, più giovane di lui di undici anni, al momento della sua morte aveva diciannove anni ed era deciso a seguirne le orme. Tuttavia, forse memore della sua sorte, non si allontanò mai dalla Germania e divenne uno specialista della flora locale. Iniziò gli studi accademici a Lipsia, dove iniziò a creare un erbario e a scrivere una flora sulle piante del territorio; terminato entro il 1600 ma rimasto manoscritto (oggi è conservato presso l'università di Erlangen), il suo Viridarium lipsiense spontaneum è considerata la più antica flora locale e cittadina in terra tedesca; elenca e descrive in ordine alfabetico circa 800 piante spontanee di Lipsia e dei suoi dintorni. Jungermann proseguì quindi gli studi a Jena e ad Altdorf, una cittadina universitaria a circa 25 km da Norimberga, dal cui consiglio cittadino dipendeva. Qui strinse amicizia con il coetaneo Caspar Hoffmann (1572-1648), che prima di iscriversi ad Altdorf aveva frequentato le università di Strasburgo, Padova e Basilea, dove era stato allievo di Felix Platter e Caspar Bauhin. Né ad Altdorf né in altre università tedesche esisteva ancora una cattedra formale di botanica; fu dunque al di fuori del curriculum ufficiale che i due amici incominciarono ad esplorare la flora dei dintorni; come aveva fatto a Lipsia, Jungermann trasse da queste ricerche un catalogo che, nel partire per Gießen, affidò a Hoffmann per la pubblicazione. Prima che ciò avvenisse, tuttavia, passarono alcuni anni pieni di impegni per entrambi. Hoffmann era rimasto ad Altdorf e aveva assunto la cattedra di medicina teorica, mentre Jungermann era fortemente impegnato nella direzione dell'orto botanico di Gießen, cui nel 1614 si aggiunse la cattedra di anatomia e botanica, la prima ufficiale in terra tedesca. Inoltre, intorno al 1612 gli fu affidata la redazione dei testi di Hortus Eystettensis, grazie presumibilmente sia alla sua crescente fama come esperto di piante, sia alla relazione familiare con Camerarius, il cui giardino aveva fatto da modello a quello di Eichstätt. Constatando, come professore di medicina, quanto carenti fossero le conoscenze botaniche dei futuri medici, Hoffmann si ricordò di quel vecchio catalogo; gli era evidente che Jungermann non avrebbe potuto occuparsene perché "due lavori allo stesso tempo sono già sufficienti". Con il suo accordo, si decise a "mettere mano nella messe altri". Il risultato fu Catalogus plantarum circa Altorfium Noricum et vicinis quibusdam locis, pubblicato ad Altdorf nel 1615. Nel frontespizio, Jungermann figura come autore, mentre Hoffmann come revisore. Nella lettera dedicatoria al senatore di Norimberga Georg Christoph Volckamer, firmata da Hoffmann, questi sintetizza la genesi e gli scopi dell'opera, ribadisce che il materiale risale a Jungermann, ma che il lavoro redazionale è stato in gran parte svolto da lui. Il catalogo vero e proprio, in ordine alfabetico, è costituito da un elenco di nomi di piante in latino, essenzialmente basato su Phytopinax di Caspar Bauhin; seguono i sinonimi di altri autori (tra più citati Lobel e Dodoens), spesso il nome tedesco e quasi sempre l'indicazione dell'habitat: generica come nei boschi, in luoghi sabbiosi, in luoghi umidi, ecc; o più specifica come "nella Pfaffenthal", "presso la fortezza di Hollenstein". Le piante segnalate come nuove sono sei in tutto, ad esempio Chamaedrys fruticosa nostra, Pseudocamaedrys elatior Jungermannii, di cui si dà una breve diagnosi con le differenze rispetto a specie affini. Possono essere nuove però anche altre specie non segnalate come tali ma non seguite da referenze bibliografiche. Tra di esse parecchi muschi. Jungermann lavorò e insegnò a Gießen fino al 1625, pubblicando ancora due flore locali: Cornucopiae Florae Giessensis e Catalogus herbarum circa Giessam, pubblicate nel 1623 ed entrambe oggi perdute. Nel 1625, nell'ambito della guerra dei Trent'anni, il langravio occupò Marburg e decise di traferire in quella sede storica l'università, chiudendo quella di Gießen. Anche l'orto botanico fu abbandonato. Su invito di Hoffmann, Jungermann preferì trasferirsi a Altdorf; portò con sè quanto poteva delle piante del giardino di Gießen, con le quali creò un hortus medicus privato, Con il sostegno di Hoffmann, riuscì a convincere il consiglio cittadino di Norimberga a finanziare la sua trasformazione in orto botanico universitario (tre anni prima l'accademia di Altdorf si era ufficialmente trasformata in università). Il giardino, noto come Hortus medicus altdorfinus o Doktorgarten, si trovava al di fuori delle mura cittadine, a sud-ovest dell'edificio universitario; a pianta quadrata, era circondato da un muro di arenaria e misurava inizialmente 3000 m2. I due viali principali, incociandosi al centro, occupato da un padiglione, lo dividevano in quattro quadranti di uguali a dimensioni; i due posti a nord, che confinavano con gli edifici universitari, avevano funzione ornamentale, con ramages di gusto barocco disegnati da basse siepi di bosso; le erbe medicinali erano coltivate in quelli a sud, che avevano anche funzione di orto e vivaio. Il giardino cercava dunque di conciliare la funzione didattica con le esigenze estetiche di un giardino di piacere. Nel progetto di Jungermann confluiva un variegato bagaglio di esperienze: il ricordo del giardino di suo zio Camerarius a Norimberga, le suggestioni del giardino vescovile di Eichstätt, il modello degli orti botanici italiani e la sua stessa esperienza come prefetto dell'orto botanico di Gießen. Anche se erano gli anni difficili della guerra dei Trent'anni, nell'arco di pochi anni egli riuscì a creare un giardino rinomato per la sua bellezza e la ricchezza di piante esotiche e rare; alcune le portò con sè da Giessen, altre le ottenne da Eichstätt e da giardini monastici, altre ancora dai suoi numerosi corrispondenti. Molti sono citati nella breve prefazione del catalogo del giardino, Catalogus plantarum, quae in horto medico et agro Altdorphino reperiuntur, pubblicato da Jungermann nel 1635. Sono soprattutto tedeschi, medici o generosi proprietari di giardini privati (tra i pochi nomi che oggi ci dicono ancora qualcosa Gillenius, ovvero Arnold Gille, medico di Cassel, e Wilhelm Ernst Scheffer, medico di Francoforte), ma ci sono anche il prefetto di Leida Adolphus Vortius e Giovanni Pona, "farmacista veronese celeberrimo". Fino fine dei suoi giorni (morì ottantenne nel 1653), Jungermann visse ad Altdorf, come praefectus dell'orto botanico e professore di anatomia e botanica; fu anche più volte rettore. Faceva regolarmente lezione nel giardino e accompagnava i suoi studenti in escursioni botaniche. I contemporanei lo consideravano un "botanico non secondo a nessuno"; rifiutò ripetutamente nomine onorevoli, compresa quella di successore di Mathias Lobel come botanico del re d'Inghilterra. Era un uomo simpatico e affabile, versato anche nella poesia latina. Non si sposò mai; secondo un aneddoto, agli amici che lo esortavano a prendere moglie, rispondeva che lo avrebbe fatto quando qualcuno gli avesse portato una pianta che non conosceva. Alla sua morte lasciò in eredità alla biblioteca di Altdorf il suo notevole erbario di 2000 campioni. Due parole sulle vicende successive dell'orto botanico di Altdorf. Poco dopo la morte di Jungermann, fu ampliato, portando la superficie a 4500 m2 e dotato di un hibernaculum, ovvero una limonaia, che poteva essere riscaldata da due stufe. Fino alla fine del Settecento, fu tra i più ricchi e reputati della Germania. Il suo ultimo catalogo, redatto nel 1790 dal prefetto e professore di botanica Benedict Christian Vogel, che esclude le piante "indigene e volgari", registra 2500 piante esotiche. Una di esse era un'Agave americana che fiorì e fruttificò nel 1798. Dopo il congresso di Vienna, Norimberga, fin ad allora città libera, fu annessa al Regno di Baviera. L'università di Altdorf venne sciolta e il giardino smantellato. Poche piante, tra cui una cicadacea e un grande albero di canfora, furono trasferite nell'orto botanico dell'Università di Erlangen, mentre il grosso andò ad arricchire le aiuole e le serre del recentemente fondato orto botanico di Monaco di Baviera.  Un genere con una storia travagliata Come ho anticipato, invece il giardino di Gießen esiste ancora. Dopo la pace di Westfalia, nel 1650, l'università di Gießen fu ripristinata e anche il suo orto botanico tornò a rivivere. All'inizio del Settecento, vi studiò Heinrich Bernhardt Ruppius, che era nativo proprio di quella città. Come Jungermann un secolo prima, studiava la flora locale e nella sua Flora jenensis (1718) si ricordò del suo predecessore dedicandogli il genere Jungermannia, poi convalidato da Linneo in Species plantarum. Si trattava del primo genere di epatiche fogliose ad essere descritto; ha dato il nome alla famiglia Jungermanniaceae e all'ordine Jungermanniales. Inizialmente incluse tutte le epatiche fogliose, poi nel corso dell'Ottocento, in base a specifiche caratteristiche degli organi riproduttivi, ne vennero via via separati numerosi generi. Nella seconda metà del Novecento prevalse invece l'idea di raggrupparli nuovamente in un vastissimo Jungermannia, che comprendeva tra 120 e 200 specie, distribuite in tutto il mondo, in ogni ambiente, eccetto i deserti, le savane e le foreste pluviali tropicali. A cavallo tra la fine del Novecento e gli anni Duemila, gli studi molecolari filogenetici hanno drasticamente mutato questo quadro, dimostrando che Jungermannia inteso in senso largo era un gruppo artificiale che raggruppava specie poco correlate tra loro. A Jungermannia in senso stretto, diviso da Liochlaena e Solenostoma sulla base di caratteristiche come la forma del perianzio e l'assenza di periginio, sono al momento attuale attribuite 9-10 specie prevalentemente distribuite nelle zone temperate dell'emisfero boreale. Una delle più diffuse è J. atrovirens, presente anche nella nostra flora; caratterizzata dal colore verde scuro che le dà il nome, è una specie alquanto variabile che cresce in una varietà di situazioni su suolo calcareo, in luoghi umidi o anche come acquatica in laghi e torrenti; dioica, ha foglie ovoidali concave che avvolgono gli steli da eretti a prostrati e può formare densi tappeti erbosi. Nel 1586, presso l'editore Rouillé di Lione, comparvero i due tomi di Historia generalis plantarum, nota anche come "erbario di Lione". Il primo elemento che ci colpisce aprendo quest'opera poderosa è che, nonostante il reboante sottotitolo che promette al lettore la descrizione di tutte le piante note agli antichi nonché di quelle prima ignote scoperte "nelle parti orientali ed occidentali" e oltre un migliaio di illustrazioni "riccamente superiori a tutte le precedenti", il frontespizio non rechi il nome di alcun autore. Eppure un autore, o almeno un autore principale, c'era, e aveva lavorato a quell'opera per almeno un quarto di secolo. Era il medico, botanico e filologo Jacques Daléchamps. È troppo per pensare che fosse così insoddisfatto della redazione finale, che l'editore aveva affidato ad altri, da preferire che il suo nome non comparisse? Confusa, piena di errori, pesantemente censurata da Caspar Bauhin, con le sue oltre 2700 piante era comunque l'opera più ampia e ambiziosa dell'epoca e nonostante i difetti fu molto letta e consultata, specie nell'edizione francese. A ricordare il dottissmo Daléchamps, autore anche di una notevolissima edizione di Plinio, il genere Dalechampia, omaggio di Plumier replicato da Linneo. 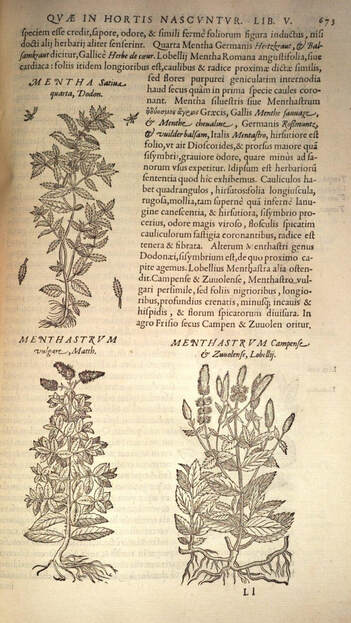 Un autore, troppi autori e un'opera anonima Nel Cinquecento, in seguito ai viaggi di esplorazione, il numero di piante conosciute incominciò ad aumentare drammaticamente, dalle poche centinaia note agli antichi alle migliaia incontrate dai viaggiatori europei nelle Americhe, in Asia, in Africa. I botanici del tempo, però, si illudevano ancora che il loro numero fosse gestibile, che fosse ancora possibile a una singola persona racchiuderle tutte in una singola opera. Dal De plantis di Andrea Cesalpino al Pinax di Caspar Bauhin, che con le sue 6000 piante segnerà allo stesso tempo il culmine e la fine di questo filone, il secondo Cinquecento è tutto un fiorire di queste opere enciclopediche che si vorrebbero onnicomprensive. Tra i tentativi più grandiosi ma allo stesso tempo sfortunati, spicca Historia generalis plantarum di Jacques Daléchamps (1513-1588). Figlio egli stesso di un medico di Caen, nel 1545, già ultratrentenne, si iscrisse all'università di Montpellier, dove fu uno dei primissimi allievi di Rondelet, con il quale rimase in termini di stretta amicizia, scrivendo in suo onore anche due dei poemi encomiastici che si leggono in De piscibus. Dopo la laurea, per qualche tempo visse a Valence e a Grenoble, finché intorno al 1550 si stabilì a Lione dove sarebbe vissuto fino alla morte. Nel 1552 fu nominato medico dell'Hôtel-Dieu dove avrebbe esercitato per circa trent'anni, nel corso dei quali fu sempre più presente nella vita cittadina. Erano anni difficili per Lione, devastata dalle guerre di religione, della povertà, dalla sifilide, da ripetute epidemie di peste. Daléchamps si fece un nome come ottimo medico e chirurgo e fu più volte chiamato a far parte delle commissioni mediche nominate dal consiglio cittadino o dal governatore per cercare di contrastare quel terribile flagello. Proprio alla peste dedicò quella che è probabilmente la sua prima opera a stampa (De Peste libri tres opera Jacobi Dalechampii, 1552), che non è un lavoro originale, ma la riedizione di un trattato trecentesco del medico di Montpellier Raymond Chalin de Vinario. È l'ingresso di Daléchamps nel mondo dell'editoria che aveva in Lione una delle sue capitali. Da quel momento egli fu molto attivo sia come autore (gli si deve tra l'altro una Chirurgie Françoise, pubblicata nel 1570), sia come filologo, traduttore e divulgatore di opere dell'antichità: tradusse in latino e commentò I deipnosofisti di Ateneo di Naucrati; tradusse in francese dal greco l'opera di Galeno e le opere mediche di Paolo Egineta e dal latino le opere mediche di Celio Aureliano. La più importante delle sue opere filologiche è senza dubbio l'edizione commentata della Naturalis historia di Plinio (1584), un lavoro dottissimo e assai apprezzato che lo impegnò per almeno un decennio. Al momento della morte, lasciò manoscritta un'edizione delle opere dei due Seneca, il retore e il filosofo, e una traduzione latina di tutte le opere superstiti di Teofrasto. Furono presumibilmente proprio questi molteplici impegni editoriali ad impedirgli di curare di persona la pubblicazione di Historia generalis plantarum e in definitiva a determinarne il fallimento. D'altra parte l'iniziativa di pubblicare una grande opera illustrata che raccogliesse tutte le piante note agli antichi e ai moderni presumibilmente non venne da lui, ma dall'editore Rouillé; nella prefazione (Lettera al lettore), quest'ultimo scrive: "Più di 20 anni fa, entrando nello studio di Jacques Daléchamps, trovai questo eccellente medico intento a consultare un grosso manoscritto di disegni di piante; la vista di questi disegni rari e squisiti mi fece pensare che avrebbero potuto essere l'infanzia e l'origine di un'opera estesa". Questa versione è confermata dal medico lionese Jacques Pons, una fonte molto affidabile in quanto collega ed amico di Daléchamps. Rouillé (in latino Rovillus), che si era formato a Venezia con i Giolito, era un abilissimo imprenditore che nei suoi 45 anni di attività pubblicò circa 830 testi, spaziando dai classici alla letteratura francese, italiana e spagnola, al diritto, alla religione, alla medicina e alle scienze. Sapeva scegliere i suoi collaboratori ed era perfettamente consapevole che il successo commerciale di un'opera di botanica dipendeva soprattutto dall'apparato iconografico, come avevano dimostrato i recenti esempi di Historia stirpium di Fuchs (1542) e dell'edizione latina illustrata dei Commentari di Mattioli (1554). Non stupisce che sia stata attratto e colpito, più che dal sapere botanico e filologico di Daléchamps, dalla sua grande ed eccellente collezione di immagini. Daléchamps iniziò a collaborare con Rouillé nel 1552 curando il già citato trattato sulla peste; nel 1558 l'editore lo coinvolse in una riedizione del commento a Dioscoride di Amato Lusitano. Stando al sottotitolo, "sono state aggiunte a quest'opera, oltre alla correzione dei lemmi, le annotazioni di R. Constantin nonché le immagini dei semplici di Leonhardt Fuchs, Jacques Daléchamps e altri", il suo ruolo dovette limitarsi a procurare alcune immagini, mentre le altre furono "piratate" da Fuchs ed altri. Della cura del testo si occupò un altro medico e filologo, Robert Constantin. Anche lui era originario di Caen e buon amico di Daléchamps, cui dedicò la sua opera più nota, il Lexicon graeco-latinum (1562). Se già a questa data egli aveva messo insieme quel grosso manoscritto di "disegni rari e squisiti", possiamo ipotizzare che Daléchamps avesse iniziato ad erborizzare, disegnare o far disegnare piante, se non nella sua giovinezza in Normandia, per lo meno negli anni di studio a Montpellier, secondo l'insegnamento di Rondelet, che incoraggiava i suoi allievi a percorrere le campagne alla ricerca di piante. Dovette dunque aderire con entusiasmo al progetto editoriale di Rouillé, che da parte sua si fece carico delle costosissime matrici xilografiche, sia originali, sia copiate da altre opere; mise a disposizione di Daléchamps il suo grande giardino, la Recluserie de Ste Hélène, dove secondo Pierre Jacquet, "i botanici lionesi coltivavano le piante descritte in Historia generalis plantarum"; tramite la sua vasta rete commerciale, gli fece inviare campioni di piante da tutto l'Occidente; infine, gli trovò in successione due aiutanti. Il primo fu Jean Bauhin (1541-1613). Allievo di Fuchs e Gessner, nell'ottobre 1561, appena ventenne, si iscrisse alla facoltà di medicina di Montpellier, laureandosi l'anno successivo. Anche lui allievo di Rondelet, durante il soggiorno in Linguadoca erborizzò intensamente con il condiscepolo Leonhard Rauwolf. Viaggiò poi in Italia e nel settembre 1563 si stabilì a Lione, prendendo alloggio a casa di Rouillé. Qui lavorò a un'opera sulle piante che, secondo diversi commentatori, altro non sarebbe che Historia generalis plantarum. Nel 1568, come protestante, dovette però lasciare la città con la famiglia (nel frattempo si era sposato con una lionese) e rifugiarsi in Svizzera. Nella sua prefazione, Rouillé non fa parola di questa collaborazione, mentre in una lettera scritta circa trent'anni anni dopo, a proposito di Historia generalis plantarum Jean Bauhin scrive "Quando questa storia mi è stata affidata, mi dedicai ad essa con coraggio e con qualche successo". Pierre Jacquet, che verso la fine del Novecento ha dedicato un approfondito articolo ai botanici lionesi del Rinascimento, soffermandosi in particolare su Daléchamps e sull'erbario di Lione, ritiene si tratti di una vanteria, corrispondente all'aspirazione di Bauhin di "essere riconosciuto come collaboratore di questa grande impresa, ma le circostanze hanno fatto sì che la sua partecipazione sia fallita e ne è derivato un grande risentimento". Jacquet è però in controtendenza; generalmente si ritiene che l'opera a cui lavorava Jean Bauhin quando viveva a Lione fosse Historia generalis plantarum e che egli abbia iniziato a lavorare alla sua Historia plantarum universalis molto dopo. Del resto, visto il pessimo giudizio di Bauhin sull'opera, è strano che desiderasse intestarsela. Tuttavia, il suo soggiorno a Lione durò appena cinque anni, il che dovette forzatamente limitare la portata del suo contributo. Daléchamps dovette continuare a lavorare alacremente al grandioso progetto nel corso degli anni '70, da una parte moltiplicando le ricerche sul campo, dall'altra leggendo, annotando, confrontando, chiosando le opere botaniche di antichi e moderni. Jacquet ha documentato una serie di viaggi in Normandia, a Parigi (dove potrebbe aver visitato giardini pubblici e privati con collezioni di piante esotiche), in Alvernia, nelle Cevenne, nel Delfinato, nel Giura, nel Vallese, nella regione di Ginevra. Daléchamps corrispondeva (e scambiava materiali) con molti botanici di primo piano, tra i quali troviamo Gessner, Camerarius e Lobel. Tuttavia, con l'intensificarsi degli altri impegni editoriali - il commento a Plinio, dopo un impegno ventennale, fu completato e pubblicato nel 1587, contemporanemente a Historia generalis plantarum, e in quegli anni Délechamps lavorava anche alle traduzioni di Teofrasto e Seneca - egli dovette rassegnarsi ad affidare ad altri la redazione finale di quella che in una lettera all'amico Camerarius definisce la "nostra opera monumentale sulle piante"; la scelta dell'editore cadde sul medico Jean Desmoulins (1530-1582). Anch'egli aveva studiato a Montpellier, ma probabilmente non fu allievo di Rondelet, morto lo stesso anno della sua iscrizione alla facoltà di medicina; collaborava da tempo con Rouillé per il quale aveva curato la traduzione francese dei Commentarii di Mattioli (Les Commentaires de M. Pierre-André Matthiole, médecin sénois, sur les six livres de P. Dioscoride, 1572 e nuovamente 1579). La natura del contributo di Desmoulins è chiarita dal ben informato Pons che, dopo aver ricordato la genesi dell'opera, il debito con gli antichi e i moderni (cita Mattioli, Dodoens, Anguillara, Fuchs, Lobel e Pena, Bock e un misterioso Tenerus) e le "non poche" descrizioni e immagini messe insieme da Daléchamps, scrive: "Il medico Molinaeus [= Jean Desmoulins], uomo di singolare erudizione e dottrina, con la massima cura e diligenza divise questa massa di piante [ovvero sia quelle raccolte e descritte da Daléchamps, sia quelle ricavate dalle opere di autori antichi e moderni] in ordini e classi, ne aggiunse molte dagli antichi, e anche qualcuna di suo, avvelendosi del consiglio di Daléchamps". Insomma, il suo ruolo fu quello di editor o, se vogliamo usare l'espressione impiegata da Jacquet, di negro, incaricato di trasformare le note più o meno organizzate accumulatesi in 25 anni di lavoro in un testo compiuto. Inoltre contemporaneamente attese a una traduzione parziale in francese. Forse la cosa avrebbe potuto funzionare, se Desmoulins non fosse morto nel 1582, quando era stata completata la stampa solo dei primi 4 libri (su 17 totali). Daléchamps - vecchio, malato, sovraccarico di lavoro - non poteva occuparsene, Rouillé voleva pubblicare a tutti i costi, viste le ingenti spese già sostenute; di fatto, tra dilazioni e ritardi, a occuparsi di quanto rimaneva sarebbero stati i tipografi, con l'accumularsi di errori di ogni tipo. Scrivendone a Clusius in una lettera del 1603, Lobel indica un colpevole: "M. Chaubin [presumibilmente il proto che si occupò della messa in pagina] è imputabile degli errori e dei gravi abusi di questo erbario e di ben 400 figure usate due o anche tre volte per la stessa pianta in paragrafi diversi". Adriaan van der Spiegel nella sua Isagoge in rem herbariam (1606) aggiunge altri responsabili: "si afferma da fonte sicura che [Daléchamps] aveva lasciato incompiuto il suo erbario; così questo libro contiene molti errori dovuti ai copisti che hanno preparato l'erbario per la stampa". Infine i due volumi furono pronti per la fiera di Lione del gennaio 1586 (a causa dell'ennesimo refuso, il primo volume reca la data 1587), ma sul frontespizio non compare il nome di nessun autore; la spiegazione più probabile è che, vedendo il disastro, Daléchamps abbia preferito non figurare come autore di un'opera così sconciata. Forse sperava di firmare una prossima seconda edizione rivista; tuttavia egli morì nel 1588, Rouillé lo seguì l'anno dopo, e il suo erede non aveva alcun interesse a mettere mano a una seconda edizione, tanto più che la prima non era esaurita; solo molti anni dopo, nel 1617, avrebbe pubblicato l'edizione francese nella traduzione di Jean Desmoulins che, al contrario, di quella latina, fu un successo editoriale .  Luci e ombre di un'opera monumentale Per dimensioni e numero di piante trattate si trattava effettivamente di un'opera enciclopedica: due volumi in folio per 2034 pagine complessive, illustrate con 2686 incisioni; le piante trattate sono 2700, molte di più di qualsiasi opera precedente (per fare due soli esempi, in Stirpium adversaria nova di Pena e Lobel erano 1200, in De plantis di Cesalpino 1500). Le piante non sono esposte in ordine alfabetico, ma raggruppate in diciotto categorie, ognuna delle quali occupa un libro. A differenza proprio di Cesalpino o anche di Lobel, non abbiamo a che fare però con un sistema, ma con raggruppamenti eclettici, basati ora sull'habitat, ora sugli usi, ora su caratteristiche delle piante stesse. Iniziando dal Libro I, troviamo gli alberi che crescono spontaneamente nei boschi; quindi gli arbusti che crescono spontaneamente nelle siepi e nei cespugli (libro II); gli alberi piantati nei frutteti (libro III); grani, leguminose e erbe selvatiche che li accompagnano (libro IV); ortaggi e erbe che crescono nei giardini e negli orti (libro V); le ombellifere (libro VI); le piante che piacciono per i loro fiori (libro VII); piante aromatiche (libro VIII); piante palustri (libro IX); piante che crescono in luoghi aspri, sabbiosi, rocciosi o aridi (libro X); piante dei luoghi ombrosi, umidi, fangosi, umiferi (libro XI); piante delle rive del mare e del mare stesso (libro XII); piante rampicanti (libro XIII); cardi e altre piante spinose e pungenti (libro XIV); piante bulbose, con radici carnose e geniculate (libro XV); piante purgative (libro XVI); piante velenose (libro XVII); piante esotiche (libro XVIII), ovvero le plantae peregrinae come si chiamavano allora. È il libro più ampio - oltre 170 pagine -attinto soprattutto da Mattioli, Clusius e Lobel. Segue un amplissimo indice plurilingue (latino, greco, arabo, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese, ceco e inglese) di una cinquantina di pagine. A questo punto l'editore dovette accorgersi che qualcosa rimaneva fuori e volle ancora aggiungere due appendici, la prima sulle piante esotiche poco note, ricavata essenzialmente dalle opere di Acosta e Garcia da Orta, la seconda sulle piante egizie e siriane inviate da Rauwolf. Dalle lettere di Daléchamps a Camerarius sappiamo che questa aggiunta fu un'idea esclusiva di Rouillé, che rallentò ulteriormente la pubblicazione e lo contrariò assai. Da eccellente editore qual era, Rouillé garantì un'opera graficamente curata, con bei capilettera e capitoli chiaramente scanditi da sottotitoli a margine; ogni capitolo è dedicato a una pianta, di cui vengono esposti i nomi (nomina), le sottospecie o tipi (genera), l'aspetto (forma), l'habitat (locus), le proprietà medicinali e gli usi, con riferimenti puntuali e citazioni di antichi e moderni; l'opera vuole infatti presentarsi come una summa di tutto ciò che è stato scritto sulle piante fino a quel tempo. Secondo Jacquet, gli autori citati sono oltre 300. Tra gli antichi i più citati sono Plinio e Dioscoride, tra i moderni Mattioli, Pena e Lobel. Un enorme sovraccarico informativo che è crollato su se stesso quando la cura dell'opera è rimasta abbandonata a Rouillé e ai suoi tipografi. I possibili disastri sono ben esemplificati dalla voce Primula del settimo libro (riprendo l'esempio dal bell'articolo di B. Olgivie The Many Books of Nature: Renaissance Naturalists and Information Overload); dopo averne elencato i nomi, vengono descritti i tre tipi menzionati da Dodoens, cui se ne aggiungono altri tre, per un totale di sei, ma le illustrazioni sono sette. Segue un lungo excursus in cui si discute se questa pianta va identificata con il verbascum di Dioscoride, che risulta del tutto inutile dato che esso viene confuso con verbasculum. Così, quando infine l'opera uscì, per citare ancora Olgivie, "molti contemporanei condivisero l'impressione che fosse una raccolta di note mal editate". Clusius la attendeva con impazienza, ma dopo la sua pubblicazione non la menzionò mai, forse anche offeso dall'omissione di molte piante trattate nelle sue opere. Anche il medico e naturalista sassone Caspar Schwenckfeld ne fu profondamente deluso: in una lettera a Caspar Bauhin, scrive che il libro è stato messo insieme con poco giudizio e in un ordine confuso. Durissimo il giudizio di Jean Bauhin: "A dire il vero, colui che ha messo insieme questo erbario di Lione ha usato i nostri materiali, ma con molte altre cose, li ha accatastati con poco giudizio, talvolta separando i generi dalle specie, talvolta introducendo, spesso a sproposito, descrizioni e rappresentazioni. Ovviamente non poteva fare diversamente, essendo mal informato in materia di piante e poco al corrente delle dotte riflessioni del sapientissimo Daléchamps, che confonde indistintamente con le nostre e quelle di qualcun altro. Ne risulta una storia confusa, mal digerita e senza giudizio e, si potrebbe dire, senza grande utilità per il vero botanico". Se Bauhin poteva essere mosso dal risentimento personale, si deve invece al devoto ricordo dell'amico scomparso e al desiderio di salvare il salvabile l'intervento di Jacques Pons. Nell'opuscolo In Historium generalem plantarum Rouillii, duobus tomis et appendice comprehensam breves annotationes & animadversiones compendiosæ, pubblicato nel 1600, dopo una breve prefazione utile per ricostruire la genesi dell'erbario di Lione, egli elencò e corresse 294 errori, per la più tipografici e non sostanziali. Pons dimostra grande ammirazione per Daléchamps, non critica l'opera in sé e di fatto il suo è un errata corrige, di cui infatti gli eredi Rouillé tennero conto nell'approntare l'edizione francese (Histoire générale des plantes, sortie latine de la bibliothèque de M. Jacques Daléchamps, puis faite française, par M. Jean de Moulins, 1615). Hanno invece tono e intento demolitorio le Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam pubblicate nel 1601 da Caspar Bauhin; le sue critiche puntano in particolare contro le descrizioni e le figure prese di peso da altre opere e soprattutto il pasticcio delle figure, 400 delle quali sono ripetute due o anche tre volte. Le tristi vicende editoriali della sua opera botanica hanno finito anche per occultare a lungo il contributo personale di Daléchamps non come erudito o chiosatore di opere altrui, ma come botanico sul campo. Il primo ha sottolineare questo aspetto fu forse Dominique Villars nel 1786 scrivendo: "Quanto ne avrebbe guadagnato la reputazione di Dalechamps se, invece di affidare le sue note a medici che poco sapevano di botanica, a tipografi, a gente che voleva racchiudere tutto in una storia generale, avesse potuto redigere egli stesso e darci ciò che aveva visto, senza obbligare G. Bauhin a scrivere [...] un libro per rilevare gli errori grossolani in cui essi erano caduti". Qualche anno dopo, in Historia rei herbariae (1807) Curd Sprengel diede un primo elenco di 57 piante del Lionese e della Francia occidentale descritte per la prima volta da Daléchemps; tuttavia, il suo contributo come pioniere dello studio della flora delle Alpi occidentali è stato messo in luce solo all'inizio del Novecento dallo svizzero Hermann Christ. Nel suo articolo più volte citato, Jacquet ha infine individuato "131 piante nuove descritte da nostro semplicista lionese", fornendone l'elenco con i nomi di Daléchamps e quello attuali. Nel mare magnum di Historia generalis plantarum, rappresentano appena il 6%, ma sono sufficienti a dimostrare che non sbagliava Linneo in Philosophia botanica a classificare il nostro non solo tra i "commentatori degli antichi" (pensava certo al suo Plinio), ma anche tra i "descrittori utilissimi".  Una pianta degli orti e un genere singolare Il XVI capitolo del V libro, quello sulle umili piante degli orti, è dedicato a Hieracium. Se ne illustra il nome in greco, latino e francese, quindi si passa ai tipi: "Dioscoride gli assegna due tipi, il grande e il piccolo, ai quali Daléchamps aggiunge Hieracium macrocaulon [...]. Quest'ultimo prende il nome dalla lunghezza del fusto". Questo "Hieracium" dal fusto lungo e sottile oggi si chiama Hypochaeris radicata ed in realtà era già stato descritto da Dodoens e Lobel. La vera novità è il supposto H. magnum di Dioscoride, di cui Daléchamps, contestando la precedente identificazione di Mattioli, fornisce una propria illustrazione e un'accuratissima descrizione. Sono le prime in assoluto di una pianta che ancora porta il suo nome: è il boccione maggiore Urospermum dalechampii. Ma, per volere di Plumier confermato da Linneo, Daléchamps è ricordato anche da un genere esotico, che mai vide e conobbe. Dalechampia (famiglia Euphorbiaceae) è un grande genere di un centinaio di specie diffuso soprattutto dal Messico all'America tropicale, con un numero minore di specie in Africa, Madagascar e Asia meridionale; il numero maggiore di specie si concentra invece in Brasile, con una settantina di specie e una cinquantina di endemismi. È caratterizzato da fiori unisessuali secondariamente uniti in infiorescenze bisessuali (pseudanthia) che fungono da unità di impollinazione. Ciascuna infiorescenza, a simmetria bilaterale, è caratterizzata da due brattee grandi e vistose oppure piccole e ridotte a stipole, un pleiocasio di 4-50 fiori staminati (maschili) e una cimetta di 1-3 fiori pistillati (femminili); diverse specie sono munite di ghiandole resinifere. La singolarità dei fiori, unici in questa famiglia (tanto che il genere è l'unico rappresentante di una propria tribù, Dalechampiinae), e la grande varietà di forme di impollinazione ne hanno fatto uno dei gruppi più studiati tra le Euphorbiaceae. La maggior parte delle specie neotropicali sono impollinate da femmine di varie specie di imenotteri che usano la resina per costruire i nidi; una dozzina di specie è però impollinata da imenotteri maschi, che si servono della resina profumata per attirare le femmine. Le specie asiatiche sono impollinate da api Megachile racoglitrici di resina, mente quelle malgasce lo sono sia da api raccoglitrici di resina sia da api raccoglitrici di polline. Le Dalechampia sono prevalentemente rampicanti, in alcuni casi liane, più raramente arbusti o suffrutici. Hanno rami cilindrici, in alcune specie muniti di peli urticanti, morfologia fogliare molto varia, con foglie da intere a composte, con lamina lineare, obovata, cordata, lanceolata, talvolta profondamente lobata, con grande variabilità anche nello stesso individuo. Alcune specie con brattee vistosamente colorate sono talvolta coltivate; quella più comunemente offerta dai vivai è Dalechampia aristolochiifolia, con brattee viola, anche se, a causa della scorretta identificazione iniziale, è per lo più commercializzata come D. dioscoreifolia. Fresco di laurea, il medico di Basilea Werner de Lachenal si affrettò ad inviare la sua tesi ad Albrecht von Haller. Per anni, mentre lavorava come medico e farmacista, ne fu uno dei più assidui corrispondenti, informatori e raccoglitori, divenendo un reputato esperto della flora di Basilea e del Giura. Solo dopo diversi anni ottenne la cattedra di anatomia e botanica presso l'Università di Basilea, illustrandosi con due benemerenze: fece rinascere l'orto botanico universitario, pagando in gran parte di tasca propria, e salvò quanto rimaneva dell'erbario di Caspar Bauhin, oggi perla dell'erbario di Basilea. A ricordarlo il bellissimo genere di bulbose sudafricane Lachenalia, che meriterebbe di essere coltivato più spesso. 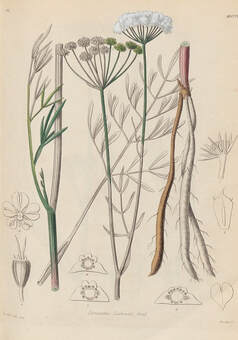 Una lunga collaborazione con von Haller Come abbiamo visto in questo post, per ottenere gli esemplari e le informazioni necessari alle due edizioni della sua monumentale flora della Svizzera, Albrecht von Haller si servì, oltre della raccolta diretta, di una vasta rete di informatori, corrispondenti, raccoglitori. Ciò divenne tanto più indispensabile quando l'età, la gotta e la corpulenza lo costrinsero a delegare ad altri il grosso del lavoro di raccolta. I candidati ideali erano giovani medici o studenti di medicina, di cui nel suo saggio Making Natural History: Doing the Enlightenment, Bettina Dietz ha tracciato un identikit: "essere fisicamente abbastanza robusti da far fronte alle fatiche di escursioni in montagna protratte per diverse settimane; avere una buona conoscenza della botanica; avere scarse pretese per i pagamenti, che Haller sborsava di tasca propria; seguire le sue istruzioni su cosa cercare; consegnare ad Haller il bottino delle loro escursioni botaniche in ottimo stato". Quando entrò in contatto con von Haller, il neo-medico di Basilea Werner de Lachenal (1736-1800), che fu uno dei principali raccoglitori-informatori per Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, apparve subito riunire tutti in requisiti. Figlio di un farmacista, fu egli stesso avviato alla farmacia, per poi iscriversi all'università di Basilea; nel 1755 ottenne il titolo di magister di filosofia e nel 1759 la licenza per esercitare la medicina con una tesi (Specimen Inaugurale Observationum Botanicarum) dedicata ad alcune piante poco note o mal determinate della flora locale. Si affrettò a mandarne copia a von Haller che ne fu piacevolmente colpito, gli rispose con una lettera di elogi e gli chiese di inviargli campioni di alcune di quelle specie rare. La corrispondenza proseguì mentre il giovane medico completava la sua formazione all'università di Strasburgo e il tirocinio pratico a Montbéliard con il medico di corte del Württemberg David Charles Emmanuel Berdot. Avendo ormai verificato la sua preparazione e la sua affidabilità, Haller gli propose una prima escursione botanica per suo conto e a sue spese, che nell'estate del 1760 portò Lachenal nel Vallese e nelle Alpi Graie fino al Piccolo San Bernardo. L'estate successiva, insieme a un altro giovane medico, Jean Jacques Châtelain (1736-1822), lo inviò fino a Mendrisio in Canton Ticino. un'area che riteneva quasi inesplorata. Anche se Lachenal fu piuttosto deluso della flora della meta designata, molto meno ricca di quanto pensasse, durante il viaggio fece molte raccolte e ne informò puntualmente von Haller, così soddisfatto del lavoro dei due botanici da elogiarli con insolito calore: "Non potevo sperare di riunire in un medesimo viaggio due compagni di uguale ardore. E' impossibile che l'uno superi l'altro per perizia e per passione". L'anno dopo avrebbe ancora voluto inviare Lachenal in Valtellina e in Engadina, ma questa terza spedizione non avvenne mai. Per il medico di Basilea era infatti ora di pensare a una sistemazione stabile. Haller aveva sì cercato di usare tutta la sua influenza per fargli assegnare una cattedra a Gottinga, ed egli era stato incluso nella terna dei nomi selezionabili, ma non si era andati oltre. Nel 1763 Lachenal conseguì il dottorato in medicina, quindi rilevò la licenza decennale per una farmacia. Con gli impegni professionali come medico e farmacista, i lunghi viaggi erano fuori discussione; continuò invece ad esplorare la flora dei dintorni e quella del vicino Giura borgognone e a soddisfare con sollecitudine le richieste di Haller, che non di rado gli chiedeva di procurargli questa o quella pianta. Raccoglieva anche per sè, in vista di una flora della regione di Basilea. La relazione tra Lachenal e Haller non era ovviamente paritaria, ma tipicamente quella tra discepolo e maestro; una volta il bernese giunse persino a rimproverare il suo giovane corrispondente per aver usato il nome linneano per designare Trifolium fragiferum; al che Lachenal ritenne necessario giustificarsi, spiegando che aveva usato quel nome perché al momento non ne aveva a disposizione nessun altro La corrispondenza tra i due botanici svizzeri durò 18 anni (dal 21 aprile 1759 al 31 giugno 1774). Durante questo lungo periodo, che lo vide trasformarsi da giovanissimo neolaureato in affermato medico di mezza età e riconosciuto esperto della flora locale, oltre che con moltissimi invii di campioni di erbario, Lachenal si rese utile al suo maestro come correttore delle bozze dei supplementi alla flora elvetica (Emendationes et auctaria ad stirpium Helveticarum historiam), pubblicati presso un tipografo di Basilea; compito difficilissimo e ingrato, vista l'impazienza di Haller e la sua grafia sempre più illegibile.  La rinascita dell'orto botanico La grande svolta nella vita di Lachenal, forse inattesa persino per lui, avvenne nel 1776, quando per sorteggio gli fu infine assegnata la cattedra di anatomia e botanica all'università di Basilea. Era una cattedra prestigiosa con una lunga storia: quella di anatomia era stata creata addirittura nel 1571 da Felix Platter, grande anatomista e allievo di Rondelet a Montpellier, a sua volta maestro di Caspar Bauhin che nel 1589 fondò l'orto botanico universitario, uno dei più antichi d'Europa e il fu il primo titolare della cattedra di anatomia e botanica. Quando Lachenal assunse la cattedra, erano glorie del passato. Il suo predecessore Johann Rudolf Stähelin (titolare della cattedra di anatomia e botanica dal 1753, dal 1776 passò alla cattedra di medicina teorica) all'insegnamento preferiva l'esercizio della professione e i segni della trascuratezza si facevano sentire. Da un sopralluogo di quello stesso anno il teatro anatomico risultò "così fatiscente che rischiava di crollare da un momento all’altro”. Lachenal suggerì addirittura di demolirlo e trasferirlo nell'orto botanico; il consiglio cittadino preferì ristrutturarlo, rendendolo più ampio e luminoso. Né migliore era la sitazione dell'orto botanico; c'era un solo giardiniere, che, salvo qualche piccola regalia occasionale, non riceveva alcun salario; di fatto, gli era stato permesso di trasformare l'orto botanico in orto, frutteto e vigna, dalla vendita dei cui prodotti ricavava il suo unico reddito. Nel 1754 il Comune fece costruire una modesta casetta, composta da un atrio, due stanze e alcuni locali laterali, che serviva sia da appartamento del professore sia da auditorium per le lezioni. Anch'essa era inadeguata. Lachenal chiese la ristrutturazione del giardino, condizioni migliori per il giardiniere, un appartamento dignitoso per il professore. Offrì di pagare un quarto delle spese e di cedere all'università la sua biblioteca; in cambio, chiedeva di mantenere la cattedra vita natural durante e il versamento di una pensione alla moglie, nel caso gli fosse sopravvissuta. Nell'agosto 1777 le condizioni furono accettate e i lavori procedettero abbastanza celermente. L'orto botanico poté disporre di un budget annuale e da quel momento rinacque. Venne anche costruita una serra che, a quanto pare, Lachenal pagò di tasca propria. Nel venticinquennio in cui insegnò all'università di Basilea, egli acquisì una solida reputazione internazionale, anche se non pubblicò quasi nulla. Corrispondeva con numerosi colleghi, con i quali scambiava esemplari d'erbario, scriveva articoli per qualche rivista, ma non riuscì mai a completare e pubblicare la sua flora di Basilea (Catalogus stirpium Basiliensis). Conosciamo la sua esistenza, oltre che dalla corrispondenza con von Haller, che più volte lo sollecitò a concluderla, da diverse testimonianze contemporanee, ma dopo la morte di Lachenal l'opera scomparve. Il manoscritto incompleto è stato riscoperto solo nel 1987 durante lavori di ristrutturazione dell'Istituto botanico di Basilea e rimane inedito. Presumibilmente, Lachenal lo aveva lasciato in eredità all'istituto botanico, insieme a tutti i suoi libri e al suo erbario, di enorme importanza storica perché egli vi aveva incluso l'erbario di Caspar Bauhin, che aveva acquistato da un discendente del grande botanico intorno al 1774. Contrariamente all'uso del tempo, l'erbario di Bauhin non era rilegato, ma costituito da fogli sciolti, che egli poteva così facilmente riorganizzare per i suoi lavori tassonomici. Ciò ne aveva però favorito anche la dispersione, perché nel corso dei decenni la famiglia Bauhin aveva permesso a diversi botanici di consultarlo e anche di attingervi; quando Lachenal lo acquistò, era ridotto a un terzo dell'originale. Nuovamente separato da quello di Lachenal, oggi costuisce una collezione separata dell'erbario di Basilea ed è preziosissimo, sia come testimonianza del lavoro di uno dei padri fondatori della botanica moderna, sia come uno dei pochissimi erbari rinascimentali giunti fino a noi, Quanto all'erbario personale di Lachenal, comprendeva circa 3000 specie, in prevalenza elvetiche, ma anche un certo numero di esotiche, ottenute da corrispondenti o orti botanici; è interessante notare che per etichettare le piante svizzere egli usò le denominazioni di von Haller, per tutte le altre quelle di Linneo.  Splendide bulbose sudafricane A ricordare Lachenal è oggi un busto nell'orto botanico di Basilea che ebbe il merito di far rinascere, l'eponimo di alcune piante più o meno rare che fu il primo a raccogliere o segnalare, come Hieracium lachenalii, Carex lachenalii, Festuca lachenalii e Oenanthe lachenalii, ma anche il bellissimo genere sudafricano Lachenalia, omaggio di Joseph Franz von Jacquin (il figlio di Nikolaus) che era uno dei suoi corrispondenti e gli fece visita quando passò dalla Svizzera durante il suo viaggio in Europa del 1788-91. In una lettera dell'ottobre 1790 al padre, lo ricorda con grande affetto e gli chiede di scrivergli per ringraziarlo delle tante cortesie che gli ha dimostrato. Ma a ben vedere lo aveva già ringraziato lui anticipatamente (la dedica risale al 1784) dedicandogli questo notevolissimo genere. Lachenalia (famiglia Asparagaceae) comprende circa 130 specie di bulbose perenni originarie della Namibia e del Sudafrica, distribuite in zone con piogge invernali; durante la stagione estiva, calda e arida, vanno in dormienza per poi entrare in vegetazione alle prime piogge autunnali; la fioritura, che è di relativamente lunga durata, avviene in inverno o all'inizio della primavera. Le foglie, che in alcune specie sono emesse prima dei fiori, in altre quasi contemporaneamente ad essi, sono basali e spesso graziosamente maculate, così come gli steli fiorali. I fiori campanulati, tubolari o cilindrici sono raccolti in spighe o racemi; a seconda delle specie, le corolle presentano una grande varietà di colori, dal bianco al rosa, dal lilla all'azzurro, dal giallo all'arancio e al rosso vivo. Il colore più raro e straordinario è il verde-turchese dei fiori di L. viridiflora. In varie specie, i fiori sono molti colori grazie agli apici più scuri. Le dimensioni dei bulbi e delle piante in fioritura sono molto varie, dai 5 cm di L. ensifolia e L. flava ai 40 di certe varietà di L. aloides. Lachenalia ha una lunga storia orticola, ma non è mai diventatomun genere popolare. La prima attestazione è un disegno dell'attuale L. hirta, risalente alla spedizione del Namaqualand del 1685-1686; da quel momento varie specie, sotto vari nomi, fecero qua e là la loro comparsa nel mercato dei bulbi e nelle raccolte dei collezionisti; il primo a studiare sistematicamente questo genere fu però verso la fine del Settecento von Jacquin padre, grazie alle raccolte sudafricane dei cacciatori di piante di Schönbrunn; come ho anticipato, il genere fu creato nel 1784 da suo figlio. Mano a mano che venivano scoperte nuove specie, con la loro grande varietà di dimensioni, forme e colori, attirarono l'attenzione degli ibridatori; il primo ibrido riconosciuto venne realizzato nel 1888 dal reverendo John G. Nelson, incrociando L. reflexa e L. aloides. A partire dal 1965, un vasto programma di ibridazioni è stato avviato dal Roodeplant Vegetable and Ornamental Plant Institute del Sudafrica; lo scopo era produrre, più che bulbi da giardino, fiori da taglio (i fiori di Lachenalia durano da due a quattro settimane) e piante fiorite in vaso per l'esportazione. I primi ibridi furono commercialmente disponibili nel 1997-1998, ma il programma fu rallentato da vari fattori, che vanno dall'isolamento politico del paese a causa dell'apartheid alle peculiarità del clima sudafricano che resero difficile adattare le condizioni di crescita di crescita all'emisfero nord. I primi ibridi (è la serie African Beauty) furono commercializzati alla fine del secolo, ma la risposta del mercato europeo fu minore di quanto sperato; il potenziale di queste splendide piante è ancora in gran parte da scoprire. Sono ancora soprattutto piante da collezionisti, piuttosto costose e non sempre facili da reperire. Anche in Olanda sono essenzialmente commercializzate da specialisti di bulbose rare; talvolta, come altre bulbose sudafricane, come Albuca o Ledebouria, sono offerte tra le succulente. Eppure sono bellissime e, a quanto pare, di non difficile coltivazione. Morto a soli 35 anni senza aver pubblicato nulla, il botanico inglese Edmund Davall - visse però gran parte della sua vita adulta in Svizzera - non avrebbe lasciato molte tracce di sè se non fosse stato amico e assiduo corrispondente di James Edward Smith, presidente e fondatore della Linnean Society. Una selezione delle sue lettere, pubblicata nelle memorie di Smith, ci fanno conoscere da vicino questo giovane di grande sensibilità e humour, un vero figlio del preromantcismo diviso tra l'entusiasmo per la natura e la malinconia di quello che considerava un vero e proprio esilio. Grazie a Smith, a ricordarlo ci sono soprattutto le bellissime felci del genere Davallia. Una vita attraverso le lettere Nel 1832, la vedova di James Edward Smith, Pleasance Reeve Smith, completò e pubblicò le memorie del defunto consorte, che includono una scelta della sua ampissima corrispondenza. Come sottolineava Mme de Lessens nella sua recensione di Memoirs and Correspondence of Sir James Edward Smith, "tra i corrispondenti più gradevoli di Mr. Smith, c'è un giovane svizzero, Mr. Davall di Orbe, entusiasta della botanica, della natura e del grande apprezzamento che ricevono in Inghilterra. Le sue lettere sono assai piacevoli". Queste lettere sono quasi tutto ciò che rimane di questo sfortunato botanico, morto troppo presto e senza aver potuto pubblicare nulla. Al contrario di quanto scrive Mme de Lessens, Edmund Davall (1762-1798) non era propriamente svizzero, ma piuttosti anglo-elvetico. Era infatti nato a Londra dall'omonimo Edmund Davall, ufficiale di approvvigionamento dell'ammiragliato, e da Charlotte Thomasset, figlia di una vedova svizzera che si era trasferita nella capitale inglese dove insieme alle sue figlie gestiva con un certo successo una scuola per giovinette. Come racconta egli stesso in una delle sue lettere al "più caro degli amici" Smith, benché avesse un'inclinazione per le scienze naturali, il loro studio non aveva fatto parte della formazione del giovane Edmund. Si interessava però di giardinaggio, e aveva acquistato una copia di The Gardeners Calendar di Miller, dove per la prima volta vide uno schema del sistema linneano, Ne fu "istantaneamente ispirato" e decise di "perseguire uno studio che certamente mi avrebbe procurato maggior felicità di qualsiasi progetto volto a un vantaggio pecuniario". Iniziò dunque a studiare la botanica da autodidatta e nel febbraio 1784 arrivò in Svizzera, deciso a esplorare la flora delle sue montagne. Si stabilì a Orbe, nella casa delle sue numerose zie Thomasset che erano tornate in Svizzera intorno al 1777; pochi mesi dopo, il padre morì in seguito a un'ampitazione e la madre decise di tornare in patria. Quattro anni dopo sarebbe morta anche lei, lasciando definitivamente legato il figlio a Orbe e alle "buone vecchie zie", di cui nelle lettere egli traccia un memoriabile ritratto dolce-amaro. Se in Inghilterra erano considerate povere, in Svizzera un piccolo patrimonio e qualche terra al sole le facevano senz'altro rientrare nella "bonne societé". Amavano ricevere e trascorrevano ore intere a giocare alle carte. A sentire il nipote, il jeu de Quadrille era la loro unica passione e il loro unico argomento di conversazione, al punto che una di loro sarebbe "letteralmente morta con le carte in mano". La migliore stanza della casa era dedicata alle interminabili partite di carte che riunivano il "gregge troppo numeroso" della buona società di Orbe, "eternamente desideroso di ammazzare il tempo che non sapeva come impiegare" e che esprimeva "la sua stima per chi aveva interessi intellettuali con un'alzata di spalle". Per sfuggire alla noia, Davall si gettò più che mai nella botanica. Creò un giardino che curava personalmente e intensificò le escursioni alla ricerca di piante da trapiantare e da montare nel suo erbario. Orbe sorge in un'amena posizione nel cuore del Giura svizzero; con una breve passeggiata si può raggiungere la cima del Suchet, dalla quale si gode uno splendido panorama sugli altopiani del Giura e su tutto l'arco alpino. Sulle sue pendici calcaree Davall trovò una flora particolare e interessante. Nell'estate del 1787 scoprì alcune piante rare in compagnia di Albrecht von Haller junior, il figlio omonimo del grande von Haller. Davall avea infatti cominciato a farsi conoscere nell'ambiente dei botanici svizzeri, in ciò incoraggiato da Charles Victor de Bonstetten, ultimo balivo di Nyon e membro del "gruppo di Coppet", un sodalizio intellettuale informale che si riuniva attorno a Mme de Stael e Benjamin Constant. Entrò così in contatto con il pastore e naturalista di Berna Jakob Samuel Wyttenbach, con il pastore, bibliotecario e botanico di Ginevra Jean Senebier e con il professore di anatomia e botanica dell'Università di Basilea Werner de Lachenal. Saussure nel suo Voyage dans les Alpes ricorda di avergli fatto visita ad Orbe. Nel 1784, munito di lettere di presentazione di Wyttenbach e Senebier, Davall partì per Londra e si presentò a James Edward Smith che aveva da poco creato la Linnean Society. Smith lo accolse con grande affabilità, lo ospitò in casa sua, lo presentò ai suoi amici e lo fece entrare nella Linnean Society, di cui Davall fu così uno dei primissimi membri. Da parte sua, Davall intodusse Smith presso la marchesa di Rockingham, con la quale forse era in contatto grazie alla posizione del padre all'ammiragliato. La nobildonna, grande appassionata di piante esotiche, avrebbe poi ispirato a Smith le magnifiche Icones pictae, in cui Sowerby ritrasse numerose piante coltivate nelle serre e nei giardini di Hillingdon. I giardini inglesi con le loro collezioni di piante esotiche, le società scientifiche con le loro animate discussioni, la grande considerazione in cui era tenuta la botanica entusiasmarono Davall e fecero del soggiorno londinese "il periodo più memorabile e felice della mia vita", nonostante cominciassero già amanifetarsi imprimi segni di una salute malferma. Lui e Smith erano quasi coetanei e strinsero una profonda amicizia, destinata a durare quanto la sua vita, anche se dopo il suo ritorno a Orbe non si sarebbero mai più incontrati. Continuarono invece a scriversi con assiduità; le lettere di Davall, pervase dall'entusiasmo e dal sentimento religioso per la natura, ma anche da quello che egli stesso definisce mal du pays, ovvero dalla nostalgia per l'Inghilterra, piacevolissime e spesso piene di humour, informano di gioie e dolori (il matrimonio, la nascita dei figli, la dolorosissima morte della primogenita a soli undici mesi), dei fastidi di una piccola vita di provincia, delle aspirazioni intellettuali presto frustrate da un ambiente chiuso, dalle necessità pratiche, ma soprattutto da una salute sempre più traballante. Nella casa di Orbe, dove il salotto buono rimaneva intoccabile santuario all'eterno gioco di carte, poté ricavare per sè solo un piccolo studio, dove un "angolo sacro" riuniva le opere di Linneo, il suo modesto erbario e due prezosi cimeli incorniciati sotto vetro: un esemplare di Diapensia lapponica, raccolto da Linneo in persona, dono dell'amico Smith ("un frammento della vera croce è meno prezioso per un cattolico bigotto"), e uno di Smithia sensitiva. Una grande fonte di piacere era il giardino, che egli coltivava di persona dedicandogli molto tempo e cura; e un'altra le escursioni botaniche in montagna. Ne riportava piante per il suo giardino ed esemplari che essiccava per il suo erbario e che spediva regolarmente all'amico Smith. Visitò ripetutamente il Suchet, ma le lettere documentano anche viaggi a più ampio raggio: attraversò il ghiacciaio di Valsorey nel Vallese alla ricerca di una pianta segnalata da von Haller e si spinse fino al Gran San Bernardo. Sappiamo che lavorò a lungo a un saggio sulla flora svizzera, ma non riuscì a terminarlo. Più ancora delle contingenze della vita materiale, a impedirglielo furono i problemi di vista sempre più gravi e una salute sempre più precaria. Le lettere stesse incominciarono a diradarsi. Davall iniziò l'ultima il 13 febbraio 1798. Ma ormai stava così male che non poté finirla; Smith l'avrebbe ricevuta solo dopo la sua morte. Certo avrà letto con grande commozione le ultime righe: "a lungo la mia più cara e unica speranza è stata quella di incontrare il mio amico in un mondo diverso e migliore". A informarci degli ultimi mesi di Davall sono le lettere a Smith di un altro amico comune: il veterinario Bracy Clark. Tra il 1797 e il 1798 egli fu impegnato in un grand tour continentale, anche se le condizioni di guerra gli impedirono di visitare la Francia. Soggiornò invece per qualche tempo in Svizzera; nel dicembre 1797 a Berna fece visita a Wyttenbach che lo informò che l'amico di Smith Davall aveva sofferto gravemente, forse di una paralisi, e gli scrisse una lettera di presentazione per lui. Il cattivo tempo e copiose nevicate impedirono a Clark di recarsi ad Orbe fino alla fine di marzo. Davall lo accolse cordialmente e lo ospitò a casa sua; era assai provato nel corpo e profondamente turbato dalla situazione politica, con i venti della rivoluzione che soffiavano anche in Svizzera. Durante l'estate, che Clark trascorse per lo più a Orbe, sembrò migliorare; poi la situazione precipitò e il 27 settembre Davall morì, ad appena 35 anni. Onorando le sue ultime volontà, la vedova fece pervenire a Smith la lettera mai terminata, l'erbario, i libri e i manoscritti del marito. Quest'ultimi sono tuttora conservati nella biblioteca della Linnean Society, mentre l'erbario è andato perduto. Nel pubblicare la corrispondenza di Davall con il marito, Pleasance Reeve scrive: "Assomigliava all'amico scelto dal suo cuore nel calore e nella devozione degli affetti, ma poté resistere meno di lui ai mali della vita. Molti passi delle lettere [...] mostrano il valore, la tenerezza, il raro affetto, la devozione alla scienza, il suo amore per la natura strettamente legato all'amore di Dio [...]. Se qualcuno considerasse [questi sentimenti] troppo acuti o riprovevoli, si ricordi che «quei teneri desideri che assorbivano la sua anima, logoravano il suo spirito, minavano la sua salute», erano i dolori di un uomo esiliato. Lasciamo che coloro che possono comandare a piacimento tanto il piacere quanto la società contemplino con profonda compassione il generoso e disinteressato Davall".  Rizomi con la pelliccia Nella speranza che l'amico con le sue opere occupasse prima o poi il posto che gli spettava nella scienza delle piante, fin dal 1793 Smith aveva provveduto ad eternarne il nome con la dedica del genere Davallia, scrivendo: "Ho dedicato questo nuovo genere con grandissimo piacere al botanico instancabile e acutissimo, amabile di carattere, così come illustre per scienza, Edmund Davall, membro della Linnean Society, che vive in Svizzera". Gli dedicò anche Carex davalliana, una specie che cresceva copiosa nelle aree unide di orbe e che Davall aveva distinto per primo. Al contrario della insignificante Smithia - una dedica lievemente maligna, come ho raccontato in questo post, di cui il presidente della Linnean Society avrebbe volentieri fatto a meno - il genere dedicato all'amico del cuore è davvero un dono sontuoso. Davallia è l'unico genere della famiglia Davalliaceae (alcuni studiosi però preferiscono classificarla nelle Polypodiaceae, intese in senso largo) e raggruppa una cinquantina di specie di felci epifite o litofite delle aree tropicali e subtropicali del Vecchio mondo e dell'Australia. La caratteristica più evidente sono i lunghi rizomi aerei grazie ai quali si abbarbicano sulla corteccia degli alberi o si insinuano nelle fessure delle rocce. Intricati e solitamente ricoperti da fitte squame simili a una pelliccia, le hanno guadagnato nomignoli come "felce ragno", "felce zampa di coniglio", "felce zampa di scoiattolo". Curiose e molto decorative, diverse specie sono apprezzate come piante da interni. Alcune però sono rustiche e possono essere coltivate in giardino. È il caso della giapponese D. mariesii, una piccola felce decidua con sottili rizomi pelosi e fronde triangolari, che può essere utilizzata come coprisuolo in angoli ombrosi e umidi. Meno resistente al freddo è invece D. canariensis, una specie originaria della Macaronesia e del Mediterraneo occidentale (Marocco e penisola iberica occidentale), che in natura cresce sui tronchi e i rami degli alberi e sulle rocce silicee umide e muschiose, soprattutto dove può godere dell'umidità oceanica. Da noi viene solitamente coltivata in vaso o anche su zattera o bark per orchidee, in modo da godere dell'intrico delle radici che si interesecano e pendono al di fuori. Tra le specie solitamente coltivate all'interno, la più nota è probabilmente D. solida var. fejeensis, originaria delle isole Figi, un'epifita caratterizzata da rizomi densamente ricoperti da squame grigio-rosate e da brevi fronde triangolari. Per mettere in risalto la bellezza dei rizomi, è spesso coltivata in cestini appesi, così come D. tyermannii, originaria della Cina e dell'Asia orientale, nota anche come felce tarantola o felce ragno per l'intrico di lunghi rizomi pelosi che evocherebbero a questi animali. A Bex i Thomas non erano i soli a raccogliere piante e a commercializzare campioni d'erbario e semi di piante alpine. A far loro concorrenza, negli ultimissimi anni del Settecento e nei primi due decenni dell'Ottocento, c'era il farmacista di origini tedesche Johann Christoph Schleicher, che fu il primo ad avere l'idea di pubblicizzare il suo commercio prima con annunci in riviste scientifiche, poi con un catalogo che comprendeva circa 2000 piante e giunse a quattro edizioni. Pubblicò anche a più riprese cataloghi specifici per le crittogame. Per qualche anno ottenne un notevole successo, come testimonia la presenza dei suoi campioni negli erbari di moltissime istituzioni e di qualche pianta nata dai suoi semi nei cataloghi dei vivai inglesi. Poi si fecero sentire l'età e la concorrenza del molto più giovane e aguerrito Emmanuel Thomas, tanto che fu costretto a vendere il suo erbario e terminò i suoi giorni in miseria. Oltre all'eponimo di diverse specie, lo ricorda il genere asiatico Schleichera (Sapindaceae). 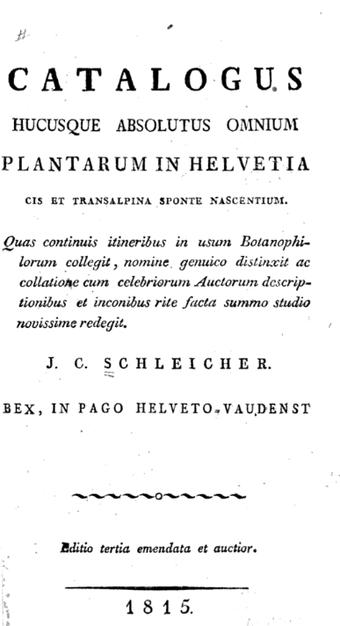 Campioni d'erbario e semi a modico prezzo Intorno al 1790, si stabilì a Bex nel Vaud un giovane di origine tedesca, Johann Christoph Schleicher (1768/70-1834), che nella nuova patria si sarebbe fatto chiamare anche Jean Charles. Talvolta viene definito dottore, ma era piuttosto farmacista, e difficilmente, per la giovane età, avrà avuto una formazione completa. Dei suoi primi anni sappiamo pochissimo. Incerta è la stessa data di nascita, 1768 secondo alcune fonti, 1770 secondo altre. Nato a Hofgeismar nell'Assia da Anna Marie Sawitzky, ebbe inizialmente il cognome materno per poi assumere quello con cui è noto quando fu adottato da un certo Carl Schleicher. Nulla sappiamo della sua formazione; secondo varie fonti, incluso il data base biografico dell'Università di Gottinga, il botanico Heinrich Schräder sarebbe stato il suo padrino; la notizia è certamente priva di fondamento per banali ragioni anagrafiche: i due erano praticamente coetanei, essendo nato Schräder nel 1767. Al momento dell'arrivo di Schleicher, a Bex il ricordo (e il magistero) di Albrecht von Haller era tenuto vivo, oltre che dall'attività commerciale della famiglia Thomas, dai medici Bernard Jean François e Jean David Ricou. Bernard Jean François Ricou (1730-1798), medico cittadino, farmacista e capo chirurgo dell'ospedale, negli anni '50 era stato uno dei raccoglitori di von Haller, per il quale aveva erborizzato nelle valli di Saint-Nicolas e di Bagnes e nelle regioni del Sempione, del Gran San Bernardo, di Alesse e di Fully. Nel 1764, insieme al pastore Abram-Louis Decoppet, pubblicò nelle "Memorie della società economica" di Berna una lista di 128 piante della flora elvetica con i nomi in dialetto, francese e latino (Essai d'une collection de noms vulgaires ou patois des principales plantes de Suisse). Certamente si deve a lui la creazione del "bell'erbario" segnalato nel 1804 nella guida della Svizzera di Johann Gottfried Ebel, all'epoca di proprietà del figlio Jean David, anch'egli medico. Schleicher dovette legarsi strettamente alla famiglia Ricou (probabilmente lavorò per loro come aiuto farmacista e nel 1797 sposò Julie, figlia di Jean David) e fu probabilmente l'esempio delle raccolte di Bernard Jean François a spingerlo a sua volta a percorrere le montagne alla ricerca di piante rare. Il suo scopo era chiaramente commerciale: l'opera di von Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici e degli amatori sulla flora elvetica e il mercato di campioni d'erbario era fiorente. Dotato di notevole spirito imprenditoriale, ispirato dall'esempio di raccoglitori di piante tedeschi, già nel 1794, nel numero 41 della rivista di Lipsia "Annalen der Botanik" Schleicher, sotto forma di lettera ai signori Le Royer e Tingry, proprietari di un'importante farmacia di Ginevra, offrì in vendita, al prezzo di 2 talleri francesi, una centuria di piante svizzere, assicurando la consegna in 4-6 settimane. Altre due centurie avrebbero fatto seguito nel numero successivo, pubblicato lo stesso anno. Nel 1796, ancora su "Annalen der Botanik" la snelle centurie si trasformarono in una più ambiziosa lista di quasi 700 "piante raccolte nel Vallese e nelle Alpi vicine nel 1795 da Schleicher", indicate con un nome binomiale, preceduto però (tranne un'appendice di una quarantina di specie scoperte successivamente alla pubblicazione di quest'opera) dal numero con cui compaiono in Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata di von Haller; non compaiono più né prezzi né indicazioni esplicite del fine commerciale, non perché Schleicher avesse cambiato intenzioni, ma probabilmente perché aveva ormai una clientela consolidata. Due anni dopo, sempre sulla stessa rivista, comparve una seconda lista sotto il titolo "Indice delle piante raccolte nel Vallese e nella Svizzera transalpina nel 1796 da C. Schleicher"; le modalità erano le stesse, ma la lista si era allungata, passando da 9 a 12 pagine, e, soprattutto, ora compariva a parte un elenco di 84 Musci & Algae (in realtà ci sono anche felci e numerosi licheni). Si trattava di un nuovo segmento di mercato che, come vedremo, sarebbe diventato una specialità del raccoglitore tedesco. Poi, nel 1800, il salto di qualità. Con quello che dovette essere un notevole impegno anche finanziario, Schleicher pubblicò a Bex quello che è considerato il primo catalogo commerciale di piante svizzero, Catalogus plantarum in Helvetia cis- et transalpina sponte nascentium; il sottotitolo precisa: "raccolte dall'autore con continui viaggi ad uso dei botanofili e verificate con sommo studio sulle descrizioni e le immagini degli autori più celebri". Nel volumetto di una settantina di pagine sono elencate circa 2000 piante, con il nome binomiale seguito dal nome d'autore e preceduto, nella maggior parte dei casi, dal rinvio numerico all'opera di Haller. Mentre le felci sono elencate nel catalogo generale, sono presentate nuovamente a parte alcune centinaia di Musci, Algae et Fungi. A chiudere il catalogo, una selezione di semi "raccolti e offerti da Schleicher"; come facevano anche i Thomas, anche i semi, come i campioni d'erbario, erano per lo più raccolti in natura. Anzi, da questo punto di vista sembra che Schleicher non andasse tanto per il sottile; secondo una nota pubblicata nel "Bulletin de l’Association pour la protection des plantes" del 1884, "distrusse [appositamente] diverse specie al solo scopo di aumentare il valore dei campioni che vendeva agli erbari, rendendole rare". Almeno alcune piante tuttavia dovevano essere coltivate nell'orto botanico che Schleicher aveva creato a Bévieux, non lontano dalla salina. Sempre secondo la guida di Ebel, meritava una visita; dopo aver parlato dell'erbario di Ricou, egli ci informa inoltre che "Suo genero M. Schleicher, abile erborizzatore che ha percorso gran parte delle montagne della Svizzera occidentale e meridionale, ha un consideravole magazzino di piante essiccate che vende per un luigi il centinaio. Ha scoperto una quantità di specie prima sconosciute in Svizzera". Per qualche anno il commercio di piante di Schleicher dovette andare a gonfie vele; numerosi suoi campioni sono presenti nei principali erbari europei; era in corrispondenza con molti importanti botanici (vendette molti esemplari a Balbis e ci è rimasta una lettera a Persoon); forniva semi al celebre vivaio londinese Loddiges che lo cita come fornitore di varie piante alpine offerte per la prima volta sul mercato britannico. L'ampliamento dell'offerta è testimaniato dalle successive edizioni del catalogo (1807, 1815, 1821, le ultime due con il titolo Catalogus hucusque absolutus omnium plantarum in Helvetia cis et transalpina sponte nascentium), e da una serie di cataloghi specifici, uno riservato ai salici (1807) e diversi alle crittogame (Plantae Cryptogamicae Helvetiae 1803-1807), parzialmente riprodotti nella rivista diretta da Schräder "Neues Journal für die Botanik", nella quale nel 1805 Schleicher pubblicò anche il resoconto di un viaggio nella Svizzera italiana. Nelle liste delle crittogame si precisa che esse erano state reccolte e essicate da Schleicher; la precisazione è significativa se considerimo che al raccoglitore tedesco si deve l'introduzione del sublimato corrosivo (cloruro di mercurio) per la trattazione dei campioni d'erbario. Tra riedizioni, supplementi e cataloghi specifici, le pubblicazioni si intensificarono tra il 1803 e il 1808, poi intorno al 1815 il successo dovette cominciare a declinare. Ne è spia la curiosa iniziativa che Schleicher prese nel 1816: una lotteria il cui premio era costituito da exsiccata. Probabilmente, incominciava a farsi sentire la concorrenza dei fratelli Thomas, che avevano pubblicato il loro primo catalogo intorno al 1806. Seguendo il loro esempio, nel catalogo del 1815, Schleicher aggiunse all'offerta minerali e plantule di conifere; c'erano anche campioni di erbario di piante esotiche, provenienti da Francia meridionale, Italia e Ungheria, e prezzi differenziati: cento esemplari costavano 36 lire francesi per acquisti di meno di 200 campioni, 30 lire da 200 a meno di 400, solo 24 lire da 400 in su. Offriva inoltre erbari completi della flora Svizzera, collezioni di piante medicinali, i semi di "tutte le piante che si coltivano o si possono coltivare in giardino" al costo di 24 lire il centinaio, piante a radice nuda pronte da piantare a 6 soldi l'una quelle erbacee, 9 soldi quelle arbustive e arboree. L'offerta non finiva qui. Leggiamo infatti: "Quest'anno e i seguenti, se Dio vorrà, a casa mia nel villaggio subalpino di Bex, darò lezioni di botanica - un corso completo di questa scienza - ai giovani botanici che me ne faranno richiesta. Quando il tempo lo permetterà, accompagnerò gli allievi in escursioni botaniche, non solo perché vedano e raccolgano le piante nel loro luogo natale, ma anche perché osservino con me le caratteristiche della flora d'altitudine. Mostrerò loro il metodo per essiccare le piante durante il viaggio stesso, in modo che conservate nel modo più perfetto possano ornare l'erbario". Lezioni in lingua francese e prezzi da concordare. Sei anni dopo, nella quarta e ultima edizione, escursioni botaniche e lezioni private non ci sono più (ora Schleicher era sulla cinquantina, e probabilmente non se la sentiva più). Scompaiono anche i minerali, mentre rimangono inalterati prezzi e offerta di exisiccata, erbari completi, semi e piante vive. Compare invece una nuova postilla che ci informa su cosa coltivasse Schleicher nel suo giardino botanico: "Oltre alle piante svizzere, coltivo un grande numero di sassifraghe esotiche, indicate in una speciale appendice in calce al catalogo. In questo giardino spuntano già diverse specie dei generi Aconithum, Delphinium, Narcissus e Allium di cui gli amanti di questi generi possono trovare presso di me un catalogo annuale, sia delle specie che possiedo sia di una moltitudine di piante esotiche che giungono per scambi con gli amici". Non abbiamo traccia di questi cataloghi annuali (erano forse manoscritti? o non furono mai realizzati?). In ogni caso, gli anni felici erano orami alle spalle. Vecchio e malato, Schleicher non poteva più salire in montagna e per sopravvivere dovette smantellare il suo prezioso erbario personale. Contrasse molti debiti; tra i suoi creditori c'era anche Emmanuel Thomas, al quale fu costretto a cedere, come pagamento, tutte le crittogame dell'erbario e diversi generi di fanerogame. Nel 1832 si rivolse al Consiglio di Stato per mettere in vendita quanto rimaneva: "Dal momento che la mia età e la mia salute non mi consentono più di salire in montagna e di continuare il mio commercio di piante, mi vedo costretto a vendere la mia biblioteca e il mio erbario per vivere". Le autorità incaricarono della perizia il direttore delle saline Jean de Charpentier, che provvide con l'assistenza dell'amico Emmanuel Thomas; nella sua relazione, emerge che l'erbario delle piante straniere (circa 10.000) "un tempo veramente magnifico, ha considerevolmente perso valore perché ne sono state tolte le specie più rare e interi generi"; per contro, il lotto di 4073 specie e varietà della flora svizzera "era ed è ancora unico nel suo genre, perché è senza discussione la collezioni più completa e curata della Svizzera. Vi si trovano non solo le piante selvatiche, ma anche le variazioni che subiscono in coltivazione". La vendita andò in porto e l'erbario delle fanerogame fu acquistato dal Museo di scienze naturali di Losanna. Schleicher investì una parte del ricavato per riscattare gli esemplari che aveva dovuto cedere a Emmanuel Thomas. Morì due anni dopo, nel 1834; nel 1837 gli eredi vendettero allo stesso museo l'erbario delle crittogame. La parte più preziosa di questa collezione è costituita dai licheni; nella proposta d'acquista dei conservatori del museo leggiamo: "Questa collezione, composta da più di 1060 campioni, la maggior parte su pietra o legno, è preziosa da ogni punto di vista [...]. Ha grande valore agli occhi dei botanici perché i campioni sono stati determinati con cura e perché è il frutto del lavoro di molti anni ed ha potuto essere formata solo a prezzo di pene, cure e spese".  Dalla Svizzera all'Asia sud-orientale Il significativo ruolo per la conoscenza della flora elvetica di questo farmacista divenuto cacciatore e commerciante di piante alpine è testimoniato dalla sua notevole presenza nella nomenclatura botanica. In primo luogo, anche se i suoi cataloghi sono meri elenchi, grazie al riferimento numerico alla flora di Haller (che, lo ricordo, usava nomi polinomiali, quindi non validi) ha introdotto alcuni nomi validi, come Hieracium canescens e Cnicus nudiflorus. Più numerose le denominazioni risalenti a lui ma introdotte attraverso altri autori che lo conobbero, erborizzarono con lui o furono sui clienti, come Campanula excisa introdotto da Murith, Phyteuma umile, Pedicularis ascendens e Festuca valesiaca introdotti da Gaudin, Lotus alpinus introdotto da Ramond. Una ventina di taxa portano in suo onore gli epiteti schleicheri e schleicherianus; si tratta di specie delle Alpi elvetiche per lo più presenti nei suoi cataloghi o nel suo erbario, ma in qualche caso anche da lui introdotte nei giardini britannici attraverso i vivai che acquistavano i suoi semi. Quattro sono tuttora validi: Alpagrostis schleicheri, Erigeron schleicheri, Fumaria schleicheri, Rubus schleicheri. Nel 1806 Willdenow, direttore di uno degli orti botanici cui forniva campioni e sementi, quello di Berlino, gli dedicò il genere Schleichera, purtroppo senza esplicitare la motivazione; si limitò infatti a scrivere "Ho nominato questo genere in memoria del celebre Schleicher, svizzero". Con questo genere monotipico della famiglia Sapindaceae ci allontaniamo dalle Alpi svizzere per spostarci sulle pendici dell'Himalaya, sull'altopiano del Deccan e nelle foreste del sudest asiatico. Il suo unico rappresentante S. oleosa è infatti un albero tropicale presente soprattutto nelle aree aride e aperte del subcontinente indiano, di Ceylon, della Thailandia e dell'Indonesia. L'epiteto è dovuto all'alto contenuto di olio dei suoi semi; quest'ultimo, noto come olio di kusum, dal nome più comune della pianta in India, viene utilizzato per la cura dei capelli, ma anche come combustibile, in cucina e come unguento medicinale. Lo svizzero Albrecht von Haller fu una delle personalità più eminenti del secolo dei Lumi. Come poeta, ha mutato il modo di vedere la montagna, ha influenzato il sentimento romantico della natura e lanciato la moda delle escursioni alpine; come medico, ha distinto le funzioni dei nervi da quella dei muscoli e dato la prima descrizione completa delle funzioni del corpo umano; genio universale, poligrafo, giornalista e polemista, i suoi scritti si contano a migliaia, incluse le 9000 recensioni di pubblicazioni su argomenti che vanno dalla filosofia alla religione alla politica alla letteratura alle scienze naturali; ha influenzato il pensiero di personalità tanto diverse tra loro come Kant, Schiller e Hegel. Come botanico, ha donato alla Svizzera la flora più completa del suo tempo. Non era né amabile né modesto, anzi adorava la polemica, e Linneo era uno dei bersagli preferiti dei suoi strali; tuttavia non gli ha fatto mancare la dedica del vistoso genere Halleria. 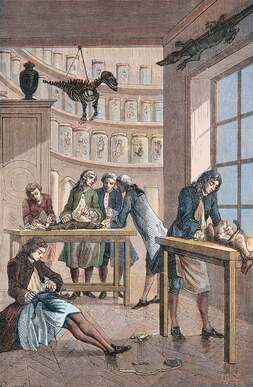 Poeta, fisiologo, bibliografo... Nel luglio 1777, di ritorno da Parigi, dove si era recato anche per risolvere l'imbarazzante situazione matrimoniale della sorella Maria Antonietta (a sette anni dalle nozze, mancava ancora un erede, per una ragione molto semplice: il matrimonio non era mai stato consumato), l'imperatore Giuseppe II passò da Berna. Viaggiava in incognito, sotto il nome di conte di Falkestein, e fece visita a una sola persona: il medico e scienziato Albrecht von Haller (1708-1777); tralasciò invece Ferney, con grande disappunto di Voltaire. Haller era da tempo malato (sarebbe morto pochi mesi dopo) e ricevette l'augusto e inatteso il visitatore in veste da camera e berretto da notte, semisdraiato su una bergère. L'imperatore conversò con lui per oltre un'ora, riconoscendo in quel vecchio piegato dalla malattia almeno lo spirito che l'aveva reso uno degli uomini più ammirati dell'Europa dei Lumi. A commento dell'episodio, nella mostra che il Museo storico di Berna dedicò al più illustre dei bernesi in occasione del trecentenario della nascita leggiamo: "Il segno di ammirazione più prestigioso gli fu tributato dall'imperatore d'Austria Giuseppe II che andò a fargli visita nella sua casa di Berna". E prosegue: "Un erudito universale e enciclopedico: Albrecht von Haller fu uno degli ultimi a poter abbracciare tutte le conoscenze del suo tempo". La sua cultura era vastissima e la sua opera ha lasciato un'impronta profonda nei campi più disparati: come poeta e cantore delle Alpi, mutò la concezione della montagna e lanciò la moda del turismo alpino in Svizzera; come medico, gettò le basi della moderna fisiologia del corpo umano; come botanico, scrisse la prima flora completa della Svizzera. Ma si occupò anche politica, della relazione tra scienza e fede, scrisse tre romanzi, creò una delle biblioteche più importanti d'Europa (ben 23.000 volumi). La sua corrispondenza conta quasi 17.000 lettere, scambiate con 1.139 corrispondenti. Haller (per quarant'anni non ci sarà alcun von davanti al suo cognome) era figlio di un avvocato e funzionario; dopo la formazione iniziale nella città natale, adolescente iniziò gli studi di medicina a Tubinga, poi li continuò a Leida dove fu allievo del grande Boerhaave, che gli trasmise un metodo strettamente sperimentale. A Leida incontrò un altro svizzero affamato di conoscenza, lo zurighese Johannes Gessner, con il quale strinse una fervida amicizia. Dopo la laurea nel 1727, approfondì gli studi di medicina a Londra e a Parigi; qui assistette a molti interventi chirurgici, praticamente tutti mortali, e decise che non sarebbe stato chrirugo, ma anatomista. A Parigi ritrovò anche Gessener, con il quale andò a Basilea per seguire i corsi di matematica di Bernoulli e nell'estate fece un memorabile viaggio a piedi nel Giura e nelle Alpi. Reduce dal soggiorno parigino, fu profondamente colpito dalla maestosità delle Alpi e dalla semplicità della vita dei loro abitanti, che contrapponeva a quella artificiosa e corrotta dei cittadini; sono i sentimenti che ispirarono il più celebre dei suoi poemi, Die Alpen ("Le Alpi"), scritto nel 1729. Come vedremo meglio più avanti, l'incontro con le montagne fu anche quello con la flora alpina. Per qualche anno fu attivo come medico a Berna, dove creò un teatro anatomico, ma non ebbe molto successo; dal 1735 fu bibliotecario della città. Anche se aveva già iniziato le ricerche di fisiologia e botanica che lo avrebbero reso famoso, in questi anni era noto soprattutto come poeta (è del 1732 la raccolta Versuch schweizerischer Gedichte): la sua è una poesia filosofica, in cui riflette sulla fede e sui limiti della ragione, sull'origine del male, sull'eternità. Aspirava a una carriera politica e polemizzò ferocemente contro la corruzione e la degenerazione oligarchica del governo della sua città; ciò finì per chiudergli tutte le porte. Nel 1736, quando le sue candidature a medico cittadino e professore di eloquenza furono respinte, decise di accettare la cattedra di anatomia, chirurgia e botanica all'Università di Gottinga. L'università Georg-August era appena nata (era stata fondata due anni prima dall'elettore di Hannover, ovvero dal re d'Inghilterra Giorgio II), Gottinga era ancora una cittadina di provincia, non mancarono le difficoltà e i lutti privati (la morte delle prime due mogli), ma si respirava un'atmosfera aperta di libera ricerca. Haller creò il teatro anatomico, l'orto botanico e la prima clinica ostetrica di Germania. Come insegnante, attirò frotte di studenti da tutta la Germania. All'insegnamento poté affiancare un'ampissima attività sperimentale; grazie a non meno di 350 autopsie e a esperimenti sistematici sugli animali (purtroppo sì, su di essi praticava la vivisezione) diede una descrizione completa del sistema arterioso, approfondì le conoscenze sulla respirazione e lo sviluppo del feto e dimostrò che l'irritabilità è dovuta ai muscoli e la sensibilità ai nervi. Cominciarono a susseguirsi una serie di opere monumentali, a cominciare dai sette volumi di Erläuterungen zu Boerhaaves Institutiones (1739-1744) e dagli otto fascicolo delle Icones anatomicae (1743-1756), per culminare con gli otto volumi di Elementa physiologiae corporis humani (1757-1766). In questo testo di riferimento fondamentale, riedito fino all'inizio del Novecento, che lo fece salutare "padre della fisiologia", diede una descrizione completa delle strutture del corpo umano e delle loro funzioni. Non meno importante il suo ruolo come organizzatore culturale. Nel 1747 fu nominato direttore scientifico della rivista Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, che nel 1752 mutò il titolo in Göttingische Gelehrte Anzeigen e dal 1753 divenne l'organo della Società reale delle Scienze di Gottinga. Di quest'ultima, fondata nel 1751 per volontà di Giorgio II, fu uno dei soci fondatori e presidente a vita. La rivista, seguitissima anche al di fuori della Germania, aveva (anzi ha, visto che ancora esiste ed è la più antica rivista scientifica di lingua tedesca ancora in attività) carattere universalistico e pubblicava recensioni critiche delle pubblicazioni tedesche e straniere in campo letterario, scientifico, economico, storico, ecc. Per Haller divenne la palestra dove esercitare il suo sapere enciclopedico e il suo spirito critico (e non di rado la sua vis polemica). Continuò a scrivervi anche dopo il ritorno a Berna, pubblicando più di 9000 recensioni. Inoltre collaborava con moltissime altre riviste scientifiche, sulle quali pubblicava soprattutto articoli di medicina e botanica. La fama e gli onori incominciarono a moltiplicarsi. Nel 1743 fu ammesso alla Royal Society, nel 1747 all'Accademia delle Scienze svedese; le università di Oxford e Utrecht gli offrirono una cattedra, le rifiutò così come l'invito di Federico II a trasferirsi a Berlino. Accolse invece con soddisfazione il cavalierato e il titolo onorifico di medico di corte conferitogli da Giorgio II e il titolo nobiliare che venne dall'imperatore Francesco. Ma il suo vero sogno era tornare in patria e ottenere il meritato riconoscimento di una carriera pubblica. Fin dal 1745, benché risiedesse a Gottinga, era membro del Gran consiglio della città e nel 1753, rifiutato per la seconda volta l'invito di Federico II, tornò a Berna. Come si sa, nemo profeta in patria. I maggiorenti della città non aveva dimenticato le satire politiche dell'età giovanile. Ottenne solo incarichi di secondo piano: dal 1753 al 1757 fu intendente di palazzo della città (Rathausammann); fu eletto presidente della Società economica e cofondatore dell'orfanatrofio. Nel 1758 fu nominato direttore delle saline di Roche nel Vaud e dal 1762 vicegovernatore d'Aigle; fino al 1764, quando l'incarico terminò, visse a Roche, dove ebbe modo di estendere i suoi studi ai modi più economici per ricavare il sale e poté riprendere le ricerche sulla flora alpina. Nel 1764 acquistò la signoria de Goumoens-le-Jux e assunse il nome di Haller von Goumoens. Fece poi ritorno a Berna. Tra il 1764 e il 1773, per ben nove volte, si candidò al Piccolo consiglio, ma non fu mai eletto. Nel 1769, fu richiamato a Gottinga nella veste di cancelliere, ma rifiutò in seguito alla nomina ad assessore perpetuo del Consiglio della sanità di Berna. A trattenerlo a Berna era anche la salute ormai compromessa. Da ragazzo, era stato malaticcio, ma poi le camminate e le scalate lo avevano reso un agile e vigoroso alpinista. A Göttingen, con il superlavoro, vennero l'insonnia, i mal di testa feroci, lo stomaco in disordine. Con l'età si aggiunsero verigini, artrite, gotta, obesità, una tormentosa infezione delle vie urinarie. Per ritrovare il sonno ed alleviare il dolore incominciò a ricorrere all'oppio; ne divenne dipendente e dovette assumerme quantità sempre maggiori. I suoi ultimi anni furono quelli di un valetudinario, precocemente invecchiato. Eppure riuscì ancora a scrivere un'altra opera gigantesca, la quattro Bibliothecae, in parte pubblicate postume: Bibliotheca botanica (1771-72), Bibliotheca anatomica (1774-1777), Bibliotheca chirurgica (1774-1775), Bibliotheca medicinae practicae (1788). Si tratta di una bibliografia completa, e spesso di un esame critico, di tutto ciò che era stato pubblicato su queste materie dall'antichità ai suoi tempi, per un totale di 52.000 titoli. Nei suoi ultimi anni, la maggiore preoccupazione di von Haller andava alla sorte della sua immensa biblioteca. Dopo la sua morte, gli eredi la vendettero al governo austriaco, a condizione che fosse mantenuta intatta; destinata alla Lombardia, fu invece smembrata tra varie biblioteche. I due fondi più consistenti sono conservati alla Braidense di Milano e alla biblioteca universitaria di Pavia, con circa 3000 volumi e altrettante dissertazioni. A Pavia era giunto anche l'immenso erbario di Haller; durante la Campagna d'Italia nel 1796 i francesi se ne appropriarono e fu portato a Parigi; dopo la caduta di Napoleone, il governo austriaco non lo reclamò (scarso interesse per la botanica?) e lì è rimasto. I suoi 59 volumi in folio sono oggi conservati all'Herbier national presso il Museum d'Histoire naturelle. 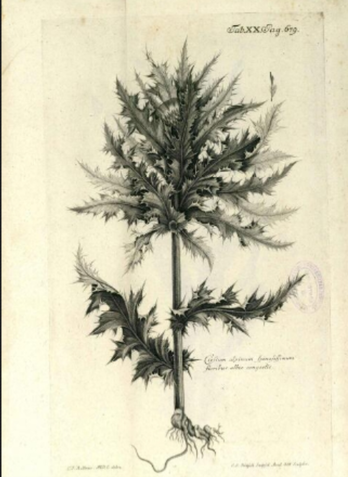 E botanico! Quel gigantesco erbario era frutto degli invii dei suoi numerosissimi corrispondenti, ma in larga parte anche delle raccolte dirette di van Haller che nella sola Svizzera compì almeno 25 escursioni botaniche. Infatti la botanica, dopo la fisiologia e l'anatomia, fu il campo scientifico cui più applicò il suo genio. Egli aveva trascorso l'infanzia in una piccola proprietà a circa cinque km da Berna, sulla riva dell'Aar, tra una collina e una foresta, un paesaggio amato che indirizzò i suoi futuri sentimenti verso la natura. All'epoca la botanica (dalle piante si ricavano gran parte dei medicamenti) faceva parte del bagaglio professionale di ogni medico, e certo Haller l'avrà studiata già a Tubinga, ma il primo contatto documentato avvenne a Leida, dove il venerato maestro Boerhaave nella stagione propizia aveva l'abitudine di iniziare ogni giornata didattica con una rituale visita all'orto botanico, circondato dai suoi studenti. La botanica era già una passione per l'amico Gessner, che prima di spostarsi a Leida aveva raccolto un erbario nello zurighese e sulle Alpi. È possibile che, quando studiavano insieme a Basilea, sia stato lui a proporre di percorrere a piedi i distretti alpini della Svizzera occidentale e centrale durante le vacanze accademiche, anche e soprattutto per raccogliere piante. Se fino ad allora per Haller il loro studio aveva fatto parte del necessario bagaglio professionale, quel viaggio fatidico ebbe il senso di una duplice scoperta: delle Alpi e dei loro abitanti, cantati nel suo celebre poema, e delle piante alpine. Dopo il ritorno a Berna nella primavera del 1729, Halle rcominciò a dedicare il tempo libero agli studi botanici; fece molte spedizioni, brevi o lunghe, in diverse valli alpine e fino alla sua partenza per Gottinga ogni anno dedicò a questi viaggi botanici almeno un mese delle vacanze estive. Per quest'uomo iperattivo e fondamentalmente asociale, che oggi definiremmo senza mezzi termini workaholic, le lunghe escursioni, le scalate anche impegnative, il contatto con la gente semplice della montagna, la raccolta e la metodica preparazione delle piante alpine aveva anche un forte valore terapeutico. Lettore compulsivo, accompagnava la ricerca sul campo con lo studio metodico di tutto ciò che era stato scritto e si andava scrivendo sulla scienza delle piante; aveva grande venerazione per i grandi botanici del passato, e in particolare per Tournefort, la cui opera a suo parere segnava un tale spartiacque che in Bibliotheca botanica intitolerà il primo tomo "Epoche prima di Tournefort" e il secondo "Da Tournefort ai nostri tempi". Tuttavia il suo approccio era totalmente diverso; anche in botanica era essenzialmente un empirico e rifiutava una netta gerarchia tra classi, ordini, generi. Il suo stesso concetto di specie era aperto e sfumato (e sorprendentemente moderno): al contrario di Linneo, che credeva nella fissità delle specie, immutate dal momento della creazione, egli aveva invece constatato che in natura la variabilità è la norma: non solo la vegetazione muta con l'ambiente e l'altitudine, ma la stessa pianta cresciuta in ambienti diversi, oppure in natura o in coltivazione, assume caratteristiche differenti. Strumento essenziale per studiare questa variabilità era l'erbario, dove raccoglieva molti esemplari della stessa pianta in diversi stadi di sviluppo raccolti in più località e habitat. Mentre andava preparando un'opera complessiva sulla flora svizzera, pubblicò su varie riviste scientifiche brevi articoli di argomento botanico o monografie su generi specifici, come De alii genere naturali (1745); infine nel 1742, diede alle stampe la prima versione della sua flora svizzera, Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, in due volumi, corredati da 24 eccellenti tavole disegnate dal pittore ginevrino Jean Huber e incise dall'artista di Gottinga G.D. Heumann. Mentre il suo amico Johannes Gessner fu uno due primi ad adottare il sistema linneano, Haller lo considerava del tutto lontano dalla natura; si sforzò dunque di creare un proprio sistema "naturale" basandosi su un insieme di caratteristiche, e in particolare la mancanza o la presenza di fiori e semi, le caratteristiche dei fiori e quelle dei semi. A inaugurare l'opera sono le tre classi delle "piante apetale prive di stami", ovvero alghe, funghi, licheni, "piante apetale prive di stami cospicui", ovvero muschi, licopodi, marsilie, "piante con semi prive di fiori e apici cospicui", ovvero le felci. Seguono le piante "dotate di petali e stami cospicui", suddivise in un numerose classi, generi e ordini (una categoria inferiore al genere, corrispondente grosso modo al sottogenere). Di ogni specie è data una breve diagnosi, che ne è anche il nome polinomiale, seguita dai sinonimi degli autori precedenti, una descrizione più dettagliata, informazioni sulla localizzazione e l'habitat (mai così attente e dettagliate in nessun autore precedente); concludono, ove noti, gli eventuali usi medici e economici. Rilevante per il gran numero di specie descritte e per l'attenzione riservata a distribuzione e habitat, l'opera è particolarmente notevole per le crittogame, molte delle quali descritte per la prima volta. Essa fu pubblicata a Gottinga, che Haller aveva trasformato in un importante centro di studi botanici con la creazione di un orto botanico che si ispirava a quello di Leida. Presto si arricchì di piante fatte venire dai quattro angoli del mondo e divenne una delle principali attrazioni della città. Haller ne diede anche il catalogo; inoltre completò e pubblicò Flora jenensis di Heinrich Bernhard Ruppius. Intanto continuava ad arricchire il suo erbario grazie agli invii dei suoi corrispondenti, perfezionava il suo sistema e meditava una seconda edizione della sua flora. A dare nuovo impulso alle sue ricerche sulla flora elvetica fu però la nomina a sovrintendente delle saline e il trasferimento a Roche, nel cuore delle montagne del Vaud. Riprese a percorrere le montagne, ma soprattutto ingaggiò, perché raccogliessero per lui, le guardie forestali delle saline; i più attivi ed abili si rivelarono Pierre e Abraham Thomas. Anche altri raccoglievano per lui; citiamo almeno il giovane Horace Bénédict de Saussure che fece la sua prima escursione nella Valle di Chamonix proprio come raccoglitore di von Haller. Il risultato non fu una semplice seconda edizione, ma una nuova opera fortemente ampliata, Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, in tre volumi, pubblicata a Berna nel 1768. Secondo Cuvier, "a quei tempi era la più ricca flora d'Europa". Arricchito era anche l'apparato iconografico, con 25 tavole aggiuntive. Complessivamente, tra piante da fiore, felci, muschi, licheni, alghe e funghi, le specie trattate sono circa 2000; le specie descritte per la prima volta, prevalentemente alpine, sono circa 300. Il primo volume si apre con una prefazione di enorme importanza storica, De plantis Helveticis, in cui von Haller illustra le caratteristiche geografiche, climatiche, geologiche del paesaggio elvetico, individua una serie di ambienti naturali e analizza la distribuzione delle specie in base all'altitudine e al clima, giungendo anche a definire diverse associazioni vegatali. È insomma un vero saggio di fitogeografia che non mancherà di influenzare Humbold. Rispetto all'ancora incerto sistema di Enumeratio methodica, Haller ha fatto enormi passi nella ricerca di un sistema naturale; ora le piante sono raggruppate in diciannove classi, a partire da quelle dotate di petali e stami fino ai funghi ("plantae staminibus nullis"), procedendo quindi in ordine inverso rispetto all'opera precedente. Siamo ancora lontani dal sistema naturale basato sul concetto di famiglia (anche se qualche famiglia naturale fa qua e là capolino), ma il sistema di Haller non mancò di esercitare qualche influenza su de Candolle. De Candolle ruppe con il sistema sessuale di Linneo a favore di sistema naturale, ma mantenne la nomenclatura binaria. Invece von Haller rimase ostinatamente legato alla tradizionale nomenclatura polinomia. Le motivazioni sono molteplici; c'entravano il rispetto per la tradizione e i grandi botanici del passato, la rivalità personale con Linneo, ma soprattutto per lui era inaccettabile una nomenclatura basata sui concetti di genere e specie; abbiamo già visto che concepiva le specie in modo diverso da Linneo; quanto al genere, a parte qualche caso evidente, distaccandosi anche dall'ammirato Tournefort, lo riteneva un'unità artificiale, una creazione speculativa dei botanici. Non comprendendo l'importanza di separare la denominazione dalla determinazione, riteneva i nomi binomi inadeguati e imprecisi. Questa scelta gli costò cara: dato che la nomenclatura binomiale è diventata lo standard, le specie da lui scoperte, prive di un nome binomiale valido, oggi portano nomi stabiliti da altri; qualcuno lo recuperò, adattandolo, il suo discepolo de Saussure.  Alle offese, si risponde con un fiore Fin dalla gioventù, quando si alienò i maggiorenti di Berna con le sue satire, von Haller non si tirava indietro quando si trattava di polemizzare. Polemizzò con Voltaire, di cui lui, luterano profondamente religioso, detestava l'irriverenza, il teismo e la filosofia pessimistica della storia; con il materialismo di La Mettrie, che riduceva il corpo umano a una macchina; con le idee politiche di Rousseau, che pure era un grande ammiratore della sua flora. E soprattutto, polemizzò instancabilmente contrò Linneo, il suo sistema, i suoi nomi, la sua pretesa di essere il "principe dei botanici" e il "nuovo Adamo" che aveva ribattezzato piante e animali. Nelle sue lettere a de Saussure, lo chiamava sarcasticamente "il tiranno del Nord". Al di là delle concezioni profondamente diverse della botanica, contavano molto anche tratti caratteriali e il desiderio di entrambi di imporre la propria supremazia sulla "repubblica delle lettere". Un contemporaneo svedese ebbe a dire: "Assomigliavano a Cesare e Pompeo. Uno, il nostro Linneo, non tollerava uguali, e l'altro, Haller, non tollerava superiori. E vice versa". Per qualche anno i due avevano manifestato reciproca stima, furono addirittura amici di penna e corrisposero a lungo. Nonostante le critiche di Haller alla sua Flora svecica (1743), Linneo manifestò grande apprezzamento per la trattazione della crittogame di Enumeratio methodica e nel 1747 favorì l'ammissione di Haller all'Accademia svedese delle scienze. Poi le cose incominciarono a guastarsi, tra insinuazioni e pettegolezzi dei reciproci entourages, e nel 1749 le relazioni si interruppero definitivamente. Nelle sue recensioni per la rivista di Gottinga, lo svizzero demolì sistematicamente le opere dello svedese e addirittura tra il 1750 e il 1753 incaricò il figlio Gottlieb Emanuel di scrivere una serie di pamphlet contro Linneo. Bisogna ammettere che in questo scontro il più signorile fu quest'ultimo: come aveva promesso al comune maestro Boerhaave non interveniva mai di persona nelle polemiche, e in Species plantarum fu abbastanza magnanimo da confermare la dedica al rivale di un genere che aveva istituito ai tempi della loro amicizia, in Hortus Cliffortianus, Halleria "in onore del dottissimo botanico Albrecht Haller, professor di botanica a Gottinga. E non si tratta di una pianta sgradevole e puzzolente, come la Siegesbeckia affibiata all'odiato Siegesbeck, o di un ritratto vegetale per lo meno ambiguo come Milleria per un altro pervicace oppositore delle denominazioni binomiali, Philip Miller. Le sudafricane Halleria lucida e H. elliptica, le due specie note a Linneo, sono infatti piante di sontuosa bellezza, potremmo dire un omaggio regale. Il genere Halleria (Stilbaceae, in precedenza Scrophulariaceae) comprende cinque specie di alberi e arbusti diffusi nell'Africa tropicale e meridionale e in Madagascar. Per i loro fiori spettacolari in inglese sono dette Tree fuchsia, fuchsia arborea, anche se con le vere fucsie non hanno alcuna parentela. Il centro di diversità è il Sudafrica, dove sono presenti tre specie su cinque, una delle quali (H. ovata) endemica; H. ligustrifolia e H. parviflora sono endemiche del Madagscar; H. lucida ha un ampio areale che va dall'Etiopia al Sudafrica, mentre H. elliptica ha distribuzione digiunta ( Malawi, Sudafrica, Madagascar). La specie di maggiore diffusione è anche probabilmente la più attraente. H. lucida è un piccolo albero dalla chioma arrotondata, con rami elegantemente arcuati e foglie lucide persistenti; diventa spettacolare al momento della fioritura, quando si ricopre di fiori tubolari da arancio a rosso mattone, raccolti in infiorescenze a grappolo alle ascelle delle foglie o portate direttamente sul tronco. Molto attraenti anche i frutti, bacche dapprima verdi poi nere a maturazione, eduli, di sapore dolce ma tendenzialmente allappanti. I fiori sono ricchi di nettare e sono impollinati da uccelli nettarini. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

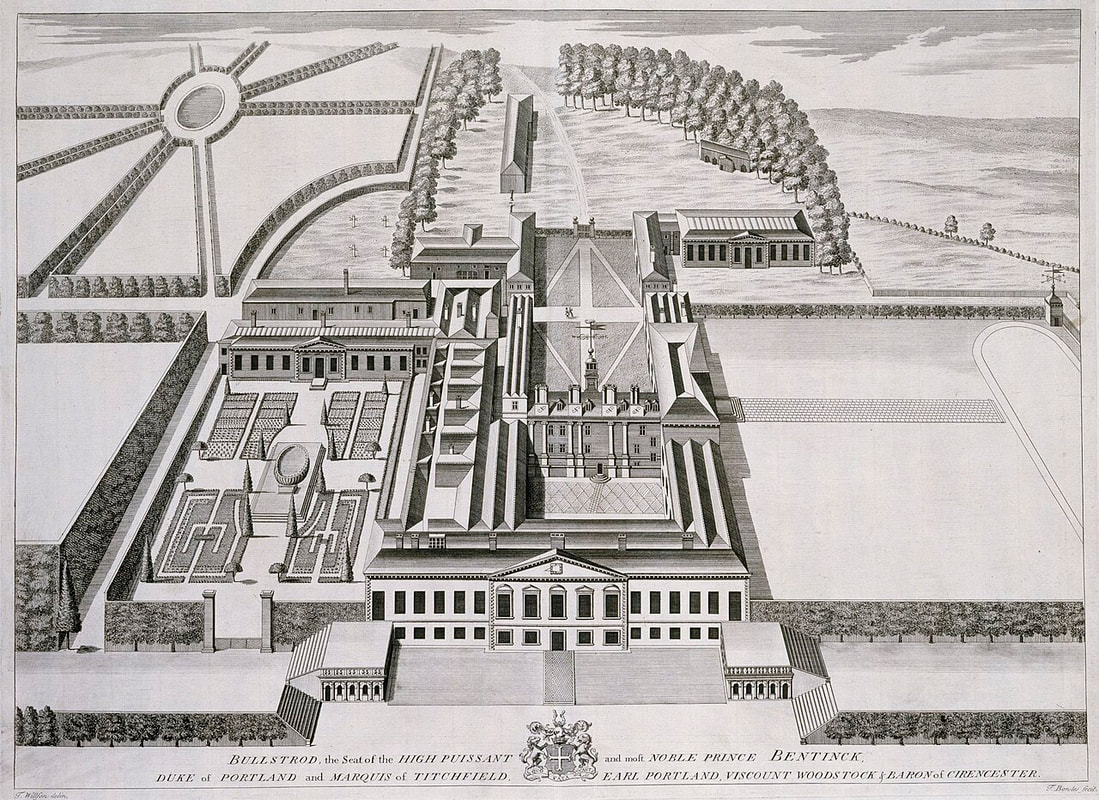


 RSS Feed
RSS Feed