Botanica e indipendenza: i discepoli di Mutis, il movimento indipendentista e il genere Lozania30/6/2022 José Celestino Mutis morì l'11 settembre 1808. Non assistette dunque agli eventi che tra il 20 luglio 1810 e l'agosto 1819 portarono all'indipendenza del Vicereame della Nuova Granada, a partire dal 1831 Repubblica di Colombia. Vi ebbero invece un ruolo di primo piano molti dei suoi discepoli e collaboratori, a cominciare dal nipote Sinforoso Mutis e dal più noto di tutti, Francisco José de Caldas. Sorge spontanea la domanda: la Real Expedición Botánica ebbe anche un contenuto politico? Fu un covo di cospiratori (dal punto di vista spagnolo) o di patrioti (dal punto di vista colombiano)? Gli storici tendono ad escluderlo, sottolineando che le idee di emancipazione, più che nei laboratori della Casa della Botanica, nacquero nelle aule universitarie e nei circoli letterari frequentati anche dai giovani intellettuali creoli reclutati dalla spedizione. Da Mutis però essi furono educati al pensiero libero e rigoroso, al metodo scientifico, agli ideali illuministi, e certo anche la partecipazione alla spedizione rafforzò in loro la coscienza della diversità americana non solo dal punto di vista della natura. Così, allo scoppio dell'insurrezione, guidata da intellettuali come loro, li troviamo in prima fila; una scelta che molti pagarono con la vita. Come naturalista, più di uno ha avuto l'onore di essere ricordato da un genere botanico, ma rimane valido solo Lozania, dedicato a Jorge Tadeo Lozano, zoologo della spedizione e primo presidente della Repubblica di Cundinamarca. 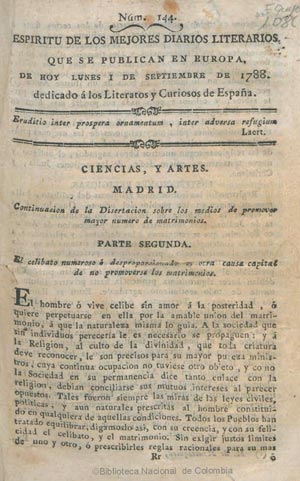 Quale fu la culla dell'indipendenza? A partire dal 1808, in seguito all'occupazione francese della Spagna, le colonie dell'America latina si trovarono isolate dalla madrepatria e le élites creole approfittarono del vuoto di potere per proclamare l'indipendenza. Inizia così un tumultuoso susseguirsi di eventi che, tra guerra tra spagnoli e insorti e guerre civili, si protrarrà fino ai primi anni '30 e sfocerà nella nascita dei paesi latino-americani. Nel Regno di Nuova Granada la rivolta iniziò il 20 luglio 1820. Era venerdì, giorno di mercato e di grande affluenza nella piazza principale di Santa Fé di Bogotà; facendo leva sulle tensioni latenti tra spagnoli e "americani", un gruppo di agitatori riuscì a provocare un'insurrezione che la sera stessa portò alla creazione di una Giunta suprema di governo e alla proclamazione dell'Indipendenza. La giornata era stata attentamente pianificata da un gruppo di intellettuali creoli di idee liberali che da qualche tempo si riunivano in un luogo insospettabile: l'Osservatorio voluto da José Celestino Mutis e diretto dal più noto dei suoi discepoli, Francisco José de Caldas, che fu anche coinvolto negli incidenti del 20 luglio. Tra i firmatari dell'Atto di indipendenza e membri della Giunta suprema anche altri provenivano dalle file della Real Expedición Botánica; José María Carbonell che ne era lo scrivano; Jorge Tadeo Lozano, che dirigeva le ricerche zoologiche; Sinforoso Mutis Consuegra, nipote di Mutis e direttore del ramo botanico della spedizione dopo la morte dello zio. Più tardi si sarebbe unito agli indipendentisti anche il capo dei pittori della spedizione e "maggiordomo" di Mutis, Salvador Rizo Blanco. Ne dobbiamo concludere che la spedizione fu la culla del movimento indipendentista? Non in modo diretto, ma certamente l'insegnamento di Mutis ne gettò le basi, educando un'intera generazione al pensiero scientifico e agli ideali illuministi e aprendola alle nuove idee che venivano dall'Europa. Come notò con stupore Humboldt, l'ambiente intellettuale del vicereame era vivacissimo; a Santafé di Bogotà si pubblicavano diversi giornali; si traducevano libri europei; c'erano circoli letterari e associazioni culturali in cui si incontravano giuristi, giornalisti, scienziati e altri intellettuali e si discutevano appassionatamente idee di riforma. In qualcuna di queste tertulias, come erano chiamate, circolavano idee decisamente radicali; è il caso del Casino Literario che si riuniva a casa di Antonio Nariño (anche lui un ex allievo di Mutis al Colegio del Rosari) ed era frequentato da latri "rosaristi" come Lozano; tra gli habitué uno dei più stretti collaboratori di Mutis, il botanico Francisco Antonio Zea, e il giovanissimo Sinforoso Mutis. La vera culla del movimento indipendentista, dunque, più che la spedizione stessa, furono i collegi universitari e i circoli intellettuali. La posizione personale di Mutis era moderata e prudente e nelle sue lettere traspare grande preoccupazione per le frequentazioni pericolose del nipote e di Zea. La sua vera rivoluzione, è stato scritto, non fu politica, ma scientifica ed educativa. La preoccupazione del sapiente Mutis era più che fondata. Nel 1794 Nariño tradusse e pubblicò clandestinamente la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; contemporaneamente sui muri di Bogotà comparvero manifesti (pasquinas, ovvero pasquinate) che denunciavano l'oppressione spagnola e inneggiavano alla libertà, presumibilmente opera di studenti dei Collegi del Rosario e di San Bartolomé. La repressione colpì duro: sia Nariño sia altri membri del circolo vennero arrestati, inclusi Zea e Sinforoso, che insieme a lui furono tradotti al carcere del Castillo de San Sebastián di Cadice; mentre Nariño riuscì a evadere quindi a raggiungere la Francia, Zea e Sinforoso rimasero agli arresti fino al 1799. Prima di tracciare un breve profilo dei collaboratori e discepoli di Mutis coinvolti nel movimento indipendentista, riassumiamo brevemente le vicende di quest'ultimo. Gli anni tra il 1810 e il 1814 furono caratterizzati da un duplice conflitto: da una parte, la guerra d'indipendenza contro gli spagnoli, dall'altra la guerra civile tra le due autoproclamate repubbliche delle Provincias Unidas de la Nueva Granada e dell'Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, la prima decisamente federalista, la seconda tendenzialmente centralista. Nel 1814, per ordine del Congresso delle Province unite, Bolivar conquistò la capitale, costringendo Cundinamarca a unirsi alle altre province. Anche queste divisioni favorirono la ripresa realista; nel 1815 il generale Morillo invase il paese e nel 1816 mise fine all'effimera repubblica, scatenando una pesantissima repressione contro i patrioti colombiani, con centinaia di condanne a morte; tra i caduti i protagonisti di questa storia: José María Carbonell, Jorge Tadeo Lozano, Salvador Rizo Blanco e Francisco José de Caldas. Sinforoso Mutis invece ebbe salva la vita; vedremo più avanti perché e come.  Dalla spedizione alla politica Iniziamo con un non scienziato, José María Carbonell (1778 - 1816); nato a Bogotà, studiò al Colegio Mayor de San Bartolomé, quindi fu assunto come scrivano della Expedición Botánica. Il suo compito era trascrivere i materiali necessari; probabilmente fu lui a ricopiare per la stampa l'opera postuma di Mutis El arcano de la quina. Durante la giornata del 20 luglio 1810 fu tra i più attivi soprattutto nel coinvolgere gli strati più popolari; acceso centralista, durante la Repubblica occupò diversi incarichi: primo presidente della Giunta, capitano delle milizie di fanteria, ufficiale maggiore cassiere, contabile e tesoriere del Tesoro di Cundinamarca. Al momento della repressione la sua condanna fu senza appello: definito da Morillo "uno degli uomini più preversi e crudeli che si siano segnalati tra i traditori", venne impiccato il 19 giugno 1816. Jorge Tadeo Lozano (1771-1816) apparteneva a una famiglia nobile, una delle più prestigiose e influenti del vicereame; ricevette un'approfondita educazione, quindi studiò letteratura, filosofia e medicina al Collegio del Rosario, dove fu allievo di Mutis. Inizialmente abbracciò la carriera militare e combatté contro la Francia nella Guerra dei Pirenei; approfittò del soggiorno a Madrid anche per studiare matematica e chimica presso il Real Laboratorio de Química e viaggiò in Europa, vivendo per qualche tempo a Parigi. Al suo ritorno a Nuova Granada nel 1797, divenne un membro attivo dei circoli letterari, in particolare del Casino di Nariño. Nel 1801 fondò il settimanale Correo curioso, erudito, económico y mercantil de la ciudad de Santafé de Bogotá, in cui propugnò tra l'altro la fondazione di una Società patriottica. Nel 1802, su proposta di Mutis, ottenne la cattedra di chimica al collegio del Rosario e gli succedette in quella di matematica; resse le due cattedre fino al 1806, quando fu aggregato alla Real Expedición Botánica come zoologo. Indirizzò i suoi studi sugli anfibi e i rettili, pubblicando nel 1810 Memoria sobre las Serpentes e diversi saggi sul Semanario, tra cui l'inizio di un'annunciata Fauna cundinamarqiesa. Poi la politica travolse anche lui. Dopo la proclamazione dell'indipendenza, fu nominato presidente della commissione incaricata di redigere la nuova costituzione: il risultato fu la Constitución de Cundinamarca, che trasformava lo stato in una monarchia costituzionale. Nell'aprile 1811 fu eletto primo presidente della Cundinamarca, ma dopo pochi mesi fu costretto alle dimissioni in seguito a una campagna di discredito orchestrata da Nariño. Ritornò ai suoi studi ma non abbandonò del tutto la politica; nel 1814 fondò un secondo giornale di orientamento più politico, Anteojo de Larga Vista, e nel 1815 prese parte al Congresso generale della Nuova Granada come deputato della provincia del Chocó. La posizione relativamente defilata e le idee moderate non gli salvarono la vita: anche lui fu condannato a morte e fucilato alla schiena il 6 luglio 1816. Porta il suo nome l'Universidad Jorge Tadeo Lozano, un ateneo privato di Bogotà. Con Salvador Rizo Blanco (1760-1816) andiamo al cuore della Real Expedición Botánica. Mutis lo incontrò nel 1784, quando Rizo lavorava come disegnatore per un ingegnere stradale. Notando le eccellenti qualità del suo tratto, lo portò con sé a Mariquita per farne il primo pittore della spedizione. Era abile, fedele, infaticabile; Mutis gli affidò non solo la direzione del laboratorio di pittura, ma anche quella che chiamava "mayordomia", ovvero l'amministrazione e l'organizzazione finanziaria della spedizione. Quale fosse il suo lavoro, e quanto centrale, lo spiegò egli stesso in un memoriale rivolto al Viceré qualche anno dopo: "Erano affidate a me la riscossione delle rendite destinate alla spedizione e le spese ordinarie; incarichi, viaggi, escursioni botaniche, tutto passava per le mie mani. Allo stesso tempo disegnavo e coloravo le tavole della Flora che mi erano state affidate, e cercavo di dare la maggiore perfezione possibile a quelle curate da altri artisti venuti da Quito; ho trasmesso i miei principi ai giovani che mi erano stati affidati, creando a tal fine una scuola". Tra i disegni della spedizione si conservano 140 tavole firmate da Rizo (probabilmente ne produsse molte di più senza firma); sebbene siano di qualità artistica inferiore rispetto a quelli dell'altro pittore principale, Francisco Javier Matís, si distinguono per la fedeltà al modello e il disegno sicuro. Fu anche un valido ritrattista: gli si devono un busto di Mutis e un ritratto di Cavanilles, dipinto in abito talare di profilo, mentre tiene davanti a sé la tavola botanica di Rizoa ovatifolia (la pianta che aveva dedicato a Rizo) e ne completa la descrizione. Mutis aveva tale fiducia in lui da nominarlo suo esecutore testamentario. Dopo la sua morte, Rizo riuscì a far completare oltre 200 tavole botaniche, ma dovette scontrarsi con l'ostilità della famiglia Mutis, con invidie e sospetti, che si fecero anche più pressanti dopo il 20 luglio; Nariño fece perquisire la sua casa con l'accusa di aver sottratto materiali e manoscritti, spingendolo ad abbandonare la città con la sua famiglia. Nel 1813 si arruolò nell'esercito delle Province unite sotto il comando di Bolivar, come Provveditore generale dell'Esercito. Nel dicembre 1814 tornò a Bogotà con Bolivar, e si trovò invischiato in una causa intentatogli dai suoi nemici che ribadiva l'accusa di furto di manoscritti e averi di Mutis. Si trovava dunque in città quando Murillo scatenò il terrore contro i patrioti. Arrestato, fu detenuto per cinque mesi, senza avere la consolazione di vedere riconosciuta la sua innocenza dai vecchi compagni di spedizione che pure condividevano la stessa sorte. Condannato a morte, fu fucilato il 12 ottobre 1816.  Astronomo, botanico, ingegnere militare Tra i discepoli e collaboratori di Mutis il più noto è Francisco José de Caldas (1768-1816) che, come il suo mentore, si guadagnò il soprannome di "el sabio", il sapiente. Egli nacque a Popoyán, dove iniziò gli studi nel Seminario Mayor, dimostrando una particolare attitudine per la matematica. La famiglia voleva farne un avvocato; continuò dunque gli studi al Colegio del Rosario di Bogotà, laureandosi in legge nel 1793. Tornò a Popoyan e per qualche tempo divise il suo tempo tra l'avvocatura e i viaggi d'affari in Ecuador. Intorno al 1796 la lettura di alcuni testi della Spedizione geodetica all'equatore riaccese la sua passione scientifica; acquistò un barometro, due termometri e un ottante e approfittò dei suoi viaggi tra Popoyan e Quito per misurare l'altitudine e la latitudine di diverse località e raccogliere dati geografici ed astronomici. Tra il dicembre 1798 e il febbraio 1799, su richiesta della comunità di Timaná alle prese con alcuni problemi di confine, ne tracciò la carta e stabilì la latitudine basandosi su un'eclissi lunare. Si procurò un telescopio, costruì da se stesso altri strumenti, come uno gnomone e un quadrante, e creò una specie di osservatorio nel patio della casa di famiglia. Nel 1801, avendo letto sul Correo curioso di Lozano una stima scorretta dell'altezza dei monti Guadalupe e Monserrate, che egli stesso aveva misurato, rispose con un articolo di rettifica che fu pubblicato e cominciò a farlo conoscere al di fuori dell'ambiente provinciale. I suoi amici di Bogotà ne approfittarono per fare il suo nome a Mutis; tra i due iniziò una corrispondenza. Nel maggio di quell'anno Caldas fece la sua più importante scoperta; scoprì che, poiché la temperatura a cui bolle l'acqua varia con l'altitudine, essa può essere utilizzata con notevole precisione per stabilire l'altitudine stessa, senza altri strumenti che un termometro. A tal fine elaborò una formula matematica e costruì un apposito termometro ipsometrico. Il 4 novembre di quel memorabile 1801 Humboldt e Bompland, dopo aver trascorso diversi mesi a Bogotà accolti da Mutis, arrivarono a Popoyán. Il barone aveva letto l'articolo di Caldas sul Correo Curioso che lo aveva stupito per la grande esattezza, aveva sentito parlare di lui dai suoi amici di Bogotà, ed era ansioso di incontrarlo ma el sabio non era in città: era a Quito ad occuparsi di affari di famiglia. Humboldt visitò però il padre di Caldas che gli mostrò i quaderni del figlio. L'incontro tra i due scienziati sarebbe avvenuto l'ultimo giorno dell'anno a Ibarra in Ecuador. Quindi viaggiarono insieme fino a Quito, confrontandosi e discutendo di molti argomenti scientifici. Per l'autodidatta Caldas fu quasi un corso d'aggiornamento accelerato: Humboldt gli mostrò i suoi quaderni di campo, gli insegnò nuovi metodi per misurare l'altitudine e come usare l'ottante. Tra febbraio e marzo 1802 per 37 giorni i tre naturalisti lavorarono insieme a Chillo. Caldas fece escursioni botaniche con Bompland e misurazioni trigonometriche con Humboldt. A questo punto avrebbe voluto con tutte le forze unirsi ai due europei, ma il progetto fu respinto dal tedesco, nonostante la raccomandazione di Mutis. Svanito questo sogno, fu proprio Mutis a invitarlo a partecipare alla spedizione botanica. Gli chiese in particolare di studiare le piante utili, soprattutto le varie specie di Cinchona dell'Ecuador. Caldas accettò con entusiasmo e per qualche anno, da astronomo, divenne botanico. Tra il 1802 e il 1805 esplorò intensamente la flora della regione, sempre prendendo note accuratissime sui luoghi di crescita e gli eventuali usi; nel 1802 viaggiò da Ibarra a Imbabura, nel 1803 da Ibarra al Pacifico, nel 1804, di nuovo alla ricerca delle piante di china, visitò Latacunga, Ambato, Cuenza e Loja; nel 1805 ritornò a Popayán e da qui Bogotá, con un bottino di più di 6000 fogli di erbario. In tal modo la Real Expedición Botánica si allargò all'Ecuador. Al suo arrivo a Bogotà, Mutis lo incaricò di dirigere l'appena inaugurato Osservatorio astronomico. Anche se ormai si sentiva più botanico (stava lavorando a una Fitogeografia dell'Ecuador, in cui era giunto a conclusioni simili a quelle di Humboldt sulla distribuzione altimetrica delle piante), egli si gettò con tutta l'impulsività della sua natura anche in questa avventura stabilendo un programma regolare di osservazioni astronomiche, geografiche e meteorologiche; inoltre fondò e redasse un giornale scientifico El semanario del Nuevo Regno de Granada sul quale vennero pubblicati articoli suoi e di altri membri della spedizione nonché traduzioni dal francese di Lozano. Per la botanica, di particolare importanza la pubblicazione di una serie di nuovi generi stabiliti da Mutis, ma mai pubblicati. Abbiamo già visto che si trovò al centro degli eventi del 20 luglio, anche se forse aveva ospitato i congiurati nel suo alloggio all'osservatorio più per amicizia che per convincimento politico. Ancora una volta cambiò totalmente vita e rivolse il suo genio alla fabbricazione di armi e all'allestimento di fortificazioni: nel 1811 fu nominato capitano del corpo degli ingegneri militari e dal 1812 fu promosso tenente colonnello. Nel 1813, avendo partecipato a un tentativo di deporre Nariño, si rifugiò a Antioquia dove fu ancora ingegnere militare con il grado di colonnello. Tra il 1813 e il 1814 si occupò delle fortificazioni del fiume Cuaca e della creazione di una polveriera e di una fabbrica di fucili. Nel 1815 il presidente Camilo Torres gli chiese di fortificare Bogotà in vista dell'attacco spagnolo e lo incaricò di dirigere la Scuola militare. Quando gli spagnoli invasero il paese, tentò la fuga ma fu catturato e anche lui condannato a morte. Si racconta che nel sentire la sentenza egli stesso o i presenti facessero appello a Morillo oppure a Pascual Enrile y Acedo (esistono varie versioni) perché fosse risparmiata la vita a quel sapiente. La risposta fu: "La Spagna non ha bisogno di sapienti". Come gli altri patrioti, fu fucilato alla schiena come traditore.  La fine della spedizione L'unico a sfuggire a questo destino fu Sinforoso Mutis Consuegra (1773-1822); era uno dei tre figli di Manuel Mutis Bosio, fratello di José Celestino, e della colombiana María Ignacia Consuegra. Quando il padre morì, aveva solo tredici anni e lo zio si fece carico della sua educazione, affidandolo a un altro ex membro della spedizione, Juan Eloy Valenzuela, parroco a Bucaramanga. Sinforoso poi studiò al Colegio del Rosario dove seguì i corsi di Filosofia naturale in cui si studiava matematica, fisica, astronomia e scienze naturali. Nel 1791, proprio nel momento in cui la sua sede veniva spostata da Mariquita a Santafé, fu aggregato alla spedizione come disegnatore apprendista; si dimise nel 1793 per riprendere gli studi di legge al Colegio del Rosario. Fu probabilmente in queste circostanze che incominciò a frequentare gli ambienti "sovversivi" e finì implicato nell'affare delle pasquinate. La brutta avventura ebbe però anche risvolti positivi: nel 1799 il carcere fu mutato in arresti domiciliari, il che gli permise di frequentare il corso di botanica tenuto nell'Ospedale reale di Cadice da Francisco Arjona. Finalmente amnistiato, fu reintegrato nella spedizione e gli fu concesso di approfondire gli studi di botanica all'orto botanico di Madrid seguendo le lezioni di Miguel Barnades junior e lavorando accanto a Cavanilles, Nel 1802 ritornò a Bogotà; Mutis lo inviò a studiare la flora di Cartagena de Indias, quindi a Cuba in una missione tanto scientifica quanto commerciale: doveva infatti vendere la corteccia di china, ma anche raccogliere piante e riportare nella colonia il vaccino contro il vaiolo. Rientrò a Bogotà nell'agosto 1808, appena due settimane prima della morte dello zio. Nel testamento scientifico di quest'ultimo non veniva indicato un direttore della spedizione, ma piuttosto un triumvirato: Rizo avrebbe continuato a dirigere il lavoro dei pittori, Caldas si sarebbe occupato dell'osservatorio e Sinforoso sarebbe stato il direttore scientifico per la botanica, con il risultato che al momento furono tutti scontenti, soprattutto Caldas che si aspettava da Mutis la consacrazione a suo successore. L'incarico venne confermato a Sinforoso dal viceré nel febbraio 1809. Egli si concentrò sul completamento e nella pubblicazione del libro sulle piante di china di suo zio, integrato con le scoperte di altri membri della spedizione, soprattutto Caldas. Giunse a un accordo con quest'ultimo, riconoscendogli la priorità sulla pubblicazione delle piante dell'Ecuador; entrambi contavano di continuare, concludere e pubblicare la Flora di Bogotà. Sinforoso dedicò qualche mese a fare un inventario dei materiali, poi pubblicò sul Semanario una memoria sulla spedizione e diverse nuove piante; nel numero seguente altre furono pubblicate da Caldas, che sigillò la pacificazione con la dedica del genere Consuegria. Si era ormai nel 1810 e anche Sinforoso finì nel vortice della politica. Dopo il 20 luglio, fu nominato deputato del popolo e membro della Giunta suprema e come tale firmò l'Atto di Indipendenza. Nel 1811 fece parte della commissione che redasse la Costituzione della Repubblica di Cundinamarca. Nel 1812 riprese la direzione della spedizione, anche se ormai le ricerche erano bloccate da tempo e il gruppo dei pittori si era dissolto con la partenza di Rizo. Nel novembre del 1814 il governo gli affidò l'inventario della parte botanica della spedizione; grazie a questa fortunata circostanza, in materiali si salvarono dal saccheggio dell'Osservatorio e della Casa della Botanica invasi dai soldati di Bolivar. Nel 1816 anche lui fu accusato di sedizione e incarcerato nel Colegio del Rosario; qui dovette occuparsi di allestire e imballare i materiali della spedizione per l'invio a Madrid, con l'aiuto del pittore Francisco Javier Matís. Il gravoso (e doloroso) compito, insieme al nome di suo zio e alla sua origine spagnola, probabilmente gli salvò la vita: anziché essere condannato a morte come i suoi compagni, gli furono comminati due anni di carcere e l'esilio a Panama. Nel 1817 in seguito a indulto reale, fu confinato a Cartagena. Solo nel 1821 poté tornare a Bogotà con la sua famiglia e fu nominato deputato dell'Assemblea costituente da cui doveva nascere la Repubblica di Colombia. Tuttavia, ormai minato nella salute, morì l'anno dopo a soli 49 anni.  Generi per quattro naturalisti Ad eccezione di Carbonell che come abbiamo visto non era un naturalista, tutti gli altri hanno avuto l'onore di dare il loro nome ad almeno un genere botanico, anche se uno solo è oggi accettato. Si tratta di Lozania che fu pubblicato sul Semanario del Nuevo Reino de Granada da Caldas, rispettando la volontà di Mutis. E' uno dei due generi della piccola famiglia Lacistemataceae (l'altro è appunto Lacistema) e gli sono attribuite cinque specie di piccoli alberi o anche arbusti distribuiti nel Centro America meridionale (dal Nicaragua a Panama), nel sud America tropicale (dal Venezuela alla Bolivia) e nella regione amazzonica occidentale, dove tipicamente crescono nel sottobosco delle foreste umide fino a 2400 m di altitudine. Hanno foglie alternate, da ellittiche a obovate, e infiorescenze terminali raccolte in racemi. I fiori minuscoli (circa un mm) consistono in un disco munito di sepali e di un unico stame che si divide in due antere. Il frutto è una capsula che si apre in tre valve e contiene un singolo seme circondato da un arillo. Come ho anticipato, fu invece Cavanilles a dedicare a Rizo Rizoa (oggi sinonimo di Clinopodium). A Caldas (e la cosa non stupisce, visto che era l'unico ad avere una reputazione internazionale) sono stati dedicati ben tre generi Caldasia, nessuno dei quali è però oggi accettato; in ordine cronologico, il primo giunse già nel 1806 da Willdenow, direttore dell'orto botanico di Berlino, a cui le attività scientifiche del sabio Caldas erano note grazie a Humboldt (oggi è sinonimo di Bomplandia); quindi lo stesso Caldas pubblicò ancora sul suo Semanario l'omonimo genere che gli era stato dedicato da Mutis (oggi sinonimo di Helosis); infine nel 1821 fu la volta dello spagnolo Lagasca, che intese così anche riabilitare la memoria del naturalista fucilato alla schiena come traditore dai suoi compatrioti (oggi sinonimo di Chaerophyllum). Concludiamo la rassegna con un ultimo genere valuto da Mutis e pubblicato da Caldas, Consuegria; non solo non è valido, ma di incerta sede, ovvero non identificato.
0 Comments
Di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, è stato detto che potrebbe essere nominato patrono laico dei giardini e dei giardinieri statunitensi. Quella per la natura, le piante e i giardini fu infatti per lui una passione costante in tutte le fasi della vita, fino alla creazione dello splendido giardino di Monticello. Protagonista di una rete di "scambisti" di piante tra le due sponde dell'oceano, botanico dilettante, presidente della American Philosophical Society, ebbe anche il merito di sponsorizzare la grande spedizione di Lewis e Clark. Lo ricorda una pianta del sottobosco delle foreste americane, Jeffersonia diphylla, che coltivava in una delle aiuole del suo giardino, dove spesso gli faceva omaggio della sua candida fioritura come dono di compleanno.  Una dedica all'uomo di scienza, non al politico La sera del 18 maggio 1792 sei uomini si incontrarono presso la Philosophical Hall di Filadelfia, la sede della American Philosophical Society, per la consueta riunione del venerdì; dopo il momento conviviale del pranzo, Benjamin Smith Barton, professore di botanica e storia naturale presso l'Università della Pennsylvania, lesse una lettera che aveva scritto ai colleghi europei circa una pianta nativa della Virginia. Linneo, basandosi solo su esemplari essiccati, l'aveva assegnata al genere Podophyllum, con il nome P. diphyllum. Barton, studiandola dal vivo, era giunto alla conclusione che andasse invece assegnata a un genere nuovo e, aggiunse, "Mi sono preso la libertà di renderlo noto ai botanici sotto il nome di Jeffersonia, in onore di Thomas Jefferson, segretario di Stato degli Stati Uniti". E ciò, aggiunse, non in considerazione dei suoi meriti politici, ma delle sue conoscenze di storia naturale che, soprattutto nei campi della zoologia e della botanica "sono eguagliate da poche persone negli Stati Uniti". In effetti, il multiforme Thomas Jefferson, estensore della Dichiarazione d'Indipendenza, quindi ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, segretario di Stato, presidente per due mandati, oltre che uno dei padri fondatori degli Stati Uniti fu un intellettuale di notevole spessore, con forti interessi scientifici che spaziavano dalla matematica all'archeologia, dalla geografia alla paleontologia: le scienze naturali e la botanica furono una passione che coltivò per tutta la vita. Si racconta che quando era presidente conoscesse tutte le piante dei dintorni della Casa Bianca, e non si facesse sfuggire una specie nuova per il suo erbario. Per quanto riguarda la botanica, notevole fu il suo lascito in tre settori: la promozione dell'agricoltura del suo paese, con migliorie tecniche e l'introduzione di nuove specie; la creazione dello splendido giardino di Monticello; la promozione dell'esplorazione delle risorse naturali del territorio statunitense. Convinto che l'agricoltura fosse la base della prosperità, dell'indipendenza, ma anche della moralità di una nazione, sognava un paese di piccoli agricoltori liberi, anche se lui, da parte sua, era il proprietario schiavista di vaste piantagioni. Il suo contributo in questo campo fu soprattutto nella sperimentazione e nell'introduzione di nuove varietà: ad esempio, portò con sé dall'Europa una pianta di fico acquistata a Marsiglia, che a suo dire produceva i frutti migliori che mai avesse mangiato, e ne distribuì talee a vicini e amici; creò un vigneto sperimentale; incoraggiò la coltivazione del sesamo per la produzione familiare di olio. Ma il suo capolavoro fu Monticello, la sua residenza nei pressi di Charlottesville, Virginia, il cui nome italiano fa riferimento alla posizione della proprietà, sulla cima di un colle delle Southwest Mountains. Nel 1768 iniziò l'edificazione di una casa in stile palladiano, progettata dallo stesso Jefferson, che era quasi completa nel 1784 quando egli dovette lasciare gli Stati Uniti per la Francia, con l'incarico di ambasciatore presso la corte di Parigi. Contemporaneamente, cominciò a realizzare il giardino, sulle cui vicende siamo ben informati grazie al suo Garden Book, ovvero il quaderno dove annotava piantagioni, semine, esperimenti. La prima annotazione risale al 1769, quando Jefferson fece piantare alberi da frutto sul versante sud della collina. Nel 1774, in collaborazione con l'italiano Filippo Mazzei, che procurò vignaioli e vitigni, impiantò la prima vigna della Virginia. Tra il 1778 e il 1782 fu la volta di un vasto frutteto di meli e peschi e del primo orto, lungo la strada principale della piantagione, dove vennero seminari asparagi, piselli e carciofi. Il soggiorno in Europa, che si protrasse dal 1784 al 1789, permise a Jefferson di allargare i suoi orizzonti culturali e di allacciare proficue relazioni. Oltre alla Francia, visitò la Gran Bretagna, l'Italia, il Belgio e i paesi Bassi, dove visitò case e giardini, rimanendo profondamente impressionato dallo stile libero dei nuovi parchi all'inglese. A Parigi incominciò a frequentare il salotto di Madame de Tessé, zia di Lafayette e grande appassionata di giardini, che gli chiese di procurargli piante americane; e così, tra Parigi e Monticello, iniziò un attivo scambio transoceanico di piante: mentre esemplari di Callicarpa americana, Diospyros virginiana, Calycanthus floridus procurati da amici e corrispondenti di Jefferson raggiungevano il parco di Chaville, a Monticello arrivavano semi di elitropio bianco (Helitropium arborescens), ranuncoli, cavolfiori, broccoli e bulbi di tulipani. Un altro contatto importante fu André Thouin, capo giardiniere del Jardin du Roi.  Un giardino per frutti, verdure, fiori Tornato in patria, Jefferson cercò di conciliare l'attività politica (che egli definiva il suo dovere) con gli interessi scientifici (che egli definiva la sua passione). Così, nel 1791 lo troviamo ad erborizzare nel New England con l'amico James Madison. Nel 1797 fu nominato presidente della American Philosophical Society (incarico che mantenne per un ventennio, anche durante i due mandati presidenziali). Nel 1812, quando durante la guerra anglo-americana un incendio distrusse la biblioteca del Congresso, Jefferson offrì di reintegrarla con la sua collezione (che vantava il doppio dei volumi di quella perduta), dietro un compenso che doveva aiutarlo a ripianare i grandi debiti contratti per la ristrutturazione di Monticello; il congresso accettò, creando così il primo nucleo dell'attuale Library of Congress. Egli inoltre si impegnò attivamente nella creazione dell'Università della Virginia a Charlottesville, che fu infine inaugurata nel 1819. A partire dal 1794, lo stesso anno in cui divenne segretario di Stato, Jefferson intraprese la totale ristrutturazione della casa e del parco di Monticello, ispirandosi a quanto aveva visto in Europa. Come Mount Vernon di Washington, anche il giardino concepito da Jefferson unisce le funzioni di parco paesaggistico, frutteto, orto e giardino di piacere. I frutteti e gli orti si trovavano fuori del parco vero e proprio, lungo il viale principale della piantagione. I frutteti, con pianta formale a grata, erano due, uno posto a nord, l'altro a sud. Includevano anche meli per la produzione di sidro; a più riprese, venne impianta una vigna, ma con poco successo. L'orto venne collocato su una lunga terrazza ricavata dal lavoro degli schiavi sul fianco della collina; comprendeva 24 parcelle quadrate destinate alla produzione di "radici" (come rape e carote), "frutti" (pomodori, fagioli), "foglie" (insalate, cavoli). Al centro un piccolo padiglione da cui si poteva godere il panorama. Alla base del muro di sostegno venivano coltivate le primizie e le piante più delicate, come i piselli, una delle grandi passioni di Jefferson. Anche i fichi portati dalla Francia crescevano qui. L'orto era anche uno spazio sperimentale dove provare novità, come i broccoli e i cavolfiori importati dall'Europa o gli stessi pomodori. Si calcola che nel corso degli anni Jefferson vi abbia fatto coltivare 330 varietà di 70 specie. La sommità della collina era occupata da una spianata con un vasto prato dai contorni irregolari, il West Lawn, a nord ovest del quale si trova il Grove, il boschetto, un'area di 18 acri concepita come una foresta ornamentale in cui agli alberi nativi più alti (potati in modo da lasciare luce e spazio agli alberi minori) si affiancavano piante scelte per il contrasto di colori, forme, tessiture. Il sottobosco naturale doveva essere eliminato per lasciare posto a radure a prato, con erbacee perenni e gruppi di arbusti disposti secondo un disegno labirintico a spirale. Il collegamento tra le varie parti del giardino era garantito da quattro viali circolari concentrici, posti a livelli differenti, bordati di gelsi e Gleditsia triacanthos e collegati tra loro da sentieri diagonali. Se, proprio come Mount Vernon, all'inizio anche Monticello era stato concepito soprattutto con funzioni utilitarie, dopo l'esperienza europea l'interesse di Jefferson per i fiori e le piante ornamentali aumentò. Nel 1807, in previsione del suo ritiro dalla vita politica, egli disegnò venti aiuole ovali, poste ai quattro angoli della casa, ciascuna delle quali destinata a una specie diversa, con bulbose, erbacee perenni e piccoli alberi da fiore. Probabilmente nel 1808 fu creata la grande bordura serpeggiante che contorna il prato centrale. In entrambe le aree la figlia e le nipoti di Jefferson coltivavano una grande varietà di piante e bulbi, forniti soprattutto dal vivaista di Filadelfia Bernard McMahon, in modo da assicurare fioriture dalla primavera all'autunno. C'erano i fiori coltivati tradizionalmente che i coloni avevano portato con sé dall'Europa; piante più inusuali o novità fornite dai contatti europei (ogni anno, una cassa giungeva dal Jardin des Plantes di Parigi). Almeno un quarto delle piante da fiore coltivate a Monticello erano tuttavia native; oltre a Jeffersonia diphylla, particolarmente gradita perché oltre a portare il suo nome fioriva proprio intorno al suo compleanno (il 2 aprile), c'erano diverse specie raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark, come Fritillaria pudica e Lobelia cardinalis. Siamo così giunti all'ultimo titolo di merito di Jefferson: quella spedizione era stata voluta e sponsorizzata proprio da lui, durante il suo primo mandato presidenziale. Negli anni successivi all'indipendenza, il territorio del nuovo stato era confinato nella stretta striscia tra gli Appalachi e l'Oceano, mentre si avevano scarse conoscenze delle terre poste al di là delle montagne. Jefferson era conscio delle enormi potenzialità di quel territorio inesplorato e sognava di trovare una via di comunicazione con l'Oceano Pacifico. Già quando si trovava a Parigi come ambasciatore sostenne il progetto dell'esploratore anglo-americano John Ledyard che si proponeva di raggiungere lo stretto di Bering attraversando la Russia via terra; da qui pensava di trovare un passaggio per l'Alaska, da dove sarebbe sceso verso sud per poi percorrere il continente americano fino alla Virginia. Ma, dopo essere arrivato in Siberia, nel febbraio del 1788 Ledyard fu arrestato per ordine dell'imperatrice Caterina e deportato in Polonia. Una seconda possibilità si presentò nel 1793, quando l'American Philosophical Society pensò di affidare la missione di "esplorare il paese lungo il Missouri e di lì proseguire verso ovest fino all'Oceano Pacifico" al botanico francese André Michaux, che da qualche anno viveva in Carolina del Sud e aveva una larga esperienza di viaggi di esplorazione e raccolta. Jefferson stesso organizzò la sottoscrizione che doveva finanziare la spedizione e ottenne l'assenso di Washington; tuttavia, quando fu chiaro che Michaux era coinvolto in un piano antispagnolo organizzato dall'ambasciatore francese, per evitare di peggiorare le relazioni diplomatiche con la Spagna il progetto fu annullato. Il sogno di Jefferson poté infine realizzarsi nel 1804 grazie alla spedizione capeggiata da Lewis e Clark, argomento su cui però tornerò in un altro post. Jefferson morì nel 1826, a ottantaquattro anni, ormai sprofondato nei debiti contratti per la sua vita troppo dispendiosa e soprattutto per la creazione di Monticello. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. La figlia fu costretta a vendere la tenuta che, dopo essere passata attraverso vari proprietari, nel 1836 fu acquistata da Uriah Levy, grande ammiratore di Jefferson, il quale nel 1862 la lasciò in eredità al popolo americano perché fosse usata come scuola agraria. Ma si era in piena guerra civile e il congresso rifiutò il lascito. Dopo complesse vicende, a cercare di salvare Monticello, che era ormai in uno stato deprecabile di abbandono, fu il nipote Jefferson Monroe Levy, che ne iniziò il restauro, poi proseguito a cura della Thomas Jefferson Foundation, nata nel 1923. Monticello come lo vediamo oggi è il frutto dei restauri da essa promossi: sono stati ricreati il prato e la sua bordura, le aiuole ovali, il viale circolare inferiore, la terrazza con l'orto, mentre i frutteti non esistono più e il Grove è ben diverso da come doveva presentarsi all'epoca del suo creatore. Dal 1987 la tenuta è inclusa nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO. Moltissime notizie sul giardino e sullo stesso Jefferson nel sito di Monticello.  Una pianta americana Abbiamo già visto che Jeffersonia fu dedicata a Jefferson nel 1792 da Benjamin Smith Barton. Appartenente alla famiglia Berberidaceae, comprende una sola specie, appunto J. diphylla, una rara erbacea perenne a fioritura primaverile del sottobosco delle foreste decidue con suolo calcareo degli Stati Uniti orientali. Alta fino a 25 cm, ha grandi foglie bilobate con lobi da arrotondati ad acuti posti quasi ad ala di farfalla; all'inizio della primavera produce fiori a coppa con otto petali bianchi e stami gialli. Gli si attribuiscono proprietà antireumatiche. Qualche informazione in più nella scheda. Ha anche una bellissima cugina asiatica che oggi, dopo molte incertezze, è stata restituita al genere Plagiorhegma. Dunque dobbiamo rassegnarci a chiamare questa perla dei giardini boschivi con foglie lobate e fiori lilla con l'orrendo nome Plagiorhegma dubium anziché Jeffersonia dubia. Nel 1800 Brickell dedicò a Jefferson un secondo genere Jeffersonia; illegittimo per la regola della priorità, è oggi sinonimo di Gelsemium. Nella maggior parte dei casi, i nomi delle piante vengono dedicati da botanici a altri botanici; non sono i rari i casi di dediche a sovrani, mecenati, scienziati celebri in altri campi. Ma qualche volta anche un nome botanico può essere un atto politico. Ce lo dimostra la storia del genere Casimoroa e del suo dedicatario, Casimiro Gomez. Ma in questo post faremo anche un po' di backstage su come nasce questo blog.  Sulle tracce di Casimiro Per una volta parlo di me (i blogger lo fanno, ma qui in genere non succede). Qualche giorno fa, in un gruppo Internet di appassionati, ho visto la fotografia di un frutto esotico che non conoscevo, quello di Casimiroa edulis, o sapote bianco. Il primo impulso per la sottoscritta è scoprire qualcosa di più su questa pianta; ma il secondo (è ormai un riflesso condizionato) è chiedersi: "Ma chi è questo Casimiro?" E così inizia la ricerca. Il primo passo è consultare l'ottimo Verzeichnis eponymischer Pflanzennamen (Index of Eponymic Plantes Names) di Lotte Burkhardt. Leggo che il nome è stato creato nel 1825 da La Llave, che l'ha dedicato a un combattente per la libertà del Messico, Casimiro Gomez, fucilato nel 1815. Navigo un po' in Internet, e trovo informazioni contraddittorie: la maggior parte dei siti indica come dedicatario Casimiro Gomez de Ortega (importantissimo botanico spagnolo a cavallo tra Sette e Ottocento); una minoranza conferma il messicano Casimiro Gomez; qualche fantasioso tira fuori un fantomatico cardinale Casimiro Gomez Ortega. Aggiungo che l'attribuzione a Gomez de Ortega è data anche da un repertorio autorevolissimo ( di cui non faccio il nome per carità di patria). Come si scopre chi ha ragione? Semplice: si cerca di risalire alla fonte primaria. Nel caso dei nomi botanici, la fonte primaria è la pubblicazione scientifica (rivista, libro, atti di un società scientifica) in cui è comparsa l'attribuzione; spesso, anche se non sempre, gli autori spiegano le motivazioni dei nomi che creano. Nel nostro caso la fonte primaria è il secondo fascicolo di Novorum vegetabilium descriptiones, pubblicato da Pablo La Llave e Juan Martinez de Lexarza a Città del Messico nel 1825. Si tratta di un'opera importantissima, in cui vennero pubblicati generi oggi molto noti come Mina, Calibrachoa o Montanoa. C'è quindi una buona probabilità che sia disponibile in rete. Mi metto alla ricerca, ma prima di trovarlo, mi imbatto in una fonte secondaria, ovvero in uno studio scientificamente fondato che, incidentalmente, analizza alcuni aspetti del libro di La Llave e Lexarza; si tratta di un'articolo M.C. Cuevas Cardona e C. López Ramírez, Cambios de gobierno en la vida de un botanico mexicano: Maximino Martinez. Leggo con grande interesse (ne parlo sotto) in che modo i due botanici messicani giunsero a dedicare un certo numero di nuovi generi a diverse personalità, tra cui il nostro Casimiro (indubbiamente messicano, indio e martire della guerra d'indipendenza). C'è anche la traduzione in spagnolo della nota dedicatoria. Poco dopo trovo anche il fascicolo di La Lave e Lexarza (è lì, scaricabile gratuitamente, a disposizione di tutti, come Google Books). E' l'ultima conferma: ora so su quale Casimiro concentrare la ricerca. E cercando notizie su di lui, scopro anche perché per qualche sprovveduto si sia potuto trasformare in un cardinale: il povero Casimiro (povero vedrete tra poco perché) era nato in un paesino dello stato messicano di Hidalgo, El Cardonal. Basta cambiare una lettera e "Casimiro Gomez di El Cardonal" si trasforma in "El Cardenal Casimiro Gomez". Tutti i dubbi sono fugati, tranne uno: perché la gente che ha a disposizione la più grande biblioteca che mai l'umanità abbia avuto (sto parlando della rete, con migliaia e migliaia di testi, incluse le fonti primarie) la usa così male, facendo solo del copia incolla?  Un martirologio botanico Il 28 settembre 1821, dopo una lotta decennale, il Messico ottiene l'indipendenza. Nel 1824 si dota di una costituzione e nasce la repubblica. Quello stesso anno Pablo La Llave e Juan Martinez de Lexarza pubblicano il primo fascicolo di Novorum vegetabilium desciptiones, cui l'anno successivo fa seguito il secondo. I due botanici vi descrivono per la prima volta diverse piante della flora messicana, tra cui anche una trentina di nuovi generi. Ferventi patrioti, intendono il loro lavoro come un atto politico: fino ad allora, la flora del nuovo mondo è stata per lo più studiata e descritta da botanici europei; una flora messicana scritta da messicani è un segnale di emancipazione, di "indipendenza" anche a livello scientifico (tanto che i due botanici non esitarono a polemizzare con un mostro sacro come Alexander von Humboldt). Ma l'intento politico e patriottico è anche più esplicito: il primo fascicolo è aperto dalla dedica all' "eterna memoria" di Miguel Hidalgo e di altri tredici patrioti morti per dare la libertà alla patria; e sono proprio loro i dedicatari della maggior parte dei nuovi generi (altri si aggiungeranno nel secondo fascicolo, tra cui proprio il nostro Casimiro Gomez). Certo ci sono anche, più tradizionalmente, un esploratore e botanico come José Mariano Mociño (dedicatario dell'oggi non più valido Mocinia), un botanico e farmacista come Antonio de la Cal y Bracho (dedicatario di Calibrachoa) oppure qualche personalità del Messico indipendente come lo storico José de Mier, autore dell'Historia de la revolución de Nueva España. Ma la parte del leone la fanno i martiri, gli eroi della patria, famosi come Hidalgo o oscuri come Casimiro Gomez. E veniamo finalmente a Casimiro. Era un indio otomì, nato a El Cardonal nello stato di Hidalgo; di famiglia poverissima, da bambino accompagnava i mulattieri che trasportavano vari tipi di materiali a Città del Messico. Adattato da uno spagnolo, visse nella capitale fino al 1810, quando, scoppiata la guerra di indipendenza, ritornò nel villaggio natale e organizzò la lotta degli indigeni contro gli spagnoli. Rivelò notevoli doti militari nelle azioni di guerriglia, tanto da vedersi riconosciuto il grado di colonnello. Tuttavia nel 1813, come luogotenente di Villagrán, quando questi venne sconfitto preferì arrendersi in cambio dell'indulto per sé e i suoi uomini. Appena liberato, ritornò sulle montagne e riprese la lotta, ma fu catturato e sconfitto dagli spagnoli nel 1815; questa volta, i realisti non ebbero pietà: Casimiro Gomez fu fucilato, quindi decapitato; il suo capo, come macabro monito e trofeo, fu esposto a un albero del burrone di Santa Monica, teatro di alcune delle sue imprese. Ma lasciamo la parola a La Llave e Lexarza e leggiamo la dedica: "A Casimiro Gómez, nato a El Cardonal, della tribù otomì. uomo sobrio e temperato, sagace e coraggiosissimo in guerra, che disprezzando le comodità e vestendosi umilmente come i suoi soldati, unicamente con un pugno di guerriglieri otomì condusse innumerevoli e gloriosissime azioni per il bene della patria". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  La dolce (e soporifera) Casimiroa Certo non conciliava il sonno delle truppe realiste spagnole il glorioso guerrigliero indio Casimiro Gomez, come fanno i frutti di una delle piante che ne portano il nome. Il genere Casimiroa appartiene alla famiglia delle Rutaceae come gli aranci e i limoni, tuttavia i suoi frutti non sono esperidi (come nel genere Citrus), ma drupe. Comprende una decina di specie arboree native dell'America centrale e dell'altopiano messicano. La più nota è C. edulis, nota come sapote bianco (sapote blanco) o matasano; quest'ultimo nome ("uccide le persone sane") fa riferimento ad alcune tossine presenti nei semi, che contengono alcaloidi dall'effetto sedativo. Il frutto, più o meno della dimensione di un'arancia, ha una polpa estremamente zuccherina, con un sapore che viene descritto come simile a quello del mango o della pesca, con sentori di mandorla. Oltre che in Messico e in America centrale, è coltivato commercialmente in Florida e in California (dove fu introdotto da monaci francescani), nei Caraibi, alle Hawaii, in Sud Africa, in Nuova Zelanda e in Australia. Relativamente rustico, di crescita veloce e decorativo per il bel fogliame sempreverde, con una buona resa di frutti, è occasionalmente coltivato anche da noi. Qualche approfondimento nella scheda. Tipografo, giornalista e poligrafo, scienziato e inventore, uomo politico e padre della patria: Benjamin Franklin non ha certo bisogno di presentazioni. Meno note sono le sue relazioni con la botanica. La storia della pianta che lo celebra è un apologo sul male (molto) e sul bene (poco) che gli uomini possono arrecare alla natura.  Ben Franklin padre della patra... e dell'orticoltura Un tratto comune di molti dei padri fondatori degli Stati Uniti fu la passione per piante e giardini; quanto a Benjamin Franklin, vero uomo di città, sul piano personale non si poteva dire un vero appassionato, ma fu profondamente consapevole dell'importanza economica dell'agricoltura per lo sviluppo delle colonie americane e la sua vita si intrecciò in molti modi con la botanica, l'orticultura e il giardinaggio. Oltre a pubblicare, come editore, molti libri di agricoltura e botanica, occupò un ruolo non secondario nella rete di naturalisti, mercanti, botanici e appassionati che nella seconda metà del Settecento mutò il volto dei giardini e dei parchi inglesi con l'introduzione di centinaia di nuove specie nordamericane. Fu proprio lui a metterne in contatto i principali attori, Collinson e Bartram. Tutto iniziò nel 1731, quando Franklin, di fronte alla difficoltà di procurarsi libri europei a costi accessibili, ebbe l'idea di creare a Filadelfia un club di lettura, la Library Company, primo nucleo delle future biblioteche circolanti. In tal modo conobbe il mercante-naturalista inglese Peter Collinson; entusiasta di ogni iniziativa che aiutasse a diffondere il sapere, infatti, quest'ultimo si offrì di assumere l'incarico di agente della Library a Londra, con la quale collaborò (scegliendo, acquistando e inviando libri) per oltre un trentennio. In questo modo, l'inglese divenne il patrono della nascente comunità scientifica di Filadelfia, introdusse Franklin negli ambienti scientifici europei, ne fece conoscere le ricerche sull'elettricità e ne proposte la candidatura alla Royal Society. Mentre Collinson a Londra assicurava contatti e libri, in America John Bartram, uno dei più stretti amici di Franklin, raccoglieva per lui semi, radici e piante che poi Collinson distribuiva ai suoi clienti (ma questa storia sarà raccontata in un altro post). Attento soprattutto ai risvolti economici della conoscenza della flora spontanea, Franklin incoraggiò Bartram a scrivere un libro sulla flora americana, con particolare riguardo alle piante medicinali e utilitarie. Per finanziarne le spedizioni botaniche, lanciò una pubblica sottoscrizione sul suo giornale (la Pennsylvania Gazette). Nel 1743, nel promuovere la creazione di una società scientifica ispirata alla Royal Society britannica, in Proposal for promotion useful knowledge among the British plantations in America sostenne l'importanza della diffusione delle nuove conoscenze per lo sviluppo agricolo delle tredici colonie. L'anno successivo lui e Bartram furono tra i soci fondatori della Philosophical Society, la prima e più importante società scientifica americana, e in tale veste nel 1748, quando Kalm giunse a Filadelfia, lo accolsero con entusiasmo, facendo anche da tramite con Linneo (attraverso il solito Collinson). Franklin di Kalm divenne amico e ne pubblicò il resoconto del viaggio alle cascate del Niagara. A partire dalla seconda metà degli anni '50, il crescente impegno politico portò ripetutamente Franklin in Europa; tra il 1757 e 1775 egli visse per lo più in Inghilterra, dove rivestiva il ruolo di ambasciatore ufficioso delle tredici colonie, specialmente della Pennsylvania. A Londra, oltre ad essere l'animatore del gruppo che si incontrava dapprima nella St. Paul Coffehouse, quindi nella London Coffehouse (il cosidetto Club of Honest Whigs), divenne membro corrispondente di numerose società scientifiche, diverse tra le quali si occupavano specificamente di agricoltura. Si interessò in particolare della diffusione nelle colone di nuove tecniche agrarie (ad esempio, l'uso del gesso come ammendante) e di colture da reddito e industriali. Convinto sostenitore delle potenzialità di un'industria della seta americana, studiò le caratteristiche del baco da seta e del gelso, che si ritiene sia stato introdotto negli Stati Uniti per sua iniziativa. Infatti, mentre le piante americane inviate da Bartram attraversavano l'oceano e andavano ad abbellire i giardini britannici, grazie a Franklin altre piante facevano il cammino inverso e contribuivano allo sviluppo economico delle colonie. Oltre al gelso, gli si attribuisce l'introduzione in America di cavolo scozzese, orzo svizzero, rabarbaro cinese, cavolo rapa. Ma contribuì anche all'agricoltura inglese, facendo giungere sul suolo britannico le mele americane Newtown pippin o la foraggera Phleum pratense (una poacea europea che intorno al 1720 era giunta in America grazie al coltivatore Timothy Hanson, e verso il 1760, con il nome di Timothy grass, incominciò ad essere coltivata anche in Inghilterra proprio grazie a Franklin). Inoltre, da Londra e più tardi da Parigi, spediva regolarmente semi di piante orticole e ornamentali alla moglie Debora a Filadelfia. Tra il 1775 e il 1781 egli fu ambasciatore del Congresso in Francia; al di là del suo importantissimo ruolo politico, divenne un personaggio universalmente noto e ammirato e poté frequentare da pari a pari gli ambienti scientifici parigini; grazie ai suoi contatti con gli animatori del Jardin des Plantes, poté così inviare semi, arbusti e alberi esotici sia in Inghilterra sia in patria. L'invio di semi, in particolare di varietà nuove, resistenti e potenzialmente produttive, divenne anche più importate con il boicottaggio dei prodotti inglesi: la battaglia per la libertà e l'indipendenza passava anche attraverso l'autonomia economica. Una sintesi della sua intensa e poliedrica vita nella sezione biografie. Nel 1785, al suo ritorno definitivo da Parigi, Franklin fece trasformare l'orto della sua casa di Filadelfia in un giardino: non c'erano aiuole di fiori (secondo lui, come ornamento erano già sufficienti e imbattibili quelli del vicino mercato) ma un prato circondato da alberi e da arbusti fioriferi, con sentieri in brecciolino. Il punto focale era un gelso, all'ombra del quale Franklin, durante i lavori della Convenzione costituzionale, amava sedere e discutere con i delegati. La casa e il giardino di Franklin non ci sono stati conservati, ma nel 1976, in occasione del bicentenario dell'indipendenza nel luogo in cui sorgevano sono state create due "strutture fantasma" in acciaio tubolare che suggeriscono le linee degli edifici scomparsi, al centro di un giardino che richiama gli elementi essenziali di quello originale: un gelso, il prato, aiuole rialzate con alberelli di sofora (Styphlobium japonicum) e fioriture stagionali.  Breve vita felice di Franklinia alamataha Nell'ottobre 1765, mentre esplorava la valle del fiume Alatamaha nei pressi di Fort Barrington insieme al figlio William, John Bartram notò alcuni curiosi arbusti (data la stagione, senza fiori). Solo nel 1773, William, nel corso dell'ampia spedizione botanica nel sud del paese, finanziata dal dottor Fothergill, di ritorno nella valle dell'Alamataha, poté ammirarne la fioritura; così racconta l'incontro nei suoi Travels: "Mentre stavo disegnando vicino al forte fu assai deliziato dalla scoperta di due magnifici arbusti in piena fioritura. Uno di loro sembrava essere una specie di Gordonia, ma i fiori sono più grandi e meno profumati di quello di G. lasianthus." William raccolse alcuni semi e, al suo ritorno a Filadelfia nel 1777, li seminò con successo nel suo vivaio: gli alberi crebbero e arrivarono a fiorire nel giro di pochi anni. Egli battezzò la nuova pianta Gordonia pubescens; ma Solander, sulla base di un esemplare inviato a Fothergill, fece notare che si trattava di un genere sconosciuto. I Bartram chiamarono dunque la pianta Franklinia alatamaha in onore del grande Benjamin Franklin, carissimo amico di famiglia, e del maestoso fiume sulle cui rive viveva. Nel 1785 il nome fu ufficializzato da Humphrey Marshall, cugino di William, nel suo Arbustum Americanum: The American Grove. Franklinia è un genere monotipico della famiglia Theaceae. La sua unica specie, appunto F. alatamaha, un grande arbusto o alberello caducifolio con spettacolari fiori bianchi, è estinta allo stato naturale. Quando William la individuò, notò che cresceva esclusivamente in un'area pianeggiante di due o tre acri lungo il fiume Alatamaha; non c'erano notizie che crescesse altrove. Nel 1790 Moses Marshall, figlio di Humphrey, nel corso di una spedizione di raccolta, localizzò di nuovo la stazione dove viveva la Franklinia. Nel 1803, John Lyon, giardiniere e cacciatore di piante scozzese, ne trovò da sei a otto esemplari; è l'ultima segnalazione della presenza della pianta in natura; essa può essere considerata estinta allo stato selvatico non molto dopo quella data. Perché la Franklinia si è estinta? Alcuni non esitano ad additare un colpevole a due zampe: sarebbe stata proprio la raccolta dei semi e dei pochi esemplari da parte dei cacciatori di piante a decretarne la fine. Ma forse la situazione è più complessa: il fatto che in coltivazione abbia mostrato una buona rusticità, crescendo rigogliosa in climi più freschi e suoli più ricchi di humus, ha fatto pensare che la specie sia di origine più settentrionale e si sia spostata a sud durante le glaciazioni; ma mano a mano che il clima si faceva più caldo, essa si trovò a vivere in suoli poveri, argillosi, poco drenati (proprio l'opposto delle condizioni preferiti dalle Theaceae). La popolazione, un tempo ben più diffusa, così incominciò a declinare e quelli trovati dai Bertram erano i suoi ultimi rappresentanti. Un'altra ipotesi è che al suo declino abbia contribuito la coltivazione estensiva del cotone nell'area, con la conseguente diffusione di organismi patogeni radicali, ancora oggi un grave problema per gli esemplari coltivati. Se l'uomo ha forse dato l'ultima spinta alla sorte vacillante della Franklinia, ne ha se non altro garantito la sopravvivenza in coltivazione: tutti gli esemplari oggi esistenti al mondo (si calcola che sia coltivata in un migliaio di luoghi: parchi, giardini, arboreti, orti botanici) discendono dai semi piantati da William Bartram nel 1777. Non è neppure ipotizzabile una sua reintroduzione in natura; proprio perché tutte le piante esistenti sono strettamente imparentate, non assicurano la diversità genetica sufficiente per resistere a nuove malattie o per adattarsi ai cambiamenti climatici. Nella scheda qualche informazione in più sulla bellissima e fragile Franklinia alatamaha e suoi notevoli ibridi nati dall'incrocio con altre Theaceae. La città francese di Rochefort, sulla costa Atlantica, offre al turista due attrazioni da non perdere: il grande edificio della Corderie Royale, al centro dell'Arsenale militare voluto da Luigi XIV, e il Conservatoire du Begonia, che vanta la più importante collezione di begonie d'Europa. Tra di esse c'è un legame: Michel Bégon, ri-fondatore della città e patrono del genere Begonia.  Un porto e un arsenale per il Re Sole La Francia del Re Sole non possedeva una flotta all'altezza delle altre potenze europee, dalla Spagna all'Inghilterra ai Paesi Bassi. Il re chiese dunque al superministro Colbert di costruire un grande porto militare dotato del "più grande e più bell'arsenale d'Occidente". La scelta cadde su un'area paludosa in un'ansa della foce del fiume Charente, che garantiva l'accesso al mare ma anche una posizione facilmente difendibile. Nel 1666 nasce così Rochefort. Quando Michel Bégon (1638-1710) vi approda, nel 1688, l'arsenale è operativo da pochi anni, ma resta ancora molto da fare. Su sua iniziativa vengono riedificati in pietra i quartieri abitativi, fino ad allora occupati da baracche di legno; inoltre opere di canalizzazione rendono più salubre l'abitato, infestato dalla malaria. Come ricorda il suo epitaffio, "Trovò questa città nascente in legno, la lasciò di pietra". Bégon, appassionato collezionista e cultore di botanica, ha fitti rapporti epistolari con scienziati, come Plumier o Tournefort che aveva conosciuto quando era intendente delle galere di Marsiglia. Anche grazie al suo impulso, Rochefort diventa la base di partenza delle spedizioni naturalistiche, che incominciano a infittirsi alla fine del XVII secolo. La città è il porto d'arrivo delle piante esotiche che arrivano dalle America, dall'Asia e dall'Africa, come ci ricorda il suggestivo nome di "Jardin des Retours" (Giardino dei ritorni) con il quale è stato battezzato il parco che circonda la Corderie royale (inaugurato nel 1991). Altre notizie su Bégon, sicuramente un personaggio interessante al di là dei suoi meriti botanici, nella sezione biografie.  Rochefort, capitale mondiale della Begonia Ma veniamo alla Begonia, di cui Rochefort si proclama la "capitale mondiale". Intorno al 1690, rientrato a Rochefort dal suo primo viaggio nelle Antille Charles Plumier dedica all'intendente della città la Begonia flore roseo folio orbiculare (oggi Begonia rotundifolia). In tal modo il frate paga un debito di riconoscenza: era stato proprio Bégon, in quel momento Intendente delle galere di Marsiglia, a fare il suo nome come botanico e disegnatore della spedizione nelle Antille. Inoltre l'uomo politico ben conosceva le isole, di cui era stato Intendente negli anni 1682-83. Botanofilo, si era interessato della flora locale e ne aveva redatto un catalogo. Passano i secoli e Rochefort sembra dimenticarsi della Begonia; in Francia il fiore non è molto di moda. Fa eccezione una straordinaria figura di coltivatore. Negli anni '60 del Novecento, il giardiniere Vincent Millerioux, specializzato in piante tropicali, incomincia a coltivare e collezionare begonie, mettendo a punto un substrato specifico. Quando nel 1985 cessa l'attività, la sua collezione, che comprende 400 tra specie e ibridi, rischia di essere dispersa; la città di Rochefort decide di acquisirla. Le circa 200 talee che arrivano nel 1986 saranno il primo nucleo del Conservatoire du Begonia che vanta oggi circa 1500 esemplari, 500 specie e 1000 ibridi. A partire dal 1988, le begonie trovano casa in una magnifica serra alla periferia della città, indovinate a quale indirizzo? in rue Charles Plumier n. 1! Nella gallery potete vedere alcune fotografie scattate in un afoso e indimenticabile pomeriggio del luglio 2011. Non mancate almeno una visita virtuale al sito del Conservatoire. Nella sezione schede notizie e curiosità sul genere Begonia. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|













 RSS Feed
RSS Feed