|
Nel 1586, presso l'editore Rouillé di Lione, comparvero i due tomi di Historia generalis plantarum, nota anche come "erbario di Lione". Il primo elemento che ci colpisce aprendo quest'opera poderosa è che, nonostante il reboante sottotitolo che promette al lettore la descrizione di tutte le piante note agli antichi nonché di quelle prima ignote scoperte "nelle parti orientali ed occidentali" e oltre un migliaio di illustrazioni "riccamente superiori a tutte le precedenti", il frontespizio non rechi il nome di alcun autore. Eppure un autore, o almeno un autore principale, c'era, e aveva lavorato a quell'opera per almeno un quarto di secolo. Era il medico, botanico e filologo Jacques Daléchamps. È troppo per pensare che fosse così insoddisfatto della redazione finale, che l'editore aveva affidato ad altri, da preferire che il suo nome non comparisse? Confusa, piena di errori, pesantemente censurata da Caspar Bauhin, con le sue oltre 2700 piante era comunque l'opera più ampia e ambiziosa dell'epoca e nonostante i difetti fu molto letta e consultata, specie nell'edizione francese. A ricordare il dottissmo Daléchamps, autore anche di una notevolissima edizione di Plinio, il genere Dalechampia, omaggio di Plumier replicato da Linneo. 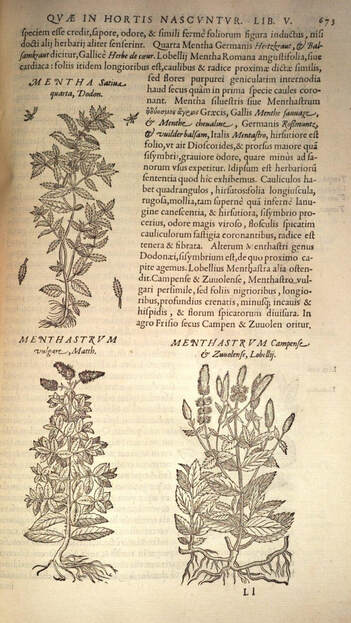 Un autore, troppi autori e un'opera anonima Nel Cinquecento, in seguito ai viaggi di esplorazione, il numero di piante conosciute incominciò ad aumentare drammaticamente, dalle poche centinaia note agli antichi alle migliaia incontrate dai viaggiatori europei nelle Americhe, in Asia, in Africa. I botanici del tempo, però, si illudevano ancora che il loro numero fosse gestibile, che fosse ancora possibile a una singola persona racchiuderle tutte in una singola opera. Dal De plantis di Andrea Cesalpino al Pinax di Caspar Bauhin, che con le sue 6000 piante segnerà allo stesso tempo il culmine e la fine di questo filone, il secondo Cinquecento è tutto un fiorire di queste opere enciclopediche che si vorrebbero onnicomprensive. Tra i tentativi più grandiosi ma allo stesso tempo sfortunati, spicca Historia generalis plantarum di Jacques Daléchamps (1513-1588). Figlio egli stesso di un medico di Caen, nel 1545, già ultratrentenne, si iscrisse all'università di Montpellier, dove fu uno dei primissimi allievi di Rondelet, con il quale rimase in termini di stretta amicizia, scrivendo in suo onore anche due dei poemi encomiastici che si leggono in De piscibus. Dopo la laurea, per qualche tempo visse a Valence e a Grenoble, finché intorno al 1550 si stabilì a Lione dove sarebbe vissuto fino alla morte. Nel 1552 fu nominato medico dell'Hôtel-Dieu dove avrebbe esercitato per circa trent'anni, nel corso dei quali fu sempre più presente nella vita cittadina. Erano anni difficili per Lione, devastata dalle guerre di religione, della povertà, dalla sifilide, da ripetute epidemie di peste. Daléchamps si fece un nome come ottimo medico e chirurgo e fu più volte chiamato a far parte delle commissioni mediche nominate dal consiglio cittadino o dal governatore per cercare di contrastare quel terribile flagello. Proprio alla peste dedicò quella che è probabilmente la sua prima opera a stampa (De Peste libri tres opera Jacobi Dalechampii, 1552), che non è un lavoro originale, ma la riedizione di un trattato trecentesco del medico di Montpellier Raymond Chalin de Vinario. È l'ingresso di Daléchamps nel mondo dell'editoria che aveva in Lione una delle sue capitali. Da quel momento egli fu molto attivo sia come autore (gli si deve tra l'altro una Chirurgie Françoise, pubblicata nel 1570), sia come filologo, traduttore e divulgatore di opere dell'antichità: tradusse in latino e commentò I deipnosofisti di Ateneo di Naucrati; tradusse in francese dal greco l'opera di Galeno e le opere mediche di Paolo Egineta e dal latino le opere mediche di Celio Aureliano. La più importante delle sue opere filologiche è senza dubbio l'edizione commentata della Naturalis historia di Plinio (1584), un lavoro dottissimo e assai apprezzato che lo impegnò per almeno un decennio. Al momento della morte, lasciò manoscritta un'edizione delle opere dei due Seneca, il retore e il filosofo, e una traduzione latina di tutte le opere superstiti di Teofrasto. Furono presumibilmente proprio questi molteplici impegni editoriali ad impedirgli di curare di persona la pubblicazione di Historia generalis plantarum e in definitiva a determinarne il fallimento. D'altra parte l'iniziativa di pubblicare una grande opera illustrata che raccogliesse tutte le piante note agli antichi e ai moderni presumibilmente non venne da lui, ma dall'editore Rouillé; nella prefazione (Lettera al lettore), quest'ultimo scrive: "Più di 20 anni fa, entrando nello studio di Jacques Daléchamps, trovai questo eccellente medico intento a consultare un grosso manoscritto di disegni di piante; la vista di questi disegni rari e squisiti mi fece pensare che avrebbero potuto essere l'infanzia e l'origine di un'opera estesa". Questa versione è confermata dal medico lionese Jacques Pons, una fonte molto affidabile in quanto collega ed amico di Daléchamps. Rouillé (in latino Rovillus), che si era formato a Venezia con i Giolito, era un abilissimo imprenditore che nei suoi 45 anni di attività pubblicò circa 830 testi, spaziando dai classici alla letteratura francese, italiana e spagnola, al diritto, alla religione, alla medicina e alle scienze. Sapeva scegliere i suoi collaboratori ed era perfettamente consapevole che il successo commerciale di un'opera di botanica dipendeva soprattutto dall'apparato iconografico, come avevano dimostrato i recenti esempi di Historia stirpium di Fuchs (1542) e dell'edizione latina illustrata dei Commentari di Mattioli (1554). Non stupisce che sia stata attratto e colpito, più che dal sapere botanico e filologico di Daléchamps, dalla sua grande ed eccellente collezione di immagini. Daléchamps iniziò a collaborare con Rouillé nel 1552 curando il già citato trattato sulla peste; nel 1558 l'editore lo coinvolse in una riedizione del commento a Dioscoride di Amato Lusitano. Stando al sottotitolo, "sono state aggiunte a quest'opera, oltre alla correzione dei lemmi, le annotazioni di R. Constantin nonché le immagini dei semplici di Leonhardt Fuchs, Jacques Daléchamps e altri", il suo ruolo dovette limitarsi a procurare alcune immagini, mentre le altre furono "piratate" da Fuchs ed altri. Della cura del testo si occupò un altro medico e filologo, Robert Constantin. Anche lui era originario di Caen e buon amico di Daléchamps, cui dedicò la sua opera più nota, il Lexicon graeco-latinum (1562). Se già a questa data egli aveva messo insieme quel grosso manoscritto di "disegni rari e squisiti", possiamo ipotizzare che Daléchamps avesse iniziato ad erborizzare, disegnare o far disegnare piante, se non nella sua giovinezza in Normandia, per lo meno negli anni di studio a Montpellier, secondo l'insegnamento di Rondelet, che incoraggiava i suoi allievi a percorrere le campagne alla ricerca di piante. Dovette dunque aderire con entusiasmo al progetto editoriale di Rouillé, che da parte sua si fece carico delle costosissime matrici xilografiche, sia originali, sia copiate da altre opere; mise a disposizione di Daléchamps il suo grande giardino, la Recluserie de Ste Hélène, dove secondo Pierre Jacquet, "i botanici lionesi coltivavano le piante descritte in Historia generalis plantarum"; tramite la sua vasta rete commerciale, gli fece inviare campioni di piante da tutto l'Occidente; infine, gli trovò in successione due aiutanti. Il primo fu Jean Bauhin (1541-1613). Allievo di Fuchs e Gessner, nell'ottobre 1561, appena ventenne, si iscrisse alla facoltà di medicina di Montpellier, laureandosi l'anno successivo. Anche lui allievo di Rondelet, durante il soggiorno in Linguadoca erborizzò intensamente con il condiscepolo Leonhard Rauwolf. Viaggiò poi in Italia e nel settembre 1563 si stabilì a Lione, prendendo alloggio a casa di Rouillé. Qui lavorò a un'opera sulle piante che, secondo diversi commentatori, altro non sarebbe che Historia generalis plantarum. Nel 1568, come protestante, dovette però lasciare la città con la famiglia (nel frattempo si era sposato con una lionese) e rifugiarsi in Svizzera. Nella sua prefazione, Rouillé non fa parola di questa collaborazione, mentre in una lettera scritta circa trent'anni anni dopo, a proposito di Historia generalis plantarum Jean Bauhin scrive "Quando questa storia mi è stata affidata, mi dedicai ad essa con coraggio e con qualche successo". Pierre Jacquet, che verso la fine del Novecento ha dedicato un approfondito articolo ai botanici lionesi del Rinascimento, soffermandosi in particolare su Daléchamps e sull'erbario di Lione, ritiene si tratti di una vanteria, corrispondente all'aspirazione di Bauhin di "essere riconosciuto come collaboratore di questa grande impresa, ma le circostanze hanno fatto sì che la sua partecipazione sia fallita e ne è derivato un grande risentimento". Jacquet è però in controtendenza; generalmente si ritiene che l'opera a cui lavorava Jean Bauhin quando viveva a Lione fosse Historia generalis plantarum e che egli abbia iniziato a lavorare alla sua Historia plantarum universalis molto dopo. Del resto, visto il pessimo giudizio di Bauhin sull'opera, è strano che desiderasse intestarsela. Tuttavia, il suo soggiorno a Lione durò appena cinque anni, il che dovette forzatamente limitare la portata del suo contributo. Daléchamps dovette continuare a lavorare alacremente al grandioso progetto nel corso degli anni '70, da una parte moltiplicando le ricerche sul campo, dall'altra leggendo, annotando, confrontando, chiosando le opere botaniche di antichi e moderni. Jacquet ha documentato una serie di viaggi in Normandia, a Parigi (dove potrebbe aver visitato giardini pubblici e privati con collezioni di piante esotiche), in Alvernia, nelle Cevenne, nel Delfinato, nel Giura, nel Vallese, nella regione di Ginevra. Daléchamps corrispondeva (e scambiava materiali) con molti botanici di primo piano, tra i quali troviamo Gessner, Camerarius e Lobel. Tuttavia, con l'intensificarsi degli altri impegni editoriali - il commento a Plinio, dopo un impegno ventennale, fu completato e pubblicato nel 1587, contemporanemente a Historia generalis plantarum, e in quegli anni Délechamps lavorava anche alle traduzioni di Teofrasto e Seneca - egli dovette rassegnarsi ad affidare ad altri la redazione finale di quella che in una lettera all'amico Camerarius definisce la "nostra opera monumentale sulle piante"; la scelta dell'editore cadde sul medico Jean Desmoulins (1530-1582). Anch'egli aveva studiato a Montpellier, ma probabilmente non fu allievo di Rondelet, morto lo stesso anno della sua iscrizione alla facoltà di medicina; collaborava da tempo con Rouillé per il quale aveva curato la traduzione francese dei Commentarii di Mattioli (Les Commentaires de M. Pierre-André Matthiole, médecin sénois, sur les six livres de P. Dioscoride, 1572 e nuovamente 1579). La natura del contributo di Desmoulins è chiarita dal ben informato Pons che, dopo aver ricordato la genesi dell'opera, il debito con gli antichi e i moderni (cita Mattioli, Dodoens, Anguillara, Fuchs, Lobel e Pena, Bock e un misterioso Tenerus) e le "non poche" descrizioni e immagini messe insieme da Daléchamps, scrive: "Il medico Molinaeus [= Jean Desmoulins], uomo di singolare erudizione e dottrina, con la massima cura e diligenza divise questa massa di piante [ovvero sia quelle raccolte e descritte da Daléchamps, sia quelle ricavate dalle opere di autori antichi e moderni] in ordini e classi, ne aggiunse molte dagli antichi, e anche qualcuna di suo, avvelendosi del consiglio di Daléchamps". Insomma, il suo ruolo fu quello di editor o, se vogliamo usare l'espressione impiegata da Jacquet, di negro, incaricato di trasformare le note più o meno organizzate accumulatesi in 25 anni di lavoro in un testo compiuto. Inoltre contemporaneamente attese a una traduzione parziale in francese. Forse la cosa avrebbe potuto funzionare, se Desmoulins non fosse morto nel 1582, quando era stata completata la stampa solo dei primi 4 libri (su 17 totali). Daléchamps - vecchio, malato, sovraccarico di lavoro - non poteva occuparsene, Rouillé voleva pubblicare a tutti i costi, viste le ingenti spese già sostenute; di fatto, tra dilazioni e ritardi, a occuparsi di quanto rimaneva sarebbero stati i tipografi, con l'accumularsi di errori di ogni tipo. Scrivendone a Clusius in una lettera del 1603, Lobel indica un colpevole: "M. Chaubin [presumibilmente il proto che si occupò della messa in pagina] è imputabile degli errori e dei gravi abusi di questo erbario e di ben 400 figure usate due o anche tre volte per la stessa pianta in paragrafi diversi". Adriaan van der Spiegel nella sua Isagoge in rem herbariam (1606) aggiunge altri responsabili: "si afferma da fonte sicura che [Daléchamps] aveva lasciato incompiuto il suo erbario; così questo libro contiene molti errori dovuti ai copisti che hanno preparato l'erbario per la stampa". Infine i due volumi furono pronti per la fiera di Lione del gennaio 1586 (a causa dell'ennesimo refuso, il primo volume reca la data 1587), ma sul frontespizio non compare il nome di nessun autore; la spiegazione più probabile è che, vedendo il disastro, Daléchamps abbia preferito non figurare come autore di un'opera così sconciata. Forse sperava di firmare una prossima seconda edizione rivista; tuttavia egli morì nel 1588, Rouillé lo seguì l'anno dopo, e il suo erede non aveva alcun interesse a mettere mano a una seconda edizione, tanto più che la prima non era esaurita; solo molti anni dopo, nel 1617, avrebbe pubblicato l'edizione francese nella traduzione di Jean Desmoulins che, al contrario, di quella latina, fu un successo editoriale .  Luci e ombre di un'opera monumentale Per dimensioni e numero di piante trattate si trattava effettivamente di un'opera enciclopedica: due volumi in folio per 2034 pagine complessive, illustrate con 2686 incisioni; le piante trattate sono 2700, molte di più di qualsiasi opera precedente (per fare due soli esempi, in Stirpium adversaria nova di Pena e Lobel erano 1200, in De plantis di Cesalpino 1500). Le piante non sono esposte in ordine alfabetico, ma raggruppate in diciotto categorie, ognuna delle quali occupa un libro. A differenza proprio di Cesalpino o anche di Lobel, non abbiamo a che fare però con un sistema, ma con raggruppamenti eclettici, basati ora sull'habitat, ora sugli usi, ora su caratteristiche delle piante stesse. Iniziando dal Libro I, troviamo gli alberi che crescono spontaneamente nei boschi; quindi gli arbusti che crescono spontaneamente nelle siepi e nei cespugli (libro II); gli alberi piantati nei frutteti (libro III); grani, leguminose e erbe selvatiche che li accompagnano (libro IV); ortaggi e erbe che crescono nei giardini e negli orti (libro V); le ombellifere (libro VI); le piante che piacciono per i loro fiori (libro VII); piante aromatiche (libro VIII); piante palustri (libro IX); piante che crescono in luoghi aspri, sabbiosi, rocciosi o aridi (libro X); piante dei luoghi ombrosi, umidi, fangosi, umiferi (libro XI); piante delle rive del mare e del mare stesso (libro XII); piante rampicanti (libro XIII); cardi e altre piante spinose e pungenti (libro XIV); piante bulbose, con radici carnose e geniculate (libro XV); piante purgative (libro XVI); piante velenose (libro XVII); piante esotiche (libro XVIII), ovvero le plantae peregrinae come si chiamavano allora. È il libro più ampio - oltre 170 pagine -attinto soprattutto da Mattioli, Clusius e Lobel. Segue un amplissimo indice plurilingue (latino, greco, arabo, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese, ceco e inglese) di una cinquantina di pagine. A questo punto l'editore dovette accorgersi che qualcosa rimaneva fuori e volle ancora aggiungere due appendici, la prima sulle piante esotiche poco note, ricavata essenzialmente dalle opere di Acosta e Garcia da Orta, la seconda sulle piante egizie e siriane inviate da Rauwolf. Dalle lettere di Daléchamps a Camerarius sappiamo che questa aggiunta fu un'idea esclusiva di Rouillé, che rallentò ulteriormente la pubblicazione e lo contrariò assai. Da eccellente editore qual era, Rouillé garantì un'opera graficamente curata, con bei capilettera e capitoli chiaramente scanditi da sottotitoli a margine; ogni capitolo è dedicato a una pianta, di cui vengono esposti i nomi (nomina), le sottospecie o tipi (genera), l'aspetto (forma), l'habitat (locus), le proprietà medicinali e gli usi, con riferimenti puntuali e citazioni di antichi e moderni; l'opera vuole infatti presentarsi come una summa di tutto ciò che è stato scritto sulle piante fino a quel tempo. Secondo Jacquet, gli autori citati sono oltre 300. Tra gli antichi i più citati sono Plinio e Dioscoride, tra i moderni Mattioli, Pena e Lobel. Un enorme sovraccarico informativo che è crollato su se stesso quando la cura dell'opera è rimasta abbandonata a Rouillé e ai suoi tipografi. I possibili disastri sono ben esemplificati dalla voce Primula del settimo libro (riprendo l'esempio dal bell'articolo di B. Olgivie The Many Books of Nature: Renaissance Naturalists and Information Overload); dopo averne elencato i nomi, vengono descritti i tre tipi menzionati da Dodoens, cui se ne aggiungono altri tre, per un totale di sei, ma le illustrazioni sono sette. Segue un lungo excursus in cui si discute se questa pianta va identificata con il verbascum di Dioscoride, che risulta del tutto inutile dato che esso viene confuso con verbasculum. Così, quando infine l'opera uscì, per citare ancora Olgivie, "molti contemporanei condivisero l'impressione che fosse una raccolta di note mal editate". Clusius la attendeva con impazienza, ma dopo la sua pubblicazione non la menzionò mai, forse anche offeso dall'omissione di molte piante trattate nelle sue opere. Anche il medico e naturalista sassone Caspar Schwenckfeld ne fu profondamente deluso: in una lettera a Caspar Bauhin, scrive che il libro è stato messo insieme con poco giudizio e in un ordine confuso. Durissimo il giudizio di Jean Bauhin: "A dire il vero, colui che ha messo insieme questo erbario di Lione ha usato i nostri materiali, ma con molte altre cose, li ha accatastati con poco giudizio, talvolta separando i generi dalle specie, talvolta introducendo, spesso a sproposito, descrizioni e rappresentazioni. Ovviamente non poteva fare diversamente, essendo mal informato in materia di piante e poco al corrente delle dotte riflessioni del sapientissimo Daléchamps, che confonde indistintamente con le nostre e quelle di qualcun altro. Ne risulta una storia confusa, mal digerita e senza giudizio e, si potrebbe dire, senza grande utilità per il vero botanico". Se Bauhin poteva essere mosso dal risentimento personale, si deve invece al devoto ricordo dell'amico scomparso e al desiderio di salvare il salvabile l'intervento di Jacques Pons. Nell'opuscolo In Historium generalem plantarum Rouillii, duobus tomis et appendice comprehensam breves annotationes & animadversiones compendiosæ, pubblicato nel 1600, dopo una breve prefazione utile per ricostruire la genesi dell'erbario di Lione, egli elencò e corresse 294 errori, per la più tipografici e non sostanziali. Pons dimostra grande ammirazione per Daléchamps, non critica l'opera in sé e di fatto il suo è un errata corrige, di cui infatti gli eredi Rouillé tennero conto nell'approntare l'edizione francese (Histoire générale des plantes, sortie latine de la bibliothèque de M. Jacques Daléchamps, puis faite française, par M. Jean de Moulins, 1615). Hanno invece tono e intento demolitorio le Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam pubblicate nel 1601 da Caspar Bauhin; le sue critiche puntano in particolare contro le descrizioni e le figure prese di peso da altre opere e soprattutto il pasticcio delle figure, 400 delle quali sono ripetute due o anche tre volte. Le tristi vicende editoriali della sua opera botanica hanno finito anche per occultare a lungo il contributo personale di Daléchamps non come erudito o chiosatore di opere altrui, ma come botanico sul campo. Il primo ha sottolineare questo aspetto fu forse Dominique Villars nel 1786 scrivendo: "Quanto ne avrebbe guadagnato la reputazione di Dalechamps se, invece di affidare le sue note a medici che poco sapevano di botanica, a tipografi, a gente che voleva racchiudere tutto in una storia generale, avesse potuto redigere egli stesso e darci ciò che aveva visto, senza obbligare G. Bauhin a scrivere [...] un libro per rilevare gli errori grossolani in cui essi erano caduti". Qualche anno dopo, in Historia rei herbariae (1807) Curd Sprengel diede un primo elenco di 57 piante del Lionese e della Francia occidentale descritte per la prima volta da Daléchemps; tuttavia, il suo contributo come pioniere dello studio della flora delle Alpi occidentali è stato messo in luce solo all'inizio del Novecento dallo svizzero Hermann Christ. Nel suo articolo più volte citato, Jacquet ha infine individuato "131 piante nuove descritte da nostro semplicista lionese", fornendone l'elenco con i nomi di Daléchamps e quello attuali. Nel mare magnum di Historia generalis plantarum, rappresentano appena il 6%, ma sono sufficienti a dimostrare che non sbagliava Linneo in Philosophia botanica a classificare il nostro non solo tra i "commentatori degli antichi" (pensava certo al suo Plinio), ma anche tra i "descrittori utilissimi".  Una pianta degli orti e un genere singolare Il XVI capitolo del V libro, quello sulle umili piante degli orti, è dedicato a Hieracium. Se ne illustra il nome in greco, latino e francese, quindi si passa ai tipi: "Dioscoride gli assegna due tipi, il grande e il piccolo, ai quali Daléchamps aggiunge Hieracium macrocaulon [...]. Quest'ultimo prende il nome dalla lunghezza del fusto". Questo "Hieracium" dal fusto lungo e sottile oggi si chiama Hypochaeris radicata ed in realtà era già stato descritto da Dodoens e Lobel. La vera novità è il supposto H. magnum di Dioscoride, di cui Daléchamps, contestando la precedente identificazione di Mattioli, fornisce una propria illustrazione e un'accuratissima descrizione. Sono le prime in assoluto di una pianta che ancora porta il suo nome: è il boccione maggiore Urospermum dalechampii. Ma, per volere di Plumier confermato da Linneo, Daléchamps è ricordato anche da un genere esotico, che mai vide e conobbe. Dalechampia (famiglia Euphorbiaceae) è un grande genere di un centinaio di specie diffuso soprattutto dal Messico all'America tropicale, con un numero minore di specie in Africa, Madagascar e Asia meridionale; il numero maggiore di specie si concentra invece in Brasile, con una settantina di specie e una cinquantina di endemismi. È caratterizzato da fiori unisessuali secondariamente uniti in infiorescenze bisessuali (pseudanthia) che fungono da unità di impollinazione. Ciascuna infiorescenza, a simmetria bilaterale, è caratterizzata da due brattee grandi e vistose oppure piccole e ridotte a stipole, un pleiocasio di 4-50 fiori staminati (maschili) e una cimetta di 1-3 fiori pistillati (femminili); diverse specie sono munite di ghiandole resinifere. La singolarità dei fiori, unici in questa famiglia (tanto che il genere è l'unico rappresentante di una propria tribù, Dalechampiinae), e la grande varietà di forme di impollinazione ne hanno fatto uno dei gruppi più studiati tra le Euphorbiaceae. La maggior parte delle specie neotropicali sono impollinate da femmine di varie specie di imenotteri che usano la resina per costruire i nidi; una dozzina di specie è però impollinata da imenotteri maschi, che si servono della resina profumata per attirare le femmine. Le specie asiatiche sono impollinate da api Megachile racoglitrici di resina, mente quelle malgasce lo sono sia da api raccoglitrici di resina sia da api raccoglitrici di polline. Le Dalechampia sono prevalentemente rampicanti, in alcuni casi liane, più raramente arbusti o suffrutici. Hanno rami cilindrici, in alcune specie muniti di peli urticanti, morfologia fogliare molto varia, con foglie da intere a composte, con lamina lineare, obovata, cordata, lanceolata, talvolta profondamente lobata, con grande variabilità anche nello stesso individuo. Alcune specie con brattee vistosamente colorate sono talvolta coltivate; quella più comunemente offerta dai vivai è Dalechampia aristolochiifolia, con brattee viola, anche se, a causa della scorretta identificazione iniziale, è per lo più commercializzata come D. dioscoreifolia.
0 Comments
Nel 1546, quando parte per il suo memorabile viaggio in Oriente, il francese Pierre Belon è già un naturalista completo, formatosi niente meno che alla scuola del geniale Valerius Cordus. Visita quei paesi da vero uomo del Rinascimento, deciso a tutto osservare e tutto annotare. Il suo obiettivo principale è identificare in situ le piante e gli animali citati nelle opere di Galeno e Dioscoride, ma non mancherà di soffermarsi sulla geografia, i monumenti, gli usi e i costumi, la medicina. Al suo ritorno, oltre a descrivere ciò che ha visto e osservato nel suo libro più celebre, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs, continua a viaggiare in Europa e pubblica moltissimo, forse nell'intento di scrivere una grande storia naturale. Incisivo soprattutto il suo contributo alla zoologia, con due notevoli trattati, uno sui pesci e l'altro sugli uccelli, celebre per contenere il primo tentativo di anatomia comparata. Come botanico, scrive la prima opera dedicata esclusivamente alle conifere e un trattato di arboricoltura, che riflette il suo interesse per l'acclimatazione di piante esotiche; gli è attribuita l'introduzione in Francia di diverse piante mediterranee, dal cedro del Libano all'albero di Giuda. Grazie a Plumier e Linneo, lo ricorda il piccolo genere Bellonia (Gesneriaceae), endemico di Cuba e Haiti.  Anni di apprendistato: Francia, Germania, Italia Dopo il disastro della battaglia di Pavia (1526), per controbilanciare lo strapotere di Carlo V, il re di Francia Francesco I cerca l'alleanza di Solimano il Magnifico. Dal 1537 c'è un ambasciatore permanente presso la Sublime Porta. Il primo è Jean de la Forest, che negozia le Capitolazioni che concedono alla Francia gli stessi privilegi di cui già godevano Venezia e Genova: la sicurezza dei beni e delle persone, l'extraterritorialità e la libertà di trasportare e vendere beni a condizione di pagare i diritti di dogana; tuttavia, la sua missione è complessivamente un fallimento e le Capitolazioni saranno ratificate solo nel 1569. Si succedono diversi altri ambasciatori, che sono soprattutto militari, e negli anni successivi i turchi intervengono a più riprese a fianco dei francesi contro gli imperiali; tuttavia nel 1545, Francesco I è costretto ad accettare la pace di Crépy che prevede il riconoscimento del dominio di Carlo V sull'Italia e un armistizio tra turchi e imperiali. Il re francese l'ha siglata a malincuore, e non sogna altro che riprendere la guerra. Conta più che mai sull'alleato ottomano, che vorrebbe convincere a rompere la tregua e a intervenire sia in Italia sia in nord Africa. Per recuperare il prestigio intaccato da tante sconfitte e da una politica esitante, nel 1546 invia a Costantinopoli una grandiosa ambasceria. A capeggiarla è Gabriel de Luetz, signore di Aramon, un diplomatico esperto che conosce bene la corte ottomana per aver già partecipato a missioni precedenti, accompagnato un grandioso seguito di settantacinque o ottanta persone. E' una missione diplomatica, ma anche scientifica; del gruppo fanno parte l'erudito Pierre Gilles, con il compito di procurare manoscritti per la biblioteca reale, e il naturalista Pierre Belon, con la missione di recensire le risorse dell'impero ottomano in vista di una futura partnership commerciale. Più tardi, saranno raggiunti dall'avventuroso André Thevet e dal geografo Nicolas de Nicolay. Tutti al loro ritorno in Francia pubblicheranno resoconti dei loro viaggi. Quello più importante dal nostro punto di vista, e non solo per lo spazio privilegiato occupato dalle piante e dagli animali, è quello di Pierre Belon, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs. Belon è un erudito, che affronta il suo viaggio in Oriente con il bagaglio di molte letture, ma è soprattutto un osservatore meticoloso, deciso a mettere al primo posto l'esperienza diretta. E' il metodo che ha appreso dal suo maestro, il botanico tedesco Valerius Cordus, di cui in qualche modo raccoglie l'eredità: visitare il Levante per verificare sul posto la tradizione botanica degli antichi era il grande sogno di Cordus, morto troppo presto. Pierre Belon (1517-1564) nasce nel villaggio di Souletières, a una trentina di km da Le Mans, che più tardi avrebbe considerato la sua patria, tanto da firmarsi alla latina Petrus Bellonius Centomanus. Non conosciamo quasi nulla dei suoi primi anni: nato probabilmente in una famiglia contadina, trascorre l'infanzia in Bretagna, in un ambiente dove già stava penetrando il protestantesimo (forse nelle terre dei Rohan), con una natura varia e affascinante che accende il suo interesse per le scienze naturali. Adolescente, entra come apprendista nella bottega di un conterraneo, il farmacista René des Prez, e nel 1535 lo segue in Alvernia al servizio di Guillaume du Prat, vescovo di Clermont. Tre anni anni dopo torna nel Maine e passa al servizio di René du Bellay, vescovo di Les Mans, probabilmente come farmacista. Il vescovo era il più giovane dei quattro fratelli du Bellay (Guillaume, Jean, Martin e appunto Renè) che, come diplomatici, uomini politici, religiosi, mecenati delle arti e scrittori essi stessi, ebbero un ruolo di primo piano nella politica e nella cultura francese del Rinascimento. Erano inoltre cugini del grande poeta Joachim du Bellay, uno dei sette fondatori della Pléiade. E' forse la comune passione per le piante che fa scoprire al vescovo il talento di quel giovane farmacista. A Touvoie, non lontano da Les Mans, il vescovo possiede un raffinato giardino che anni dopo sarà lodato da Conrad Gessner: "E' impossibile lodare a sufficienza il giardino di René du Bellay, vescovo di Les Mans, per la coltivazione delle erbe e degli alberi più rari; è il più nobile tra tutti quelli che oggi possiamo vedere non solo in Germania ma nella stessa Italia, tanto che nulla si può aggiungere all'assoluta cura e diligenza d'un giardino ben coltivato e ricolmo di innumerevoli ricchezze di piante". Lo stesso Belon lo definirà «un vasto vivaio di alberi e arbusti esotici»; è considerato uno dei primi giardini botanici francesi, ma più correttamente si trattava di un giardino di acclimatazione nonché di un arboretum. La relazione tra Belon e il giardino di Touvoie non è molto chiara. Scrivendone molti anni dopo la morte del suo protettore, dopo aver lodato la singolare liberalità e bontà del cancelliere di Francia François Olivier, Belon aggiunge: "Lo stesso si può dire del fu monsignor René du Bellay, vescovo di Le Mans, dal quale in passato nella nostra giovane età abbiamo ricevuto benefici, e non per avergli portato i semi di parecchie piante dall'Italia, dalla Germania e dalle Fiandre, alcune delle quali ancora sopravvivono, abbellendo il giardino Touvoie che egli ha creato vicino alla città di Les Mans". Una base molto esile per dedurne che Belon in quel giardino avesse il ruolo di giardiniere, di curatore o addirittura di progettista, come si legge in varie parti. E' invece certo che il vescovo decide di prendere sotto la sua ala protettrice il promettente giovanotto e di finanziargli gli studi. Così, nel 1540 Belon parte per una meta sorprendente nell'Europa dilaniata dai conflitti religiosi: l'università di Wittenberg, ossia il maggiore centro culturale del luteranesimo, fondata dal protettore di Lutero Federico il Saggio e profondamente influenzata dal suo braccio destro Filippo Melantone. Meno sorprendente conoscendo il ruolo dei fratelli du Bellay nella diplomazia ufficiale, ufficiosa e segreta della Francia di Francesco I. Il capo della famiglia, Guillaume (soldato lodato per il suo coraggio, fine diplomatico, storico e scrittore di talento, autore di molti dei testi ufficiali di Francesco I), prima in Italia e poi nel resto d'Europa intessé una rete informale di corrispondenti, informatori ed agenti, reclutata soprattutto tra i letterati e gli eruditi che temevano lo strapotere imperiale. Du Bellay alimentava ovunque era possibile la contestazione contro Carlo V, in particolare in Germania, dove intratteneva rapporti ufficiosi con i principi protestanti della Lega di Smalcalda. Non sappiamo se prima di partire per la Germania Belon abbia incontrato il potente fratello del suo protettore, e se già a questo punto sia stato reclutato nella sua rete; ma certo in Germania non perde tempo. Egli, che ha appreso il latino e il greco da autodidatta, segue le lezioni di farmacia, chimica e botanica del brillante Valerius Cordus che commenta Dioscoride, ma soprattutto insegna ai suoi allievi un metodo rigoroso che, senza negare il patrimonio di conoscenze ereditato dai classici, lo verifica alla luce dell'esperienza diretta; da lui impara ad osservare meticolosamente, a cogliere affinità e differenza, cogliere i particolari che distinguono una pianta dalla altra. Insieme a Cordus, che ha appena due anni più di lui ed è ormai un amico, viaggia incessantemente alla scoperta della flora tedesca: "Nessuno se n'è mai andato altrettanto vagando per i paesi di Sassonia, Turingia, Pomerania quanto me, anzi in tutte le foreste di Germania e di Boemia. Nello spazio di quattro mesi percorremmo tutte le contrade della Germania, ospiti talvolta di teologi talvolta di medici, finché giungemmo nella Germania settentrionale". Benoît Léthenet, che ha studiato attentamente i movimenti di Belon, dimostrando che è stato innegabilmente un "informatore reale", fa notare che questo viaggio naturalistico non è tanto diverso da una ricognizione militare nelle terre imperiali. In ogni caso, al suo ritorno in Francia nel 1542, Belon porta nei suoi bagagli non solo semi per il vescovo di Les Mans, una formazione all'avanguardia in chimica e in botanica, ma anche una perfetta conoscenza dell'area tedesca e della sua lingua. Continua gli studi in medicina a Parigi (si laureerà solo molti anni dopo, nel 1560) e, grazie alla presentazione dei du Bellay, trova un nuovo protettore in un altro personaggio di primo piano della corte francese: il cardinale François de Tournon, che è stato definito "il ministro degli esteri in pectore" di Francesco I. Nel 1543 ritorna in Germania, certamente per incontrare il suo maestro, ma anche nei panni di agente reale: gli vengono affidate sia lettere per i principi tedeschi che si stanno avvicinando alla Francia, sia per l'ambasciatore francese ad Augusta. Poi è a Soletta in veste di interprete dell'ambasciata francese; è un luogo strategico: in questa città cattolica anche in passato legata alla Francia viene organizzato il reclutamento di mercenari elvetici. A Ginevra si fa trascinare in una disputa teologica; arrestato, rimane sei mesi in carcere. Liberato, passa da Lione, visita la Provenza e prosegue per l'Italia. In Liguria ritrova Valerius Cordus; probabilmente è uno dei compagni del suo ultimo viaggio ed assiste alla sua morte per malaria a Roma. Nelle sue opere Belon cita molte località italiane che potrebbe aver visitato in questi anni, ma i particolari della sua vita in questi periodo sono oscuri. Di sicuro nel 1546 è tornato in Francia, alloggia nell'abbazia di Saint-Germain-en-Laye, di cui il cardinale Tournon è abate, e frequenta la corte. Ed è certo grazie al suo influente protettore che viene aggregato all'ambasceria Aramon a Costantinopoli. Come consulente scientifico, certamente; come diplomatico, probabilmente; come agente speciale, forse. Come vedremo, è finanziato abbastanza generosamente da viaggiare anche in modo indipendente. 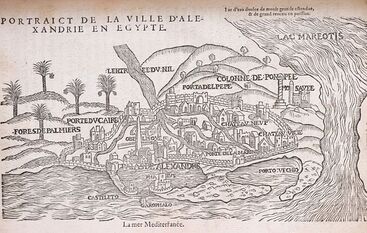 Il viaggio in Oriente Conosciamo minuziosamente l'itinerario del suo viaggio in Oriente, che durerà tre anni, grazie a Les observations. L'ambasceria lasciò segretamente Parigi nel dicembre 1546 e, dopo aver attraversato la Francia e la Svizzera, nel gennaio 1547 si imbarcò a Venezia su tre galee. La piccola flotta attraversò l'Adriatico fino a Ragusa, da dove il viaggio proseguì via terra fino a Adrianopoli (oggi Edirne). Invece Belon e Bénigne de Villers, un farmacista di Digione, proseguirono via mare; visitarono Corfù, Zante e Citera; a Paxos, mentre Belon stava erborizzando, il suo compagno e diversi marinai furono rapiti dai pirati. Belon sfuggì alla cattura e poté proseguire per Creta; l'isola aveva fama di essere un paradiso botanico, e il naturalista francese non mancò di scalare il monte Ida e i monti della regione di Sfakia, visitò Rethymnon, si illuse di aver identificato il famoso labirinto nelle cave di Ampelouzos, studiò l'estrazione del labdano (la resina tratta da Cistus ladanifer), ma soprattutto, come aveva fatto in Germania con Cordus, andò in giro, raccolse piante, osservò e fece domande su tutto ciò che lo colpiva. Infine si imbarcò su una feluca veneziana diretta a Costantinopoli. Al largo di Kea, sfuggì a un altro attacco di pirati. Forse alla fine della primavera o all'inizio dell'estate, era a Costantinopoli, dove si ricongiunse all'ambasceria. Affascinato dalla capitale, che esplorava in compagnia di Pierre Gilles, si concentrò soprattutto sulle piante medicinali e sugli altri semplici venduti nelle botteghe del bazar, che costituivano la principale merce di importazione dei mercanti veneziani. Per identificarle, si serviva di un glossario turco, che aveva compilato lui stesso sulla scorta del canone di Avicenna con l'aiuto di un amico turco che conosceva l'arabo. Tra i prodotti medicinali più famosi c'era la cosiddetta terra lemnia, che per le sue proprietà astringenti era utilizzata per curare le ferite e le emorragie interne. Come già abbiamo capito, Belon non era tipo da accontentarsi del sentito dire, e decise di andare a vedere di persona i luoghi di estrazione. Munito di salvacondotti e lettere di raccomandazione, si imbarcò su un brigantino alla volta di Lemno. Ancora una volta i pirati incrociarono la sua strada, e, prima di raggiungere la meta, fu costretto a rifugiarsi per due giorni nel porto di Imbros. A Lemno lo attendeva una delusione: scoprì che la famosa terra lemnia veniva estratta solo una volta l'anno, il 6 agosto, la festa della Trasfigurazione di Gesù. Si consolò esplorando a fondo l'isola, la sua flora e la sua fauna e riuscì se non altro a visitare i depositi del prezioso minerale. In compagnia di due monaci, raggiunse Thasos e da qui il Monte Athos; visitò la sacra montagna con occhio di geografo, di antropologo, di erudito e di naturalista. Non trascurò i monasteri (nelle Observations ne enumererà 24), osservò la vita quotidiana dei monaci, si informò sulle attività economiche, sugli aspetti religiosi, politici e amministrativi. Ma ovviamente il suo interesse maggiore andava alle piante, sia quelle coltivate dai monaci erboristi, sia quelle selvatiche; la montagna gli apparve un vero giardino naturale "colmo di erbe in tutti i luoghi dove abbiamo messo i piedi; e non c'è pianta insigne che non sia conosciuta con il nome antico lasciato per iscritto da Teofrasto, Dioscoride e Galeno". Per quanto riguarda gli alberi, constatò che il monte offriva un microclima particolarmente favorevole; e nelle Observations cita con entusiasmo gli allori, gli olivi selvatici, i mirti, e soprattutto i platani, la cui altezza era seconda solo a quella dei cedri che che avrebbe visto in Siria e in Anatolia. Già zoologo oltre che botanico, si occupò anche di insetti, uccelli e i pesci. Fu dunque con i quaderni pieni di osservazioni e i bagagli colmi di esemplari che ripartì alla volta di Salonicco. Nella penisola Calcidica visitò le miniere di Siderocapsa, in Macedonia diverse citt,à le rovine di Filippi e le miniere di allume di Sapes. Attraverso la Tracia, all'inizio di agosto era di ritorno a Costantinopoli, dove scoprì che Francesco I era morto e che il suo successore Enrico II aveva inviato a informarne il sultano uno dei suoi gentiluomini di camera, François de Fumel. Quando, alla fine di settembre, Fumel con un grosso seguito di gentiluomini francesi e una scorta di servitori, dragomanni (interpreti) e giannizzeri, parte per l'Egitto, Belon è ovviamente della partita. Uscendo dai Dardanelli, egli è il primo europeo a localizzare le rovine di Troia. Il viaggio quindi tocca Lesbo, Chio, dove Belon si informa sulla preparazione del mastice, Patmos, Leros e altre isole del Dodecaneso, per gettare infine l'ancora a Rodi. Da quasi trent'anni i turchi l'avevano strappata ai Cavalieri, ma era ancora un porto e un mercato molto animato che aveva molto da offrire alla curiosità di Belon. Infine si fa rotta direttamente per Alessandria d'Egitto, raggiunta in tre giorni di navigazione. Belon e i suoi compagni visitano puntigliosamente le antiche rovine, ma lo sguardo curioso del nostro viaggiatore si posa sui costumi degli abitanti, i loro vestiti, i vini e i mille prodotti alimentari che si vendono nelle botteghe, compresi certi grossi sacchi di semi di cumino nero (Nigella sativa). Non dimentica le piante, ma lo incuriosiscono soprattutto gli animali, inclusi quelli esotici venduti nei bazar: coccodrilli, ippopotami, una gazzella che forse è l'oryx dei greci, giraffe, pesci di molte specie. Il più affascinante è il camaleonte, che ama mimetizzarsi sotto i rami di Rhamnus alaternus, mutando colore dal verde al giallo al blu. Per raggiungere il Cairo, i francesi navigano lungo la costa fino a Rosetta, dove a colpire Belon sono soprattutto le coltivazioni di papiro, Musa (banani), canna da zucchero, Colocasia (un alimento importantissimo nella dieta degli egiziani), sicomori. Quindi si imbarcano su uno dei bracci del Nilo fino al Cairo, dove trascorreranno gran parte del loro soggiorno egiziano. Oltre a visitare i principali monumenti cittadini, compreso il Nilometro, il giardino di Matariyeh e l'obelisco di Heliopolis, Belon va a Giza per vedere le piramidi, la sfinge e qualche mastaba. Quindi accompagna l'ambasciatore al monte Sinai e al monastero di Santa Caterina. Alla fine di ottobre, il gruppo lascia il Cairo alla volta della Palestina. Il viaggio, via terra, dura dieci giorni. In Terra Santa visitano le località consuete dei pellegrinaggi (Gerusalemme, la Galilea, Nazareth, Betlemme e Gerico); Belon si commuove debitamente nei luoghi santi, ma anche qui è in primo luogo un naturalista e un erudito, che confronta ciò che vede con i testi degli antichi, identifica ed enumera animali rari, pietre più o meno preziose, alberi e altre piante. Da naturalista più che da devoto, a Gerusalemme studia minuziosamente le piante spinose per tentare di identificare quella con cui fu fatta la corona di Cristo. Dalla Palestina, in cinque giorni di marcia attraverso campi di sesamo e cotone, i francesi raggiungono Damasco; poi, sempre procedendo verso nord, sarà la volta delle rovine di Baalbek, delle foreste di cedri, di Aleppo, Antiochia e Adana. Raggiunta l'Anatolia, i viaggiatori toccano Konya e Aksehir e svernano a Afyonkarahisar, dove Belon mette a frutto la sosta raccogliendo informazioni sulle origini dei turchi, la vita privata e pubblica, l'amministrazione dell'Impero ottomano, i costumi religiosi e le credenze dei musulmani. Nel primavera del 1548 si riparte; Belon visita Kütahya e Bursa, e infine ritorna per la terza volta a Costantinopoli, dove l'ambasciatore d'Aramon si prepara a seguire Solimano in una spedizione militare contro la Persia. Belon lo accompagna solo per un breve tratto, fino a Nicomedia (Izmit), poi ritorna a Costantinopoli e all'inizio del 1549 si imbarca per Venezia. Intanto in Francia, con l'ascesa al trono di Enrico II, la situazione politica era cambiata e il cardinale Tournon era stato estromesso dal consiglio reale. Al momento si trovava a Roma per partecipare al conclave seguito alla morte di Paolo III. Belon lo raggiunse; fece così conoscenza con il medico personale del cardinale, Guillaume Rondelet, e poté ammirare la sua collezione di illustrazioni di pesci. Incontrò anche un altro dei padri dell'ittiologia, Ippolito Salviani, che era il medico di un altro partecipante al conclave, il cardinale Cervini che anni dopo sarebbe diventato papa come Marcello II. Certamente tra i tre scienziati ci furono confronti e scambi di materiali, anche se più tardi sarebbero stati divisi da gelosie e accuse incrociate di plagio. Nel 1550, Belon tornò a Parigi e si stabilì nuovamente a Saint-Germain-des-Prés. Anche se il cardinale, in disgrazia a Parigi, sarebbe rimasto in Italia per ben dieci anni, evidentemente gli era ancora molto legato, e lo sarebbe rimasto anche quando trovò un nuovo protettore nello stesso sovrano; ancora nel 1550, presumibilmente anche come "informatore reale", è a Londra, dove è ospite dell'ambasciatore veneziano Daniele Barbaro, che gli mostra la sua collezione di 300 illustrazioni di uccelli e lo autorizza a servirsene. Ritornato a Parigi, Belon si dedica intensamente alla scrittura. Nell'arco di pochi anni si susseguono, per citare solo le opere maggiori, due trattati sugli animali acquatici (L'histoire naturelle des estranges poissons marins, 1551 e De aquatilibus libri duo, 1553); un trattatello sulle conifere e i sempreverdi (De arboribus coniferis, resiniferis [...], 1553); un trattato in tre volumi sulle abitudini funerarie degli antichi (De admirabili operi antiquorum, 1553); il resoconto del viaggio in Oriente (Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangèrs, 1554), un trattato sugli uccelli (L'histoire de la nature des oyseaux, 1555); un trattato sull'arboricoltura e l'introduzione di specie esotiche (Les Remonstrances sur le default du labour et culture des plantes, 1556). Sebbene scriva e pubblichi tanto, Belon continua anche a viaggiare, benché solo in Europa: torna più volte in Alvernia e in Svizzera; nel 1556 si trova a Metz, appena liberata dalle truppe di Carlo V, ma a Thionville è arrestato dagli spagnoli che lo rilasciano solo dopo tre mesi; nel 1557 va Zurigo a visitare Conrad Gessner; nel 1558 viaggia in Italia; nel 1562 è a Moulins e Bourges, appena liberata, in compagnia del governatore. Secondo Benoît Léthenet, in questi viaggi che si muovono spesso in località di frontiera, le ricerche naturalistiche sono anche una perfetta copertura per la sua attività di informatore, spia o agente segreto al servizio successivamente dei re Francesco I, Enrico II e Carlo IX. Les observations sono un enorme successo; il libro conosce molte edizioni, e lo stesso avverrà per la traduzione latina Plurimarum singularium & memorabilium rerum in Graecia, Asia, Aegypto, Iudaea, Arabia, aliisque exteris provinciis ab ipso conspectarum observationes, commissionata da Plantin a Clusius e pubblicata per la prima volta nel 1589. Belon è ormai un naturalista di fama e nel 1556 Enrico II gli concede una pensione reale di duecento scudi che però non gli viene versata; Belon rilancia indirizzando al sovrano una rimostranza in cui presenta un articolato progetto di acclimatazione di piante esotiche. Nel 1559 Enrico II gli affida la cura del Bois de Boulogne e Carlo IX gli mette a disposizione un appartamento nel castello di Madrid, al margine del Bois. Ed è proprio nel mentre fa rientro a casa, nell'aprile 1565, che una sera incappa in un gruppo di banditi che lo picchiano a morte. Ma è stato anche ipotizzato che gli assassini non fossero ladri capitati lì per caso, ma nemici politici ugonotti, che volevano fargli pagare le sue posizioni recisamente filocattoliche. Al momento della morte, aveva 49 anni e stava lavorando al commento delle opere di Dioscoride e Teofrasto. 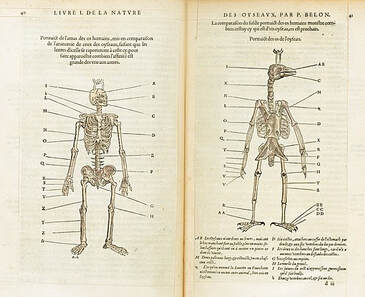 Tra zoologia e botanica Belon, oltre ad essere uno dei primissimi naturalisti viaggiatori, è anche il maggiore naturalista francese del suo tempo. Nel resoconto del viaggio in Oriente come nei trattati di vario argomento, si segnala per la profonda erudizione, la capacità di osservazione, l'attenzione minuziosa ai particolari, lo spirito critico, l'esattezza delle informazioni, le intuizioni originali. Les observations divennero un classico e riscossero il plauso sia di Clusius, che come abbiamo visto ne fu il primo traduttore, sia di Pitton de Tournefort, che un secolo e mezzo dopo Belon avrebbe ripercorso diverse tappe del suo viaggio. Anche se la sua prima passione andava alla botanica, ha lasciato i maggiori contributi come zoologo. I due trattati sui pesci (anzi, più in generale sugli animali acquatici) ne fanno uno dei padri dell'ittiologia, con Rondelet, Salviati e Aldovrandi; il primo contiene la prima accurata descrizione del delfino e il secondo è corredato da ottime illustrazioni, probabilmente fornite da Barbaro, come quelle che accompagnano quello sugli uccelli (o sui volatili, visto che include i pipistrelli). Quest'ultimo libro è celebre soprattutto per contenere due immagini affiancate, una dello scheletro di un essere umano, l'altra dello scheletro di un uccello, con tiranti e didascalie che ne mostrano le affinità. Si tratta dunque del primo tentativo di anatomia comparata. Belon ha dedicato moltissime pagine delle Observations alla flora dei paesi visitati, descrivendo per primo dozzine di piante tra cui il platano Platanus orientalis, l'acacia arabica Vachellia nilotica, il cedro del Libano Cedrus libani e forse il lillà Syringa vulgaris. Ha invece riservato alla botanica solo due piccole opere, una in latino, l'altra in francese. La prima, De arboribus coniferis, resiniferis, aliis quoque nonnullis sempiterna fronde virentibus, è un trattatello di una trentina di pagine che ha il merito storico di essere la prima opera in assoluto a trattare specificamente le conifere, nome che si deve proprio a lui, anche se fu adottato e diffuso da Gessner. Non è il solo motivo di interesse di quest'opera: come tutti i botanici del suo tempo, anche l'obiettivo principale di Belon è identificare le piante citate dagli antichi; tuttavia, anche se conosce a menadito i loro testi e non lesina le citazioni erudite, non lo fa con gli strumenti del filologo, ma con quelli del botanico, ovvero osservando le piante analiticamente e mettendole a confronto quasi con chiavi dicotomiche ante litteram; ecco quanto dice, ad esempio, a proposito di un'entità che propone di chiamare Pinaster: "Perciò ritengo a ragione che vada chiamato Pinaster; infatti Abies, il Cedrus grande [ovvero il cedro del Libano], Sapinus e Larix estendono i loro rami ai lati del tronco come le braccia di una persona, per poi discendere arcuati; invece Pinaster, Pinus e Picea li emettono storti". L'altra opera, Les Remonstrances sur le default du labour et culture des plantes, et de la cognoissance d'icelles, ha natura totalmente diversa: scritta non a caso in lingua volgare, è al tempo stesso un trattato di arboricoltura, con molte indicazioni tecniche, e un programma per rilanciare il patrimonio forestale francese depauperato da secoli di sfruttamento. Belon, sul modello soprattutto di ciò che ha visto in Italia, sogna una Francia dove nelle parti non utilizzate delle tenute vengano piantate grandi quantità di alberi, scelti per la loro utilità (sono alberi da legname, non fruttiferi), la facilità di coltivazione, ma anche la bellezza estetica. Gli alberi autoctoni, seminati in estesi vivai, vi si mescoleranno a quelli esotici di cui raccomanda l'introduzione. A tal fine, acclude anche un lungo elenco di alberi "tanto selvatici quanto addomesticati" adatti ad essere "allevati ed educati in ogni luogo". Egli stesso, come riferisce anche Gessner, fece esperimenti di acclimatazione nel suo giardino a Parigi (forse prima a Saint Germain poi al Bois de Boulogne) e gli è solitamente attribuita l'introduzione in Francia di un lungo elenco di piante esotiche che avrebbe riportato con sé dal suo viaggio in Oriente ma anche dall'Italia: l'albero di Giuda Cercis siliquastrum, la quercia da sughero Quercus suber, il leccio Quercus ilex, il pistacchio Pistacia vera, il mirto Myrtus communis, il ginepro rosso Juniperus oxycedrus e le due piante che più aveva ammirato in Oriente, il cedro del Libano Cedrus Libani e il platano Platanus orientalis. Solo di quest'ultimo, di cui tentò l'introduzione a Touvois, ci sono tracce documentate; tutti gli altri sono nominati nei suoi testi, ma non abbiamo alcuna prova che ne abbia veramente riportato con sé i semi, come nelle Remonstrances invita a fare i naturalisti viaggiatori .  Un piccolo genere alquanto singolare Del suo eventuale ruolo come arricchitore della flora francese non fa per altro menzione padre Plumier, che nel dedicargli il genere Bellonia (con due enne, sulla base del nome latino) ne ricorda invece le opere e la tragica morte: "Pierre Belon (Petrus Bellonius Cenomanus) fu medico, uomo di indefesso lavoro e studio, che possiamo in qualche modo percepire dal frutto delle sue veglie che divulgò in parte in latino in parte in francese. Infatti in latino ha lasciato un libro sulle conifere, in francese libri sugli uccelli e sui pesci, un commento a Dioscoride e un libro di agricoltura. Altro ancora progettava di scrivere, ma, mentre si accingeva a tal lodevole intento, fu interrotto dall'inattesa morte inflitta dalla mano di un empio ladrone". Nacque così il genere Bellonia, poi ufficializzato da Linneo, inizialmente con una sola specie, B. aspera, cui più tardi se ne aggiunse una seconda, B. spinosa. Il piccolo genere, endemico di Cuba e di Hispaniola, appartiene alla famiglia Gesneriaceae, nell'ambito della quale appare unico da diversi punti di vista. In primo luogo, sono veri e propri arbusti, con rami legnosi; in secondo luogo, B. spinosa è la sola specie dotata di spine dell'intera famiglia. Infine i fiori presentano le caratteristiche tipiche dei fiori impollinati per sonicazione. Mentre nella maggior parte dei fiori le antere si aprono longitudinalmente per rilasciare il polline, in una minoranza di angiosperme (8-10%), lo rilasciano parsimoniosamente come risposta a stimoli sonori. Le caratteristiche tipiche di questi fiori che si ritrovano in Bellonia, sono: posizione del fiore inclinata, petali che si allargano a formare una campana, corolla bianca, stami eretti con brevi filamenti e grandi antere gialle che formano una specie di cono e si aprono solo all'apice da un poro o una breve fessura, polline polveroso, assenza di nettare. Gli impollinatori (alcuni tipi di imenotteri e di surfidi) avvicinano il fiore dal basso; dopo l'atterraggio, lo afferrano con le zame e usando i muscoli del torace (ma senza muovere le ali) emettono un ronzio, percepibile a breve distanza, che fa vibrare le antere e stimola l'apertura dei pori apicali e il rilascio del polline. Ecco perché questo particolare tipo di impollinazione, oltre che sonicazione, è detta impollinazione a ronzio (buzz pollination). Le due specie sono piuttosto simili (tanto che per qualche tempo sono state considerate una specie sola) ma B. spinosa differisce da B. aspera non solo per la presenza di spine, ma anche per i fiori solitari, anziché raccolti in cime di 2-4, il tubo più breve e alcune caratteristiche del polline. La prima è presente sia a Cuba sia a Hispaniola, in una varietà di substrati, mentre la seconda è endemica dell'area meridionale di Haiti in terreni calcarei. Il medico alsaziano Gustav Mülhenbeck per quasi trent'anni esplorò la flora della sua regione, condivise generosamente le sue raccolte, si fece un nome come esperto di crittogame. Tuttavia non scrisse mai nulla di botanica, e la morte gli impedì di scrivere l'opera sui funghi che progettava. Il suo vero lascito è un enorme erbario, perfettamente montato e accuratamente classificato secondo gli standard dell'epoca, oggi parte dell'erbario dell'Università di Strasburgo. A ricordarlo provvede anche il variabile genere Muehlenbeckia, di cui almeno una specie (o forse due) è coltivata anche nei nostri giardini.  Un raccoglitore generoso, modesto e instancabile Con oltre mezzo milione di esemplari, l'erbario dell'Università di Strasburgo è uno dei più grandi d'oltralpe. Oltre alla collezione generale ed erbari specifici per la flora alsaziana e le crittogame, conserva separatamente anche una serie di erbari storici. Tra i più importanti l'erbario H. G. Mülhenbeck, risalente alla prima metà dell'Ottocento e qui depositato dalla Société Industrielle de Mulhouse. A crearlo fu l'alsaziano Henri Gustave Mulhenbeck (in tedesco Heinrich Gustav Mülhenbeck, 1798-1845), medico di professione e botanico e micologo per passione. Nato a Sainte-Marie-aux-Mines, una cittadina mineraria a ridosso dei Vosgi e rimasto presto orfano, Mülhenbeck studia medicina e chirurgia a Strasburgo e Parigi, dove si laurea nel 1822. La scoperta della botanica avviene negli anni universitari a Strasburgo, quando è allievo di Christian Gottfried Nestler, che gli trasmette la passione per le erborizzazioni, le crittogame e gli erbari. Da diversi anni, Nesteler affianca Jean-Baptiste Mougeot nella creazione di una grande collezione di exsiccata di crittogame (Stirpes cryptogamae vogeso-rhenanae) i cui fascicoli di cento esemplari o centuriae sono via via pubblicati anche in una versione a stampa a partire dal 1810. Il giovane allievo viene coinvolto nelle ricerche e stringe amicizia con Mougeot che sarà per lui un punto di riferimento e un modello di vita: proprio come più tardi Mülhenbeck, egli si divideva infatti tra la medicina e le scienze naturali, e per più di sessant'anni percorse instancabilmente i Vosgi alla ricerca di fossili e piante. Simile è anche la vita di Mülhenbeck, quando, fresco di laurea, si stabilisce come medico generico a Guebwiller, una cittadina ai piedi del Ballon d'Alsace all'imbocco della Valle del Florival. Nell'agosto 1823 così scrive proprio a Mougeot: "Percorrendo la valle per visitare i malati, si trova la strada meno lunga grazie alla diversità dei prodotti di Flora"; e una volta a casa, nel proprio gabinetto medico "non si può trovare società migliore dell'erbario, che è dunque il mio migliore amico e diventa di giorno in giorno più caro: si tra tranquilli con lui!". Nel tempo libero, le passeggiate si allungano per esplorare la flora delle colline calcaree dei dintorni, dove scopre diverse piante segnalate per la prima volta nella regione. Non che il giovane dottore sia un asociale. Nel 1828 viene iniziato alla loggia massonica La Parfaite armonie di Mulhouse, dove incontra un medico dalle idee progressiste, Pierre Paul Jaenger, che più tardi aderirà alle idee socialiste di Fourier. La loggia è soprattutto l'espressione della borghesia imprenditoriale della città, un importante centro tessile, i cui membri, quasi tutti protestanti calvinisti di idee liberali, negli anni napoleonici avevano avuto un ruolo di primo piano nella vita politica locale e ora, negli anni della restaurazione, promuovono iniziative economiche, educative, assistenziali. Nel 1825 viene fondata la Societé industrielle de Mulhouse (SIM); tra i 22 soci fondatori, 12 sono membri della loggia. L'obiettivo principale della SIM è "fare passere l’industria dallo stato empirico al rango di una vera scienza"; per perseguirlo, nel 1829 la società si doterà di un Comitato di scienze naturali (Comité des sciences de la Nature), che con gli anni diventerà una vera e propria società scientifica, con tre sezioni dedicate alla botanica, all'ornitologia e alla paleontologia. Mülhenbeck ne diventa il segretario e nel 1831 è tra i membri fondatori della Société médicale du Haut-Rhin. Ormai molto riconosciuto nella sua professione, nel 1833 egli si traferisce a Mulhouse, dove vive ed esercita fino alla morte. Si interessa di storia locale e nei primi anni '30 pubblica diversi articoli sulla Revue d'Alsace. Anche se la botanica non è mai dimenticata, per qualche anno passa un po' in secondo piano. Ritorna prepotentemente al centro della sua vita grazie all'amicizia con Wilhelm Philippe Schimper, che nel 1836 pubblica insieme a Philipp Bruch il primo dei sei volumi di Bryologia europea; i due lo coinvolgono nelle loro ricerche; Mülhenbeck erborizza con loro, condivide le sue raccolte e nel 1839 li accompagna in una lunga escursione attraverso le Alpi; nel 1844, sarà di nuovo con loro nei Grigioni. Con Schimper, Bruch e Mougeot, ormai anziano ma sempre attivo, scopre diverse specie di muschi precedentemente mai segnalate in Svizzera, appartenenti alla flora nordica, da considerare relitti della flora preglaciale. Esplora anche l'area di Basilea e comunica diversi ritrovamenti a Carl Meissner e Karl Friedrich Hagenbach, che lo cita ripetutamente nel secondo volume di Tentamen florae basileensis. Come Schimper, oltre che ai muschi, si interessa ai fossili e alla paleontologia, ma non scrive nulla né di questi argomenti né di botanica, accontentandosi di condividere generosamente le sue raccolte con amici e corrispondenti. Progetta invece di scrivere un libro sui funghi e inizia addirittura a farne disegnare e dipingere un gran numero; ma il progetto non si concretizzerà, perché muore prima dei cinquant'anni, nel 1847.  Un genere variabile... con qualche confusione Della sorte delle illustrazioni di funghi, che dopo la sua morte secondo Kirschleger furono acquistate dal banchiere Édouard Vaucher, non sappiamo nulla. Rimane invece come maggiore lascito proprio "l'amico erbario". Mülhenbeck non aveva mai cessato di arricchirlo fin da quando, studente universitario, partecipava alle prime escursioni con Nestler e Mougeot; alla sua morte, contava ben 20.000 esemplari, accuratamente montati e classificati secondo il sistema che andava alla maggiore ai suoi tempi, quello di de Candolle. Le sue raccolte personali erano considerevoli, molto l'ottenne con scambi con altri botanici, ma soprattutto non lesinò spese per acquistare esemplari messi in vendita da altri raccoglitori. Così quell'erbario, che nel 1857 Kirschleger, autore di Flore d'Alsace, definì "magnifico", oltre a specie della flora dell'Alsazia e della Svizzera o più un generale europea, comprende anche exsiccata di piante esotiche: tra le altre, piante raccolte in Algeria da Bové; in Medio Oriente da Boissier, Kotschy e Pinard ; nel Caucaso da Hohenacker; in varie parti dell'Asia da Helfer; in Indonesia da Kollman; in Sudafrica da Ecklon, Zehyer e Drège; in Australia da Preiss; nelle Americhe da Hartweg, Hostmann, Blanchet e von Martius. In tal modo costituisce un'importante testimonianza dell'attività di alcuni dei principali raccoglitori della prima metà dell'Ottocento. Alla morte di Mülhenbeck , l'erbario fu messo in vendita dagli eredi; con un notevole sforzo finanziario e ricorrendo a una sottoscrizione, riuscì ad aggiudicarselo per 10.000 franchi la Societé industrielle de Mulhouse; ospitato in un'intera stanza della sede dell'istituzione, il prezioso lascito riuscì a superare indenne le vicissitudini e i bombardamenti di due conflitti mondiali, finché, non avendo né le risorse finanziarie né le strutture per assicurarne l'adeguata conservazione, la società decise di depositarlo presso l'Università di Strasburgo. Nel 2007 ne è iniziata la digitalizzazione, compito non facile vista l'ingentissima mole. Come tappa preliminare, si è provveduto all'inventario delle famiglie e dei generi rappresentati, inizialmente sotto la nomenclatura usata dallo stesso Mühlenbeck. Si passerà poi all'allineamento con la nomenclatura attuale, anche allo scopo di scegliere le famiglie o i generi da digitalizzare in modo prioritario. A ricordare il medico alsaziano, oltre al gigantesco erbario, ha provveduto da tempo la dedica di alcune piante, come il muschio Bryum muehlenbeckii, e il genere Muehlenbeckia. A dedicarglielo nel 1841, dunque quando Mühlenbeck era ancora in vita, fu uno dei suoi corrispondenti, lo svizzero Carl Meissner, professore di botanica dell'Università di Basilea, che così scrive: "Ho dedicato questo genere al chiarissimo amico Gustav Mühlenbeck, dottore in medicina, medico a Mulhouse, esploratore e osservatore instancabile della flora alsaziana, specie di quella crittogamica, autore di un'opera micologica che sarà presto pubblicata". Meissner scrisse tra l'altro una monografia sulle Polygonaceae e pubblicò molte piante australiane. E infatti creò il genere a partire da due specie del continente australe, M. australis, originaria della Nuova Zelanda, e M. adpressa, originaria dell'Australia meridionale. Oggi al genere sono assegnate circa 25 specie distribuite tra la Papuasia e l'Australasia e dall'nord America subtropicale al Sud America. La sua caratteristica saliente è la variabilità: raccoglie infatti erbacee perenni, arbusti eretti più o meno legnosi, liane tanto rampicanti quanto tappezzanti. Tutte hanno radici rizomatose, ma differiscono in tutto il resto: nella forma delle foglie, dotate o meno di picciolo, sempreverdi o decidue; nelle dimensioni dei fiori, verdastri e insignificanti in alcune specie, relativamente vistosi in altre; alcune specie sono dioche, altre ginodioche, altre monoiche. Nei nostro giardini la più coltivata è M. complexa, anche se non di rado è commercializzata sotto il nome arbitrario di M. axillaris. Le due specie, in effetti, entrambe originarie della Nuova Zelanda (M. complexa è presente anche in Tasmania e nell'Australia meridionale), si assomigliano, anche se non al punto di confondersi. M. axillaris è una tappezzante bassa che forma densi tappeti anche di un metro di diametro, espandendosi sia tramite rizomi sia radicando ai nodi. In estate produce masse di minuscoli fiori bianco crema, portati in gruppi fino a tre all'ascella fogliare. M. complexa ha fusti volubili molto più sottili, che possono ricedere o arrampicarsi sulle rocce o sulla vegetazione circostante e forma molti rami che tendono a intrecciarsi strettamente. Porta foglie picciolate sempreverdi (possono però cadere negli inverni più rigidi), lucide, più o meno arrotondate, ma variabili nella forma e nelle dimensioni anche sulla stessa pianta. I piccoli fiori a stella, raccolti in spighe lunghe circa 2 cm che emergono all'ascella dei rami, sono profumati e seguiti da bacche traslucide. Ottima come ricadente da muretti, è adatta anche alla coltivazione in vaso. Forse perché limitatamente rustiche, le Muehlenbeckia da noi non hanno finora manifestato le potenzialità invasive delle sorelle Fallopia e Reynoutria. Ma non è ovunque così: in California M. complexa è diventata così problematica da essere sottoposta a programmi di eradicazione. Per un approfondimento sulle specie neozelandesi, in tutto cinque, due delle quali endemiche, nonché su qualche altra specie interessante o curiosa, si rinvia alla scheda. Nel 1787, Ramond de Carbonnères, che all'epoca è il segretario del cardinale di Rohan, capita un po' per caso nei Pirenei. Da quel momento lo scopo della sua vita sarà scoprire i segreti della formazione geologica della catena, che all'epoca costituiva un enigma; per svelarli, ne esplora per decenni la sezione centrale, con un'ossessione: riuscire a scalare quella che al tempo se ne riteneva la massima cima, il Monte Perdido o Mont Perdu. Vero padre della scoperta scientifica dei Pirenei, Ramond era anche un appassionato botanico e uno specialista della flora di alta montagna. La dedica del bel genere Ramonda, che annovera un endemismo dei Pirenei e due specie balcaniche, è assolutamente perfetta. 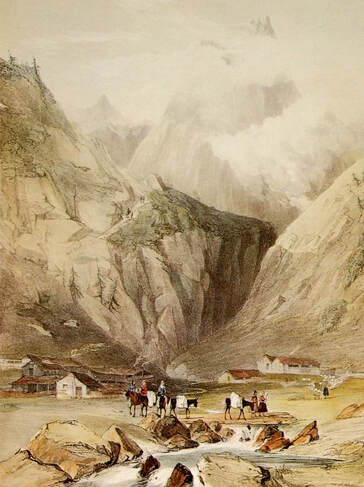 Da poeta a scienziato: un percorso di vita Nella primavera del 1787, quando per la prima volta arriva nei Pirenei, Louis Ramond (1755–1827) non sa ancora che quelle montagne diventeranno la sua passione, anzi la sua ossessione. Ha poco più di trent'anni, ma è come se avesse già vissuto almeno due vite. Nato a Strasburgo, una città-frontiera, è diviso tra due culture anche nell'identità personale, figlio com'è di un padre francese della Linguadoca e di una madre alsaziana di origine tedesca. Dunque, nulla di strano che sia tra i primi a scoprire il preromanticismo tedesco dello Sturm und Drang. Ha appena diciannove anni quando esce I dolori del giovane Werther di Goethe; la lettura di quel romanzo generazionale è una tale folgorazione che decide di diventare a sua volta scrittore e nel 1777 (ora ha ventidue anni) pubblica a sua volta Les Dernières aventures du jeune d'Olban, che, come il suo modello goethiano, si conclude con un colpo di pistola. Come Werther, anche Louis (che quell'anno si è anche laureato in legge) ha vissuto un amore impossibile, ma lascia che a suicidarsi per lui sia il suo eroe, e per consolarsi parte per la Svizzera; è alla ricerca di paesaggi che nutrano la sua ispirazione poetica e, come scrive in una lettera al padre, si mette in viaggio per "osservare e non per arrivare"; ci sono incontri con personalità importanti, come il patriarca dei naturalisti Albrecht von Haller, il biologo Charles Bonnet e il fondatore della fisiognomica Lavater, ma c'è soprattutto la scoperta delle alte montagne: scala diverse cime del Bernese, poi si sposta al San Gottardo e va all'esplorazione delle Alpi ticinesi. Poi, per tre anni, è soprattutto uno scrittore. Pubblica una raccolta di poesie, poi si trasferisce nella capitale dove dà alle stampe un dramma romantico e la traduzione di Sketches of Swisserland di William Coxe (Lettres de M. William Coxe à M. W. Melmoth sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse), che infarcisce di note e osservazioni tratte dal suo viaggio svizzero al punto da irritare l'autore. Il successo letterario a cui aspira non arriva: ci vorranno anni perché il gusto romantico conquisti Parigi; per i milieu letterari, Ramond è uno scrittore appena mediocre, più tedesco che francese. Ma la contestata traduzione ha un merito: attira l'attenzione del vescovo di Strasburgo, il cardinale di Rohan, che nel 1781 lo assume come segretario; per sette anni ne sarà il più ascoltato consigliere e gli sarà fedelissimo; sbriga i suoi affari, organizza le sue feste, lo accompagna in tutti i viaggi, viaggia per suo conto quando il cardinale preferisce rimanere nella prediletta residenza di campagna di Saverne, ai piedi dei Vosgi. Alla colorita corte del cardinale, conosce Cagliostro, che lo inizia alla massoneria e ne fa il suo discepolo nelle sedute di magia e ipnosi. Per adeguarsi al nuovo ambiente, cambia anche nome: ora si fa chiamare Louis Ramond de Carbonnières, pretendendo che si tratti di un vecchio nome che da tre secoli distingue un ramo della sua famiglia . Quando il cardinale viene arrestato in seguito all'affare della collana, Ramond- uno dei pochi del suo entourage rimasto a piede libero - si incarica di far sparire le lettere compromettenti; poi va in Inghilterra a cercare le prove che la collana è stata venduta dai truffatori e il cardinale è stato ingannato; anche grazie ad esse, Rohan viene assolto, ma il re lo manda in esilio all'abbazia di Chaise-Dieu in Alvernia. Ramond è con lui e approfitta di quella che per il suo padrone è una orribile seccatura per immergersi nella natura e dedicarsi alle passeggiate botaniche. Quando arriva l'inverno, il cardinale e il suo seguito sono autorizzati a trasferirsi a Marmoutier, in Touraine. Poi, gli viene permesso di viaggiare per "passare le acque"; così nella primavera del 1787, sua Eminenza lo manda in avanscoperta nei Pirenei. La scelta cade su Barèges, un villaggio a circa 1200 metri d'altitudine, annidato nelle montagne, lungo la strada che conduce al Col Tourmalet, ai piedi del Pic du Midi; all'epoca reputata per le sue acque solforose, è la stazione termale più elevata dei Pirenei. La comitiva del cardinale vi arriva alla fine di luglio, e già il 2 agosto Ramond scala per la prima volta il Pic de Midi: ai suoi occhi si mostra una gran parte dei Pirenei centrali, fino alla vetta culminante, il Monte Perdido/ Mont Perdu. Diverse escursioni seguiranno nei giorni successivi; la maggiore, dal 16 al 24 agosto, lo porta a percorrere ben 250 km e un dislivello di 13 km, da Barèges al ghiacciaio della Maladeta e ritorno. Non sono solo la passione alpinistica e il gusto romantico a spingerlo a percorrere il massiccio, solo o accompagnato da pastori locali; in gioco c'è anche una disputa scientifica. L'idea dominante all'epoca, confermata dall'ascensione al Monte Bianco di Saussure, era che le montagne più alte ed antiche fossero granitiche, mentre quelle più recenti e basse calcaree; secondo Dolomieu (un uomo che destava i sistemi) la catena centrale dei Pirenei faceva eccezione, essendo calcarea. Per verificare se abbia ragione, Ramond si propone di raggiungere il centro della catena, ovvero quel Mont Perdu che ha visto come un miraggio fin dalla sua prima ascensione. Ma come arrivarci nessuno lo sa. Così, quando, venuto l'autunno, tocca ripartire, egli si rassegna a rimandare il problema alla prossima occasione, Nel dicembre 1788, lascia il servizio del cardinale e si trasferisce a Parigi, deciso a fare della scienza la sua nuova professione. Pubblica Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de suite à des observations sur les Alpes e segue le lezioni di Antoine Laurent de Jussieu e René Desfontaines al Jardin des Plantes. Ma a imporre una momentanea battuta d'arresto è la politica: nel settembre 1791 è eletto deputato all'Assemblea legislativa; esponente di spicco dei Foglianti, è strettamente legato a La Fayette e avverso ai giacobini. Nell'estate del 1792, mentre la situazione politica precipita, Ramond si allontana prudentemente dalla capitale e torna a Barèges. L'8 agosto è di nuovo sul Pic du Midi. Durante la Convenzione, rimane nei Pirenei, fissando la sua residenza prima a Barèges poi a Gèdre; continua ad esplorare la catena, anche se le tensioni tra Francia e Spagna ostacolano i suoi movimenti. Finché nel gennaio 1794 viene arrestato come "elemento controrivoluzionario" e condotto nel carcere di Tarbes; rimarrà agli arresti per più di sette mesi, fino a novembre, rischiando anche la condanna capitale. Se ne salva grazie ad alcuni amici, tra cui l'illustre botanico Desfontaines.  La difficile conquista del Mont Perdu Ora per Ramond de Carbonnières inizia una nuova vita, l'ennesima. Lasciatosi alle spalle l'ambizione politica, vuole essere solo scienziato. Così scrive a Philippe Picot de Lapeyrouse, colui che considera il suo maestro e la sua guida per la storia naturale dei Pirenei: "Non sono posseduto da alcuna ambizione [...]. Sono amico della natura e nient'altro. Non posso essere utile ai miei concittadini che sotto questa forma". Si stabilisce a Bagnères-de-Bigorre, ma Barèges, dove ora abita sua sorella che ha sposato il capo chirurgo del locale ospedale, continua ad essere il punto di partenza delle sue escursioni; arricchisce l'erbario, raccoglie campioni di rocce e fossili, disegna schizzi (è infatti anche un ottimo disegnatore), corrisponde con altri studiosi, tra cui Dominique Villars, grande esperto di flora alpina. Nel 1795, alla creazione della scuola centrale degli Alti-Pirenei a Tarbes, viene nominato professore di storia naturale, e si dedica al nuovo compito con grande serietà. Le sue lezioni entusiasmanti lo rendono presto popolare tra gli studenti, ai quali vuole trasmettere “non la scienza, ma il desiderio e il modo di apprendere”. Momento chiave di questo insegnamento sono le erborizzazioni e le escursioni in natura, anche di più giorni e anche in montagna. Non ha rinunciato al progetto di scalare il Mont Perdu; è convinto che l'unica via per raggiungere quella montagna proibita ("mai, da quando si dà un nome alle montagne, ce n'è stata una con un nome così appropriato") sia la valle d'Estaubé. Nell'estate del 1797 è pronto ad affrontare la sfida con due guide fidate e pochi allievi già esperti alpinisti, quando vede arrivare Picot de Lapeyrouse, che è venuto a Barèges a curarsi i reumatismi. Tra lui e Ramond c'è una disputa: entrambi concordano sulla natura calcarea della catena centrale dei Pirenei, ma mentre il primo pensa che non presenti tracce di fossili e dunque sia di orogenesi primitiva, il secondo ne dubita, convinto che l'ipotesi vada per lo meno verificata sul campo, e che la risposta la darà il Mont Perdu. Così l'11 agosto quello che parte da Barèges è un folto gruppo: Picot de Lapeyrouse, suo figlio Isidore, due allievi e il giardiniere della scuola centrale di Tolosa, due pastori che hanno già accompagnato Ramond in molte gite, Ramond stesso e quattro allievi della scuola centrale di Tarbes; uno di loro è Charles-François Brisseau de Mirbel, futuro padre della citologia vegetale. Da Gèdre il gruppo sale a Coumélie lungo un sentiero tortuoso; Ramond nota qui e là un fiore simile al colchico che annuncia già l'autunno. Lo ritiene un genere nuovo e lo battezza Merendera (oggi l'unico genere da lui creato non è accettato, ed è sinonimo di Colchicum); passano la notte in una grangia e Ramond ingaggia altre tre guide, due pastori di Coumélie e un cacciatore, che aveva fama di conoscere il Mont Perdu ("il fatto è che non ne sapeva niente più di noi"). All'alba del giorno successivo, procedendo lungo i pascoli, si dirigono verso la valle di Estaubé. In quel paesaggio imponente e severo, fioriscono in abbondanza i lunghi pennacchi di Saxifraga longifolia, di cui Lapeyrouse è stato il primo scopritore. Mano a mano che avanzano nella valle, il Mont Perdu sembra giocare a rimpiattino, sempre più nascosto da imponenti bastioni di roccia, fino a scomparire del tutto. Non si scoraggiano e continuano a salire, fino a giungere ai piedi del ghiacciaio mediano di Tuquerouye, dove incontrano un contrabbandiere che, finalmente, sembra saperne qualcosa, e consiglia loro di tornare indietro, ridiscendere e risalire da un'altra via; sono ore di marcia perdute, e Ramond propone ai suoi compagni una strada più diretta e audace: salire fino al ghiacciaio e attraversarlo. Il contrabbandiere approva, e presto si dilegua. Eccoli dunque risalire lungo la morena del ghiacciaio, fino a toccare la neve. La traversata è impegnativa, Lapeyrouse è sempre più in difficoltà, finché Ramond lo convince a fermarsi; lo lascia ad attenderli in compagnia della più fidata delle sue guide, mentre gli altri proseguono. Dopo un'ora di difficile marcia, ritrovano il contrabbandiere, caduto in un precipizio. Lo recuperano e lo uniscono a loro, anche se la disavventura nella quale ha perso, insieme alla piccozza, gran parte della sua sicurezza, semina la sconforto. Finché, superato il punto di massima inclinazione del ghiacciaio, la pendenza si addolcisce visibilmente e riprendono fiducia e slancio. Un grido di gioia annuncia il cambiamento di scena: la montagna, cinta da nubi, avvolta di ghiacci, separata da loro da abissi, si è degnata di mostrarsi, come "un Dio la cui presenza è sentita più che vista e che si manifesta in tutto ciò che lo circonda prima di rivelarsi". La cima è davanti a loro, ma è anche chiaramente irraggiungibile. Ramond e i suoi compagni decidono di esplorare il lago ghiacciato che si occupa una valletta ai piedi della montagna. Lo attraversano e sondano le rocce che lo circondano; dappertutto, trovano "vestigia di abitanti del mare. Sostanzialmente ostriche e una moltitudine di madrepore costituiscono la parte più appariscente di questi venerabili resti". Ormai è mezzogiorno, ed è tempo di ritornare. Pensare di trascorrere lì la notte, al freddo e senza viveri, per tentare la scalata il giorno dopo, sarebbe follia. Ramond, preoccupato per i suoi compagni, provati dalla salita, decide di scendere per la strada inizialmente indicata dal contrabbandiere, che nel frattempo si è ecclissato di nuovo. E' poco meno difficile e pericolosa. Ore dopo, più in basso, al Port de Pinède, ritrovano Lapeyrouse, che Ramond ha fatto avvertire del cambio di programma da una delle guide; gli mostra le sue scoperte che provano l'indubbia natura secondaria dell'asse dei Pirenei. Il vecchio scienziato è amareggiato e deluso e, anche se non cesseranno di corrispondere, continuerà a nutrire rancore verso il più giovane collega, cercando di sminuirne le scoperte. L'8 settembre, ancora con i suoi allievi e le due guide più fidate, Ramond ritorna al lago glaciale per tentare la scalata alla cima; devono di nuovo rinunciare, ma raccolgono altri fossili. Negli anni successivi, è impegnato in molte ascensioni lungo il massiccio, talvolta da solo, talvolta con Mirbel e altri allievi, o amici come Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans, professore di storia naturale alla scuola centrale di Agen. Nel 1801, racconta le sue ascensioni ed espone la sua teoria generale sulla formazione dei Pirenei in Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées, un libro di grande precisione scientifica ma anche di lettura appassionante, in cui dietro lo scienziato si avverte la mano del poeta romantico. Il Mont Perdu è ancora inviolato. Lo rimane fino al 6 agosto 1802, quando le due fidate guide di Barèges, Rondo e Laurens, inviati in avanscoperta da Ramond, riescono a raggiungere la cima. Tre giorni più tardi vi guidano Ramond, che poi racconterà l'impresa in Voyage au sommet du Mont-Perdu in uno stile che Henri Beraldi ha definito "molto veni, vidi, vici". Lo stesso anno la sua fama di scienziato è consacrata dall'ammissione all'Institut de France (la vecchia Accademia delle scienze) nella classe di scienze fisiche e matematiche.  Piante d'alta quota Dopo il colpo di stato di Napoleone, Ramond, molto stimato dal primo console, ha anche ripreso a fare politica. Dal 1800 al 1806 è deputato del corpo legislativo. Nei cinque mesi in cui avvengono le sedute, vive a Parigi; il resto dell'anno è ospite della sorella e del cognato a Barèges. Alle ricerche geologiche e botaniche, si sono aggiunti anche i rilievi barometrici, cui è stato iniziato dall'amico Bon-Joseph Dacier, conservatore della biblioteca imperiale. Nel 1806 Bonaparte lo nomina prefetto del Puy-de-Dome. Come funzionario, è serio ed efficiente come lo è stato come professore. Ma è ancora soprattutto uno scienziato, che fa rilievi barometrici dal balcone della prefettura, esplora i monti Dores, i monts Dômes e il massiccio del Sancy. Frutto di queste ricerche è Nivellement des Monts Dores et des Monts Dômes disposé par ordre de terrains (1815). Nel 1809 l'imperatore premia la sua fedeltà facendolo barone dell'Impero. Nel 1810, torna ancora una volta nei Pirenei e il 28 settembre scala per la 33 e ultima volta il Pic du Mid. La morte della sorella nel 1812, poi del cognato nel 1815, chiude definitivamente il capitolo Pirenei. Nel 1813 lascia la funzione di prefetto, e si stabilisce definitivamente a Parigi, con la giovane moglie, figlia dell'amico Dacier. Anche se durante i Cento giorni è nuovamente deputato, questo volta per il dipartimento di Puy-de-Dome, la Restaurazione lo lascia indenne, tanto che nel 1818 è nominato al Consiglio di Stato. Nell'estate nel 1821, torna in Alvernia e inizia alla geologia e alla botanica del massiccio centrale due giovani naturalisti parigini, Victor Jacquemont e Hippolte Jaubert. Ma è ancora dedicata ai Pirenei l'ultima memoria, Sur l’état de la végétation au sommet du Pic du Midi (1825). Muore a Parigi nel 1827. Anche se i suoi contributi più decisivi sono nel campo della geologia, Ramond è stato un appassionato botanico, fin dai tempi in cui ancora al servizio del cardinale di Rohan erborizzava a Saverne. Le narrazioni delle sue escursioni sono costellate di puntuali riferimenti alla flora; persino nei momenti più difficili, quando ciascuno di noi baderebbe più che altro a dove mette i piedi, non manca di osservare ed elencare le piante che si offrono al suo sguardo attento e innamorato. Il suo contributo principale alla botanica è ovviamente nello studio della flora di alta quota, là dove pochi erano andati ad erborizzare prima di lui. Gli si deve la scoperta di nove specie, sette delle quali endemiche dei Pirenei: Arenaria purpurascens, Asperula hirta (oggi Hexaphylla hirta), Festuca eskia, Leucanthemum maximum, Medicago suffruticosa, Scorzonera aristata, Pinguicola longifolia, scoperta durante una delle sue ascensioni al Mont Perdu. Le altre due sono Potentilla micrantha e Viola pirenaica, presenti rispettivamente nell'Europa centrale e meridionale e nelle montagne europee. Ad eccezione di Asperula hirta, pubblicata dallo stesso Ramond, furono tutte pubblicate da de Candolle, a cui egli aveva affidato le sue osservazioni e i fogli d'erbario. Ramond considerava il suo erbario l'oggetto più prezioso, il custode della memoria della sua vita: "Ora sono vecchio e mi riposo [...]. Diminuisco la mia biblioteca, e conservo solo ciò che è necessario per me e mio figlio, soprattutto il mio erbario, perché è la storia di mezzo secolo della mia vita. Adesso vivo con il mio erbario e i ricordi che lo accompagnano; al di fuori di questo, tutto mi è superfluo". Conservato in 68 sacchi di tela e donato dagli eredi alla Societé Ramond (creata nel 1866 per promuovere la scoperta naturalistica, storica, etnologica e sportiva dei Pirenei), dal 2003 è stato affidato al Conservatoire botanique nationale des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, che ne ha curato la pubblicazione on line a questo indirizzo.  Gioielli vegetali dai Pirenei e dai Balcani A celebrare il padre degli studi pirenaici non poteva che essere una pianta di quelle montagne. Nel 1805 Louis Claude Richard, nell'assegnare a un nuovo genere una pianta che Linneo aveva descritto come Verbascum myconi, la rinominò Ramonda pyrenaica, "così chiamata in memoria del celebre Ramond per i suoi meriti nell'osservazione delle piante pirenaiche". Qualche anno dopo Lapeyrouse nel suo Histoire Abrégée des Plantes des Pyrénées, forse memore dello sgarbo di Ramond, la ribattezzò Myconia borraginea. Troppo tardi. Il nome valido è quello di Richard, anche se ovviamente la specie ha recuperato il più antico eponimo linneano e oggi si chiama Ramonda myconi. E' una delle tre (o quattro) specie di questo genere della famiglia Gesneriaceae, diffusa soprattutto ai tropici, di cui, insieme a Haberlea e eventualmente Jancaea, è l'unico rappresentante europeo. Vestigio dell'epoca terziaria, quando il nostro continente godeva di un clima subtropicale, più caldo e umido, queste piante all'arrivo delle glaciazioni si sono rifugiate in enclave montane. R. myconi è stata a lungo l'unica specie conosciuta; è ristretta ai Prepirenei, ai Pirenei e alla catena costiera catalana, dove vive nelle gole calcaree e nelle valli umide di montagna. La sua scoperta risale addirittura al Cinquecento, quando venne raccolta nella montagna di Montserrat dal farmacista e botanico catalano Francisco Micó, che la comunicò a Jacques Dalechamps che a sua volta la pubblicò in Historia generalis plantarum sotto il nome Auricula ursi myconi. E' una piccola è graziosissima semoreverde rupicola, con foglie a rosetta e fiori viola che ricordano da vicino quelli della Saintpaulia. Verso la fine dell'Ottocento si aggiunsero altre due specie, scoperte in Serbia da Joseph Pančić, R. serbica e R. nathaliae. Entrambe vivono in habitat calcarei, ma hanno distribuzione diversa. R. serbica, scoperta da Pančić nel 1874 sul monte Rtanj, appartiene al bacino idrografico adriatico ed ha areale più ampio (Serbia, Albania; Montenegro, Macedonia, Grecia settentrionale, tra 200 e 1950 metri sul livello del mare); R. nathaliae, scoperta nel 1884 nella gola di Jelašnica presso Niš dallo stesso Pančić e dal medico di corte Sava Petrović, che la dedicarono alla regina di Serbia Natalija Obrenović, è ristretta alla Macedonia e ad aree adiacenti di Grecia, Serbia e Kosovo ed appartiene al bacino idrografico egeo. Le due specie sono molto simili, ma R. serbica ha foglie più romboidali con margini vistiosamente dentati o incisi, fiori più piccoli e meno numerosi portati su lunghi scapi, R. nathaliae foglie più arrotondate, fiori più grandi e scapi più brevi. Nel 1928 il botanico russo Pavel Černjavskij stava riordinando il suo erbario quando casualmente vi rovesciò sopra un bicchiere d'acqua; per rimediare al disastro, lasciò asciugare le carte e le piante per tutta la notte; al mattino dopo, scoprì che un esemplare di R. nataliae, che faceva parte della sua collezione da un anno e mezzo ed era totalmente disseccato, si era reidratato ed appariva vivo e vegeto. Pubblicò subito la scoperta sulla rivista della società botanica russa, con una conseguenza politica; da allora R. nataliae è stata scelta come simbolo della "resurrezione" della Serbia e del suo esercito dopo la Prima guerra mondiale. La rara particolarità di potersi disseccare completamente e di riprendersi alla prima pioggia, diffusa tra licheni, epatiche e muschi, ma rarissima tra le Angiosperme, è condivisa da tutte le specie del genere, anzi da tutte le Gesneriaceae europee; hanno sviluppato questa capacità per poter sopravvivere, nonostante la loro origine tropicale, in aree montane con estati secche e temperature invernali che scendono di molto sotto zero. Nel 1851, Theodor von Heldreich, all'epoca direttore dell'orto botanico di Atene, scoprì sulle pendici del monte Olimpo un'altra gesneriacea, di cui però non vide i fiori. Inizialmente Boissier la classificò come Haberlea heldreichii, poi, dopo la raccolta di esemplari fioriti, la trasferì a un genere proprio, Jancaea, in onore di Viktor Janka, curatore dell'erbario di Budapest ed esploratore della flora dei Balcani. Non tutti erano d'accordo: Alphonse e Casimir de Candolle la collocarono nel genere Ramonda, come R. heldreichii. Recentemente, l'appartenenza a Ramonda è stata supportata da dati molecolari; Plant of the World on line ne prende atto, riducendo Jancaea a sinonimo. Ma poiché la maggioranza dei repertori, inclusi il sito della Gesneriad Society e Flora of Greece on line, lo trattano ancora come genere a sé, così farò anch'io, soprattutto per poter dedicare un post a Janka. Quando il suo professore gli propose una tesi sul genere Solanum, Michel Félix Dunal probabilmente non immaginava che la famiglia delle patate e dei pomodori avrebbe segnato la sua carriera scientifica. Invece è proprio per i suoi contributi allo studio delle Solanaceae, culminato con la loro trattazione nel Prodromus di de Candolle (era lui il suo maestro), che egli è ancora noto nella storia della botanica. A celebrarlo non poteva che essere un genere di quella famiglia, Dunalia. 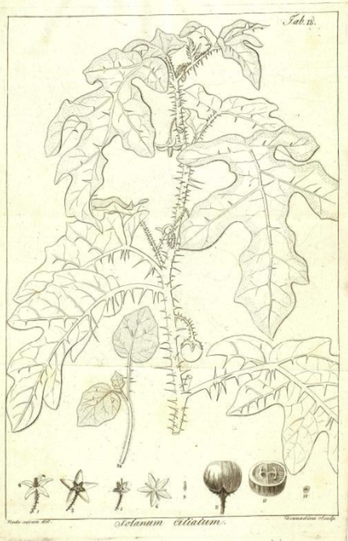 Dalle Solanacee alle Solanacee Nel sostenere l'utilità anche pratica del suo sistema naturale, Antoine-Laurent de Jussieu aveva osservato che piante che si assomigliano devono condividere anche le proprietà medicinali; a partire da questa osservazione, Augustin Pyrame de Candolle, che nel 1807 era stato nominato professore di botanica e direttore dell'Orto botanico di Montpellier, suggerì alla facoltà di medicina di assegnare come tesi monografie su gruppi di piante. A fare da apripista fu il suo allievo più promettente, Michel Félix Dunal (1789-1856), con la tesi Histoire naturelle, médicale et économique des Solanum, et des genres qui ont été confondues avec eux, discussa e pubblicata nel 1813. Così, nel doppio segno di Solanum e di de Candolle, iniziò la carriera scientifica di Dunal; e così sarebbe terminata, con la trattazione della famiglia Solanaceae del Prodromus di de Candolle nel 1852. Michel Félix Dunal apparteneva a una ricca famiglia della borghesia calvinista di Montpellier. Il padre era un banchiere e lo costrinse ancora adolescente a lasciare gli studi per lavorare con lui in banca; il ragazzo obbedì, ma sognava altro: di carattere ardente e romantico, si era innamorato della botanica leggendo le Lettres sur la botanique di Rousseau. Alla fine riuscì a convincere il padre a permettergli almeno di seguire come uditore qualche lezione di botanica e anatomia. Le gite nelle Cevenne con il suo primo maestro Guillaume-Joséph Roubieu gli confermarono che quella era la sua strada. L'arrivo a Montpellier di de Candolle segnò la svolta definitiva; finalmente libero di seguire la sua vocazione, Dunal si iscrisse a medicina e divenne l'allievo preferito del professore ginevrino. Nel 1811, fu uno dei suoi compagni in una lunga escursione che toccò le Cevenne, il Vivarais, il Velais, l'Alvernia, il Périgord, il Médoc, il Bourbonnais e la Sologne. Quindi accompagnò il maestro a Parigi, dove, grazie a lui poté frequentare i circoli scientifici e stringere amicizie, soprattutto con Augustin de St. Hilaire e Carl Sigismund Kunth. Tornò quindi a Montpellier per preparare la tesi da cui ho preso le mosse, per la quale poté avvalersi, oltre che delle piante vive dell'orto botanico, dei disegni della spedizione di Sessé e Mociño, fortunosamente approdati nella città occitana come ho raccontato in questo post, il che gli permise di pubblicare numerose specie ancora ignote in Europa. La monografia si divide in due parti: la prima è dedicata alla storia e agli usi economici e medici del genere, con approfondimenti per la patata (trattata a proposito delle radici), la dulcamara e le morelle (trattate a proposito di fusti e foglie), la melanzana (trattata a proposito dei frutti); la seconda contiene la descrizione botanica di 2 specie del genere Witheringia, 6 del genere Lycopersicon, 199 del genere Solanum (che salgono a 235 aggiungendo le specie "non sufficientemente note"). A conclusione una breve lista di specie erroneamente assegnate al genere Solanum, tra cui Atropa belladonna. Numerose le specie descritte per la prima volta; ma soprattutto, Dunal tenta una classificazione del genere, dividendolo nei due gruppi Inermia (senza spine) e Aculeata (spinose) e in 12 "serie naturali" sulla base di caratteristiche morfologiche quali le foglie, le infiorescenze, il calice; alcuni dei gruppi individuati corrispondono a sezioni attualmente accettate. Ne risulta una voluminosa opera di oltre 300 pagine, che egli poté permettersi di far stampare in una curata veste tipografica e di corredare di 26 tavole disegnate da François Toussaint Node-Véran, l'artista dell'orto botanico di Montpellier. Conseguita la laurea, Dunal tornò a Parigi, dove si trattenne per circa un anno, finché nel 1814 l'invasione della Francia lo costrinse a tornare a Montpellier, dove come medico fu impegnato a contrastare l'epidemia di tifo. Contrasse la malattia, e dedicò la lunga convalescenza a una monografia sulle Annonaceae; anche in questo caso si tratta della prima trattazione sistematica di questa famiglia, cui Dunal assegnò nove generi, incluso Monodora, da lui istituito e tuttora riconosciuto; pubblicata nel 1817, anch'essa illustrata da Node-Véran, contribuì a consolidare la reputazione del giovane botanico. L'anno prima aveva dato alle stampe un'edizione rivista della tesi, Solanorum generumque affinium synopsis, in cui le specie di Solanum salgono a 320, ma senza grandi novità sistematiche. Intanto la politica aveva provocato un terremoto anche nella vita universitaria di Montpellier. De Candolle, considerato troppo allineato al regime napoleonico e inviso agli ambienti cattolici, nel 1816 diede le dimissioni e tornò a Ginevra, dove l'Accademia creò immediatamente una cattedra per lui. Delle due cattedre di botanica che teneva a Montpellier, quella della facoltà di scienze fu soppressa, mentre quella della facoltà di medicina rimase vacante fino al 1819. La facoltà di medicina nominò Dunal direttore ad interim della Scuola di botanica e dell'orto botanico. Certo egli si aspettava che gli fosse assegnata la cattedra, invece fu nominato Alire Raffeneau Delile (per ironia, ben più legato a Napoleone ben più di de Candolle e tanto più di Dunal, visto che era stato il botanico della spedizione in Egitto). Dunal, che in quel momento si trovava in Inghilterra a consultare erbari, accettò il fatto compiuto con grande signorilità. Contemporaneamente, la sua famiglia conobbe un rovescio di fortuna. Dunal si ritirò in campagna, affiancando al lavoro come medico la gestione di due aziende agricole; in questa veste inventò uno strumento che chiamò eno-alcolometro, utile per misurare la gradazione alcoolica del vino. Non aveva per altro lasciato la botanica: de Candolle gli affidò la trattazione delle Cistineae (oggi Cistaceae) nel primo volume del Prodromus (1824). Questa parentesi durò fino al 1829, quando la facoltà di scienze decise di ristabilire la cattedra di botanica e di assegnarla a Dunal. Per poterla assumere, egli provvide a laurearsi in scienze naturali, discutendo la tesi Considérations sur la nature et les rapports de quelques-uns des organes de la fleur, che si basa sulla teoria della metamorfosi degli organi vegetali e incontrò seguito limitato (come dimostra il fatto che il termine "lepali" che egli coniò per le appendici del ricettacolo non è entrato nella terminologia botanica). Dunal fu un professore molto amato dai suoi studenti, il più famoso dei quali è Jules Émile Planchon. Dal 1830, ai doveri didattici,ù si aggiunse l'incarico di decano della Facoltà, con tutta una serie di compiti amministrativi. Tra i suoi successi, l'acquisizione all'università di una serie di erbari, incluso quello del botanico dilettante e collezionista Bouché-Doumenq, prezioso perché contiene gli erbari di Magnol e Broussonet. Insieme a un altro botanico, Frédéric de Girard (1810-1850), progettò una Flora di Montpellier che però si arenò presto. L'ultimo lavoro che lo attendeva era un ritorno alle origini: Alphonse de Candolle gli affidò la trattazione delle Solanaceae per il Prodromus, di cui forma quasi interamente il 13° volume (1852), per un totale di poco meno di 700 pagine. A sentire Planchon, questo enorme lavoro ha pesato su di lui "come un fardello di cui solo il suo rispetto per de Candolle poteva alleggerire il peso". Con la salute ormai da tempo deteriorata, lontano dalle grandi biblioteche e dai grandi erbari, certo non fu facile per Dunal portare a termine il compito "ingrato", "spaventevole" (a definirlo così è ancora Planchon), se consideriamo che per il solo genere Solanum trattò oltre 850 specie (oggi sono oltre 1200). Ne risultò comunque una trattazione che rimase un punto di riferimento per oltre un secolo, se pensiamo che nessuno tentò più una sistematizzazione complessiva della famiglia prima di Solanaceae Biology and Systematics di William D'Arcy (1986). Oltre ad ampliare enormemente le specie trattate e a estendere il lavoro a tutti i generi della famiglia, Dunal approfondisce il tentativo di suddividere in sezioni il genere Solanum. I giudizi sui risultati sono quanto meno vari. Planchon sorvola, definendo la monografia "opera del declino"; altri, compreso lo stesso D'Arcy, ne riconoscono il ruolo pionieristico per essere stato il primo a presentare divisioni e suddivisioni come categorie gerarchiche formali; piuttosto duro il giustizio di C. V. Morton che in Taxonomic studies of tropical american plants scrive senza troppi peli sulla lingua: "Dunal era un lavoratore attento e le sue descrizioni sono un modello di accuratezza. Tuttavia il suo modo di concepire le relazioni non è affidabile, tanto che spesso nella sua trattazione specie correlate sono ampiamente separate. In effetti, la stessa specie è talvolta descritta sotto nomi diversi in sezioni differenti, La monografia è di difficile uso perché manca una chiave e le descrizioni non sono contrastive e non fanno emergere chiaramente i caratteri differenziali. Chiunque tenti di identificare un esemplare sconosciuto di Solanum per mezzo della monografia di Dunal si sente come se fosse perso in un labirinto di parole". Forse, come sostiene Planchon, l'immane lavoro logorò davvero Dunal, che un anno dopo averla terminata fu costretto a rinunciare alle lezioni e cedette appunto a lui la direzione del dipartimento di botanica. Come ricorda nel commosso elogio funebre lo stesso Planchon, cercò con le poche forze che gli rimanevano di seguire quanto possibile la vita della facoltà e mai rinunciò a partecipare alle escursioni botaniche, nonostante le difficoltà crescenti. Morì il 29 luglio 1856, due giorni dopo aver presieduto a una sessione d'esami.  Una Solanacea andina Non poteva che appartenere alla famiglia Solanaceae il genere che lo celebra; a dedicarglielo fu Kunth, con un tributo insieme all'amico e al botanico: "L'ho denominato in onore di Michel Félix Dunal, dottore in medicina di Montpellier, per la soavità dei costumi a tutti caro e a me amicissimo, e per i lucidissimi scritti sui Solanum e le Annonaceae finora non trattati da nessun botanico". La fama di cui godette in quegli anni il giovane botanico occitano è dimostrata da altre due Dunalia, ovviamente non valide che gli furono tributate quasi contemporaneamente da Robert Brown e Curt Sprengel, cui dopo la morte si aggiunse un quarto genere omonimo, omaggio di Montrouzier. Gli è stata dedicata anche l'alga Dunaniella, che egli scoprì per primo negli stagni nei pressi della sua città. Dunalia Kunth è un piccolo genere di cinque specie di arbusti o piccoli alberi che vivono in ambienti aridi d'altura nel Sud America centro orientale, con centro di diversità in Perù e qualche specie che si spinge in Argentina e in Cile; è affine al più noto genere Iochroma, il maggiore della sotto tribù Iochrominae. Come adattamento all'aridità, in genere sono piante spinose con foglie più o meno coriacee per lo più riunite in verticilli; i fiori tubolari sono viola, molto stretti (presumibilmente sono impollinati da colibrì), mentre i frutti sono bacche carnose rosso aranciato. Purtroppo non sono disponibili studi recenti e in rete si trovano poche informazioni sulle singole specie, ad eccezione di D. spinosa, un arbusto estremamente spinoso e intricato che vive in biomi desertici dal Perù al Cile e all'Argentina settentrionale tra 500 e 2000 metri. I fiori, viola scurissimo quasi bruno, hanno corolla stretta con dieci brevi lobi dentati e sono seguite da bacche aranciate simili a pomodorini. E' una pianta medicinale, usata nella medicina tradizionale per curare varie affezioni; le analisi di laboratorio le hanno riconosciuto proprietà antimicrobiche. Inoltre c'è una certa confusione, perché in passato il genere era molto più ampio, comprendendo specie che poi sono state trasferite a generi affini; come capita in questi casi, i vecchi nomi sono ancora diffusi, quando non prevalenti. E' il caso di Iochroma arborescens, in passato Dunalia arborescens, e soprattutto di Saracha ferruginea, precedentemente Dunalia solanacea e di Eriolarnyx australis, in precedenza Dunalia australis. Il genere Eriolarnyx è affine a Dunalia, me se ne distingue per le corolle campanulate. Nella primavera del 1788, il botanico francese André Michaux e suo figlio François André visitano la Florida occidentale dove sono accolti con squisita cortesia dal governatore Vicente Manuel de Céspedes. Memore di quell'accoglienza, qualche anno dopo Michaux gli dedica uno dei suoi nuovi generi americani, ma un errore di lettura o una svista del tipografo trasformano il buon governatore in Lespedez e il genere in Lespedeza. 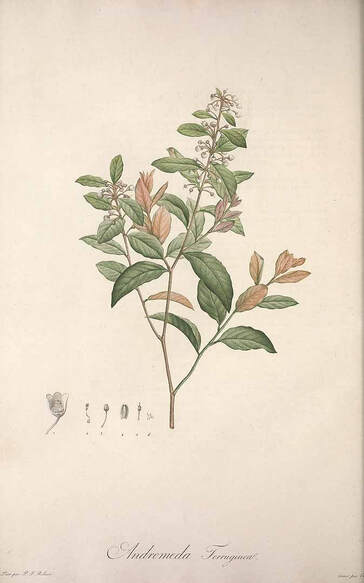 Un memorabile viaggio in Florida Inviato negli Stati Uniti come botanico reale alla ricerca di piante utili per ripopolare le foreste francesi, André Michaux era invece intenzionato ad andare oltre questo mandato: voleva scrivere una flora del Nord America, e per questo desiderava visitare tutte le zone accessibili, incluse la Florida spagnola e le Bahamas, nonostante la loro flora tropicale o subtropicale poco si adattasse all'introduzione in terra francese. Già nel 1787 aveva comunicato al Conte d'Angevilliers, direttore generale dei Bâtiments du Roi (da cui dipendeva la sua missione) la sua intenzione di visitare la Georgia e la Florida. Tensioni di frontiera bloccarono per qualche mese il progetto, finché alla fine del febbraio 1788, accompagnato dal figlio François André e da un servitore, egli salpò da Charleston alla volta di St. Augustine, la capitale della Florida occidentale. Agli ufficiali di porto dichiarò di essere stato autorizzato a studiare la storia naturale della provincia dal governatore, Vicente Manuel de Céspedes (o Zéspedes), al quale evidentemente aveva scritto, anche se il carteggio non ci è pervenuto. Condotto alla presenza del governatore, fu ricevuto con grande calore e cortesia. Solo qualche giorno dopo scrisse nuovamente a d'Angevilliers per ottenere il permesso ufficiale di fare raccolte botaniche in Florida. Di fatto, si era già messo al lavoro. Oltre a esplorare i dintorni della città, dove scoprì una nuova specie di Ericacea, Lyonia ferruginea, si era procurato un terreno dove creare un vivaio temporaneo e aveva affittato una canoa e due rematori. Il 12 marzo partì alla volta dell'Anastasia Island, dove fu ospite del mercante Jesse Fish che nella sua residenza, chiamata El Verge, aveva creato un giardino ricco di olivi, palme da dattero, limoni e aranci; Michaux nelle sue memorie lo definisce un paradiso. Era la prima tappa di un viaggio, parte in canoa, parte a piedi, parte a cavallo, che li portò in direzione sud, sempre erborizzando, ad esplorare la costa orientale della Florida lungo il Northwest River e l'Indian River fino all'altezza dell'attuale Bonaventure, dove giunsero all'inizio di aprile; oltre non era possibile andare, essendo ormai penetrati in territorio indiano. Durante il viaggio di ritorno affittarono dei cavalli per riportare le raccolte a St. Augustine e osservarono un incendio: sia gli indiani sia gli europei usavano applicare incendi per facilitare la caccia o per liberare terreni per il bestiame, una pratica altamente disapprovata da Michaux. Rientrato a St. Augustine il 17 aprile, Michaux fece subito visita al governatore, che nei giorni successivi volle visitare di persona le collezioni e invitò il botanico a pranzo. Quest'ultimo era impegnato a riordinare le raccolte (stando al suo diario, fino a quel momento ammontavano a 105 specie), a scrivere lettere in Francia e ai rappresentanti diplomatici francesi, anche per battere cassa, e a preparare la prossima escursione. Il 29 aprile era infatti di nuovo in partenza con gli stessi compagni, questa volta a cavallo, alla volta della residenza di Job Wiggins, che aveva accompagnato William Barton nella spedizione del 1774. Situata sulla riva orientale del St. Johns River, era un buon punto di partenza per esplorare il bacino del fiume, il maggiore della colonia; nei dintorni, Michaux trovò una nuova specie di graminacea, Stenopholis obtusata. Da quel momento il viaggio proseguì in canoa, toccando Mount Royal, una collina sabbiosa visitata e così denominata da John Bartram nel 1765, e Drayton Island sul lago George; quindi continuò lungo il St Johns River e nella strettoia oggi chiamata Salt Springs Run fino alla sorgente dove Michaux raccolse Illicium parviflorum, già osservato nei lori viaggi dai due Bartram ma ancora non descritto. Quindi il gruppo esplorò Silver Gleb Spring e proseguì fino alla confluenza tra il lago George e il St. Johns River, quindi lungo il fiume dove dopo qualche giorno si imbatté in correnti contrarie e grandi masse di alligatori; giunto all'altezza dell'attuale High Bank, avendo trovato poche specie nuove, Michaux decise di rientrare a St. Augustine. Il viaggio volgeva al termine. Dopo un'ulteriore visita al governatore e ad alcune famiglie influenti, i Michaux si imbarcarono con loro raccolte alla volta di Charleston; qui le talee prese in Florida furono trapiantate nel vivaio, mentre i semi di molte piante venivano spediti in Francia; tra le altre, Guilandina bonduc, Sophora tomentosa, Chiococca alba, Ceanothus microphyllus, Conocarpus erectus, Psychoria nervosa, Amyris eleifera, Zamia integrifolia, Tillandsia utriculata, Modiola caroliniana.  Ripopolare la Florida E' ora di sapere qualcosa di più dell'ospitale governatore Vicente Manuel de Céspedes (1721?-1794); appartenente a una famiglia di militari e militare egli stesso, prima di arrivare in Florida per circa un anno era stato governatore facente funzione a Santiago de Cuba; nel 1783 fu nominato primo governatore della Florida orientale che, dopo vent'anni di occupazione britannica, tornava sotto sovranità spagnola in forza del trattato di Parigi. Céspedes si trovò così a gestire una difficile transizione. Il problema principale era quello del popolamento. La popolazione era molto mista: c'erano spagnoli provenienti dalla madre patria, cubani, minorchini (Minorca nel Settecento era passata più volte dalla sovranità spagnola a quella britannica e viceversa, e molti erano di lingua inglese), francesi, italiani, greci, britannici che durante l'occupazione inglese erano subentrati agli spagnoli che avevano preferito lasciare la colonia. Il timore era che con il tempo gli anglofoni potessero prendere il sopravvento o che gli Stati Uniti decidessero di invadere il paese; venne così fissato l'obiettivo di aumentare la popolazione, fino a eguagliare nell'arco di 25 anni quella della Georgia. La corona fissò regole molto stringenti per i nuovi immigrati, la principale delle quali era che dovevano essere di religione cattolica; anche gli stranieri erano ben accetti, purché fossero appunto cattolici e imparassero la lingua spagnola. Céspedes, da parte sua, cercò di favorire i nuovi arrivi, garantendo dieci anni di esenzione dalle tasse, terre, aiuti come bestiame, sementi, attrezzi. Buona parte del territorio era disabitato, e le terre non mancavano, ma la questione del ripopolamento si incrociava con quella delle proprietà. Alcune, i cui proprietari ispanici avevano preferito lasciare la Florida, erano rimaste vacanti al momento dell'occupazione inglese, altre erano state abbandonate dagli inglesi al ritorno degli spagnoli. Céspedes propose che tutte le proprietà vacanti e non rivendicate entro una certa data fossero confiscate dalla corona, per essere ridistribuite ai nuovi immigrati, in particolare i cosiddetti floridanos, ovvero quelle persone che si erano stabilite a Cuba dopo l'occupazione inglese della Florida, di cui voleva incoraggiare il ritorno nella penisola. Un'ultima questione riguardava gli schiavi neri. Poiché nella Florida spagnola non c'erano né piantagioni né miniere, erano pochi; inoltre, nel 1693, il re Carlo II aveva emanato un decreto che concedeva la libertà agli schiavi fuggiti dall'America britannica, purché accettassero la religione cattolica. Così si era formato un notevole insediamento di neri liberi a nord di S. Augustine; godevano della libertà personale, non erano discriminati e formarono persino un reggimento di milizia. Altri schiavi fuggiti si erano rifugiati presso gli indigeni Creek e Seminole. Durante il ventennio di occupazione, i coloni britannici avevano introdotto l'economia di piantagione (si coltivavano cotone, indaco, canna da zucchero) e con essa schiavi neri portati dall'Africa. Al ritorno degli Spagnoli, essi chiesero di essere liberati in osservanza alla legge di Carlo II, mentre i loro proprietari, che ora si era stabiliti in Georgia o nelle Caroline, ne chiedevano la restituzione; Céspedes, anche se temeva che molte conversioni fossero di comodo, li trattenne in Florida. Buona parte del territorio era inesplorato; gli abitati si concentravano lungo la costa, con centro principale a St. Augustine (Jacsksonville e Miami non esistevano ancora) e non si spingevano oltre il Río de Mosquitos, forse a sud dell'attuale Cape Canaveral. Gli inglesi avevano poi creato una serie di piantagioni lungo il St Johns River, il più lungo e importante della regione anche per i commerci, anche se, per le sue acque basse e paludose, era navigabile solo in canoa. Si capisce dunque perché il governatore si sia mostrato così amichevole verso Michaux e abbia incoraggiato la sua esplorazione. Nel 1784, ordinò un censimento, seguito nel 1786 da un secondo più dettagliato. La conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche geografiche e umane, delle sue risorse, erano per lui un dovere d'ufficio, come dimostra il suo unico scritto noto, Descripción de la Florida Oriental: su clima, terreno, productos, ríos, barras, bahías, puertos, números y calidades de la gente que la habitan, un manoscritto inedito oggi conservato nell'Audiencia de Santo Domingo dell'Archivio General de Indias, da lui inteso come una vera e propria guida per indirizzare la politica immigratoria. Il documento inizia con una una descrizione geografica della Florida orientale, soffermandosi sull'estensione, il clima, le forme del territorio; si trattano poi i fiumi principali, i laghi, le lagune costiere, sempre indicando gli eventuali popolamenti e la loro consistenza, i pochi nuclei urbani. Dopo aver trattato in modo abbastanza generico le risorse naturali (che sono comunque abbondanti e promettenti), Céspedes conclude con la parte più politica: le sue indicazioni per incrementare il commercio (che a suo parere deve avvenire soprattutto da e verso Cuba) e per favorire l'immigrazione, terminando con le Reglas y condiciones para pobladores tanto extranjeros como naturales di cui abbiamo già parlato. L'incarico di Céspedes terminò nel 1790; dovette quindi ritornare a Cuba, dove sappiamo che morì nel 1794 e fu sepolto nella cattedrale dell'Avana.  Un errore... di sbaglio Michaux non dimenticò mai la cortesia con la quale era stato accolto dal governatore Céspedes, che la sua lotta con l'avara e poco sollecita amministrazione francese prima e dopo la rivoluzione gli facevano apprezzare anche più. Così nella sua Flora boreali-americana non poteva mancare di rendergli omaggio, dedicandogli uno dei suoi nuovi generi. Il libro fu pubblicato postumo nel 1803 a cura del figlio François André e questo forse spiega il fattaccio: tanto il nome del genere quanto quello del dedicatario sono infatti sbagliati. Il genere si chiama Lespedeza, non Cespdeza o Zespedeza (le due forme sotto le quali conosciamo il nome del governatore) e del dedicatario si dice "Per il sig. Lespedez, governatore della Florida, cortesissimo nei confronti dei miei viaggi". Eppure anche François André era della partita... ma, come si dice in questi casi, la colpa è del proto che avrà scambiato la lettera iniziale C con L. Lespedeza Mich. è un genere di una quarantina di specie della famiglia Fabaceae, con una distribuzione nettamente disgiunta: una trentina vivono nelle zone temperate e subtropicali dell'Asia orientale e in Australia, mentre le altre sono originarie del Nord America orientale. Il numero delle specie e la loro corretta individuazione hanno dato filo da torcere ai botanici a causa sia dell'estrema variabilità delle specie, sia della tendenza a produrre con facilità ibridi naturali. Il genere, caratterizzato dai fiori papilionacei (ma molte specie hanno anche fiori cleistogami, cioè autofecondanti, privi di petali) e da baccelli tipici di questa famiglia, è piuttosto vario: comprende infatti erbacee perenni, arbusti e rampicanti. La specie più nota e coltivata nei giardini è senza dubbio L. thunbergii, uno splendido arbusto originario della Cina e del Giappone con eleganti rami arcuati che alla fine dell'estate si trasformano in una cascata di fiori rosa-porpora. L'americana L. capitata è invece famosa per altre ragioni: già gli indiani ne usavano le foglie per preparare tisane medicamentose; oggi è usata in fitoterapia per le sue proprietà drenanti, diuretiche e antiossidanti, che la rendono particolarmente indicata per migliorare le funzioni renali. Come molte leguminose, anche le piante di questo genere hanno radici dotate di noduli che ospitano batteri in grado di fissare l'azoto, arricchendo così il terreno. In Asia diverse specie sono usate come foraggere e appunto per il sovescio. Le loro forti radici sono utili anche per arginare il terreno, contenendo gli smottamenti. Ma queste belle qualità possono anche presentare un rovescio della medaglia, come dimostra la storia dell'asiatica L. cuneata. Questa pianta è stata introdotta in diversi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti dove venne piantata per la prima volta nel 1896 nel Nord Carolina per bonificare i terreni di miniere abbandonate, e anche come foraggiera; grazie alle radici molto profonde, non solo trattiene il terreno, ma riesce a sopravvivere a lunghi periodi di siccità. Ne sono anche state sviluppate diverse varietà. Eppure tanto vigore ha un rovescio della medaglia: una singola pianta può produrre 1000 semi all'anno, dove si insedia invade gli spazi delle piante native, inibisce la crescita dei semenzali degli alberi, produce sostanze chimiche che inibiscono la crescita di altre piante. Negli Stati Uniti è già un problema, in Europa non ancora, ma l'Unione europea l'ha inserita nella lista delle piante invasive e ne ha vietato la commercializzazione. Jean-Baptiste Leschenault de La Tour è stato definito da Lucille Allorge "il più viaggiatore dei botanici viaggiatori". In effetti, da quando ventisettenne si imbarcò sul Géographe alla volta dell'Australia, non smise mai di spostarsi da un paese all'altro, eccetto quando ne fu impedito dalla guerra. Dal 1800 al 1803 fu appunto il botanico (l'unico rimasto) della spedizione Baudin nelle Terre Australi; sbarcato malato a Timor, si spostò a Giava, dove rimase tre anni a botanizzare in un ambiente naturale ricchissimo e quasi inesplorato. Dal 1807 al 1815 la guerra lo bloccò in Francia; ma, appena tornata la pace, eccolo ad esplorare l'India meridionale. Ritornò in patria solo nel 1822, ma dopo meno di un anno ripartì, alla volta del Sud America. La salute precaria (che già lo aveva tradito altre volte) lo costrinse a un rientro anticipato, l'ultimo. Si potrebbe però anche definirlo botanico coloniale perché dedicò quasi metà della sua vita a cercare piante adatte alla naturalizzazione nelle colonie francesi. A ricordarlo il bellissimo genere australiano Lechenaultia (o Leschenaultia), omaggio dell'amico Robert Brown. Australia, India, Sud America Non conosciamo molto della giovinezza di Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (1773-1826), soprattutto ignoriamo per quali vie si fosse avvicinato alla botanica. Nel 1798 dalla natia Borgogna si traferì a Parigi e si presentò a Antoine Laurent de Jussieu, nella speranza di essere ammesso come allievo al Museum National d'Histoire naturelle. Probabilmente ci riuscì, visto che Jussieu, nel sostenere la sua candidatura per la spedizione Baudin alle Terre australi, lo presenta come allievo dell'istituto. Si dice che Leschenault l'avesse presentata spinto dal motivo apposto rispetto allo zoologo François Péron: questi voleva partire perché il padre di lei gli aveva rifiutato la mano della ragazza che amava, lui invece voleva sottrarsi a un matrimonio mal riuscito. Come che sia, Jussieu era abbastanza soddisfatto delle sue competenze da proporlo come allievo botanico della spedizione; così scrive di lui: "Il cittadino Leschenault si occupa da qualche anno di botanica e ne sa abbastanza da nominare un certo numero di piante senza ricorrere a libri e da decifrare in questi ultimi la maggior parte di quelle che non conosce". Inoltre, sapeva essiccare correttamente le piante, le disegnava in modo abbastanza corretto, era di buon carattere e di eccellente educazione. Ma dopo la rinuncia di Ledru, da allievo Lechenault passò a botanico, rimasto poi l'unico della sventurata spedizione. In Australia, egli visse questa nuova responsabilità diviso tra un forte senso del dovere e la coscienza della propria inadeguatezza; entrambi i sentimenti emergono in una bella lettera inviata a Jussieu da Port Jackson in cui non può nascondere la sua invidia per il botanico della spedizione Flinders. A lui tocca raccogliere le piante, essiccarle, descriverle e pure disegnarle, visto che i disegnatori Lesueur e Petit sono divisi tra il lavoro per il comandante e quello per lo zoologo Péron. "Che contrasto - scrive - con gli aiuti di ogni tipo accordati al mio buon amico Robert Brown!" Certo fece il suo dovere fino in fondo e le sue raccolte furono notevolissime, anche se durante la spedizione ebbe ricorrenti problemi di salute. Durante il soggiorno a Port Jackson era tanto deteriorata che in un primo tempo egli pensò di chiedere l'autorizzazione a rientrare in Francia con il Naturaliste. Poi si riprese, poté partecipare a diverse escursioni botaniche nei dintorni di Port Jackson, a Parramatta e sulle Blue Mountains; ma a dissuaderlo fu soprattutto il capitano Baudin che seppe trovare le parole giuste per rassicurarlo, con un atteggiamento comprensivo e paterno (decisamente non era il mostro che è stato dipinto). Sicuramente Leschenault non si pentì di essere rimasto, visto che l'ultima parte del viaggio fu la più produttiva. Ma il prezzo fu il deterioramento della sua salute: nel maggio 1803 arrivò a Timor in tali condizioni che dovette essere lasciato a terra. Sperava di rimettersi e di tornare quanto prima a casa. Un mese dopo la partenza dei suoi compagni, si imbarcò su una nave olandese diretta a Batavia, dove giunse così malato da non potere proseguire. Chiese però il premesso di trasferirsi a Samarang, che godeva di un clima un po' meno insalubre. Vi giunse a ottobre e fu accolto dal governatore Engelhard, in cui trovò un uomo colto e interessato alle scienze naturali. Nacque così un nuovo progetto: Leschenault sarebbe rimasto a Giava e avrebbe esplorato le ricchezze naturalistiche dell'isola, solo marginalmente sfiorate dai naturalisti che l'avevano visitata in precedenza. L'amministrazione olandese fornì uomini e mezzi, permettendogli di muoversi in sicurezza e con relativo agio. L'esplorazione iniziò con un viaggio nelle due capitali dei sultanati di Surakarta e Yogykarta. Partito da Samarang il 24 ottobre, Leschenault si diresse dapprima a Surakarta, passando per i monti Ungaran, Merbabu e Merapi, un vulcano attivo; per un mese esplorò la città e i suoi dintorni, quindi passò a Yogykarta, visitando lungo il cammino le rovine del tempio buddista di Prambanang. Aveva di nuovo preteso troppo da se stesso: dopo due settimane a Yogyakarta, ebbe un crollo; trasportato in barella a Samarang, vi giacque malato dal febbraio all'ottobre 1804. Quando si fu ristabilito, ripartì per visitare la parte orientale di Giava, di cui toccò tutti i distretti costieri; quindi si imbarcò per l'isola di Madura, dalla quale sarebbe stata sua intenzione proseguire per l'arcipelago Kangean, ma la notizia di un'incursione di pirati malesi lo indusse a desistere; tornato sulla terraferma, esplorò la regione sud orientale fino a Banyuwangi, dove si fermò due mesi; quindi passò a Bali, di cui visitò le coste. Tornato a Banyuwangi, passando dall'interno e toccando i monti Tingar si diresse a Surabaya. Qui si imbarcò infine per Samarang, dove rientrò nell'agosto 1806, dopo un viaggio di 18 mesi. Andò poi a Batavia, con l'intenzione di imbarcarsi per la Francia. In Europa infuriava la guerra e non era facile trovare un imbarco su una nave neutrale, tanto più che portava con sé molte casse di piante, animali, conchiglie, oggetti etnografici; finalmente, a novembre riuscì a trovare un passaggio su una nave americana. Nell'aprile 1807 era a Filadelfia dove riuscì a ottenere dall'ambasciatore inglese un passaporto per sé e le proprie collezioni. A luglio, dopo sette anni di assenza, toccava il suolo francese. Quasi il suo primo atto fu scrivere a Jussieu per informarlo del suo ritorno e delle sue avventure. Le raccolte furono esaminate da una commissione designata dal ministero dell'Interno (ne facevano parte anche Lamarck e Cuvier) che le giudicò così importanti da proporre di considerare l'esplorazione di Giava parte integrante della missione nelle Terre Australi: a condizione che consegnasse le collezioni al Museum, era giusto pagargli quattro anni di stipendio arretrato e assegnargli una pensione analoga a quella concessa a Péron. Napoleone acconsentì. Fino alla caduta di quest'ultimo, venne l'ora di lavori da scrivania (tra gli altri, la stesura di un dizionario di lingua malese); nel 1816, ritornata la pace, ripartì. La nuova destinazione era Pondichéry (oggi Pondicherry), la capitale dell'"India francese", costituita da cinque empori situati lungo la costa del Malabar e recentemente restituita alla Francia dal Congresso di Vienna. Era invece rimasta in mani inglesi l'Ile de France, ovvero Mauritius: una perdita molto dolorosa perché per quasi un secolo l'isola e il suo giardino di Pamplemousses avevano costituito il principale luogo di acclimatazione delle specie esotiche da diffondere nelle colonie francesi. Ora quel ruolo passava all'altra isola delle Mascarene, la Réunion, tornata a chiamarsi Ile Bourbon con la restaurazione, e al suo giardino di Saint Denis, appena creato dal botanico Nicolas Bréon. La missione di Leschenault era proprio quella di cercare piante indiane utili per l'agricoltura e il commercio, da acclimatare a Bourbon per essere poi distribuite in quanto rimaneva delle colonie francesi. Il botanico prese molto sul serio il compito. Anche se nei sei anni in cui rimase in India raccolse anche un'imponente quantità di esemplari di piante, animali e minerali e si interessò di molti aspetti della vita e della cultura indiane, ne fece il principale oggetto delle proprie ricerche. Prima di partire per l'India, andò in Inghilterra ad incontrare il vecchio Banks, per ottenere lettere di raccomandazione per gli amministratori e i botanici inglesi, che in effetti gli furono di grande aiuto. Giunto a Pondichéry nel settembre 1816, dedicò il primo anno allo studio dei sistemi di coltivazione in uso lungo la costa del Coromandel. Studiò anche le tecniche tintorie tradizionali a Karikal, l'altra enclave francese. Nel 1818, il primo viaggio alla ricerca di piante utili lo portò a Salem, da cui riportò, oltre a un erbario di 400 specie e semi di circa 160, il primo carico di piante vive e semi destinato a Bourbon: c'era la pianta tintoria Nerium tinctorium (oggi Wrightia tinctoria), due specie di canna da zucchero, una nera e una bianca, alberi di sandalo e di teak, semi di papavero da oppio e di quattro tipi di cotone. Poi la salute lo tradì di nuovo: nel mese di ottobre ripartì per visitare i Ghati occidentali, ma a Coimbatore fu colpito da un pericoloso attacco di febbre gialla che lo costrinse a rientrare a Pondichéry. Appena il tempo di ristabilirsi, ed eccolo di nuovo a Coimbatore, punto di partenza per una lunga escursione sulle Nigiri Hills, in cui fu accompagnato da due amici inglesi, Mr. Sullivan e il dr. Jones. Su queste montagne, non molto elevate ma dai fianchi assai ripidi e difficili da scalare, caratterizzate da un clima fresco e ricchezza di acqua, trovò una ricca flora con molti generi presenti anche in Europa (Rhododedndron, Rubus, Geranium, Impatiens, Rosa, Salix, Berberis), che egli giudicò particolarmente adatte alla naturalizzazione nei giardini europei; tra le piante utili, una nuova specie di Berberis che per le sue eccellenti qualità tintorie battezzò B. tinctoria. Nel 1819 andò in nave in Bengala e ne tornò con molte piante da inviare a Bourbon, ma anche in Senegal. Oltre a molti alberi da legname o falegnameria, nella sua relazione all'Accademia delle scienze, egli cita la palma da zucchero Saguerus rumphii (oggi Arenga pinnata), Ficus elastica per la sua gomma elastica, piante tessili come Asclepias (oggi Marsdenia) tenacissima, Urtica tenacissima (oggi Bohemeria nivea), Boswellia thurifera (oggi B. serrata), da cui si ricava un tipo d'incenso. Il viaggio più lungo e impegnativo fu l'ultimo, dedicato all'estrema regione dell'India sud-orientale e all'isola di Ceylon. Leschenault visitò i due piccoli regni di Thanjavur e Tondiman, il distretto di Madurai e le montagne di Cottalam, punto di incontro tra i due monsoni, con una flora assai variata. Dal sud dell'India inviò a Pondichéry un convoglio di carri con 35 balle di alberi di 42 specie diverse, tra cui il teak Tectona grandis. Al loro arrivo, furono trapiantati nel giardino del governatore, primo nucleo dell'orto botanico di Pondichéry che sarebbe stato creato nel 1826 sui terreni dell'ex Campo di Marte. Torniamo a Leschenault. Dopo aver visitato la provincia di Tinnevelly, si imbarcò per Ceylon; dopo aver soggiornato per qualche tempo a Colombo, ottenne il permesso di visitare l'interno, cosa che fece per tre mesi, finché nel febbraio 1821 l'ennesima malattia lo costrinse a imbarcarsi per Pondichéry. Portava però con sé molti esemplari di Cinnamomum verum, l'albero da cui si ricava la pregiata cannella di Ceylon. Ad agosto lasciò l'India per Bourbon, accompagnato da cinque pecore e da un montone della razza di Coimbatore, 130 piante vive, compresi 32 pianticelle di Cinnamomum verum, e circa 200 specie di semi. Mentre si trovava sull'isola, con l'aiuto di Bréon tentò esperimenti di innesto del cotone su Thespesia populnea, Hibiscus liliflorus e Guazuma ulmifolia. Infine, il 15 febbraio 1822 si imbarcò alla volta della Francia via Capo della Buona speranza, dove approfittò di uno scalo di due settimane per incrementare la collezione di semi, acquistare qualche tartaruga e una nuova specie di uccello. Al suo rientro in Francia l'enorme contributo alle collezioni botaniche, zoologiche e mineralogiche del Museo e all'introduzione di specie coloniali utili gli valse l'attribuzione della Legion d'onore. Dopo meno d'un anno, arrivò una nuova missione: con il titolo ufficiale di "botanico della corona" (ne aveva fatta di strada dai tempi in cui era "allievo botanico"!) fu inviato nella Guaiana francese per rilanciare l'agricoltura di quella colonia. L'11 giugno 1823 egli partì da Brest in compagnia di A. J. L. Doumerc, diretto a Cayenne, dove giunse il 5 novembre, dopo due scali a Rio e Bahia. Portava con sé pianticelle di tè per l'orto botanico. Dopo un breve soggiorno nella capitale, i due si spostarono a Nouvelle Angoulême sul fiume Mana, dove si separarono. Doumerc visitò le tribù amerinde Galibi e Arrowali, mentre Leschenault proseguiva alla volta del Suriname (Guaiana olandese). Anche qui fece notevoli raccolte, ma la salute malferma lo costrinse a interrompere il viaggio e a rientrare a Parigi nel novembre 1824. Quando sembrava aver recuperato, morì all'improvviso il 14 marzo 1826 all'età di 52 anni.  Lechenaultia o Leschenaultia? Sempre in viaggio, Leschenault de La Tour raccolse moltissimo ma pubblicò molto poco. Al ritorno da Giava diede alle stampe due brevi testi relativi alla spedizione Baudin, uno sulla città di Kupang a Timor, l'altro sulla vegetazione della Nuova Olanda (pubblicato nel secondo volume della relazione ufficiale di Péron e Freycinet), e una memoria su alcune piante velenose di Giava. Ugualmente scarsi gli scritti sull'India, che si limitano alla relazione sul viaggio letta all'Accademia delle scienze, alla pubblicazione del Berberis scoperto sulle Nigiri Hills e a una memoria sulla cannella di Ceylon. Ad approfittare delle sue raccolte e dei suoi erbari furono altri naturalisti. Senza dimenticare che quando Leschenault tornò in Europa Robert Brown, che invece era rientrato nel 1805, aveva già fatto in tempo a pubblicare un certo numero di specie australiane raccolte da entrambi, rendendo in qualche modo superato almeno in parte un suo eventuale lavoro. Un certo numero di piante raccolte da Leschenault in Australia furono descritte da Etienne Ventenat e da Aimé Bonpland nelle loro opere sul giardino di Malmaison, altre furono pubblicate da Labillardière, altre ancora da R. L. Desfointaines, che descrisse anche alcune delle sue specie indiane nei cataloghi delle collezioni del Jardin des plantes. Moltissimo ovviamente rimase non pubblicato nei depositi del Museo Nazionale. Diverse decine di piante ricordano il nostro botanico viaggiatore nel nome specifico e con le loro diverse origini riassumono le tappe dei suoi viaggi: tra le altre, citiamo le australiane Beyeria leschenaultii e Calitrix leschenaultii, le indonesiane Hypericum leschenaultii e Aralia leschenaultii, le indiane Argureya leschenaultii e Impatiens leschenaultii. Tra gli animali, ricordiamo il corriere di Leschenault Charadius leschenaultii, il cuculo di Sirkeer Toccocua leschenaultii, il codaforcuta capobianco Enicurus leschenaulti, il pipistrello Rousettus leschenaultii, la lucertola Ophiosops leschenaultii. In Australia conserva il suo nome la bellissima laguna Leschenault Estuary, separata dall'Oceano Indiano dalla penisola Leschenault. Nel breve periodo in cui entrambi si trovavano a Port Jackson come botanici rispettivamente delle spedizioni Baudin e Flinders, Leschenault de La Tour e Robert Brown avevano stretto amicizia. Nel giugno 1802 fecero almeno un'escursione insieme, nella quale lo scozzese ebbe modo di apprezzarne le doti di acuto osservatore. Fu proprio lui a dedicare un genere al collega francese in Prodromus Florae Novae Hollandiae, con una motivazione piena di elogi: "L'ho nominato in onore del mio stimato amico Lechenault, celebre viaggiatore, esperto botanico, da cui si attende avidamente la pubblicazione delle piante della costa occidentale della Nuova Olanda e delle isole di Giava e Timor". La grafia del cognome non è un mio errore di battitura: così lo trascrive un po' ad orecchio Brown, che infatti denominò il nuovo genere Lechenaultia, senza esse. Qualche anno dopo George Bentham lo corresse in Leschenaultia, nome che si impose a lungo, finché in rispetto delle norme della nomenclatura botanica, si è tornati alla denominazione originale. Ma l'incertezza rimane: mentre nella letteratura botanica prevale Lechenaultia, Plants of the World on line usa Leschenaultia, che è anche la forma più usata come nome comune. Lechenaultia / Leschenaultia (famiglia Goodeniaceae) è un genere endemico dell'Australia con una ventina di specie; per lo più sono piccoli arbusti, con qualche erbacea annuale; in genere hanno portamento prostrato e tappezzante. La maggior parte si trova nei suoli sabbiosi e nel clima arido o semi-arido dell'Australia occidentale, una in condizioni simili nell'Australia orientale, due nella regione tropicale del nord; L. filiformis si spinge in Nuova Guinea, unica specie al di fuori dell'Australia. Attraenti sia per l'aspetto generale sia per le fioriture, diverse specie sono coltivate come ornamentali. Solitamente hanno foglie lineari e carnose, di colore grigio-verde, che al momento della fioritura formano uno sfondo perfetto per i numerosi fiori dalle coloratissime corolle asimmetriche: blu intenso per L. biloba, giallo luminoso o rosso carminio per L. formosa, rosa carico per L. macrantha. Anche da noi in vivai ben forniti è possibile reperire almeno la prima, di cui sono state selezionate alcune cultivar, ma coltivarla e mantenerla in vita per più di pochi anni non è semplice. Qualche approfondimento nella scheda. Il "Viaggio di scoperta alle Terre australi", più noto come "Spedizione Baudin", avrebbe dovuto assicurare la gloria scientifica della nuova Francia di Napoleone; invece, nonostante gli indubbi successi, con la ricognizione di ampi tratti delle coste australiane e la raccolta di migliaia di esemplari, è passato alla storia come una spedizione maledetta. Defezioni, malattie e morti ne falcidiarono l'imponente équipe scientifica: alla partenza da Le Havre, a bordo del Géographe e del Naturaliste, senza contare uno stato maggiore di una sessantina di eccellenti ufficiali, diversi dei quali recentemente diplomati dell'Ecole polytechnique, c'erano ventidue tra scienziati e artisti; alla partenza da Mauritius alla volta dell'Australia, il secondo gruppo si era ridotto a quattordici (contando anche due artisti reclutati nel frattempo); alla partenza da Port Jackson per la seconda parte della spedizione, erano diventati nove. In Francia ne tornarono solo sei, tre dei quali morirono nel giro di pochi anni in seguito alle malattie contratte durante il viaggio. Dunque, un vero disastro sul piano umano, non compensato dai risultati scientifici, imponenti ma in gran parte rimasti inediti. Occorreva un capro espiatorio, e fu facilmente trovato nel capitano Baudin: un outsider ammesso da pochissimo nella marina militare, dopo aver servito per anni una potenza nemica, per di più impossibilitato a difendersi, essendo morto lui stesso durante il viaggio. A costruire la leggenda nera provvidero solerti gli autori della relazione ufficiale, prima lo zoologo Péron poi l'ufficiale Louis de Freycinet, che per motivi diversi nutrivano astio nei confronti dello sventurato comandante. Solo in anni relativamente recenti, la pubblicazione del giornale di bordo di Baudin ha permesso di riequilibrare un poco quel quadro. Eppure, i risultati erano sotto gli occhi di tutti: nel parco della Mailmaison scorrazzavano canguri ed emù e cigni neri si dondolavano sul laghetto, mentre i giardini e i viali di Francia incominciavano a popolarsi di eucalipti e di mimose, germinate dai semi giunti dall'Australia. Tra ufficiali-cartografi e scienziati, contando sia quelli che rimasero fino alla fine sia quelli che lasciarono la spedizione, sono almeno una dozzina quelli che hanno ricevuto l'onore di un genere botanico; due soli sono validi, e per una strana coincidenza ricordano due dei salvati tornati a Le Havre a bordo del Géographe: l'ultimo comandante, Pierre Bernard Milius, colui che lo riportò in Francia dopo la morte di Baudin, e l'unico tra i giardinieri o botanici rimasto fino alla fine: il ragazzo giardiniere Antoine Guichenot, sedicenne quando lasciò Le Havre. La spedizione si sfilaccia: Le Havre-Ile de France Dopo il successo della spedizione della Belle Angelique e la trionfale partecipazione alla Festa della libertà, Nicolas Baudin, che ormai godeva della stima e dell'amicizia di Antoine Laurent de Jussieu, il direttore del Museum National, propose al Direttorio una missione scientifica più ambiziosa: niente meno che la circumnavigazione del globo, per rinnovare la gloria del viaggio di Bougainville in salsa repubblicana. Sempre a corto di quattrini, il Direttorio tergiversò, finché Baudin e i suoi sponsor del Museum tornarono alla carica con il nuovo padrone della Francia, Napoleone Bonaparte. Il primo console ricevette il capitano e una delegazione dell'Institut national des sciences et des arts, approvò il progetto, ma fissò una meta e un compito più circoscritti: l'esplorazione e la mappatura delle coste meridionali, occidentali e settentrionali della Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Non di meno, per il numero di persone coinvolte e l'ampiezza degli obiettivi scientifici, che oltre alla cartografia includevano mineralogia, astronomia, zoologia, botanica ed etnografia, si trattava di un'impresa grandiosa, che avrebbe dovuto sancire la preminenza scientifica della nuova Francia. Nulla fu lasciato al caso. Una commissione, che comprendeva molti dei più bei nomi del Museum, stilò precise istruzioni (quelle antropologico-etnografiche furono scritte da Cuvier), l'itinerario venne fissato nei minimi particolari, furono allestite due corvette di recente fabbricazione, la Galathée et la Menaçante, prontamente ribattezzate Géographe e Naturaliste, cui venne aggiunto un ponte per ricavare spazio per le provviste, le attrezzature e il personale scientifico, costituito da ben 22 tra scienziati, giardinieri e artisti. La attrezzature erano all'ultimo grido e comprendevano persino un alambicco per distillare e rendere potabile l'acqua marina. Si era in guerra, e fu necessario ottenere il beneplacito dell'Inghilterra, che fu concesso grazie alla mediazione di Joseph Banks, anche se lui stesso e la Royal Navy temevano che dietro quella facciata scientifica si nascondessero mire coloniali; ecco perché venne immediatamente allestita una contro-spedizione, quella del capitano Matthiew Flinders sull'Investigator, con la missione dichiarata di mappare le coste dell'Australia e quella segreta di sorvegliare i francesi. Il Géographe e il Naturaliste salparono da Le Havre il 19 ottobre 1800. A bordo del Géographe, comandato da Nicolas Baudin con l'assistenza del capitano di fregata Alexandre Le Bas de Sainte Croix, c'erano 118 uomini, tra ufficiali (tra i quali vale la pena di segnalare almeno il figlio di Bougainville Hyacinthe e Henri de Freycinet), marinai, personale di bordo, e un'équipe scientifica che comprendeva il geografo Charles-Pierre Boullanger, l'astronomo Frédéric Bissy, il mineralogista Louis Depuch, gli zoologi René Maugé, Stanislas Levillain e François Péron, il botanico Jean Baptiste Leschenault de La Tour, i giardinieri Anselme Riedlé, Antoine Sautier e Antoine Guichenot, gli artisti Louis Lebrun e Jacques Gerard Gilbert. Erano invece 120 le persone imbarcate sul Naturaliste, comandato dal capitano di corvetta Jacques Félix Hamelin des Essarts con l'assistenza del secondo Pierre Bernard Milius; tra gli ufficiali, il minore dei Freycinet, Louis; l'équipe scientifica comprendeva il geografo Pierre Ange Faure, il mineralogista Joseph Charles Bailly, l'astronomo Pierre-François Bernier, gli zoologi Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, i botanici Jacques Delisse e André Michaux, assistito dai giardinieri Jean François Cagnet e Merlot (un ex schiavo nero quattordicenne che Michaux aveva portato con sé dagli Stati Uniti), l'artista Michel Garnier. Sul Géographe, fin dall'inizio si creò un solco tra Baudin e i suoi ufficiali: quasi tutti di origine aristocratica, giovani, ambiziosi, diversi di loro da poco diplomati all'École polytechnique, mal tolleravano un comandante venuto dalla marina mercantile, che oltre tutto aveva servito per anni sono bandiera nemica; il carattere chiuso e autoritario di Baudin non aiutava. Il 2 novembre le navi gettarono l'ancora a Tenerife, dove si trattennero undici giorni. Michaux fu ospite di Broussonet, sull'isola in qualità di commissario delle relazioni commerciali del governo francese, che informò i compatrioti dell'imminente partenza per l'Europa di un battello con prigionieri inglesi; alcuni marinari ne approfittarono per disertare. Ma soprattutto nacquero le prime tensioni tra Baudin e i naturalisti: dopo qualche giorno passato a fare entusiasmanti raccolte, furono trattenuti a bordo in attesa di un'imminente partenza che però veniva rinviata di giorno in giorno. Eppure l'ordine non valeva per gli antichi compagni di Baudin sulla Belle Angélique, il giardiniere Riedlé e gli zoologi Maugé e Levillain. Le navi lasciarono Tenerife il 13 novembre, con qualche inconveniente dovuto alla maggiore lentezza del Naturaliste e alla difficoltà di allineamento tra le due navi. Al largo di Madera, il Géographe fu fatto segno di un colpo di cannone da un vascello spagnolo, che lo aveva scambiato per una nave britannica. Fu forse il rischio di altri incontri pericolosi a far optare Baudin per una rotta più prossima alla costa africana, anziché quella consueta più vicina alla costa brasiliana (alcuni però pensano a una scelta obbligata, dovuta alla caduta degli alisei); rallentata dalla bonaccia, la navigazione si allungò di un mese e mezzo. Con due conseguenze disastrose: il moltiplicarsi di casi di scorbuto e il crollo della fiducia nelle capacità marinare del comandante. Il Capo di Buona speranza venne avvistato solo a metà gennaio, senza farvi scalo. Dopo aver superato una tempesta, l'Ile de France fu raggiunta il 16 marzo 1801, con due mesi buoni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Qui le navi avrebbero dovuto esser rifornite di viveri e attrezzature, rifiutati però dalle autorità locali che avevano i magazzini sguarniti e temevano un attacco inglese. Baudin fu costretto a ricorrere a un prestito garantito dal console danese. Molti degli uomini erano malati, quasi tutti erano scontenti. A rompere gli indugi fu forse l'esempio di André Michaux. Il vecchio botanico, contrariato dalle regole d'ingaggio che stabilivano che le raccolte sarebbero appartenute esclusivamente allo Stato, diede le dimissioni, seguito dai suoi aiutanti Merlot e Cagnet. Dichiarandosi malati, lo imitarono l'astronomo Bissy, gli zoologi Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, il farmacista e botanico Jacques Delisse e tutti gli artisti. Baudin, che non credeva più di tanto a queste malattie più o meno diplomatiche, non li rimpianse, accontentandosi di trasferire Bernier sul Géographe e di sostituire gli artisti con due giovani di talento che si erano imbarcati come aiuto-cannonieri, Charles Alexandre Lesueur e Nicolas Martin Petit. Gli spiacque molto di più la diserzione di ventun marinai. 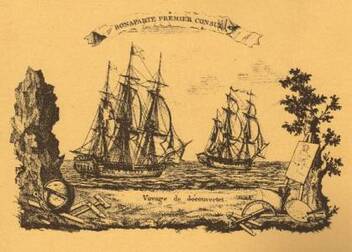 Malattia a bordo: Ile de France-Port Jackson È dunque con l'équipe scientifica dimezzata e gli effettivi ridotti che la spedizione riparte il 25 aprile 1801. Eccetto due giorni di tempesta, la navigazione è tranquilla e sospinta da venti favorevoli; la costa australiana è avvistata all'altezza del Capo Leuwen il 27 maggio. A causa del ritardo accumulato, Baudin ha infatti deciso di iniziare le ricognizioni non dalla Tasmania, secondo le istruzioni del Ministero della marina, ma dalla costa occidentale. Il primo contatto dei naturalisti con la terra australiana è nei pressi del capo che viene battezzato Naturaliste (31 maggio): i francesi si stupiscono nel vedere come una terra così arida ospiti una tale varietà di alberi e arbusti. Viene quindi esplorata la baia battezzata Géographe, dove va perduta una lancia e annega un marinaio. Il 10 giugno una tempesta separa le due navi. Avendo mancato i diversi punti d'incontro, non si riuniranno fino a Timor. Il Géographe esplora la costa tra Shark Bay e il North-West Cape, e in particolare l'isola Bernier dove l'attivissimo capo giardiniere Riedlé fa molte raccolte interessanti; poi, con diversi casi di scorbuto a bordo e provviste al lumicino, fa vela per Timor dopo getta l'ancora il 22 agosto. Il Naturaliste invece esplora a fondo la foce dello Swan river e le isole adiacenti, poi anch'esso si dirige a Timor, dove giunge un mese dopo l'ammiraglia. Lo scalo a Timor è necessario per rifornire la nave, ma notoriamente pericoloso. Molti si ammalano di dissenteria e muoiono sei uomini, tra cui il capo giardiniere Riedlé. Quando le navi lasciano Timor, il 13 novembre, i malati a bordo sono molti; tra di loro anche Leschenault, che è stato trasferito sul Naturaliste. Con grande gioia di Baudin, deve invece rimanere a terra il suo detestato secondo Le Bas de Sainte Croix, rimasto ferito in un duello contro l'ingegnere Ronsard. Lo sostituisce il maggiore dei Freycinet, Henri, Ora la spedizione fa rotta verso la Terra di van Diemen (ovvero la Tasmania). Prima di raggiungerla, sul Géographe si contano altri sette morti, tra cui il giardiniere Sautier (15 novembre) e lo zoologo Levillain (23 dicembre). Il 13 gennaio 1802 le due navi navigano lungo il Canale d’Entrecasteaux che separa la Tasmania dall'isola Bruny, dove gettano l'ancora. Il giorno dopo incontrano per la prima volta un gruppo di aborigeni. Iniziano a mappare accuratamente le coste sud-orientali dell'isola. Il 18 gennaio gettano l'ancora nella Great Oyster Bay, sulla costa occidentale di Maria Island. Qui muore e viene sepolto Maugé, che non si è mai ripreso; è un grave colpo per il comandante che con lui perde l'ultimo compagno della Belle Angelique e forse l'unico amico. Il 27 febbraio le due navi lasciano l'isola e fanno rotta a nord per continuare la ricognizione della costa orientale della Tasmania. Il 6 marzo un canotto con il geografo Boullanger, l'aspirante Maurouard e sei marinai è incaricato di rilievi più ravvicinati, ma a causa del cattivo tempo perde il contatto con il Géographe; tre giorni dopo, è recuperato dal brigantino inglese Harrington, che porta i francesi a bordo del Naturaliste, il quale a sua volta ha perso di vista l'altra nave. Come in precedenza, anche questa volta tutti i punti d'incontro verranno mancati, a partire da quello di Waterhouse, dove le due corvette passano il 19 marzo, a poche ore di distanza, senza riuscire a vedersi a causa della nebbia. Non si incontreranno più fino a Port Jackson (Sidney). Dopo qualche giorno di tempo tempestoso, Hamelin riprende i rilievi della costa orientale della Tasmania; ne parte il 7 aprile, e dopo aver fissato la posizione del Wilson Promontory e mappato la costa di Western Port, essendo a corto di viveri e acqua, fa rotta per Port Jackson dove getta l'ancora il 26 aprile. Ne riparte il 18 maggio, ma non avendo potuto doppiare la Tasmania a causa del cattivo tempo, vi rientra il 28 giugno. Invece Baudin, navigando verso nord, il 27 marzo ha raggiunto il Wilson Promontory e ha proseguito esplorando da est a ovest la costa meridionale dell'Australia. L'8 aprile si vede arrivare incontro un'altra nave: pensa si tratti del Naturaliste, invece è l'Investigator di Matthew Flinders: ovviamente, il capitano inglese sa benissimo che i francesi potrebbero essere da queste parti, e a ogni buon conto ordina di armare i cannoni, ma fa anche issare la bandiera bianca. I due capitani ignorano che pochi giorni prima (il 25 marzo) è stata firmata la pace d'Amiens; per quanto ne sanno, i loro paesi sono in guerra. Ma dopo tutto comandano una missione scientifica. L'Investigator affianca il Géographe e Flinders sale a bordo, i due capitani si salutano cordialmente e scambiano informazioni sulle loro rispettive scoperte. Un secondo incontro si avrà il mattino dopo. Il punto d'incontro (a 5 miglia dalla costa meridionale dell'Australia di fronte all'attuale Adelaide) sarà battezzato da Flinders Encounter Bay. Nonostante l'entusiasmo per aver incontrato un collega che stima e di cui conosce l'abilità di cartografo, Baudin è certo deluso per aver scoperto di non essere il primo ad aver mappato la costa meridionale dell'Australia, per altro solo per un breve tratto. Quindi la navigazione riprende. Poco dopo l'incontro con gli inglesi, nel golfo di St Vincent la nave è sballottata da onde così violente che Baudin lo ribattezza Golfe de la Mauvaise. Il 25 aprile il Géographe tocca le isole St Peter e St Francis, mappa la costa est della penisola Eyre, finché la scarsità di viveri e le malattie che continuano a imperversare a bordo convincono Baudin a raggiungere Port Jackson; il cattivo tempo lo costringe a prendere la rotta più lunga e difficile che contorna la Tasmania. Arriverà a Port Jackson il 20 giugno; il 28 le due corvette si riuniscono dopo quasi quattro mesi di separazione.  Ritorno: Port Jackson-Ile de France-Francia Accolti ospitalmente dagli inglesi (nonostante qualche tensione in occasione del decennale della Repubblica il 22 settembre 1802), i francesi si fermano a Port Jackson per quasi cinque mesi. A corto di uomini per le morti e le malattie, Baudin decide di acquistare una nave più piccola e più adatta ai rilievi oceanografici, la Casuarina (così chiamata dal legname usato per costruirla) e di rinviare in Francia il Naturaliste, con a bordo le carte, le memorie, le osservazioni scientifiche e le collezioni fatte nella prima parte del viaggio. A preparare le piante vive è il giovanissimo apprendista giardiniere Antoine Guichenot (sedicenne al momento della partenza, ora deve avere circa diciotto anni), l'unico rimasto dopo la defezione o la morte dei suoi quattro compagni. Nonostante i pochi anni, è solerte e capace, ed accompagna Baudin a bordo del Naturaliste per un'ultima ispezione quando il comandante vi sale per impartire a Hamelin dettagliate raccomandazioni su come trattare quel traporto tanto fragile quanto prezioso. Le tre navi lasciano insieme Port Jackson il 18 novembre; il 6 dicembre gettano l'ancora in una baia dell'isola King che appare letteralmente ricoperta di leoni marini, da cui il nome Sea Elephant Bay; agli occhi dei francesi, l'isola, con la sua vegetazione lussureggiante, la ricchezza di acqua e l'abbondanza di animali, è un vero paradiso terrestre. Péron, Lesueur, Guichenot e Leschenault, che si è riunito agli amici, sono ovviamente i più entusiasti, e vi si attardano alcuni giorni, mentre il Géographe è tenuto al largo dal cattivo tempo. Nel frattempo la Casuarina, comandata dal più giovane dei fratelli Freycinet, è stata inviata ad esplorare le isole Hunter. L'8 dicembre, mentre il Naturaliste si prepara alla partenza, arriva da Port Jackson la Cumberland, comandata dal capitano Charles Robbins, spedita dal governatore King per accertarsi che i francesi non abbiano l'intenzione di preparare un insediamento in Tasmania. Hamelin viene a sapere da uno degli uomini di Robbins che loro stessi hanno lo stesso compito, ma non ne informa Baudin. Poco dopo c'è l'addio definitivo. Il Naturaliste arriverà a le Havre il 7 giugno 1803, dopo essere stato trattenuto per breve tempo dagli inglesi a Portsmouth. Il 15 dicembre, nel corso delle manovre d'attracco nella Sea Elephant Bay, il Géographe perde una lancia. Riuscirà ad ancorarsi e a recuperare i naturalisti solo il 25 dicembre. Due giorni dopo si riunisce con la Casuarina e i due vascelli procedono insieme fino all'isola dei Canguri (scoperta l'anno prima da Flinders), di cui cartografano la costa meridionale. Quindi la Casuarina va ad esplorare i golfi St Vincent e Spencer, mentre il Géographe è all'ancora all'Eastern Cove, con gli uomini impegnati nella costrizione di una nuova lancia; ne parte il 1 febbraio 1803 e fa vela verso ovest; alle due è segnalata, in direzione opposta, la Casuarina: Freycinet non vira per seguire il comandante, e le due navi rimarranno separate per due settimane. Raggiunta la costa del continente nei pressi di Streaky Bay, il 7 febbraio il Géographe getta l'ancora a Denial Bay; durante la sosta di quattro giorni per i rilievi cartografici, i naturalisti hanno modo di incrementare le loro raccolte. Intanto la Casuarina ha visitato alcune delle isole Nuyts, per poi dirigersi verso il King George Sound, dove il 17 febbraio le due navi si riuniscono. L'area viene attentamente mappata, permettendo di nuovo ai naturalisti di scendere a terra. E' forse il luogo dove Guichenot e Leschenault fanno le raccolte più abbondonati. Il 20 febbraio, il sotto-luogotenente Ransonnet, che sta esplorando un tratto di costa, incontra la nave baleniera americana Union il cui comandante il giorno dopo fa visita a Baudin; in ricordo di questo incontro, la baia verrà denominata Two People Bay. Il 1 marzo la spedizione lascia il King George Sound, per doppiare il capo Leuwen e risalire la costa occidentale dell'Australia. Le due navi si perdono ancora una volta di vista, finché il 13 marzo si ritrovano alla Rottnest Island, fissata come punto d'incontro. Proseguono insieme fino a Shark Bay, dove Péron, Lesueur e Guichenot fanno notevoli raccolte, quindi esplorano la costa dal North-West Cape a un gruppo di isole, ribattezzato Bonaparte Archipelago. Alla fine di aprile, Baudin, già assai malato di tubercolosi, decide di dirigersi a Timor, per caricare acqua e rifornimenti. Vi arrivano il 6 maggio e ne ripartono il 3 giugno; Leschenault, anch'egli gravemente malato, viene lasciato a terra. Le due navi si dirigono a sud est, per iniziare la ricognizione della costa settentrionale dell'Australia, che esplorano fino all'altezza dell'isola Melville; il 5 giugno Bernier muore per una febbre contratta a Timor. L'equipaggio è sfinito, l'acqua sempre più scarsa, il comandante quasi in fin di vita: il 7 luglio, si rassegna a mettere fine alla spedizione e a tornare in Francia via Mauritius. Il Géographe vi arriva il 7 agosto, seguito il 12 dalla Casuarina, da cui era stato separato per l'ennesima volta da una tempesta. Il 16 settembre Baudin muore e viene sepolto con gli onori dovuti al suo rango, ma poco rimpianto dai suoi uomini. La Casuarina viene disarmata e venduta; uomini, attrezzature e raccolte vengono trasferite sul Géographe, che affronta l'ultimo tratto di viaggio sotto il comando di Pierre Bernard Milius. Nel maggio 1802 il secondo di Hamelin era stato lasciato malato a Port Jackson. Prima dell'arrivo del Géographe e del ritorno del Naturaliste, si era imbarcato per Canton e da qui nel febbraio 1803 aveva raggiunto l'Ile de France. Tra gli ufficiali della spedizione, è il più anziano, per questo viene preferito (con grande disappunto di quest'ultimo) al secondo di Baudin, Henri de Freycinet. Con un grande carico di collezioni portate da Timor e dalla Nuova Olanda o procurate in loco, il Géographe lascia il porto di Saint Louis il 16 dicembre, per terminare il suo viaggio a Lorient il 25 marzo 1804. Altre piante vengono aggiunte durante lo scalo al Capo di Buona Speranza.  Bilancio: disastro o successo? Il disastro umano, con la morte del comandante, di metà dei membri dell'équipe scientifica e di un decimo dell'equipaggio (una percentuale per altro non inconsueta nei viaggi oceanici dell'epoca) ha finito per eclissare i risultati geografici e scientifici della spedizione, che furono notevolissimi ma rimasero poco noti perché molto parzialmente pubblicati. Lo scopo principale della missione, rilevare le coste sud, ovest e nord dell'Australia, visitando le aree ancora ignote e rettificando le carte, era stato raggiunto almeno per la costa est della Tasmania, la costa ovest e ampi tratti della costa meridionale dell'Australia. A sancire questi risultati, la pubblicazione nel 1811 della cosiddetta "carta di Freycinet", inclusa nella seconda parte dell'Atlante storico che accompagna la relazione ufficiale del viaggio, scritta da Péron e Louis de Freycinet. Tuttavia, la spedizione di Baudin si intrecciò con quella di Flinders, con uno strascico di polemiche sulla priorità delle scoperte tra francesi e britannici che oscurò in parte anche questo successo. Per le scienze naturali, i contributi maggiori riguardano la zoologia e l'antropologia, e si devono alla stessa persona, François Péron. Con la defezione di Bory de Saint Vincent e Dumont e la morte di Levillain e Maugé, questo giovane allievo di Cuvier (aggregato alla spedizione soprattutto per le ricerche antropologiche), divenuto il solo zoologo della spedizione, dovette estendere il suo campo d'indagine alla biologia marina (il suo settore d'elezione), alle osservazioni metereologiche e all'intera fauna, Era un vero personaggio romantico (basti pensare che si era imbarcato in seguito a una delusione amorosa), con un carattere focoso e appassionato, ambizioso e ribelle che, spinto dal suo zelo di conoscenza, spesso si trovò in conflitto con Baudin. Preso dalla foga dell'esplorazione, tendeva a trascurare ogni prudenza e ad allontanarsi rischiando di perdersi e di ritornare ormai esausto e sulla soglia della disidratazione. Una di queste imprese (che ebbe come teatro la penisola della Shark Bay che oggi porta il suo nome e ospita il François Péron National Park) portò all'esasperazione il capitano Baudin che il 19 marzo 1803 scrisse sul giornale di bordo: "E' la terza scappata di questa natura che combina il nostro colto naturalista, ma sarà anche l'ultima, perché non gli permetterò più di scendere a terra, a meno che io stesso sia sulla stessa barca". Con l'aiuto dei disegnatori Lesueur e Petit, Péron mise insieme una collezione di 100.000 esemplari di 4000 specie diverse di cui 2500 nuove per la scienza. Impegnato nella stesura della relazione ufficiale della spedizione e morto pochi anni dopo il ritorno in Francia (durante la spedizione anche lui si era ammalato di tubercolosi), non poté catalogare e pubblicare le sue raccolte, che tuttavia diedero un contributo fondamentale alla conoscenza della fauna australiana, di cui poterono usufruire Lamarck e gli autori del Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle. Molto importanti anche le sue osservazioni antropologiche, soprattutto sui popoli aborigeni della Tasmania, che di lì a pochi anni sarebbero stati quasi totalmente sterminati dalle malattie e da una guerra genocida. Di fronte all'immensità delle collezioni del prorompente zoologo, quelle botaniche sembrano passare in secondo piano; anch'esse non furono pubblicate né dell'unico botanico sopravvissuto, Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (tornato in Francia solo nel 1807) né da La Billardière, cui furono affidate come esperto di flora australiana. In realtà, erano di notevole importanza e hanno lasciato una traccia tangibile nel paesaggio francese (e non solo). Secondo Antoine Laurent de Jussieu, l'erbario messo insieme da Riedlé, Sautier, Guichenot e Leschenault conteneva non meno di 1500 specie, in numerosi esemplari, preparati e conservati in modo eccellente. Come abbiamo visto, Riedlé morì durante il primo scalo a Timor e Sautier ebbe la stessa sorte durante la navigazione verso la Tasmania; così tutto il lavoro botanico ricadde sui due più giovani e inesperti, Guichenot sul Géographe e Leschenault sul Naturaliste. Si deve certamente a loro il grosso delle raccolte botaniche che riempivano le stive e il ponte del Naturaliste nel suo viaggio di ritorno e, secondo una testimonianza dell'epoca ammontavano, a più di mille pacchi di semi e cinquantacinque casse di piante; c'erano inoltre 3.560 esemplari d'erbario, raccolti da Riedlé, Leschenault e Maugé, ben impacchettati in 14 casse. Ancora maggiori le raccolte della seconda parte della spedizione, in cui i due poterono lavorare fianco a fianco; contando anche gli esemplari caricati all'Ile de France e al Capo di Buona Speranza, si trattava di 63 casse o mezzi barili con più di mille piante vive, cui vanno aggiunte due casse di semi e cinque casse di esemplari d'erbario. Durante il lunghissimo viaggio verso l'Europa, ovviamente le piante vive ebbero molto a soffrire. Thouin, che visitò il Naturaliste poco dopo l'arrivo della nave a Le Havre, dovette tristemente constatare che su circa 800 individui raccolti tra Timor e la Nuova Olanda, forse venti davano ancora segni di vita, e non più di 12 o 15 sembravano in buona salute; tutti gli altri erano morti per mancanza d'acqua o erano stati distrutti dai ratti che infestavano la nave. Un inventario redatto qualche mese dopo, cita tra le piante sopravvissute qualche albero da frutto cinese imbarcato all'Ile de France e sette piedi di Phormium tenax. Alcuni semi contenuti nelle balle di terra, fatte prudentemente trasportare al Museum, germinarono: erano graminacee e alcune specie dei generi Opercularia, Mimosa, Casuarina. Ventenat, nel suo splendido catalogo del giardino della Malmaison (cui, secondo le disposizioni di Napoleone, era destinato il meglio delle raccolte), cita espressamente quattro piante nate da semi trasportati dal Naturaliste: quella con cui volle incensare la neo-imperatrice Josephinia imperatricis (oggi Sesamum imperatricis), Apium prostratum, Hibiscus heterophyllus e Callistachys lanceolata. Il ricco carico del Géographe, che, anziché essere lasciato a se stesso, poté godere delle cure di Guichenot, ebbe sorte migliore, ma molte piante morirono per il freddo e le piogge incessanti in cui la nave incappò alla latitudine di Bordeaux. Ne sopravvissero circa 230; 98 tra le specie più sane furono scelte da Mirbel, il sovrintendente della Mailmaison, per le serre dell'imperatrice. Alcune furono poi moltiplicate per essere acclimatate nella Francia meridionale, soprattutto a Tolone e Nizza. Tra queste ultime, varie specie dei generi Ecalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, Acacia, tra cui la più nota di tutte, A. dealbata, ovvero la mimosa, che fiorì per la prima volta alla Malmaison nel 1811. Dunque, da molti punti di vista, un successo. Ma non quello che Napoleone avrebbe voluto: la gloria di aver mappato per primi le coste australiane era venuta meno e c'erano troppi morti e troppi errori da occultare. Farlo era semplice: attribuire tutto il buono a ufficiali, cartografi e scienziati, tutto il cattivo al capitano Baudin. Che essendo morto, non poteva difendersi. Un aneddoto vuole che, al rientro della spedizione, Napoleone abbia esclamato: "Baudin ha fatto bene a morire. Altrimenti l'avrei fatto fucilare". E' certamente apocrifo, ma rende bene l'idea. I primi a spargere maldicenze sul capitano erano stati ovviamente alcuni dei transfughi di Mauritius, desiderosi di attribuire la responsabilità della loro defezione a Baudin, raffigurato come incompetente, tirannico, vendicativo, nonché corrotto. Il colpo di grazia gli fu inferto dal resoconto ufficiale,Voyage de découvertes aux terres australes: exécuté par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goëlette le Casuarina, pendent les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, scritto da François Péron e completato da Louis de Freycinet. Come si vede fin dal titolo, Baudin è sparito. Infatti Péron evita di nominarlo se non in modo indiretto (notre commandant) e non esita a denigrarlo, spesso alterando i fatti; inoltre, per compiacere Napoleone, spesso e volentieri attribuisce nomi francesi a luoghi già scoperti dagli inglesi: così la costa sud-est dell'Australia diventa Terre Napoléon; in seguito alle proteste inglesi, queste denominazioni verranno cancellate nell'edizione definitiva del 1815, curata da Freycinet. Se le radici dell'astio dell'aristocratico Freycinet, che insieme al fratello maggiore più volte si era scontrato con Baudin, sono chiare, perché Péron si prestò? Alcuni parlano di vecchie ruggini, altri di ambizione, ma forse la spiegazione più convincente è che capitano e zoologo non potevano intendersi perché incarnavano due modi di concepire il sapere: Baudin (e i suoi raccoglitori Levillain, Maugé e Riedlé) quello dell'enciclopedismo settecentesco, Péron (e in qualche senso Leschenault) quello della specializzazione dei saperi. Purtroppo per Baudin, l'operazione riuscì perfettamente e la sua spedizione fu nota al mondo attraverso il resoconto alterato di Péron e Freycinet. Solo in tempi recenti, la pubblicazione dei diari di bordo, il confronto tra le testimonianze e le ricerche di archivio hanno cominciato a rendergli giustizia. Determinante è stata anche la mostra The Art of Science: Baudin’s Voyages 1800–1804, a cura del National Museum of Australia (30 marzo-24 giugno 2018), con molti materiali prestati dal Muséum d’histoire naturelle di Le Havre, tra cui i disegni e le splendide tavole di Lesueur per l'Atlas che accompagnava il resoconto ufficiale. Di notevole interesse anche il sito The Baudin Legacy project, a cura dell'Università di Sidney.  Epilogo: omaggi botanici La spedizione ha lasciato una notevole traccia nella nomenclatura botanica; tra i suoi membri, almeno una dozzina sono stati onorati dalla dedica di un genere botanico, anche se alcuni di loro lo hanno guadagnato in circostanze precedenti o successive. E' il caso ovviamente di André Michaux, che da tempo si era conquistato questo alloro con i suoi viaggi in Oriente e in America. Meriti successivi lo assicureranno agli altri transfughi di Mauritius Jean-Baptiste Bory de St Vincent e Jacques Delisse, che meritano un post a parte, così come Louis de Freycinet e Jean-Baptiste Leschenault de La Tour, per i quali il Viaggio nelle terre australi fu il preludio ad altre avventure. Generi oggi ridotti a sinonimi sono toccati sia a Baudin (ne ho già parlato qui) sia al comandante del Naturaliste Jacques Félix Hamelin des Essarts; ma forse quest'ultimo deve il genere Hamelinia (Asteliaceae, sinonimo di Astelia), dedicatogli nel 1832 da Achille Richard, soprattutto alle sue successive imprese militari, grazie alle quali divenne barone dell'impero; come eroe delle guerre napoleoniche, il suo nome figura sull'Arc de Triomphe, il solo di un ufficiale navale. Allo stesso modo, non fu solo la solerzia con cui trasportò in un porto francese le piante e gli animali della spedizione Baudin ad aver fatto guadagnare il genere Miliusa all'ultimo comandante del Géographe Pierre Bernard Milius (1773-1829). Egli fece infatti una notevole carriera amministrativa. Dal 1818 al 1821 fu governatore della Réunion (all'epoca ancora Ile Bourbon), dove intraprese molte iniziative come la costruzione di un canale e di strutture portuali e la fondazione del Collège Royal de Borbon e della Société philotechnique de Bourbon. Interessato alle arti e alle scienze, incoraggiò l'esplorazione botanica di Nicolas Bréon, il fondatore e primo direttore del Jardin du Roi dell'isola; in contatto epistolare con Leschenault de La Tour, che all'epoca si trovava in India, favorì e incoraggiò in ogni modo l'importazione di piante indiane a Bourbon. Al suo ritorno in Francia, portò con sé una pianta allora rara originaria del Madagascar, e ne donò tre esemplari all'orto botanico di Bordeaux, sua città natale. Si tratta dell'oggi notissima "spina di Cristo", ovvero Euphorbia milii, che lo celebra nell'epiteto (in cui il suo cognome francese è curiosamente declinato come se fosse una parola latina). Tra il 1823 e il 1825 fu governatore della Guaiana. Nel 1827, al comando del Scipion, si segnalò alla battaglia di Navarino, Il genere Miliusa gli fu dedicato a Alphonse de Candolle sulla base di un esemplare raccolto in India da Leschenault. Appartenente alla famiglia Annonaceae, comprende una sessantina di specie di alberi o arbusti eretti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e l'Australia settentrionale, con centri di diversità in India e in Tailandia. Diverse specie sono utilizzate nella medicina tradizionale: ad esempio M. balansae per le gastropatie, M. velutina come tonico e afrodisiaco, M. thorelii come analgesico. Veniamo ora ai naturalisti. A François Péron sono stati dedicati due generi Peronia, nessuno dei quali oggi accettato. Nel 1811, quindi poco dopo la sua morte, Delaroche, autore dei testi del celebre volume di Redouté Les liliacées, gli dedicò Peronia stricta, che era fiorita proprio quell'anno per la prima volta al Museum national da semi di origine ignota venuti dall'Inghilterra; la pianta fu poi identificato come Thalia dealbata. Nel 1832 volle ricordarlo anche Robert Brown, che era diventato buon amico di Péron e Leschenault durante lo scalo a Port Jackson; Peronia R.Br. è oggi sinonimo di Sarcosperma. Sono stati giustamente onorati tutti e tre i giardinieri che rimasero con Baudin, a cominciare dal capo giardiniere Anselme Riedlé (1765–1801); allievo di Thouin formato al Jardin des Plantes, aveva già preso parte alla spedizione della Belle Angélique. conquistandosi l'amicizia e la stima di Baudin. Durante la spedizione fu attivissimo, facendo raccolte sia a Tenerife sia negli scali lungo la costa occidentale dell'Australia, dove raccolse semi, esemplari d'erbario e piante vive. In questa fase, fu un maestro e un punto di riferimento non solo per i suoi due aiutanti, ma per lo stesso Leschenault che in precedenza non aveva quasi esperienza di raccolte sul campo. Purtroppo fu vittima della dissenteria che colpì la spedizione a Timor; fu sepolto con tutti gli onori nel cimitero di Kupang accanto alla tomba in cui riposava David Nelson, il botanico dello sventurato viaggio del Bounty. Baudin disegnò personalmente la sua tomba, ma non poté presenziare alle esequie, essendo a sua volta malato. Anche a lui furono dedicati due generi Riedlea oggi non riconosciuti: nel 1802 da Mirbel (sinonimo di Onoclea) e nel 1807 da Ventenat (sinonimo di Melochia). Ammalatosi anche lui a Timor come il suo capo, ben presto ne seguì la sorte l'assistente giardiniere Antoine Sautier (ca. 1771-1801); nato a Parigi, probabilmente lavorava anche lui al Museum e aveva 29 anni al momento della partenza. Decaisne, che nel 1834 gli dedicò Sautiera, oggi sinonimo di Dyscoriste, lo ricorda per "lo zelo, con il quale arricchì il Museo di un gran numero di oggetti nuovi". L'unico genere valido è toccato al solo sopravvissuto, il "garzone giardiniere" Antoine Guichenot (1783-1867). Figlio di un militare che prestava servizio alla Menagerie del Jardin des Plants e della responsabile delle sementi, era praticamente nato del giardino, ma al momento dell'ingaggio non aveva pressoché esperienza di erborizzazioni sul campo. Era quasi illetterato (le sue note d'erbario sono scritte con un'immaginifica ortografia fonetica), ma era un lavoratore instancabile e un grande osservatore, tanto che le sue note sono spesso più dettagliate di quelle dello stesso Leschenault. Va certamente a lui gran parte del merito della raccolta (per non parlare della conservazione in vita) delle piante vive del Géographe. Baudin, che ne apprezzava la dedizione e lo zelo, gli dedicò Guichenault Point, un promontorio della penisola Péron nella Shark Bay. Dopo il ritorno a Parigi, Guichenot tornò a lavorare come giardiniere al Museum; poco sappiamo sulla sua vita, eccetto alcuni aneddoti raccolti in un articolo comparso nel 1861 sul Bulletin de la Societé imperiale zoologique d'acclimatation. Dopo aver informato i lettori che all'epoca Guichenot si era stabilito a Couets nei pressi di Nantes, l'autore M. Pépin riferisce che, benché si trovasse in una situazione difficile, in seguito alla morte del padre e di due fratelli, lo scrupoloso giardiniere resistette "alle offerte più seducenti" rifiutando di vendere sottobanco i semi di una Banksia per cui un botanico inglese gli offriva 25 franchi il pezzo nonché una rara conchiglia di cui aveva raccolto numerosi esemplari. Nel 1814 fu decorato con l'ordine del giglio. Forse fu il padre dello zoologo del Museum Alphonse Antoine Guichenot, che risulta figlio di un giardiniere della stessa istituzione. E' invece infondata e dovuta alla confusione con Gaudichault, il botanico della spedizione, la notizia che abbia preso parte al viaggio dell'Uranie al comando di Freycinet. La dedica del genere Guichenotia da parte di Jacques Étienne Gay (1821) appare quanto mai azzeccata e opportuna. Si tratta infatti di un genere australiano, di cui il giovane giardiniere, insieme a Riedlé e Leschenault, raccolse la prima specie conosciuta, G. ledifolia, nel 1801 durante il primo passaggio della spedizione a Shark Bay. Oggi assegnato alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), è affine ai generi Thomasia, Lysiosepalum e Lasiopetalum, comprende 16-17 specie di arbusti endemici dell'Australia occidentali. Adattati all'estrema aridità di questa regione, hanno foglie lineari e coriacee e graziosi fiori a campanella. Quelli di G. macrantha, la specie più nota e coltivata, negli Stati Uniti sono commercializzati come Aussie Bells, "campanelle australiane". Per accattivarsi il favore di sovrani, uomini politici e potenti, da cui dipendevano finanziamenti e incarichi prestigiosi, i botanici sono stati prodighi di dediche di generi, spesso scelti tra i più vistosi. Non fa eccezione neppure Napoleone, che anzi ha collezionato ben tre dediche. Ad aprire la lista sono gli spagnoli Ruiz e Pavón che già nel 1802 intitolano all'allora primo Console Bonapartea. Niente di strano: i due non andavano tanto per il sottile con le dediche, e le elargirono generosamente ai potenti di turno, adattandosi di volta alla linea politica del momento; all'epoca, la monarchia spagnola era alleata con la Francia e si trattava di ingraziarsi, più ancora che lo stesso Napoleone, il ministro filofrancese Godoy (lui stesso dedicatario di Godoya). Nel 1804, l'anno in cui Bonaparte si autoincorona imperatore, arriva un omaggio ben più sorprendente: il botanico Palisot de Beauvois, un nobile vittima della rivoluzione, battezza pomposamente Napoleonaea imperialis un singolare alberello da lui scoperto in Africa. Il personaggio è tale che la dedica non può essere liquidata come plateale adulazione, e vale la pena di approfondire. Non stupisce (tranne che nel nome) che lo stesso anno Ventenat, che al momento era nel libro paga di S. M. l'Impératrice, abbia voluto metterci anche del suo con Calomeria. E poi, tutto sommato, i meriti di Napoleone agli occhi degli scienziati, inclusi i botanici, non erano pochi. 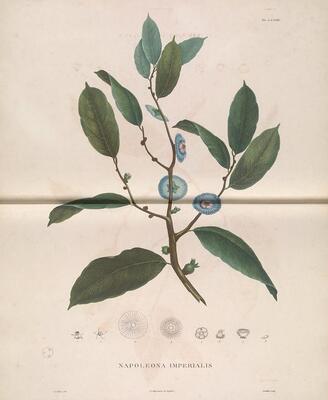 Un'adulazione smaccata? Il due dicembre 1804, con un gesto clamoroso, Napoleone Bonaparte incoronò se stesso Imperatore dei francesi. Culminava così un lungo processo, iniziato il 18 maggio, quando il Senato aveva mutato la costituzione trasformando la Repubblica in impero ereditario; immediatamente dopo la decisione era stata sancita dal plebiscito i cui risultati furono proclamati il 6 novembre: risultati ovviamente... plebiscitari, con 99,76% di voti favorevoli e solo 2569 contrari. In mezzo a queste date, il botanico Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois allestì la sua personale corona per Napoleone: una corona di petali (o almeno luio credeva così), quelli di una pianta che aveva raccolto in Africa. Dopo averla preannunciata in una seduta dell'Institut de France di ottobre, pubblicò scoperta e dedica verso la fine di dicembre, a incoronazione avvenuta, nell'opuscolo Napoléone impériale: Napoleonaea imperialis. E' una esplicita scelta di campo, dal significato eminentemente politico; il sottotitolo "Primo genere di un nuovo ordine di piante: le Napoleonée" non lascia dubbi. Napoleonaea inaugura una nuova famiglia di piante, esattamente come Napoleone inaugura un regime senza precedenti e una nuova dinastia: "Per essere un re si devono ereditare vecchie idee e genealogie. Io non voglio discendere da alcuno." Come dobbiamo leggere la plateale dedica di Palisot de Beauvois? E' la più smaccata delle adulazioni? O l'espressione di un entusiasmo reale, del resto condiviso - al netto della propaganda e della repressione - da una grande maggioranza di francesi? Certo non possiamo escludere l'interesse. All'epoca Palisot de Beauvois versava in una situazione economica molto difficile. Un tempo ricco possidente terriero, era stato rovinato dalla rivoluzione, da un amministratore incapace (o piuttosto interessato e disonesto) e da un divorzio; tornato in Francia dopo una serie di viaggi avventurosi e un lungo esilio, aveva in programma di pubblicare degnamente le sue scoperte in una serie di opere illustrate, corpose e costose: la sua Flore d'Oware et de Benin incominciò ad uscire proprio nel 1804; l'anno successivo seguì il primo volume di Insectes recueillis en Afrique et en Amérique. Cerro sperava anche che l'appoggio di Napoleone e dei suoi corifei scientifici gli garantisse l'ammissione come membro effettivo (con tanto di stipendio) dell'Institut de France (che aveva incorporato l'Accademia delle scienze), di cui era da tempo membro corrispondente. Eppure, a leggere le biografie e le testimonianze su Palisot de Beauvois, il tipo di cortigiano leccapiedi non sembra calzargli affatto (al contrario di tanti anche più famosi colleghi, a cominciare da Laplace). Nobile, durante la rivoluzione si era trovato proscritto e privato di tutti i suoi beni ed aveva potuto rientrare in Francia solo alla fine del 1798, quando il suo nome era stato cancellato dalle liste degli emigrati (un provvedimento che anticipa l'amnistia generale concessa da Napoleone primo console nel 1802). Di Napoleone certamente apprezzava la politica di conciliazione nazionale, ma anche di ritorno all'ordine dopo gli eccessi rivoluzionari. Feroce difensore dello schiavismo, che per le proprie posizioni aveva rischiato di essere messo a morte durante la rivolta di Haiti, gradiva particolarmente che egli avesse ristabilito la schiavitù nelle colonie, a suo parere follemente abolita dai rivoluzionari. Dunque, la dedica riflette probabilmente l'adesione al progetto politico di Napoleone, che rimarrà costante e sincera anche in tempi difficili, come conferma un fatto inequivocabile: nel 1815, durante i Cento giorni, il traballante Napoleone si fidava tanto della sua fedeltà che lo nominò consigliere per l'Università. 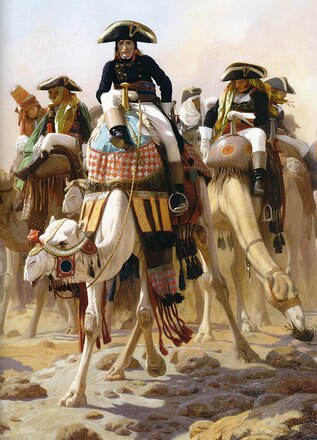 Napoleone e la scienza Oltre a considerazioni di ordine più generale, avrà pesato anche la politica culturale del nuovo imperatore che aveva fatto della scienza un importante tassello della sua propaganda e aveva valorizzato il ruolo politico e sociale degli scienziati, tanto che Eric Sartori ha definito quello napoleonico "l'impero delle scienze". Lo era, secondo lo studioso francese, da tre punti di vista: il dominio scientifico a livello europeo; la formazione e la passione scientifica dell'imperatore stesso; il ruolo politico assegnato all'élite scientifica. Quanto al dominio scientifico, la Parigi napoleonica è indubitabilmente la capitale della scienza: Laplace rivoluziona l'astronomia, i vari Berthollet, Fourcroy, Gay-Lussac portano avanti la rivoluzione della chimica inaugurata da Lavoisier, l'abate Haüy studia la struttura dei cristalli, Daubenton e Lacépède proseguono l'opera di Buffon, Fourier fa avanzare l'analisi matematica, Cuvier getta le basi della paleontologia, Lamarck e Saint-Hilaire preparano l'evoluzionismo. Parlando poi di Bonaparte, l'interesse per la scienza è una costante della sua vita, da quando ragazzo era considerato il migliore matematico della scuola militare fino all'esilio di Sant'Elena, quando riempiva le giornate leggendo la Storia naturale di Buffon, il trattato di astronomia di Delambre o il corso di chimica di Fourcroy (gli ultimi due, per altro, pubblicati grazie a lui). Veniamo al terzo punto, anche se nel breve spazio di un post dovremo limitarci a qualche cenno. Già durante la Campagna d'Italia Napoleone intraprende una vera propria opera di seduzione verso gli scienziati, chiamati a sostituire le vecchie classi dirigenti e a formare una nuova élite fondata non sul sangue e sul privilegio, ma sul talento e il sapere. A Milano, frequenta artisti, letterati e scienziati, invita alle propria tavola Volta e Spallanzani, incoraggia gli scienziati ad assumere un nuovo ruolo sociale: "A Milano gli scienziati non godono della considerazione che spetterebbe loro. Ritirati nel fondo dei loro laboratori, si ritengono fortunati se i re e i preti si limitano a non offenderli. Ma oggi non è più così: in Italia il pensiero ora è libero. Non ci sono più né Inquisizione, né intolleranza, né despoti. Invito gli studiosi a riunirsi e ad espormi le loro idee sui mezzi da adottare, o sui bisogni che emergeranno, per dare alle scienze e alle arti una nuova vita e una nuova esistenza. Tutti quelli che vorranno venire in Francia saranno accolti con distinzione dal governo. Il popolo francese valuta molto di più l'acquisizione di un matematico [...] che la conquista della città più ricca e più popolosa". Ovviamente questi proclami democratici fanno da paravento alla spogliazione del patrimonio culturale italiano; in nome della fratellanza e della libertà, a prendere la via di Parigi non sono solo quadri e statue, ma anche biblioteche intere, collezioni scientifiche, erbari e piante vive (attese con trepidazione da sua moglie Joséphine, grande appassionata di piante e giardini). Tra i "commissari governativi" che dirigono la spogliazione ci sono il grande matematico Monge (uno degli insegnanti di Napoleone alla scuola militare) e il chimico Berthollet; entrambi si legano a Bonaparte e nel 1797 ne propongono la candidatura all'Institut de France per la sezione meccanica. L'elezione del brillante generale, che non ha scritto una riga né di meccanica né di altre scienze al contrario dei candidati sconfitti, è tutta politica, primo atto della sua alleanza con l'establishment scientifico. Il secondo atto è la spedizione in Egitto (1798-1801); insieme ai soldati, ci sono 167 savants: disegnatori, architetti, ingegneri, geometri, cartografi, astronomi, chimici, mineralogisti, zoologi e botanici; divisi nelle quattro sezioni di matematica, fisica, economia politica, letteratura e arti, devono studiare e descrivere ogni aspetto dell'Egitto del passato e del presente: la geografia, la flora, la fauna, le risorse minerarie, l'arte, la società. A reclutarli a stato proprio Monge - assistito ancora da Berthollet e dal matematico Fourier - che li ha contattati e convinti in segreto (la missione era coperta dal segreto militare). In genere sono molto preparati, giovani, di salute robusta, ma una ventina di loro perirà durante la missione. Tralasciando gli altri settori, soffermiamoci sulle scienze naturali. Il compito dei naturalisti è redigere un catalogo completo della fauna e la flora del paese; per assolverlo lo zoologo Geoffroy de Saint Hilaire, affiancato dal pittore Henri-Joseph Redouté (fratello del più celebre Pierre-Joseph) e il botanico Alire Raffeneau-Delile intraprendono molte spedizioni, a volte lunghe e faticose, nell'alto e nel basso Egitto. Raffeneau-Delile descrive il loto e il papiro e crea un orto botanico al Cairo; un altro attivo raccoglitore è Ernest Coquebert de Montbret, che la ha sfortuna di morire ventunenne di peste il 7 aprile 1801, lo stesso giorno in cui la Commissione delle scienze e dell'arti si imbarca alla volta dell'Europa. Nel febbraio 1802 un decreto di Napoleone ormai primo console ordinerà la pubblicazione dei risultati a spese delle stato, ma a beneficio degli autori: è l'inizio della grandiosa Description de l'Egypte, che coinvolgerà 160 savants, 2000 artisti tra cui 400 incisori, si protrarrà per oltre vent'anni e comporterà nella prima edizione 19 volumi, 37 nella seconda. Ma abbiamo anticipato gli eventi. Come è noto, Bonaparte parte per Parigi nell'agosto del 1799 (insieme a lui, viaggia l'ormai inseparabile Monge); il 18 brumaio (ovvero il 9 novembre) con un colpo di stato rovescia il Direttorio e si impadronisce del potere. Per legittimare il quale, ha cura di circondarsi di scienziati e di chiamarli alle più alte responsabilità: diversi di loro, tra cui Lagrange, sono nominati senatori; Laplace diviene addirittura ministro dell'interno: grande matematico e fisico, ma amministratore incapace, sarà allontanato dopo appena sei settimane; Fourier è prefetto dell'Isère; Monge senatore, presidente dell'Institut d'Egypte e direttore dell'école polytechnique. Come si vede, tra questi notabili non c'è nessun botanico; cultore della matematica e delle "scienze dure", Napoleone non ha una gran considerazione della scienza della piante; in famiglia, la botanica era sua moglie Joséphine, come ci ricorda un aneddoto spesso ripetuto. Nel 1804, quando Humboldt ritornò dal suo grande viaggio in America latina, il neoimperatore lo ricevette e gli domandò, in tono quasi di disprezzo: "Dunque vi interessate di botanica? Anche mia moglie si occupa di piante". Forse nuoce ai botanici del Jardin des plantes (ora Muséum national d'histoire naturelle) anche il loro passato giacobino. E' vero che Antoine-Laurent de Jussieu ne mantiene la direzione che esercita fin dai tempi della Convenzione e nel 1804 è nominato professore di botanica alla facoltà di medicina e presidente della I sezione dell'Institut national, ma non riceverà mai gli onori che toccano ai colleghi fisici, chimici e matematici. Tra i naturalisti, l'uomo di Napoleone è Cuvier, segretario perpetuo dell'Institut e presidente della commissione che deve riformare l'università. Un merito di Bonaparte agli occhi dei botanici sarà stato se non altro aver finanziato la spedizione Baudin (1800-1803), quando era ancora primo console. Diretta verso le "coste della Nuova Olanda", ovvero l'Australia, aveva obiettivi geografici e cartografici, ma anche naturalistici, come ci ricordano i nomi delle due navi della spedizione, Géographe e Naturaliste. A bordo ci sono 24 tra artisti e scienziati, compresi molti membri dell'Institut de France, e cinque giardinieri, incaricati di occuparsi delle piante vive; tra i botanici, l'ormai anziano André Michaux, che però abbandona l'impresa per dissensi con il comandante Baudin, e Jean-Baptiste Leschenault de la Tour. Nonostante tante vicissitudini, compresa la morte del comandante, il successo scientifico della spedizione è straordinario: 200.000 esemplari di animali e piante vanno ad arricchire le collezioni del Muséum national e del Jardin des plantes. Piante e animali vivi raggiungono invece i giardini della Malmaison; e nelle sue serre fioriscono per la prima volta molte piante ora a tutti familiari, come Acacia dealbata, ovvero quella che siamo abituati a chiamare "mimosa". Per quanto tiepidamente interessato alla botanica, che delegava volentieri alla botanofila Joséphine, questi risultati avranno fatto piacere anche al quasi imperatore, cui non sfuggiva l'importanza dell'introduzione di nuove specie per il progresso dell'agricoltura, che considerava invece "l'anima, la base prima dell'Impero". Questo interesse pratico gli poteva derivare dall'esempio del padre, Carlo Bonaparte, che, convinto esponente della scuola fisiocratica, aveva iniziato a bonificare la tenuta delle Saline, dove aveva creato un vivaio con alberi da frutto e piante esotiche. Nel 1800, ancora all'epoca del consolato, Napoleone fece creare ad Ajaccio il primo orto botanico della Corsica, il Jardin d'Expériences. Inaugurato il 12 giugno 1801, si trovava nel recinto dell'ex convento di San Francesco, trasformato in ospedale militare, aveva una superficie di circa 6.000 metri quadri e godeva di un clima favorevole che permise l'acclimazione di piante esotiche, tra cui il tabacco. Nel 1807 con un decreto imperiale passò direttamente sotto l'amministrazione del Muséum di Parigi, ma solo nel 1812 fu dotato di finanziamenti e fu costruita una serra. Anche in seguito ebbe vita grama, con la morte per febbre perniciosa di almeno due giardinieri. Durante gli anni napoleonici, le società agricole, abolite ai tempi del Terrore, rifiorirono e si moltiplicarono. Prima la perdita delle colonie, poi le difficoltà dei commerci a lunga distanza causati dall'interminabile ciclo di guerre, infine il blocco continentale resero ancora più urgente l'acclimazione di piante esotiche anche nel territorio metropolitano o la ricerca di loro succedanei. L'esempio più noto è quello della coltivazione della barbabietola da zucchero; il metodo di estrazione fu messo a punto da un altro botanico, Benjamin Delassert. Nominato barone da un grato Napoleone, andò aggiungersi alla piccola schiera di scienziati di primo piano entrati a far parte della nobiltà dell'Impero (che, però, non dimentichiamolo, era formata per quasi il settanta per cento da militari). Per un alto numero di scienziati, però, c'erano incarichi pubblici ben rimunerati, posti di insegnamento nelle scuole secondarie (dove le scienze divennero materia obbligatoria) e all'università, premi in denaro, donazioni e vitalizi come quelli assegnati a Volta, la possibilità di pubblicare a spese dello stato, le sovvenzioni per le ricerche e le innovazioni tecniche, prime fra tutte quelle che potevano essere utili all'esercito, come il telegrafo ottico inventato da Claude Chappe.  Le dediche botaniche a Napoleone Palisot de Beauvois era stato anticipato di due anni dagli spagnoli Ruiz e Pavón che nel 1802 dedicarono al primo Console Bonapartea sulla base di una specie da loro raccolta in Perù. Erano abituati a offrire con disinvoltura le loro piante all'uomo politico di turno, e la dedica a Napoleone, intesa a ingraziarsi forse ancor più di lui il filofrancese Godoy, da poco ritornato al potere, è un capolavoro di servilismo e adulazione: "Genere dedicato a Napoleone Bonaparte, rifondatore della ricostituita repubblica francese, primo console, comandante sempre invitto, patrono della botanica, di tutte le scienze fruttuose e delle arti, difensore della religione, ripristinatore della pace in tutto il globo, uomo immortale, che rimarrà nella memoria degli uomini famosissimo per le sue gesta". E' quasi una consolazione sapere che il genere non è valido (è un sinonimo diTillandsia), mentre lo è il bel Lapageria, che i due botanici iberici dedicarono contestualmente "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Senza esprimersi in termini così smaccati, Palisot de Beauvois è non meno celebrativo. Per omaggiare il neoimperatore sceglie una pianta i cui vistosi fiori a coccarda ostentano un triplice giro di petali (più probabilmente staminoidi), che li fanno assomigliare a una corona. Non meno importante è il convincimento - confermato da Antoine-Laurent de Jussieu, amico di una vita - che la Napoleonaea non appartenga ad alcuna famiglia nota, anzi inauguri una famiglia propria. In effetti, la famiglia Napoleonaeaceae è stata a lungo accettata dai botanici, per essere poi assorbita nelle Lecythidaceae. Oggi al genere sono assegnate diciassette specie, tutte originarie dell'Africa tropicale occidentale e centrale intorno al golfo di Guinea; quelle più note sono N. imperialis e N. vogelii. Il primo è un alberello alto circa 6 metri, il secondo un albero di dimensioni maggiori; entrambi sono sempreverdi, con grandi foglie alternate obovate, e curiosi fiori che nascono sui rami maturi o direttamente sul tronco. Hanno una struttura molto complessa, che ha fatto parecchio discutere i botanici. Oltre che a una corona, possono essere paragonati a una coccarda, con due giri esterni di elementi simili a petali disposti orizzontalmente e un giro interno di venti stami e staminoidi eretti. Per alcuni botanici, anche recenti, si tratta di una vera corolla e gli elementi esterni sono petali; per altri è un fiore apetalo e si tratta di staminoidi, una tesi confortata dai dati molecolari e dal confronto con le strutture fiorali delle Lecythidaceae. In ogni, caso una struttura peculiare ed affascinante, nonché discussa e discutibile, come lo stesso Napoleone. Che lo stesso anno ricevette una seconda dedica vegetale dal botanico Etienne Pierre Ventanat, che in quel momento, per incarico di Joséphine, stava redigendo il catalogo delle collezioni del giardino della Mailmaison, una splendida opera in due volumi, con le illustrazioni di Pierre-Joseph Redouté. E fu proprio su richiesta della sua patrona che creò un terzo genere in onore dell'ormai imperatore, come racconta egli stesso: "Sua Maestà l'Imperatrice dei francesi, essendosi resa conto che la pianta di cui ho appena presentato la descrizione appartiene a un genere nuovo, ha voluto indicarmi il nome che dovevo dargli. I signori Ruiz e Pavón hanno già consacrato quello di Bonapartea nella Flora del Perù, e il signor Palissot-Beauvois quello di Napoleonaea in Flora d'Oware e del Benin; ho fatto così ricorso alla lingua greca, che ha fornito ai botanici un gran numero di denominazioni tanto espressive quanto armoniose, per obbedire al desiderio di Sua Maestà l'Imperatrice e dare a Sua Maestà l'Imperatore una modesta prova della riconoscenza che gli devono tutti coloro che coltivano le arti e le scienze". Come tutti i francesi, anche Ventenat è appena passato da cittadino a suddito, e si comporta di conseguenza. La pianta in questione è Calomeria amaranthoides, coltivata nei giardini della Malmaison dai semi giunti dall'Australia grazie alla spedizione Baudin. Il nome generico, come spiega lo stesso Ventenat, è formato da due parole greche, καλός (kalòs) "bello, buono" e μερίς (meris) "parte": dunque, Bonaparte. E' forse l'unica specie del piccolo genere Calomeria (Asteraceae), a cui vari repertori ne attribuiscono quattro, con una sorprendente distribuzione disgiunta: mentre C. amaranthoides è endemica degli stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud nell'Australia sud orientale, le altre tre vivono nell'Africa meridionale e orientale. Appaiono alquanto diverse dalla sorella australiana, e altri botanici le assegnano decisamente al genere Helichrysum. Parliamo dunque della sola specie certa. quella descritta e denominata da Ventenat. E' una perenne di breve vita solitamente coltivata come biennale, di grandi dimensioni (può superare i tre metri) e foglie intensamente profumate d'incenso. In estate produce grandi infiorescenze color amaranto simili a pennacchi. Ricordano tanto da vicino quelli inalberati sull'elmo dell'alta uniforme della Guardia Imperiale da far pensare che non si tratti di una semplice coincidenza. Prima di concludere, vale la pena di ricordare la damnatio memoriae che toccò a Napoleonaea imperialis. Nel 1814, appena caduto per la prima volta Napoleone, un altro botanico francese, Nicaise Augustin Desvaux, ritenne che quella ignominiosa dedica dovesse essere cancellata, e si affrettò a rinominare la pianta Belvisia caerulea, in onore dello stesso scopritore Palisot de Beauvois. Ma, grazie al repubblicano e antinapoleonico Augustin Pyramus de Candolle, in botanica vale la regola della priorità: Napoleonaea vive, Belvisia è un nome illegittimo. A scusante dei quattro botanici che si affrettarono a prostrarsi ai piedi di Napoleone, ricordiamo che non furono i soli a subirne la fascinazione. Come è noto, lo stesso Beethoven voleva dedicargli la sua terza sinfonia, finché proprio l'incoronazione gli aprì gli occhi. E le tre dediche vegetali sono tutte comprese tra il 1802 e il 1804, quando davvero Napoleone poteva ancora presentarsi nelle vesti di pacificatore, restauratore dell'ordine e al tempo stesso fautore del progresso e del rinnovamento sociale. Morto a 29 anni negli anni più turbolenti della rivoluzione francese, il medico alsaziano Benjamin Pierre Gloxin avrebbe lasciato ben poche tracce di sé se non fosse per la sua tesi di laurea, in cui aveva discusso alcune piante nuove e rare coltivate nell'orto botanico della sua università. Capitata nelle mani del botanico L'Héritier de Brutelle, gli guadagnò la dedica del genere Gloxinia, un nome abbastanza noto anche se la gloxinia o glossinia dei fiorai ora si chiama Sinningia. 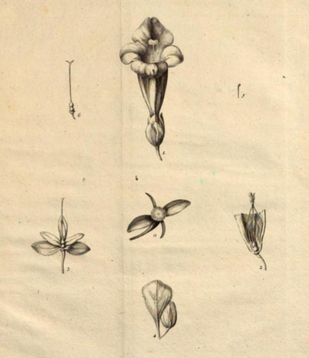 Dalle piante alla rivoluzione Discendente di una famiglia di medici, farmacisti e intellettuali di origine tedesca stabilitasi a Colmar da più di un secolo e figlio del medico cittadino, Benjamin Pierre Gloxin (1765-1794) nel 1785, ad appena vent'anni, si laureò in medicina all'università di Strasburgo discutendo una tesi di botanica. A incoraggiarlo in questa scelta fu il suo relatore, il professore Jean Hermann (1738-1800) che era anche il direttore dell'orto botanico universitario. Nella sua dissertazione Gloxin esamina alcune specie "nuove e rare" coltivate nel giardino: Salvia leonuroides (oggi Salvia formosa), Cyperus aegyptiacus (oggi Cyperus capitatus), Mesembryanthemum cordifolium e soprattutto, a partire dalle due specie di Martynia presenti nell'orto, presenta una disanima complessiva dei generi Martynia L., Craniolaria L., Proboscidea Schmidel, analizzando scrupolosamente la letteratura precedente. Giunge alla conclusione che nessun carattere distintivo saliente giustifica la separazione di questi generi e propone una nuova classificazione del genere Martynia in sei specie: Martynia perennis (oggi Gloxinia perennis), M. capensis (oggi Rogeria longiflora), M. diandra (oggi M. annua), M. craniolaria (oggi Craniolaria annua), M. proboscidea (oggi Proboscidea luisianica), M. fruticosa (oggi Gesneria fruticosa). Stampato in accuratissima veste grafica dal tipografo-editore Dannbach, il fascicolo (un in quarto di una ventina di pagine) comprende anche tre tavole calcografiche di Balz incise da Jean Martin Weis e godette di una discreta circolazione, come attestano le recensioni, le citazioni nella letteratura botanica, la presenza in collezioni pubbliche e private. A favorire la notorietà dell'operina e del suo autore fu sicuramente la quasi immediata dedica a Gloxin del genere Gloxinia da parte di L'Héritier de Brutelle nel primo fascicolo di Species novae (1785). Il genere fu istituito sulla base di una delle specie studiate dal neomedico alsaziano, M. perennis. L'Héritier rileva che essa non può essere assegnata a Martynia (l'assegnazione risale a Linneo) avendo l'ovario infero anziché supero; inoltre si differenzia da Gesneria per la corolla campanulata anziché tubolare; va dunque attribuita a un nuovo genere che egli chiama Gloxinia "in memoria del celebre amico Benjamin Petrus Gloxin, medico di Colmar, di ottimi meriti per la botanica". Certo, può sembrare curioso un simile omaggio a un ventenne esordiente, ma come si deduce dalle parole di L'Héritier si sarà trattato in parte di un attestato di stima, in parte di un gesto di amicizia. Di lì a poco, l'esistenza tanto del dedicante quanto del dedicatario - e di milioni di francesi - sarebbe stata sconvolta dalla rivoluzione. Sappiamo che il giovane medico, oltre ad essere molto impegnato nella professione (come il padre, fu medico cittadino e più tardi diresse l'ospedale), coltivava anche interessi culturali e letterari. Era membro della Tabagie litterarie, un club di lettura di impronta illuminista fondato nel 1785, possedeva una ricca biblioteca per incrementare la quale nel 1786 si recò ad Amsterdam, dal 1791 fu ammesso alla American Philosophical Society. Ma con lo scoppio della rivoluzione, si gettò animo e corpo nella lotta politica. Gloxin era un esponente della borghesia luterana che, almeno tra il 1789 e il 1793, aderì in gran parte alla causa rivoluzionaria. L'Alsazia, dopo aver fatto parte per secoli dell'impero, era stata annessa al regno di Francia da poco più di cent'anni, all'epoca del re Sole, e in virtù di una serie di trattati conservava in parte le proprie libertà e le proprie particolarità. Dal punto di vista religioso, era un caleidoscopio di fedi: cattolica, luterana, calvinista, anabattista, ebraica, senza parlare di un numero non irrilevante di intellettuali liberi pensatori. I luterani alsaziani godevano della libertà di culto, ma erano esclusi da tutti gli incarichi pubblici. Attivi nelle professioni liberali, nell'industria e nel commercio, erano una minoranza ricca e influente che si sentiva oppressa dai tentativi di imporre il cattolicesimo e dallo strapotere della chiesa cattolica e aspirava a una piena parità giuridica, come evidenziano i cahiers de doléances redatti dalla comunità per gli Stati generali. Colmar, in precedenza città libera dell'impero, era divenuta francese nel 1679, con il trattato di Nimega. Di lingua tedesca, era per due terzi luterana. Con i suoi 13.000 abitanti, era la principale città dell'Alto Reno, la regione alsaziana che abbracciò con maggior favore la rivoluzione, al contrario del cattolico e "austriaco" Basso Reno. I decreti dell'agosto 1789 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che finalmente mettevano fine alle discriminazioni, guadagnarono infatti l'adesione di buona parte dei protestanti alsaziani. Più tardi, la ricca borghesia luterana si giovò largamente dell'acquisto delle proprietà ecclesiastiche requisite come beni nazionali. Gloxin, un medico e un intellettuale molto noto in città, si schierò in prima fila, divenendo un esponente di punta del giacobinismo alsaziano. Nel 1791 fu tra i fondatori della Société des Amis de la Constitution di Colmar, di cui fu nominato presidente. La situazione, in Francia come in Alsazia, evolveva rapidamente, e in quella regione di confine si faceva sempre più tesa. Gli attriti tra le diverse confessioni religiose furono inaspriti dalla chiusura dei conventi, dalla spaccatura tra clero girato e refrattario (che non risparmiò i pastori protestanti), dalla vendita dei beni ecclesiastici; ne seguirono i primi arresti e i primi processi. Nel 1792, lo scoppio della guerra, inizialmente disastrosa per i francesi, con la concreta minaccia di un'imminente invasione della regione, esacerbò gli animi, alimentò sospetti e innescò una radicalizzazione che spinse buona parte della comunità luterana a schierarsi con i girondini e la loro "guerra ad oltranza". Tuttavia anche in Alsazia il processo e l'esecuzione del re (21 gennaio 1793) scavò un solco nell'opinione pubblica, allontanando anche molti protestanti dalla rivoluzione o spostandoli su posizioni più moderate. Tra loro non c'era il dottor Gloxin: quando la Società degli amici della Costituzione si trasformò nella più radicale Société populaire des Amis de la Liberté et de l’Égalité, egli ne divenne vicepresidente; era anche ufficiale della Guardia nazionale. Convinto che fosse possibile conciliare gli ideali cristiani e le parole d'ordine della rivoluzione, nel dicembre del 1793, quando la collegiata Saint Martin venne trasformato in tempio della Ragione, partecipò senza esitare alle cerimonie di inaugurazione. Ma ormai le sue preoccupazioni erano altre. Come direttore dell'ospedale cittadino si trovò a fronteggiare un accentuato incremento di ricoveri e decessi; tra le cause, la carestia provocata dal susseguirsi di annate di maltempo e cattivi raccolti, ma soprattutto la concentrazione in città dei soldati e dei volontari accorsi per unirsi all'armata del Reno. Fosse vaiolo, fosse tifo, fossero "febbri tifoidi", si determinò una crisi sanitaria di cui fu vittima lo stesso Gloxin che morì nei primi giorni nel 1794, ad appena ventinove anni. Una sintesi della sua breve vita nella sezione biografie.  Credevo fosse una Gloxinia, invece era... Gloxinia perennis fu la prima specie del genere a giungere in Europa; il primo a descriverla, in Hortus cliffortianus (1738), fu Linneo, che la denominò Martynia foliis serratis; mettendola a confronto con due specie di Martynia raccolte da Houstoun in Colombia e coltivate al Chelsea Physic garden (da identificarsi con M. annua e Proboscidea louisianica), insiste che si tratta di una terza specie longe alia, "totalmente diversa". Non ne conosciamo esattamente la provenienza perché egli si accontentò di indicare genericamente "cresce in America". Nel 1753 in Species plantarum le assegnò il binomiale Martynia perennis, che come abbiamo visto fu conservato da Gloxin. L'Héritier invece la rinominò Gloxinia maculata (l'eponimo linneano fu recuperato a fine Ottocento per la legge della priorità). A lungo fu anche l'unica specie coltivata nel nostro continente. Nel 1815 Joachim Conrad Loddiges, proprietario di un grande vivaio nei pressi di Londra, ricevette probabilmente da uno dei cacciatori di orchidee che aveva sguinzagliato in Brasile una magnifica specie tuberosa con grandi fiori a campana. Egli coltivava anche Gloxinia maculata (allora si chiamava ancora così) e, notando la somiglianza, la pubblicò come Gloxinia speciosa (1817). La nuova introduzione ottenne un successo strepitoso, divenne una pianta amatissima, nota a tutti semplicemente come gloxinia (in italiano, anche glossinia). Intanto, con le sempre più numerose spedizioni in Sud America, soprattutto in Brasile, stavano arrivando molte altre specie che vennero via via inserite in Gloxinia. Una fu raccolta nel 1824 dal famoso cacciatore di piante David Douglas, di passaggio a Rio de Janeiro. Inviò i semi in Europa, dove il botanico boemo Mikan la classificò come Gloxinia schottii. Ma nel frattempo qualche seme, tramite Heller, il direttore dell'orto botanico di Würzburg, era pervenuto al suo collega di Bonn, il botanico Nees von Esenbeck, un grande tassonomista che capì che questa Gesneriacea non apparteneva a nessun genere conosciuto e denominò la nuova pianta Sinningia helleri, in onore del suo capo giardiniere (1825). Ma Gloxinia speciosa continuò a chiamarsi così per un altro mezzo secolo; solo nel 1877 il botanico britannico William Philip Hiern aggiustò il tiro e mise la pretesa glossinia al suo posto, rinominandola Sinningia speciosa. Ma, ovviamente, le abitudini sono dure a morire e continua ad essere la glossinia per antonomasia, o "Gloxinia dei giardinieri". Dopo altre vicende complicate che lo hanno visto allargarsi e contrarsi, oggi al genere Gloxinia L'Hérit., famiglia Gesneriaceae, sono assegnate solo quattro specie: G. alternifolia, G. erinoides, G. perennis, G. xantophylla. Il genere è distribuito soprattutto nelle Ande dell'America centrale (dall'Honduras a Panama) e in Sud America (dal Venezuela all'Argentina); solo una specie, appunto G. perennis, raggiunge i Caraibi, una presenza che però potrebbe essere il frutto di un'antica introduzione. G. alternifolia, scoperta solo di recente, è un endemismo del Mato Grosso. L'ambiente prevalente delle Gloxiniae è la foresta a galleria, in particolare su affioramenti rocciosi. Sono erbacee di piccole dimensioni che si distinguono dai generi della stessa tribù per i rizomi squamosi, fiori bratteati riuniti in infiorescenze simili a racemi con corolla bianca, lilla, rosata o parzialmente marrone, frutti secchi privi di tricomi uncinati. La specie più comunemente coltivata è G. perennis, ma talvolta si coltiva anche G. ericoides, caratterizzata da foglie molto attraenti. Nel corso delle vicissitudini che hanno segnato la storia tassonomica di Gloxinia, ne sono stati separati anche due piccoli generi che rendono indirettamente omaggio al nostro medico rivoluzionario. Entrambi sono stati creati nel 2005. Gloxinella (H. E. Moore) Roalson & Boggan comprende una sola specie, G. lindeniana, in precedenza nota solo in coltivazione, ma recentemente riscoperta nelle Ande colombiane. E' un erbacea eretta, molto ramificata, con foglie villose con nervature chiare su fondo scuro e vistosi fiori ascellari singoli. Anche Gloxiniopsis è un genere monospecifico, limitato a G. racemosa, un endemismo colombiano. Apparentemente è piuttosto simile a Gloxinia perennis, con fiori campanulati bianchi raccolti in racemi, ma i dati molecolari ne dimostrano l'appartenenza a un genere proprio. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
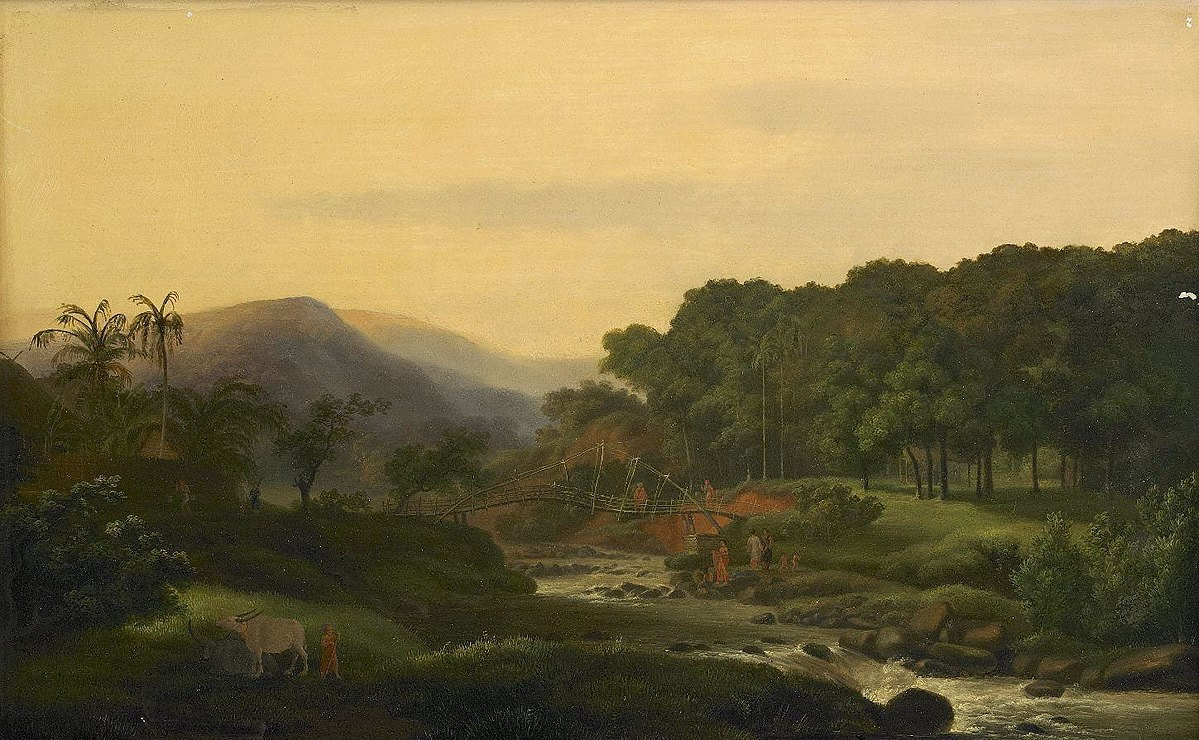


 RSS Feed
RSS Feed