|
Nei primi anni dell'Ottocento, Antonino Bivona-Bernardi esplora la flora siciliana, rinnovando alla tradizione di Boccone e Cupani. Progetta un'opera complessiva, ma sulla sua strada incontra l'ambizioso Rafinesque. Prima di perdere la priorità anche di quelle, decide allora di pubblicare almeno le specie nuove o meno note, e intensifica le ricerche sulle crittogame e le alghe, all'epoca ancora poco indagate. Molto noto in Italia e all'estero come solerte ricercatore della flora dell'isola, non ottiene però né la cattedra di botanica né la direzione dell'orto palermitano; arriva invece la nomina a ispettore generale delle Acque e Foreste che lo spinge ad approfondire gli studi di agronomia, mineralogia, geologia. Anche se non insegnò mai formalmente, è considerato almeno il maestro spirituale di diversi botanici della generazione successiva, primo fra tutti Filippo Parlatore. Oltre a diverse specie, lo ricorda il monospecifico Bivonaea, che però, a differenza di quanto credeva de Candolle, non è esclusivo della Sicilia. 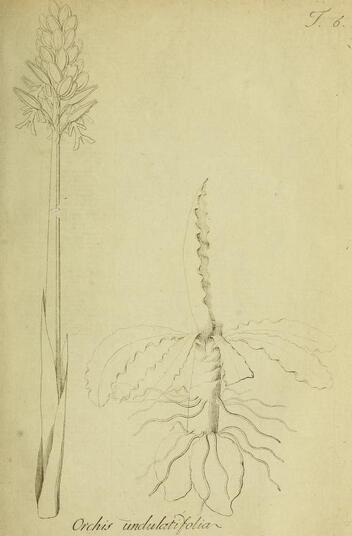 Un solerte indagatore delle piante siciliane Giunta dall'Asia, negli anni '30 dell'Ottocento una grave epidemia di colera contagiò gran parte dell'Europa. Attraverso la Francia, dove si diffuse a partire da Marsiglia nel dicembre 1834, il morbo entrò in Italia e nei due anni successivi toccò la maggior parte della penisola. Gli effetti più devastanti si ebbero nel regno delle due Sicilie. Napoli fu investita da due ondate, la prima tra l'ottobre 1836 e il marzo del 1837, la seconda dall'aprile all'ottobre 1837; assai più lunga e grave della precedente, fece una terribile strage, portando il numero delle vittime a quasi 20.000 morti. La più illustre fu il poeta Giacomo Leopardi, deceduto il 14 giugno 1837. Ancora più pesante fu il bilancio in Sicilia, raggiunta più o meno negli stessi giorni: le prime notizie del contagio a Palermo sono del 22 giugno. Rapidamente si diffuse in città grandi e piccole e imperversò per tutta l'estate. La più colpita fu Palermo, con la cifra record di 24.014 morti. Tra di essi, anche qui troviamo vittime illustri, anche se ben meno note al grande pubblico dell'autore dell'Infinito: il fisico e storico Domenico Scinà, l'economista Niccolò Palmieri e il botanico e naturalista Antonino Bivona Bernardi (1778-1837). Importante botanico, ma anche naturalista ecclettico versato in molti campi, secondo Raimondo e Not fu il "principale esponente della classe scientifica più autorevole espressa dalla Sicilia in quel tempo" (ovvero i primi decenni dell'Ottocento) e "il primo vero naturalista moderno". Egli era nato a Messina come Antonino Bernardi da genitori di origine romana. Entrambi morirono quando egli era in fasce; da quel momento a provvedere a lui fu il barone Antonino Bivona, che lo adottò come figlio. Il barone era un avvocato celebre per la sua eloquenza, e il ragazzo, dopo aver frequentato le Scuole Pie, fu avviato agli studi di legge; ma a una passo dalla laurea ottenne di passare alle scienze naturali, e in particolare alla botanica, per la quale nutriva maggiore inclinazione. A spingerlo in tal senso erano la ricchezza floristica dell'isola, gli illustri precedenti di Boccone e Cupani, la frequentazione del già magnifico orto botanico di Palermo (Goethe che lo visitò nel 1787 lo definì "il luogo più stupendo del mondo"), all'epoca diretto da Giuseppe Tineo. Egli ne seguì le lezioni all'università di Palermo e prese anche lezioni private dal suo assistente, il dimostratore Giuseppe Bartolotta. Nel 1804 affari di famiglia lo portarono a Napoli, dove conobbe i botanici partenopei Vincenzo Petagna e Michele Tenore. Continuò poi i suoi viaggi per approfondire lo studio della botanica: fu a Roma, Bologna, Modena, Pavia (dove studiò chimica, fisica e anatomia e seguì le lezioni di Volta e le conferenze di Monti), Padova, Milano, Genova, Pisa, ovunque erborizzando, visitando orti botanici ed erbari e stringendo relazioni con altri studiosi, tra cui i botanici Sebastiani, Viviani, Santi, Savi, Bertoloni. Nel 1806 una grave malattia del padre adottivo lo richiamò a Palermo. Non poté neppure rivederlo; il barone era infatti morto, lasciandolo in un pesante dissesto economico, in gran parte causato proprio dagli studi e dai viaggi del figlio adottivo. Da quel momento Bivona non si mosse più dalla Sicilia, dovendo anche provvedere a una famiglia in rapida crescita (sposatosi poco dopo il ritorno a Palermo, ebbe otto figli), e si concentrò sullo studio della flora dell'isola. Già quell'anno pubblicò una prima raccolta di piante (Sicularum plantarum centuria prima), frutto delle sue erborizzazioni nel Palermitano; quindi si recò a Catania, sull'Etna e a Messina, pubblicando i risultati nel 1807 in Sicularum plantarum centuria secunda. Ciascuna centuria contiene la descrizione di cento piante. Nella prima, corredata da 5 tavole, dieci specie sono presentate come nuove; nella seconda le tavole sono 7 e le nuove specie 5. I due fascicoli ottennero ampio riconoscimento europeo. Nelle intenzioni dell'autore, sarebbero dovuto essere il preludio a un'opera complessiva sulla flora siciliana, organizzata secondo il sistema di Linneo, ma l'arrivo in Sicilia di Rafinesque, nel timore di essere preceduto, lo spinse ad abbondonare il progetto e a pubblicare invece quattro serie di piante inedite o poco note (Stirpium rariorum, minusque cognitarum in Sicilia sponte provenientium descriptiones I-IV, 1813-1816). Nelle due ultime dedicò molta attenzione alle crittogame, che all'epoca costituivano un campo di ricerca meno battuto, così come le alghe. Tra le sue scoperte, il nuovo genere di alghe Scinaia, dedicato a Domenicò Scinà. Aspirava alla cattedra universitaria e alla direzione dell'orto botanico, ma gli furono invece preferiti Vincenzo Tineo e Giovanni Gussone. Trovandosi in ristrettezze economiche in seguito alla soppressione della carica di segretario del regno, ereditata dal padre adottivo, per provvedere alla numerosa famiglia accettò di amministrare i possessi del duca di Sperlonga. L'esperienza, che lo avvicinò alla botanica applicata e all'economia agraria, gli fu utile per ottenere nel 1820 la nomina a ispettore generale delle Acque e Foreste in Sicilia; in questo ruolo influì notevolmente sulla regolamentazione del nuovo servizio forestale e sulla legislazione riguardante l'economia dei boschi. Con gli intenti di divulgare le scienze naturali e le buone pratiche agrarie e di favorire l'incontro tra gli studiosi, nel 1822 fondò la rivista "Iride", che tuttavia dovette chiudere dopo appena un anno per mancanza di sottoscrittori. Intanto aveva allargato i suoi interessi alla mineralogia e alla geologia (con la notevole scoperta di ossa fossili di grandi mammiferi nella grotta di Maredolce e al monte Billieni), all'entomologia, con un saggio su una nuova specie di cavallette che nel 1847 devastò la Sicilia centrale, ai molluschi, di cui si proponeva di stilare un catalogo di tutte le specie siciliane. Alla sua morte era rimasto allo stadio manoscritto, così come le sue ultime fatiche botaniche, un quinto manipolo e uno studio sulle querce siciliane. Alcune piante inedite furono pubblicate dal figlio Andrea (Nuove piante inedite del Barone Antonino Bivona Bernardi pubblicate dal figlio Andrea, 1838). Il progetto di una flora del Palermitano fu invece realizzato da Filippo Parlatore che, adolescente, era suo consueto compagno di erborizzazioni nei dintorni della città. Lasciò inoltre un erbario notevolissimo sia per gli esemplari in sé sia per la perizia della loro disposizione; il catalogo fu pubblicato nel 1839 dal figlio Andrea e da Filippo Parlatore.  Bivonaea, un genere mediterraneo Gli studi di Bivona sulla flora siciliana erano ben noti sia in Italia sia all'estero, come dimostrano anche le numerose specie che gli furono dedicate: Presl gli dedicò Lupinus bivonii (oggi L. albus subsp. albus) e Genista bivonae (oggi Adenocarpus complicatus subsp. bivonae), Steudel Euphorbia bivonae, Gay Polycarpon bivonae (oggi Polycarpon polycarpoides), Gussani Colchicum bivonae e Trifolium bivonae, Todaro Orchis × bivonae. Una dedica venne persino da Rafinesque che Bivona, stando a quanto scrive il figlio Andrea, considerava il suo rivale e la sua bestia nera. Non era vero però il contrario: l'americano era grato a Bivona per avergli fatto parte delle sue scoperte e per averlo guidato ad erborizzare in varie località e, oltre a rinominare Vicia bivonae la Vicia leucantha dello stesso Bivona, nel 1810 dedicò il suo Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia al "caro e pregiato amico" don Antonino Bivona-Bernardi. Il nobiluomo siciliano è ricordato anche da due generi. Nel 1821 Curt Sprengel creò Bivonia "in onore di Antonino Bivona-Bernardi, barone di Alta Torre, botanico siciliano celeberrimo". Non accettato, è oggi sinonimo di Bernardia. Ma lo stesso anno a dedicare al nostro un genere valido aveva provveduto de Candolle con Bivonaea, scegliendo un endemismo siculo già segnalato da Cupani: "Ho dedicato questo genere che consiste in una sola specie siciliana al celebre Bivona-Bernardi, inclito successore di Cupani e solerte indagatore delle piante siciliane, che per primo tra i botanici odierni ha segnalato ed egregiamente descritto questa nuova specie". Allora come oggi, Bivonaea lutea è l'unica specie di questo genere della famiglia Brassicaceae; in passato gli sono state attribuite altre specie, poi assegnate a Ionopsidium. Cupani l'aveva pubblicata come Thlspi montanum luteum in Hortus catholicus e Bivona come Thlaspi luteum nella prima delle sue centurie. Non è però un endemismo siculo come riteneva de Candolle. È stato infatti segnalato anche per la Tunisia e l'Algeria e per la Sardegna centro-orientale (due sole stazioni nel Nuorese); in Sicilia non è comune, ma è presente in diverse stazioni sui monti calcarei del versante occidentale dell'isola. È un'erbacea annuale con foglie basali oblunghe e foglie cauline ovali, con margine profondamente dentato, ricoperte di pruina biancastra. In primavera produce infiorescenze di piccoli fiori giallo-verdi con quattro petali bilobati. Il frutto è una siliquetta con nervi trasversali evidenti. Vive in ambienti semi aridi di bassa e media montagna (fino a 1000 metri).
0 Comments
Il nome di Gabriele Falloppio probabilmente è noto anche a chi non ha particolari conoscenze né di anatomia umana, né di storia della medicina, per aver prestato il suo nome alle trombe uterine o tube di Falloppio. Egli fu infatti un grande anatomista, il primo ad aver descritto con precisione l'apparato sessuale femminile, tanto che si devono proprio a lui anche termini come placenta e vagina. Ma le sue scoperte riguardano anche molte altre parti del corpo umano, e in particolare la testa e i suoi organi. Professore prima a Ferrara, poi a Pisa, infine per un decennio a Padova, fu anche un medico ricercato da pazienti altolocati. Era un grande sperimentatore e, anche se i suoi contributi che hanno fatto la storia riguardano soprattutto l'anatomia, era un buon conoscitore dei "semplici" e aveva una notevole fama come farmacologo, tanto che dopo la sua morte precoce uno stampatore veneziano pubblicò sotto il suo nome un ricettario con 400 "segreti", sicuro che avrebbe attirato l'interesse di un vasto pubblico. Che l'opera sia davvero di Falloppio è discusso, ma è certamente un documento interessante e curioso. Non è invece certo, ma assai probabile che Adanson pensasse a lui creando il genere Fallopia, che tra le sue dodici specie annovera due piante native della nostra flora e una notissima rampicante ornamentale, forse fin troppo esuberante.  La breve vita di grande anatomista Il 9 ottobre 1562 moriva a Padova, a soli 39 anni, uno dei più illustri professori dello studio, l'anatomista Gabriele Falloppio (1523-1562). A stroncarlo fu una malattia polmonare, la tisi secondo alcuni, una pleuropolmonite secondo altri. Nato a Modena da un uomo d'arme di pessima fama morto di sifilide che lo lasciò orfano quando aveva solo dieci anni, dal padre ereditò solo una salute malferma e una situazione economica precaria che lo costrinse ad abbandonare gli studi. La famiglia lo spinse ad abbracciare lo stato ecclesiastico, contando che ereditasse il beneficio di uno zio canonico; così a 19 anni fu ordinato sacerdote, ma presto abbandonò una carriera che gli garantiva qualche entrata ma per la quale non aveva alcuna vocazione. Fin da bimbo l'aveva infatti trovata nella medicina: si racconta che a soli sei anni già annotasse mentalmente i decorsi di un'epidemia di peste. Incominciò a studiare anatomia, farmacologia, botanica da autodidatta, quindi la sua formazione proseguì nell'ambito del Collegio medico di Modena, dove divenne allievo di Niccolò Machella. Avido lettore e proprietario di una biblioteca notevole per l'epoca, Machella era un medico erudito e dalle posizioni eterodosse, uno dei principali animatori dell'accademia informale che si riuniva presso la bottega dello speziale Antonio Grillenzoni, cui partecipavano anche umanisti come il celebre filologo Ludovico Castelvetro. Gli accademici dibattevano con grande libertà e spirito critico di letteratura e scienza, ma anche - più pericolosamente - di religione, tanto che nel 1543 furono costretti a sottoscrivere un formulario di accettazione dei dogmi della chiesa cattolica. Tra il firmatari il ventenne Falloppio, accusato di essere "un pessimo eretico luterano". Falloppio si perfezionò nella dissezione di animali e raggiunse una tale abilità nel 1544 il suo maestro gli affidò la pubblica dissezione anatomica del cadavere di una giovane donna impiccata come criminale. Ottenne anche la licenza di praticare la chirurgia, ma intorno al 1545 il miglioramento della situazione economica della famiglia gli permise di trasferirsi a Ferrara per studiare anatomia e medicina con Gianbattista Canano e Antonio Musa Brasavola. Forse seguì come uditore anche le lezioni di Gianbattista da Monte e Matteo Realdo Colombo a Padova, ma non ne abbiamo la certezza. E' probabile che già affiancasse i suoi maestri come dimostratore di anatomia e per l'anno 1547-48, sebbene non avesse ancora conseguito la laurea, fu incaricato di insegnare "la scienza delle erbe, delle piante e delle altre cose che nascono dalla terra", ovvero di commentare Dioscoride. L'anno successivo fu chiamato ad insegnare medicina all'Università di Pisa, incarico che mantenne fino al 1551. Il duca Cosimo I gli permise di sperimentare veleni e oppiacei sui condannati, fino a provocarne la morte, per poi anatomizzarli, cosa che gli procurò pressi i posteri l'accusa di aver praticato la vivisezione. Meno discutibili le sue ricerche sulla causa e le possibili cure della sifilide, di cui fu tra i primi a comprendere correttamente l'origine contagiosa. Nel fecondo ambiente del recente ateneo pisano, Falloppio allargò i suoi interessi alle scienze naturali e strinse amicizia con Luca Ghini, il fondatore del primo orto botanico, e il suo allievo Bartolomeo Maranta. Ci è noto che erborizzò nelle campagne pisane, alla ricerca delle piante degli antichi. Fu così che riconobbe nella salsapariglia la Smilax di Dioscoride e prese a utilizzarla anche per curare la sifilide. La sua competenza di "simplicista" era tale che, dopo la morte di Ghini, Maranta inviò a lui il manoscritto del suo Methodi cognoscendorum simplicium, pregandolo di verificarne l'esattezza e di correggerlo. All'epoca Falloppio era già a Padova, dove nel 1551 fu chiamato a reggere la doppia cattedra di "Lettura dei semplici e chirurgia, con l'obbligo di anatomia", anche se avrebbe conseguito la laurea solo l'anno dopo (si addottorò a Ferrara con Brasavola nell'ottobre 1552). Per dieci anni, tenne lezioni seguitissime, in cui profondeva la sua competenza nei campi dell'anatomia, della chirurgia, della medicina generale, della farmacologia e più in generale delle scienze naturali; così nel 1555 trattò del morbo gallico, ovvero della sifilide, nel 1556 delle acque termali e dei tumori, nel 1557 di metalli e fossili, di fratture e lussazioni, nel 1558 delle ulcere provocate o meno dal morbo gallico e dei purganti, nel 1560 del libro di Ippocrate sulle ferite alla testa, nel 1561 del primo libro di Dioscoride, nel 1562 (l'ultimo della sua vita) nuovamente di morbo gallico e ulcere. Avendo fatto della "sua meravigliosa scientia prove soprahumane", come scrive un biografo contemporaneo e conterraneo, F. Panini, divenne un medico noto e ricercato. Tra i suoi pazienti più illustri, il papa Giulio II, Alfonso II e Isabella d'Este, il duca di Parma Ottavio Farnese, il tipografo Aldo Manuzio che guarì di una malattia agli occhi. Uomo noto per la sua gentilezza, la pacatezza, la rettitudine morale, i poveri li curava gratis, fin da ragazzo, quando addirittura chiedeva la carità per loro. Forse intorno al 1554 (non conosciamo con precisione la data) nella sua vita entrò Melchiorre Guilandino; non era raro che Falloppio ospitasse e aiutasse gli studenti indigenti e meritevoli, ma nel medico tedesco, coetaneo, con alle spalle una travagliata storia familiare, fondamentalmente autodidatta, trovò un alter ego e un inseparabile compagno di vita, con il quale amava erborizzare sui colli euganei. Il legame tra i due giovani medici non mancò di suscitare la malignità di Mattioli, un tempo amico di Falloppio; quando Guilandino osò criticare i suoi Commentari a Dioscoride, a suo parere con il consenso e la complicità di Falloppio, non potendo attaccare direttamente quest'ultimo, troppo celebre e prestigioso, l'irascibile senese incominciò a diffondere insinuazioni scurrili sulla loro relazione, che, se fossero giunte alle orecchie dell'inquisizione, avrebbero potuto diventare molto pericolose. Lo stesso Falloppio , a malincuore, consigliò l'amico di accompagnare in Oriente il bailo veneziano in partenza per Costantinopoli. Quando seppe che Guilandino era stato catturato da corsari turchi ed era prigioniero ad Algeri, mise insieme 200 scudi e, nonostante la salute traballante, non esitò a partire per la Grecia per consegnare il riscatto. Sappiamo che soffriva di una debolezza polmonare, probabilmente da identificare come tubercolosi. Mano a mano che il suo fisico si indeboliva diventò sempre più difficile per lui far fronte ai tanti impegni, ed in particolare alle lezioni nelle stanze fredde e umide dell' ateneo patavino; fin dal 1556-57, tramite un altro amico, Ulisse Aldrovandi, entrò in trattative segrete con l'Università di Bologna per trasferirsi in quell'ateneo. Ma le trattative andarono per le lunghe e solo nel 1562 sembrò certa la sua nomina per l'anno accademico 1562-63; ma prima che potesse assumere la cattedra bolognese, all'inizio di ottobre si ammalò di una forma acuta di "mal di punta" che in meno di una settimana lo portò alla morte. Sconsolato, Guilandino (che da un anno, certo anche grazie all'interessamento del suo compagno, era diventato prefetto dell'orto botanico) pose sulla sua tomba una commossa epigrafe: «Falloppio, in questa tomba non verrai sepolto da solo / con te viene sepolta anche la nostra casa». Nel 1589, alla morte di Guilandino, le ossa di Falloppio vennero traslate nella sua tomba "da una mano pietoso". 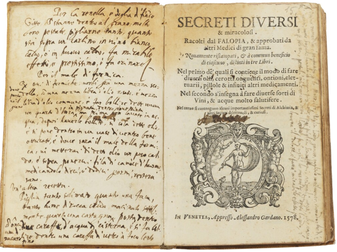 Grandi scoperte anatomiche e ricette pratiche Intorno al 1557 Falloppio incominciò a esporre le proprie scoperte anatomiche in un trattato che pubblicò a Venezia nel 1561 con il titolo Observationes anatomicae. Si tratta della sua unica opera edita in vita. Consapevole dell'importanza delle sue scoperte, che in molti casi superavano e correggevano quelle dello stesso Vesalio, temendo che qualcun altro se ne attribuisse il merito, si affrettò a pubblicare il suo trattato senza figure (certo pensava a una seconda edizione illustrata, ma ne fu impedito dalla morte); è però stato scritto che le sue descrizioni sono così accurate e precise da rendere quasi superflue le immagini. La sua scoperta più famosa è certamente quella delle trombe uterine, comunemente note come trombe o tube di Falloppio. Da lui prende il nome anche il legamento inguinale, o legamento di Falloppio. Oltre agli organi riproduttivi di entrambi i sessi, studiò molte altre parti del corpo umano, e in particolare l'anatomia della testa e dei suoi organi. Diede importanti contributi alla conoscenza dell'anatomia dell'orecchio e dell'occhio, diede un'accurata descrizione dei muscoli del capo e del collo, analizzò la struttura dei denti e descrisse il processo di sostituzione dei denti da latte con quelli permanenti, dimostrò la funzione dei muscoli intercostali, descrisse accuratamente i nervi oculo-motori, l'ipoglosso e il trigemino. Notevoli furono anche i suoi contributi alla medicina generale e alla farmacologia, ma li conosciamo solo in modo indiretto, attraverso numerose opere postume, non scritte direttamente da lui, ma basate sugli appunti presi durante le sue lezioni dai suoi allievi e forse su sui manoscritti. La più nota di queste opere "indirette" è probabilmente De morbo gallico tractatus, pubblicato a Padova nel 1563, che contiene anche la prima descrizione di un antenato del preservativo inventato dallo stesso Falloppio. Per passare all'argomento che più interessa questo blog, ovvero la botanica farmaceutica, la "materia medica" come si chiamava allora, le sue lezioni sui purganti furono pubblicate nel 1565 come De simplicibus medicamentis purgantibus tractatus. Ma forse il lascito più curioso è una raccolta di ricette, pubblicata inizialmente dallo stampatore veneziano Marco di Maria nel 1563 sotto il titolo Secreti diversi, et miracolosi e poi ripubblicata nel 1565 in edizione ampliata, con le ricette riordinate e riviste da alcuni allievi di Falloppio; il libro ottenne abbastanza successo da essere successivamente ristampato tre volte entro il 1602 da altri tipografi. La curiosa opera, che dovrebbe presentare le ricette messe a punto e sperimentate da Falloppio in vent'anni di carriera medica, raccoglie 400 "segreti", divisi in tre libri. Il primo, dedicato al "modo di fare cerotti, unguenti, pillole e altri medicinali", è quello più propriamente medico; vi compaiono ad esempio rimedi contro la peste, per combattere o prevenire la quale vengono anche suggeriti gli alimenti più opportuni. Falloppio prescrive ricette per curare le malattie polmonari, cui egli stesso era soggetto, il mal di testa, il mal di denti, i calcoli renali. Non mancano antidoti contro il morso dei serpenti e ricette per eliminare i vermi, curare la rogna, guarire le ferite da taglio. Molte le ricette per curare la sifilide, di cui, come abbiamo già visto, Falloppio era uno specialista. Il secondo libro è dedicato a "diverse sorti di vini e acque molto salutifere". Vi troviamo un vino "per il core, et per molti altri casi, miracoloso, et salutifero" che, oltre a fluidificare il sangue, combatte la malinconia e un altro che facilita e mantiene le gravidanze; acque per guarire le malattie della pelle e una per sciogliere i calcoli renali, a base di varie erbe tra cui la sassifraga. Infine il terzo libro, dedicato a "secreti di Alchimia, et altri dilettevoli, e curiosi", esce dalla medicina vera e propria per occuparsi dell'igiene della persona e della casa, con ricette per cacciare mosche, zanzare, pulci e pidocchi, trucchi per lavare e pulire i vestiti, pomate cosmetiche per la pelle, ricette contro la calvizie, per rendere i capelli biondi o migliorare la memoria. Tra la chimica, l'alchimia e la magia, le ricette per preparare il sale d'ammonio, l'acqua borica, il cinabro, l'ambra e il corallo, trasformare il piombo in oro, trovare il cadavere di un annegato. Potrebbe invece risalire alle esperienze degli anni di Pisa il metodo per estrarre oppio finissimo per fare dormire: "con un poco di questo farai dormire uno quanto tu vuoi, ma ci bisogna buona discretione". Non sappiamo quanto di queste ricette risalga davvero a Falloppio; alcuni studiosi considerano il libro del tutto spurio, altri lo ritengono almeno in parte risalente all'esperienza del medico modenese, che però qui si rivolge non ai dotti o agli studenti di medicina, ma alle persone comuni, alla ricerca di rimedi pratici con ingredienti semplici e facili da reperire. Per il suo ampio ventaglio di argomenti, la raccolta è comunque un documento significativo della pratica medica e farmacologica del tempo.  Rampicanti assai esuberanti, con qualche confusione Nel 1763, nel secondo volume di Familles de plantes Michel Adanson separò da Polygonum il nuovo genere Fallopia. Benché egli non fornisca alcuna indicazione sull'origine della denominazione, si ritiene generalmente abbia così voluto rendere omaggio a Gabriele Falloppio, il cui cognome latinizzato era appunto Fallopius, con una sola p. Esplicita è invece la dedica al nostro del secondo genere Fallopia (Malvaceae), creato da Loureiro nel 1790: "L'ho nominato in memoria del celebre Gabriele Falloppio, professore di botanica a Padova". Per la legge della priorità, il genere di Loureiro è illegittimo, mentre è valido quello di Adanson (famiglia Polygonaceae). Valido ma con una storia piuttosto travagliata. Nell'Ottocento, i botanici per lo più lo includevano in un più ampio genere Polygonum: così fecero sia Meissner nel 1856 sia Bentham e Hooker nel 1880. Il genere è stato universalmente accettato solo nella seconda metà del Novecento, a volte inteso in senso più ristretto, a volte in senso più ampio, a includere anche l'affine Reynoutria. Le analisi basate sul DNA hanno confermato sia l'indipendenza di Fallopia, sia la sua stretta affinità con Reynoutria e Muhelenbeckia, con le quali forma un'unica clade nota con la signa RMF (Reuynoutria, Muhelenbeckia, Fallopia). Sono noti anche ibridi intergenerici con Reynoutria (x Reyllopia) e Muhelenbeckia (x Fallenbeckia). La situazione è comunque ancora fluida. Per fare solo due esempi POWO riconosce Reynoutria e Fallopia come generi indipendenti, mentre INaturalist include tutte le specie di Reynoutria in Fallopia. Senza dimenticare i botanici che ancora optano per un vastissimo Polgygonum. Da qui incertezze di denominazione: ad esempio. il poligono giapponese è classificato come Reynoutria japonica nell'edizione più recente di Flora d'Italia, ma è ancora denominato Fallopia japonica in molti libri e repertori. Qui, seguendo la linea prevalente, considereremo Fallopia e Reynoutria come generi separati. Ne ricordiamo le differenze principali: Fallopia comprende specie rampicanti, annuali o perenni, con infiorescenze ascellari ad asse semplice; i fiori hanno perianzio carnoso e stimmi capitati; i frutti sono talvolta muniti di ali. Reynoutria comprende specie non rampicanti con infiorescenze ascellari ad asse ramificato; i fiori hanno perianzio sottile e stimmi flabellati; i frutti non sono alati. Purtroppo, i due generi hanno in comune una caratteristica spiacevole: varie specie dell'uno come dell'altro, introdotte nei giardini come ornamentali, si sono rivelate aliene invasive di straordinario successo e difficili da combattere, anche se da questo punto di vista Reynoutria ha la fama del peggiore. Fallopia in senso stretto comprende una dozzina di specie originarie dell'emisfero boreale (Eurasia, Nord America, Africa settentrionale), ma largamente introdotte anche altrove. Sono per lo più liane e rampicanti noti per il grande vigore e la rapida crescita, decidui, tanto annuali quanto perenni. Il genere è soprattutto eurasiatico, con nove specie, e centro di diversità in Cina con cinque specie, tre delle quali endemiche; due specie sono nordamericane; una di amplissimo areale si spinge anche in Africa. E' F. convolvulus, diffusa dalla Macaronesia all'Asia orientale, passando per il Nord Africa e l'Europa; è presente anche in tutte le regioni italiane, dove cresce come infestante delle culture di cereali e negli ambienti ruderali; è già citata negli erbari del rinascimento, incluso quello di Mattioli. Si ritiene tuttavia non sia originaria del nostro territorio, ma vi sia giunto in un'epica molto antica. Della flora italiana fa parte anche l'eurasiatica F. dumetorum, ugualmente presente in tutte le regioni eccetto la Sardegna; come la precedente è un'erbacea annuale e cresce preferenzialmente sulle siepi e ai margini delle foreste di latifoglie decidue. Sono invece largamente coltivate F. aubertii e F. baldschuanica, la prima di origine cinese, la seconda proveniente dall'Asia centrale, che POWO tratta come specie diverse, mentre molte fonti autorevoli le considerano sinonimi. Il problema non è semplice, trattandosi di specie altamente variabili. F. aubertii fu raccolta nel 1899 nel Tibet cinese dal padre missionario francese Georges Aubert, che ne inviò i semi al Muséum national di Parigi, che la distribuì già l'anno successivo; nel 1907 fu descritta da Louis Henry come Polygonum aubertii e riclassificata nel 1971 dal botanico ceco Holub come F. aubertii. Fallopia baldschuanica fu invece raccolta per la prima volta nell'attuale Turkestan nel 1883 da August von Regel che la introdusse nell'orto botanico di San Pietroburgo e l'anno successivo la pubblicò come Polygonum baldschianicum; il nome deriva dal toponimo latino Baldschuan, una località della zona orientale del kanato di Bukhara. Anch'essa fu riclassificata come F. baldschuanica da Holub nel 1971. Se si tratta della stessa specie, la priorità spetta a questa denominazione, mentre F. aubertii è sinonimo. F. baldschuanica è rampicante estremamente vigoroso, capace di crescere anche di 30 cm al giorno, raggiungendo un'altezza di 15 metri. E' in grado di coprire rapidamente una facciata (perciò la chiamano Consolazione dell'architetto), ma si arrampica anche su alberi e altri rampicanti, ed è difficile da rimuovere per le radici molto forti. In Italia è stata introdotta per la prima volta in Piemonte nel 1900; oggi è presente in tutto il territorio nazionale tranne la Calabria, è naturalizzata nella maggior parte delle regioni e classificata come alloctona invasiva in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Campania. F. aubertii, se si tratta di un'entità diverse, è molto simile; forse la principale differenza sono le infiorescenze pelose anziché glabre, e forse un vigore appena minore. Sono piante di grande bellezza (al momento della fioritura si trasformano in una cascata di fiori candidi), ma può essere imprudente coltivarle, a meno di controllarne strettamente la crescita. Studiare la natura per sollievo dell'animo, ovvero le vicissitudini di Giovanni Antonio Scopoli23/2/2023 Autore di cinquantasette pubblicazioni che spaziano dalla medicina alla zoologia, alla botanica, alla chimica, alla mineralogia, Giovanni Antonio Scopoli fu salutato dai contemporanei come "Linneo dell'impero austriaco". Il suo biografo Otto Guglia lo ha definito "il primo europeo anazionale", visto che nacque in Trentino, ma fu suddito austriaco, studiò in Italia e in Austria, lavorò e fece le sue ricerche in Slovenia, Slovacchia, Lombardia. Come botanico, è soprattutto l'iniziatore dello studio della flora slovena, grazie alla sua Flora carniolica. Come la sua gemella Entomologia carniolica, non sarebbe mai nata se il destino fosse stato più generoso con lui e non lo avesse relegato nel "carcere" di Idria, una cittadina mineraria della Slovenia, e soprattutto non l'avesse privato di tutti gli affetti più cari. Egli cominciò a battere campagne e montagne alla ricerca di insetti e piante proprio per trovare sollievo a tante disgrazie. Sebbene meno tragiche, anche le sue vicende successive furono segnate da continue contrarietà personali e professionali, tanto che egli intitolò la sua autobiografia Vitae meae vices, "Le vicissitudini della mia vita". L'ultima, beffarda e allo stesso tempo patetica, lo attendeva a Pavia, dove pensava di aver finalmente trovato il meritato riconoscimento. Grazie all'illustre von Jacquin che prima gli fu amico e poi (a sentir lui) ostile, lo ricorda la tossica Scopolia, da cui fu inizialmente estratta la scopolamina, a lungo uno dei principali anestetici. Né lo dimentica il Museo di scienze di Lubiana che ha ugualmente intitolato "Scopolia" la sua rivista ufficiale. 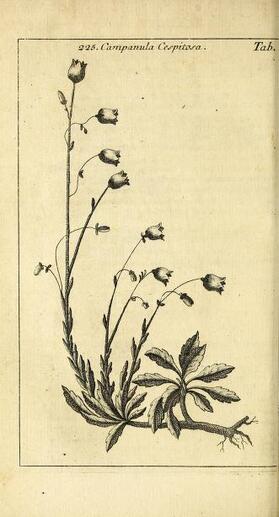 Insetti e piante della Carniola Nella prefazione della sua Entomologia Carniolica, Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) ebbe a scrivere: «ricordatevi sempre che non coltivo il teatro della Natura per amore dello studio, ma per sollievo dell’animo, in verità per alleviare i tristissimi dolori della mia esistenza». Pensava certo alla tragica moglie della moglie e dei figlioletti, periti in un incendio, ma anche alle difficoltà della sua carriera, che per sedici anni lo relegò nella periferica Idria, che nella sua autobiografia definirà senza mezzi termini "carcere". Quando vi era arrivato poco più che trentenne, aveva ben altre aspirazioni, e alla sola vista di quel villaggio montano costituito solo dalle "miserrime casette inedificate dei minatori" avvertì un presago di sventura. Scopoli era nato a Cavalese in Val di Fiemme, figlio del commissario militare del principe vescovo di Trento e di una nobildonna trentina che era anche pittrice. Dopo aver iniziato gli studi a Trento, si laureò in medicina a Innsbruck, quindi esercitò la professione per qualche tempo in Val di Fiemme e a Trento. Importante fu il soggiorno a Venezia del 1745, che gli permise di approfondire le conoscenze mediche con Lotario Giuseppe Lotti, di frequentare i giardini veneziani, in particolare quello di Lionardo Sesler, e di conoscere il sistema linneano, di cui sarebbe diventato un convinto sostenitore. Tornato a Trento, si sposò e, grazie alla protezione del protomedico Borsieri, fu assunto come segretario privato del principe vescovo Leopoldo Ernesto Firmian, che accompagnò a Graz e a Passau. Approfittò dei due anni trascorsi in Stiria per preparare l'esame di abilitazione che gli avrebbe consentito di esercitare in tutto il territorio soggetto agli Asburgo; lo superò in modo brillante nel 1753, alla presenza dello stesso van Swieten; impressionato dalla sua tesi su un nuovo metodo di classificazione botanica (Methodus plantarum enumerandis stirpibus ab eo hucusque repertis destinata), questi gli promise il primo posto vacante in una condotta medica. Scopoli sperava in Linz, invece fu Idria. A fare la fortuna - o anche la sfortuna, vista la pericolosità di questo materiale - di questa cittadina annidata nelle Prealpi della Carniola fu il mercurio, scoperto negli ultimi anni del 1400; pochi anni dopo vi fu aperta una miniera e Idria si trasformò nel centro più importante della Slovenia dopo Lubiana. La vita dei minatori era precaria; vivevano stipati nelle "casone", e la loro speranza di vita non andava oltre i 40 anni. Quando vi giunse Scopoli, con le loro famiglie costituivano una comunità di 2000 persone. Già il viaggio non aveva fatti presagire nulla di buono; dopo la nomina, Scopoli era tornato in patria a prendere la moglie Albina de’ Miorini, figlia del presidente della Magnifica Comunità di Fiemme, e la figlioletta; quindi a Hall nel Tirolo la famigliola si era imbarcata per un viaggio fluviale sull'Inn, gonfio di pioggia; il giorno dopo, l'imbarcazione fu colpita da un tronco e fece naufragio; Scopoli e i suoi furono tratti in salvo, ma tutti i bagagli, compresi i libri e gli strumenti medici, andarono perduti. Ospitato a Salisburgo e poi tornato a Vienna, Scopoli sperava che l'infortunio suscitasse la benevolenza reale, e che gli fosse assegnata la condotta di Linz, che sapeva ancora vacante. Ottenne invece un dono personale di 500 fiorini da parte dell''imperatrice, informata dell'incidente, poi dovette rassegnarsi a raggiungere Idria. Anche prima della tragica morte di moglie e figli, vi si trovò malissimo. Veniva pagato attraverso i proventi del monopolio sul vino, una beffa se si pensa che l'alcolismo era uno dei problemi sanitari che affliggevano i minatori e le loro famiglie, aggiungendosi agli effetti deleteri dei vapori del mercurio. Non conoscendo la lingua del paese, poco capiva i suoi pazienti; pessimi poi erano i suoi rapporti con il direttore della miniera, interessato solo al guadagno e per nulla sollecito della salute dei lavoratori. Il lavoro era pesante, e per nulla remunerativo; dopo nove anni di tormenti, Scopoli si rassegnò a chiedere il trasferimento con una supplica. Non lo ottenne, ma nel 1763 gli fu assegnata la cattedra di metallurgia chimica alla neoistituita scuola superiore di Idria con uno stipendio annuo di 400 fiorini. A consolarlo dalle vicissitudini personali e professionali c'era solo l'ambiente naturale, con una flora e una fauna ancora del tutto inesplorate. Secondo quanto egli stesso scrive nella prefazione alla seconda edizione di Flora carniolica, le sue escursioni iniziarono intorno al 1755 con l'esplorazione dei monti e dei boschi del distretto di Idria; nel 1756 percorse le paludi e le campagne di Lubiana; nel 1757 il monte Nanos; nel 1758 i territori di Škofja Loka e di Kranj, il monte Storžič e la catena montuosa che si estende fino al fiume Kokra; nel 1759 l'area tra Lubiana e Kočevje e i monti Grintovec, Kočna e Kalški Greben; nel 1760 i pascoli alpini e i dintorni del lago di Cerknica; nel 1761 nuovamente il monte Nanos e il Senožeče, il Carso e Trieste; nel 1762 gran parte della Carniola superiore e i monti di Bohinjska Bistrica; nel 1764 i circondari di Gorizia e Duino e la costa adriatica. Il primo risultato di queste ricerche fu la prima edizione di Flora carniolica (1760), della cui pubblicazione Scopoli informò il suo idolo Linneo con una lettera datata 1 settembre 1760. Fu l'inizio di una corrispondenza che sarebbe stata interrotta solo dalla malattia e poi dalla morte dello scienziato svedese. Nel 1763 seguì l'ancor più importante Entolomologia carniolica in cui vengono descritte 1153 specie di insetti (o meglio di artropodi), più della metà delle quali nuove per la scienza, classificati in sette classi sulla base di un sistema proprio; più olistico rispetto a quello di Linneo (basato sulle ali) o di Fabricius (basato sull'apparato boccale), tenta di tenere conto di più caratteristiche possibili per giungere a una classificazione naturale. Come medico, Scopoli fu anche il primo a rendersi conto dei nefasti effetti del mercurio, illustrati in De Hydroargyro Idriensi Tentamina (1761), che fa parte della più complessivo Tentamina physicochymico-medica, un'opera che, con i suoi suggerimenti sulla sicurezza dei lavoratori, fa di Scopoli uno di padri della medicina del lavoro. Tradotta (e piratata) in Germania, insieme alla successiva Introductio ad diagnosim et usum fossilium (1763), legata all'insegnamento di metallurgia chimica, incominciò a farlo conoscere a livello internazionale. Dalla Slovacchia all'Insubria Fu certamente questa fama crescente a liberarlo finalmente dalla "prigione" di Idria. Nel 1766 gli fu proposta la cattedra di mineralogia all'Accademia di San Pietroburgo, ma egli la rifiutò, così come l'incarico di medico personale del vescovo di Passau, preferendo rimanere al servizio degli Asburgo, tanto più che contava che l'arrivo di un altro medico, Balthasar Hacquet, lo sollevasse dai compiti più ingrati. Nel 1769, accettò invece di succedere a von Jacquin alla cattedra di mineralogia e metallurgia all’Accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica in Slovacchia). Il periodo slovacco fu molto fruttuoso sul piano professionale, con la pubblicazione di molte opere che spaziano sui tre regni della natura: Anni historico-naturales (1769-1772), scritti vari di mineralogia, cristallografia, micologia e zoologia, che contengono tra l'altro la descrizione di diverse specie di uccelli provenienti da varie collezioni; Dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes (1772), di argomento prevalentemente mineralogico; Principia mineralogiae systematice et praticae (1772), scritto come manuale per i suoi studenti; la seconda edizione di Flora carniolica (1772); Crystallographia hungarica (1776); Introductio ad historiam naturalem (1777), un tentativo di sintetizzare i "caratteri essenziali" dei generi dei tre regni della natura. Anche se continuava a interessarsi di zoologia e botanica, in questi anni, a occupare il centro dei suoi studi erano soprattutto la chimica e la mineralogia, un altro campo in cui diede contributi originali. La seconda edizione di Flora carniolica non è un semplice ampliamento della prima, ma un'opera di impostazione del tutto diversa. Nella Flora del 1760, Scopoli aveva descritto 756 specie di fanerogame e 256 di crittogame, in gran parte autoctone, dedicando anche una notevole attenzione ai funghi. Fu in effetti uno dei primi a studiare la flora e la fauna della grotte (incluso il famoso proteo Proteus anguinus); anche se apprezzava già Linneo, definito nella prefazione Princeps botanicorum, utilizzò le tradizionali denominazioni polinomiali, costituite da brevi diagnosi, e una propria classificazione "naturale" in 33 classi, una rielaborazione di quella di Tournefort. E' ancora l'opera di un medico-farmacista, e come tale Scopoli si preoccupò di integrare le descrizioni con note più o meno ampie sulle proprietà medicinali e gli eventuali altri usi. Non ci sono illustrazioni. La Flora del 1672 è quella di un linneano ortodosso, ed è esclusivamente botanica; le note farmacologiche scompaiono; di Linneo vengono adottati tanto le denominazioni binomiali quanto il sistema. Le specie lievitano a 384 crittogame, 1251 fanerogame, 141 tra funghi, licheni, alghe. Molte quelle descritte per la prima volta, e molte anche quelle che conservano ancora oggi il nome dato loro da Scopoli: tra i generi Ostrya, Rorippa, Sesleria, tra le specie Cotinus coggygria, Centaurea kartschiana, Cirsium carniolicum, Tragopogon dubius, Ostrya carpinifolia, Cakile maritima, Campanula cespitosa, Euonymus verrucosus, Genista sylvestris, Onobrychis viciifolia, Vicia grandiflora, Gentiana pannonica, Tilia platyphyllos, Sanguisorba minor, Salix alpina. Tra i funghi, ricordiamo almeno che si deve a Scopoli l'eponimo dell'ovolo reale Amanita caesarea (per lui, Agaricus caesareus), calco del nome volgare tedesco della Carniola Kaiserling. In due volumi, l'opera è illustrata da 66 tavole incise da F. Rein a partire da disegni dello stesso Scopoli. Anche negli anni slovacchi, così ricchi di pubblicazioni, non mancarono pene e contrarietà. Scopoli subì la perdita della seconda moglie Caterina de' Franchenfeldt; fu costretto a lavorare in un laboratorio umido e angusto che, oltre a mettere a dura prova la sua salute, era del tutto inadatto alle lezioni; la commissione di corte per i minerali gli proibì di pubblicare senza uno specifico permesso. Ma soprattutto la sua carriera era di nuovo bloccata; in una lettera a Linneo del 1773, lamenta che von Jacquin, che in precedenza gli era tanto amico, ora non vuole più avere nulla a che fare con lui e lo ostacola in tutto. Quando all'Università di Vienna venne istituita una seconda cattedra di storia naturale, accanto a quella di chimica e botanica tenuta appunto da von Jacquin, fece domanda per ottenerla, ma gli fu preferito l'oscuro farmacista viennese Jacob Well. Nel 1776 si risolse così ad accettare la cattedra di botanica e chimica all'Università di Pavia, dove incominciò ad insegnare nel 1777. Tra i suoi compiti la direzione dell'orto botanico, che era stato istituito nel 1773 nell'ambito delle riforme dell'insegnamento universitario promosse in Lombardia dal plenipotenziario degli Asburgo conte Firmian. Scopoli ne fece regolarizzare la superficie, creò due arboreti, rispettivamente ad est dell'edificio che ospitava il laboratorio di chimica e a nord delle serre in legno fatte costruire dal suo predecessore Valentino Brusati. Lo spazio centrale fu diviso in aiuole regolari separate da viali. La tradizione vuole che nel 1778, per commemorare l'amato Linneo, abbia fatto piantare l'esemplare di platano (Platanus x hispanica) che oggi costituisce l'albero più venerabile del giardino. Grazie ai suoi molti corrispondenti (all'epoca era membro di innumerevoli società scientifiche) inserì il nuovo giardino nel circuito internazionale degli orti botanici, accrescendone notevolmente le collezioni attraverso scambi. La sistemazione dell'orto botanico e del laboratorio di chimica lo distolsero per qualche tempo da nuove pubblicazioni, tanto più che era impegnato nella traduzione del Dizionario di chimica di Macquer. Ambiva però a pubblicare una grande opera illustrata, con la descrizione di specie rare e inedite; il progetto si tradusse nella raffinata e costosa ultima opera di Scopoli, Deliciae florae et faunae insubricae, in tre parti (1786-1788), una rassegna illustrata di animali, piante e minerali, in parte raccolti da lui stesso durante le sue escursioni naturalistiche in Lombardia o da allievi e corrispondenti, in parte coltivati nell'orto botanico o conservati nelle collezioni museali; vi pubblicò anche mammiferi e uccelli esotici raccolti da Pierre Sonnerat durante i suoi viaggi. Nel terzo e ultimo volume incluse un'autobiografia (Vitae meae vices, ovvero "Le vicissitudini della mia vita"). Deliciae florae et faunae insubricae, per altri aspetti pregevole, segnò la fine di Scopoli, che, nella smania di pubblicare, di tenere alta la propria fama internazionale, magari con uno scoop naturalistico, incappò in un madornale errore; nel 1785, mentre era alla ricerca di materiali curiosi e soprattutto inediti per la prima serie, fu avvicinato da un sedicente medico di campagna che gli offrì uno " singolarissimo verme" conservato sott'alcool; a suo dire, lo aveva vomitato una donna piemontese poco prima del parto. Con la bocca aperta e due tubi divergenti, era davvero mai visto e entusiasmò Scopoli che si affrettò a farlo disegnare e lo pubblicò nel primo fascicolo come Physis intestinalis, con tanto di dedica a Joseph Banks. Il povero Scopoli era stato vittima di un truffatore (o forse di una beffa): non si trattava di un verme, ma di un artefatto, la trachea e l'esofago di una gallina con la parte inferiore cucita. La verità sarebbe venuta a galla tre anni dopo, in seguito a uno squallido episodio in cui, purtroppo, il nostro protagonista fece una pessima figura. Fin dal suo arrivo a Pavia, si era delineata una forte tensione con un altro scienziato universale, Lazzaro Spallanzani, titolare della cattedra di scienze naturali e creatore del Museo di scienza naturale dell'Università, al quale lo stesso Scopoli vendette una parte delle sue collezioni; Spallanzani ne aveva controllato il catalogo, rilevando diverse mancanze, con grande disappunto del nostro, che in tal modo passava per ladro o imbroglione. C'era poi una rivalità scientifica: Scopoli era un sistematico, un catalogatore linneano, per il quale il compito principale della scienza era catalogare la natura, e la massima aspirazione era aggiungere un nuovo tassello alla lista; Spallanzani era un fisiologo, attento soprattutto alle funzioni e ai meccanismi fisiologici. Si aggiunga l'antipatia personale, alimentata dal dileggio dell'emiliano Spallanzani per il "dialetto germanico-italico" del trentino Scopoli. Fu certamente quest'astio a spingere quest'ultimo a divenire parte attiva di una vera e propria congiura ordita dal custode del Museo naturale, Giovanni Serafino Volta (omonimo e non parente di Alessandro, all'epoca rettore dell'Università), il quale, approfittando dell'assenza di Spallanzani, che era andato a Costantinopoli in viaggio di studio, lo accusò di essersi impadronito di diversi esemplari del Museo per arricchire la propria collezione privata. Rivelò la sua presunta scoperta, oltre che a Scopoli, al medico e anatomista Antonio Scarpa, titolare della cattedra di anatomia, e al matematico Gregorio Fontana, direttore della biblioteca universitaria; nell'estate del 1786 i quattro inviarono una denuncia sia al governo imperiale della Lombardia sia alla Commissione ecclesiastica degli studi (Spallanzani era infatti abate). Scopoli si incaricò di informare del fattaccio urbi et orbi, scrivendo una lettera circolare che fu inviata ai membri delle università italiane e a personalità della scienza e della cultura europea: certamente in buona fede, ma accecato dal rancore vide nella vicenda la "mano di Dio", che aveva ritorto la stessa accusa infamante contro colui che l'aveva ingiustamente accusato di furto. All'epoca Pavia era la più quotata università italiana; l'accusato era illustre, e lo erano altrettanto almeno due degli accusatori, Scarpa e Scopoli. Lo scandalo era dunque clamoroso. Le autorità austriache si affrettarono ad ordinare un'inchiesta, diretta del plenipotenziario Wilczeck; Spallanzani fu del tutto scagionato con tanto di editto imperiale, che allontanò Volta e ammonì i tre professori per "per il danno arrecato alla reputazione di Spallanzani, accusandolo senza prove sufficienti", per essersi fidati ciecamente delle false affermazioni di Volta. Ma, purtroppo per Scopoli, anche se conservò la cattedra, la storia non finì lì. Nel 1788, vennero pubblicate due lettere al "signor Dottore Scopoli", datate da Zoopoli, a firma di una certo dottor Francesco Lombardini bolognese. Anche se egli lo negò sempre, l'autore era Spallanzani che, nel tono più beffardo, coprì Scopoli di ridicolo per aver scambiato le viscere di un pollo per un inedito verme intestinale. Il vaso con il "verme singolarissimo" sparì prontamente dal Museo, ma ormai il danno era fatto. Travolto dal discredito, l'8 maggio 1788, mentre si celebrava la festa di san Pio, in onore di papa Pio V, fondatore del Collegio Ghislieri, il povero Scopoli si accasciò per un ictus sotto il portico dell'Istituto.  Dediche botaniche Insomma, il destino giocò con Scopoli fino alla fine, preparandogli una morte al tempo stesso tragica e grottesca, di cui si spiacque ormai troppo tardi anche lo stesso Spallanzani. La sgradevole vicenda non intaccò per altro la stima per una luminosa carriera scientifica, costellata di più di cinquanta pubblicazioni con contributi originali in tutti i campi che aveva toccato. Per limitarci alla botanica, Flora carniolica è ancora oggi una pietra miliare, per aver avviato lo studio della flora della Slovenia e più in generale delle Alpi orientali. Nella tassonomia botanica, celebrano Scopoli l'eponimo di due specie soprattutto balcaniche, Arabis scopoliana e Senecio scopolii, una centro europea ma presente anche in Italia, Scrophularia scopolii; recentissima è la dedica di Hieracium scopolii, endemismo del monte Lesima tra Piacenza e Pavia. A dedicare al naturalista trentino un genere Scopolia furono in parecchi; ad aprire le danze fu Adanson (che tra l'altro Scopoli ammirava moltissimo: entrambi aspiravano a un sistema naturale); seguirono von Jacquin, i Forster, il figlio di Linneo, James Edward Smith. Tutti nomi di peso che attestano la sua fama europea. Poiché la denominazione di von Jacquin era più nota di quella di Adanson, tanto da essere fatta propria da Linneo, è quella conservata (nomen conservandum); e non si tratta di una dedica da poco. Nella prima edizione di Flora carniolica Scopoli descrisse una pianta che "vive in tutti i boschi ombrosi nei pressi di Idria" con la seguente diagnosi: "Atropa caule herbaceo, foliis ovatis interis, calycibus erectis, fructu capsulari" (belladonna con fusto erbaceo, foglie ovate intere, calici eretti, frutto a capsula). La mise poi a confronto con Atropa belladonna, chiarendone con grande precisione caratteristiche comuni e differenti. Tre anni dopo von Jacquin, che da poco si era trasferito a Banská Štiavnica ad occupare la cattedra che poi sarebbe stata di Scopoli, individuò in questa specie un nuovo genere, che dedicò opportunamente allo scopritore: "Scopola carniolica. Questa pianta che nasce spontaneamente nei boschi ombrosi di Idria, se non erro, fu scoperta e descritta per primo da Giovanni Antonio Scopoli, medico di Idria e indefesso cultore della storia naturale; poiché mi pare richieda assolutamente un nuovo genere, l'ho chiamata Scopola dal suo scopritore". Come si vede, von Jacquin chiamò il nuovo genere, scorrettamente, Scopola, senza i. Sembra che il nome spiacesse a Scopoli, visto che in veneziano una scopola è uno schiaffone. Nel 1767 Linneo aggiustò le cose, modificando la denominazione in Scopolia, anche se come eponimo, visto che attribuì la specie al genere Hyoscyamus come H. scopolia. Velenosissima, è una delle tre specie di questo genere delle Solanaceae, che sembra in effetti collocarsi a metà tra i generi Atropa, che ricorda per il rizoma, le foglie e i fiori, e Hyoscyamus, che ricorda per i frutti. E' probabile che ben prima che Scopoli la "scoprisse", fosse ben nota a guaritrici e fattucchiere; secondo alcune fonti, fin dal tardo Medioevo era utilizzato come narcotico, anestetico e ingrediente di filtri amorosi, oltre che per scopi criminali; contiene infatti diversi alcaloidi (iosciamina, atropina, scopolamina), con proprietà simili a quelle della belladonna. Del resto, nel 1554 era già stata descritta da Mattioli che l'aveva raccolta sul monte Sabotino quando viveva a Gorizia e la pubblicò come Solanum somnificum alterum. Nel 1824, Ernst A. Schmidt dell'università di Marburg estrasse dal rizoma di Scopolia carniolica il principio attivo chiamato scopolamina, un alcaloide con effetti narcotici ed allucinogeni, estremamente tossico anche in piccole dosi. Nell'Ottocento, ebbe un certo uso come anestetico, tanto che la società slovena di anestesiologia ha scelto Scopolia carniolica come proprio simbolo, anche se il suo uso è stato abbandonato da tempo. Nella seconda metà del Novecento la scopolamina venne usata come componente del siero della verità dalla CIA e da altre agenzie, finché si capì che altera talmente la percezione della realtà da dare risultati inaffidabili. Scopolia carniolica è diffusa in modo discontinuo nell'Europa centro-meridionale e sud-orientale, in particolare nei Carpazi e nella penisola balcanica; è presente anche altrove (Germania, Danimarca, Ucraina, Russia), ma potrebbe essere stata introdotta come pianta medicinale, importante nell'Ottocento per l'estrazione di atropina e scopolamina. Anche la sua distribuzione in Italia è disgiunta: la si trova infatti nel Biellese e in poste stazione delle Prealpi Giulie lungo il confine con la Slovenia. Endemica di quest'ultima è la rara S. carniolica var, hladnikiana. Le altre specie sono S. caucasica, nativa del Caucaso settentrionale, e S. japonica, presente in Corea e Giappone. Per finire, un ultimo omaggio... cartaceo. Per celebrare colui che è indubbiamente il fondatore dello studio della flora slovena, l'organo del Museo di scienze naturali di Lubiana è stato battezzata "Scopolia". Con due libri dal ricercato titolo greco, Fabio Colonna segna una tappa decisiva per l'avvento della botanica come scienza, negli anni a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Membro dell'Accademia dei Lincei, ha ancora la formazione erudita di stampo classico e la vastità di interessi dell'uomo universale del Rinascimento, ma è già a tutti gli effetti un uomo della nuova scienza, corrispondente di Galileo e scienziato sperimentale, che più che all'auctoritas degli antichi si affida al libro della natura. I suoi contributi alla nascita di un metodo scientifico per studiare le piante e determinarne i generi gli guadagnarono il plauso di Tournefort e Linneo, per non parlare di Plumier che gli dedicò il sontuoso genere Columnea. 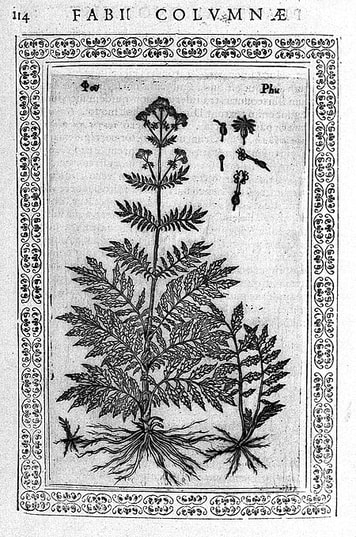 La botanica come cura Forse, se avesse goduto di buona salute, il napoletano Fabio Colonna (1567-1640) non sarebbe mai diventato un naturalista. Esponente di un ramo cadetto della celebre famiglia romana, nel 1589 si laureò utroque iure all'Università di Napoli, ma la salute precaria gli impedì di esercitare la professione. Spirito indagatore, per trovare rimedio ai suoi mali, e in particolare ai ricorrenti attacchi di epilessia, si rivolse ai testi degli antichi, a cominciare da Dioscoride, dove lesse delle proprietà antiepilettiche di una pianta chiamata Phu. Incominciò così a battere le campagne alla sua ricerca; il risultato fu che si innamorò della botanica e fece scoperte ben più interessanti dell'identificazione delle piante di Dioscoride, croce e delizia dei botanici del Rinascimento. Ma qui lascio volentieri la parola a Michele Tenore: "L'impegno di riconoscere nelle campagne la pianta che l'Anazarbeo chiamava Fu [...] lo condusse a scorrere le nostre selve, i nostri boschi e i monti; ove siccome doveva necessariamente avvenire, con giornaliero paragone delle descrizioni di Dioscoride con le piante che incontrava, invece del Fu di questo Autore, che scambiò con la Valeriana officinalis [...], riconobbe non solo la maggior parte delle piante mentovate dagli antichi scrittori; ma anche moltissime altre proprie del nostro suolo che egli scopriva per la prima volta". Nelle sue scorribande botaniche, che, a detta di Tenore, dovettero giovargli ben più del supposto rimedio dioscorideo, per memoria delle piante che incontrava, e per meglio confrontarle con le descrizioni degli antichi, Colonna dovette iniziare ad allestire un originale erbario ad impressione, testimoniato dal magnifico manoscritto in due volumi conservato a Blickling Hall nel Norfolk e intitolato Icones ipsis plantis ad vivum expressae quoad fieri potuit nova quadem arte excogitata ab ipso auctore Fabio Columna pro ipsius oblectatione, studio e memoria. Perfezionando una tecnica attestata fin dal secolo precedente, Colonna cospargeva di pigmenti l'esemplare, fresco o essiccato, ma sempre raccolto in natura (la coltivazione, aveva osservato, altera l'aspetto delle piante), quindi lo pressava su un foglio; ma, a differenza di Boccone o altri, a questo punto disegnava i particolari che l'impressione non conservava, talvolta aggiungendo anche i colori originali ad acquerello. Il poderoso erbario (oltre 500 fogli) fu certo il frutto di ricerche di molti anni, ma è probabile che egli lo abbia iniziato prima del 1592, data di pubblicazione dell'opera frutto di quelle prime escursioni e ricerche. Per identificare le piante di Dioscoride, Colonna, figlio di un agguerrito filologo ed egli stesso perfetto conoscitore delle lingue antiche, non rifuggiva dalla critica testuale, ma cercava la risposta soprattutto nel confronto tra le succinte e spesso criptiche descrizioni del testo greco con le piante raccolte in natura, minuziosamente osservate o "interrogate". E' questo il senso del curioso titolo della sua prima opera, Phytobasanos, sive plantarum aliquot historia. Come spiega Eva Cantarella, in greco il termine basanos originariamente indicava la pietra di paragone, utilizzata per saggiare l'oro, "da questo passò a indicare qualunque strumento o procedimento utile a 'mettere alla prova' una persona: e dunque, successivamente, anche la pratica che noi chiamiamo tortura". Ecco perché Phytobanos è stato variamente tradotto "Interrogazione delle piante", "Pietra di paragone della piante", "Tortura delle piante". La breve opera, stampata a Napoli a spese dell'autore nel 1592 (all'epoca Colonna aveva 25 anni) e dedicata al cardinale Marcantonio Colonna, è divisa in due parti; la prima analizza 26 piante di Dioscoride, ricavandone l'identificazione, più che dall'analisi filologica e dai pareri di altri studiosi (anche se non mancano né l'una né gli altri), dalla accurata e minuziosa descrizione della pianta stessa; la seconda parte, che si aggiunse in corso d'opera, durante la stampa della prima, tratta quattro animali marini e altre otto piante, che dovrebbero essere "nuove", cioè non descritte in precedenza. Lo era davvero la splendida Primula palinuri, che Colonna, il suo scopritore, identifica invece con la dioscoridea Alisma. Parte integrante dell'opera sono le 37 incisioni calcografiche a piena pagina, sicuramente almeno in parte ricavate da impressioni e disegni dello stesso Colonna. E' la prima volta che l'incisione su rame, con i suoi tratti molti più fini di quella su legno, viene applicata alla botanica; ed è anche la prima volta che, accanto alla pianta stessa, completa di radici, vengono raffigurati a parte, ingranditi, particolari essenziali per l'identificazione, come gli organi della fruttificazione. Stando a quanto scrive Colonna nella prefazione Ad lectorem, l'opera fu per lui, autodidatta ("nullo mostrante, aut docente"), un laborioso apprendistato; ma certo si avvalse dei consigli del farmacista Ferrante Imperato, che poi divenne il suo maestro e lo indirizzò anche allo studio dei fossili. Nel 1599, quando Imperato diede alle stampe Dell'historia naturale, Colonna contribuì con alcune tavole di serpenti disegnati dal vero. Grande influenza su di lui esercitò anche Giambattista della Porta, che più tardi l'avrebbe introdotto all'Accademia dei Lincei. 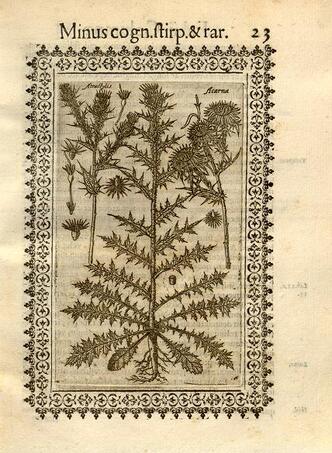 Un metodo per determinare i generi Dopo il 1593, anche se la stampa di Phytobasanos aveva alquanto intaccato il suo scarso patrimonio, ora che la migliorata salute gli permetteva di viaggiare, Colonna estese le sue ricerche oltre i confini del Napoletano, approfittando dei legami familiari. Per qualche tempo soggiornò presso un fratello a Campochiaro, dove studiò la flora del Matese, poi fu a Cerignola presso uno zio, quindi passò al servizio del duca di Zagarolo Marzio Colonna, mettendo finalmente a frutto le sue competenze giuridiche nella risoluzione di complesse controversie di confini. Era anche di frequente a Roma, dove poteva ammirare gran copia di piante esotiche nei giardini dei porporati come i famosi orti farnesiani. Ma a interessarlo erano soprattutto le specie "che nascono sotto il nostro cielo". Anche se non manca qualche esotica, sono soprattutto loro le protagoniste della seconda, più ampia opera di Colonna, Minus cognitarum stirpium aliquot ac etiam rariorum nostro coelo orientium Ekphrasis, la cui prima parte uscì a Roma presso Facciotto nel 1606. Il termine Ekphrasis è preso in prestito dal lessico artistico, dove indica la descrizione verbale, il più possibile dettagliata, di un'opera d'arte. Vi ritroviamo infatti le accuratissime descrizioni che già caratterizzavano Phytobasanos, nonché le splendide tavole calcografiche basate su disegni dello stesso Colonna; ad essere nuova è invece la consapevolezza metodologica. Ormai il botanico napoletano ha elaborato un solido metodo per lo studio scientifico delle piante, a partire dalla riconoscimento dell'importanza per la classificazione dei fiori e dei semi, ed ha maturato un metodo che farà l'ammirazione di Tournefort, che riconobbe in lui lo scopritore della "constituendorum generum ratio", ovvero del metodo per la determinazione dei generi. Né minore fu la considerazione di Linneo, che lo proclamò "primo di tutti i botanici". Importanti anche i suoi contributi alla terminologia, tra l'altro con la creazione del termine "petalo". Già pronta intorno al 1603, ma ritardata dai soliti problemi finanziari, l'opera fu dedicata da Colonna al duca di Zagarolo: tuttavia, nonostante l'alto valore scientifico e le splendide illustrazioni (in questa prima edizione sono 114, 102 delle quali dedicate a piante, le altre ad animali marini e terrestri, incluso un ippopotamo) non ebbe molta fortuna. Per qualche tempo Colonna fece la spola tra Roma e Napoli, dove tornò definitivamente intorno al 1610. In questa fase, il suo interesse principale si spostò sui fossili, con la determinazione dell'origine animale delle cosiddette glossopietre: non lingue di serpente, come si credeva, ma denti di squalo pietrificati. Nel 1612, grazie alla raccomandazione di Della Porta, entrò a far parte della colonia napoletana dell'Accademia dei Lincei di cui fu l'undicesimo membro nonché uno degli esponenti più attivi, divenendo uno stretto collaboratore di Cesi, anche come consulente e procuratore; corrispose con Galilei e fu tra i primi a capire le potenzialità dei suoi nuovi strumenti ottici. Ispirato dalle esperienze dello scienziato pisano, costruì da solo un cannocchiale con il quale replicò le osservazioni galileane del Sole e della Luna. Ancora maggiore fu il suo entusiasmo per il microscopio, che Galileo chiamava occhialino ed egli propose di battezzare enghiscopio "che vol dir occhiale da vicino, a differenza dell'altro che vede di lontano". Insoddisfatto dello strumento che Galileo aveva donato a Cesi, ne costruì uno con una lente da lui stesso molata di ampio diametro, che utilizzò per osservare l'anatomia delle api. Queste osservazioni era finalizzate a un'opera celebrativa offerta dai Lincei al cardinale Matteo Barberini, appena eletto pontefice con il nome Urbano VIII: le api, accampate sul loro stemma gentilizio, erano infatti il simbolo della famiglia Barberini. Nel 1615, alla morte di Della Porta, Colonna divenne viceprincipe, ovvero capo della colonia napoletana. Ed è orgogliosamente come Linceo che figura nel frontespizio della seconda, più ampia edizione di Ekphrasis, stampata a Roma nel 1616 da Mascardo, il tipografo di fiducia dell'Accademia; si è aggiunta qualche pianta, ma soprattutto due appendici, una dedicata alle glossopietre, l'altra alla porpora, ma soprattutto ai molluschi da cui è ricavata. Fu proprio De purpura ad assicurargli una certa fama europea; Colonna vi fonde le competenze antiquarie, con citazioni di Plinio, Aristotele, Dioscoride, la conoscenza della letteratura più recente (tra i nomi citati, Guillaume Rondelet), con l'indagine zoologica diretta delle diverse specie di molluschi del Tirreno meridionale, di cui esamina una ventina di specie, elencando anche i luoghi di crescita, da lui visitati personalmente. Intorno al 1624, Colonna fu coinvolto nel più ambizioso progetto collettivo dei Lincei, Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, più noto come Tesoro messicano, ovvero la pubblicazione commentata dell'epitome che Nardo Antonio Recchi aveva tratto dall'opera di Hernandez sulla natura messicana (le cui complesse vicende editoriali sono riassunte in questo post). Inizialmente, Cesi aveva affidato la parte botanica a Giovanni Faber e Giovanni Terrenzio, ma dopo la partenza di quest'ultimo per la Cina, insoddisfatto delle succinte note da lui redatte, si rivolse a Colonna, che, nuovamente afflitto da problemi di salute, accettò con riluttanza, soprattutto per non scontentare il principe. Temeva infatti di non essere sufficientemente aggiornato sugli sviluppi della botanica, che proprio in quegli anni stava facendo rapidi progressi (basti pensare che nel 1623 era uscito il Pinax di Caspar Bauhin). Ma, una volta entrato nel progetto, vi lavorò con il consueto impegno e serietà, redigendo le Annotationes et Additiones, che consegnò nel luglio 1628, in tempo per essere incluse nel primo volume, di cui avrebbero costituito la terza parte (pp. 847-899); sono prevalentemente dedicate alle botanica, tranne le ultime quattro, dedicate ai mineralia. Colonna, nell'esaminare le piante messicane e nel confrontarle con analoghe specie già note, ha modo di approfondire il metodo di determinazione dei generi; aggiunge inoltre la trattazione di alcune piante esotiche, non necessariamente messicane, e talvolta neppure americane. Ad esempio, in Narcissus indicus serpentarius riconosciamo il sudafricano Haemanthus coccineus, che negli stessi anni è descritto anche da Ferrari. E' invece nordamericano il Flos cardinalis Barberini, che Colonna dedicò a Francesco Barberini, protettore delle arti e della scienza, prendendo spunto dal colore rosso dei fiori, lo stesso della veste cardinalizia. Oggi si chiama Lobelia cardinalis, conservando l'eponimo voluto da Fabio Colonna. Dopo la morte di Cesi (1630), che ritardò per un ventennio l'effettiva diffusione del Tesoro messicano, Colonna fu indicato come suo possibile successore, ma la proposta non ebbe seguito. Poco sappiamo dei suoi ultimi anni, certo funestati da difficoltà finanziarie e crescenti problemi di salute. Morì nel 1640. Vale la pena di ricordare, tra i suoi poliedrici interessi, anche la musica; gli si deve anche la creazione di uno strumento musicale, il pentecontachordon o sambuca lincea, una specie di cembalo con 50 corde.  Magnificenze tropicali Come esploratore della flora dell'Italia centro-meridionale, si deve a Colonna la scoperta di almeno una ventina di specie. Diverse portano l'epiteto columnae (dalla forma latina del suo nome, Fabius Columna); tra di esse Doronicum columnae, Aubrieta columnae, Romulea columnae. Ci porta invece nell'America tropicale il genere Columnea, che gli fu dedicato da Plumier con un vero e proprio peana: "Fabio Colonna, nobile romano, nato in quella antica ed illustrissima famiglia, che occupa il primo rango tra le più nobili famiglie italiane, da lodare sopra tutti per la squisita conoscenza della storia naturale. In effetti, in questo campo nulla è paragonabile alle opere di un uomo così grande, che si guardino le immagini disegnate di sua mano o le descrizioni e le dissertazioni critiche". Già sappiamo quanto lo ammirasse anche Linneo, che fece proprio il genere. Con oltre 200 specie riconosciute, Columnea L. è il più vasto dei generi delle Gesneriaceae neotropicali. Ovviamente, è anche uno dei più vari. Diffuso dal Messico alla Bolivia e verso Est fino allo stato di Amapá in Brasile, trova il suo habitat ideale nelle foreste pluviali, dove può disporre di umidità tutto l'anno; è a sua agio soprattutto in quelle fresche ad altitudine media. Anche se il genere comprende anche arbusti ed erbacee, è fondamentalmente rappresentato da epifite che vivono sui tronchi e tra i rami degli alberi della foresta pluviale, a volte anche a considerevole altezza. Possono essere erette, ricadenti o rampicanti, e hanno per lo più foglie in coppie opposte, carnose, lucide, da ovate a lineari. Le specie più frequentemente coltivate e più utilizzate per la creazione di ibridi, come C. hirta, C. linearis o C. magnifica, appartengono alla sezione Columnea, caratterizzata da fiori tubolari fortemente bilabiati, con i due lobi superiori fusi a formare una specie di cappuccio, o galea; in genere la corolla è rossa, ma talvolta aranciata o rosa. Per la loro forma, che ricorderebbe un pesce rosso, in inglese vengono chiamata flying fish plants. La sezione Ortholoma è invece caratterizzata o da corolle piccole così fittamente ricoperte di peli da nascondere la corolla stessa (è il caso di C. purpurata) o da appendici poste alla base dal calice, che sembra emergere da una soffice palla di peli (è il caso di C. minor). I fiori delle sezioni Collandra, a sua volta assai varia, sono in genere molto meno colorati; in alcune specie a dare spettacolo e a fungere da richiamo sono le foglie: quelle di C. consanguinea sono segnate da una vistosa macchia rossa traslucida a forma di cuore. La sezione Pentadenia raggruppa specie per lo più terrestri, erbacee o arbustive, alte ed erette, con fiori tubolari o imbutiformi. Anche le specie della sezione Stygnanthe sono per lo più terresti, con corolle tubolari prive di lobi. Infine, la sezione Angustiflorae riunisce specie erbacee epifite, con rami sottili e corolla tubolare stretta ed allungata, non bilabiata. Alle già numerose specie si sono aggiunte dozzine di ibridi, in genere considerati più adattabili e quindi più facili da coltivare rispetto alle specie; inoltre spesso sono in grado di fiorire tutto l'anno. Tra i più notevoli, 'Bonfire', con corolla fortemente bilabiata, tubo giallo-aranciato e apici dei lobi rossi; 'Orange Fire', con calice verde piumoso, lungo tubo giallo e piccoli lobi arancio; 'Early Bird' (una delle varietà più popolari), con corolla bilabiata, tubo giallo vivo e galea arancio; 'Broget Stavanger' ha invece lunghi rami ricadenti e foglie variegate. Per una selezione di specie si rimanda alla scheda. Nel 1696, il frate francescano Francesco Cupani pubblica lo straordinario Hortus Catholicus: è il catalogo delle circa 3000 tra specie e varietà che crescevano nello splendido giardino di Misilmeri, voluto da Giuseppe del Bosco principe di Cattolica. Accanto alle officinali di prammatica, c'erano le specie sicule, molte delle quali raccolte di persona da Cupani, assiduo esploratore della flora dell'isola, e le esotiche più rare, giunte in Sicilia grazie alla rete di corrispondenti italiani e europei abilmente coltivata dal botanico francescano. Rimase invece incompleta e inedita l'ultima opera di Cupani, l'ancor più grandioso Panphyton siculum. Il confratello Plumier volle ricordarlo con il genere Cupania, cui più tardi si affiancò Cupaniopsis. Al suo allievo Bonanno, che tentò di completarne l'opera inedita, è invece toccato il monotipico Bonannia. 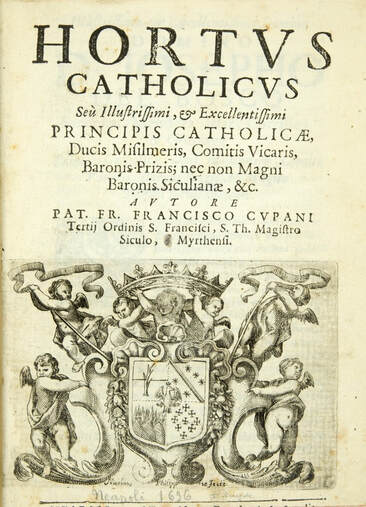 Un giardino straordinario e il suo catalogo Intorno al 1690, Giuseppe del Bosco, principe di Cattolica, decise di trasformare in orto botanico il Giardino Grande del suo palazzo di Misilmeri, a una quindicina di km da Palermo; già esistente almeno dal XV secolo, godeva di acque abbondanti grazie a una vicina sorgente. Non conosciamo nei particolari la genesi del progetto, che voleva anzitutto venire in soccorso delle genti bisognose del feudo attraverso la coltivazione di piante medicinali utili, ma è probabile che sia stato determinante l'incontro con il frate francescano Francesco Cupani (1657-1710), che da qualche anno si stava dedicando all'assidua esplorazione della flora siciliana. Nato a Mirto in provincia di Messina, come riferisce egli stesso nel prologo di Hortus Catholicus, Cupani inizialmente studiò medicina a Palermo, appassionandosi soprattutto di botanica; tuttavia a 24 anni entrò nel terzo ordine francescano, e lasciò lo studio della natura per la filosofia e la teologia, che in seguito insegnò prima a Verona poi a Palermo. La passione per le piante, relegata a svago marginale, si riaccese con forza al ritorno in Sicilia, alimentata dalla frequentazione di medici e speziali come Ignazio Arceri, medico del Regio nosocomio palermitano, e l'aromataro Nicola Gervasi (1632-1681), console del Collegio dei farmacisti e autore dell'Antidotarium Panormitanum Pharmaco-Chimico; di quest'ultimo, che Cupani definisce affettuosamente praceptor meus, "mio maestro", egli loda il giardino palermitano ricchissimo di piante rare. Ma la spinta determinante venne dall'esempio di Paolo Silvio Boccone, suo modello e assiduo corrispondente, che lo incoraggiò a proseguire le ricerche sulla flora indigena. Frutto di quattro anni di erborizzazioni, sfidando il caldo estremo dell'estate e i geli dell'inverno, è la prima opera edita di Cupani, Catalogus plantarum sicularum noviter adinventarum, pubblicata a Palermo nel 1692. Sono appena quattro pagine, con una lista di circa 150 piante in ordine alfabetico; secondo l'uso del tempo Cupani si avvale di nomi-descrizione polinomiali; ad esempio, l'attuale Euphorbia pithyusa subsp. cupanii figura come Tithymalus exiguus, pumilus, saxatilis, Portulaceae foliolis, flosculis rubentibus. A conclusione della lista, in una breve nota il francescano esprime la speranza di poter presto pubblicare le immagini delle piante, a meno che non lo faccia per lui il reverendo Silvio Boccone "famosissimo per la competenza erboristica", al quale ha inviato generosamente tutti gli exsiccata "mosso dall'onore della patria". Al momento dell'uscita del catalogo, il principe di Cattolica gli aveva già affidato la realizzazione del giardino di Misilmeri, in cui alle piante medicinali tanto native quanto esotiche si sarebbero affiancate ornamentali, piante esotiche rare, alberi da frutto e orticole. Per le piante medicinali e autoctone, il frate si avvalse della collaborazione di farmacisti ed erboristi come Pietro Citraro e Francesco Scaglione, nonché degli invii di numerosi corrispondenti che vivevano in parti dell'isola non esplorate di persona; ma continuò anche il lavoro sul campo, tanto che già nel 1694 fu in grado di stampare una seconda lista di piante siciliane, Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum, pubblicata sempre a Palermo, in cui le specie e varietà elencate sono salite a 300. Intanto il giardino cresceva grazie alla munificenza del principe, che lo trasformò in un luogo fatato con statue, fontane e addirittura uno zoo con animali esotici; lo circondava un muro coronato da oltre 600 vasi di piante esotiche, quasi un'anticipazione della ricchissima collezione di piante che racchiudevano. A farle arrivare in Sicilia fu una vasta rete di corrispondenti italiani ed europei che Cupani mise insieme forse con la mediazione iniziale di Boccone. Tra i corrispondenti più assidui troviamo infatti uno dei contatti di Padre Silvio, William Sherard, che a sua volta fece da tramite con botanici, appassionati e collezionisti britannici, gli inviò piante esotiche in cambio di semi siciliani, gli procurò libri (tra gli altri, Historia plantarum di John Ray). Determinante per la crescita del giardino fu poi Giovanni Battista Trionfetti, il curatore dell'orto botanico della Sapienza a Roma, che poté far giungere a Misilmeri le novità che affluivano a Roma grazie a gesuiti e sacerdoti viaggiatori. Tra i corrispondenti di Cupani troviamo molti altri grandi nomi della botanica del tempo: lo stesso Ray, Pitton de Tournefort, Caspar Commelin, i tedeschi Johann Georg Volkamer e Johannes Böhm. Questi scambi epistolari, oltre ad arricchire il giardino, consentirono al botanico siciliano di superare l'isolamento di una località periferica e di tenersi aggiornato sui progressi della botanica e sui grandi dibattiti del suo tempo, procurandosi i testi di riferimento indispensabili per catalogare le piante del giardino; nella nota di autorità premessa a Hortus Catholicus, egli elenca ben 90 titoli, tra i quali, oltre a testi già classici della botanica rinascimentale o del primo Seicento, troviamo libri di pubblicazione recente o recentissima, come il catalogo delle piante canadesi di Cornut (1635), Flora sinica di Boym (1656), la Centuria e il Prodromus di Breyne (rispettivamente 1678 e 1680), il catalogo delle piante olandesi di Jan Commelin (1683), i primi sei volumi di Hortus Malabaricus (1678-1686), il catalogo dell'orto botanico di Montpellier di Magnol (citato nella seconda edizione di Hortus Catholicus, e uscito lo stesso anno 1697). Come si vede, si tratta principalmente di cataloghi di orti botanici e di rassegne di flore esotiche: il problema principale che si poneva Cupani, come si evince anche dalla corrispondenza con Sherard, era infatti la corretta identificazione, per evitare di presentare come nuove piante già pubblicate in precedenza. Nonostante la grande mole di piante da identificare e descrivere, già nel 1696 Cupani fu in grado di dare alle stampe la prima edizione di Hortus Catholicus, accompagnata da un primo supplemento e seguita l'anno dopo da un secondo. E' un'opera imponente, che elenca circa 3000 tra specie e varietà; per le identificazioni e le denominazioni, Cupani rimase fedele all'insegnamento di Boccone, scegliendo una soluzione un po' datata: come punto di riferimento principale per l'identificazione dei generi (il concetto, anche se in modo ancora impreciso, si andava ormai affermando) si affidò all'autorità di Robert Morison, e al suo sistema basato sulla fruttificazione (che in qualche modo poteva essergli familiare, visto che anche Castelli, maestro del suo praeceptor Gervasi, si era basato sui frutti); per le specie e le denominazioni, oltre a Morison stesso, all'ancora più datato Pinax di Caspar Bauhin e all'Historia plantarum di Jean Bauhin. Come nelle liste precedenti, anche in Hortus Catholicus le piante si susseguono in ordine alfabetico, da Abies alba a Yucca. Per quelle già note, tipicamente Cupani parte dalla denominazione del Pinax, seguita, se differenti, da quelle di Jean Bauhin e di Morison; la voce si conclude (e questa invece è una novità) con il nome vernacolo siciliano, nel desiderio di allargare la conoscenza delle piante anche a chi non leggeva il latino. A mo' di esempio, ecco la voce iniziale (corrispondente a Abies alba Mill): Abies alba, seu foemina CBP [ovvero Caspar Bauhin Pinax], sive elate Thilia IB [ovvero Jean Bauhin], vulgo Erva di S. Filippu, o Arvulu cruci, Arvulu caccia diavuli. Ovviamente, se la pianta nel Pinax non compare, Cupani ricorre ad una o più altre autorità, ad esempio per l'attuale Hibiscus mutabilis L. a Paul Hermann, Morison e Ferrari: Althaea arborea, Rosea, Sinensis, flore multiplici HLB [Hermann, Hortus logduno-batavus], Althaea arborea, Sinensis Moris. Hist. 2 [Morison, Historia universalis Oxoniensis vol. 2], Rosa sinensis Ferrari Florae cult. vulgo Rosa Indiana. Per le piante non descritte in precedenza, Cupani usa una denominazione polinomiale, costituita dal nome generico seguito da uno o più epiteti. A tale proposito, si è spesso detto che egli abbia anticipato Linneo, facendo largo uso di nomi binomiali. Lasciando da parte i binomi ripresi da Bauhin (che a sua volta è ritenuto l'inventore dei nomi binomiali, ma non li usò in modo sistematico), vediamo se è vero con un esempio, tratto ancora dalla lettera A. Oltre a sei specie di Acetosa già descritte dai Bauhin e/o da Morison, Cupani ne descrive cinque nuove: "Acetosa Nebroides Arisari pallido-virenti folio", "Acetosa peregrina, lanceolata, vesiculis trigonis, venis sanguineis inscriptis", "Acetosa alienigena caule carens, sterilis, radice nimio reptatu, foecunda", "Acetosa lanceolato folio, e basi lata polyfido, Etnensis", "Acetosa montana angusto folio sagittae". Si tratta, evidentemente, di nomi descrizione polinomiali; anzi, nella secondo supplemento, Cupani esprime la sua perplessità di fronte a nomi troppo brevi che, egli teme, impedirebbero il riconoscimento proprio delle specie nuove. Per dirlo in altri termini, la separazione tra denominazione e descrizione, che Linneo stesso raggiungerà solo in Species plantarum, non è ancora avvenuta. Infatti, in Bibliotheca botanica, lo svedese collocò Cupani non certo tra gli innovatori o i sistematici, ma tra i curiosi, ovvero "coloro che raccolsero piante prima del tutto ignote o mal conosciute e le illustrarono con descrizioni e immagini". Il merito maggiore di Cupani sta ovviamente nell'esplorazione della flora siciliana, di cui fu instancabile raccoglitore e descrittore, segnando un passo avanti notevolissimo anche rispetto a Boccone. Da segnalare è anche l'attenzione alle produzioni agricole locali e soprattutto alle varietà delle piante fruttifere, che ne fanno un antesignano della pomologia: ad esempio, sono elencate e puntigliosamente descritte 35 varietà di mandorli, 48 di fichi, 45 di meli, 73 di peri, 48 di viti, 20 di limoni, 21 di aranci, 5 di cedri. Mentre scriveva Hortus Catholicus, Cupani già pensava a un progetto ancora più ambizioso: una vasta opera illustrata che avrebbe fatto conoscere al mondo la natura siciliana, descrivendo non solo le piante, ma anche gli animali, le conchiglie, i fossili, i minerali. Secondo quanto scrive nel prologo della prima edizione di Hortus Catholicus, intorno al 1696 il lavoro era già abbastanza avanzato: erano state incise 600 delle 800 lastre di rame previste (a pagarle fu evidentemente il generoso principe di Cattolica, che contava di trarre gloria europea dal munifico investimento); per quanto riguarda le piante era sua intenzione specificarne la denominazione secondo le indicazioni dei Bauhin e di Morison, il luogo di origine, le proprietà officinali, l'etimologia, i sinonimi in latino, il nome volgare, il segno celestiale, l'astro dominante e l'epoca più indicata di raccolta. Nel supplemento dell'anno successo, ci informa che ormai le lastre erano tutte pronte e il manoscritto a buon punto, tanto che contava, Dio volendo, di completarlo in pochi mesi. Ma, evidentemente, Dio non volle: il lavoro di raccolta e verifica si prolungò più del previsto e nel 1710 Cupani morì prematuramente, a poco più di cinquant'anni, lasciando l'opera incompleta. Torneremo più avanti sulla sorte di quell'opera sfortunata, per soffermarci sulle vicende successive del giardino di Misilmeri. Morto Cupani, che lo aveva fondato e diretto per quasi vent'anni, la direzione passò successivamente a due suoi collaboratori, Pietro Citraro e Francesco Scaglione. Nel 1714 ricevette la visita di Vittorio Amedeo II, appena divenuto re di Sicilia. Tuttavia nel 1721 Giuseppe del Bosco morì senza lasciare eredi diretti, e le proprietà e i feudi passarono al figlio di una sorella, Francesco Bonanno del Bosco. Nel corso del Settecento, i Bonanno sperperarono il patrimonio familiare. A risentirne fu anche lo splendido ma dispendioso giardino, via via sempre più trascurato. Intorno alla metà del secolo, ebbe ancora un sussulto, grazie all'arrivo da Padova dell'abile capo giardiniere Giovanni Maria Lattini, ma quando questi lasciò l'incarico, insoddisfatto del salario, il declino divenne inarrestabile. Nel 1785, all'atto della fondazione dell'orto botanico di Palermo, con il benestare del principe in carica, 2000 piante tra le più rare furono espiantate e traslate nel nuovo giardino, insieme a vasche di marmo, sedili di pietra e altro materiale. Da quel momento dell'antico Hortus Catholicus del principe Giuseppe del Bosco e di Francesco Cupani rimase solo il ricordo.  Da Cupania a Cupaniopsis A testimoniare il ruolo di Cupani nella scoperta delle piante sicule sono le diverse specie che lo ricordano nell'epiteto, come Colchicum cupanii, Genista cupanii, Aira cupaniana e la già citata Euphorbia pithyusa subsp. cupanii. Tributo alla fama europea del giardino e del suo creatore è invece la dedica del genere Cupania da parte di Plumier, che cita il giardino "ricchissimo di piante fatte venire dalle più remote contrade del mondo" nonché il suo "ordinatissimo catalogo". Poi validato da Linneo, il genere Cupania, della famiglia Sapindaceae, esclusivo dell'America tropicale, dal Messico all'Argentina, con centro di diversità in Brasile, comprende circa 60 specie di alberi e arbusti, che vivono in vari habitat, dalle foreste stagionalmente aride alle foreste pluviali. Benché presentino sia fiori femminili sia fiori maschili sulla stessa pianta, sono funzionalmente dioiche e poligame, poiché i fiori staminati (maschili) e quelli nettariferi (femminili) si aprono in momenti diversi. Hanno foglie composte alternate, con nervature molto evidenti, generalmente coriacee, spesso con faccia superiore glabra e inferiore tomentosa; i fiori, piccoli, con cinque petali e cinque sepali, sono raccolti in grandi infiorescenze spesso molto ramificate e sono seguiti da capsule che contengono semi arillati. Tra le specie di maggiore diffusione, citiamo C. cinerea, originaria delle foreste umide dalla Costa Rica al Brasile, a volte coltivata come ornamentale; particolarmente notevoli i frutti, che a maturazione si aprono formano una stella coriacea con al centro semi neri avvolti in un arillo aranciato. Per la sua chioma elegante, è spesso utilizzata nelle alberature anche C. vernalis, diffusa dalla Bolivia al Brasile e all'Argentina settentrionale. A celebrare indirettamente Cupani, si è aggiunto il genere Cupaniopsis ("simile a Cupania"), stabilito da L.A.T. Radlkofer nel 1879. Anch'esso appartenente alla famiglia Sapindaceae, raggruppa una quarantina di specie di alberi e arbusti diffusi in Nuova Guinea, in Australia e nelle isole del Pacifico; ricorda Cupania per le foglie composte e i frutti a capsula. Purtroppo molte piante di questo genere, endemiche di piccole aree, sono minacciate, in pericolo di estinzione o addirittura già estinte, come C. crassivalvis della Nuova Caledonia, dichiarata estinta nel 1998. La specie più nota è l'australiana C. anacardioides, nota con il nome vernacolare tuckeroo. E' un piccolo albero originario delle foreste litoranee dell'Australia orientale e settentrionale. Più che al momento della fioritura, diventa spettacolare al momento della fruttificazione, quando produce grandi grappoli di capsule aranciate che si aprono in tre lobi, rivelando i semi scuri ricoperti da un arillo arancio brillante; sono appetiti da numerose specie di uccelli. Per la sua bellezza, anche questa specie è spesso utilizzata nelle alberature stradali, soprattutto nelle zone costiere vista la sua tolleranza alla salinità.  Un'opera maledetta e una pianta tossica Per concludere, resta ancora da raccontare della sorte dell'ultima opera inedita di Cupani. Nel 1713, probabilmente per volontà del principe, sotto il titolo Panphyton siculum vennero stampate le sole immagini, con una tiratura di poche copie (se ne conoscono in tutto sette), per altro diverse tra loro, tanto da fare pensare a prove di stampa. I manoscritti furono invece affidati, perché li completasse e li preparasse per la stampa, al farmacista Antonio Bonanno, nei testi d'epoca spesso chiamato Antonino, figlio di Vincenzo, uno dei collaboratori di Cupani, e di una figlia di Nicola Gervasi (per questo motivo, è anche noto come Bonanno Gervasi). Bonanno riuscì a rivedere e predisporre un primo volume, con 187 tavole, che fu stampato nel 1719, ma lo stesso anno morì. Come abbiamo già visto, nel 1721 morì anche il principe, e con la sua morte ebbe fine ogni tentativo di pubblicare quell'opera sfortunata. I manoscritti furono ereditati da un'altra famiglia di farmacisti imparentata con i Bonanno, i Chiarelli, che custodirono gelosamente una copia di Panphyton Siculum in quattro volumi, appartenuta a Antono Bonanno con le sue annotazioni manoscritte, e 16 volumi di note manoscritte di Cupani. Desideravano pubblicarli, ma mancavano le risorse finanziarie. Il momento giusto sembrò arrivare quando entrarono in contatto con il botanico statunitense Rafinesque, che visse in Sicilia dal 1805 al 1815. Deciso a far risorgere il Panphyton, da lui ribattezzato Panphysis sicula, fece approntare copie delle incisioni e cercò di coordinare i suoi sforzi con quelli dei Chiarelli, ma poi anche lui dovette rinunciare. Nel 1815, quando ripartì dall'America, portò con sé le 121 tavole di incisioni che era riuscito a far preparare; al largo del Connecticut si inabissarono nelle acque dell'oceano, insieme alla biblioteca di Rafinesque e circa 60 casse di collezioni; il botanico salvò la vita, ma dovette ricominciare dal nulla. Non stupisce che egli abbia voluto ricordare il tentativo dell'altrettanto sfortunato Bonanno; nel 1814 pubblicò su un giornale siciliano, Specchio delle scienze, il genere Bonannia (Sapindaceae) con queste parole "Questo genere ha gran somiglianza con Cupania [...]; gli ho perciò dato il nome di Bonannia in onore di Antonino Bonanni Gervasi, discepolo ed illustratore del P. Cupani, e del P. Filippo Bonanni gesuita, autore di una conchilogia". Pubblicato su una rivista locale, il nuovo genere passò inosservato. Come nomen rejicendum, è oggi sinonimo di Blighia. Nel 1826, fu la volta del boemo Presl che in Flora Sicula creò un secondo genere Bonannia (Brassicaceae), in onore tanto di Vincenzo quanto di Antonio Bonanno "coetanei e discepoli del reverendo Cupani". Oggi è sinonimo di Brassica. Infine, nel 1843 Gussani in Florae Siculae Synopsis creò un terzo genere Bonannia (Apiaceae); anche se non lo cita esplicitamente, il riferimento a una tavola del volume curato da Bonanni, fa presumere che il dedicatario sia sempre lui; benché sia l'ultimo arrivato, fu accettato dalla comunità scientifica ed è tuttora valido come nomen conservandum. Si tratta di un genere monotipico, rappresentato dalla sola B. graeca, una rara erbacea dei pascoli montani aridi, presente in Sicilia dal Messinese al Palermitano, in Calabria nella Sila e nel Pollino e in poche località sparse in Grecia e nell'Egeo. E' un'erbacea perenne, alta fino a 30 cm, con foglie basali lanceolate e foglie cauline ridotte a guaine, e fiori gialli riuniti in ombrelle. Tutta la pianta emana una resina giallastra tossica, che può causare la morte degli agnelli. Paolo Boccone, che prese il nome di Silvio quando entrò nell'ordine cistercense, è uno dei più importanti botanici italiani del Seicento, certo il più noto a livello interazionale, grazie ai suoi viaggi, ai molti contatti, all'erudizione delle sue opere. Lo testimoniano i luoghi di pubblicazione, che vanno da Parigi a Oxford, da Amsterdam a Venezia, e i molti erbari che confezionò per i suoi protettori e mecenati, conservati a Lione, Parigi, Leida, Oxford, Innsbruck, Vienna, Breslavia. Il suo maggior merito fu attirare l'attenzione degli studiosi europei sulla peculiare flora siciliana, che fu uno dei primi ad esplorare. Plumier, che fu suo allievo a Roma, volle onorarlo con il genere Bocconia, poi validato da Linneo. 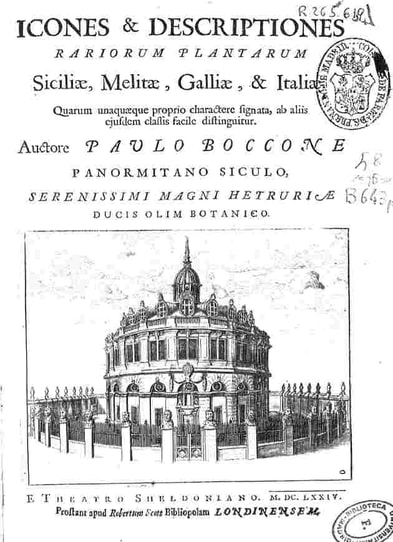 Da Palermo a Parigi Il palermitano Paolo Boccone (1633-1704) fu una figura di caratura internazionale per le sue ricerche che, oltre alla botanica, toccarono la chimica, la mineralogia, la natura dei fossili, le eruzioni dell'Etna e molti altri argomenti. Eppure, la sua biografia è tutt'altro che chiara, e molte delle notizie che si ripetono su di lui mancano di prove: ad esempio, non è affatto provato che la sua famiglia fosse di nobili origini, né che si sia laureato a Padova, né tanto meno che abbia insegnato in quell'ateneo. Molto incerta è la cronologia della sua vita, in particolare dei viaggi che lo portarono a visitare molti paesi europei. Nacque a Palermo da una famiglia oriunda di Savona e si ritiene si sia avvicinato alla botanica, alla chimica e alla scienze naturali grazie alla frequentazione di Pietro Castelli e dell'orto botanico di Messina, ma neppure di questa notizia spesso ripetuta abbiamo alcuna evidenza; fu invece con certezza allievo del matematico Giovanni Alfonso Borelli, che conobbe a Messina e di cui intorno al 1655 seguì le lezioni a Pisa. Lasciata la Sicilia, continuò infatti gli studi a Perugia, a Padova e nella città toscana. Nella seconda metà degli anni '50 dovette fare la spola tra la Sicilia e la Toscana, dove sperava di inserirsi stabilmente alla corte del granduca. In effetti per qualche tempo divenne uno dei semplicisti di Ferdinando II; nel frontespizio di gran parte delle sue opere, non manca di ostentare questo titolo, usando formule diverse: "botanico del serenissimo duca di Toscana", "serenissimi magni Hetruriæ ducis Phylliatra", "Herboriste de Ferdinand II de glorieuse mémoire Grand-Duc de Toscane"; il suo compito principale doveva essere quella di raccogliere piante e semi per arricchire i giardini granducali, nonché gli orti dei semplici di Pisa e Firenze. Era però una posizione subordinata e poco soddisfacente (nella dedicatoria a Cosimo III di Recherches et observations naturelles del 1674 scrive più realisticamente "per qualche tempo ho avuto l'onore di essere uno degli erboristi del fu Monsignore vostro padre"); Boccone dunque si rassegnò a tornare in Sicilia, dove si fissò almeno dal 1663. Si sposò e cercò di conciliare gli impegni familiari (che egli definisce "noiosi", ovvero penosi e difficili) con le ricerche naturalistiche, specialmente con il "diletto di osservar piante", che lo portò a percorrere molte contrade dell'isola. Erano un oggetto di studio, ma anche un cespite d'entrate; nel 1668 a Catania pubblicò l'elenco di piante siciliane Manifestum botanicum de plantis Siculis, il cui scopo commerciale è palese nella riedizione dello stesso anno, Elegantissimarum plantarum cultoribus, nec non obseruatoribus perdoctis, quibus forte desunt infrascripta semina nunc recentia offeruntur, & communicantur honesto pretio per Paulum Boccone Panormitanum, ovvero un catalogo di semi offerti a studiosi e appassionati a giusto prezzo. Importante fu la frequentazione del pittore messinese Agostino Scilla, con il quale condivideva l'interesse per i fossili, la geologia, le specie marine e quelle strane forme che paiono al confine tra i regni della natura: coralli, madrepore, fossili marini, pietre a forma di conchiglia o di lingua. In questi anni risiedeva nella Sicilia orientale, tra Leontini, Messina e Catania, dove pubblicò i suoi cataloghi e il suo primo saggio naturalistico, Della pietra belzuar minerale Siciliana, dedicato a Giacomo Ruffo visconte di Francavilla e scritto sotto forma di lettera al farmacista bolognese Giacomo Zannone, uno dei suoi clienti e corrispondenti. Nel 1668 visitò Malta, dove stabilì qualche utile contatto, raccolse poche piante (nel libro sulla flora siciliana e maltese che pubblicherà qualche anno dopo a Oxford ne figurano solo tre e un fungo), ma molti fossili tra cui le ricercatissime glossopietre. Rientrò poi a Messina, dove fece escursioni e ricerche congiunte con Scilla. Ebbe anche modo di assistere all'eruzione dell'Etna, la più importante dell'epoca. Si trovava nell'isola ancora nel marzo 1669, come risulta da una lettera a Redi in cui accenna all'acquisto di semi per l'orto botanico di Pisa su incarico del granduca. La morte della moglie, avvenuta quell'anno, e la speranza di reinserirsi nell'ambiente toscano lo spinsero a lasciare l'isola. Nella seconda metà del 1669 era a Firenze, dove mostrò le sue collezioni al granduca, ma la morte di quest'ultimo nel maggio 1670 lo convinse a cercare fortuna altrove. Munito di lettere di presentazione dell'archiatra Giovanbattista Gornia, di altri medici toscani e del Gran Priore dell'ordine di Malta Valencé, si imbarcò per la Francia. Dalle raccolte botaniche, risulta che erborizzò nei dintorni di Marsiglia ed Aix e nell'Isola Ste Marguerite, di fronte a Cannes. Fu poi a Lione, dove è conservato uno dei suoi erbari e per tre mesi insegnò la bella arte della botanica a due distinte dame (come aveva già fatto in Italia con "gentiluomini di prima qualità"). Era sicuramente a Parigi all'inizio del 1671; infatti, secondo quanto egli stesso scrive nel curioso dialogo "Entretien d'un Seigneur de la Cour de France avec M. Boccone" che conclude Recherches et observations naturelles sur la production de plusieurs pierres, nell'aprile di quell'anno aveva iniziato a tenere nella sua casa parigina quelli che potremmo definire dei seminari in cui presentava le curiosità che aveva portato con sé dall'Italia e determinava le piante proposte dai partecipanti: ognuno era invitato a portarne con sé "fino a mezza dozzina, fresche o essiccate, per essere esaminate, scegliendole tra le più curiose e le più rare"; gli incontri si tenevano il giovedì all'una, ogni due settimane, e Boccone vi parlava “di piante, di animali, di pietre, di metalli, e di tutto ciò che di più raro e prezioso la natura racchiude nel suo seno”. Dal dialogo scopriamo anche che il botanico siciliano aveva portato con sé i semi di piante da offrire al Re cristianissimo per arricchire il Jardin du Roi, e a tal fine aveva preso contatto con il sovrintendente Vallot, che li aveva rifiutati, sostenendo che erano vecchi e non più vitali, anche se Boccone chiedeva di essere ricompensato solo per quelli che avrebbero germinato. Non era dunque un dono, ma una transazione commerciale. Il trattatello, stampato a Parigi appunto nel 1671, oltre al dialogo fittizio, contiene cinque saggi in forma di lettera su pietre dalle forme curiose, la pietrificazione di parti di animali e l'eruzione dell'Etna, che riproducevano in forma scritta le conferenze tenute da Boccone all'Accademia privata fondata dal medico del principe di Condé, l'abate Pierre Bourdelot. Seguì una seconda serie, intitolata Recherches et observations curieuses sur la nature du corail, con ulteriori cinque lettere sul corallo e alcuni pesci; nell'introduzione dell'editore si preannuncia la prossima uscita di un'opera illustrata totalmente dedicata alle piante. Rispetto a un opuscolo con poche immagini, si trattava di un'operazione editoriale decisamente costosa, che Boccone non poteva affrontare senza un mecenate. In realtà, proprio grazie a Bourdelot, ne aveva incontrato uno dal nome altisonante, appunto il gran Condé; ma il principe, in disgrazia per la sua partecipazione alla Fronda, era privo di ogni influenza politica e viveva lontano dalla corte, nella sua tenuta di Chantilly; Boccone dovette frequentarla con una certa assiduità e una sua erborizzazione è testimoniata dal Cahier de Chantilly, un quaderno di piccolo formato probabilmente di sua mano in cui le piante raccolte sono elencate utilizzando per lo più la nomenclatura del Pinax di Caspar Bauhin; la seconda parte del manoscritto è un erbario, non costituito da exsiccata, ma da impressioni ottenute inchiostrando esemplari secchi, una tecnica impiegata qualche anno primo anche da Fabio Colonna e perfezionata dallo stesso Boccone. Era invece un più tradizionale erbario di piante essiccate quello che Boccone avrebbe approntato per un altro principe reale in odore di Fronda, il botanofilo Gastone d'Orlèans, ugualmente conservato a Parigi; visto che il principe morì nel 1660, quando Boccone viveva ancora in Toscana ed era del tutto sconosciuto, è escluso che gli sia mai appartenuto, tanto più che contiene piante sicuramente raccolte da Boccone nelle Fiandre nel 1672; moltissimi esemplari sono invece comuni all'erbario del Principe di Condé, anche se non sappiamo quando e per chi il botanico siciliano preparò il cosiddetto "erbario di Gastone d'Orlèans". 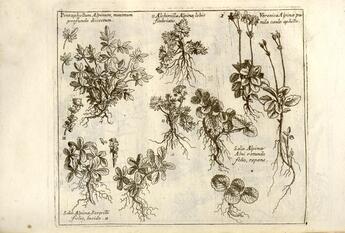 Un naturalista di fama europea Nel 1672 Luigi XIV si decise a riabilitare il gran Condé per servirsi del suo genio militare nella campagna contro l'Olanda. Una buona notizia per lui, ma non necessariamente per Boccone, che vide il suo principale protettore partire per il campo di battaglia. Forse il suo manoscritto, con le descrizioni delle piante raccolte in Sicilia, a Malta, in altre regioni italiane e in Francia e le illustrazioni a stampa diretta, era pronto, ma mancava chi lo finanziasse. Ma la cronologia si imbroglia di nuovo; non sappiamo quando abbia lasciato la Francia né se abbia visitato altri paesi, a parte una visita ad Anversa nel 1672. Di certo invece si trovava a Londra il 5 maggio 1673, giorno in cui presentò alla Royal Society, alla quale aveva donato un gabinetto di curiosità e una piccola natura morta di Agostino Scilla, una memoria su alcune pietrificazioni siciliane. Fu presumibilmente in questo ambiente che conobbe un gentiluomo appassionato di botanica e giardinaggio, Charles Hatton, che era stato allievo di Robert Morison e decise di inviare il manoscritto al suo maestro. L'arrogante Morison per una volta comprese pienamente il valore di quel materiale, e si diede da fare per prepararlo per la pubblicazione. Hatton, benché non fosse un nababbo, non fece mancare il sostegno finanziario, così nel 1674, per i tipi dell'Università di Oxford, uscì Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae, con la descrizione di un centinaio di piante (ci sono anche alcuni funghi), più della metà delle quali siciliane, e incisioni ricavate dalle immagini a stampa diretta; saltando i passaggi del dipinto e del disegno al tratto, i costi si riducevano di molto, ma i risultati, tranne che nei casi di piante minute o dalle forme lineari, lasciano spesso a desiderare; diverse immagini erano di qualità così bassa che Morrison le scartò e le sostituì con sette incisioni calcografiche, che furono pagate da Hatton così come la stampa. Con il libro fresco di stampa, Boccone ripartì alla volta dell'Olanda, deciso a farlo conoscere e cercare nuovi sponsor per stampare le sue opere erudite sulle curiosità naturali; sappiamo che pensò a Hieronymus van Beverningh, il protettore di Paul Hermann, visitò diversi gabinetti di curiosità, donò uno dei suoi erbari a Arnold Seyen, professore di botanica a Leida. Tra gli altri, incontrò il microscopista Johannes Swammerdam, perfezionando l'uso del microscopio che fu il primo ad applicare allo studio dei fossili. Incontrò anche il farmacista Johann Breyne, ma mancò il nipote Jacob, il collezionista e botanico di Danzica. Nel 1674 ad Amsterdam uscì Recherches et observations naturelles, che riprende ed amplia le pubblicazioni parigine e le comunicazioni alla Royal Society; le lettere, indirizzate ad eminenti esponenti della scienza italiana, francese, inglese e olandese, sono ora 29, e toccano argomenti disparati. In ogni caso, assicurarono la fama europea di Boccone. Sulle vicende successive e sulla data del rientro in Italia di nuovo la cronologia e i percorsi (ricavabili per lo più dai luoghi di raccolta delle piante citate in Museo di piante rare e da notizie sparse in varie opere) si fanno incerti e intricati. Forse tornò per qualche tempo in Francia, e certo sulla via del ritorno visitò il Delfinato e la Savoia (raccolse alla Grande Chartreuse e a Chambéry), varcò le Alpi al passo del Moncenisio, dove fece notevoli raccolte, quindi visitò il giardino reale di Torino. Fu poi la volta della Liguria, da dove passò in Corsica, visitata nel 1677. Nel 1678 era a Roma, dove ritrovò Agostino Scilla e frequentò l'accademia fisico-matematica fondata da Giovanni Giustino Ciampini, di cui condivideva il metodo sperimentale e lo spirito di ricerca. Lo si vedeva anche alle riunioni dell'Accademia reale voluta da Cristina di Svezia, cui donò l'ennesimo erbario. Passato per donazioni successive all'Istituto botanico di Genova, è probabilmente andato perduto durante la seconda guerra mondiale. Forse Boccone anche a Roma teneva lezioni ed accademie come quelle parigine; certo tra i suoi discepoli vi fu Charles Plumier, che in quegli anni studiava presso il convento dei minimi di Trinità dei monti. In questo stesso torno di anni, incominciò a corrispondere con Francesco Cupani, incoraggiandolo ad esplorare la flora siciliana. Non sappiamo come maturò la decisione, alla vigilia dei cinquant'anni, di abbracciare lo stato ecclesiastico. Nel 1682 entrò nell'ordine cistercense, assumendo il nome di Silvio (Sylvius) e svolgendo il noviziato a Firenze. Non per questo cessò di studiare e di viaggiare per raccogliere piante e oggetti naturali. Nel 1684 pubblicò a Bologna Osservazioni naturali, sempre sotto forma di lettere a medici e dotti soprattutto bolognesi e veneti, dedicate ad argomenti disparati, in cui sembrano prevalere gli aspetti più curiosi della natura, dai "fuochi naturali" di cui i contadini modenesi si servono per cucinare alle formiche o mosche odorose della campagne pisane. Delle piante si parla soprattutto per le proprietà farmacologico-terapeutiche, ma nella lettera 21 si disquisisce "delle cause della viridità perpetua di alcune piante in tutte le stagioni". Bologna non fu certo l'ultima tappa della sua vita errabonda. Nella biblioteca nazionale di Vienna sono conservati due piccoli erbari di Boccone, da lui dedicati "alla sacra maestà cesarea di Leopoldo Primo", in cui probabilmente sperava di trovare l'ennesimo mecenate. Il primo è intitolato "Piante originali e rare ostensive", è firmato Paolo Boccone ed è relativo alle piante di Icones et descriptiones; il nome secolare e il contenuto ci rimandano a una data precedente il 1682, forse addirittura agli anni francesi. Il secondo, intitolato "Piante dell'Austria", è invece firmato Silvio; sul recto di ciascun foglio sono incollate piante piuttosto comuni dei dintorni di Vienna, sul verso sintetiche indicazioni sul loro uso terapeutico, certamente di mano del botanico siciliano, di cui documentano il passaggio in Austria probabilmente negli anni '90. Sono gli anni in cui Boccone, con il nome onorifico di Plinius II, è ammesso all'Accademia curiosorum naturae di Halle, posta sotto l'alto patronato di Leopoldo I e ribattezzata Accademia cesarea leopoldina. Come risulta da Museo di piante rare, da Vienna si spostò a Brno, Bratislava, quindi potrebbe aver raggiunto Wroclaw, dove è conservato un altro erbario. Secondo una serie di documenti in gran parte inediti ritrovati dalla studiosa palermitana Floriana Giallombardo, i viaggi in Europa centrale si collocano tra il 1694 e il 1697. Ma era soprattutto di casa in Veneto. Nel 1694 fece raccolte in Dalmazia e nel 1697 pubblicò a Venezia Museo di fisica e di esperienze, l'ultima delle grandi opere miscellanee su svariati argomenti di scienze naturali, e Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, la più ampia delle sue opere botaniche. L'impostazione è assai diversa rispetto alla sintetica opera oxoniense: le descrizioni delle piante, che rimangono brevi o brevissime, sono riunite in gruppi o decadi affini per qualche ragione (ad esempio, le analoghe proprietà medicinali, l'origine alpina, il profumo simile delle foglie) e si alternano a trattati più ampi, sotto forma di lettere aperte ad altrettanti dotti e mecenati. Le tavole, di buona qualità, non sono più alternate al testo, ma riunite nella seconda parte del volume; ne risulta un'opera corposa, di quasi 200 pagine di testo e 130 tavole calcografiche con 319 figure. È dedicato "ad alcuni nobili patritii Veneti protettori della botanica, e delle buone lettere", ovvero agli sponsor che aprirono la borsa per finanziare il bello e certamente costoso volume. Alle piante già pubblicate in Icones et descriptiones si sono aggiunte quasi duecento nuove specie; i nuclei principali di raccolta, il cui luogo è quasi sempre puntigliosamente indicato, sono il Moncenisio, le Alpi Apuane, la Corsica, l'Appennino modenese e la zona di Norcia/Monti Sibillini; frequenti pure le raccolte dei territori di Bologna, Roma e Padova. Se il grosso Boccone lo raccolse personalmente, qualche specie si deve a doni e invii di amici e corrispondenti; il gruppo più cospicuo gli fu donato dal domenicano francese Jacques Barrelier, che probabilmente Boccone conobbe a Parigi (e non a Roma, come scrivono alcuni). Nella prefazione, Boccone racconta che fu incoraggiato a pubblicarlo da William Sherard, che nel 1697 come lui si trovava a Venezia; quando gli mostrò le sue raccolte, l'inglese confermò che molte piante erano inedite. L'anno successivo, il volume fu recensito da John Ray sulle Transactions della Royal Society, che ne riconosce l'importanza ("ci offre una vasta collezione di piante rare, la maggioranza delle quali sono nuove e mai descritte"), ma rimarca tre difetti: le piante sono collocate senza alcun ordine o connessione; le descrizioni si limitano a pochi elementi, senza una sufficiente descrizione delle parti principali; mancano i sinonimi delle piante descritte da altri botanici; prosegue poi facendo le pulci a diversi passi specifici. Questa recensione agrodolce è comunque una carezza in confronto alla reazione di Antoine de Jussieu che accusò Boccone di plagio per aver pubblicato alcune piante raccolte da Barrelier (di cui per altri riconosce sempre apertamente la paternità). Dopo il grande exploit dei due Musei, Boccone dovette ritornare a Palermo; visse gli ultimi anni nella Abbazia di Santa Maria di Altofonte in Parco, a 5 km dalla città, divenendone anche priore; qui morì nel 1704. Come pioniere dello studio della flora siciliana, e più in generale mediterranea, gli è stata dedicata la rivista Bocconea, edita dalla fondazione internazionale Pro Herbario Mediterraneo.  Una bella invadente Come scopritore di decine di specie inedite (intorno a 120), Boccone è ricordato dall'epiteto di numerose specie, dallo splendido Eryngium bocconei a Limonium bocconei, da Seseli bocconei a Hieracium bocconei. Il genere Bocconia si deve a Plumier che in Nova plantarum americanarum genera riserva a Boccone termini assai elogiativi: "Il reverendo padre Dom Silvio Boccone, in precedenza Paolo Boccone, nobile gentiluomo palermitano, celeberrimo in tutto il mondo letterario per le sue opere sia botaniche sia naturalistiche, che dopo aver contemplato molte parti del mondo terrestre, si accinge a meditare su quello celeste, essendo stato accolto nell'ordine cistercense a Firenze". Non fa cenno di esserne stato allievo, ma confermò la circostanza all'amico Garidel. Fatto proprio da Linneo, il genere Bocconia (Papaveraceae) riunisce una decina di specie di arbusti e piccoli alberi, diffusi nei Caraibi, in Messico e in Sud America. Hanno rami sottili, grandi foglie lobate o dentate, piccoli fiori apetali raccolti in pannocchie terminali; i rami spezzati emanano un latice giallastro o arancio, con proprietà antidolorifiche; dalla corteccia di alcune specie si ricava invece una tintura gialla. La specie più nota e diffusa è B. frutescens, nativa del Messico, delle Antille e di parti del centro e del Sud America, dove si trovi in habitat diversi, dalle foreste aride a quelle umide, incluse quelle nebulose, nonché in terreni disturbati. E' un grande arbusto o piccolo albero, alto fino a sei metri, molto ramificato, con rami sottili e intricati, che portano all'apice gruppi di grandi foglie profondamente lobate. Benché i fiori siano privi di petali, le grandi infiorescenze a pennacchio risultano piuttosto decorative. Per questo, intorno al 1920 è stata introdotta come pianta da giardino nelle Hawaii, dove si è rivelata una pericolosa infestante. Produce infatti una grande quantità di piccoli frutti, mangiati e dispersi dai semi, e cresce in fretta, sottraendo luce e nutrienti alle piante native. Non fa invece più parte del genere B. cordata, trasferita al genere Macleaya come M. cordata. Nel 1638, il medico e botanico romano Pietro Castelli ottiene dal senato di Messina il terreno e i finanziamenti per creare l'orto dei semplici universitario. E' il primo della Sicilia, anzi del Sud Italia, guarda al modello di Padova, ma due elementi lo rendono unico: la disposizione delle piante, per la prima volta sistematica, e l'attenzione alla flora endemica con le piante provenienti dalle pendici dell'Etna. Di colpo, Messina diventa una delle capitali europee della botanica, e gli allievi di Castelli Boccone e Cupani ne metteranno a frutto gli insegnamenti. A ricordarlo il genere monotipico Castellia, la cui unica rappresentante è presente in Italia solo in pochissime località di Sicilia e Sardegna.  Anni romani L'orto botanico "Pietro Castelli" di Messina fu il primo della Sicilia e dell'Italia meridionale; a fondarlo nel 1638 fu il romano Pietro Castelli (1583-1661) che abbiamo già incontrato in questo post, a proposito della paternità dell'opera sugli orti farnesiani Exactissima descriptio. Il senato accademico lo aveva chiamato a Messina ad occupare la prima cattedra di medicina; malgrado all'epoca avesse già pubblicato molto e fosse da anni un personaggio di spicco dell'ambiente medico-botanico romano, la sua vita fino a quel momento presenta molti punti oscuri, a iniziare dalla stessa data di nascita. A. De Ferrari, nella voce a lui dedicata nel Dizionario biografico degli italiani (che è anche la biografia più ampia del nostro) lo dice nato a Roma "tra il 1570 e il 1575 da Francesco e Diana de Giorgi". Erik Neil, in un interessante articolo sulla nascita dell'Hortus messanensis, fa notare che la data sembra piuttosto alta se consideriamo che pubblicò le prime opere intorno al 1620, ovvero tra i 50 e i 45 anni; possiamo aggiungere che al suo arrivo a Messina avrebbe superato la sessantina. Il mistero della data di nascita può essere facilmente sciolto se identifichiamo il padre Francesco Castelli con il pittore fiammingo Frans van de Casteele o Kasteele, attivo a Roma almeno dagli anni '70 del Cinquecento e noto come Francesco de Castelli. Dalla voce a lui dedicata dal Dizionario biografico, scritta da Nicole Dacos, risulta che sua moglie si chiamava Diana de Giorgis e che la coppia ebbe tre figli: Pietro nel 1583, Michele nel 1587, Stefano nel 1595. C'era anche una sorella, Caterina Castelli, che nel 1603 sposò un altro fiammingo romanizzato, Hendrik De Raef, che a Roma si faceva chiamare Enrico o Arrigo Corvino e gestiva la celebre farmacia "All'aquila imperiale". La parentela non è sfuggita agli storici dell'arte e ai biografi della nipote, la notevole miniatrice Maddalena Corvina, figlia di Enrico e Caterina, che collaborò tra l'altro al trattato De Florum cultura di Giovanni Battista Ferrari, ma soprattutto è confermata dallo stesso Pietro Castelli che nel 1621 dedicò una delle sue prime opere, Discorso della durazione de medicamenti tanto semplici quanto composti, "alli molto illustri signori li SS. Francesco Castelli e Diana de Georgi, padre e madre miei carissimi"; segue un ditirambo che funge da epitaffio al padre, morto nell'ottobre di quell'anno. Frans van de Casteele era un pittore piuttosto noto, più volte eletto principe dell'Accademia di San Luca; poté quindi garantire al figlio maggiore una buona educazione. Pietro studiò medicina all'università di Roma, dove ebbe tra i suoi maestri Andrea Bacci, Marsilio Cagnati e Andrea Cesalpino, certamente il più influente e venerato, tanto che in Hortus Messanensis lo celebra come "medico, peripatetico e semplicista illustrissimo, e amorevolissimo maestro nostro". Una seconda figura di riferimento fu certamente il cognato Enrico Corvino che in Exactissima descriptio è definito "insigne farmacopio e botanico" ed è citato con elogio e affetto in Hortus Messanensis. La farmacia di Corvino era un punto di incontro dei naturalisti romani, frequentato tra l'altro da Federico Cesi, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, e dall'erudito e collezionista Cassiano dal Pozzo. Grazie agli insegnamenti di Bacci e Cesalpino, e agli incoraggiamenti del cognato, Castelli dovette incominciare a farsi un nome come semplicista, ovvero come esperto di piante officinali; scrivendo di sé stesso in Hortus messanensis (pubblicato nel 1640) dice "40 anni continui ho fatto il maestro de' semplici in Roma e altrove", quindi più o meno dall'inizio del secolo; il che significa che probabilmente insegnava botanica privatamente. Improbabile che abbia terminato gli studi nel 1594, come afferma De Ferrari; certo si laureò entro il 1615, data in cui è indicato come medico nell'archivio di S. Lorenzo in Lucina. Nel 1619, presso Mascardi (l'editore dei Lincei) pubblicò la sua prima opera edita Defensio antiquorum utentium Arsenico et Sandaraca, che gli diede una certa rinomanza europea. E' il primo degli undici titoli pubblicati presso lo stesso editore fra il 1619 e il 1634, di argomento prevalentemente farmacologico, ma anche botanico, come le epistole De Elleboro (1622) in cui dimostrò che negli scritti di Ippocrate quando si parla di elleboro si fa riferimento a quello bianco (Veratrum album) e non a quello nero (Helleborus niger). In una data imprecisata divenne medico personale di Lelio Biscia (1573-1638), collezionista e mecenate delle arti, una figura influente dei pontificati di Paolo V e Urbano VIII, che lo fece cardinale nel 1626. Su sua sollecitazione scrisse un trattato sulle eruzioni del Vesuvio (Incendio del Monte Vesuvio, 1632) e annotazioni all'Antidotario romano, nella cui prefazione ricorda con riconoscenza che il cardinale gli procurò "un luogo nel fioritissimo studio di Padova con amplo stipendio". Nulla sappiamo del soggiorno padovano di Castelli, neppure se precede o segue l'incarico di lettore dei semplici presso la Sapienza che giunse nel 1625-26 grazie alla protezione del cardinale Francesco Barberini; nel 1629, alla morte di Johannes Faber, da "simplicista straordinario", che dimostrava i semplici i giorni festivi, divenne "simplicista ordinario", ovvero insegnante teorico di medicina e botanica; nel 1627 le sue lezioni trattarono i sintomi, nel 1628 le urine, nel 1629 le malattie infantili, nel 1630 i libri I e II di Dioscoride, nel 1631 i minerali. Faber era stato anche direttore dell'orto botanico pontificio e non è chiaro se Castelli gli subentrò anche in questo incarico. Diversi studiosi sostengono di sì, ma da un'amara lettera inviata anni dopo da Messina a Cassiano dal Pozzo sembrerebbe che gli sia stato preferito Tobia Aldini: "essendo io in Roma lettor de Semplici, ero senza Horto, hora ho l’horto e non la lettura de semplici [...]. Dunque Tobia [ha] l’Horto". E aggiunge "Roma non mi volse ne per Teorico ne per Prattico". A me sembrerebbe escluderlo anche il frontespizio di Hortus messanensis, in cui Castelli esibisce orgogliosamente tutti i suoi titoli; mentre si proclama "primo prefetto e fondatore dell'orto botanico universitario", per il periodo romano si descrive come "nell'arciginnasio romano dapprima lettore di filosofia, quindi di medicina e dei semplici"; certo non avrebbe passato sotto silenzio un incarico così prestigioso come la direzione dell'orto dei semplici pontificio. 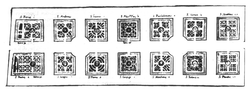 Un orto botanico senza uguali Come che sia, gli sembrava che la sua carriera romana fosse giunta a un punto morto, tanto che nel 1634 decise di accettare una cattedra di medicina all'ateneo di Messina, benché quella città di paresse "l'estremo d'Italia e del mondo". Dovette giungervi nell'aprile 1635, come risulta da una lettera a Cassiano dal Pozzo datata Messina li 12 d’Aprile 1635. Quasi subito iniziò la sua battaglia con il senato per ottenere la creazione di un orto botanico: "arrivato che qui fui, considerando quanto era necessario l'Horto de' semplici per compimento dello Studio, per correggere gli errori che potevano occorrere dall'ignoranza, e il danno che per difetto dei semplici era imminente, ne feci più volte istanza all'illustrissimo senato". La richiesta fu infine accolta nel 1638, con l'assegnazione di un terreno di considerevoli dimensioni (circa 580 metri x 50) situato nel fossato all'esterno delle vecchie mura e compreso tra due ponti preesistenti, il Ponte di Porta Imperiale e il Ponte della Porta della Maddalena; gli spazi sotto i ponti furono adattati per ospitare un laboratorio di chimica, un museo naturalistico e una cappella, mentre dai ponti stessi i cittadini potevano godere una vista panoramica del giardino anche durante le ore di chiusura. I più antichi documenti esistenti risalgono all'agosto 1638 e riguardano un anticipo di 100 onze per lavori murari. Nella progettazione presumibilmente fu coinvolto l'architetto e ingegnere della città di Messina Giovanni Antonio Ponzello che negli stessi creò il Teatro marittimo o Palizzata, che ridisegnò il lungomare e le vie d'accesso, con lo smantellamento delle mura di cinta liberando tra l'altro lo spazio del fossato poi occupato dal giardino; quest'ultimo, con le sue eleganti aiuole barocche, divenne così parte integrante di quel progetto complessivo che ridisegnava la città in forme aperte, ordinate e esteticamente ricercate. Stretto ed allungato, il giardino comprendeva 14 hortuli o parterres più o meno quadrati, ciascuno intitolato a un santo e a sua volta suddiviso in aiuole dalle eleganti forme geometriche con sentieri che convergevano al centro dell'hortulus, occupato da una vasca per le piante acquatiche. Più che in queste forme, indubbiamente ispirate all'orto padovano e volute, forse più che da Castelli, dal Senato ("questi signori si sono risoluti di fare un horto di semplici `a gara di quello di Padova", scrive in una lettera all'amico Cassiano), l'originalità del progetto sta nella disposizione delle piante. Mentre negli altri orti botanici coevi esse erano solitamente raggruppate in base alle loro virtù medicinali, Castelli adottò un criterio sistematico, suddividendole in quattordici classi sulla base dei frutti e in qualche caso la disposizione dei fiori, secondo l'insegnamento del suo maestro Cesalpino. Iniziando dall'hortulus I S. Petri troviamo le specie con un solo seme Unisemina; quindi nel II con un solo loculo Univascula; III con due semi Bisemina; IV con silique Siliquosa; V con tre semi Trisemina; VI con due loculi Bivascula; VII erbacee con quattro semi Quadrisemina herbacea; VIII con tre loculi Trivascula; IX legnose con quattro semi Quadrisemina surculosa; X con molti loculi Multivascula; XI con capolini Capitata; XII con corimbi Corymbifera; XIII a corona Coronaria; XIV con spine o aculei Aculeata. Una quindicesima classe era costituita da felci, muschi e piante acquatiche, poste nella vasche al centro di ogni parterre. Al di là delle semplici etichette, non sappiamo però quali piante fossero assegnate a ciascuna categoria, dato che nel catalogo che conclude Hortus Messanensis le piante sono elencate in ordine alfabetico e divise in tre gruppi di natura differente: semplici, orticole e fruttiferi, selvatiche. L'anatomista danese Thomas Bartholin che visitò il giardino nel 1644, quindi poco dopo il suo completamento, lo lodò in tono entusiastico, riferendo che, oltre a piante medicinali di ogni tipo, vantava anche piante esotiche tra cui persino un baobab. Castelli se le era procurate in primo luogo ricorrendo al cognato Enrico Corvino e, dopo la sua morte nel 1639, al nipote Francesco Corvino; molte piante gli furono poi inviate dallo speziale Girolamo Cardo di Francavilla, suo compagno di escursioni sull'Etna e molte le raccolse egli stesso nelle sue erborizzazioni sulle pendici del vulcano. Era infatti la flora etnea a rendere unico il giardino di Messina, anche se Castelli mobilitò tutti i suoi contatti per arricchirlo di piante esotiche e rare: "[mi hanno somministrato] altri amici da altre parti, e molte n'aspetto, onde spero tra pochissimo tempo dover avere un fioritissimo Horto de semplici, un Horto Hesperide, un Paradiso Terrestre". E, stando alla testimonianza di Bartholin, ma anche di altri visitatori inclusi Francis Willughby e John Ray, ci riuscì. Castelli era molto orgoglioso della sua creatura, che curava personalmente e da cui sperava di ottenere tanta gloria da essere richiamato a Roma; scriveva infatti al solito dal Pozzo che, sebbene a Messina ricevesse uno stipendio di 1000 once, e molte di più ne ottenesse come medico, "più volentieri starei in Roma per 300". E così si affretto a dare alle stampe la descrizione e il catalogo del giardino (Hortus messanensis, 1640), dedicato al papa Urbano VIII, e continuò a scrivere opere di medicina e farmacologia, "pur voglio, che per il Mondo si sappia che son vivo, non cessando dar gran voci, e risonanti bombi con le mie stampe". Ma senza esito: rimase a Messina fino alla morte nel 1661. Il magnifico giardino che aveva creato purtroppo ebbe breve vita. Ancora fiorente quando vi lavorò Malpighi, andò totalmente distrutto in seguito alla rivolta dei messinesi contro il dominio spagnolo del 1674. Infatti, quando gli spagnoli ripresero la città nel 1678, per spregio lo trasformarono prima in un pascolo per i cavalli dell'esercito poi in un campo di bietole. Bisognò attendere più di due secoli perché l'università di Messina avesse nuovamente un orto botanico. Ma nel frattempo l'insegnamento di Castelli aveva lasciato buoni frutti in un folto gruppo di discepoli: il medico Domenico Bottone, il farmacista, chimico e botanico Niccolò Gervasi, il pittore e "curioso della natura" Agostino Scilla. I due grandi botanici della generazione successiva, Paolo Silvio Boccone e Francesco Cupani, anche se non furono suoi allievi diretti come spesso si pretende, certo risentirono l'eco del suo insegnamento.  Una rara graminacea mediterranea Non a caso fu un botanico siciliano, Vincenzo Tineo, a sua volta grande esploratore della flora siciliana, a dedicare al suo illustre predecessore uno dei due nuovi generi contenuti nei tre fascicoli di Plantarum rariorum Siciliae minus cognitarum, Castellia (Poaceae). E' un genere monotipico rappresentato da un'unica specie, l'annuale Castellia tuberculosa. E' una modesta graminacea che può ricordare il loglio, con ciuffi di foglie piane, lunghe fino a 20 cm, da cui emergono i culmi eretti, rigidi, alti fino a un metro, che culminano in un'infiorescenza con racemi semplici o un poco ramificata in basso, con spighette solitarie, disposte lungo la rachide in due serie laterali; la caratteristica più spiccata è il lemma arrotondato, quasi interamente ricoperto nella pagina dorsale da piccoli tubercoli uncinati e appiattiti lateralmente. In Italia è rara ed inclusa nella lista rossa delle piante a rischio; è presente solo nella Sardegna occidentale presso Cuglieri e a Linosa nell'arcipelago delle Pelagie. Specie di habitat aperti e aridi, è distribuita dalle Canarie all'Iran, passando per la sponda meridionale del Mediterraneo. Nel 1625 il tipografo romano Mascardi pubblica Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, quæ continentur Romæ in horto Farnesiano; nel frontespizio e nella lettera dedicatoria figura come autore Tobia Aldini, medico del cardinal Farnese e prefetto del suo giardino sul Palatino, ma diversi elementi hanno indotto gli studiosi a pensare che la paternità vada attribuita a Pietro Castelli, medico illustre e futuro fondatore dell'orto botanico di Messina. Come che sia, l'opera è di grande interesse perché contiene alcune delle prime descrizioni, nonché pregevoli immagini, di piante esotiche di recentissima introduzione, tra le quali Vachellia farnesiana, dedicata propria alla famiglia Farnese nei cui giardini fiorì per la prima volta in Europa. Con o senza meriti, l'altrimenti quasi sconosciuto Tobia Aldini si fregia invece della dedica del genere Aldina (Fabaceae), americano come molte delle piante che coltivava nel giardino dei Farnese. 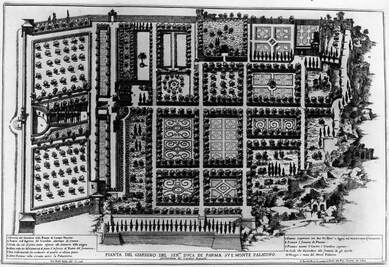 Un giardino rinascimentale adagiato sulla Roma imperiale Fin dagli anni '20 del Cinquecento, il cardinal Farnese, futuro papa Paolo III, incominciò ad acquistare diverse vigne sul Palatino, forse già allora pensando di farvi costruire, a gloria del suo casato in ascesa, un giardino "adagiato" in senso letterale sulle glorie di Roma imperiale. In quest'area sorgeva infatti il primo vero palazzo imperiale, quello di Tiberio, di cui si vedevano imponenti vestigia. E fu su di esse che a partire dal 1565 il celebre architetto Jacopo Barozzi (detto il Vignola, 1507-1573), su incarico del "cardinal nepote" Alessandro Farnese (1520-1589) si appoggiò per creare gli Orti farnesiani, forse il più celebre giardino della Roma rinascimentale. Iniziati dal Vignola e proseguiti da Carlo Rainaldi (1611-1691), i lavori si protrassero per tre generazioni, con il cardinale Odoardo (1573-1626) e il duca di Parma Odoardo I (1612-1646), che ordinò gli ultimi grandi lavori. Ma quando trasferì la sua corte a Parma, per il giardino iniziò il declino. Oggi di quel celebre complesso rimangono alcuni elementi monumentali, sottoposti a un recente restauro: il Ninfeo della pioggia, il Teatro del Fontanone e le sovrastanti uccelliere. Possiamo però ricostruirne l'aspetto al tempo del massimo fulgore grazie a stampe dell'epoca. Il giardino, che supera un dislivello di 20 metri, comprendeva quattro terrazze sovrapposte, collegate da sentieri e scale, con elementi monumentali posti a diversi livelli lungo un unico asse longitudinale, forse sul modello del Tempio della Fortuna primigenia di Palestrina. Il visitatore dell'epoca vi accedeva da un portale monumentale progettato dal Vignola (demolito, fu ricostruito in altra posizione a metà Novecento) e si trovava immediatamente di fronte il Teatro d'ingresso, uno spazio semicircolare adornato da statue e fiancheggiato simmetricamente da due boschetti in pendio; una rampa di scale lo portava al Ninfeo della pioggia, creato da Rainaldi, un vasto ambiente a pianta rettangolare, parzialmente interrato, con nicchie, statue e una fontana decorata con rocce, concrezioni calcaree e stalattiti, che stillando acqua a gocce produceva (e produce) un suono caratteristico che ricorda lo scroscio della pioggia. Da questo ambiente due scale parallele davano accesso direttamente alla terza terrazza, mentre la seconda, una stretta striscia con alberelli in vaso e aiuole geometriche bordate di bosso, era collegata alla prima da quattro sentieri paralleli. Il punto focale della terza terrazza era il Teatro del Fontanone, una fontana monumentale racchiusa in una nicchia absidata decorata da stalattiti da cui l'acqua ricade in un ampio bacino, che faceva da base a una loggia centrale e a due voliere, due edifici a pianta pressoché quadrata che ospitavano uccelli rari ed esotici. affaccianti sul quarto e ultimo ripiano, al quale si accedeva da due scale laterali. A questo punto, il visitatore aveva raggiunto la sommità del colle e il giardino vero e proprio, che si estendeva pressoché in piano, fino al ciglio del Palatino che si affaccia sul Circo Massimo. Era un tipico giardino all'italiana con una serie di "stanze" verdi quadrate o rettangolari con parterres a ramages, bordate da alberi d'alto fusto. La piazza dei platani si distingueva dagli altri scomparti per una fontana con bacino a frastagli, circondata da 10 platani posti in cerchio; da qui, tramite due scale si scendeva al ninfeo degli specchi. Nell'angolo sud-occidentale si trovavano il Casino dei fiori e il giardino segreto, riservato all'esclusiva fruizione del principe, e all'estremo lembo, racchiuso da muri, il selvatico, con le piante lasciate allo stato naturale. Quando i Farnese lasciarono Roma, il giardino andò incontro a un progressivo degrado, e le aiuole tornarono ad essere vigne, orti e carciofaie. Nell'Ottocento, divennero una zona di scavo archeologico, e, mentre le strutture vennero conservate, quanto rimaneva dei giardini fu totalmente distrutto. All'inizio del Novecento, Giacomo Boni, soprannominato l'archeologo giardiniere per la sua passione e i suoi studi sulle piante, risistemò alcune aree a verde, da una parte guardando agli antichi giardini di Roma imperiale, dall'altra proprio agli Orti farnesiani. Per individuare le piante esotiche introdotte all'epoca del Cardinal Odoardo si rifece a Exactissima Descriptio Rarorium Quarundam Plantarum quae continentur Romae in Horto Farnesiano, che è anche il punto di riferimento dell’attuale restauro vegetale del Palatino. 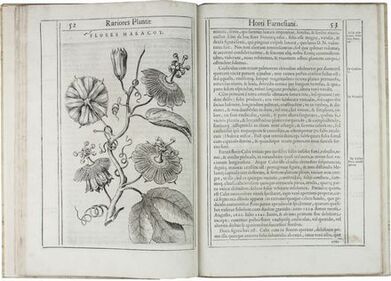 Una paternità contesa Il libro fu pubblicato nel 1625 dal tipografo romano Mascardi, legato all'Accademia dei Lincei di cui pubblicò alcune delle prima opere. Si tratta di un catalogo delle piante rare, per lo più di origine americana, coltivate negli Orti farnesiani al tempo del Cardinal Odoardo, cui il contatto con i gesuiti garantivano l'accesso in anteprima a piante esotiche. La paternità del libro è un piccolo giallo: nel frontespizio e nella lettera dedicatoria al cardinale figura come autore Tobia Aldini, medico del cardinal Odoardo e prefetto degli Orti farnesiani, ma già nel Settecento è stato suggerito che il vero autore potrebbe essere un altro medico attivo a Roma, Pietro Castelli. Infatti subito dopo la dedicatoria si trova un acrostico dedicato "all'eruditissimo autore" in cui la prima lettera di ogni verso forma la scritta Petrus Castellus Romanus; inoltre la nota del tipografo è sparsa di lettere maiuscole che formano la scritta Petrus Castellus e si conclude con la frase in caratteri maiuscoli In gratiam Tobiae Aldini scipsi cunta, "Ho scritto tutto per la benevolenza di Tobia Aldini". Se ne è voluto dedurre che Aldini sia solo un prestanome, o addirittura uno pseudonimo di Castelli. A me pare che la posizione più equilibrata sia quella di Lucia Tongiorgi Tomasi, secondo la quale "sembra più probabile che, sebbene Aldini sia il vero autore, si sia avvalso ampiamente dei consigli e dei suggerimenti dell'illustre botanico, specialmente nella redazione del testo latino". In effetti, Castelli è citato più volte, e potremmo senz'altro attribuire a lui, o almeno alla sua consulenza, gli excursus eruditi, mentre sembrano più farina del sacco di Aldini le puntuali informazioni sulla coltivazioni delle piante, frutto evidentemente dell'esperienza diretta in giardino. Come che sia, si tratta di un testo di grande interesse per conoscere i viaggi delle piante esotiche di fine Rinascimento. E' diviso in sedici capitoli, di lunghezza molto diseguale (da molte pagine a poche righe), ciascuno dedicato a una singola pianta esotica coltivata negli Orti farnesiani, di cui vengono fornite una descrizione spesso molto dettagliata, informazioni sull'arrivo in giardino e sulla coltivazione, le eventuali virtù medicinali e gli usi culinari. Molto pregevoli le illustrazioni in bianco e nero, che in alcuni casi ritraggono anche particolari come i frutti o i semi. Il libro esordisce con un lungo capitolo su Acacia farnesiana (oggi Vachellia farnesiana), di cui costituisce la prima attestazione in Europa; la pianta, ottenuta da semi giunti da San Domingo nel 1611 come dono del granduca di Toscana, si ambientò benissimo, tanto da fiorire copiosamente due volte all'anno; doveva costituire l'orgoglio del cardinale, quindi Aldini le dedica il capitolo più lungo, un vero trattatello di una trentina di pagine, che comprende anche un confronto con la prima acacia nota in Europa, Acacia nilotica. La seconda specie trattata è Hyiucca canedana, ovvero una Yucca che sulla base delle illustrazioni è stata identificata come Yucca gloriosa var. tristis; stranamente, la si dice giunta dal Canada, paese dove non cresce alcuna specie di questo genere, segno delle vie anche contorte di trasmissione delle piante esotiche; anche questo capitolo è un ampio trattatello, con il confronto con altre specie e informazioni dettagliate sul pane di yucca messicano, che però non è ricavato da una Yucca, ma dalla cassava o manioca. Ancora americana la terza specie, maracot, ovvero la passiflora, una pianta altamente simbolica nei cui fiori i gesuiti vedevano i segni della passione di Cristo; Aldini si mostra scettico, scrivendo: "Io non ci vedo tanto significato mistico, se non a forza; in tutta la pianta non compare affatto la croce, che è il primo e principale segno della passione del salvatore". Invece si dilunga nella descrizione della pianta, dei fiori e dei frutti, "aciduli ma dal sapore gradevole". Giunta dalle Indie nel 1620 è laurus indica (Persea indica), in realtà originaria delle Canarie. L'autore, con grande sfoggio di erudizione, si preoccupa soprattutto di negare che vada identificata con la cannella. Da qui in avanti, i capitoli si fanno sempre più brevi, riducendosi spesso a un disegno e una pagina di testo. Non tutte le piante sono identificabili (non lo è, ad esempio, Narcissus calcedonicus, unica pianta non illustrata da un disegno): citiamo hololiuchi o convolvolo peruviano, in cui riconosciamo Rivea corymbosa; glans unguentaria, ovvero Moringa oleifera; Lilionarcisso rubeo indico, presumibilmente un Hippeastrum; il ricino americano ovvero Jatropha curcas; solis flos tuberosus, ovvero il topinambur Helianthus tuberosus; Agave americana, ormai quasi una vecchia presenza nei giardini europei, dove è attestata già nella prima metà del Cinquecento.  Un genere amazzonico per un esperto di piante americane Di Tobia Aldini sappiamo molto poco: non ne conosciamo né la data di nascita né quella di morte, ma soltanto che era nato a Cesena e che a partire dal 1617 il cardinale Odoardo Farnese, di cui era anche il medico personale, gli affidò la direzione degli Orti farnesiani. Dai documenti del tempo in cui è citato emerge che faceva parte dei circoli intellettuali e scientifici della Roma del primo Seicento, ed era molto stimato tanto come chimico, ovvero farmacista, quanto come semplicista, ovvero esperto di erbe medicinali. In particolare ci è rimasta una sua lettera a Faber, in quegli anni impegnato nell'edizione del Tesoro messicano, al quale potrebbe aver fornito informazioni sulle piante americane coltivate nel giardino. Nel 1621 contribuì con una lettera a Discorso della duratione delli medicamenti di Pietro Castelli, al quale inizialmente dovette essere legato da grande amicizia, che tuttavia venne meno dopo il 1626, quando, morto il cardinale, Aldini passò al servizio del cardinal Barberini come curatore del suo Museo di curiosità ed ebbe anche la direzione del giardino dei semplici vaticano, con grande dispiacere di Castelli, che aspirava a quel posto per sé. Fu probabilmente questa situazione a spingerlo a trasferirsi a Messina. Così si esprime in amara lettera a Cassiano dal Pozzo; "Roma non mi vole, e stima un Tobia per maggior semplicista, per maggior Chimico, per maggior Cosmografo, e per maggior filosofo e Medico che Dioscoride, Paracelso. Tolomeo, Aristotele e Galeno quali tutti al suo dire sono ignoranti". Dopo questa data non abbiamo altre notizie di Aldini. Nonostante una presenza un po' fantasmatica e la discussa paternità di Exactissima Descriptio, gli sono stati dedicati due generi Aldina, rispettivamente da Adanson e Endlicher, e due generi Aldinia da Scopoli e Rafinesque. L'unico valido è Aldina Endl., un piccolo genere di circa 17 specie di alberi della famiglia Fabaceae, nativi delle foreste umide di Guyana e Amazzonia settentrionale. Sono alti alberi, spesso muniti di contrafforti, con foglie composte pennate e infiorescenze terminali o ascellari, solitamente ricoperte di una peluria dorata o rugginosa. I fiori, a simmetria radiale, hanno 4-6 petali, da bianchi a giallastri, numerosi stami, e sono profumati. Il frutto è un legume drupoide, talvolta spugnoso, per favorire la dispersione fluttuando sulle acque. Il genere Vigna, cui appartengono almeno una decina di specie di legumi alimentari molti coltivati (tra cui il nostro fagiolo dell'occhio V. unguiculata) non ha nulla a che fare con vigne e vigneti. Anch'esso deve il suo nome a una persona, il medico e botanico toscano Domenico Vigna, più volte ma sempre per breve tempo prefetto del giardino dei semplici di Pisa, che ha ricevuto tanto onore da uno dei suoi successori, anche se non sembra vantare particolari meriti botanici. 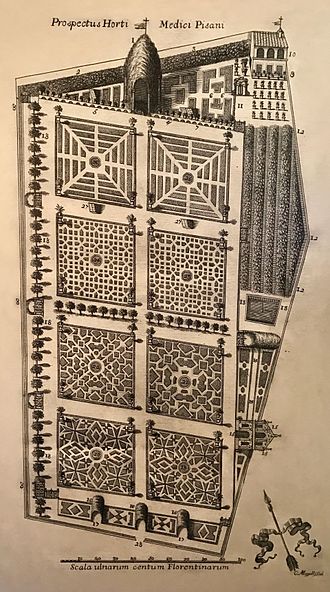 Un prefetto tappabuchi Gaetano Savi, prefetto dell'orto botanico di Pisa dal 1814, si propose di fare uscire dall'oblio diversi esponenti anche minori della botanica toscana dedicando loro un genere botanico. Probabilmente il più importante di questi generi (molti dei quali non più accettati) è Vigna (Fabaceae) che raggruppa una grande quantità di fagioli diffusi un po' in tutti i continenti, dal nostro fagiolo dell'occhio (V. unguiculata) agli orientali azuki (V. angularis). Il personaggio che dà loro il nome è Domenico Vigna, che insegnò botanica a Pisa e fu a più riprese prefetto dell'orto botanico pisano nella prima metà del Seicento. Gran parte delle scarse notizie che abbiamo su di lui si devono sempre a Savi, che le riprese in parte da Giovanni Targioni Tozzetti. Vigna era fiorentino, ma non ne conosciamo la data di nascita. Medico, dovette essersi formato proprio a Pisa, dato che Savi lo dice allievo di Baldelli, Malocchi e Rovezzani. Nominato medico condotto a Vico Pisano, acquistò una notevole reputazione professionale. Nel 1608, alla morte di Orazio Rovezzani, gli succedette come Professore di medicina con lettura di botanica, cattedra che mantenne fino alla morte nel 1647. Non lasciò per tanto la più redditizia professione medica, tanto che Savi commenta "in conseguenza non poteva aver tempo per badare alla Botanica". Nel 1614 fu per qualche mese prefetto dell'orto pisano, una posizione che tornò ad occupare ad interim, quasi come tappa buchi, ancora tra 1632 e il 1634. Sembra che come professore, pur non essendo un luminare, se la cavasse onorevolmente; dice infatti di lui Giovanni Targioni Tozzetti: "contuttoché non fosse un gran Botanico, pure per istruire i Giovani, e mostrare loro le piante utili, era più che sufficiente". Almeno di erbe medicinali doveva intendersi abbastanza; sappiamo che erborizzò nelle campagne di Agnano, nella Valle di Calci, presso San Giuliano, Ripafratta, Corliano, Avane e Vecchiano e, secondo Targioni Tozzetti, fu il primo a pubblicare alcune piante locali. Le sue lezioni dovevano essere piuttosto tradizionali, ovvero consistere nella lettura e nel commento a Teofrasto e Dioscoride. La sua unica opera edita è infatti Animadversiones, sive observationes in libros de historia, et de causis plantarum Theophrasti (1625), libro che Savi giudica severamente, definendolo "superficialissimo, con interpretazioni strane, ed erronee, e che non mostra gran dottrina". Ritiene però di qualche utilità la parte storica, per le notizie sui suoi predecessori all'Università e all'orto pisano, per i nomi vernacolari delle piante e la loro corretta localizzazione nonché per l'origine delle piante esotiche. Più drastico di lui Targioni Tozzetti, che dice l'opuscolo scritto in "latino barbaro" e aggiunge "in esso libro ha eseguito il suo assunto in maniera da far pietà". Anch'egli riconosce l'utilità delle sue notizie storiche, quindi ci informa che aveva tenuto lezioni su certe gomme e resine e che intendeva fare un indice di Dioscoride, progetto al quale presumibilmente rinunziò. Meritò comunque che il suo ritratto fosse esposto, insieme a quello dei suoi colleghi, nel vestibolo dell'orto botanico.  Fagioli per tutti i gusti Il genere associato da Savi a questo non indimenticabile botanico è decisamente importante, perché gli appartengono alcuni dei legumi più coltivati al mondo. Linneo aveva riunito i fagioli del vecchio e del nuovo mondo nei generi Phaseolus o Dolichos; nel 1822 Savi ne staccò i due generi Malocchia e Vigna, dedicati a due dei prefetti del giardino dei semplici di Pisa, il frate Francesco Malocchi e appunto Domenico Vigna. Mentre Malocchia oggi non è più valido (è sinonimo di Canavalia), Vigna (famiglia Fabaceae) è un vasto genere di oltre 100 specie, diffuso nelle aree tropicali e subtropicali di tutti i continenti; almeno una decina hanno notevole importanza alimentare. Iniziamo dal nostro continente con Vigna unguiculata, ovvero il fagiolo dell'occhio, originario dell'Africa ma già ampiamente coltivato da Greci e Romani. Sembra sia stato domesticato in Africa forse già intorno al 2000 a.C., sia come foraggera sia come tessile, per poi diffondersi in India, in Cina e in Europa, dove forme coltivate sono note almeno dal 300 a.C. Nel Medioevo costituiva la principale fonte di proteine da legumi; fu soppiantato a partire dal Cinquecento dai più produttivi fagioli americani, divenendo una coltivazione a carattere locale. Ancora oggi è il principale legume alimentare in Africa; in Nigeria, che ne è il maggiore produttore mondiale, è coltivato anche per le fibre tratte dai lunghi peduncoli del gruppo textilis. In Cina invece è stata selezionata la sottospecie sequipedalis, con baccelli lunghi anche più di un metro: si tratta dei cosiddetti fagiolini a metro, di cui si consumano appunto i baccelli immaturi. In Africa è molto coltivato anche il fagiolo Bambara V. subterranea, originario dell'Africa occidentale, ma introdotto in altre regioni africane e in America centrale e meridionale, usato sia nell'alimentazione umana sia come mangime per gli uccelli da cortile. Come le arachidi, dopo la fecondazione il fiore si piega a terra e i frutti maturano sottoterra. Diverse specie di Vigna sono coltivate in India; tra le più apprezzate l'urad o fagiolo nero o gram neroV. mungo, che, oltre ad essere consumato stufato o in curry, viene utilizzato anche sotto forma di farina nella preparazione di pani, frittelle e dolci. Nativo dell'India è anche V. aconitifolia, noto come matki o fagiolo farfalla, anch'esso usato nei curry, ma anche come foraggio; per la sua resistenza alla siccità è stato identificato come una delle colture del futuro. Largamente coltivata non solo in India, ma in tutta l'Asia orientale è V. radiata, noto come azuki verde, mungo verde o gram verde. Nel subcontinente è usato essiccato e per lo più privo decorticato in molte preparazioni salate e dolci ma anche sotto forma di farina. Se ne ricava la farina con la quale vengono preparati i cosiddetti spaghetti di soia. I germogli, noti impropriamente come germogli di soia verde, sono consumati crudi in alternativa ai veri germogli di soia. Nel nostro giro del mondo attraverso il genere Vigna siamo così giunti in Giappone, dove V. angularis, ovvero l'azuki o fagiolo rosso è la verdura più consumata dopo la soia. Nativo della Cina o della regione himalayana, è stato domesticato intorno al 1000 a.C. per poi diffondersi in tutta l'Asia orientale. Nelle cucine di questa area è l'ingrediente di molte preparazioni, incluse quelle dolci, a base di una pasta o confettura in Giappone detta anko a base di azuki bolliti con lo zucchero. Alcune specie sono così diffuse che è difficile stabilirne l'origine; è il caso di V. luteola, presente nelle aree tropicali di tutto il mondo: alcuni studiosi la ritengono originaria dell'Africa, altri del Sudamerica. Questa specie cresce in acque basse ed è utilizzata soprattutto come foraggio. Infine, una curiosità; come la maggior parte delle specie americane, sono state spostate in altri generi due specie dai fiori molto decorativi: V. caracalla oggi è Cochliasanthus caracalla, unica specie di questo genere, mentre V. speciosa è Sigmoidotropis speciosa. La nostra storia comincia in un giardino di Messina; ospite del proprietario, il visconte Ruffo, una sera forse del 1662 il medico e professore universitario Marcello Malpighi vi passeggia, finché un ramo di castagno gli sbarra la strada; lo spezza, ma non lo getta; incuriosito dalla sua natura fibrosa, decide di portarselo a casa per studiarlo al microscopio. E' l'inizio dello studio dell'anatomia vegetale, di cui, insieme a Nehemiah Grew, lo scienziato emiliano è il padre fondatore. Ma anche uno dei padri dell'osservazione al microscopio, dell'embriologia e dell'anatomia comparata, lo scopritore dei capillari, dei globuli rossi, dei recettori sensoriali linguali e cutanei, dei tubuli renali che da lui prendono il nome di glomeruli di Malpighi, dello sviluppo embrionale del baco da seta e dei pulcini, e di molto altro. Recuperando un assist del solito Plumier, Linneo gli dedicò il genere Malpighia, che a sua volta dà il nome alla famiglia Malpighiaceae. E c'è ancora qualche sorpresa.  Nemo profeta in patria: Malpighi e Bologna Il 28 dicembre 1667, Henry Oldenburg, segretario della Royal Society (fondata appena sei anni prima) scrive al medico e professore italiano Marcello Malpighi (1628-1691) per invitarlo a corrispondere regolarmente con la società, inviando informazioni e manoscritti su ogni soggetto interessante riguardante le scienze naturali. La lettera - segno della crescente reputazione internazionale di Malpighi - arriva in un momento delicato per lo scienziato bolognese (uno dei tanti, in realtà, della sua vita costellata di contrasti), che accetta di buon grado. Nel 1669 sarà il primo italiano a diventare membro della Society, che sosterrà finanziariamente le sue ricerche, pubblicherà la sua opera omnia e nel 1684, quando egli perde i suoi microscopi in un incendio, gli rifonderà la spesa e gli procurerà nuove lenti. Gli scontri con i sostenitori dell'ortodossia e dell'autorità di Galeno erano iniziati presto, quando Malpighi era ancora studente dell'università di Bologna. Qui prese a frequentare il circolo anatomico che si riuniva attorno a Bartolomeo Massari, dove si praticava la dissezione degli animali e, quando disponibili, di cadaveri umani, Furono forse queste frequentazioni ad attirargli l'ostilità del corpo accademico, e in particolare di Ovidio Montalbani (onnipossente professore di matematica, logica, astronomia e medicina, ma anche astrologo ufficiale della città e autore di fantasiosi almanacchi che firmava come Bumaldus, nome con il quale è entrato nella nomenclatura botanica grazie all'eponimo di Spiraea bumalda). Minacciato addirittura di morte, se volle laurearsi Malpighi dovette piegarsi a dichiarare la sua fedeltà alla medicina galenica. Fu forse per questo che, anche se gli venne proposta una cattedra di logica nell'ateneo bolognese, preferì accettare l'invito dell'arciduca Leopoldo di Toscana e si trasferì a Pisa ad insegnare medicina pratica. I tre anni trascorsi nella città toscana furono decisivi. Malpighi entrò a far parte dell'Accademia del Cimento, che si rifaceva al magistero di Galileo e al metodo sperimentale, legandosi particolarmente al matematico e naturalista Giovanni Alfonso Borelli che lo introdusse alla iatromeccanica, ovvero alla concezione - derivata dal razionalismo cartesiano - che assimilava i corpi di uomini e animali a macchine complesse. Riprese i suoi esperimenti e incontrò lo strumento che l'avrebbe accompagnato per il resto della vita: il microscopio. Nel 1659 un tragico affare di famiglia lo richiamò a Bologna: nel corso di una rissa per strada (molto simile nella dinamica all'episodio di Ludovico-fra Cristoforo nei Promessi Sposi) suo fratello Bartolomeo uccise Tommaso Sbaraglia, primogenito di una famiglia in lite con i Malpighi per questioni di confini e fratello di un altro dei rivali accademici di Marcello, Giovanni Girolamo. Bartolomeo Malpighi fu inizialmente condannato a morte, ma il fratello, grazie all'aiuto del Cardinal Farnese, riuscì a farlo rilasciare dopo meno di un anno di reclusione. Risolta l'incresciosa faccenda, Malpighi rimase a Bologna, assumendo la cattedra di medicina teorica. La sua prima importante scoperta - poi riferita nelle due epistole a Borelli De pulmonibus - è del 1660, quando indentificò la struttura spugnosa del polmone in termini di alveoli circondati da una rete di minuscoli vasi sanguigni e gettò le basi per la comprensione del processo di respirazione. L'anno successivo, partendo dall'osservazione dei polmoni di una rana, fornì la prova che confermava la teoria della circolazione del sangue di Harvey, scoprendo i capillari che mettono in relazione vene e arterie. Erano scoperte rivoluzionarie che lo resero famoso in tutta Europa, ma rinfocolarono più che mai il malanimo, il rancore e l'invidia dei tradizionalisti che, rifacendosi a Galeno, pensavano che il sangue fosse prodotto dal fegato e che i polmoni fossero costituiti da sangue coagulato. A venirgli in soccorso fu l'amico Borelli, che lo convinse a trasferirsi a Messina dove gli procurò una cattedra pagata quattro o cinque volte di più di quella bolognese. Nella città siciliana, dove Malpighi si mosse con prudenza, rinunciando persino a esercitare come medico per non suscitare risentimenti, continuò con grande successo le sue ricerche: studiò gli organi del gusto e del tatto e la loro connessione con il cervello, pubblicando poi i risultati dopo il rientro a Bologna, nel 1665, nei tre opuscoli De lingua (per lo studio delle papille della lingua si avvalse anche dell'aiuto della sua cuoca, che gli insegnò come rimuovere i due strati più superficiali di una lingua bovina, mettendo in evidenza il corpo papillare), De cerebro e De externo tactus organo. Come vedremo meglio in seguito, fu sempre a Messina che incominciò ad occuparsi di anatomia vegetale. Nonostante ogni cautela, anche nella nuova sede non tardarono a scoppiare le polemiche. Malpighi decise di rientrare a Bologna, dove gli fu assegnata la cattedra di medicina pratica e, come medico, si creò una vasta clientela che gli diede una certa agiatezza. Tuttavia, con la decisione di lasciare Messina si inimicò Borelli; fu forse per questo che accettò con entusiasmo la proposta della Royal Society da cui abbiamo preso le mosse, che lo sottraeva all'isolamento. Anche se non interruppe mai gli studi di anatomia (studiando il rene e il sangue, con la scoperta tra l'altro dei globuli rossi), i contatti londinesi lo spinsero ad allargare le sue ricerche, oltre che all'anatomia vegetale, all'embriologia, con De bombyce, sui bachi da seta, 1669 e soprattutto il fondamentale De formatione pulli in ovo, 1673, sull'embrione del pulcino, entrambi pubblicati a Londra a spese della Royal Society. La sua carriera scientifica e la fama internazionale avevano raggiunto l'apice, tanto che dal 1687 la Royal Society ne pubblicò l'opera omnia; ma non bastò per tacitare le polemiche nella provinciale Bologna. Nel 1676 il botanico Giovanni Battista Trionfetti attaccò e cercò di ridicolizzare i suoi studi sull'anatomia vegetale; nel 1689 il libello De recentiorum medicorum studio dissertatio epistolaris ad amicum, uscito anonimo, ma dovuto all'arcinemico Giovanni Girolamo Sbaraglia, sostenne l'inutilità dal punto di vista pratico delle indagini anatomiche e delle osservazioni al microscopio, difendendo le cure tradizionali che si rifacevano all'esperienza diretta e all'insegnamento degli antichi. Nel 1683 la casa di Bologna di Malpighi andò distrutta in un incendio; fu in questa occasione che la Royal Society gli venne in soccorso per ripristinare i preziosi microscopi. Sembra invece non sia mai avvenuta l'incursione nella sua casa di campagna di un gruppo di uomini mascherati guidato da Sbaraglia, che Malpighi racconta in una lettera a un amico: non è il racconto di un fatto reale - come a lungo si è creduto -, ma la metafora grottesca degli attacchi alla sua reputazione subiti da Sbaraglia e soci. Malpighi era ormai stanco delle polemiche; si facevano sentire anche l'età e crescenti problemi di salute. Nel 1691, una nuova svolta: l'ex cardinale di Bologna Antonio Pignatelli venne eletto papa con il nome di Innocenzio XII, e volle con sé il vecchio amico Malpighi come medico personale; nonostante fosse riluttante a lasciare la sua città, egli non poté rifiutare. Il pontefice lo nominò addirittura Cameriere segreto, con lo status ecclesiastico di monsignore e il diritto di esercitare liberamente la professione a Roma; con il che, cessarono anche gli attacchi alla sua persona, ormai divenuta intoccabile. Ma soltanto tre anni dopo moriva in seguito a due colpi apoplettici. 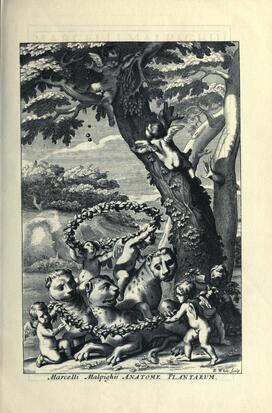 Un trattato sull'anatomia delle piante All'origine dell'interesse di Malpighi per l'anatomia delle piante, c'è un piccolo episodio (l'equivalente della mela di Newton) e un convincimento scientifico profondo. Racconta lo stesso Malpighi che quando viveva a Messina (siamo probabilmente nel 1662) una sera stava passeggiando nel giardino di uno dei suoi protettori, il visconte Ruffo; a un certo punto, si imbatté in un ramo di castagno che gli sbarrava la strada; lo spezzò, ma, anziché gettarlo, da quel grande osservatore che era, fu subito colpito dalla sua natura fibrosa. Lo portò a casa e lo esaminò al microscopio, osservando la struttura che oggi chiamiamo xilema, Il convincimento scientifico è quello dell'uniformità della natura, che opera con i medesimi meccanismi in tutti suoi regni. Lo studio dell'anatomia delle piante sarà dunque un grimaldello per comprendere le strutture di organismi più complessi, come egli stesso spiega nella prefazione di Anathome plantarum: "La natura delle cose, avvolta nelle tenebre, si svela solo con metodo analogico, e deve essere investigata nella sua totalità, affinché noi, attraverso lo studio delle macchine più semplici e più accessibili ai sensi, possiamo risolvere la struttura di quelle più complicate". In giovinezza aveva studiato essenzialmente l'anatomia dell'uomo e degli animali "perfetti", ma per comprenderla aveva dovuto passare a quelli più semplici: "questi, avvolti nelle proprie tenebre, rimangono nell'oscurità; per cui è necessario studiarli analogicamente attraverso gli animali semplici. Mi arrise quindi l'indagine degli insetti; ma anche questa comporta le sue difficoltà. Finii quindi a rivolgermi alle piante, in modo che una lunga esplorazione di questo mondo mi aprisse la strada per ritornare ai miei primi studi, partendo dal gradino della natura vegetante". Quando entra in contatto con la Royal Society, ha già fatto molti passi avanti in questo campo e nel 1674 è in grado di inviare a Londra il manoscritto di quello che diverrà il primo volume di Anatome plantarum, pubblicato l'anno successivo dalla società londinese; il libro, scritto in latino, comprende 82 pagine, più un'appendice con il saggio sull'embrione dei pulcini, 54 tavole in bianco e nero con 336 figure, basate su disegni dello stesso Malpighi, un eccellente disegnatore. Solo una quindicina riproducono strutture viste al microscopio perché anche Malpighi, come Grew, integra l'osservazione a occhio nudo (o con una lente di ingrandimento) con quella al microscopio. Dunque lo stesso termine Anatome va inteso più come Morfologia che come anatomia in senso stretto. Nell'introduzione Malpighi rivendica l'importanza metodologica dello studio dell'anatomia delle piante, in precedenza ritenute organismi indifferenziati e privi di organi; egli le concepisce invece come un sistema che può essere diviso in parti con relazioni sinergiche, dunque veri e propri organi. Quindi li passa in rassegna analiticamente, a iniziare dal tronco con la corteccia (cortex) cui è dedicato il primo capitolo. Seguono le parti del fusto (de partibus caulem vel caudicem componentibus), in cui i termini caulis e caudex indicano rispettivamente lo stelo delle piante erbacee e il tronco di quelle legnose. Si passa quindi alla crescita della corteccia e ai nodi (de caudices augumento & nodis) con l'individuazione degli anelli di crescita annuale, di un cilindro legnoso, fasci fibrosi e fasci legnosi. Il quarto capitolo è dedicato alle gemme (de gemmis) di cui è correttamente riconosciuto il ruolo nella produzione di foglie e foglioline, nel caso di piante con foglie composte; vengono esaminate le gemme di varie piante, di cui è riprodotta la sezione longitudinale, e viene descritta la forma generale di varie foglie, poi esaminate nel capitolo successivo (de foliis). Con il sesto capitolo si passa ai fiori (de floribus) di cui Malpighi riconosce esplicitamente il ruolo nella riproduzione, descrivendone varie parti anche se in modo impreciso, e analizzando diversi tipi di fiori e infiorescenze. Non stupisce che il biologo bolognese, che in quegli stessi anni studiava l'embriologia animale, riservi il capitolo più ampio alla formazione del seme (de seminum generatione), dedicato alla fecondazione, alla formazione dell'embrione e alle prime fasi dell'emergenza della plantula, esplicitamente collegata al seme (seminalis plantula). Va nello stesso senso il capitolo successivo, dedicato alla formazione del frutto, significativamente non chiamato così, ma utero (de uterorum augumento & ipsorum succedente forma), presumibilmente inteso come ovario; vengono poi descritti diversi tipi di frutti in modo piuttosto esatto, anche se con una terminologia a volte imprecisa (viene però introdotto il termine pericarpo). Il nono e ultimo capitolo (De secundinis (et) contento plantarum foetu) ritorna sulla questione della formazione dell'embrione prima della germinazione del seme e della nascita della plantula. Nel 1679, sempre a spese della Royal Society, uscì una seconda parte, un volume di 93 pagine e 39 tavole, con 142 figure. Mentre la prima parte può essere considerata un trattato generale sull'anatomia della piante, la seconda parte si occupa essenzialmente di malformazioni e anomalie e strutture specifiche e in qualche senso curiose, con capitoli dedicati a galle, tumori e altre formazioni ipertrofiche, a peli, spine, viticci e formazioni analoghe, a piante eterotrofe e parassite. Di particolare interesse il capitolo sulle galle, che Malpighi spiegò correttamente come escrescenze prodotte dalla deposizione di uova da parte di particolari insetti; una spiegazione che fu contestata tra gli altri da Francesco Redi. In sintesi, in tutti i variegati campi in cui operò, Malpighi aprì nuovi orizzonti o, per dirla con il contemporaneo Domenico Gagliardi (Anatomes Ossium Novis Inventis Illustratae Pars Prima, 1689), nuovi mondi: "come un secondo Colombo del microcosmo, egli scoprì non soltanto uno, ma innumerevoli nuovi mondi nella sola struttura delle viscere", e - potremmo aggiungere - delle piante.  Omaggi floreali L'ammirazione di Gagliardi è condivisa da Charles Plumier che pochi anni dopo la morte di Malpighi, nel suo Nova plantarum americanarum genera (1703) lo celebra con la dedica del genere Malpighia, accompagnata da un vero peana: "Il celeberrimo Marcello Malpighi bolognese, professore di medicina, archiatra del sommo pontefice Innocenzio XII, filosofo eminentissimo, membro della Royal Society, accuratissimo esploratore delle opere della natura, gettò le basi della vera anatomia delle piante con un'opera degna di ogni ammirazione, ovvero un ricchissimo tesoro botanico-anatomico che abbraccia 24 trattati". Linneo riprende la proposta in Hortus Cliffortianus e la ufficializza in Species plantarum. Oggi Malpighia è il genere tipo di un'intera famiglia, Malpighiaceae, con oltre 70 generi e 1300 specie, che a sua volta dà il nome a uno dei più vasti ordini delle Angiosperme, Malpighiales, cui fanno capo 36 famiglie e più di 16000 specie (l'8,5% delle Eudicotiledoni). Non male per il bistrattato Malpighi! che del resto è un nome familiare persino agli studenti delle scuole medie, ricordato da parti anatomiche, istituti e accademie, piazze e strade, un'isola dell'Antartide e un asteroide, mentre quello del rivale Sbaraglia è noto solo a pochi specialisti. Malpighia L. comprende un centinaio specie di arbusti e piccoli alberi nativi dell'America tropicale e subtropicale, dal Texas e dalla Baja California a Nord al Perù settentrionale a Sud, passando per l'America centrale e le Antille, dove troviamo il centro di diversità, con 58 specie (di cui 53 endemiche) nell'isola di Cuba. Sempreverdi e molto ramificati, hanno spesso dense chiome, rami spinosi o densamente pelosi, foglie semplici, fiori solitari o raccolti in umbelle, con cinque petali unghuiculati bianchi, rosa, rossi o viola, seguiti da un drupa dall'aspetto simile a una ciliegia. E sono proprio i frutti a far apprezzare la specie più nota, M. emarginata, nota con il nome comune acerola o ciliegia delle Barbados. Dal gusto delizioso, i frutti di acerola sono anche molto salutari perché contengono un'altissima percentuale di vitamina C (sei volte quella dell'arancia), nonché vitamine A, B1, B2 e B3, carotenidi e bioflavonidi; oltre che freschi, vengono consumati sotto forma di succo, marmellata e gelatina; l'estratto del succo è utilizzato, sotto forma di pastiglie, come integratore con ottime proprietà antiossidanti. In alcune erboristerie sono anche disponibili panetti di polpa essiccata. M. emarginata è talvolta confusa con M. glabra, che tuttavia ha fiori assai diversi e frutti più piccoli e insipidi. Ha invece essenzialmente usi ornamentali M. coccigera, un arbusto originario dei Caraibi, con foglie dai margini spinosi che ricordano quelle dell'agrifoglio e fiori con petali bianchi frastagliati seguiti da bacche rosse molto apprezzate dagli uccelli. Sempre nell'ambito delle Malpighiaceae, troviamo ancora due omaggi indiretti a Malpighi. Il primo è il genere Malpighiodes Nied. (ovvero "affine a Malpighia"), che comprende quattro specie di liane legnose diffuse tra il Venezuela, le Guiane e il Brasile settentrionale. Il maggiore tratto distintivo sono le aeree infiorescenze a dicasio, con 4 o 8 fiori portati in coppie di umbelle o corimbi; le corolle, a simmetria bilaterale, hanno petalo posteriore differente dagli altri quattro; il frutto è una samara con ali membranacee o ridotte. Sorprendentemente, si rifà a Malpighia anche il genere Galphimia: infatti ne è l'anagramma! L'enigmista che si divertì con questo gioco di parole non è altri che l'abate Cavanilles, il direttore dell'orto botanico di Madrid. Con circa 25 specie di grandi erbacee, arbusti e piccoli alberi, si estende dal Messico al bacino dell'Amazzonia, con centro di diversità in Messico, con una ventina di specie. Quella più nota è la bella G. gracilis, un arbusto originario del Messico orientale, spesso coltivato nei giardini a clima mite per l'alta resistenza alla siccità e i racemi di brillanti fiori gialli. Tanto per fare un po' di confusione, è commercializzata anche come G. brasiliensis o G. glauca (o anche Tyrallis brasiliensis e T. glauca), che però sono specie diverse. Dalle foglie e dai fiori essiccati di G. glauca si ricava un tè con proprietà rilassanti, dovute alla presenza di galpimina B; ecco perché in Messico è nota come noche buena o buena noche, la pianta della buona notte. Estratti di questa pianta sono usati in fitoterapia e omeopatia per contenere i disturbi da ansia e alcune allergie. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
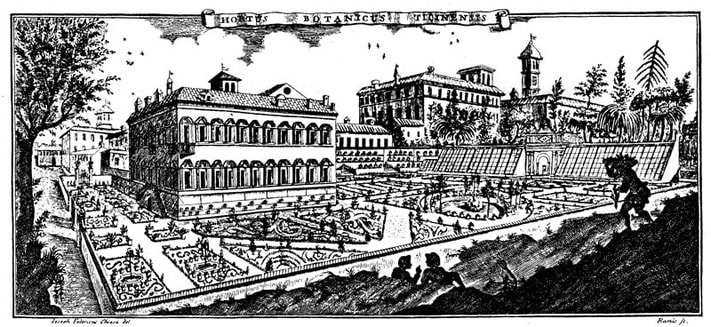

 RSS Feed
RSS Feed