|
In ritardo rispetto alle altre capitali europee, Lisbona si dota di un orto botanico e di un museo di scienze naturali solo nel 1768, grazie a un botanico italiano, Domenico Agostino Vandelli, che trasmette la botanica linneana ai suoi allievi di Coimbra. Saranno loro, a partire dal 1783, ad essere inviati a caccia di piante, minerali e animali nelle colonie portoghesi, il cui pur ricco patrimonio naturalistico era fino ad allora pressoché inesplorato. Uno di loro è João da Silva Feijó, che viene mandato senza aiuti e con ben poche attrezzature a Capo Verde. Tra l'ostilità delle autorità locali, le pretese di Lisbona, che lesina sulle spese ma è sempre insoddisfatta dei risultati, vi rimarrà per quasi quindici anni. Dopo un passaggio a Lisbona per organizzare le raccolte e raccontare la sua avventura in Itinéraire philosophique, ritorna in Brasile, dove era nato, esplora il Ceará, quindi termina la sua vita come insegnante di zoologia e botanica all'accademia militare di Rio de Janeiro. Di tanto lavoro restano poche pubblicazioni, qualche manoscritto e un erbario presto disperso; dopo pochi anni anche Feijó è quasi dimenticato, se a ricordarlo non fosse il genere Feijoa, con la deliziosa e profumatissima F. sellowiana. 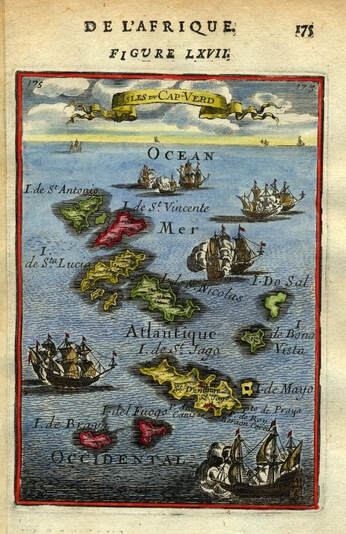 Un difficile "viaggio filosofico" L'arcipelago di Capo Verde, scoperto dai portoghesi intorno al 1460, fu la prima colonia tropicale di una nazione europea, ma, nonostante occupasse una posizione strategica nei collegamenti tra Europa, Africa e Asia, fino alla fine del Settecento la sua natura rimase pressoché inesplorata. Le prime raccolte botaniche di cui abbiamo notizia furono effettate da Johann Reinold Forster e suo figlio durante in secondo viaggio di Cook, che nell'agosto 1772 fece un breve scalo nell'isola di Santiago, dove i due naturalisti tedeschi raccolsero una quarantina di piante nei dintorni di Praia. La vera esplorazione scientifica di Capo Verde inizia nel 1783 quando il luso-brasiliano João da Silva Feijó (1760-1823) vi viene inviato con il compito di raccogliere e catalogare ogni tipo di minerale, animale e vegetale dell'arcipelago, nell'ambito dei "viaggi filosofici" organizzati dalla corona portoghese per impulso di Domenico Agostino Vandelli, direttore del Museo e giardino reale di Ajuda e professore di chimica e scienze naturali a Coimbra. João da Silva Feijó era nativo di Rio de Janeiro o dei suoi dintorni, ma questa è praticamente l'unica informazione certa sui suoi primi anni; le sue stesse origini familiari sono discusse. Una delle ipotesi più accreditate è che il suo vero nome fosse João da Silva Barbosa, e che avesse adottato lo pseudonimo Feijó in omaggio al filosofo Benito Jerónimo Feijoo, reputato esponente dell'illuminismo spagnolo. Nella seconda metà degli anni '70 fu tra i relativamente numerosi giovani brasiliani che si iscrissero all'università di Coimbra, dove seguì corsi di matematica e scienze naturali e fu allievo di Vandelli. Attirò la stima del maestro a sufficienza da essere incluso tra i neodiplomati di Coimbra che sotto la sua guida e quella del capo giardiniere Giulio Mattiazzi completarono la loro formazione al Museo di Ajuda, in vista di future spedizioni oltremare. Nel laboratorio del Museo, Feijó fece esperimenti di chimica e, insieme a un altro studente brasiliano, Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815), fu inviato ad esplorare le miniere di carbone di Buarcos presso Cabo Mondego nel distretto di Coimbra, preludio all'impiego di entrambi come "viaggiatori filosofici". Il progetto iniziale prevedeva una sola grande spedizione in Brasile, sul modello di quella di Ruiz e Pavón in Perù; invece intorno al 1782 si optò per una serie di spedizioni minori affidate ai giovani naturalisti formati ad Ajuda, che nel 1783 partirono all'esplorazione delle varie colonie dell'impero portoghese: il più promettente di tutti, Alexandre Rodrigues Ferreira, fu inviato in Brasile con i disegnatori Joaquim José Codina e José Joaquim Freire e il giardiniere Agostinho Joaquim do Cabo; Joaquim José da Silva e i disegnatori Angelo Donati e José António furono inviati in Angola; Manuel Galvão da Silva, con il disegnatore António Gomes e il giardiniere José da Costa, esplorò prima Goa poi il Mozambico. Diversamente dagli altri, Feijó, assegnato alle isole di Capo Verde con decreto reale del 3 gennaio 1783, partì senza alcun assistente. Forse all'arcipelago, usato soprattutto come luogo di confino ed esilio dei dissidenti politici, si attribuiva minore importanza. Al ministro della marina e d'oltremare Mello e Castro premeva soprattutto la ricognizione delle risorse minerarie, in particolare lo zolfo e il salnitro, anche se le raccolte dovevano abbracciare i tre regni della natura, a beneficio del museo di Ajuda. Quando partì da Lisbona, Feijó aveva solo 23 anni e doveva animarlo un grande entusiasmo scientifico, se pensiamo che nella capitale portoghese lasciò la moglie e un bimbo, che affidò a Mattiazzi; quest'ultimo, nella sua funzione di direttore del Museo, era colui che riceveva i suoi invii e fu anche l'unico a proteggerlo in qualche modo nelle circostanze difficili che si sarebbero presto presentate. Del procedere e dei risultati dell'esplorazione doveva invece informare direttamente il ministro; lo fece con dettagliate lettere-relazioni (ne sono rimaste sette). Lasciata Lisbona il 3 febbraio 1783, il 28 Feijó sbarcò nell'isola di São Nicolau, dove fu accolto dal vescovo Francisco de São Simão, da pochi mesi governatore di Capo Verde, con il quale ad aprile si spostò nell'isola di Santiago; vi rimase circa un mese a preparare la sua prima spedizione, nel corso della quale visitò le isole di Brava (maggio) e Fogo (giugno 1783-febbraio 1784), dove fece importanti raccolte, ma incontrò anche le prime difficoltà per la mancanza di reti per catturare gli animali, di alcol per conservare gli esemplari, di casse per spedirli. Le inascoltate lamentele di Feijó per la mancanza di aiuti, libri e attrezzature appropriate saranno una costante del suo viaggio - quasi un'odissea -, come lo saranno l'insoddisfazione di Vandelli per la quantità e la cattiva conservazione delle raccolte (ovvia conseguenza del modo in cui Feijó era costretto ad operare) e del ministro, che attendeva risultati più concreti e suggerimenti per lo sfruttamento minerario delle isole. A Fogo, dove tra l'altro scalò il vulcano Pico, la cima maggiore dell'arcipelago con i suoi 2829 metri, Feijó per altro mise insieme un primo erbario e una cassa di piante vive, raccolse minerali, rocce vulcaniche, resine, gomme e non trascurò notizie economiche, etnografiche e geografiche. Al suo ritorno a Santiago, invece che con affabile vescovo, morto durante l'estate (Feijó sospettava senza mezzi termini che fosse stato assassinato), si trovò a confrontarsi con il governatore supplente, il colonnello João Freire de Andrade, con il quale ebbe sempre rapporti conflittuali. Lo stesso avveniva non di rado con le autorità locali, che non capivano lo scopo del suo viaggio, lo sospettavano di essere una spia e una volta arrivarono persino a minacciarlo di morte. Penosa era anche la sua situazione economica, con il ministero che pretendeva che a pagargli lo stipendio fosse l'amministrazione coloniale, e quest'ultima che rifiutava i pagamenti con cavilli burocratici. Eppure, il coraggioso naturalista non demordeva. Rimasto a Santiago appena il tempo necessario per spedire a Lisbona i materiali raccolti a Brava e Fogo, si spostò a São Nicolau, che esplorò per un anno, visitando anche Santa Luzia e altre isole vicine, inclusi gli isolotti di Raso e Branco da cui riportò lo scinco gigante di Capo Verde Chioninia coctei, oggi estinto. Nuovamente a Santiago nell'aprile 1785, constatò con sollievo che il tirannico colonnello era stato sostituito da António de Faria e Maia, con il quale invece ebbe rapporti cordiali. Fu forse su sua richiesta che tra maggio e giugno andò a Santo Antão, un'isola settentrionale con orografia complessa e valli interne di difficile accesso, per visitare la fabbrica reale di anil (estratto delle foglie di Indigofera tinctoria) sulla quale scrisse una memoria più tardi pubblicata negli atti dell'Accademia delle scienze. Passò poi a São Vicente, dove rimase circa un mese. Ad agosto era a Santiago, da dove spedì a Lisbona 24 casse con le raccolte di Santo Antão e 3 con quelle di São Vicente. Il soggiorno nell'isola principale si protrasse questa volta per sette mesi; nel marzo 1786 Feijó tornò a Brava per fare raccolte di salnitro, su richiesta di Mattiazzi che aveva giudicato insufficienti per l'analisi i campioni raccolti nella visita precedente. Ritornò quindi a Fogo per raccogliere campioni di rocce vulcaniche e osservare i crateri formatosi in seguito alla recente eruzione del gennaio 1785, trattenendosi nell'isola di nuovo per un anno, dall'aprile 1786 all'aprile 1787. Creò un secondo erbario, meno ricco di quello precedente, ma con parecchie specie nuove. Tornò poi a Santiago, dove si trattenne per circa un anno, dedicato a scrivere una importante memoria sul vulcanismo di Fogo e un fascicolo sulle piante inedite da lui raccolte nei suoi viaggi, intitolato Plantae Insulanae, nelle intenzioni preludio a un'opera più ampia che purtroppo non scrisse mai. Il manoscritto di una dozzina di pagine conteneva tra l'altro quattro nuovi generi monotipici. Trasmesso all'Accademia delle scienze di Lisbona, fu giudicato insufficiente e pubblicato solo anni dopo in un fascicolo miscellaneo. Tra maggio 1788 e gennaio 1789, Feijó visitò ancora le isole settentrionali, quindi, giudicando terminato il suo lavoro scientifico, chiese di essere richiamato a Lisbona; come si espresse, quello a Capo Verde era un esilio a cui era stato condannato senza colpa. Nonostante reiterasse la richiesta, poté partire solo alla fine del 1795, quando la moglie riuscì a ottenere il suo rientro rivolgendosi direttamente alla regina. Per vivere, mentre a Lisbona sembravano essersi dimenticati di lui, Feijó dovette rassegnarsi a integrarsi nell'amministrazione coloniale, come segretario del governatore, e nell'esercito, come sergente maggiore della fortezza di Ribeira Grande. Per un certo periodo gestì persino una fabbrica di pesce secco. Tornato a Lisbona all'inizio del 1796, vi ritrovò l'amico Ferreira, che dopo il ritorno dal Brasile aveva fatto carriera e alla morte di Mattiazzi era stato nominato direttore ad interim del Museo. Nella capitale frequentò l'Accademia delle scienze, dove lesse il notevole Ensaio económico sobre as Ilhas de Cabo Verde (pubblicato solo nel 1815), scrisse la relazione del suo viaggio intitolata Itinéraire philosophique e riordinò l'erbario in vista dell'inserimento nell'erbario collettivo dei "viaggi filosofici". Nel 1798 lo mostrò al botanico tedesco Heinrich Friedrich Link, in visita ad Ajuda, che lo apprezzò, ma in privato espresse un giudizio sprezzante sulle competenze botaniche del collega brasiliano. Nel 1799 Feijó, che come abbiamo visto già a Capo Verde era entrato nell'esercito, fu nominato sergente maggiore delle milizie della capitaneria di Ceará in Brasile. In un Portogallo in cui la figura professionale del naturalista stentava ad affermarsi, era un escamotage per assicuragli uno stipendio e i privilegi di cui godevano i militari. In realtà, il suo compito era dirigere un laboratorio di estrazione del salnitro a Tatajuba, sui monti Cocos. Presto l'impresa si rivelò economicamente infruttuosa e Feijó, che fin dall'arrivo in Ceará aveva iniziato ad esplorarne la fauna e la flora, intensificò il suo interesse per la raccolta di esemplari botanici, soprattutto tra il 1803 e il 1806, quando gli fu richiesto di procurare semi sia per l'orto botanico di Ajuda sia per quello di Berlino, in base a un accordo tra le monarchie portoghese e prussiana. La flora del Cearà, ricca di endemismi della foresta arida nota come caatinga, è in effetti assai peculiare. Il soggiorno di Feijó in Ceará si protrasse per diciassette anni, durante i quali egli dovette affiancare alle ricerche naturalistiche, economiche ed etnografiche crescenti impegni militari, se nel 1811 fu promosso luogotenente colonnello del primo reggimento di cavalleria della milizia della capitaneria del Ceará. Nel 1814 pubblicò sul giornale letterario di Rio de Janeiro O Patriota la relazione ufficiale delle sue ricerche (Memória sobre a capitania do Ceará). Intorno al 1818, tornò a Rio de Janeiro, passò al corpo degli ingegneri e fu nominato professore di storia naturale all'Accademia militare reale. Iniziò a scrivere una Flora Cearense, rimasta purtroppo incompleta e manoscritta al momento della sua morte nel 1824.  Un frutto tropicale, ma non troppo Dal punto di vista scientifico, i "viaggi filosofici" furono, se non un fallimento, un'occasione mancata. I materiali si accumularono nei magazzini del Museo di Ajuda e ben poco venne pubblicato (le poche memorie di Feijó, per quanto assai parziali, sono una felice eccezione); nel 1808, nell'ambito dell'effimera occupazione francese, Geoffroy Saint-Hilaire fu inviato a Lisbona a requisire le collezioni del Museo e riuscì a farsi consegnare da Vandelli 17 casse di esemplari d'erbario provenienti dal Brasile e più in generale dai "viaggi filosofici". Tra di essi anche un erbario di Capo Verde, senza indicazione del raccoglitore. Negli anni '40 sarebbe stato studiato da Philip Barker Webb, che però ignorava risalisse a Feijó. Tuttora conservati all'Hérbier national parigino, i circa 500 esemplari sono pressoché tutto ciò che rimane delle raccolte del botanico brasiliano, essendo andati dispersi quelli di Lisbona. I pur importanti contributi di Feijó alla conoscenza delle flore del Capo Verde e del Cearà furono presto dimenticati (la loro riscoperta è piuttosto recente). Stupisce dunque che nel 1858 il botanico tedesco Otto Carl Berg gli abbia dedicato il genere Feijoa, purtroppo senza indicare la motivazione in modo esplicito. Egli lo stabilì sulla base di esemplari raccolti da Sellow nel Brasile meridionale, non lontano dalla frontiera con l'Uruguay, una zona lontanissima da quelle esplorate da Feijó nel nord-est brasiliano. Forse la dedica si deve al ricordo della collaborazione di Feijó con l'orto botanico di Berlino, o alla mediazione di von Martius che incluse una breve nota su di lui in Herbarium florae Brasiliensis, in cui lo ricorda erroneamente come direttore del gabinetto di storia naturale di Rio de Janeiro. Feijoa (famiglia Myrtaceae) è un genere monospecifico, rappresentato unicamente da Feijoa sellowiana, un arbusto o piccolo albero largamente coltivato per l'aspetto ornamentale e soprattutto per i frutti, noti come feijoa o più raramente guaiva brasiliana o guaiva-ananas, anche se non ha alcuna parentela con la vera guaiva. In siti e cataloghi è comunemente chiamata con il vecchio sinonimo Acca sellowiana; in effetti, per qualche decennio il genere Feijoa confluì in Acca, ma di recente è stato ripristinato sulla base di dati molecolari che ne hanno dimostrato l'indipendenza. Nativo degli altopiani del sud del Brasile, di Paraguay, Uruguay e Argentina settentrionale, è relativamente rustico e ben si adatta al clima mediterraneo. Tende a ramificarsi fin dalla base, formando un arbusto sempreverde dal portamento elegante. Le foglie, coriacee e lucide, sono argentee nella pagina inferiore e verde chiaro in quella superiore. Nella primavera inoltrata produce una copiosa fioritura di fiori con quattro petali carnosi bianco-rosato, profumati ed eduli, con lunghi stami color corallo, seguiti da frutti ovali, più o meno della dimensione di un uovo, con buccia verde e aromatica. La polpa, bianco-giallastra, di consistenza gelatinosa, con un sapore che ricorda quello dell'ananas e delle fragole, circonda numerosi semi. Solitamente, si consuma direttamente dal frutto con un cucchiaino, ma può anche essere usta per succhi e confetture. I frutti riescono a maturare anche in gran parte del nostro paese, ma perché la pianta fruttifichi è necessario piantarne almeno due esemplari di diverse varietà o ricorrere a varietà innestate autofertili. È largamente coltivato in diversi paesi dal clima temperato, tra cui la Nuova Zelanda che ne è il massimo produttore, ma i frutti sono per lo più prodotti per il mercato locale, per la brevità del periodo ottimale di raccolta e la difficoltà a mantenerli maturi in buone condizioni. Ricchi di vitamine e antiossidanti, poveri di grassi e di zuccheri, sono considerati salutari, oltre che deliziosi al palato e all'olfatto.
0 Comments
Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola. Per Robert Brown, Anton Pantaleon Howe (lui però lo scriveva Hove) era un "ben noto viaggiatore botanico". Per noi invece questo polacco capitato non sappiamo come né perché in Inghilterra è un illustre sconosciuto. Ha lasciato qualche traccia di sé quasi unicamente nella corrispondenza di Joseph Banks, grazie alla quale ne seguiamo le avventure in mezzo mondo, dalla Namibia all'India e poi dalla Polonia alla Crimea, scoprendo che forse dietro la facciata di botanico si nascondeva un'attività meno alla luce del sole. Gli mancava l'Australia, ma ci ha pensato appunto Brown, dedicandogli il genere australiano Hovea (Fabaceae). 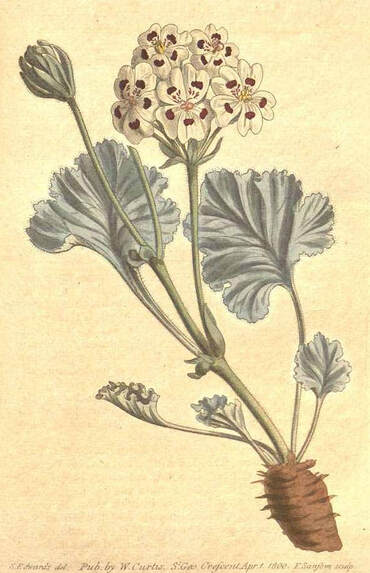 Un misterioso giramondo Tra i tanti cacciatori di piante inviati in giro per il mondo da sir Joseph Banks per arricchire il giardino reale di Kew, uno dei più oscuri e misteriosi è Anton Pantaleon Howe. Tanto misterioso che non ne conosciamo con precisione neppure il cognome, scritto anche Hove o Hoveau, che è la trascrizione inglese di un cognome ignoto che a orecchie britanniche suonava più o meno come Au. Il personaggio salta fuori dal nulla nel settembre 1785. Dopo la perdita delle colonie americane, la corona britannica cercava nuove colonie penali dove deportare i condannati. Oltre a Botany Bay in Australia, fu presa in considerazione anche la baia di Lüderitz, all'epoca nota con il nome portoghese Angra das Voltas, lungo la costa dell'attuale Namibia; se si fosse rivelata adatta, avrebbe offerto alle navi inglesi dirette in India e in Cina uno scalo alternativo all'isola di Sant'Elena e al Capo di Buona speranza, all'epoca ancora saldamente sotto il controllo della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC). Del progetto venne ovviamente informato Banks, il più ascoltato consulente dell'ammiragliato, che ottenne che alla missione partecipasse uno dei suoi raccoglitori; il candidato ideale doveva essere un esperto giardiniere con qualche conoscenza di botanica, dotato di buone capacità di osservazione. Probabilmente su suggerimento di William Aiton la scelta cadde appunto su Howe, di cui, in una lettera a Banks del 10 settembre 1785, il segretario della Royal Society Charles Blagden esalta anche il carattere allegro e le conoscenze mediche. Da una lettera di parecchi anni dopo dello stesso Banks, scopriamo che era polacco, forse di Varsavia, ma non sappiamo nulla dei suoi studi e della sua vita prima dell'arrivo in Inghilterra, di cui ignoriamo la data. Poiché in Namibia assunse anche il ruolo di chirurgo di bordo, possiamo supporre che avesse studiato medicina, pur senza laurearsi, in Polonia o altrove. Risulta invece che fosse stato assunto a Kew come giardiniere dietro raccomandazione di John Graeffer, il grande giardiniere che più tardi avrebbe realizzato il giardino inglese della Reggia di Caserta. Dato che Graeffer era tedesco, potrebbe aver conosciuto Howe all'estero; oppure il polacco potrebbe aver lavorato in precedenza per il vivaio di Gordon, di cui Graeffer era uno dei soci. Poiché l'area di Angra das Voltas si trovava a cavallo tra la zone d'influenza portoghese in Angola e olandese in Sudafrica, l'ammiragliato si mosse con la massima cautela e segretezza, sollevando anche qualche perplessità sull'ingaggio di uno straniero. Alla fine si convinse; così, a bordo della Grampus, la nave ammiraglia della piccola flotta guidata dal commodoro Edward Thompson, c'era anche Anton Howe come botanico, accanto al cartografo, il luogotenente Home Riggs Popham, e al nipote e figlio adottivo del comandante, il luogotenente Thomas Bolden Thompson. Della ricognizione vera e propria si sarebbe occupato l'agile sloop Nautilus, comandato dal capitano George Tripp. Per mascherare la vera meta, le provviste aggiuntive furono caricate sul Grampus, e la piccola flotta, salpata a settembre, si diresse nell'attuale Ghana, con l'obiettivo apparente di ispezionare le stazioni commerciali britanniche della costa occidentale dell'Africa. Tuttavia ad Apollonia il commodoro morì di febbri nel gennaio 1786: come ufficiale più anziano, Tripp assunse il comando del Grampus e ad aprile lo riportò in Inghilterra; nel frattempo le provviste erano state trasbordate sul Nautilus, che salpò in direzione sud al comando di Thomas Bolden Thompson, alla ricerca di Angra das Vueltas sulla base di imprecise carte portoghesi e di vaghe informazioni raccolte da navigatori inglesi e esploratori olandesi, che presentavano quell'area come fertilissima e ricca di potenzialità. A bordo c'erano anche Popham e Howe, nelle vesti di botanico e chirurgo di bordo. Non c'è da stupirsi se la missione fu un totale fallimento. Invece della terra fertile dal clima mite che si attendevano, gli inglesi si trovarono in un deserto "inospitale e nudo, che non ha eguali tranne nell'Arabia deserta", secondo le parole di Bolden Thompson. Non gli riuscì di trovare né Angra das Vueltas, né la foce del grande fiume indicato nelle carte, né fonti d'acqua. Al suo rientro in Inghilterra a luglio, la sua relazione non poteva che essere negativa. L'unico contento del viaggio probabilmente fu proprio Howe, che in quelle plaghe desertiche poté trovare piante ignote, raccogliendo semi, molte bulbose e 17 specie di Pelargonium, tra cui P. crassicaule, P. cortusifolium e P. ceratophyllum. Avendo dato ottima prova di sé, dimostrando "buon senso e carattere audace", come scrisse Banks, poco dopo il rientro in Inghilterra gli fu affidata una missione più delicata, a metà tra la botanica e lo spionaggio industriale: fu infatti inviato in India a studiare i metodi di coltivazione e a procurarsi semi del migliore cotone in commercio, quello di Surat nel Gujarat. A organizzare il viaggio fu l'Ufficio del commercio, su pressione dei produttori di tessuti di cotone di Manchester, che erano costretti ad importare parte della materia prima dall'estero; incrementare la quantità e la qualità del cotone coltivato nelle Antille britanniche era infatti strategico per l'industria britannica della nascente rivoluzione industriale. Howe partì per l'India nell'aprile del 1787 e, dopo uno scalo a Ceylon, dove fu derubato di raccolte e attrezzature, si trattenne nel subcontinente per circa due anni. Esplorò con molta cura l'area costiera tra Bombay e il Gujarat, raccogliendo piante (tra le altre Crotalaria juncea, una pianta da fibra citata in antichi testi sacri, e il mangostano, cui gli si attribuisce l'introduzione in Inghilterra); era un'ottima copertura per il vero scopo del viaggio, che tuttavia trapelò. Nelle sue lettere a Banks riferisce dei mille ostacoli che i funzionari della Compagnia delle Indie (che non gradiva la concorrenza del cotone delle Antille) cercarono di contrapporgli. Nonostante fosse riuscito a procurarsi semi di buona qualità, le sue richieste di denaro e le spese considerate eccessive finirono per seccare Banks e l'Ufficio del Commercio, che ordinarono a Howe di rientrare anzitempo. Imbarcatosi su una nave danese nel febbraio 1789, rientrò in Inghilterra ad agosto, dopo uno scalo a Città del Capo, nel corso del quale incontrò Francis Masson. Da questo momento le notizie che possediamo su Howe si fanno sporadiche. A un certo punto dovette lasciare la Gran Bretagna per la Germania, dove lavorò come medico, poi passò in Polonia dove fece raccolte di piante e cercò di creare un "istituto botanico". In una lettera a Banks inviata da San Pietroburgo il 20 settembre 1795, egli riferisce che aveva dovuto lasciare la Polonia e rifugiarsi in Russia in seguito all'insurrezione di Kościuszko (marzo-novembre 1794), durante la quale le sue collezioni erano andate distrutte; avendo incontrato lo zar l'anno prima e avendo relazioni con funzionari russi, era infatti considerato filorusso. E' stato ipotizzato, ma senza prove, che in questi anni avesse continuato a lavorato come agente dell'intelligence britannico. Il 15 agosto 1796, da Odessa, Howe scrisse la sua ultima a lettera a Banks: conteneva semi e una lunga descrizione dell'azalea pontica Rhododendron ponticum; da un frammento di diario pubblicato sul Botanical Magazione di Curtis nel 1799 (il resto è purtroppo perduto) possiamo ricavare qualche notizia sui suoi movimenti in questa fase: a giugno trovò esemplari di questa specie sulle rive del Dnestr nella tenuta del conte Potocki a Mohilow (attualmente Mohyliv-Podilskyi in Ucraina); il 4 luglio ne vide migliaia in una palude presso Očakiv; il 15 luglio ne trovò una valle interamente ricoperta a Trebisonda. Poi, per quasi vent'anni, nessuna notizia, fino al 1812, quando in una lettera a Knight, Banks ricorda che Howe portò l'azalea gialla dalla Crimea e sottolinea ancora una volta che era di origine polacca ed era un buon giardiniere che aveva lavorato per molti anni per i Kew Gardens. Forse all'epoca era tornato in Inghilterra, ma certo vi morì, come scopriamo da un annuncio fatto pubblicare dai suoi esecutori testamentari sulla Gazeta Krakowska il 25 novembre 1837: in seguito alla morte di Anton Pantaleon Howe a Bath nel gennaio 1830 e all'incapacità della vedova Joanna Howe per "sonnambulismo", si sollecitano potenziali eredi a comparire davanti a un tribunale londinese pena l'esclusione dall'eredità. Quattro anni dopo, anche Joanna (o Jane), morì a Kensington, all'età di 86 anni, come ci informa la sezione necrologi di The Gentleman's Magazine dell'ottobre 1841.  Australiane dai fiori blu Nel 1812, nel quarto volume della seconda edizione di Hortus Kewensis, Robert Brown dedicò a Howe uno dei suoi generi australiani, Hovea (Fabaceae), senza alcuna motivazione esplicita. Le fornisce invece pubblicando Hovea latifolia nel primo volume di The Botanical Cabinet di Loddiges (1817): "Il genere a cui appartiene questa pianta ha ricevuto il suo nome in onore di Mr. A. P. Hove, il ben noto viaggiatore botanico polacco. Grazie a lui sono state introdotte molte belle piante, e speriamo che egli voglia accrescerne il numero". Probabilmente Brown non lo conosceva di persona, ma gli erano note le piante da lui introdotte a Kew; è forse troppo dedurne che all'epoca Hove non fosse ancora tornato in Inghilterra e magari fosse impegnato in qualcuno dei suoi misteriosi viaggi. Nessun mistero sullo bellezza di Hovea, uno dei numerosi generi di leguminose endemici dell'Australia; comprende circa quaranta specie di suffrutici, arbusti ma anche piccoli alberi, distribute in tutti fli stati del paese, con vistosi fiori papilionacei viola, malva, blu, più raramente bianchi. Tra le specie più coltivate nei giardini australiani, e talvolta anche altrove, vale la pena di segnalare Hovea acutifolia, originaria dei margini delle foreste umide del Queensand e del Nuovo Galles del Sud; di veloce crescita, in primavera si ricopre di una massa di piccoli fiora da blu a viola-malva. Molto attraente anche H. trisperma, che cresce invece nelle boscaglie sabbiose dei dintorni di Perth e nei distretti di Darling e Stirling; è un arbusto dal portamento aperto che dall'inverno all'inizio della primavera produce lunghe cime terminali di fiori in varie sfumature di colore, che vanno dal blu scuro al lilla pallido al bianco. Ugualmente originaria delle aree semi aride dell'Australia occidentale è H. elliptica, un arbusto eretto con foglie ellittiche alternate e brevi cime di fiori viola all'ascella fogliare. Ci riporta invece nell'Australia orientale (e in Tasmania) H. heterophylla, un piccolo arbusto eretto o prostrato, che deve il suo nome alle varie forme delle sue foglie: da arrotondate a ellittiche alla base, da lineari a lanceolate in alto. I fiori malva hanno vessillo striato di giallo e carene viola scuro. Per un finire, anche se il nome del dedicatario è stato scritto indifferentemente Hove o Howe, fate attenzione a non confondere i generi Hovea e Howea, ovvero la cosiddetta kentia o kenzia, una palma! A differenza della vicina Virginia, la cui flora aveva destato l'interesse di botanici e appassionati fin dall'inizio del Seicento, perché iniziassero le ricerche naturalistiche in Maryland si dovette attendere la fine del secolo e la trasformazione in colonia reale. Evento decisivo fu la nomina a governatore di Francis Nicholson, patrono delle arti e delle scienze e deciso sostenitore della chiesa anglicana. Il vescovo Compton ne approfittò per inviare nella colonia il giovane pastore gallese Hugh Jones, nella speranza che, come Banister in Virginia, riuscisse a unire con successo l'attività pastorale alle raccolte botaniche. Ma, al contrario di Banister, Jones non sapeva nulla di piante e, nonostante la buona volontà e l'insegnamento a distanza di Petiver, ebbe molta difficoltà a conciliare i due compiti. A supportarlo nel 1698 giunsero da Londra ben due naturalisti: William Vernon, designato dalla Royal Society, e David Krieg, amico e agente di Petiver. Anche se il loro soggiorno nella colonia fu breve, segnò il vero inizio dell'esplorazione della flora del Maryland, con la raccolta di diverse centinaia di specie, in parte pubblicate da Ray nel terzo volume di Historia Plantarum. Sia Krieg sia Vernon sono celebrati da generi validi della famiglia Asteraceae: Krieg dal piccolo Krigia e Vernon dal grande Vernonia e, indirettamente, da Vernoniopsis e Vernonanthura.  Un pastore e apprendista botanico La tragica morte di John Banister fu un duro colpo per il vescovo Compton e per i botanofili londinesi che si riunivano nel Temple Coffee House Botanical Club; con essa si interrompeva il flusso di nuove piante americane garantito dalle raccolte del solerte pastore. Due anni dopo, nel 1694, la nomina a governatore del Maryland di Francis Nicholson, che durante il suo mandato in Virginia aveva favorito l'attività di Banister e più in generale l'esplorazione delle risorse naturali, riaccendeva le speranze. Si cercò un ecclesiastico che, come il defunto, potesse unire all'attività pastorale le raccolte naturalistiche. Su segnalazione di Edward Lhwyd, curatore dell'Ashmolean Museum di Oxford, un candidato non ideale ma passabile fu individuato nel gallese Hugh Jones (ca. 1671-1701), assistente di Lhwyd nella raccolta di fossili. Di piante non sapeva nulla e aveva seguito i corsi di teologia per non più di un anno, eppure il vescovo Compton, ritenendo imminente la partenza della flotta del tabacco diretta in Virginia, si affrettò ad ordinarlo pastore. Invece, a causa della guerra con la Francia, la partenza fu rinviata di mesi, permettendo al neo-reverendo di frequentare il Club e ricevere almeno un'infarinatura di zoologia e di botanica. Doody, Petiver e James Ayrey (un mercante e collezionista il cui negozio era vicino a quello di Petiver) lo accompagnarono a cercare fossili nella cava di calce di Charlton presso Greenwich e ad erborizzare nel Kent. Doody gli procurò un termometro e forse un densimetro, Petiver gli impartì istruzioni su come raccogliere e conservare ogni sorta di "collezione filosofica" e gli diede una copia della sue centurie e forse altri libri, nonché materiali come la carta necessaria per essiccare gli esemplari e bottiglie per conservare gli animali sotto spirito. Jones giunse in Maryland solo nel giugno 1696. La situazione, da ogni punto di vista, era più complessa rispetto alla Virginia. Il Maryland, la cui economia si basava principalmente sulla coltivazione del tabacco, era molto meno florido della colonia gemella; la popolazione era costituita principalmente da servi bianchi a contratto, in gran parte maschi, frequentemente falcidiati da malattie ed epidemie; l'importazione di schiavi neri era appena agli inizi ma in crescita. Le piantagioni erano per lo più piccoli appezzamenti circondati da foreste e gli spostamenti rimanevano difficili. Fino al 1689 la colonia era stata amministrato da un governatore-proprietario cattolico della famiglia Calvert, che aveva favorito una certa tolleranza religiosa; oltre a cattolici, c'erano quaccheri, non conformisti, e anche anglicani, ma senza una chiesa organizzata. Questa fu stabilita solo nel 1691, quando il Maryland divenne un colonia reale; così, quando Jones arrivò ad Annapolis, la capitale, per presentarsi al governatore Nicholson, scoprì che i suoi doveri ecclesiastici sarebbero stati tutt'altro che una sinecura. Gli fu affidata la grande Christ Church Parish, ancora scarsamente abitata ma geograficamente vasta, con due sedi che lo costringevano a faticosi spostamenti. I doveri ecclesiastici assorbirono gran parte del suo tempo, lasciandone ben poco alle "collezioni filosofiche", già di per sé problematiche per un novellino immerso in un ambiente pressoché sconosciuto e in gran parte selvaggio. I suoi sponsor londinesi furono delusi: decisamente, Jones non era un nuovo Banister: nell'autunno e nell'inverno del suo primo anno in Maryland inviò pochi esemplari, imperfettamente conservati, per lo più già noti e non accompagnati dalle dettagliate note naturalistiche e dai disegni a cui li aveva abitati il compianto pastore-naturalista. Petiver cercò di ovviare con una specie di corso per corrispondenza, inviando a Jones liste di esemplari, doppioni della sua collezione, istruzioni pratiche e libri di botanica tra cui, oltre ai suoi Musei petiveriani, Historia plantarum di Ray e Paradisus batavus di Hermann. Oltre a doni come formaggi e generi di prima necessità, nei suoi pacchi c'erano anche medicinali, visto che un pastore in quella colonia ancora in via di formazione doveva occuparsi della cura non solo delle anime, ma anche dei corpi. Due nuovi invii di Jones raggiunsero l'Inghilterra alla fine del 1697 e nel 1698, per lo più in cattive condizioni a causa del lungo viaggio; finalmente nell'autunno del 1698 Petiver ricevette una collezione ben preparata e ben conservata, anche se lamentò che si trattasse essenzialmente di fiori, senza frutti e semi, "dai quali si ricavano le caratteristiche più essenziali o la denominazione". Preoccupato di perdere la priorità rispetto al rivale Plukenet, che in Almagestum botanicum (1696) aveva già pubblicato diverse specie virginiane raccolte da Banister, sollecitò Jones a intensificare le raccolte; gli chiese anche di inviargli il maggior numero possibile di esemplari della medesima pianta, in modo che egli potesse restituirgli i doppioni con le sue osservazioni. Qualche invio giunse ancora, ma a quel punto alle difficoltà che già conosciamo si era aggiunto il declino fisico: il giovane ecclesiastico gallese si ammalò di tisi e ne morì all'inizio del 1701. 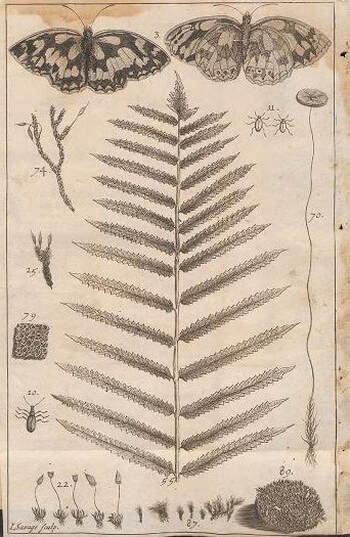 Due raccoglitori sono meglio di uno Già prima di questo infausto esito, Petiver e i suoi amici-rivali del Botanical Club e della Royal Society avevano deciso di affiancare al troppo indaffarato e troppo inesperto Jones un naturalista più preparato, ma soprattutto impegnato a tempo pieno. Nella seduta del 10 novembre 1697 della Royal Society, William Byrd II (figlio di William Byrd I, il piantatore virginiano che era stato amico, ospite ed esecutore testamentario di Banister) riferì che il governatore Nicholson intendeva offrire 25 sterline annue a un naturalista per "fare osservazioni e descrizioni di tutti i prodotti naturali di queste parti, e scriverne la storia" e chiedeva alla Royal Society di individuare la persona adatta. La scelta cadde su William Vernon (ca. 1667-ca. 1715), membro del St Peter's College di Cambridge, noto soprattutto come raccoglitore e studioso di muschi e già lodato da Ray per la profonda conoscenza della flora britannica. Ottenuti due o tre anni di congedo dall'Università, Vernon accettò l'incarico e si preparò a partire al più presto per l'America, dove contava di rimanere almeno due anni. La sua missione era sponsorizzata dalla Royal Society, quindi indirettamente dal Temple Coffee House Botanical Club; ma come sappiamo i suoi membri (in particolare Hans Sloane e James Petiver) erano divisi da una forte rivalità. Fu così che Petiver decise di giocare una seconda carta, inviando in Maryland un altro naturalista a lui legato: il medico tedesco David Krieg (1667-1713). Nato in Sassonia, quest'ultimo, dopo aver studiato all'Università di Lipsia, si era trasferito a Riga, diventando uno dei corrispondenti di Petiver, che lo aveva ospitato a casa sua quando nel 1696 egli si era spostato a Londra; inoltre lo aveva introdotto al Botanical Club e gli aveva fornito lettere di presentazione per Jacob Bobart, il prefetto dell'orto di Oxford, e per John Ray, che viveva nel suo rifugio di Black Nottley. Sicuramente nel novembre 1697, poco prima della partenza di entrambi per il Maryland, incontrò anche Vernon, ma i due viaggiarono separatamente e anche più tardi non raccolsero insieme, divisi da una presumibile rivalità; l'inglese arrivò in colonia nel marzo 1698, il tedesco (accompagnato dal "cacciatore di farfalle" di Petiver, un ragazzo chiamato Isaac) vi giunse due settimane dopo. Si era pagato il viaggio servendo come chirurgo di bordo, mentre il giovane Isaac forse viaggiò come ragazzo di cabina. Krieg dovette mettersi immediatamente all'opera, mentre Vernon, che dipendeva dal governatore e era tenuto a concordare le sue mosse con lui, dovette iniziare le raccolte solo a maggio. Non conosciamo nei particolari gli itinerari di nessuno dei due. Certamente visitarono Annapolis e i suoi dintorni ed esplorarono la costa orientale della baia di Chesapeake. L'unica lettera superstite di Krieg, scritta a maggio, ne attesta la presenza nel basso corso del Choptank River, mentre da una lettera inviata a luglio da Vernon a Sloane sappiamo che egli al momento si trovava ad Annapolis ed aveva già deciso di tornare in Inghilterra alla fine dell'estate. Non conosciamo le ragioni di questo rientro anticipato: alcuni hanno parlato di dissapori con il governatore Nicholson, altri al contrario ritengono che Vernon abbia preferito rinunciare piuttosto che rimanere in quella difficile colonia dopo la partenza del suo protettore; Nicholson infatti si accingeva a lasciare il Maryland per assumere nuovamente il governo della Virginia. Dunque, dopo circa cinque mesi di raccolte, lasciata l'America forse a settembre o a ottobre, tra novembre e dicembre sia Vernon sia Krieg erano nuovamente a Londra. Vernon presentò alcuni esemplari in una delle sedute del venerdì del Temple Coffee House Botany Club e gli sponsor si spartirono il bottino: Petiver fece la parte del leone, ricevendo da Krieg piante, insetti e conchiglie e molti esemplari anche da Vernon; altri li ottenne Sloane, altri ancora il vescovo Compton (che però lamentò che ci fossero pochi semi) e l'arcivescovo di Canterbury Tenison. Attraverso Sloane e Petiver, diverse centinaia di nuove specie furono inviate per l'identificazione a Ray, che incontrò molte difficoltà sia per l'incompletezza degli esemplari sia per la mancanza di note di accompagnamento; in ogni caso, nel terzo volume di Historia plantarum (uscito nel 1704) poté elencare 450 specie originarie del Maryland e determinarne 225. Tra il 1698 e il 1702 diverse specie furono inoltre pubblicate sulle Transactions della Royal Society da Petiver. Né Ray né Petiver (né Plukenet, che a sua volta pubblicò alcune specie del Maryland in Almatheum Botanicum, uscito nel 1705) indicano il nome dei raccoglitori, quindi non sappiamo che cosa fu raccolto rispettivamente da Jones, Vernon e Krieg. Nonostante il cambiamento di programma e le difficoltà incontrate da Ray, le raccolte dei due "inviati speciali" dovettero soddisfare a sufficienza le aspettative della Royal Society: nella seduta dell'11 gennaio 1699 fu deliberata sia l'ammissione di Krieg sia lo stanziamento di 20 sterline per inviare Vernon a caccia di piante nelle Canarie. Quasi immediatamente, egli si recò a Deale per imbarcarsi, ma mancò la partenza della flotta. Quando scoprì che non erano previste altre partenze prima di novembre, decise di rimanere a fare raccolte nel Kent e nei dintorni di Canterbury fino all'autunno. Ma ormai aveva perso la voglia di viaggiare. La missione alle Canarie sfumò, Vernon continuò per qualche anno a raccogliere in Inghilterra, specializzandosi in briofite e nel 1702 ritornò a Cambridge. Poco alla volta anche i suoi contatti con l'ambiente dei botanici e dei botanofili vennero meno, tanto che non sappiamo praticamente nulla dei suoi ultimi anni, neppure dove e quando morì. Il destino di Krieg dopo l'avventura americana fu amaro. Rimase a Londra ancora qualche mese, occupato a riordinare le sue raccolte e forse a fare disegni per Petiver; a maggio si imbarcò per Riga, dove era di ritorno il 14 giugno 1699. Per due anni esercitò la medicina nella città baltica, che offriva ben poche opportunità a un naturalista, come lamenta nelle lettere all'amico Petiver. Nel 1701 fu assunto come medico personale da Louis de Guiscard-Magny, ambasciatore della Francia in Svezia; lo raggiunse a Stoccolma e lo accompagnò a Parigi, dove ebbe modo di frequentare il Jardin des Plantes e conoscere Plumier e Vaillant. Quando scoprì che l'ambasciatore lo voleva al suo fianco come medico militare nella campagna prevista per l'anno successivo, decise di tornare a Riga. Lo faceva con riluttanza; avrebbe preferito un clima più caldo, magari un viaggio nelle Antille al servizio dell'amico Petiver. Lasciata Parigi nella primavera del 1702, dopo una breve visita a Strasburgo, dove viveva un fratello chirurgo, e alla famiglia a Schwarzeburg, nel gennaio 1703 era di ritorno a Riga. Anche se erano anni difficili per la città baltica a causa della Grande guerra del Nord tra Russia e Svezia, continuò a fare raccolte naturalistiche, nella speranza di scrivere una storia naturale della Livonia; si mantenne in contatto con gli amici inglesi, inviando loro curiosità, insetti e minerali, e ricevendo in cambio libri e strumenti. Il suo sogno era lasciare quella città provinciale dove nessuno condivideva i suoi interessi e tornare in America, o per lo meno a Londra. Ma rimase appunto un sogno. Nel 1710 Riga fu posta sotto assedio dai Russi; in città scoppiò una pestilenza che, insieme alla fame, fece 22.000 vittime. Una di loro era Krieg.  Asteraceae grandi e piccole Nessun botanico ha pensato di rendere omaggio a Jones, mentre sia Krieg sia Vernon sono onorati da almeno un genere di Asteraceae. Krigia e Vernonia, ben diversi per grandezza e distribuzione, si devono al botanico tedesco Johann Christian Daniel von Schreber, che li pubblicò nel 1791 nella sua riedizione del linneano Genera Plantarum, purtroppo senza alcuna dedica esplicita. Krigia è un piccolo genere di 7 specie, distribuite tra il Canada sud-orientale, gli Stati Uniti centrali e orientali e il Messico nord-orientale. Sono erbacee perenni o annuali, con una radice fibrosa o a fittone da cui emergono gambi eretti e solitamente non ramificate, con foglie lanceolate, dentate o lobate a rosetta e capolini per lo più solitari, gialli o arancione, molto simile a quelli dei generi Hieracium e Pilosella. Vernonia è invece un grande genere cosmopolita cui sono attribuite quasi 350 specie, ma inteso in senso lato è giunto a comprenderne anche 1000; va inoltre considerato che le specie in aree in contatto tendono ad ibridarsi con facilità. Gli studi hanno identificato due centri di biodiversità: uno in America, l'altro in Africa e nell'Asia sud-orientale. Possono essere erbacee annuali o perenni, spesso di grandi dimensioni, arbusti da piccoli a grandi, rampicanti o piccoli alberi, con foglie alternate semplici, da lanceolate a strettamente lineari. I capolini, raccolti in cime o corimbi terminali o ascellari, sono composti da un involucro a coppa o cilindrico formato da 5-6 serie di brattee embricate che proteggono il ricettacolo sul quale si inseriscono i flosculi tubolosi, usualmente bisessuali e fertili. La corolla tubolare e lobata può essere viola, blu o anche bianco-crema. I frutti sono acheni dotati di pappo. Diverse specie nordamericane sono coltivate nei giardini. Tra di esse V. arkansana (spesso commercializzata come V. crinita), originaria degli Stati Uniti centrali, un'alta perenne che tra agosto e settembre produce grandi capolini viola dall'aspetto un po' scompigliato; la rusticissima V. fasciculata, nativa di una fascia che va dal Manitoba in Canada agli Stati Uniti centro-settentrionali, che produce alti steli non ramificati che culminano in un denso corimbo di fiori magenta; V. lettermannii, originaria dell'Arkansas e dell'Oklahoma, con foglie filiformi e centinaia di piccoli fiori viola scuro; simile è V. noveboracensis, che tende ad espandersi con stoloni sotterranei, con fiori viola, ma anche lilla e bianchi. Diverse specie africane, come V. colorata, sono utilizzate come verdura da foglia; dato che crescono rapidamente e si rigenerano dopo i tagli, producendo una grande massa di foraggio che resiste molto bene alla siccità, sono note, oltre che con diversi nomi locali, con il nome inglese ironweed, erba di ferro, dovuto ai fusti rigidi e talvolta color ruggine, ma anche alla veloce crescita e alla robustezza. La specie più importante di questo gruppo, la più consumata nonché ingrediente dello Ndolé, il piatto nazionale del Cameroon, V. amygdalina, è stata trasferita al genere Gymnanthemum come G. amygdalinum; è anche una importante pianta medicinale. Secondo Plants of the World on line (ma l'accordo non è universale) va ricondotta a questa specie come sinonimo anche Vernonia condensata, poi Vernonanthura condensata, in precedenza ritenuta un endemismo brasiliano, mentre si tratta appunto di una specie africana, introdotta all'epoca della tratta degli schiavi. Dai semi di V. galamensis viene invece ricavato un olio con un alto contenuto di acido vernolico, utilizzato nell'industria delle vernici e come plastificante. Oltre ad essere il patrono dell'importantissimo genere Vernonia, William Vernon è celebrato indirettamente anche da due dei tanti generi che ne sono stati separati, Vernoniopsis e Vernonanthura. Il primo ("simile a Vernonia") è un genere endemico del Madagascar, con una o due specie di arbusti o piccoli alberi con corimbi terminali di numerosi capolini con lungo ricettacolo e corolla biancastra. Il secondo (da Vernonia + anthura, da anthera e oura "coda", in riferimento alle antere con base frequentemente caudata) è un grande genere separato nel 1995 da Vernonia, da cui differisce per la distribuzione più meridionale (dal Messico all'Argentina, passando per le Antille), le infiorescenze piramidali o tirsoidi anziché corimbose, l'habitus tipicamente arbustivo con steli legnosi fin dalla base anziché erbacei, e appunto le antere con code prominenti alla base. Il genere comprende una sessantina di specie; la più nota era probabilmente Vernonanthura condensata che, come abbiamo visto è stata trasferita a Gymnanthemum ed è per lo più ritenuta sinonimo di G. amygdalinum. Anche in questo genere troviamo piante interessanti per i nostri giardini, come V. nudiflora (in precedenza Vernonia angustifolia), un arbusto originario del Brasile e dell'Argentina, con foglie lineari e bei fiori viola. V. polyanthes ci ricorda invece quanto è pericoloso introdurre specie aliene in ambienti fragili: nativa del Brasile, all'inizio degli anni '90 del Novecento è stata introdotta in Mozambico come pianta nettarifera per le api; da qui si è diffusa nel vicino Zimbabwe e in diversi ambienti è rapidamente diventata una specie dominante ai danni della vegetazione nativa. Nella primavera del 1788, il botanico francese André Michaux e suo figlio François André visitano la Florida occidentale dove sono accolti con squisita cortesia dal governatore Vicente Manuel de Céspedes. Memore di quell'accoglienza, qualche anno dopo Michaux gli dedica uno dei suoi nuovi generi americani, ma un errore di lettura o una svista del tipografo trasformano il buon governatore in Lespedez e il genere in Lespedeza. 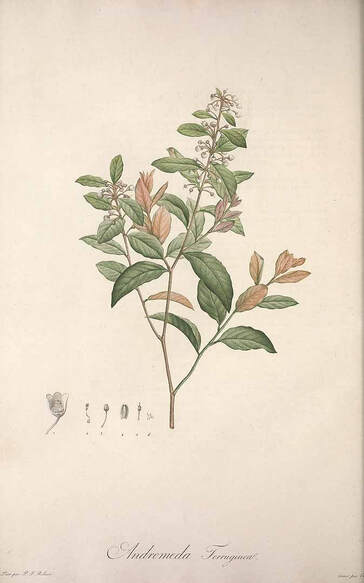 Un memorabile viaggio in Florida Inviato negli Stati Uniti come botanico reale alla ricerca di piante utili per ripopolare le foreste francesi, André Michaux era invece intenzionato ad andare oltre questo mandato: voleva scrivere una flora del Nord America, e per questo desiderava visitare tutte le zone accessibili, incluse la Florida spagnola e le Bahamas, nonostante la loro flora tropicale o subtropicale poco si adattasse all'introduzione in terra francese. Già nel 1787 aveva comunicato al Conte d'Angevilliers, direttore generale dei Bâtiments du Roi (da cui dipendeva la sua missione) la sua intenzione di visitare la Georgia e la Florida. Tensioni di frontiera bloccarono per qualche mese il progetto, finché alla fine del febbraio 1788, accompagnato dal figlio François André e da un servitore, egli salpò da Charleston alla volta di St. Augustine, la capitale della Florida occidentale. Agli ufficiali di porto dichiarò di essere stato autorizzato a studiare la storia naturale della provincia dal governatore, Vicente Manuel de Céspedes (o Zéspedes), al quale evidentemente aveva scritto, anche se il carteggio non ci è pervenuto. Condotto alla presenza del governatore, fu ricevuto con grande calore e cortesia. Solo qualche giorno dopo scrisse nuovamente a d'Angevilliers per ottenere il permesso ufficiale di fare raccolte botaniche in Florida. Di fatto, si era già messo al lavoro. Oltre a esplorare i dintorni della città, dove scoprì una nuova specie di Ericacea, Lyonia ferruginea, si era procurato un terreno dove creare un vivaio temporaneo e aveva affittato una canoa e due rematori. Il 12 marzo partì alla volta dell'Anastasia Island, dove fu ospite del mercante Jesse Fish che nella sua residenza, chiamata El Verge, aveva creato un giardino ricco di olivi, palme da dattero, limoni e aranci; Michaux nelle sue memorie lo definisce un paradiso. Era la prima tappa di un viaggio, parte in canoa, parte a piedi, parte a cavallo, che li portò in direzione sud, sempre erborizzando, ad esplorare la costa orientale della Florida lungo il Northwest River e l'Indian River fino all'altezza dell'attuale Bonaventure, dove giunsero all'inizio di aprile; oltre non era possibile andare, essendo ormai penetrati in territorio indiano. Durante il viaggio di ritorno affittarono dei cavalli per riportare le raccolte a St. Augustine e osservarono un incendio: sia gli indiani sia gli europei usavano applicare incendi per facilitare la caccia o per liberare terreni per il bestiame, una pratica altamente disapprovata da Michaux. Rientrato a St. Augustine il 17 aprile, Michaux fece subito visita al governatore, che nei giorni successivi volle visitare di persona le collezioni e invitò il botanico a pranzo. Quest'ultimo era impegnato a riordinare le raccolte (stando al suo diario, fino a quel momento ammontavano a 105 specie), a scrivere lettere in Francia e ai rappresentanti diplomatici francesi, anche per battere cassa, e a preparare la prossima escursione. Il 29 aprile era infatti di nuovo in partenza con gli stessi compagni, questa volta a cavallo, alla volta della residenza di Job Wiggins, che aveva accompagnato William Barton nella spedizione del 1774. Situata sulla riva orientale del St. Johns River, era un buon punto di partenza per esplorare il bacino del fiume, il maggiore della colonia; nei dintorni, Michaux trovò una nuova specie di graminacea, Stenopholis obtusata. Da quel momento il viaggio proseguì in canoa, toccando Mount Royal, una collina sabbiosa visitata e così denominata da John Bartram nel 1765, e Drayton Island sul lago George; quindi continuò lungo il St Johns River e nella strettoia oggi chiamata Salt Springs Run fino alla sorgente dove Michaux raccolse Illicium parviflorum, già osservato nei lori viaggi dai due Bartram ma ancora non descritto. Quindi il gruppo esplorò Silver Gleb Spring e proseguì fino alla confluenza tra il lago George e il St. Johns River, quindi lungo il fiume dove dopo qualche giorno si imbatté in correnti contrarie e grandi masse di alligatori; giunto all'altezza dell'attuale High Bank, avendo trovato poche specie nuove, Michaux decise di rientrare a St. Augustine. Il viaggio volgeva al termine. Dopo un'ulteriore visita al governatore e ad alcune famiglie influenti, i Michaux si imbarcarono con loro raccolte alla volta di Charleston; qui le talee prese in Florida furono trapiantate nel vivaio, mentre i semi di molte piante venivano spediti in Francia; tra le altre, Guilandina bonduc, Sophora tomentosa, Chiococca alba, Ceanothus microphyllus, Conocarpus erectus, Psychoria nervosa, Amyris eleifera, Zamia integrifolia, Tillandsia utriculata, Modiola caroliniana.  Ripopolare la Florida E' ora di sapere qualcosa di più dell'ospitale governatore Vicente Manuel de Céspedes (1721?-1794); appartenente a una famiglia di militari e militare egli stesso, prima di arrivare in Florida per circa un anno era stato governatore facente funzione a Santiago de Cuba; nel 1783 fu nominato primo governatore della Florida orientale che, dopo vent'anni di occupazione britannica, tornava sotto sovranità spagnola in forza del trattato di Parigi. Céspedes si trovò così a gestire una difficile transizione. Il problema principale era quello del popolamento. La popolazione era molto mista: c'erano spagnoli provenienti dalla madre patria, cubani, minorchini (Minorca nel Settecento era passata più volte dalla sovranità spagnola a quella britannica e viceversa, e molti erano di lingua inglese), francesi, italiani, greci, britannici che durante l'occupazione inglese erano subentrati agli spagnoli che avevano preferito lasciare la colonia. Il timore era che con il tempo gli anglofoni potessero prendere il sopravvento o che gli Stati Uniti decidessero di invadere il paese; venne così fissato l'obiettivo di aumentare la popolazione, fino a eguagliare nell'arco di 25 anni quella della Georgia. La corona fissò regole molto stringenti per i nuovi immigrati, la principale delle quali era che dovevano essere di religione cattolica; anche gli stranieri erano ben accetti, purché fossero appunto cattolici e imparassero la lingua spagnola. Céspedes, da parte sua, cercò di favorire i nuovi arrivi, garantendo dieci anni di esenzione dalle tasse, terre, aiuti come bestiame, sementi, attrezzi. Buona parte del territorio era disabitato, e le terre non mancavano, ma la questione del ripopolamento si incrociava con quella delle proprietà. Alcune, i cui proprietari ispanici avevano preferito lasciare la Florida, erano rimaste vacanti al momento dell'occupazione inglese, altre erano state abbandonate dagli inglesi al ritorno degli spagnoli. Céspedes propose che tutte le proprietà vacanti e non rivendicate entro una certa data fossero confiscate dalla corona, per essere ridistribuite ai nuovi immigrati, in particolare i cosiddetti floridanos, ovvero quelle persone che si erano stabilite a Cuba dopo l'occupazione inglese della Florida, di cui voleva incoraggiare il ritorno nella penisola. Un'ultima questione riguardava gli schiavi neri. Poiché nella Florida spagnola non c'erano né piantagioni né miniere, erano pochi; inoltre, nel 1693, il re Carlo II aveva emanato un decreto che concedeva la libertà agli schiavi fuggiti dall'America britannica, purché accettassero la religione cattolica. Così si era formato un notevole insediamento di neri liberi a nord di S. Augustine; godevano della libertà personale, non erano discriminati e formarono persino un reggimento di milizia. Altri schiavi fuggiti si erano rifugiati presso gli indigeni Creek e Seminole. Durante il ventennio di occupazione, i coloni britannici avevano introdotto l'economia di piantagione (si coltivavano cotone, indaco, canna da zucchero) e con essa schiavi neri portati dall'Africa. Al ritorno degli Spagnoli, essi chiesero di essere liberati in osservanza alla legge di Carlo II, mentre i loro proprietari, che ora si era stabiliti in Georgia o nelle Caroline, ne chiedevano la restituzione; Céspedes, anche se temeva che molte conversioni fossero di comodo, li trattenne in Florida. Buona parte del territorio era inesplorato; gli abitati si concentravano lungo la costa, con centro principale a St. Augustine (Jacsksonville e Miami non esistevano ancora) e non si spingevano oltre il Río de Mosquitos, forse a sud dell'attuale Cape Canaveral. Gli inglesi avevano poi creato una serie di piantagioni lungo il St Johns River, il più lungo e importante della regione anche per i commerci, anche se, per le sue acque basse e paludose, era navigabile solo in canoa. Si capisce dunque perché il governatore si sia mostrato così amichevole verso Michaux e abbia incoraggiato la sua esplorazione. Nel 1784, ordinò un censimento, seguito nel 1786 da un secondo più dettagliato. La conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche geografiche e umane, delle sue risorse, erano per lui un dovere d'ufficio, come dimostra il suo unico scritto noto, Descripción de la Florida Oriental: su clima, terreno, productos, ríos, barras, bahías, puertos, números y calidades de la gente que la habitan, un manoscritto inedito oggi conservato nell'Audiencia de Santo Domingo dell'Archivio General de Indias, da lui inteso come una vera e propria guida per indirizzare la politica immigratoria. Il documento inizia con una una descrizione geografica della Florida orientale, soffermandosi sull'estensione, il clima, le forme del territorio; si trattano poi i fiumi principali, i laghi, le lagune costiere, sempre indicando gli eventuali popolamenti e la loro consistenza, i pochi nuclei urbani. Dopo aver trattato in modo abbastanza generico le risorse naturali (che sono comunque abbondanti e promettenti), Céspedes conclude con la parte più politica: le sue indicazioni per incrementare il commercio (che a suo parere deve avvenire soprattutto da e verso Cuba) e per favorire l'immigrazione, terminando con le Reglas y condiciones para pobladores tanto extranjeros como naturales di cui abbiamo già parlato. L'incarico di Céspedes terminò nel 1790; dovette quindi ritornare a Cuba, dove sappiamo che morì nel 1794 e fu sepolto nella cattedrale dell'Avana.  Un errore... di sbaglio Michaux non dimenticò mai la cortesia con la quale era stato accolto dal governatore Céspedes, che la sua lotta con l'avara e poco sollecita amministrazione francese prima e dopo la rivoluzione gli facevano apprezzare anche più. Così nella sua Flora boreali-americana non poteva mancare di rendergli omaggio, dedicandogli uno dei suoi nuovi generi. Il libro fu pubblicato postumo nel 1803 a cura del figlio François André e questo forse spiega il fattaccio: tanto il nome del genere quanto quello del dedicatario sono infatti sbagliati. Il genere si chiama Lespedeza, non Cespdeza o Zespedeza (le due forme sotto le quali conosciamo il nome del governatore) e del dedicatario si dice "Per il sig. Lespedez, governatore della Florida, cortesissimo nei confronti dei miei viaggi". Eppure anche François André era della partita... ma, come si dice in questi casi, la colpa è del proto che avrà scambiato la lettera iniziale C con L. Lespedeza Mich. è un genere di una quarantina di specie della famiglia Fabaceae, con una distribuzione nettamente disgiunta: una trentina vivono nelle zone temperate e subtropicali dell'Asia orientale e in Australia, mentre le altre sono originarie del Nord America orientale. Il numero delle specie e la loro corretta individuazione hanno dato filo da torcere ai botanici a causa sia dell'estrema variabilità delle specie, sia della tendenza a produrre con facilità ibridi naturali. Il genere, caratterizzato dai fiori papilionacei (ma molte specie hanno anche fiori cleistogami, cioè autofecondanti, privi di petali) e da baccelli tipici di questa famiglia, è piuttosto vario: comprende infatti erbacee perenni, arbusti e rampicanti. La specie più nota e coltivata nei giardini è senza dubbio L. thunbergii, uno splendido arbusto originario della Cina e del Giappone con eleganti rami arcuati che alla fine dell'estate si trasformano in una cascata di fiori rosa-porpora. L'americana L. capitata è invece famosa per altre ragioni: già gli indiani ne usavano le foglie per preparare tisane medicamentose; oggi è usata in fitoterapia per le sue proprietà drenanti, diuretiche e antiossidanti, che la rendono particolarmente indicata per migliorare le funzioni renali. Come molte leguminose, anche le piante di questo genere hanno radici dotate di noduli che ospitano batteri in grado di fissare l'azoto, arricchendo così il terreno. In Asia diverse specie sono usate come foraggere e appunto per il sovescio. Le loro forti radici sono utili anche per arginare il terreno, contenendo gli smottamenti. Ma queste belle qualità possono anche presentare un rovescio della medaglia, come dimostra la storia dell'asiatica L. cuneata. Questa pianta è stata introdotta in diversi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti dove venne piantata per la prima volta nel 1896 nel Nord Carolina per bonificare i terreni di miniere abbandonate, e anche come foraggiera; grazie alle radici molto profonde, non solo trattiene il terreno, ma riesce a sopravvivere a lunghi periodi di siccità. Ne sono anche state sviluppate diverse varietà. Eppure tanto vigore ha un rovescio della medaglia: una singola pianta può produrre 1000 semi all'anno, dove si insedia invade gli spazi delle piante native, inibisce la crescita dei semenzali degli alberi, produce sostanze chimiche che inibiscono la crescita di altre piante. Negli Stati Uniti è già un problema, in Europa non ancora, ma l'Unione europea l'ha inserita nella lista delle piante invasive e ne ha vietato la commercializzazione. Botanica e indipendenza: i discepoli di Mutis, il movimento indipendentista e il genere Lozania30/6/2022 José Celestino Mutis morì l'11 settembre 1808. Non assistette dunque agli eventi che tra il 20 luglio 1810 e l'agosto 1819 portarono all'indipendenza del Vicereame della Nuova Granada, a partire dal 1831 Repubblica di Colombia. Vi ebbero invece un ruolo di primo piano molti dei suoi discepoli e collaboratori, a cominciare dal nipote Sinforoso Mutis e dal più noto di tutti, Francisco José de Caldas. Sorge spontanea la domanda: la Real Expedición Botánica ebbe anche un contenuto politico? Fu un covo di cospiratori (dal punto di vista spagnolo) o di patrioti (dal punto di vista colombiano)? Gli storici tendono ad escluderlo, sottolineando che le idee di emancipazione, più che nei laboratori della Casa della Botanica, nacquero nelle aule universitarie e nei circoli letterari frequentati anche dai giovani intellettuali creoli reclutati dalla spedizione. Da Mutis però essi furono educati al pensiero libero e rigoroso, al metodo scientifico, agli ideali illuministi, e certo anche la partecipazione alla spedizione rafforzò in loro la coscienza della diversità americana non solo dal punto di vista della natura. Così, allo scoppio dell'insurrezione, guidata da intellettuali come loro, li troviamo in prima fila; una scelta che molti pagarono con la vita. Come naturalista, più di uno ha avuto l'onore di essere ricordato da un genere botanico, ma rimane valido solo Lozania, dedicato a Jorge Tadeo Lozano, zoologo della spedizione e primo presidente della Repubblica di Cundinamarca. 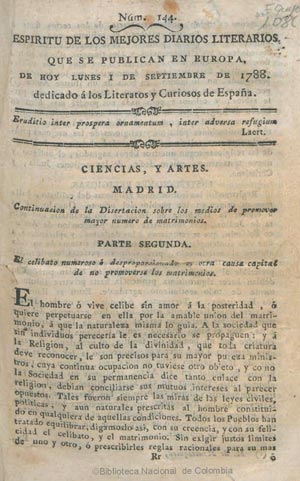 Quale fu la culla dell'indipendenza? A partire dal 1808, in seguito all'occupazione francese della Spagna, le colonie dell'America latina si trovarono isolate dalla madrepatria e le élites creole approfittarono del vuoto di potere per proclamare l'indipendenza. Inizia così un tumultuoso susseguirsi di eventi che, tra guerra tra spagnoli e insorti e guerre civili, si protrarrà fino ai primi anni '30 e sfocerà nella nascita dei paesi latino-americani. Nel Regno di Nuova Granada la rivolta iniziò il 20 luglio 1820. Era venerdì, giorno di mercato e di grande affluenza nella piazza principale di Santa Fé di Bogotà; facendo leva sulle tensioni latenti tra spagnoli e "americani", un gruppo di agitatori riuscì a provocare un'insurrezione che la sera stessa portò alla creazione di una Giunta suprema di governo e alla proclamazione dell'Indipendenza. La giornata era stata attentamente pianificata da un gruppo di intellettuali creoli di idee liberali che da qualche tempo si riunivano in un luogo insospettabile: l'Osservatorio voluto da José Celestino Mutis e diretto dal più noto dei suoi discepoli, Francisco José de Caldas, che fu anche coinvolto negli incidenti del 20 luglio. Tra i firmatari dell'Atto di indipendenza e membri della Giunta suprema anche altri provenivano dalle file della Real Expedición Botánica; José María Carbonell che ne era lo scrivano; Jorge Tadeo Lozano, che dirigeva le ricerche zoologiche; Sinforoso Mutis Consuegra, nipote di Mutis e direttore del ramo botanico della spedizione dopo la morte dello zio. Più tardi si sarebbe unito agli indipendentisti anche il capo dei pittori della spedizione e "maggiordomo" di Mutis, Salvador Rizo Blanco. Ne dobbiamo concludere che la spedizione fu la culla del movimento indipendentista? Non in modo diretto, ma certamente l'insegnamento di Mutis ne gettò le basi, educando un'intera generazione al pensiero scientifico e agli ideali illuministi e aprendola alle nuove idee che venivano dall'Europa. Come notò con stupore Humboldt, l'ambiente intellettuale del vicereame era vivacissimo; a Santafé di Bogotà si pubblicavano diversi giornali; si traducevano libri europei; c'erano circoli letterari e associazioni culturali in cui si incontravano giuristi, giornalisti, scienziati e altri intellettuali e si discutevano appassionatamente idee di riforma. In qualcuna di queste tertulias, come erano chiamate, circolavano idee decisamente radicali; è il caso del Casino Literario che si riuniva a casa di Antonio Nariño (anche lui un ex allievo di Mutis al Colegio del Rosari) ed era frequentato da latri "rosaristi" come Lozano; tra gli habitué uno dei più stretti collaboratori di Mutis, il botanico Francisco Antonio Zea, e il giovanissimo Sinforoso Mutis. La vera culla del movimento indipendentista, dunque, più che la spedizione stessa, furono i collegi universitari e i circoli intellettuali. La posizione personale di Mutis era moderata e prudente e nelle sue lettere traspare grande preoccupazione per le frequentazioni pericolose del nipote e di Zea. La sua vera rivoluzione, è stato scritto, non fu politica, ma scientifica ed educativa. La preoccupazione del sapiente Mutis era più che fondata. Nel 1794 Nariño tradusse e pubblicò clandestinamente la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino; contemporaneamente sui muri di Bogotà comparvero manifesti (pasquinas, ovvero pasquinate) che denunciavano l'oppressione spagnola e inneggiavano alla libertà, presumibilmente opera di studenti dei Collegi del Rosario e di San Bartolomé. La repressione colpì duro: sia Nariño sia altri membri del circolo vennero arrestati, inclusi Zea e Sinforoso, che insieme a lui furono tradotti al carcere del Castillo de San Sebastián di Cadice; mentre Nariño riuscì a evadere quindi a raggiungere la Francia, Zea e Sinforoso rimasero agli arresti fino al 1799. Prima di tracciare un breve profilo dei collaboratori e discepoli di Mutis coinvolti nel movimento indipendentista, riassumiamo brevemente le vicende di quest'ultimo. Gli anni tra il 1810 e il 1814 furono caratterizzati da un duplice conflitto: da una parte, la guerra d'indipendenza contro gli spagnoli, dall'altra la guerra civile tra le due autoproclamate repubbliche delle Provincias Unidas de la Nueva Granada e dell'Estado Libre e Independiente de Cundinamarca, la prima decisamente federalista, la seconda tendenzialmente centralista. Nel 1814, per ordine del Congresso delle Province unite, Bolivar conquistò la capitale, costringendo Cundinamarca a unirsi alle altre province. Anche queste divisioni favorirono la ripresa realista; nel 1815 il generale Morillo invase il paese e nel 1816 mise fine all'effimera repubblica, scatenando una pesantissima repressione contro i patrioti colombiani, con centinaia di condanne a morte; tra i caduti i protagonisti di questa storia: José María Carbonell, Jorge Tadeo Lozano, Salvador Rizo Blanco e Francisco José de Caldas. Sinforoso Mutis invece ebbe salva la vita; vedremo più avanti perché e come.  Dalla spedizione alla politica Iniziamo con un non scienziato, José María Carbonell (1778 - 1816); nato a Bogotà, studiò al Colegio Mayor de San Bartolomé, quindi fu assunto come scrivano della Expedición Botánica. Il suo compito era trascrivere i materiali necessari; probabilmente fu lui a ricopiare per la stampa l'opera postuma di Mutis El arcano de la quina. Durante la giornata del 20 luglio 1810 fu tra i più attivi soprattutto nel coinvolgere gli strati più popolari; acceso centralista, durante la Repubblica occupò diversi incarichi: primo presidente della Giunta, capitano delle milizie di fanteria, ufficiale maggiore cassiere, contabile e tesoriere del Tesoro di Cundinamarca. Al momento della repressione la sua condanna fu senza appello: definito da Morillo "uno degli uomini più preversi e crudeli che si siano segnalati tra i traditori", venne impiccato il 19 giugno 1816. Jorge Tadeo Lozano (1771-1816) apparteneva a una famiglia nobile, una delle più prestigiose e influenti del vicereame; ricevette un'approfondita educazione, quindi studiò letteratura, filosofia e medicina al Collegio del Rosario, dove fu allievo di Mutis. Inizialmente abbracciò la carriera militare e combatté contro la Francia nella Guerra dei Pirenei; approfittò del soggiorno a Madrid anche per studiare matematica e chimica presso il Real Laboratorio de Química e viaggiò in Europa, vivendo per qualche tempo a Parigi. Al suo ritorno a Nuova Granada nel 1797, divenne un membro attivo dei circoli letterari, in particolare del Casino di Nariño. Nel 1801 fondò il settimanale Correo curioso, erudito, económico y mercantil de la ciudad de Santafé de Bogotá, in cui propugnò tra l'altro la fondazione di una Società patriottica. Nel 1802, su proposta di Mutis, ottenne la cattedra di chimica al collegio del Rosario e gli succedette in quella di matematica; resse le due cattedre fino al 1806, quando fu aggregato alla Real Expedición Botánica come zoologo. Indirizzò i suoi studi sugli anfibi e i rettili, pubblicando nel 1810 Memoria sobre las Serpentes e diversi saggi sul Semanario, tra cui l'inizio di un'annunciata Fauna cundinamarqiesa. Poi la politica travolse anche lui. Dopo la proclamazione dell'indipendenza, fu nominato presidente della commissione incaricata di redigere la nuova costituzione: il risultato fu la Constitución de Cundinamarca, che trasformava lo stato in una monarchia costituzionale. Nell'aprile 1811 fu eletto primo presidente della Cundinamarca, ma dopo pochi mesi fu costretto alle dimissioni in seguito a una campagna di discredito orchestrata da Nariño. Ritornò ai suoi studi ma non abbandonò del tutto la politica; nel 1814 fondò un secondo giornale di orientamento più politico, Anteojo de Larga Vista, e nel 1815 prese parte al Congresso generale della Nuova Granada come deputato della provincia del Chocó. La posizione relativamente defilata e le idee moderate non gli salvarono la vita: anche lui fu condannato a morte e fucilato alla schiena il 6 luglio 1816. Porta il suo nome l'Universidad Jorge Tadeo Lozano, un ateneo privato di Bogotà. Con Salvador Rizo Blanco (1760-1816) andiamo al cuore della Real Expedición Botánica. Mutis lo incontrò nel 1784, quando Rizo lavorava come disegnatore per un ingegnere stradale. Notando le eccellenti qualità del suo tratto, lo portò con sé a Mariquita per farne il primo pittore della spedizione. Era abile, fedele, infaticabile; Mutis gli affidò non solo la direzione del laboratorio di pittura, ma anche quella che chiamava "mayordomia", ovvero l'amministrazione e l'organizzazione finanziaria della spedizione. Quale fosse il suo lavoro, e quanto centrale, lo spiegò egli stesso in un memoriale rivolto al Viceré qualche anno dopo: "Erano affidate a me la riscossione delle rendite destinate alla spedizione e le spese ordinarie; incarichi, viaggi, escursioni botaniche, tutto passava per le mie mani. Allo stesso tempo disegnavo e coloravo le tavole della Flora che mi erano state affidate, e cercavo di dare la maggiore perfezione possibile a quelle curate da altri artisti venuti da Quito; ho trasmesso i miei principi ai giovani che mi erano stati affidati, creando a tal fine una scuola". Tra i disegni della spedizione si conservano 140 tavole firmate da Rizo (probabilmente ne produsse molte di più senza firma); sebbene siano di qualità artistica inferiore rispetto a quelli dell'altro pittore principale, Francisco Javier Matís, si distinguono per la fedeltà al modello e il disegno sicuro. Fu anche un valido ritrattista: gli si devono un busto di Mutis e un ritratto di Cavanilles, dipinto in abito talare di profilo, mentre tiene davanti a sé la tavola botanica di Rizoa ovatifolia (la pianta che aveva dedicato a Rizo) e ne completa la descrizione. Mutis aveva tale fiducia in lui da nominarlo suo esecutore testamentario. Dopo la sua morte, Rizo riuscì a far completare oltre 200 tavole botaniche, ma dovette scontrarsi con l'ostilità della famiglia Mutis, con invidie e sospetti, che si fecero anche più pressanti dopo il 20 luglio; Nariño fece perquisire la sua casa con l'accusa di aver sottratto materiali e manoscritti, spingendolo ad abbandonare la città con la sua famiglia. Nel 1813 si arruolò nell'esercito delle Province unite sotto il comando di Bolivar, come Provveditore generale dell'Esercito. Nel dicembre 1814 tornò a Bogotà con Bolivar, e si trovò invischiato in una causa intentatogli dai suoi nemici che ribadiva l'accusa di furto di manoscritti e averi di Mutis. Si trovava dunque in città quando Murillo scatenò il terrore contro i patrioti. Arrestato, fu detenuto per cinque mesi, senza avere la consolazione di vedere riconosciuta la sua innocenza dai vecchi compagni di spedizione che pure condividevano la stessa sorte. Condannato a morte, fu fucilato il 12 ottobre 1816.  Astronomo, botanico, ingegnere militare Tra i discepoli e collaboratori di Mutis il più noto è Francisco José de Caldas (1768-1816) che, come il suo mentore, si guadagnò il soprannome di "el sabio", il sapiente. Egli nacque a Popoyán, dove iniziò gli studi nel Seminario Mayor, dimostrando una particolare attitudine per la matematica. La famiglia voleva farne un avvocato; continuò dunque gli studi al Colegio del Rosario di Bogotà, laureandosi in legge nel 1793. Tornò a Popoyan e per qualche tempo divise il suo tempo tra l'avvocatura e i viaggi d'affari in Ecuador. Intorno al 1796 la lettura di alcuni testi della Spedizione geodetica all'equatore riaccese la sua passione scientifica; acquistò un barometro, due termometri e un ottante e approfittò dei suoi viaggi tra Popoyan e Quito per misurare l'altitudine e la latitudine di diverse località e raccogliere dati geografici ed astronomici. Tra il dicembre 1798 e il febbraio 1799, su richiesta della comunità di Timaná alle prese con alcuni problemi di confine, ne tracciò la carta e stabilì la latitudine basandosi su un'eclissi lunare. Si procurò un telescopio, costruì da se stesso altri strumenti, come uno gnomone e un quadrante, e creò una specie di osservatorio nel patio della casa di famiglia. Nel 1801, avendo letto sul Correo curioso di Lozano una stima scorretta dell'altezza dei monti Guadalupe e Monserrate, che egli stesso aveva misurato, rispose con un articolo di rettifica che fu pubblicato e cominciò a farlo conoscere al di fuori dell'ambiente provinciale. I suoi amici di Bogotà ne approfittarono per fare il suo nome a Mutis; tra i due iniziò una corrispondenza. Nel maggio di quell'anno Caldas fece la sua più importante scoperta; scoprì che, poiché la temperatura a cui bolle l'acqua varia con l'altitudine, essa può essere utilizzata con notevole precisione per stabilire l'altitudine stessa, senza altri strumenti che un termometro. A tal fine elaborò una formula matematica e costruì un apposito termometro ipsometrico. Il 4 novembre di quel memorabile 1801 Humboldt e Bompland, dopo aver trascorso diversi mesi a Bogotà accolti da Mutis, arrivarono a Popoyán. Il barone aveva letto l'articolo di Caldas sul Correo Curioso che lo aveva stupito per la grande esattezza, aveva sentito parlare di lui dai suoi amici di Bogotà, ed era ansioso di incontrarlo ma el sabio non era in città: era a Quito ad occuparsi di affari di famiglia. Humboldt visitò però il padre di Caldas che gli mostrò i quaderni del figlio. L'incontro tra i due scienziati sarebbe avvenuto l'ultimo giorno dell'anno a Ibarra in Ecuador. Quindi viaggiarono insieme fino a Quito, confrontandosi e discutendo di molti argomenti scientifici. Per l'autodidatta Caldas fu quasi un corso d'aggiornamento accelerato: Humboldt gli mostrò i suoi quaderni di campo, gli insegnò nuovi metodi per misurare l'altitudine e come usare l'ottante. Tra febbraio e marzo 1802 per 37 giorni i tre naturalisti lavorarono insieme a Chillo. Caldas fece escursioni botaniche con Bompland e misurazioni trigonometriche con Humboldt. A questo punto avrebbe voluto con tutte le forze unirsi ai due europei, ma il progetto fu respinto dal tedesco, nonostante la raccomandazione di Mutis. Svanito questo sogno, fu proprio Mutis a invitarlo a partecipare alla spedizione botanica. Gli chiese in particolare di studiare le piante utili, soprattutto le varie specie di Cinchona dell'Ecuador. Caldas accettò con entusiasmo e per qualche anno, da astronomo, divenne botanico. Tra il 1802 e il 1805 esplorò intensamente la flora della regione, sempre prendendo note accuratissime sui luoghi di crescita e gli eventuali usi; nel 1802 viaggiò da Ibarra a Imbabura, nel 1803 da Ibarra al Pacifico, nel 1804, di nuovo alla ricerca delle piante di china, visitò Latacunga, Ambato, Cuenza e Loja; nel 1805 ritornò a Popayán e da qui Bogotá, con un bottino di più di 6000 fogli di erbario. In tal modo la Real Expedición Botánica si allargò all'Ecuador. Al suo arrivo a Bogotà, Mutis lo incaricò di dirigere l'appena inaugurato Osservatorio astronomico. Anche se ormai si sentiva più botanico (stava lavorando a una Fitogeografia dell'Ecuador, in cui era giunto a conclusioni simili a quelle di Humboldt sulla distribuzione altimetrica delle piante), egli si gettò con tutta l'impulsività della sua natura anche in questa avventura stabilendo un programma regolare di osservazioni astronomiche, geografiche e meteorologiche; inoltre fondò e redasse un giornale scientifico El semanario del Nuevo Regno de Granada sul quale vennero pubblicati articoli suoi e di altri membri della spedizione nonché traduzioni dal francese di Lozano. Per la botanica, di particolare importanza la pubblicazione di una serie di nuovi generi stabiliti da Mutis, ma mai pubblicati. Abbiamo già visto che si trovò al centro degli eventi del 20 luglio, anche se forse aveva ospitato i congiurati nel suo alloggio all'osservatorio più per amicizia che per convincimento politico. Ancora una volta cambiò totalmente vita e rivolse il suo genio alla fabbricazione di armi e all'allestimento di fortificazioni: nel 1811 fu nominato capitano del corpo degli ingegneri militari e dal 1812 fu promosso tenente colonnello. Nel 1813, avendo partecipato a un tentativo di deporre Nariño, si rifugiò a Antioquia dove fu ancora ingegnere militare con il grado di colonnello. Tra il 1813 e il 1814 si occupò delle fortificazioni del fiume Cuaca e della creazione di una polveriera e di una fabbrica di fucili. Nel 1815 il presidente Camilo Torres gli chiese di fortificare Bogotà in vista dell'attacco spagnolo e lo incaricò di dirigere la Scuola militare. Quando gli spagnoli invasero il paese, tentò la fuga ma fu catturato e anche lui condannato a morte. Si racconta che nel sentire la sentenza egli stesso o i presenti facessero appello a Morillo oppure a Pascual Enrile y Acedo (esistono varie versioni) perché fosse risparmiata la vita a quel sapiente. La risposta fu: "La Spagna non ha bisogno di sapienti". Come gli altri patrioti, fu fucilato alla schiena come traditore.  La fine della spedizione L'unico a sfuggire a questo destino fu Sinforoso Mutis Consuegra (1773-1822); era uno dei tre figli di Manuel Mutis Bosio, fratello di José Celestino, e della colombiana María Ignacia Consuegra. Quando il padre morì, aveva solo tredici anni e lo zio si fece carico della sua educazione, affidandolo a un altro ex membro della spedizione, Juan Eloy Valenzuela, parroco a Bucaramanga. Sinforoso poi studiò al Colegio del Rosario dove seguì i corsi di Filosofia naturale in cui si studiava matematica, fisica, astronomia e scienze naturali. Nel 1791, proprio nel momento in cui la sua sede veniva spostata da Mariquita a Santafé, fu aggregato alla spedizione come disegnatore apprendista; si dimise nel 1793 per riprendere gli studi di legge al Colegio del Rosario. Fu probabilmente in queste circostanze che incominciò a frequentare gli ambienti "sovversivi" e finì implicato nell'affare delle pasquinate. La brutta avventura ebbe però anche risvolti positivi: nel 1799 il carcere fu mutato in arresti domiciliari, il che gli permise di frequentare il corso di botanica tenuto nell'Ospedale reale di Cadice da Francisco Arjona. Finalmente amnistiato, fu reintegrato nella spedizione e gli fu concesso di approfondire gli studi di botanica all'orto botanico di Madrid seguendo le lezioni di Miguel Barnades junior e lavorando accanto a Cavanilles, Nel 1802 ritornò a Bogotà; Mutis lo inviò a studiare la flora di Cartagena de Indias, quindi a Cuba in una missione tanto scientifica quanto commerciale: doveva infatti vendere la corteccia di china, ma anche raccogliere piante e riportare nella colonia il vaccino contro il vaiolo. Rientrò a Bogotà nell'agosto 1808, appena due settimane prima della morte dello zio. Nel testamento scientifico di quest'ultimo non veniva indicato un direttore della spedizione, ma piuttosto un triumvirato: Rizo avrebbe continuato a dirigere il lavoro dei pittori, Caldas si sarebbe occupato dell'osservatorio e Sinforoso sarebbe stato il direttore scientifico per la botanica, con il risultato che al momento furono tutti scontenti, soprattutto Caldas che si aspettava da Mutis la consacrazione a suo successore. L'incarico venne confermato a Sinforoso dal viceré nel febbraio 1809. Egli si concentrò sul completamento e nella pubblicazione del libro sulle piante di china di suo zio, integrato con le scoperte di altri membri della spedizione, soprattutto Caldas. Giunse a un accordo con quest'ultimo, riconoscendogli la priorità sulla pubblicazione delle piante dell'Ecuador; entrambi contavano di continuare, concludere e pubblicare la Flora di Bogotà. Sinforoso dedicò qualche mese a fare un inventario dei materiali, poi pubblicò sul Semanario una memoria sulla spedizione e diverse nuove piante; nel numero seguente altre furono pubblicate da Caldas, che sigillò la pacificazione con la dedica del genere Consuegria. Si era ormai nel 1810 e anche Sinforoso finì nel vortice della politica. Dopo il 20 luglio, fu nominato deputato del popolo e membro della Giunta suprema e come tale firmò l'Atto di Indipendenza. Nel 1811 fece parte della commissione che redasse la Costituzione della Repubblica di Cundinamarca. Nel 1812 riprese la direzione della spedizione, anche se ormai le ricerche erano bloccate da tempo e il gruppo dei pittori si era dissolto con la partenza di Rizo. Nel novembre del 1814 il governo gli affidò l'inventario della parte botanica della spedizione; grazie a questa fortunata circostanza, in materiali si salvarono dal saccheggio dell'Osservatorio e della Casa della Botanica invasi dai soldati di Bolivar. Nel 1816 anche lui fu accusato di sedizione e incarcerato nel Colegio del Rosario; qui dovette occuparsi di allestire e imballare i materiali della spedizione per l'invio a Madrid, con l'aiuto del pittore Francisco Javier Matís. Il gravoso (e doloroso) compito, insieme al nome di suo zio e alla sua origine spagnola, probabilmente gli salvò la vita: anziché essere condannato a morte come i suoi compagni, gli furono comminati due anni di carcere e l'esilio a Panama. Nel 1817 in seguito a indulto reale, fu confinato a Cartagena. Solo nel 1821 poté tornare a Bogotà con la sua famiglia e fu nominato deputato dell'Assemblea costituente da cui doveva nascere la Repubblica di Colombia. Tuttavia, ormai minato nella salute, morì l'anno dopo a soli 49 anni.  Generi per quattro naturalisti Ad eccezione di Carbonell che come abbiamo visto non era un naturalista, tutti gli altri hanno avuto l'onore di dare il loro nome ad almeno un genere botanico, anche se uno solo è oggi accettato. Si tratta di Lozania che fu pubblicato sul Semanario del Nuevo Reino de Granada da Caldas, rispettando la volontà di Mutis. E' uno dei due generi della piccola famiglia Lacistemataceae (l'altro è appunto Lacistema) e gli sono attribuite cinque specie di piccoli alberi o anche arbusti distribuiti nel Centro America meridionale (dal Nicaragua a Panama), nel sud America tropicale (dal Venezuela alla Bolivia) e nella regione amazzonica occidentale, dove tipicamente crescono nel sottobosco delle foreste umide fino a 2400 m di altitudine. Hanno foglie alternate, da ellittiche a obovate, e infiorescenze terminali raccolte in racemi. I fiori minuscoli (circa un mm) consistono in un disco munito di sepali e di un unico stame che si divide in due antere. Il frutto è una capsula che si apre in tre valve e contiene un singolo seme circondato da un arillo. Come ho anticipato, fu invece Cavanilles a dedicare a Rizo Rizoa (oggi sinonimo di Clinopodium). A Caldas (e la cosa non stupisce, visto che era l'unico ad avere una reputazione internazionale) sono stati dedicati ben tre generi Caldasia, nessuno dei quali è però oggi accettato; in ordine cronologico, il primo giunse già nel 1806 da Willdenow, direttore dell'orto botanico di Berlino, a cui le attività scientifiche del sabio Caldas erano note grazie a Humboldt (oggi è sinonimo di Bomplandia); quindi lo stesso Caldas pubblicò ancora sul suo Semanario l'omonimo genere che gli era stato dedicato da Mutis (oggi sinonimo di Helosis); infine nel 1821 fu la volta dello spagnolo Lagasca, che intese così anche riabilitare la memoria del naturalista fucilato alla schiena come traditore dai suoi compatrioti (oggi sinonimo di Chaerophyllum). Concludiamo la rassegna con un ultimo genere valuto da Mutis e pubblicato da Caldas, Consuegria; non solo non è valido, ma di incerta sede, ovvero non identificato. Quando José Celestino Mutis arriva in Colombia (anzi, nel Nuovo Regno di Granada, come si chiamava all'epoca) è un giovane medico di ventotto anni. In America pensa di fermarsi solo qualche anno, invece vi rimarrà per tutta la vita. E per tutti diventerà "el sabio Mutis", il sapiente Mutis, il primo scienziato del paese, anzi dell'intera America latina. Come matematico e fisico farà conoscere la meccanica newtoniana e si scontrerà con l'inquisizione, ancora rimasta al modello tolemaico; come medico riformerà l'insegnamento di medicina e chirurgia e sosterrà l'inoculazione del vaiolo; come astronomo, fonderà il primo osservatorio d'America; come mineralogista riattiverà miniere che si credevano esaurite; come zoologo, studierà le formiche su suggerimento dell'amico Linneo; come botanico scoprirà che anche in Colombia cresce la Cinchona, e di qualità non inferiore a quella peruviana. Ha trent'anni quando chiede per la prima volta alla corona spagnola di finanziare una spedizione scientifica; ne ha cinquantuno quando finalmente viene posto a capo della Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. La dirige con abilità e competenza, attorniandosi di una intera generazione di giovani naturalisti, raccoglitori, artisti (questi ultimi sotto la sua supervisione elaborano un peculiare stile di illustrazione botanica, passato alla storia come "stile Mutis"). Nonostante viva nella lontana Colombia, il suo nome è ben noto in Europa; corrisponde con diversi colleghi europei, primo fra tutti Linneo; e quando Humboldt e Bompland arrivano in America, non mancano di fargli visita, rimanendo stupefatto da quanto ha già fatto e quanto si propone di fare nonostante l'età avanzata. Mutis era davvero uno studioso senza uguali; e quale genere più adatto a celebrarlo della bellissima Mutisia di cui Linneo diceva "Non ho mai visto una pianta che la superi in singolarità"? 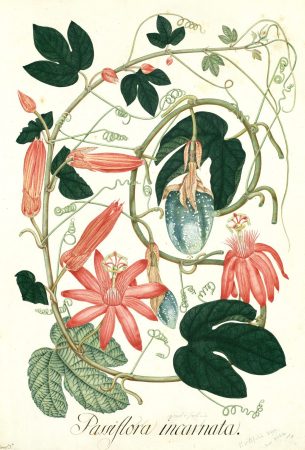 Una lunghissima attesa Nel 1760, al giovane medico originario di Cadice José Celestino Mutis (1732-1808) potrebbe aprirsi una carriera di successo nella capitale, dove si è trasferito nel 1757. Ha brillantemente superato l'esame presso il Protomedicato che abilita alla professione, tanto da essere nominato professore supplente di chirurgia presso l'ospedale maggiore, ed ha un'ottima clientela. Ora il suo protettore, il ministro della Guerra Ricardo Wall, che è anche riuscito a farlo nominare medico da camera del re Ferdinando VI, gli offre una borsa di studio per perfezionarsi a Parigi, Londra o Bologna. Ma a Mutis, grande appassionato di botanica (è allievo di Barnades e frequenta assiduamente l'orto botanico di Migas Calientes) contemporaneamente giunge una proposta molto più allettante: Pedro Messia de la Cerda, appena nominato Viceré della Nuova Granada, gli chiede di accompagnarlo in America, promettendogli di lasciargli tempo e agio per le ricerche naturalistiche. Mutis accetta: riprenderà il percorso interrotto dalla morte di Löfling e, chissà, di lì a qualche anno, tornerà in Spagna come direttore di un Gabinetto di scienze naturali e di un orto botanico indipendente e più scientifico di quello di Migas Calientes, che ancora vede la botanica come ancella della medicina e della farmacia. Dopo una passata a Cadice per salutare parenti e amici (tra cui l'allievo di Linneo Claes Alströmer) il 7 settembre Mutis si imbarca con il viceré e il suo seguito sul vascello La Castilla diretto a Cartagena de Indias, dove giungono il 29 ottobre. Qui e lungo il tragitto che li porterà a Santa Fe de Bogotà, la sede vicereale, affascinato dalla ricchezza e dalla varietà della natura tropicale, incomincia a raccogliere esemplari e ad annotare osservazioni su piante, animali, ambienti e paesaggi, costumi dei nativi, in vista di una Storia naturale dell'America settentrionale spagnola. Purtroppo a Bogotà (dove arriva il 24 febbraio 1761) la realtà si rivela diversa dalle aspettative: come uno dei pochi medici laureati della colonia è indaffaratissimo; inoltre, su sollecitazione di alcuni giovani del seguito vicereale, a partire dal maggio 1762 inaugura la cattedra di matematica superiore al Colegio Mayor del Rosario (cui dal 1764 si aggiungerà l'insegnamento di fisica o filosofia naturale) che introduce in America la meccanica newtoniana e il metodo sperimentale. Per le ricerche sul campo rimane poco, pochissimo tempo. Nel 1763 Mutis si risolve ad inviare al re Carlo III una petizione, in cui sollecita il finanziamento di una spedizione naturalistica «molto utile per la scienza, la corona e i suoi vassalli»; le raccolte dovrebbero andare a costituire un Gabinetto di scienze naturali con orto botanico annesso. L'anno successivo reitera la richiesta, ma senza ottenere risposta. Seguono alcuni anni di incertezza: nel 1766 abbandona la corte vicereale, la carriera di medico e l'insegnamento per trasferirsi a San Antonio del Real de Montuosa Baja dove forma una società per lo sfruttamento di una miniera, sperando di ottenere l'indipendenza economica che gli permetterà di continuare i suoi studi; nel 1770 rientra a Bogotà e riprende a insegnare; nel 1772 prende gli ordini sacerdotali; lo stesso anno scopre che anche in Colombia crescono piante di china; nel 1773 sostiene pubblicamente il sistema copernicano al Collegio del Rosario e l'anno dopo deve difendersi davanti all'Inquisizione; nel 1777 lascia di nuovo Bogotà per una seconda avventura mineraria, alla miniera El Sapo di Inagué, dove fino al 1782 vivrà in solitudine "gli anni più felici della sua vita". Nel frattempo non ha mai smesso di studiare, di raccogliere, di scrivere, di corrispondere con altri studiosi, primo fra tutti Linneo cui invia molti esemplari, ricevendone in cambio un'insolita attestazione di stima e di amicizia. Su suo invito, inizia a studiare le formiche del nuovo mondo, tanto quelle guerriere del genere Eciton quanto le tagliafoglie del genere Atta.  Una spedizione senza uguali A questo fecondo isolamento lo sottrae il nuovo viceré, l'arcivescovo Antonio Caballero y Góngora, che lo conosce in occasione di una visita pastorale. Lo convince a tornare con lui a Bogotà e gli affida la direzione della "Spedizione botanica del Nuovo Regno di Granada", di cui sollecita l'approvazione reale. Che arriverà con decreto del 1 novembre 1783, vent'anni dopo la petizione di Mutis. Quest'ultimo è nominato "Primo Botanico e Astronomo" della Real Expedición Botánica de la América Septentrional, più nota come Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Mutis si mette immediatamente al lavoro e crea una spedizione che si distingue da tutte le altre promosse in quegli anni dalla corona spagnola. Lo scopo è niente meno che redigere un inventario completo delle risorse naturali del Vicereame, non solo per scopi utilitari, ma più largamente scientifici; per farlo si circonda di un'ampia squadra di giovani, in gran parte creoli, molti dei quali sono stati suoi allievi: tra di essi, i botanici Juan Eloy Valenzuela, Sinforoso Mutis (suo nipote), Francisco Antonio Zea, il chimico e zoologo Jorge Tadeo Lozano, il botanico, astronomo e ingegnere militare Francisco José de Caldas. Mutis fissa la sede della spedizione a Mariquita, una località ai piedi delle Ande nel bacino del fiume Magdalena, che aveva visitato durante gli anni "minerari". Raramente raccoglie di persona (ha superato i cinquant'anni), ma coinvolge nelle raccolte decine di raccoglitori provenienti dalle più diverse categorie sociali. Gli esemplari confluiscono alla Casa della Botanica di Mariquita, dove viene creata un orto botanico e un laboratorio di pittura; qui una squadra di giovani di talento viene istruita direttamente da Mutis sulla disposizione degli esemplari e i particolari da ritrarre. Grazie ad allievi e collaboratori, l'area coperta dalla spedizione si allarga ad altre zone: ad esempio, il suo discepolo preferito Francisco José de Caldas tra il 1802 ed il 1805 esplora parte dell'attuale Ecuador, raccogliendo oltre 6000 esemplari e disegnando interessanti mappe con l'indicazione delle fasce di altitudine delle piante. Mentre i pittori creano migliaia di disegni, el sabio Mutis, il "sapiente Mutis", come ormai tutti lo chiamano, è impegnato a scrivere i testi della Flora de Bogotá o del Nuevo Reino de Granada. Dato che ha contratto la malaria, nel 1791 è costretto a trasferire la sede della spedizione a Bogotà; ormai si tratta di una vera e propria istituzione scientifica, con una sede propria (la seconda Casa della botanica), un orto botanico, una biblioteca e attrezzature scientifiche. Qui Mutis e i suoi collaboratori riordinano le collezioni, studiano, scrivono, dipingono. Humboldt e Bompland, che gli fanno visita nel 1801, rimangono stupefatti dall’eccellente organizzazione, dalla quantità di lavoro svolto e progettato da quest'uomo orami in età avanzata, da una biblioteca di forse ottomila volumi, seconda solo a quella di Banks a Londra. E' un centro scientifico polivalente, tanto che tra il 1802 e il 1803 nel suo giardino viene eretto l’Osservatorio, il primo del continente americano; Mutis ne affida la direzione all'allievo Francisco José de Caldas che da parte sua avrebbe preferito occuparsi di botanica. Quando Mutis muore, nel 1808, la sua Flora (un'opera immensa, tanto che l'edizione moderna prevede 55 tomi) non è finita e la stampa non è neppure iniziata. Nel corso degli anni, con la scusa che l'opera non è terminata, egli ha inviato a Madrid solo pochi esemplari a mo' di campione; in realtà è convinto che debbano rimanere in Colombia a disposizione degli studiosi colombiani. Dopo la sua morte la spedizione continuò per qualche tempo sotto la direzione di suo nipote Sinforoso Mutis, finché nel 1810, in seguito alle convulsioni della guerra d'Indipendenza (di cui molti allievi di Mutis furono dirigenti e protagonisti) si interruppe. Nel 1815 le truppe di Bolivar invasero la Casa della Botanica e l’osservatorio, ma i materiali si salvarono fortunosamente; nel 1816, per ordine del generale spagnolo Morillo, che aveva ripreso il controllo della colonia, furono imballati e inviati a Madrid, dove furono divisi tra il Gabinetto di storia naturale (gli animali e i minerali) e il Real Jardín Botánico (i vegetali e i manoscritti), dove rimasero a prendere polvere nei magazzini. Nel suo complesso, in trentacinque anni la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, tra raccoglitori, scienziati, pittori, aveva coinvolto 55 persone, coperto un’estensione di 8000 km² e raccolto 20.000 esemplari botanici e 7000 zoologici. Un lascito importante è costituito dalle illustrazioni botaniche, più di 6600 tavole create da oltre 30 artisti, sotto la supervisione diretta di Mutis, tanto che gli studiosi parlano di «stile Mutis», caratterizzato da uso della tempera anziché dell’acquarello, attenta disposizione del soggetto, combinazione di più esemplari per rappresentare in un’unica tavola tutti gli stadi della vita della pianta, dalla fioritura alla fruttificazione. La spedizione ebbe anche conseguenze politiche: molti degli allievi di Mutis, compreso suo nipote Sinforoso, grazie ad essa presero coscienza della loro identità di americani e si fecero paladini dell’indipendenza; pagarono queste idee con il carcere, l’esilio, Caldas e Lozano, fatti fucilare da Morillo, con la vita. 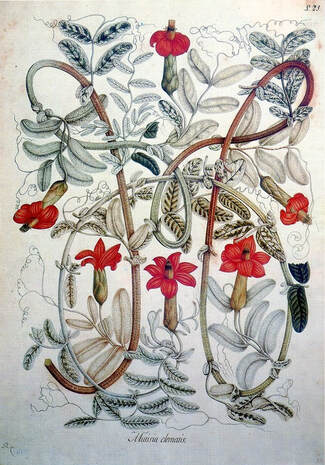 Una pianta singolare Ancora incerto se cambiare mestiere e dedicarsi a tempo pieno all'attività mineraria, nel 1773 José Celestino Mutis inviò in Svezia l'allievo Clemente Ruiz a perfezionarsi nei metodi di estrazione e purificazione dei minerali; ne approfittò per trasmettere a Linneo un ricco erbario e altri oggetti. Conteneva molte meraviglie che entusiasmarono il vecchio botanico, come egli scrive all'amico Mutis in una lettera datata 20 maggio 1774 : "Non ho mai avuto tanto piacere in tutta la mia vita, per tanta ricchezza di piante rare, uccelli e altri oggetti che mi hanno lasciato attonito. Giorno e notte negli ultimi otto giorni l'ho sfogliato e risfogliato e sempre si rinnovava la felicità di incontrare piante mai viste. Chiamerò Mutisia [oggi M. clematis] la numero 21: non ho mai visto una pianta tanto singolare: ha fiori di Singenesia [ovvero di Asteracea], presenta viticci, le foglie sono composte e tomentose, l'aspetto è di clematide; chi ha mai visto una pianta simile in questo ordine naturale? Ti felicito per il tuo nome immortale che il tempo non potrà mai offuscare." Sappiamo che Linneo, nel dedicare un genere a una persona, amava che ne fosse il ritratto vegetale. Qui molto probabilmente nel immortalare il sapiente amico pensava alla sua singolarità, che lo rendeva altrettanto senza pari tra gli studiosi quanto lo era Mutisia tra le piante della sua famiglia. Egli non fece però in tempo a pubblicare il nuovo genere; la sua volontà fu tuttavia rispettata da suo figlio Carl il giovane che lo fece per lui in Supplementum Plantarum, 1781. Mutisia L.f. è oggi un grande genere della famiglia Asteraceae cui sono assegnate oltre 60 specie, con una interessante distribuzione disgiunta: la maggior parte si distribuiscono lunga la catena delle Ande dalla Colombia settentrionale alla Patagonia, mentre un secondo gruppo di quattro specie si trova nella foresta pluviale del Brasile sudorientale (Mata Atlantica) e nelle aree adiacenti di Paraguay, Uruguay e Argentina; vivono in una grande varietà di habitat dal livello del mare a 4000 metri di altitudine. Sono per lo più grandi arbusti, ma anche liane rampicanti, con foglie lineari, oblunghe o pinnate, talvolta con margini dentati, che spesso presentano un viticcio terminale che permette loro di arrampicarsi su arbusti ed alberi. I vistosi capolini solitari sono situati all'apice dei rami, hanno lunghi involucri usualmente verdi, e sono simili a margherite, con fiori del raggio (i "petali" della margherita) molto lunghi e vistosamente colorati: il colore prevalente è l'arancio vivo, ma possono essere anche bianchi, rosa, rossi. In effetti, si nota una differenza di forme e di colori dei fiori in base all'habitat e agli impollinatori: diverse specie delle savane aperte del Cile meridionale o di alta montagna sono arbusti nani con ricettacolo più breve e capolini più corti e piatti bianchi, crema o rosa pallido, impollinati da vari tipi di insetti; le specie con grandi capolini dai colori brillanti della foresta pluviale tanto andina quanto brasiliana sono invece impollinate da colibrì. Ne è un esempio proprio la specie tipo M. clematis, un endemismo delle foreste andine della Colombia tra 2000 e 4000 metri; è una liana provvista di viticci che può raggiungere anche i 10 metri d'altezza; i fiori terminali, larghi anche 10 cm, penduli, sono provvisti di un lungo involucro con quattro-cinque serie di brattee e hanno nove o dieci fiori del raggio arancio o scarlatto brillante, disposti orizzontalmente o con apici lievemente ricurvi. Tipica del cono sur è invece M. decurrens, distribuita in una fascia tra i 500 e i 2000 metri in Cile lungo la cordigliera centro-meridionale e in Argentina nei boschi patagonici; anch'essa è una liana, ha foglie semplici dal bordo dentato e spinoso, e grazie ai viticci si arrampica fino a 4-5 metri, ricoprendo densamente arbusti e piccoli alberi; i fiori terminali e solitari hanno diametro fino a 5 cm con 7-14 flosculi del raggio arancio intenso. Ha distribuzione simile M. spinosa, che si distingue per le foglie con bordi spinosi e i fiori rosa o lilla chiaro. Un esempio delle Mutisiae arbustive è M. acerosa, un arbustino nativo delle steppe alpine aride della sezione centrale della cordigliera, in Cile e in Argentina. Come adattamento all'aridità presenta foglie lineari, rigide, simili a aghi di pino; i fiori simili a margherite rade sono relativamente piccoli, con "petali" (i flosculi ligulati) bianchi e appena toccati di rosa all'esterno. Concludiamo con un raro endemismo della provincia di Loja in Ecuador scoperto da pochi anni: la spettacolare Mutisia magnifica, il cui ambiente naturale è la foresta montana tropicale o subtropicale. Anch'essa può arrampicarsi su altri alberi e si distingue per gli enormi capolini con involucro cilindrico lungo quasi 10 cm, corolla di 12 cm di diametro, fiori del raggio arancio brillante lunghi fino a 6 cm e larghi fino 3, fiori del disco cilindrici con lunghissimi stimmi. Qualche informazione in più e altre specie nella scheda. Per Robert Brown, la partecipazione alla spedizione Flinders segnò l'inizio di una lunga e operosa carriera scientifica. Dopo il viaggio e le raccolte, venne il momento dello studio e delle pubblicazioni, la più ceelebre delle quali è Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van-Diemen che ne fa il padre della botanica australiana. Successivamente bibliotecario e curatore delle collezioni della Linnean Society, ultimo bibliotecario di Banks, curatore delle collezioni banksiane del British Museum, capo del Dipartimento di botanica dello stesso, presidente della Linnean Society, fu una figura di spicco della botanica britannica, anche se il suo carattere schivo e la meticolosa lentezza del suo lavoro tesero a isolarlo dalle nuove generazioni. Di grande importanza i suoi contributi alla tassonomia e gli studi sul polline, il nucleo cellulare, la differenza tra gimnosperme e angiosperme. Mentre studiava il polline al microscopi, le sue osservazioni sconfinarono nella fisica, con la scoperta di quello che più tardi verrà chiamato "moto browniano". A ricordarlo, oltre a diverse località, australiane o meno, e moltissimi eponimi, i generi australiani Brunonia e Brunoniella. 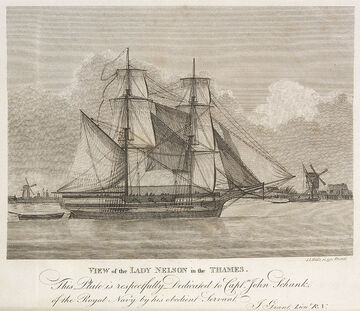 L'ultimo viaggio: Tasmania Quando Robert Brown accettò la proposta di Banks di unirsi alla spedizione Flinders, anche se il suo nome era già piuttosto noto nei circoli botanici britannici, soprattutto come esperto di crittogame (varie felci e muschi da lui raccolti furono pubblicati in Fasciculi plantarum cryptogamaticarum Britanniae da Dickson, con il suo permesso, ma senza citarlo), come aiuto chirurgo di un reggimento di stanza in Irlanda non aveva molte prospettive. La spedizione in Australia fu la grande occasione che attendeva. In tre anni e mezzo, con l'aiuto del giardiniere Good e del pittore Ferdinand Bauer, raccolse più di 3400 esemplari botanici (cui vanno aggiunti animali e minerali), anche se una parte considerevole di queste raccolte andò perduta durante il naufragio del Purpoise, Già prima di quella sventura, lui e Bauer avevano deciso di accettare l'invito del governatore King di continuare ad esplorare la flora della colonia. Per qualche mese, alternò l'esplorazione dei dintorni di Port Jackson con la sistemazione delle proprie raccolte, descrivendo molte piante, momentaneamente classificate secondo il sistema linneano, nel manoscritto intitolato Descriptorium plantarum Novae Hollandiae que in fasciculis parvis Continentur, finché il 28 novembre 1803 si imbarcò sulla Lady Nelson, inviata a Port Phillipp per trasferire in Tasmania i coloni di quell'insediamento che si era rivelato poco propizio. Non appena la nave raggiunse lo stretto di Bass, incontrò un tempo così ostile che fu costretta a rifugiarsi nelle isole del Kent Group, dove rimase bloccata per quasi un mese. Brown approfittò della sosta forzata per esplorare la flora della Deal Island, soprattutto le piante marine. Verso la fine del mese, sopraggiunse la Francis, diretta a Port Dalrymple sulla costa settentrionale della Tasmania. A bordo c'era un gruppo di esploratori incaricati di verificare se la zona era adatta a ospitare la nuova colonia. Poiché la nave era stata alquanto danneggiata dalla tempesta, fu deciso che sarebbe rientrata a Port Jackson per riparazioni, mentre la Lady Nelson l'avrebbe sostituita nella missione, dirigendosi a sua volta a Port Dalrymple, dove gettò l'ancora il giorno di Capodanno 1804. Sino al 18 gennaio, quando salpò per Port Phillipp, vennero esplorate la baia e il corso del fiume Tamar; Brown partecipò a varie spedizioni, ma la stagione già avanzata limitò le sue raccolte. Gli esploratori si trovarono alle prese con un incendio e ci furono anche diversi incontri non molto amichevoli con gruppi di indigeni. Quando infine la Lady Nelson arrivò a Port Phillipp, il governatore Collins aveva già deciso che il nuovo insediamento sarebbe sorto alla foce del fiume Derwent (si tratta dell'odierna Hobart). Così il 30 gennaio la nave ripartì per trasportarvi il primo contingente di coloni. A bordo c'era anche Robert Brown, che nei successivi sei mesi avrebbe esplorato il monte Wellington (che all'epoca era chiamato Table Mountain per la sua somiglianza con la montagna che domina Città del Capo), il fiume che ora porta il suo nome Brown River, la bassa valle del Derwent e l'estuario dell'Huon. Di ritorno a Port Jackson nell'agosto 1804, riprese a visitarne i dintorni, a volte insieme al botanico ufficiale della colonia George Caley, spingendosi a nord fino al fiume Hunter. Il 23 maggio 1805 si imbarcò alla volta dell'Inghilterra sul rabberciato Investigator insieme a Ferdinand Bauer, rientrato dalle isole Norfolk. Portava con se un erbario di 1200 piante, semi, minerali e collezioni zoologiche. 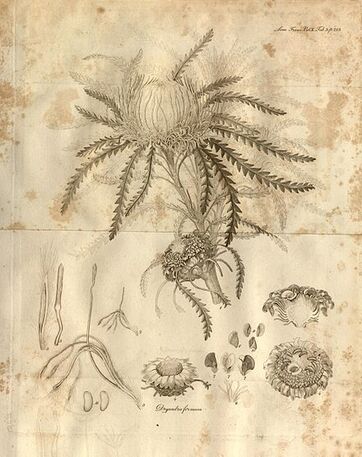 Prime pubblicazioni: uno scandalo e un disastro finanziario Ad ottobre i due amici erano di ritorno in Inghilterra. Per entrambi era giunto il momento di passare per uno dagli schizzi agli acquarelli, per l'altro dalla raccolta allo studio. Il progetto comune era la pubblicazione di una Flora complessiva dell'Australia, con i testi di Brown e le illustrazioni di Bauer. Il botanico poté dedicarsi quasi a tempo pieno al progetto grazie alla Linnean Society, che lo assunse come impiegato e bibliotecario. Era ancora ben lontano dalla meta quando, nel 1808, Dryander (il segretario e bibliotecario di Banks) gli chiese di scrivere una monografia sulle Proteaceae, in modo che egli potesse utilizzare le sue denominazioni nella nuova edizione di Hortus Kewensis che stava allestendo con il capo giardiniere Aiton. Brown accettò, studiando in modo molto accurato non solo le Proteaceae che aveva raccolto personalmente in Australia e in Sud Africa, ma anche le piante vive della collezione del mercante George Hibbert, gli erbari di Banks, Smith, Lambert e altri; poté anche esaminare brevemente le raccolte di Labillardière. Il saggio fu pronto all'inizio del 1809 e Brown lo lesse nel corso di quattro sedute della Linnean Society, tra gennaio e marzo. La pubblicazione però tardò fino al marzo 1810, quando apparve sia nella rivista della società con il titolo On the Proteaceae of Jussieu sia come volume a sé con il titolo On the natural order of plants called Proteaceae. Com'è chiaro da questi titoli, Brown non segue più la classificazione linneana (che già lo aveva lasciato insoddisfatto in Australia, ma che aveva provvisoriamente conservato per comodità) ma quella "naturale" di Antoine Laurent de Jussieu. Egli propone una nuova classificazione della famiglia, servendosi per la prima volta anche dell'analisi del polline; ne discute la distribuzione geografica; stabilisce due sottofamiglie, basandosi sulla contrapposizione tra frutti deiscenti e indeiscenti; descrive 404 specie e 38 generi, 18 dei quali nuovi. Il saggio segnò il riconoscimento scientifico di Brown, ma fu anche seguito da aspre polemiche. Poco dopo le conferenze alla Linnean Society, quindi molti mesi prima della pubblicazione a stampa del saggio di Brown, uscì On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, dopo una breve parte iniziale realmente dedicata alla coltivazione di queste piante firmata da Joseph Knigth, il giardiniere di Hibbert, presentava un'ampia revisione tassonomica della famiglia. Non era firmata ma l'autore fu facilmente identificato in Richard Salisbury che già in Paradisus londinensis (1806) aveva trattato diverse Proteaceae. Egli aveva assistito alle conferenze di Brown e, secondo la ricostruzione corrente, aveva memorizzato il nomi dei suoi nuovi generi; ora ne anticipava la pubblicazione, "rubandoli" al vero autore. Accusato di plagio, fu di fatto ostracizzato dalla botanica britannica. Brown stesso fu profondamente scioccato e scrisse di Salisbury in questi termini: "Non so che cosa pensare di lui tranne che sia un briccone e un pazzo". Nel 1810 Brown finalmente terminò quella che riteneva la prima parte della sua flora australiana; la pubblicò a proprie spese, senza illustrazioni, come Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, vol. 1; la numerazione del testo iniziava a p. 145, perché egli prevedeva una prefazione da aggiungere in ristampa. Le vendite furono così scarse che il botanico ritirò il volume dal commercio e rinunciò a scrivere sia la prefazione sia i volumi successivi. Solo vent'anni dopo sarebbe uscito un supplemento, dedicato alle Proteaceae scoperte nel frattempo. Anche il volume con le illustrazioni di Bauer (1813) fu un fiasco totale. Nonostante il disastro finanziario, il libro di Brown è una pietra miliare della botanica che segna il vero inizio dello studio sistematico della flora australiana, con la pubblicazione di 2040 specie, oltre metà delle quali nuove, e importanti contributi anche metodologici alla sistematica; vengono stabilite nuove famiglie (all'epoca si chiamavano ordini), molte delle quali tuttora accettate, e definiti in modo più preciso i criteri di classificazione delle famiglie stesse, all'epoca ancora piuttosto fluidi, 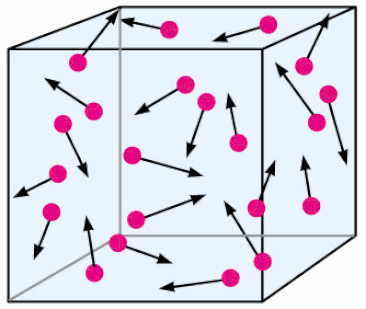 Brown diventa il Giove della botanica Il 1810 segnò per Brown anche un'importante svolta professionale. In seguito alla morte di Dryander, Banks lo assunse come segretario e bibliotecario, con uno stipendio annuo di 200 sterline e l'uso di un alloggio privato a Soho Square. Occuparsi di quella immensa biblioteca e di quel grandioso erbario, garantendone l'accesso ai numerosi visitatori, era tutt'altro che una sinecura. Per Brown, significò anche allargare i suoi interessi a nuove piante e nuove aree geografiche. Ad esempio, nel 1814 in appendice di A voyage to Abyssinia di Henry Salt pubblicò una lista di 146 piante abissine e nel 1818 l'erbario raccolto da Christian Smith in Congo. Nel 1820, alla morte di Banks, Brown ne ereditò la biblioteca e l'erbario con la clausola che, alla sua stessa morte, fossero trasferiti al British Museum. Nel 1827 egli anticipò la volontà del suo benefattore facendone dono al Museo, garantendosene però il controllo come Curatore delle collezioni banksiane; nel 1837, quando il dipartimento di Storia naturale venne diviso in tre sezioni, egli fu nominato primo curatore del dipartimento di botanica, incarico che mantenne fino alla morte. La sua posizione al British Museum ne faceva una delle figure più importanti della botanica britannica e gli permetteva di continuare a fare ciò che più amava: studiare meticolosamente le piante e le loro strutture microscopiche. Non a caso per ben due volte rifiutò una cattedra universitaria: non solo quella di Edimburgo, che implicava l'insegnamento della medicina, ma anche quella di botanica di Glasgow, per la quale caldeggiò la candidatura di William Jackson Hooker. Brown era un grande osservatore, uno sperimentatore metodico e rigoroso, uno scienziato aperto all'innovazione. Queste qualità emergono pienamente dalle sue scoperte degli anni '20 e '30. Nel 1827, in un saggio dedicato al nuovo genere Kingia, fu il primo a riconoscere le differenze fondamentali tra gimnosperme e angiosperme (anche se lui non le chiamava ancora così): mentre le ultime hanno semi racchiusi in un ovario (solitamente il frutto), le prime non hanno né fiori né frutti e i semi si presentano "nudi" e disposti sulle scaglie di un cono o pigna. E' sempre del 1827 la scoperta più celebre al di fuori della botanica. Mentre studiava al microscopio granuli di polline di Clarkia pulchella in sospensione acquosa, egli notò che essi erano in continuo movimento e che tale movimento avveniva in direzioni casuali. Dapprima pensò che i granuli fossero vivi, ma poi ripeté l'esperimento con moltissimi materiali diversi, organici e inorganici, verificando che il movimento avveniva sempre nello stesso modo. Egli non propose una spiegazione del fenomeno, tranne osservare che doveva essere un riflesso della struttura molecolare della materia. La spiegazione di quello che è noto come "moto browniano" arriverà molti anni dopo: nel 1905 da parte di Albert Einstein. Nel 1831, mentre studiava i meccanismi di impollinazione di piante delle famiglie Orchidaceae e Asclepiadeaceae, Brown notò nella cellule delle orchidee la presenza di un struttura che poi osservò anche in altre piante e la denominò "nucleo" della cellula. Il nucleo era già stato osservato in precedenza, forse fin dal Seicento dal microscopista olandese Leeuwnhoek; lo aveva notato e disegnato anche Franz Bauer a partire dal 1802, ma Brown fu il primo a dargli il nome. Sia lui sia Bauer però pensavano che fosse presente solo nelle monocotiledoni. Brown era altamente apprezzato dai suoi contemporanei; Humboldt lo definì "botanicorum facile princeps" e von Martius "Jupiter Botanicus", certo in riferimento anche al suo ruolo di padre padrone del dipartimento di botanica del British Museum. Come figura anche istituzionale, fu membro di molte società scientifiche come la Reale accademia svedese delle Scienza, la Reale accademia olandese delle Scienze e delle Arti, l'Accademia americana delle Arti e delle Scienze. Aveva un particolare legame con la Linnean Society: nel 1822 si era dimesso da impiegato, era stato immediatamente accolto come membro, poi entrò a far parte del Consiglio e nel 1828 fu nominato vicepresidente, presidente dal 1849 al 1853, quindi nuovamente vicepresidente fino alla morte. Brown era innegabilmente un grande scienziato, che qualcuno considera addirittura il maggiore botanico del suo tempo; ma la sua meticolosità e la sua dedizione al lavoro ebbero anche un risvolto negativo. Non amava delegare, con il risultato che molti esemplari raccolti da botanici e viaggiatori delle generazioni successive finivano di attendere il loro turno nei depositi del British Museum, in attesa che potesse occuparsene. Era il caso in particolare delle piante australiane, che egli tendeva a considerare la sua riserva di caccia. Il risultato fu che molte delle sue stesse raccolte rimasero inedite e che la prima opera importante sulla flora australiana dopo il Prodromus, Flora australiensis di George Bentham, iniziò ad uscire solo dopo la sua morte. Quale fosse l'atteggiamento dei naturalisti più giovani verso questo mostro sacro (anche fisicamente: era alto, imponente, severo, di poche parole e di spirito tagliente) ce lo racconta un aneddoto che ha per protagonista Charles Darwin. Nel corso del famoso viaggio attorno al mondo a bordo del Beagle, aveva visitato anche l'Australia e sapeva che il vecchio botanico era ansioso di aver da lui qualche esemplare stuzzicante. Ma lui, convinto che sarebbero finiti a prendere polvere nei magazzini del British, non aveva nessuna intenzione di accontentarlo. Così, quando alla fine lo incontrò, lo distrasse regalandogli un po' di legno fossile (i fossili erano una passione comune). In una lettera commentò: "Credo che il mio legno silicizzato abbia disselciato il cuore di Mr. Brown". 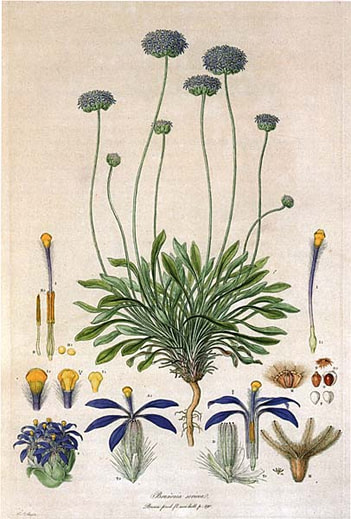 Omaggi floreali e no Robert Brown morì ottantacinquenne nel 1858 nell'alloggio di Soho Square dove abitava dal 1810. A ricordarlo vi è stata posta una targa, ma i luoghi a lui legati sono molti altri: nell'Australia meridionale il monte Brown che scalò durante la spedizione Flinders e oggi ospita un parco nazionale a lui dedicato e in Tasmania il fiume Brown; non mancano località che mai visitò, come il Capo Brown in Groenlandia, così denominato in suo onore da William Scoresby, o il monte Brown in Canada, omaggio di David Douglas, Le piante con eponimo brownii o brownianus si contano a centinaia; ci sono poi due generi, ovviamente australiani. A dedicargli il primo fu James Edward Smith che lo chiamò Brunonia; scopriamo perché grazie alle frasi iniziali del suo An Account of a new Genus of New Holland Plants named Brunonia, letto durante la seduta del 6 febbraio 1810 della Linnean Society, di cui Smith era fondatore e presidente: "Per la conoscenza della pianta che mi accingo a presentare, sono obbligato a Mr. Brown, bibliotecario della Società, che la scoprì nel corso delle sue ricerche botaniche in Nuova Olanda. Una parte assai interessante della sua ricca messe in quel paese occupa un'ampia porzione di questo volume delle nostre Transactions. Con una simile prova del suo genio e della sua abilità davanti ai nostri occhi, qualsiasi testimonianza in tal senso da parte mia sarebbe superflua, ma sono ansioso di cogliere l'opportunità, che egli ha accettato dietro mia ardente sollecitazione, di rendere giustizia ai suoi meriti dedicandogli questo genere nuovo e molto particolare. Poiché esiste già un genere Brownea in memoria dello studioso della storia naturale della Giamaica [Patrick Browne], per evitare ogni ambiguità e mantenere la massima somiglianza possibile con il suo nome, sono obbligato a ricorrere all'espediente, non eccezionale e autorizzato da precedenti, di chiamare il mio genere Brunonia". L'espediente usato da Smith consiste nell'usare l'equivalente latino di Brown, Bruno (gen, Brunonis). Qualche mese più tardi, Brown usò i nomi di Smith nel Prodromus; poiché la conferenza di Smith venne pubblicata solo nel 1811, la priorità di pubblicazione del genere spetta a lui stesso, e non a Smith. In tal modo involontariamente Brown ha violato un tabù della terminologia botanica, dedicando un genere a se stesso. Brunonia R.Br. (oppure Brunonia Smith ex R.Br.) è un genere curioso al di là di questo aneddoto. Smith lo aveva scelto perché costituiva un vero enigma tassonomico. Sembrava infatti in relazione con molte famiglie naturali, ma era difficile attribuirla con certezza all'una piuttosto che all'altra. L'incertezza non si è sciolta con il passare del tempo. In passato è stato attribuito a una famiglia propria, Brunoniaceae, ma a partire dal 2003 è stato trasferito nelle Goodeniaceae, dalle quali per altro differisce perché è l'unico con fiori a simmetria radiale, ovario supero e semi privi di endosperma. Oggi gli è attribuita un'unica specie, B. australis, un'erbacea annuale o perenne con foglie riunite in una rosetta basale, da cui emergono esili scapi che portano alla sommità una densa infiorescenza a capolino di numerosi piccoli fiori blu cielo o più raramente malva. Piuttosto diffusa, è presente in tutto il paese; predilige suoli sabbiosi o rocciosi e ambienti aridi e aperti, ma non ne è esclusiva. Si trova infatti anche in boscaglie e foreste aperte. Le infiorescenze ricordano quelle delle Scabiosa o della Knautia, da cui il nome comune blue pincushion. Un secondo omaggio è arrivato in tempi molto più recenti. Nel 1964 l'olandese Bremekamp decise di creare un nuovo genere per accogliere le specie australiane del genere soppresso Aporuellia (famiglia Acanthaceae). Poiché tre di queste specie erano state raccolte e descritte per la prima volte da Robert Brown (che le aveva assegnate al genere Ruellia) lo chiamò Brunoniella in suo onore. Comprende sei specie, cinque endemiche dell'Australia e una della Nuova Caledonia. Sono perenni tuberose, prostrate o erette, quasi tutte nane, con rami spesso scanalati longitudinalmente o appiattiti, foglie in coppie opposte ai nodi e fiori con corolla imbutiforme solitari o raccolti in spighe lasche. L'ambiente tipico è il sottobosco delle boscaglie e delle foreste umide dell'Australia settentrionale o nord-orientale. Anche se esistono anche altri colori, anche per questo genere il colore dominante dei fiori è l'azzurro, I fratelli Franz e Ferdinand Bauer furono forse i più grandi pittori botanici della prima metà dell'Ottocento. Il loro destino fu allo stesso tempo parallelo e divergente. Divisi da appena due anni d'età, furono educati alla pittura e alla botanica dallo stesso maestro e per qualche anno lavorarono fianco a fianco alla stessa opera, poi, dopo un passaggio a Vienna, entrambi si trasferirono in Inghilterra. Ma a questo punto i loro destini avevano già preso una piega diversa. Franz, il sedentario, divenne il primo pittore ufficiale dei Kew Gardens, dove andò anche ad abitare; mutò il suo nome in Francis e non si mosse più dall'Inghilterra; si specializzò nel dipingere i più minuti particolari delle piante osservati al microscopio, fornendo un inestimabile aiuto ai botanici di Kew. Socievole e ben inserito nella società scientifica, ottenne riconoscimenti come l'ammissione alla Royal Society. Ferdinand, il viaggiatore, accompagnò Sibthorp in Grecia e in Asia minore, quindi si unì alla spedizione Flinders; non solo pittore, ma anche appassionato raccoglitore di piante, dopo lo scioglimento della spedizione rimase in Australia, continuando le raccolte sia con Robert Brown, sia da solo. Disegnò moltissimo e perfezionò un codice numerico dei colori per cogliere le mille sfumature della natura australiana. Di ritorno in Inghilterra, quei numeri permettevano di trasformare gli schizzi in acquarelli di stupefacente precisione e verità. Era un lavoro quasi maniacale che lo assorbiva totalmente, ma nel suo perfezionismo destinato al fallimento commerciale. Negli ultimi anni della sua vita, preferì tornare in Austria dove divise il suo tempo tra la pittura e le escursioni alla ricerca di piante alpine. Nonostante con lui l'arte dell'illustrazione botanica abbia raggiunto il vertice, dopo la sua morte fu presto dimenticato. A ricordare i due fratelli, così simili e così diversi, provvede il bel genere australiano Bauera, voluto da Banks che li stimava in egual modo e in un certo senso fu lo sponsor di entrambi. 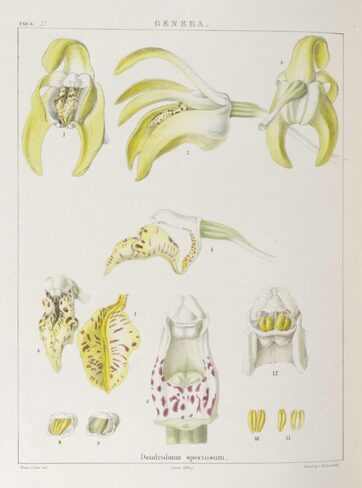 Diagnosi al microscopio Abbiamo già incontrato il pittore Ferdinand Bauer (1760-1826) come validissimo membro dell'équipe scientifica dell'Investigator. Per conoscerlo meglio dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e spostarci nella Bassa Austria, nella cittadina di Feldsberg (oggi Valtice, nella Repubblica ceca), uno dei feudi del principe di Liechtenstein. Ferdinand era il più giovane dei figli del pittore di corte Lucas che morì quando egli non aveva ancora due anni. C'erano altri due fratelli: Joseph Anton, di sei anni, e Franz Andreas (1758-1840), di quattro. La madre Theresia li fece educare alla pittura, quindi li affidò a padre Boccius, il priore del convento dei Fratelli della misericordia, che era anche un medico e un reputato botanico. Mentre il fratello maggiore, raggiunta l'età adulta, divenne a sua volta pittore di corte dei Lichtenstein, i due minori ancora adolescenti sotto la guida di Boccius iniziarono a lavorare al grandioso Codice Liechtenstein; in quattordici volumi, richiese vent'anni di lavoro e comprende oltre 3100 acquarelli botanici, metà dei quali furono dipinti da Franz e Ferdinand Bauer. Padre Boccius insegnò ai due ragazzi che il segreto dell'arte botanica sta nell'osservare i soggetti nei minimi dettagli, per poi ritrarli con precisione, verità e grazia. Grazie a questo apprendistato i due giovani appresero alla perfezione le tecniche del disegno e del colore, tanto da attirare l'attenzione di Nikolaus von Jacquin, il direttore dell'orto botanico dell'Università di Vienna, egli stesso un ottimo disegnatore, che impiegò prima Ferdinand poi anche Franz per i disegni di Icones plantarum rariorum (1781-1793). Da lui i due fratelli appresero la classificazione linneana e l'uso del microscopio. Ferdinand prese anche lezioni dal celebre pittore paesaggista Johann Christian Brand. Ben presto però von Jacquin perse i due migliori illustratori della sua scuderia. Il primo a partire fu Ferdinand nel 1786 (ma su di lui torneremo più avanti). Nel 1788 partì anche Franz, come accompagnatore del neo laureato Joseph Franz von Jacquin nel suo grand tour attraverso l'Europa. A Londra il giovane von Jacquin presentò Bauer a Joseph Banks, che, ammirato dalla sua maestria, riuscì a farlo assumere come primo pittore ufficiale dei Kew Gardens con un salario annuo di 300 sterline. Il pittore austriaco inglesizzò il suo nome in Francis, si stabilì a Kew, mantenendo quell'incarico fino alla morte, per oltre quarant'anni. Assai apprezzato da Giorgio III, fu insignito del titolo di "pittore botanico di sua maestà" e incaricato di impartire lezioni di pittura alla regina Carlotta e alle sue figlie, la più talentuosa delle quali era la principessa Elizabeth. Nel corso della sua lunga attività ai Kew Gardens, il maggiore dei Bauer ebbe modo di disegnare e dipingere centinaia di piante giunte da tutto il mondo; anche se amava dipingerle anche a figura intera, raggiunse una perfezione senza rivali nel ritrarre i particolari più minuti osservati al microscopio, uno strumento diagnostico senza pari per i molti botanici con i quali collaborò. Tra le opere che illustrò, in ordine cronologico, possiamo citare il catalogo del giardino Hortus Kewensis (con testi di Dryander e Aiton, 1789); il florilegio Delineations of Exotick Plants cultivated in the Royal Garden at Kew (1791-1801), con molte delle piante portate dal Sudafrica da Masson; Strelitzia depicta, ordinatogli da Banks (1818); The genus and species of orchidaceous plants di Lindley (1830-1838), forse il suo capolavoro assoluto (le orchidee erano senza dubbio il gruppo di piante preferite sia del botanico sia del pittore); Genera filicum di William Jackson Hooker (1842), al quale impartì anche lezioni di disegno. Socievole e ben inserito nell'ambiente scientifico, Franz Bauer divenne membro della Royal Society e alla sua morte fu sepolto nella cappella di St. Anne a Kew. Di lui possediamo anche un ritratto, che ci restituisce il volto di un uomo aperto e simpatico.  Dipingere con i numeri Neanche uno schizzo ci ha invece tramandato i tratti di Ferdinand, il fratello viaggiatore. Nel 1786 (all'epoca egli aveva ventisei anni ed era un pittore botanico professionista da almeno dieci) incontrò il suo coetaneo John Sibthorp, professore di botanica di Oxford, venuto a Vienna per esaminare uno dei più preziosi manoscritti della biblioteca imperiale, ovvero il celebre codice di De materia medica noto come "Dioscoride di Vienna". Sibthorp ne fu così affascinato da decidere immediatamente di mettersi in viaggio alla volta della Grecia e dell'Asia Minore per cercare di identificare in loco le piante descritte dal medico greco. Su suggerimento di Boccius e von Jacquin propose a Bauer di accompagnarlo come "suo disegnatore". Il pittore accettò e a marzo i due partirono per Napoli, dove si imbarcarono per Creta, con uno scalo a Milo. Dopo aver toccato diverse isole egee, visitarono Atene, quindi passarono a Smirne; trascorsero l'inverno a Costantinopoli, dove furono raggiunti dal cognato di Sibthorp, John Hawkins, con il quale nella primavera esplorarono Cipro e altre isole dell'Egeo. La minaccia di una guerra con la Russia e lo scoppio di un'epidemia li dissuase dall'esplorare la Grecia continentale; poterono però visitare una seconda volta Atene, poi l'Eubea, Delfi (con una scalata che mise a dura prova la loro resistenza), il Monte Athos, Tessalonica, Corinto, Patrasso; qui a settembre si imbarcarono per l'Inghilterra, dove giunsero a dicembre. Sia Sibthorp sia Bauer erano lavoratori ossessivi, e impressero alle loro ricerche un ritmo forsennato. Di solito il mattino era dedicato alle raccolte, con il professore che interrogava le persone del posto per cercare di identificare le piante di Dioscoride, il pomeriggio riservato al lavoro sugli esemplari. Dovendo fissare sulla carta una grande quantità di piante (ma anche animali e paesaggi), Bauer perfezionò un sistema che aveva già sperimentato con suo fratello a Feldsberg, quando disegnavano dal vero le piante locali: le forme del soggetto venivano fissate in un rapido schizzo a matita, mentre i colori delle varie pari venivano tradotti in un apposito codice numerico. Il codice che i due fratelli usavano da ragazzi comprendeva circa 140 sfumature; mentre Franz, che poteva lavorare con comodo ai Kew Gardens, lo abbandonò, Ferdinand, che doveva spostarsi in fretta da un luogo all'altro, spesso in condizioni difficili, senza avere a disposizione materiale da pittura adeguato, lo perfezionò, portando i colori usati in Grecia a 273. Va anche aggiunto che doveva occuparsi della preparazione degli esemplari (purtroppo, il professore tendeva a considerarlo più un servitore che un suo pari) e partecipava in prima persona alla raccolta; ad esempio, gli è attribuita la scoperta di Veronica glauca e Salvia candidissima subsp. candidissima. Nel corso dei diciotto mesi del viaggio, il pittore creò oltre mille schizzi di piante, e diverse centinaia di animali e paesaggi. Giunto in Inghilterra, ebbe il piacere di trovarvi il fratello; decise così di rimanere e seguì Sibthorp a Oxford, dove (in parte basandosi sugli esemplari d'erbario, in parte sfruttando la sua incredibile memoria visiva e la sua raffinatissima sensibilità al colore) iniziò a trasformare gli schizzi in spettacolari acquarelli da cui ricavare le incisioni per il grande libro sulla flora greca progettato di Sibthorp, che vi investì tutta la sua fortuna: ognuno gli costava più di un giorno di lavoro, e ne produsse 966. Per completare l'opera con le piante delle zone che non avevano potuto visitare, nel 1794 Sibthorp partì per un secondo viaggio in Grecia. Bauer si rifiutò di accompagnarlo; non si sarebbero più incontrarti: infatti il professore si ammalò di tisi e morì sulla via del ritorno nel 1796, lasciando le sue proprietà all'università di Oxford con il vincolo di pubblicare Flora Graeca. Gli esecutori testamentari e James Edward Smith, cui era stata affidata la redazione dei testi, si trovarono di fronte a materiali così caotici che l'opera richiese decenni per essere completata: il primo volume uscì nel 1806, il decimo e ultimo nel 1840. Ma intanto per Bauer era ormai iniziata un'altra avventura. Dopo la morte di Sibthorp, aveva collaborato con altri botanici, in particolare con Lambert, che gli commissionò il grosso delle illustrazioni di A description of the genus Pinus (il primo volume sarebbe uscito nel 1803, quando Bauer si trovava già in Australia); Ferdinand ne preparò 61, mentre suo fratello Francis 5. Come abbiamo già visto nei precedenti post, nel 1801 su suggerimento di Banks divenne il pittore naturalista della spedizione Flinders, affiancando Brown anche nella raccolta degli esemplari. Con i suoi 41 anni, era il decano della spedizione (sia Flinders sia Brown ne avevano ventisette, l'altro pittore Westall appena diciannove); nutrita dalla medesima passione e competenza, nonché dalla stima reciproca, la collaborazione tra botanico e pittore fu perfetta, e continuò quando nell'agosto 1803 i due decisero di comune accordo di rimanere in Australia per continuare le ricerche. A quella data Bauer aveva già realizzato 1000 disegni di piante e 200 di animali, e ulteriormente perfezionato il suo codice dei colori, che adesso aveva quattro cifre, ovvero comprendeva circa 1000 diverse sfumature. Per qualche mese, i due raccolsero insieme nei dintorni di Port Jackson, finché nel novembre 1803 Brown partì per la Tasmania; qualche tempo dopo, Bauer ebbe l'opportunità di visitare le isole Norfolk, dove rimase otto mesi, creando un erbario di non meno di 152 specie; raccolse anche animali, soprattutto uccelli, e ritrasse 70 specie di piante e 40 di animali. Di questi materiali si servì Endlicher per il suo Prodromus florae norfolkicae, 1831. All'inizio del 1805 gli amici si ricongiunsero a Port Jackson, in tempo per imbarcarsi sul restaurato Investigator, che a maggio salpò alla volta dell'Inghilterra con il prezioso carico delle loro raccolte e disegni. Questi ultimi ormai superavano i 2000. Il viaggio fu tempestoso, ma senza gravi incidenti e li riportò sani e salvi a Liverpool. Forse i due si aspettavano una calorosa accoglienza, ma il loro arrivo coincise con i festeggiamenti per la vittoria di Trafalgar (21 ottobre 1805) e passò quasi inosservato. Da quel momento avrebbero lavorato fianco a fianco per quasi dieci anni, uno a descrivere piante e animali, l'altro a dipingerli. Era diventato ancora più minuzioso e perfezionista: ora, per completare una tavola, poteva servirgli anche una settimana. Tanto più che Brown l'aveva iniziato all'arte della dissezione degli esemplari, e quindi c'erano da dipingere anche i particolari più minuti. Purtroppo il loro principale sponsor, ovvero Joseph Banks, per quanto ricco, non lo era abbastanza da sobbarcarsi l'impresa di pubblicare la loro costosissima opera. Brown si rassegnò a pubblicare il suo Prodromus floræ Novæ Hollandiæ et Insulæ Van-Diemen senza figure, ma l'opera fu un tale fiasco che ne vendette solo venticinque copie. Ancora peggio andò a Bauer: era così perfezionista che, dopo aver cercato inutilmente di trovare un incisore e un pittore per dipingere a mano le tavole stampate, non ne trovò nessuno secondo lui all'altezza, e si rassegnò a fare da sé. Riuscì a produrre solo tre fascicoli di Illustrationes Florae Novae Hollandiae (1806-1813), che vendettero anche meno. Fu una delusione tale per Bauer che decise di lasciare l'Inghilterra e di tornare in Austria. Grazie ai buoni emolumenti ottenuti dall'ammiragliato, poté acquistare una piccola casa nel sobborgo viennese di Hitzing e qui visse fino alla morte, a parte un breve viaggio a Londra nel 1819 per salutare il fratello. I suoi "clienti" però rimasero soprattutto inglesi: mentre i volumi dell'immensa Flora Graeca continuavano ad uscire, con le illustrazioni che aveva dipinto negli anni di Oxford, illustrò il secondo volume di A Description of the Genus Pinus (1824) di Lambert, Digitalium Monographia di Lindley (1821) e collaborò anche con Endlicher per Iconographia Generum Plantarum (Vienna, 1833). La maggior parte dei suoi disegni e dei suoi acquarelli rimase però inedita, e oggi è conservata in parte al British Museum of Natural History di Londra, in parte al Naturhistorische Hofmuseum di Vienna, in parte all'università di Göttingen. Negli ultimi anni della sua vita (morì sessantaseienne nel 1826) non dimenticò la passione per la botanica, alternando alla pittura le escursioni sulle Alpi. Purtroppo i suoi disegni sulla flora alpina sono tra quelli rimasti inediti.  Il genere Bauera Su suggerimento di Joseph Banks, nel 1801 Andrews creò il genere Bauera per omaggiare i fratelli Bauer, Franz già celebre e noto al pubblico inglese per le sue immagini di piante sudafricane, Ferdinand quasi sconosciuto visto che nessuna della sue opere era già stata pubblicata. Si tratta di un piccolo genere endemico dell'Australia (famiglia Cunoniaceae) che comprende tre specie di arbusti da prostrati a eretti, con foglie trifogliate disposte in coppie opposte e fiori da bianchi a rosa a coppa che ricordano quelli delle rose canine, da cui il nome comune Dog Rose. La più nota è B. rubioides, endemica dell'Australia orientale, diffusa nelle aree costiere dal Queensland sudorientale alla Tasmania, per lo più in zone umide e ombrose. Forma fitti cespugli tappezzanti ed è molto apprezzata come pianta da giardino. B. capitata è invece diffusa nelle zone costiere dal Queensland sud-orientale a Port Hacking nel Nuovo Galles del Sud, mentre B. sessiliflora è endemica della regione dei Grampiani del Victoria. Sir Joseph Banks, grande patron della spedizione Flinders, ebbe cura di raccomandare al capitano di offrire ai "gentiluomini scienziati" molte opportunità di scendere a terra per esplorare le risorse naturali. Come botanico e direttore in pectore dei Kew Gardens, contava anche di arricchire i giardini reali di nuove specie; così, accanto al già affermato pittore botanico Ferdinand Bauer e al promettente botanico Robert Brown, a bordo dell'Investigator c'era anche l'eccellente giardiniere Peter Good, che aveva già dimostrato di sapersi prendere cura delle piante vive in lunghi viaggi oceanici. I tre formarono una formidabile squadra di raccoglitori, con all'attivo circa 2000 esemplari. Purtroppo Good fu una delle vittime della dissenteria che imperversò a bordo dopo lo scalo a Timor e molte delle sue raccolte andarono perdute in seguito al naufragio del Purpoise; tuttavia era riuscito a fare arrivare a Kew tanti semi da permettere a Aiton di elencare più di cento "australiane" nel catalogo dei giardini reali; belle e rare, spinsero Salisbury a rendere un commosso omaggio a Good con la dedica del genere Goodia. 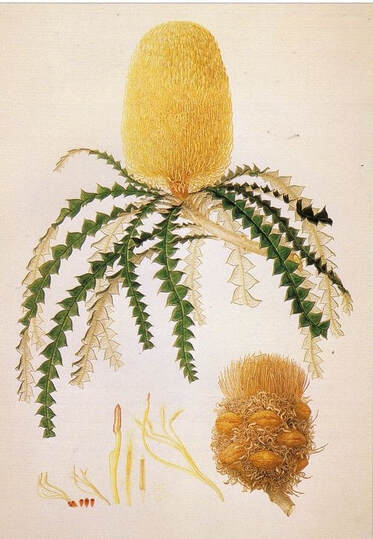 Una piccola squadra di scienziati Rispetto al dispiegamento di ben ventidue tra scienziati ed artisti della spedizione Baudin, lo staff scientifico dell'Investigator appariva modesto: in tutto sei uomini, ovvero l'astronomo John Crosley, il naturalista Robert Brown, il mineralogista John Allen, il giardiniere Peter Good e i pittori Ferdinand Bauer e William Westall. Se consideriamo che Crosley, Brown, Bauer e Westall erano accompagnati da un servitore ciascuno, l'équipe sale a dieci persone in tutto, che però presto si ridussero a otto. Infatti l'astronomo soffrì talmente il mal di mare che a Città del Capo fu lasciato a terra. Assistente all'Osservatorio di Greenwich, assegnato all'Ufficio della longitudine, aveva partecipato come osservatore alla spedizione Vancouver; in Sudafrica fece alcune osservazioni sulle coordinate, quindi, ritornato a Londra, divenne assistente dell'astronomo reale a Greenwich e si segnalò come eminente matematico, divenendo anche presidente della Spitalfields Mathematical Society. Tutti gli altri erano legati in un modo o nell'altro a Banks, che li aveva scelti personalmente. Da tempo il gentiluomo, che come primo investigatore della flora australiana e ideatore del progetto di trasformare il Nuovo Galles del Sud in una colonia penale, se ne considerava il patrono, pensava a una spedizione all'interno del paese. Contava di affidarla a Mungo Park, che alla fine del 1797 era rientrato dall'Africa coronato di gloria per aver scoperto la sorgente del Niger. Due fatti lo costrinsero a ripensarci: il governatore Hunter gli scrisse per sconsigliare una spedizione terrestre, per la quale la giovane colonia non aveva né gli uomini né le strutture; inoltre Park si scontrò con l'ammiragliato circa la sua paga e decise di sposarsi; poco dopo, come abbiamo visto qui, Flinders suggerì il progetto alternativo della circumnavigazione della Terra australis e Banks lo fece proprio con entusiasmo. Insistette però che a bordo dell'Investigator ci fosse uno staff scientifico e che durante la navigazione fossero previste soste sufficienti per esplorare le risorse naturali. A stargli particolarmente a cuore era ovviamente la flora, e non a caso come naturalista scelse un promettente botanico, il medico scozzese Robert Brown (1773-1858); dopo essersi laureato ad Edimburgo, Brown si era arruolato nell'esercito e da cinque anni serviva come medico militare in Irlanda. Meticoloso e interessato a tutte le scienze, era però affascinato soprattutto dalla botanica, in particolare delle crittogame. Aveva iniziato a corrispondere con eminenti botanici tra cui William Withring, James Edward Smith, James Dickson e José Correia da Serra. Nel 1798, quando Park rinunciò, fu proprio quest'ultimo a suggerire Brown come sostituto "In questo cambio, a guadagnarci sarà la scienza; Mr. Brown è un naturalista di professione; inoltre è scozzese, adatto a perseguire uno scopo con costanza e mente fredda". Brown (che nel frattempo era anche entrato a far parte della Linnean Society) era dunque il candidato ideale come naturalista della spedizione Flinders. Nel dicembre 1800 Banks gli scrisse per proporgli il posto; il dottore accettò e venne a Londra, dove trascorse i mesi che precedettero la partenza a leggere tutti i libri sull'argomento, a studiare le piante australiane di Banks e a scegliere con Dryander (il segretario di Banks) i doppioni da riunire in un erbario da portare con sé a bordo dell'Investigator. Anche Bauer, oltre ad essere uno dei più raffinati pittori botanici del suo tempo, poteva essere considerato un naturalista a tutti gli effetti: austriaco, era stato introdotto alla tassonomia linneana e all'uso del microscopio da von Jacquin, quindi tra il 1786 e il 1787 aveva accompagnato in Grecia il professore di Oxford John Sibthorp; il risultato fu la spettacolare Flora Graeca. A confronto, il pittore paesaggista William Westall (1781-1850) era una seconda, anzi una terza scelta. Inizialmente Banks aveva offerto il posto all'affermato paesaggista Ibbeston; al suo rifiuto, si era rivolto William Daniell, che aveva già molto viaggiato ed era specializzato in soggetti marini; questi dapprima aveva accettato, poi si era tirato indietro e forse su suo suggerimento fu rimpiazzato dal giovanissimo Westall, appena diciannovenne al momento della partenza. Allen era invece arrivato all'ultimo momento; Banks non aveva pensato a un mineralogista, finché a sottolineare la necessità di raccogliere campioni di rocce e minerali fu Flinders; sir Joseph allora scrisse a suo zio, William Milnes, che amministrava la sua tenuta di Overton, il quale scelse un giovane minatore, eccezionalmente istruito, appunto John Allen, forse all'epoca venticinquenne. Pagato meno dei suoi compagni e non considerato uno scienziato a tutti gli effetti, era un po' il parente povero del gruppo, tanto più che i minerali non interessavano per nulla a Banks e poco a Brown, nominato capo dell'intera équipe, che in una lettera a sir Joseph ebbe a scrivere sprezzantemente "sinceramente, è di ben poca utilità". Pensava tutto il contrario dell'ultimo membro della squadra, il giardiniere Peter Good (non ne conosciamo né la data di nascita né l'età), voluto da Banks con l'obiettivo dichiarato di arricchire i giardini reali di specie nuove e rare. Good era uno dei caposquadra di Kew ed era stato suggerito a Banks dal giardiniere capo William Aiton per la sua esperienza in viaggi oceanici: aveva infatti portato con successo a Calcutta una selezione di piante coltivate a Kew e nel viaggio di ritorno ne aveva riportato piante indiane preparate dal botanico Christopher Smith. Good e Allen condividevano la stessa cabina e secondo il loro contratto, a differenza degli altri, avrebbero dovuto mangiare con i sottoufficiali tecnici; ma, dato che sull'Investigator non ce n'erano, condividevano anche loro la tavola del comandante con i "gentiluomini scienziati".  Formidabili raccolte L'Investigator salpò da Spithead il 18 luglio 1801. A bordo c'erano anche casse di semi e una serra portatile con piante in vaso da consegnare a Port Jackson. Lungo la rotta per città del Capo l'unico scalo fu quello di Madera: il 2 agosto Flinders, Brown e Bauer scesero a terra sull'isola di Bugio nelle Ilhas Desertas, dove Brown osservò la natura porosa delle rocce e la luminescenza delle meduse; quindi il giorno dopo l'Investigator gettò l'ancora nel porto di Funchal, dove si sarebbe trattenuta fino al 7 agosto. Brown, Bauer, Allen e Good ne approfittarono per esplorare le vicinanze della capitale, erborizzare e scalare la maggiore montagna dell'isola, il Pico Ruivo. Brown era deluso di non aver trovato piante diverse da quelle raccolte da Banks durante lo scalo a Madera del primo viaggio di Cook, ma redasse scrupolosamente una lista della flora locale. Durante il viaggio, che proseguì tranquillo fino a Città del Capo, raggiunta il 16 ottobre, Brown si tenne occupato studiando i libri della biblioteca di bordo sulla Nuova Olanda e insegnando a Good il francese, in previsione di un incontro con gli uomini di Baudin. Fin dal 17 ottobre, Brown, Allen e Good scesero a terra; stupefatti dalla bellezza e varietà della flora del Capo, raccolsero insetti, minerali e una grande quantità di piante. Brown passò diverso tempo nella sua cabina a classificarle, mentre Good continuava le raccolte. I naturalisti trovarono anche modo di esplorare le montagne più vicine alla città, Table Mountain e Devil's Mountain, nonostante la scalata fosse resa difficile dal fango e dalla nebbia. La preparazione e la classificazione delle numerose piante raccolte da lui stesso e da Good fu la principale occupazione di Brown durante la traversata dell'Oceano Indiano. C'erano anche due nuove specie di Proteaceae, Serruria fascicularis e S. foeniculacea. Lasciata False Bay il 4 novembre, l'Investigator avvistò la costa della Nuova Olanda all'altezza del Capo Leeuwin il 6 dicembre. Flinders iniziò immediatamente la ricognizione idrografica, concentrando la sua attenzione sul King George Sound, dove la nave rimase all'ancora presso la Seal Island dall'8 dicembre al 5 gennaio 1802. La lunga sosta e la stagione non troppo avanzata permisero a Brown e Good di raccogliere il più cospicuo bottino dell'intera spedizione: circa 500 esemplari di piante, 175 di semi, mentre Bauer poté completare una cinquantina di disegni. Tra gli altri, Brown scoprì otto nove specie di Banksia. Botanico e giardiniere lavoravano in piena armonia; quando il primo si tratteneva a bordo per classificare gli esemplari, il secondo continuava le ricerche e andava a caccia di semi, dimostrando un ammirevole senso del dovere; anche Bauer (e talvolta Allen e Westall) contribuiva alle raccolte. Il 6 gennaio il viaggio riprese in direzione est; le frequenti soste per esplorare baie, isole e isolotti offrirono altre opportunità di raccolta ai naturalisti. La prima si presentò il 10 gennaio, quando essi poterono scendere a terra nei pressi dell'attuale Cape le Grand, dove trovarono una nuova specie di Cycadacea (Macrozamia riedlei), la raccolta dei cui semi diede parecchio filo da torcere a Good. L'11 gennaio l'Investigator gettò l'ancora a Lucky Bay, dove rimase per quattro giorni. Brown, Bauer e Good ne approfittarono per penetrare nell'interno fino a scalare il Frenchman Peak, una cupola granitica posta a circa 6 km dalla baia, che ospita anche una grotta, e ne ritornarono con circa 150 esemplari di piante diverse, tra cui Verticordia brownii. Il resto del mese di gennaio fu trascorso ad esplorare le isole dell'Arcipelago della Recherche, con ancoraggi a Middle e Goose Island. Ora la stagione era più avanzata, le temperature diurne potevano superare i 35° e spesso soffiavano forti venti; la vegetazione era inaridita e le raccolte botaniche si fecero molto più sporadiche. Il 17 gennaio entrarono nella Grande Baia australiana, caratterizzata da alte falesie, dove fu impossibile trovare un ancoraggio fino a Fowlers Bay (19 gennaio); Brown scese a terra, ma poté osservare ben poche piante, soprattutto specie alofile come Zotera muelleri. Mentre il caldo si faceva sempre più torrido, toccando 52°, l'Investigator continuò l'esplorazione attraverso le isole Nuyts, con ancoraggi in diverse isole che fruttarono a Brown poche nuove specie. Poté invece rifarsi durante gli scali a Memory Cove (22-24 febbraio 1802) e Port Lincoln (26 febbraio-6 marzo) dove lui e Good raccolsero 35 e 85 specie (incluso il nuovo genere Ixodia). Tra il 10 e l'11 marzo, mentre l'Investigator era ancorato all'estremità settentrionale dello Spencer Gulf, l'intero gruppo degli artisti e degli scienziati scalò una montagna situata a una ventina di km all'interno, prontamente battezzata da Flinders Mount Brown. Fu un'impresa faticosa e pericolosa: rimasti senza viveri e acqua, dovettero trascorrere la notte sulla montagna. I due pittori però poterono dipingere splendide vedute. Secondo il racconto di Good, dal punto di vista botanico la gita fu un po' deludente: non solo trovarono una varietà di vegetali inferiore alle aspettative, ma molte delle piante raccolte giunsero a bordo ormai appassite. Si trattava comunque di una sessantina di specie, cui se ne aggiunsero altrettante al successivo ancoraggio dell'isola dei Canguri (21-22 marzo e 1-7 aprile). Qui Brown poté anche tornare al suo primo amore, raccogliendo diversi interessanti licheni. Dopo il fatidico incontro con il capitano Baudin, la navigazione proseguì lungo la costa del Victoria con un breve ancoraggio all'isola King e uno più lungo a Port Phillip. Insieme al capitano e a Westall, Brown scalò la collinetta che domina la baia nota come Arthur's Seat; al termine della piacevole escursione, oltre a uno splendido panorama, godettero anche un picnic a base di ostriche fresche. In questo distretto, Brown e Good aggiunsero alle collezione un altro centinaio di specie. La prima fase dell'esplorazione era conclusa e il 2 maggio l'Investigator lasciava Port Phillip per Port Jackson. La lunga sosta necessaria per raddobbare la nave fu utilizzata da pittori e naturalisti per completare i disegni e organizzare le raccolte; Good fu anche impegnato nella preparazione dei semi da inviare a Londra. Non mancò però il tempo per qualche escursione nei dintorni e a Parramatta, ad alcune delle quali partecipò anche il francese Leschenault de La Tour, divenuto buon amico di Brown, Il 22 luglio 1802 l'Investigator salpava per la seconda, meno fortunata, parte della spedizione. Le raccolte di Brown e del suo team lungo la costa orientale e settentrionale sono state studiate meno in dettaglio rispetto a quelle della costa meridionale; grazie al diario dello stesso Brown e al suo General remarks on the botany of Terra Australis sappiamo che in entrambe le aree vennero raccolte circa 500 specie, moltissime delle quali nuove per la scienza, trattandosi di regioni scarsamente o per nulla esplorate in precedenza. Per la costa nord-orientale al di sopra del 21° grado sud, Brown cita come luoghi di raccolta Port Curtis, Keppel Bay, Port Bowen, Stronge-tide Passage e soprattutto Broad Sound, dove egli raccolse la pianta che dedicò al capitano Flinders, Flindersia australis. Ricorda anche gli scali in due delle isole Northumberland e in una delle isole Cumberland. Anche la costa settentrionale, almeno prima che il deprecabile stato dello scafo dell'Investigator costringesse Flinders a ripiegare su Timor e poi a rientrare in tutta fretta a Port Jackson, offrì ai naturalisti diverse opportunità di raccolta sia lungo la costa (tra le zone citate, Melville Bay e Caledon Bay) sia in varie isole, una delle quali venne battezzata Good's Island in onore dell'ottimo giardiniere. In effetti, anche se le raccolte sono in genere ascritte a Brown, sappiamo che si trattò di un'impresa collettiva cui molto contribuì Peter Good, ma probabilmente anche Bauer, egli stesso un appassionato raccoglitore. Oltre alle piante, che occupavano il centro d'interesse di Briwn, vennero raccolti anche insetti, uccelli e altri animali, e sicuramente Allen si occupò delle rocce, anche se non sappiamo nulla delle sue raccolte (andate perdute nel naufragio del Purpoise).  Un omaggio meritato Come agli sfortunati membri della spedizione Baudin, la sosta a Timor fu fatale a diversi uomini di Flinders. Tra di essi proprio Good, che poco dopo la partenza dall'isola si ammalò di dissenteria; non si riprese e morì nella baia di Sydney il 12 giugno 1803 pochi giorni dopo il rientro dell'Investigator. Brown lo rimpianse molto e gli dedicò Banksia goodii. Gran parte delle sue raccolte di piante vive, che egli aveva amorosamente curato finché aveva potuto, sistemate nella serra mobile dell'Investigator, furono caricate sulla Purpoise e andarono perdute nel naufragio della nave, insieme a una cassa di semi. Con i semi inviati in precedenza, Good aveva però fatto in tempo ad arricchire i giardini di Kew (e quindi indirettamente d'Inghilterra) di molte specie australiane, soprattutto provenienti dalla costa meridionale. Nella seconda edizione di Hortus kewnesis, Aiton elenca ben 103 piante da lui introdotte nei giardini reali. Molte prosperavano ancora nella Australian House ai tempi di Hooker. Si salvò invece l'erbario, che Brown aveva incorporato nel proprio. Infatti, mentre Westall e Allen si imbarcarono con Flinders sulla sfortunata Purpoise, Brown e Bauer decisero di rimanere in Australia, un po' perché convinti che il capitano sarebbe tornato presto, un po' per rintegrare le collezioni perdute, ma soprattutto perché ritenevano che ci fosse ancora molto da scoprire. Non si sbagliavano: nei due anni che seguirono, aggiunsero alle loro raccolte altre 2000 specie e centinaia di disegni. Ne riparleremo in un altro post. E' ora di conoscere il genere che, presumibilmente su suggerimento di Brown, Salisbury dedicò all'attivissimo giardiniere con queste parole: "Secondo la mia opinione, nessuno ha maggior diritto che la sua memoria sia perpetuata da una pianta che porta il suo nome di un industrioso giardiniere botanico, specialmente quando la sua vita è caduta in sacrificio per le sue fatiche in lontani climi. Non so nulla di Peter Good tranne che, avendo raccolto semi per sua maestà nel Nuovo Galles del Sud, dove morì, Kew gli deve un ricchissimo lascito delle migliori e più rare piante di quel paese, ciascuna delle quali porta l'etichetta con il suo nome". Goodia è un piccolo genere della famiglia Fabaceae che comprende sei specie di arbusti endemici dell'Australia, da medi a grandi. Sono caratterizzati da foglie composte trifogliate, spesso di colore glauco; un'altra caratteristica distintiva è la presenza di stipole effimere o persistenti alla base del picciolo. I fiori papilionacei, con il vessillo più o meno circolare e le due ali più strette, sono gialli con marcature rosse, verdi o porpora. La specie più diffusa è Goodia lotifolia, un alto e folto arbusto eretto che in fioritura può ricordare le ginestre; endemico dell'Australia sud-orientale, è largamente presente in Tasmania e lungo la costa del Victoria e del Nuovo Galles del Sud meridionale. Recentemente un secondo genere si è aggiunto a celebrare indirettamente l'ottimo giardiniere: Paragoodia ("simile a Goodia"), separato nel 2011 da Muelleranthus; è un genere monotipico, rappresentato unicamente da P. crenulata, un'erbacea prostrata con foglie composte trifogliate e fiori con marcature che possono ricordare quelli di Goodia; endemica dell'Australia occidentale, è nota in un unico sito a sud del Mt Holland. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed