|
Jean-Baptiste Leschenault de La Tour è stato definito da Lucille Allorge "il più viaggiatore dei botanici viaggiatori". In effetti, da quando ventisettenne si imbarcò sul Géographe alla volta dell'Australia, non smise mai di spostarsi da un paese all'altro, eccetto quando ne fu impedito dalla guerra. Dal 1800 al 1803 fu appunto il botanico (l'unico rimasto) della spedizione Baudin nelle Terre Australi; sbarcato malato a Timor, si spostò a Giava, dove rimase tre anni a botanizzare in un ambiente naturale ricchissimo e quasi inesplorato. Dal 1807 al 1815 la guerra lo bloccò in Francia; ma, appena tornata la pace, eccolo ad esplorare l'India meridionale. Ritornò in patria solo nel 1822, ma dopo meno di un anno ripartì, alla volta del Sud America. La salute precaria (che già lo aveva tradito altre volte) lo costrinse a un rientro anticipato, l'ultimo. Si potrebbe però anche definirlo botanico coloniale perché dedicò quasi metà della sua vita a cercare piante adatte alla naturalizzazione nelle colonie francesi. A ricordarlo il bellissimo genere australiano Lechenaultia (o Leschenaultia), omaggio dell'amico Robert Brown. Australia, India, Sud America Non conosciamo molto della giovinezza di Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (1773-1826), soprattutto ignoriamo per quali vie si fosse avvicinato alla botanica. Nel 1798 dalla natia Borgogna si traferì a Parigi e si presentò a Antoine Laurent de Jussieu, nella speranza di essere ammesso come allievo al Museum National d'Histoire naturelle. Probabilmente ci riuscì, visto che Jussieu, nel sostenere la sua candidatura per la spedizione Baudin alle Terre australi, lo presenta come allievo dell'istituto. Si dice che Leschenault l'avesse presentata spinto dal motivo apposto rispetto allo zoologo François Péron: questi voleva partire perché il padre di lei gli aveva rifiutato la mano della ragazza che amava, lui invece voleva sottrarsi a un matrimonio mal riuscito. Come che sia, Jussieu era abbastanza soddisfatto delle sue competenze da proporlo come allievo botanico della spedizione; così scrive di lui: "Il cittadino Leschenault si occupa da qualche anno di botanica e ne sa abbastanza da nominare un certo numero di piante senza ricorrere a libri e da decifrare in questi ultimi la maggior parte di quelle che non conosce". Inoltre, sapeva essiccare correttamente le piante, le disegnava in modo abbastanza corretto, era di buon carattere e di eccellente educazione. Ma dopo la rinuncia di Ledru, da allievo Lechenault passò a botanico, rimasto poi l'unico della sventurata spedizione. In Australia, egli visse questa nuova responsabilità diviso tra un forte senso del dovere e la coscienza della propria inadeguatezza; entrambi i sentimenti emergono in una bella lettera inviata a Jussieu da Port Jackson in cui non può nascondere la sua invidia per il botanico della spedizione Flinders. A lui tocca raccogliere le piante, essiccarle, descriverle e pure disegnarle, visto che i disegnatori Lesueur e Petit sono divisi tra il lavoro per il comandante e quello per lo zoologo Péron. "Che contrasto - scrive - con gli aiuti di ogni tipo accordati al mio buon amico Robert Brown!" Certo fece il suo dovere fino in fondo e le sue raccolte furono notevolissime, anche se durante la spedizione ebbe ricorrenti problemi di salute. Durante il soggiorno a Port Jackson era tanto deteriorata che in un primo tempo egli pensò di chiedere l'autorizzazione a rientrare in Francia con il Naturaliste. Poi si riprese, poté partecipare a diverse escursioni botaniche nei dintorni di Port Jackson, a Parramatta e sulle Blue Mountains; ma a dissuaderlo fu soprattutto il capitano Baudin che seppe trovare le parole giuste per rassicurarlo, con un atteggiamento comprensivo e paterno (decisamente non era il mostro che è stato dipinto). Sicuramente Leschenault non si pentì di essere rimasto, visto che l'ultima parte del viaggio fu la più produttiva. Ma il prezzo fu il deterioramento della sua salute: nel maggio 1803 arrivò a Timor in tali condizioni che dovette essere lasciato a terra. Sperava di rimettersi e di tornare quanto prima a casa. Un mese dopo la partenza dei suoi compagni, si imbarcò su una nave olandese diretta a Batavia, dove giunse così malato da non potere proseguire. Chiese però il premesso di trasferirsi a Samarang, che godeva di un clima un po' meno insalubre. Vi giunse a ottobre e fu accolto dal governatore Engelhard, in cui trovò un uomo colto e interessato alle scienze naturali. Nacque così un nuovo progetto: Leschenault sarebbe rimasto a Giava e avrebbe esplorato le ricchezze naturalistiche dell'isola, solo marginalmente sfiorate dai naturalisti che l'avevano visitata in precedenza. L'amministrazione olandese fornì uomini e mezzi, permettendogli di muoversi in sicurezza e con relativo agio. L'esplorazione iniziò con un viaggio nelle due capitali dei sultanati di Surakarta e Yogykarta. Partito da Samarang il 24 ottobre, Leschenault si diresse dapprima a Surakarta, passando per i monti Ungaran, Merbabu e Merapi, un vulcano attivo; per un mese esplorò la città e i suoi dintorni, quindi passò a Yogykarta, visitando lungo il cammino le rovine del tempio buddista di Prambanang. Aveva di nuovo preteso troppo da se stesso: dopo due settimane a Yogyakarta, ebbe un crollo; trasportato in barella a Samarang, vi giacque malato dal febbraio all'ottobre 1804. Quando si fu ristabilito, ripartì per visitare la parte orientale di Giava, di cui toccò tutti i distretti costieri; quindi si imbarcò per l'isola di Madura, dalla quale sarebbe stata sua intenzione proseguire per l'arcipelago Kangean, ma la notizia di un'incursione di pirati malesi lo indusse a desistere; tornato sulla terraferma, esplorò la regione sud orientale fino a Banyuwangi, dove si fermò due mesi; quindi passò a Bali, di cui visitò le coste. Tornato a Banyuwangi, passando dall'interno e toccando i monti Tingar si diresse a Surabaya. Qui si imbarcò infine per Samarang, dove rientrò nell'agosto 1806, dopo un viaggio di 18 mesi. Andò poi a Batavia, con l'intenzione di imbarcarsi per la Francia. In Europa infuriava la guerra e non era facile trovare un imbarco su una nave neutrale, tanto più che portava con sé molte casse di piante, animali, conchiglie, oggetti etnografici; finalmente, a novembre riuscì a trovare un passaggio su una nave americana. Nell'aprile 1807 era a Filadelfia dove riuscì a ottenere dall'ambasciatore inglese un passaporto per sé e le proprie collezioni. A luglio, dopo sette anni di assenza, toccava il suolo francese. Quasi il suo primo atto fu scrivere a Jussieu per informarlo del suo ritorno e delle sue avventure. Le raccolte furono esaminate da una commissione designata dal ministero dell'Interno (ne facevano parte anche Lamarck e Cuvier) che le giudicò così importanti da proporre di considerare l'esplorazione di Giava parte integrante della missione nelle Terre Australi: a condizione che consegnasse le collezioni al Museum, era giusto pagargli quattro anni di stipendio arretrato e assegnargli una pensione analoga a quella concessa a Péron. Napoleone acconsentì. Fino alla caduta di quest'ultimo, venne l'ora di lavori da scrivania (tra gli altri, la stesura di un dizionario di lingua malese); nel 1816, ritornata la pace, ripartì. La nuova destinazione era Pondichéry (oggi Pondicherry), la capitale dell'"India francese", costituita da cinque empori situati lungo la costa del Malabar e recentemente restituita alla Francia dal Congresso di Vienna. Era invece rimasta in mani inglesi l'Ile de France, ovvero Mauritius: una perdita molto dolorosa perché per quasi un secolo l'isola e il suo giardino di Pamplemousses avevano costituito il principale luogo di acclimatazione delle specie esotiche da diffondere nelle colonie francesi. Ora quel ruolo passava all'altra isola delle Mascarene, la Réunion, tornata a chiamarsi Ile Bourbon con la restaurazione, e al suo giardino di Saint Denis, appena creato dal botanico Nicolas Bréon. La missione di Leschenault era proprio quella di cercare piante indiane utili per l'agricoltura e il commercio, da acclimatare a Bourbon per essere poi distribuite in quanto rimaneva delle colonie francesi. Il botanico prese molto sul serio il compito. Anche se nei sei anni in cui rimase in India raccolse anche un'imponente quantità di esemplari di piante, animali e minerali e si interessò di molti aspetti della vita e della cultura indiane, ne fece il principale oggetto delle proprie ricerche. Prima di partire per l'India, andò in Inghilterra ad incontrare il vecchio Banks, per ottenere lettere di raccomandazione per gli amministratori e i botanici inglesi, che in effetti gli furono di grande aiuto. Giunto a Pondichéry nel settembre 1816, dedicò il primo anno allo studio dei sistemi di coltivazione in uso lungo la costa del Coromandel. Studiò anche le tecniche tintorie tradizionali a Karikal, l'altra enclave francese. Nel 1818, il primo viaggio alla ricerca di piante utili lo portò a Salem, da cui riportò, oltre a un erbario di 400 specie e semi di circa 160, il primo carico di piante vive e semi destinato a Bourbon: c'era la pianta tintoria Nerium tinctorium (oggi Wrightia tinctoria), due specie di canna da zucchero, una nera e una bianca, alberi di sandalo e di teak, semi di papavero da oppio e di quattro tipi di cotone. Poi la salute lo tradì di nuovo: nel mese di ottobre ripartì per visitare i Ghati occidentali, ma a Coimbatore fu colpito da un pericoloso attacco di febbre gialla che lo costrinse a rientrare a Pondichéry. Appena il tempo di ristabilirsi, ed eccolo di nuovo a Coimbatore, punto di partenza per una lunga escursione sulle Nigiri Hills, in cui fu accompagnato da due amici inglesi, Mr. Sullivan e il dr. Jones. Su queste montagne, non molto elevate ma dai fianchi assai ripidi e difficili da scalare, caratterizzate da un clima fresco e ricchezza di acqua, trovò una ricca flora con molti generi presenti anche in Europa (Rhododedndron, Rubus, Geranium, Impatiens, Rosa, Salix, Berberis), che egli giudicò particolarmente adatte alla naturalizzazione nei giardini europei; tra le piante utili, una nuova specie di Berberis che per le sue eccellenti qualità tintorie battezzò B. tinctoria. Nel 1819 andò in nave in Bengala e ne tornò con molte piante da inviare a Bourbon, ma anche in Senegal. Oltre a molti alberi da legname o falegnameria, nella sua relazione all'Accademia delle scienze, egli cita la palma da zucchero Saguerus rumphii (oggi Arenga pinnata), Ficus elastica per la sua gomma elastica, piante tessili come Asclepias (oggi Marsdenia) tenacissima, Urtica tenacissima (oggi Bohemeria nivea), Boswellia thurifera (oggi B. serrata), da cui si ricava un tipo d'incenso. Il viaggio più lungo e impegnativo fu l'ultimo, dedicato all'estrema regione dell'India sud-orientale e all'isola di Ceylon. Leschenault visitò i due piccoli regni di Thanjavur e Tondiman, il distretto di Madurai e le montagne di Cottalam, punto di incontro tra i due monsoni, con una flora assai variata. Dal sud dell'India inviò a Pondichéry un convoglio di carri con 35 balle di alberi di 42 specie diverse, tra cui il teak Tectona grandis. Al loro arrivo, furono trapiantati nel giardino del governatore, primo nucleo dell'orto botanico di Pondichéry che sarebbe stato creato nel 1826 sui terreni dell'ex Campo di Marte. Torniamo a Leschenault. Dopo aver visitato la provincia di Tinnevelly, si imbarcò per Ceylon; dopo aver soggiornato per qualche tempo a Colombo, ottenne il permesso di visitare l'interno, cosa che fece per tre mesi, finché nel febbraio 1821 l'ennesima malattia lo costrinse a imbarcarsi per Pondichéry. Portava però con sé molti esemplari di Cinnamomum verum, l'albero da cui si ricava la pregiata cannella di Ceylon. Ad agosto lasciò l'India per Bourbon, accompagnato da cinque pecore e da un montone della razza di Coimbatore, 130 piante vive, compresi 32 pianticelle di Cinnamomum verum, e circa 200 specie di semi. Mentre si trovava sull'isola, con l'aiuto di Bréon tentò esperimenti di innesto del cotone su Thespesia populnea, Hibiscus liliflorus e Guazuma ulmifolia. Infine, il 15 febbraio 1822 si imbarcò alla volta della Francia via Capo della Buona speranza, dove approfittò di uno scalo di due settimane per incrementare la collezione di semi, acquistare qualche tartaruga e una nuova specie di uccello. Al suo rientro in Francia l'enorme contributo alle collezioni botaniche, zoologiche e mineralogiche del Museo e all'introduzione di specie coloniali utili gli valse l'attribuzione della Legion d'onore. Dopo meno d'un anno, arrivò una nuova missione: con il titolo ufficiale di "botanico della corona" (ne aveva fatta di strada dai tempi in cui era "allievo botanico"!) fu inviato nella Guaiana francese per rilanciare l'agricoltura di quella colonia. L'11 giugno 1823 egli partì da Brest in compagnia di A. J. L. Doumerc, diretto a Cayenne, dove giunse il 5 novembre, dopo due scali a Rio e Bahia. Portava con sé pianticelle di tè per l'orto botanico. Dopo un breve soggiorno nella capitale, i due si spostarono a Nouvelle Angoulême sul fiume Mana, dove si separarono. Doumerc visitò le tribù amerinde Galibi e Arrowali, mentre Leschenault proseguiva alla volta del Suriname (Guaiana olandese). Anche qui fece notevoli raccolte, ma la salute malferma lo costrinse a interrompere il viaggio e a rientrare a Parigi nel novembre 1824. Quando sembrava aver recuperato, morì all'improvviso il 14 marzo 1826 all'età di 52 anni.  Lechenaultia o Leschenaultia? Sempre in viaggio, Leschenault de La Tour raccolse moltissimo ma pubblicò molto poco. Al ritorno da Giava diede alle stampe due brevi testi relativi alla spedizione Baudin, uno sulla città di Kupang a Timor, l'altro sulla vegetazione della Nuova Olanda (pubblicato nel secondo volume della relazione ufficiale di Péron e Freycinet), e una memoria su alcune piante velenose di Giava. Ugualmente scarsi gli scritti sull'India, che si limitano alla relazione sul viaggio letta all'Accademia delle scienze, alla pubblicazione del Berberis scoperto sulle Nigiri Hills e a una memoria sulla cannella di Ceylon. Ad approfittare delle sue raccolte e dei suoi erbari furono altri naturalisti. Senza dimenticare che quando Leschenault tornò in Europa Robert Brown, che invece era rientrato nel 1805, aveva già fatto in tempo a pubblicare un certo numero di specie australiane raccolte da entrambi, rendendo in qualche modo superato almeno in parte un suo eventuale lavoro. Un certo numero di piante raccolte da Leschenault in Australia furono descritte da Etienne Ventenat e da Aimé Bonpland nelle loro opere sul giardino di Malmaison, altre furono pubblicate da Labillardière, altre ancora da R. L. Desfointaines, che descrisse anche alcune delle sue specie indiane nei cataloghi delle collezioni del Jardin des plantes. Moltissimo ovviamente rimase non pubblicato nei depositi del Museo Nazionale. Diverse decine di piante ricordano il nostro botanico viaggiatore nel nome specifico e con le loro diverse origini riassumono le tappe dei suoi viaggi: tra le altre, citiamo le australiane Beyeria leschenaultii e Calitrix leschenaultii, le indonesiane Hypericum leschenaultii e Aralia leschenaultii, le indiane Argureya leschenaultii e Impatiens leschenaultii. Tra gli animali, ricordiamo il corriere di Leschenault Charadius leschenaultii, il cuculo di Sirkeer Toccocua leschenaultii, il codaforcuta capobianco Enicurus leschenaulti, il pipistrello Rousettus leschenaultii, la lucertola Ophiosops leschenaultii. In Australia conserva il suo nome la bellissima laguna Leschenault Estuary, separata dall'Oceano Indiano dalla penisola Leschenault. Nel breve periodo in cui entrambi si trovavano a Port Jackson come botanici rispettivamente delle spedizioni Baudin e Flinders, Leschenault de La Tour e Robert Brown avevano stretto amicizia. Nel giugno 1802 fecero almeno un'escursione insieme, nella quale lo scozzese ebbe modo di apprezzarne le doti di acuto osservatore. Fu proprio lui a dedicare un genere al collega francese in Prodromus Florae Novae Hollandiae, con una motivazione piena di elogi: "L'ho nominato in onore del mio stimato amico Lechenault, celebre viaggiatore, esperto botanico, da cui si attende avidamente la pubblicazione delle piante della costa occidentale della Nuova Olanda e delle isole di Giava e Timor". La grafia del cognome non è un mio errore di battitura: così lo trascrive un po' ad orecchio Brown, che infatti denominò il nuovo genere Lechenaultia, senza esse. Qualche anno dopo George Bentham lo corresse in Leschenaultia, nome che si impose a lungo, finché in rispetto delle norme della nomenclatura botanica, si è tornati alla denominazione originale. Ma l'incertezza rimane: mentre nella letteratura botanica prevale Lechenaultia, Plants of the World on line usa Leschenaultia, che è anche la forma più usata come nome comune. Lechenaultia / Leschenaultia (famiglia Goodeniaceae) è un genere endemico dell'Australia con una ventina di specie; per lo più sono piccoli arbusti, con qualche erbacea annuale; in genere hanno portamento prostrato e tappezzante. La maggior parte si trova nei suoli sabbiosi e nel clima arido o semi-arido dell'Australia occidentale, una in condizioni simili nell'Australia orientale, due nella regione tropicale del nord; L. filiformis si spinge in Nuova Guinea, unica specie al di fuori dell'Australia. Attraenti sia per l'aspetto generale sia per le fioriture, diverse specie sono coltivate come ornamentali. Solitamente hanno foglie lineari e carnose, di colore grigio-verde, che al momento della fioritura formano uno sfondo perfetto per i numerosi fiori dalle coloratissime corolle asimmetriche: blu intenso per L. biloba, giallo luminoso o rosso carminio per L. formosa, rosa carico per L. macrantha. Anche da noi in vivai ben forniti è possibile reperire almeno la prima, di cui sono state selezionate alcune cultivar, ma coltivarla e mantenerla in vita per più di pochi anni non è semplice. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
Negli anni che precedono immediatamente la rivoluzione francese, si intrecciano due storie che sembrerebbero non avere nulla in comune. Da una parte c'è il marinaio francese Nicolas Baudin, che l'origine borghese esclude da una carriera di comando nella marina reale; sceglie allora la marina mercantile, tanto più che è nipote di un armatore di Nantes dai traffici non sempre limpidi. Dall'altra parte, c'è una spedizione di botanici austriaci, che fallisce per la defezione di metà dei suoi membri. Finché, nell'isola di Haiti, dove forse è venuto a contrattare un carico di schiavi, il marinaio incontra il capo dei botanici e ne riceve una soffiata che cambierà per sempre la sua vita. Perché le piante non basta raccoglierle, bisogna anche che qualcuno le porti a casa. E magari le faccia arrivare vive. Questa diventa la specialità del capitano Baudin, che comanda una dopo l'altra ben tre Jardinière (ovvero serre viaggianti). Tutte, puntualmente, finite male. Su queste e altre navi navighiamo su e giù per l'Atlantico e l'Oceano Indiano, mentre i botanici erborizzano nelle Americhe, in Sud Africa e a Mauritius. Alla fine, a portare a casa un genere valido sono un austriaco e un francese: il giardiniere viennese Franz Bredemeyer, dedicatario di Bredemeyera (Polygalaceae), e il botanico Pierre André Ledru, dedicatario di Drusa (Apiaceae).  Come un capitano di marina si appassionò di botanica Il 9 termidoro dell'anno VI (27 luglio 1798) la folla parigina assiste a un grandioso spettacolo: muovendo dalla sede del Museo di storia naturale, un corteo di carri ornati di ghirlande raggiunge il Campo di Marte, dove verranno pronunciati numerosi discorsi e i musicisti del conservatorio offriranno un concerto. E' questo il modo scelto dal Direttorio per esporre coram populo i tesori trafugati durante la campagna d'Italia, in un'operazione propagandistica che trasforma un saccheggio in un atto di libertà: quei tesori, anziché essere gelosamente nascosti nei palazzi e nei conventi per il godimento di pochi privilegiati - si proclama - sono ora messi a disposizione di tutti nei musei della Repubblica, per il progresso delle scienze e delle arti. Il corteo è strutturato in tre divisioni: la prima è riservata alla storia naturale, con sei carri carichi di piante e animali esotici; la seconda alla scienza e alla tecnica, con altri sei carri ricolmi di libri, manoscritti, medaglie, spartiti; la terza, il clou dell'intera manifestazione, ai capolavori dell'arte: tra gli altri sfilano la quadriga di san Marco, la Venere capitolina, lo Spinario, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, quadri di Raffaello, Tiziano, Domenichino, Giulio Romano, per un totale di 300 tra statue e dipinti. Se questi ultimi sono stati strappati ai palazzi italiani, non è certo così per molta parte degli oggetti naturali: qualcosa arriva dall'Egitto, dove in quel momento si trova Napoleone, ma il grosso proviene dalle Antille, ed è stato aggiunto al corteo all'ultimo momento, su suggerimento di Antoine-Laurent de Jussieu. In un certo senso, sono anche quelli prede di guerra: è il bottino del viaggio di Nicolas Baudin ai Caraibi, un successo che di lì a un anno garantirà a questo marinaio di lungo corso il comando della più importante missione scientifica della Repubblica: la "spedizione Baudin" nelle Terre Australi. In attesa di raccontarla in un prossimo post, facciamo conoscenza con questo personaggio, le cui vicende si sono curiosamente intrecciate con quelle della "spedizione Märter", promossa dall'Austria di Giuseppe II. Nicolas Baudin (1754-1803) era nato nell'isola di Ré in una famiglia relativamente agiata; prese il mare a quindici anni, a bordo di uno dei vascelli dello zio materno Jean Peltier Dudoyer, un armatore che aveva iniziato la sua carriera armando navi negriere e aveva interessi sia in America sia nell'Oceano indiano; per molti anni Baudin navigò sulle navi sia dello zio sia della Compagnia delle Indie; quando scoppiò la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, Peltier Dudoyer fu uno degli armatori che fornirono navi e rifornimenti alle colonie ribelli; il nipote si trovò coinvolto in prima persona e si comportò con onore, tanto da essere promosso capitano. Nel 1780 gli fu assegnato il comando della fregata Apollon incaricata di trasportare truppe al Capo di Buona Speranza per sostenere gli olandesi contro i britannici; un compito squisitamente militare, tanto che il comandante del porto di Brest gli ritirò il comando per assegnarlo a un nobile (solo questi ultimi potevano diventare ufficiali della marina militare). Baudin per il momento abbandonò ogni speranza di farne parte e continuò a comandare navi mercantili. Nel 1785 come capitano della Caroline, anch'essa armata da Peltier Dudoyer, trasportò in Louisiana l'ultimo gruppo di Acadiani di Nantes; a New Orleans (all'epoca ancora francese, e ancora Nouvelle Orlèans) alcuni mercanti lo incaricarono di trasportare varie merci a Mauritius (all'epoca ancora francese e ancora Ile del France) a bordo della Joséphine (detta anche Pepita o Josepha). Forse per contrattare un trasporto di schiavi dal Madagascar nel viaggio di ritorno, egli fece scalo a Haiti, dove incontrò il botanico austriaco di origine tedesca Franz Joseph Märter (1753-1827). Facciamo un passo indietro per raccogliere questo secondo filone della nostra storia. Nel 1783 il direttore dell'orto botanico di Vienna Nikolaus von Jacquin convinse l'imperatore Giuseppe II ad inviare in America una spedizione alla ricerca di piante esotiche per i giardini di Schönbrunn. La capeggiava appunto Märter, professore di storia naturale al Theresianum, accompagnato da un altro botanico, Matthias Leopold Stupicz, dal pittore Adam Moll e dai giardinieri Franz Boos e Franz Bredemeyer. Imbarcatosi a Le Havre ad agosto, insieme al nuovo console imperiale negli Stati Uniti, il gruppo raggiunse Filadelfia dopo un viaggio di quaranta giorni, in cui sperimentò tre tempeste e Märter scoprì il proprio tallone d'Achille: un irrimediabile mal di mare. A Filadelfia egli incontrò William Bartram e avrebbe voluto senz'altro iniziare le raccolte prima dell'inverno, ma gli mancavano i libri e le attrezzature, che viaggiavano su un'altra nave. Poté così mettersi all'opera solo a novembre. Mentre tutti gli altri raggiungevano Charleston in nave, egli attraversò a cavallo Pennsylvania, Maryland, Virginia e le due Caroline, accompagnato dal medico e zoologo Johann David Schöpf, che aveva partecipato come volontario alla guerra d'indipendenza da parte britannica e aveva deciso di fermarsi nel paese per studiarne la fauna. Arrivato a Charleston nel gennaio 1784, Märter inizialmente pensò di inviare nelle Bahamas Stupicz e un giardiniere, mentre lui con gli altri esplorava le due Caroline e la Florida, ma, rendendosi conto che Stupicz non parlava quasi l'inglese, lo mandò nella Carolina del Nord, dove vivevano numerosi tedeschi. Mentre Moll e Bredemeyer rimanevano a Charleston, egli si imbarcò con Schöpf e Boos per le Bahamas, soffrendo di nuovo atrocemente il mal di mare. Fu così costretto a ritornare a Charleston, mentre nei mesi seguenti Boos, spesso in condizioni difficili, esplorò diverse isole, rientrando a Charleston verso la fine dell'anno. Nel frattempo Bredemeyer era stato inviato a Vienna con un primo trasporto; il viaggio, iniziato nel giugno 1784, si protrasse per cinque mesi con la perdita di molte piante. Poco dopo il suo arrivo, insieme all'aiuto giardiniere Schücht, egli fu rimandato in America per ricongiungersi alla spedizione, la cui situazione si era fatta piuttosto critica. All'inizio del 1785, Boos era a Charleston gravemente ammalato; Moll e Supicz, che in realtà si erano imbarcati proprio nella speranza di emigrare negli Stati Uniti, diedero le dimissioni uno dopo l'altro, per stabilirsi a Charleston, il primo come insegnante di disegno e incisore, il secondo come medico. A sua volta Märter aveva contratto la malaria. A maggio lo lasciò anche Boos, che partì per Europa con una parte delle collezioni: più fortunato di Bredemeyer, ebbe un viaggio breve e senza contrattempi, consegnando piante e animali in perfette condizioni. Poco dopo la sua partenza, Märter si imbarcò per la Martinica, fissata come punto d'incontro con Bredemeyer e Schücht. Ma il mal di mare lo tradì ancora una volta e dovette sbarcare a Guadalupa. Riuscì poi a raggiungere Haiti, dove nell'agosto 1785 finalmente arrivarono anche i due giardinieri. Tutti e tre erano malati; il più grave era proprio Märter, che fu bloccato per sei mesi e a lungo dovette anche essere ricoverato nell'Hôpital de la Charité a Cap-Français. Fu in queste circostanze che conobbe Baudin. Lo sfortunato botanico (che probabilmente lo aveva saputo da Bredemeyer) lo informò che il suo antico compagno Boos era stato inviato ad erborizzare al Capo di Buona Speranza ed era in attesa di un imbarco per Mauritius. Proprio la meta del nostro intraprendente capitano che non perse l'occasione, dirigendosi immediatamente al Capo. Almeno, questa è la storia vulgata: le date non coincidono perfettamente. Comunque, prendiamola per buona. Le collezioni americane di Franz Boos avevano fatto una tale impressione all'imperatore, che aveva deciso che, anziché tornare in America a dare supporto all'inconcludente Märter, era meglio andasse direttamente in Sud Africa, per poi passare a Mauritius. Boos partì da Vienna nell'ottobre 1785 insieme all'aiuto giardiniere Georg Scholl. Dopo un lungo e penoso viaggio, funestato dallo scoppio a bordo di un'epidemia che aveva fatto più di trenta morti, erano arrivati al Capo solo nel giugno 1786; furono generosamente ospitati dal colonnello Gordon, che comandava la guarnigione della Compagnia delle Indie olandesi; egli fece loro conoscere Francis Masson, con il quale esplorarono Swartand e il Karoo, fino ad allora non molto battuto dai botanici europei, raccogliendo non poche novità. Baudin arrivò al Capo nel febbraio 1787 e imbarcò Boos e una parte delle sue collezioni, mentre Scholl, secondo le istruzioni ricevute, rimaneva in Sud Africa. A marzo erano a Mauritius, dove Boos incontrò il governatore Ceré, che era già in corrispondenza con Vienna cui nel 1783 aveva inviato piante e semi. Boos gli consegnò i doni dell'imperatore e si trattenne a lungo a Pamplemousses, stringendo ottime relazioni con i botanici e gli appassionati che ruotavano attorno a quel magnifico orto botanico, ricevendo molte piante provenienti non solo a Mauritius, ma dall'intera Asia. Poté anche visitare l'Île Bourbon (ovvero La Réunion) ed esplorare le montagne dell'interno con il botanico Joseph Hubert. Intanto si era accordato con Baudin per noleggiare la Joséphine per trasportare a Vienna le sue collezioni, rese preziose dai contributi dei nuovi amici delle Mascarene. Nel dicembre 1787 la Joséphine-Pepita (che, tanto per aumentare la confusione, Boos aveva ribattezzato Pepinière, "vivaio") riprese il mare. Come ci informano i giornali dell'epoca, raggiunse il porto austriaco di Trieste il 18 giugno 1788. Il suo carico, che comprendeva anche qualche zebra viva, fece sensazione. Gli animali e le piante presero la via di Vienna, dove rientrò anche Boos. Durante quei lunghi mesi di viaggio, capitano e botanico avevano fatto amicizia. Boos illustrò a Baudin le tecniche migliori per preservare le piante e gli animali durante i lunghi viaggi oceanici; per Baudin fu la scoperta di una nuova vocazione: quella di raccoglitore-naturalista.  Avventure quasi corsare Il riuscito trasporto delle collezioni di Boos era senz'altro un ottimo biglietto da visita; Baudin sperava gli assicurasse il comando di una nuova spedizione di cui si andava vociferando: niente meno che la prima circumnavigazione austriaca del globo. Nel frattempo, al comando della nave commerciale Jardinière (ovvero "serra viaggiante", un nome non scelto a caso, visto che nel vaiggio di ritorno avrebbe dovuto imbarcare Scholl e le sue piante) partì per Canton, non è troppo chiaro se per conto proprio o della Compagnia imperiale delle Indie. Forse temendo guai con l'amministrazione cinese, viaggiava infatti sotto bandiera statunitense. Giunto a Canton, spedì il suo secondo in America per un traffico di pellicce, ma la Jardinière naufragò nelle Marianne settentrionali, di fronte all'isola di Asuncion. E' l'inizio di una serie di vicende rocambolesche: Baudin andò a Mauritius a procurarsi un'altra nave, che battezzò Jardinière II; il nome non portò fortuna: il 15 dicembre 1789 un ciclone colpì l'isola e la nave andò distrutta in porto. Allora Baudin si imbarcò come passeggero su una nave della Compagnia reale delle Filippine; di passaggio al Capo, poté prendere con sé solo una piccola parte delle collezioni di Georg Scholl. La nave era diretta a Cadice, ma non vi giunse mai. Lo scafo era in uno stato così deplorevole che si dovette fare rotta per le Antille e fare scalo a Trinidad, dove la collezione venne sbarcata. Baudin si imbarcò su un'altra nave e arrivò in Martinica, dove scrisse a Vienna per spiegare la situazione e riproporsi come comandante della progettata spedizione in Estremo oriente. Forse era giunta la volta buona. Nel gennaio 1792 la corte di Vienna gli concesse il titolo di capitano della Marina imperiale e gli affidò il comando di una nuova Jardinière che, oltre a prelevare Scholl e le sue collezioni, avrebbe dovuto esplorare le Indie Orientali e la Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Per accompagnarlo furono designati Franz Bredemeyer e l'aiuto giardiniere Joseph van der Schot che ad aprile si imbarcarono a Genova alla volta di Malaga. Ma i tempi erano cambiati: in Francia la monarchia era crollata, e pochi giorni dopo la loro partenza, il 20 aprile 1792, la Convenzione dichiarò guerra alla Prussia e all'Impero. Baudin all'improvviso diventava un nemico; raggiunta anch'egli Malaga, dapprima pensò di abbandonare la spedizione e cercò di negoziare il suo rientro nella marina francese; avendo avuto un rifiuto, continuò i preparativi, mentre Austria e Gran Bretagna chiedevano alle autorità spagnole il suo arresto e il sequestro della nave. Nella confusa situazione politica di quei mesi, in cui la Spagna tentava la difficile strada della neutralità, dopo una breve detenzione fu rilasciato e riprese possesso della nave. Lasciati i botanici a terra, il 1 ottobre la Jardinière salpò; ma Baudin, anziché tornare in Francia, cercò di realizzare da solo il programma scientifico inziale. Eccolo al Capo di Buona Speranza, dove caricò una parte delle collezioni di Scholl (che si accorse troppo tardi che ora la nave batteva bandiera francese); quindi si diresse verso la Nuova Olanda ma incappò in due cicloni successivi che la costrinsero ad attraccare a Bombay per riparazioni. La navigazione volse ora verso occidente, toccando il Golfo persico, il mar Rosso, la costa orientale dell'Africa, dove vennero raccolti esemplari di animali e piante, e terminò di fronte a Table Bay, dove la terza Jardinière si arenò durante una tempesta. Baudin si salvò e, a quanto pare, riuscì a recuperare almeno qualcosa delle sue raccolte, visto che anche queste finirono a Trinidad, dove passò durante il viaggio di ritorno, passeggero di una nave americana. Rientrato in Francia, nel marzo 1796 Baudin incontrò Antoine Laurent de Jussieu e gli suggerì di organizzare per conto del Museo nazionale una spedizione a Trinidad per recuperare le collezioni (sue o austriache, ormai poco importava...). Il direttorio accettò la proposta e il 30 settembre 1796 Baudin partì alla volta delle Antille al comando della Belle-Angelique. Lo accompagnava una piccola équipe scientifica: il botanico André Pierre Ledru, il giardiniere Anselme Riedlé, gli zoologhi René Maugé e Stanislas Levillain. Ma la nave era così inadatta a tenere il mare che alle Canarie Baudin dovette abbandonarla e sostituirla con una nuova nave, la Fanny, con la quale nell'aprile 1797 raggiunse Trinidad. Qui scoprì che l'isola era da poco passata nelle mani degli inglesi, che rifiutarono di consegnargli le collezioni. Baudin non era tipo da tornare in Francia a mani vuote. Nelle Antille c'erano diverse isole neutrali, come la portoghese São Tomé e la danese Saint Croix. Baudin e i suoi naturalisti le esplorarono e fecero buone raccolte di piante e animali; quindi a Saint Croix la Fanny venne sostituita con un vascello più agile, ribattezzato Belle-Angelique, a bordo della quale visitarono Porto Rico, quindi proseguirono per la Francia, dove giunsero nel giugno 1797, pochi giorni prima del grande corteo da cui abbiamo preso le mosse, giusto in tempo per esibire i loro trofei nella divisione di storia naturale. Quello stesso giorno, anche grazie ai buoni uffici del cugino Marie-Etienne Peltier - che dal 1794 batteva i mari come "corsaro della Repubblica - Baudin ricevette il comando della nave corsara Virginie; il 4 agosto fu reintegrato nella marina militare con il grado di capitano di vascello, e partecipò ad alcuni episodi della guerra contro l'Inghilterra. Ma la vera rivincita se la sarebbe presa nell'ottobre 1800, quando gli venne affidato il comando della grandiosa spedizione nelle Terre australi, più nota come "spedizione Baudin". In queste vesti lo ritroveremo in un prossimo post. E con lui tre dei naturalisti della Belle Angélique che lo seguirono nella nuova avventura, per perdervi la vita.  Epilogo: e vissero felici e contenti Molti sono i personaggi di questa storia affollata ad aver ricevuto l'onore della dedica di un genere botanico, anche se ne rimane valido uno solo. Ad aprire le danze è lo stesso capitano Baudin. Per ben due volte, De Candolle gli dedicò un genere Baudinia, ma entrambi sono ridotti a sinonimi: Baudinia (Myrtaceae) di Melaleuca e Baudinia (Goodeniaceae) di Scaevola. Si consola con l'eponimo di Limonium baudinii, una specie della Tasmania raccolta durante la sua celebre spedizione. Veniamo ora ai suoi compagni austriaci, raccontando ancora qualcosa delle loro vite dopo il turbinoso incontro con il capitano francese. L'ottimo Franz Boos (1753 - 1832) dopo il ritorno a Vienna fece carriera. Nel 1787, quando von Jacquin lasciò l'incarico, fu nominato direttore dei giardini e dell'orto botanico di Schönbrunn, cui nel 1790 si aggiunse la direzione del serraglio imperiale e del cosiddetto "Giardino olandese". Fino al ritiro nel 1827, continuò anche ad essere capo giardiniere e nel 1816 insieme al figlio Joseph Boos, anch'egli un valente professionista, pubblicò un catalogo delle piante selvatiche e coltivate di Schönbrunn. Nel 2001 il botanico austriaco Speta ha voluto ricordarlo con il genere Boosia, generalmente non accettato (è sinonimo di Drimia). Gli è stata anche dedicata una via nel quartiere di Hietzing. Dopo aver visto involarsi una parte delle sue collezioni per l'inganno di Baudin, Georg Scholl (1751-1831) rimase ancora in Sudafrica per diversi anni (il suo soggiorno ne durò in tutto dodici), ancora ospite del colonello Gordon. Le sue raccolte diventavano sempre più imponenti e sempre più difficili da trasportare, come ci informa Francis Masson nelle sue lettere a Joseph Banks. Di tanto in tanto, riusciva a spedire a Vienna bulbi e semi, tra cui quattro spedizioni tra il 1790 e il 1792 che, attraverso il console austriaco in Olanda, raggiunsero Vienna via Amsterdam. Solo nel 1799 gli fu possibile lasciare il paese, ritornando a Vienna con la collezione di piante vive sudafricane più importante d'Europa (ora capiamo meglio perché Banks, appena tornata la pace, si sia affrettato ad inviare al Capo il suo raccoglitore James Bowie). L'esemplare più sensazionale era una Fockea capensis, una specie così rara che a lungo si credette fosse estinta in natura. E' tuttora possibile ammirarla nella serra di Schöbrunn, grazie alla previdenza di un giardiniere che, durante la seconda guerra mondiale, lo salvò portandoselo a casa. Con i suoi 600 anni valutati, è considerata la più vecchia pianta in vaso del mondo. Quanto a Scholl, tornò a lavorare a Schönbrunn, quindi dal 1802 divenne capo giardiniere al Belvedere. Nel 1811 il figlio di von Jacquin gli dedicò Schollia (sinonimo di Hoya) e sempre nel 2001 Speta Geschollia (ugualmente sinonimo di Drimia). Lo ricorda l'eponimo dell'Aizoacea sudafricana Ruschia schollii. Nonostante la grande ricchezza e l'importanza storica delle collezioni di Boos e Scholl, la maggior gloria botanica è però riservata a Franz Bredemeyer (1758-1839), ricordato da un genere valido e da una decina di eponimi. Lo abbiamo lasciato ad Haiti al momento del ricongiungimento con Märter. Nel febbraio 1786 questi inviò lui e Schücht in Venezuela, dove contava di raggiungerli appena recuperata la salute. I due passarono da Porto Rico, che furono i primi botanici a visitare, quindi visitarono Caracas e il porto di La Guaira, dove avrebbe dovuto raggiungerli Märter. Nel frattempo questi aveva di nuovo cambiato idea e li richiamò, ma i due giardinieri ormai agivano in modo indipendente (e molto più efficace). Pur dovendo fare i conti con difficoltà economiche, carte sbagliate e i sospetti delle autorità spagnole, che temevano fossero spie, decisero di esplorare il più possibile quel paese tanto affascinante quanto quasi inedito per la botanica. Acquistarono dei muli e assunsero un assistente; a settembre viaggiarono a est di Caracas, visitando Guatire, Caucagua e la foresta pluviale nei pressi di Capaya (nell'attuale stato di Miranda); da marzo a maggio dell'anno successivo si spostarono verso ovest nell'attuale stato di Aragua e nei Llanos. Nell'aprile del 1788 si imbarcarono a La Guaira alla volta di Curaçao, dove noleggiarono la goletta americana The Commerce che li avrebbe riportati in Europa insieme a molte piante che fecero sensazione per l'aspetto decisamente esotico e tropicale. Li aveva preceduti di circa un anno lo stesso Märter. Invece di raggiungere i due giardinieri in Venezuela, era passato in Giamaica; qui aveva visitato le Blue Mountains, dove lo incontrò il botanico svedese Olof Schartz; secondo la testimonianza di quest'ultimo, era di nuovo malato, nonché depresso per la disgrazia in cui era caduto presso la corte di Vienna, che gli attributiva tutta la colpa del fallimento della spedizione. Nel maggio 1787 imbarcò totalmente a sue spese una collezione che secondo le sue dichiarazioni ammontava a non meno di 3000 esemplari, tra cui 1800 piante vive. Giunto a Londra, le fece svernare in serra; qui e in Olanda acquistò anche molti uccelli impagliati. Poté così presentarsi a testa alta all'imperatore che dovette perdonarlo, se lo nominò professore di botanica e storia naturale all'Università dei Paesi Bassi austriaci, fondata l'anno prima. Su sua raccomandazione, Bredemeyer venne nominato direttore dell'annesso orto botanico. Per entrambi, un incarico di brevissima durata. La rivoluzione del Brabante dell'ottobre 1789 li costrinse alla fuga. Una nuova occasione si presentò per Bredemeyer quando, come abbiamo anticipato, venne nominato naturalista della missione della terza Jardinière. Già sappiamo che l'avventura sfumò e il povero giardiniere rimase a terra, mentre Baudin partiva senza di lui. Non gli restava che tornare a Vienna. Nel 1793 divenne supervisore dei frutteti e dei parchi di Schönbrunn; in seguito si occupò dei giardini degli arciduchi, che nel 1802 accompagnò ad erborizzare in montagna. Al pensionamento di Boos, divenne a sua volta direttore dei giardini e del serraglio di corte. Sotto la sua direzione, furono allestite la "Casa delle giraffe" e una collezione di piante parassite. Divenuto consigliere imperiale e membro di molte società orticole, inclusa la Horticultural Society di Londra, morì ottantenne nel 1839. Le specie tropicali raccolte in Venezuela divennero una delle maggiori glorie delle serre di Schönbrunn, destando l'ammirazione di Humboldt, che fu spinto anche da quello spettacolo al suo viaggio in Sud America, dove non avrebbe mancato di ripercorrere le orme di Bredemeyer e Schücht. Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, conosceva bene Bredemeyer, delle cui note si servì ad esempio per descrivere le piantagioni di cacao del Venezuela, ombreggiate da alberi di bucaré (Erythrina poeppigiana) dagli smaglianti fiori rossi tra cui volavano eserciti di pappagalli dalle piume multicolori. Fu sicuramente lui a suggerire l'acquisto dell'erbario di Bredemeyer, 180 fogli del quale si trovano ora al Museo botanico di Berlino-Dahlem. Non stupisce dunque che sia stato proprio Willdenow a dedicargli il genere Bredemeyera, sulla base di una pianta raccolta da Franz Bredemeyer nei pressi di Caracas. Oggi a questo genere della famiglia Polygalaceae sono attribuite 18 specie, distribuite dal Messico al Paraguay settentrionale. Sono liane legnose o piccoli arbusti con foglie semplici, fiori con cinque sepali, due esterni e tre interni, con ali petaloidi; la corolla ha cinque petali (due laterali, la carena, e due rudimentali): i frutti sono capsule con semi protetti da un arillo con peli più lunghi dei semi stessi. La specie tipo descritta di Willdenow B. floribunda, diffusa dal Venezuela al Paraguay, presenta cospicui grappoli di fiori bianchi; è una specie officinale, con proprietà disintossicanti, cui la medicina tradizionale attribuisce efficacia contro i morsi dei serpenti. Tra le diverse specie che si fregiano dell'eponimo bredemeyeri o bredemeyerianus, vorrei ricordare almeno la spettacolare Bomarea bredemeyeriana: con i suoi grappoli di fiori a campana aranciati fu probabilmente una delle piante la cui vista colpì al cuore Humboldt. E Märter? forse qualcuno si domanderà. Sappiamo che la collezione d'uccelli fu da lui donata alla loggia massonica Zur true Eintracht (frequentata anche da Mozart e Schikaneder che ne avrebbero tratto ispirazione per l'uccellatore Papageno del Flauto magico) e andò dispersa quando il cattolicissimo imperatore Francesco bandì la massoneria nel 1794. Non ci è noto il destino della collezione botanica, forse meno favolosa di quanto Märter pretendesse. In condizione di professore "giubilato", ovvero in pensione, nel 1796 egli pubblicò una seconda edizione assai accresciuta di un libro sugli alberi austriaci che aveva pubblicato prima della spedizione (Verzeichniß der östreichischen Bäume, Stauden und Buschgewächse); l'anno successivo fu la volta di una monografia sulla batata dolce. Nel 1797, quando venne riaperta l'Accademia dei cavalieri teresiani, gli fu assegnata la cattedra di silvicoltura. La coltivazione di alberi da frutta e da legname era infatti ormai il suo interesse principale, tanto che nel 1799 aprì un vivaio con 300 piante da frutto; l'avrebbe venduto nel 1806 per motivi di salute, così come nel 1803 per la stessa ragione aveva dato le dimissioni dal Theresianum. Per altro morì più di vent'anni dopo, nel 1827, a 73 anni. Giuseppe II lo considerava streitsüchtig, ovvero polemico. A me pare piuttosto inconcludente. Sta di fatto che nessun botanico ha mai pensato di dedicargli, nonché un genere, neppure una specie. Fu invece nientemeno che de Candolle a dedicare un genere al solo botanico francese di questa storia, André Pierre Ledru (1761-1825), uno dei naturalisti della Belle Angélique. Sappiamo che era un sacerdote, da poco consacrato quando scoppiò la rivoluzione, cui aderì senza esitare, prestando giuramento alla Costituzione civile del clero. Nella fase più convulsa della controrivoluzione vandeana, come prete giurato si trovò in pericolo di vita; si trasferì così a Parigi, dove presumibilmente entrò in contatto con gli ambienti del Museum national e in particolare con Antoine Laurent de Jussieu (nel suo erbario si trovano esemplari donatogli da lui, comprese alcune piante coltivate al Trianon da suo zio Bernard de Jussieu). Grazie a queste frequentazioni, fu scelto come botanico della spedizione nelle Antille, durante la quale fece notevoli raccolte a Tenerife, Porto Rico e in diverse isole. Al suo rientro, tornò in provincia, divenendo insegnante, anche se non abbandonò mai del tutto la botanica, visto che allestì un orto botanico privato e possedeva un notevole erbario, ora conservato al Museo di Le Mans. De Candolle, che all'epoca lavorava ancora al Museum national, gli dedicò Drusa (Apiaceae), sulla base di un esemplare raccolto da Ledru (che egli definisce "ragguardevole botanico") a Tenerife, lungo la strada che conduce a La Orotava. La sua unica specie D. glandulosa è una piccola rampicante pelosa e appiccicosa, con fiori minuscoli e curiosi frutti dotati di ali dentate. Singolare la sua distribuzione: oltre che nelle Canarie e in Marocco (dove si ritiene introdotta), si trova in alcune stazioni della catena Cal Madow in Somalia. Nella storia australiana, Allan Cunningham è noto soprattutto come esploratore, per aver aperto nuove vie di comunicazione e scoperto diversi valichi, tra cui quello che porta il suo nome (Cunningam's Gap); tuttavia, anche dopo essere stato coinvolto dal governatore Brisbane nell'esplorazione del territorio della colonia, egli continuò a sentirsi in primo luogo un botanico che, come scrisse a Kew, aveva trovato il modo di "mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". Finite le spedizioni marittime guidate del capitano King, tra il 1822 e il 1829 Cunningham perlustrò gran parte del Nuovo Galles del sud, per poi essere incaricato di trovare vie di collegamento con il Queensland, e prese parte a più di venti spedizioni, almeno una delle quali diretta e organizzata da lui stesso. Un viaggio lo portò anche in Nuova Zelanda. Senza però mai smettere di raccogliere piante: secondo l'amico e primo biografo Robert Heward, durante i suoi quindici anni australiani furono oltre 3000 specie. Moltissime sono quelle che lo ricordano nel nome specifico, Alania cunninghamii anche in quello generico. Senza dimenticare il genere Cunninghamia, che divide con il quasi omonimo James Cunighame.  Tra fatiche e speranza Il 25 aprile 1822, con il rientro a Sydney della Bathurst, si concludeva la prima fase delle avventure australiane di Allan Cunnigham, quella marittima (l'ho raccontata in questo post). L'infaticabile botanico del re rivolgeva ora la sua attenzione all'interno del paese. Dopo aver dedicato qualche mese a preparare i materiali da spedire a Kew (fase a cui dedicava ogni attenzione e che sempre lo preoccupava sommamente, per il lunghissimo viaggio che attendeva i suoi campioni e le fragili piante vive), già a settembre era di partenza: superate le Blue Mountains, per tutto il mese fu impegnato ad erborizzare nell'area compresa tra Bathurst e il fiume Cudgegong, spingendosi anche a oriente di quest'ultimo. I risultati di questa spedizione attirarono l'attenzione del nuovo governatore del Nuovo Galles del Sud, sir Thomas Brisbane, che lo incaricò di cercare una via di collegamento tra Bathurst e le Liverpool Plains scoperte da Oxley nel 1818. Cunningham, che da tempo coltivava la passione per l'esplorazione, accettò di buon grado e scrisse a Kew: "'Ho scoperto di poter mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". L'appoggio logistico offerto dal governatore tornava per altro comodo, visto il magro salario e gli scarsi finanziamenti londinesi. Nel marzo 1823 Cunningham, accompagnato da cinque servitori e altrettanti robusti cavalli da soma, partì da Bathurst dirigendosi verso nord in direzione del Lawson's Goulburn River, poi a est fino alle sorgenti del fiume Hunter. Da qui risalì la Liverpool Range alla ricerca di un valico; dal Mount Macarthur (oggi Mount Moan) vide a est un punto in cui catena di abbassava e decise di muovere in questa direzione, ma il cammino si fece sempre più difficile, finché risultò bloccato da ogni parte da ripidi burroni. Non restava che tornare indietro fino al Mount Macarthur, per cercare un passaggio in direzione nord-ovest. L'infruttuosa deviazione era costata tre settimane e tre giorni. Dopo altri sei giorni di cammino lungo la catena, il 2 giugno Cunningham decise di salire nuovamente su una cima: guardandosi intorno, a non più di tre miglia scorse una notevole depressione, al di là della quale si intravvedevano pianure aperte. Cunningham aveva scoperto il Pandora's Pass: gli diede questo nome pensando, da una parte, alle privazioni e alle difficoltà del viaggio, dall'altra alla piccola speranza che aveva trovato alla fine, che gli facevano pensare al mito di Pandora che, quando apre il suo vaso, sparge nel mondo ogni male, ma in fondo le rimane la speranza. Raggiunto il valico il 9 giugno, ritornò infine a Bathrust il 27 giugno, dopo undici settimane di arduo cammino. Relazionò poi i due viaggi da Bathurst in A Specimen of the Indigenous Botany […] between Port Jackson and Bathurst, e in Journal of a Route from Bathurst to Liverpool Plains (1825); significativamente, il focus del primo sono le piante, del secondo l'esplorazione. Dopo questa epica spedizione, fu la volta di una serie escursioni più brevi, per lo più in distretti già esplorati, in cui la botanica tornava in primo piano: a novembre raccolse esemplari nelle Blue Mountains lungo la Bells Line; nel gennaio 1824 tornò a Bathrust a raccogliere semi maturi. Poco dopo il suo ritorno a Parramatta, attraccò a Port Jackson il battello francese Coquille, che stava circumnavigando il globo al comando di Louis Isidore Duperrey. Con grande gioia, Cunningham fece conoscenza con il naturalista ufficiale della spedizione René Primevère Lesson e il primo ufficiale e botanico Jules Dumont d'Urville e in marzo li accompagnò a erborizzare nelle contee di Camden e Argyle; visitarono i laghi George e Bathurst, le sorgenti del Murrumbidge, Brisbane Downs, la Marley Plain e Shoalhaven. Era una zona facile da percorrere e almeno in parte già battuta, che non offriva grandi novità botaniche, tranne intorno alle cave calcaree di Shoalhaven, ma fu senz'altro un splendido biglietto d'ingresso per i due naturalisti francesi, Rientrato con loro a Parramatta all'inizio di maggio, Cunningham trascorse i mesi di luglio e agosto a erborizzare a Illawarra, uno dei suoi luoghi preferiti, riportandone piante vive che piantò in piccole scatole o vasi, perché recuperassero prima di essere spedite in Inghilterra. Tra l'altro scoprì la terribile Dendrocnide excelsa (lui la chiamò Urtica gigas), un albero dalle foglie urticanti che provocano un dolore che può durare mesi, tanto inteso da resistere alla morfina. Si affrettò poi a rientrare a Parramatta, in modo da imbarcarsi sulla Amish diretta a Moreton Bay; questa spedizione, di nuovo guidata da Oxley, aveva lo scopo di esplorare il fiume Brisbane. Insieme a Oxley, Cunnigham risalì in battello il fiume finché fu navigabile; lungo le sue rive poté scoprire molte piante interessanti, tra cui Araucaria cunninghamii, e anche diverse specie di orchidee. A ottobre era di nuovo a Parramatta; per concludere l'anno, tornò nuovamente a Bathurst a fare incetta di semi. Ne riportò novità come Banksia cunninghamii, Grevillea anethifolia, Eucalyptus mannifera. Dal Nuovo Galles al Queensland Nell'inverno del 1825 (da aprile a giugno) fu la volta di una nuova spedizione verso nord, che nel prima tratto ripercorse la strada che egli stesso aveva aperto due anni prima. Passando da Richmond, Cunningham raggiunse la valle dell'Hunter, quindi superò il Pandora's Pass procedendo verso nord attraverso le Liverpool Plains, dove trovò un notevole ostacolo nella pioggia continua e nel terreno piatto e paludoso; proseguì alla ricerca di una strada più elevata, finché fu costretto a tornare indietro, trovando la piana completamente allagata. Rientrò a Parramatta il 17 giugno, avendo percorso un circuito di 700 miglia. Gli ultimi mesi dell'anno furono trascorsi ad esplorare le aree della Wellington valley e di Mudgee, alla ricerca di semi ed esemplari da inviare a Kew; il bottino più interessante furono diverse orchidee terrestri. Ma la sua salute cominciava a risentire di tante fatiche e tanti viaggi, e dovette fermarsi fino a febbraio, per poi accontentarsi di escursioni botaniche relativamente brevi lungo il Cox's River e ancora a Illawarra. Nell'agosto 1826 poté realizzare un sogno che accarezzava da molto tempo: imbarcatosi su una baleniera, raggiunse la Nuova Zelanda dove fu accolto calorosamente dai missionari della Baia delle isole. Si trattenne nell'isola del Nord per quattro mesi, visitando l'area compresa tra la Baia delle isole e Hokianga, la zona di Wangoroa e la baia di Plenty. Infine, il 29 dicembre si imbarcò sul piccolo vascello dei missionari diretto a Sydney, dove sbarcò il 20 gennaio 1827 dopo un viaggio reso lungo e penoso dai venti avversi. Risultato della breve visita fu Florae Insularum Novae Zelandiae Precursor (1837-39), considerato la prima sinossi della flora neozelandese. Lo attendeva la più impegnativa delle sue spedizioni. Essendogli giunta notizia che il governatore sir Ralph Darling desiderava si esplorassero le potenzialità economiche dell'area compresa tra la Grande Catena divisoria e Moreton Bay (l'odierna Brisbane), si offrì come capo della spedizione, per la quale propose un dettagliato itinerario. Ad accompagnarlo sarebbero stati sei uomini, parecchi cani e undici cavalli da soma con le provviste per quattordici settimane; i cavalli vennero inviati via terra fino all'alto corso del fiume Hunter, mentre Cunnigham raggiungeva in nave Newcastle; da qui risalì il fiume con le provviste fino a Dulwich, dove il gruppo si riunì. Proseguirono quindi insieme fino a Segenhoe, all'epoca la fattoria più estrema e punto di partenza della spedizione vera e propria. Gli esploratori ne partirono il 30 aprile e si diressero a nord, varcando la Liverpool Range all'altezza di Dartbrook Creek; spesso la strada era così ripida che bisognava alleggerire i cavalli, trasportando i bagagli a braccia. Quindi si diressero verso nord in direzione del fiume Peel, passando attraverso una boscaglia aperta di Eucalyptus sideroxylon. Il 21 maggio raggiunsero un vasto fiume che Cunningham chiamò Gwydir; proseguirono attraverso aride boscaglie interrotte da crinali e gole, fino a fiume Macintyre che era quasi asciutto per la siccità. Preoccupato dalla mancanza di pascolo per i cavalli e per le provviste, già consumate a metà, Cunningham decise di non proseguire verso nord come aveva progettato, ma di spostarsi più a est. Fu così che il gruppo si imbatté in un fiume largo e profondo che il botanico battezzò Dumaresq, in onore del segretario del governatore Henry Dumaresq. Dopo averlo attraversato, proseguirono per altri sei giorni; il 6 giugno Cunnigham salì sul monte Damaresq: di fronte a lui una vasta pianura feritile di ricchi pascoli. Era le terra promessa che era venuto a cercare: non a caso la battezzò Darling Downs in onore del governatore che aveva voluto quella spedizione. A una distanza di forse dieci km, vide anche un valico che prometteva di offrire un comodo passaggio verso Moreton Bay. Debilitato dall'epatite di cui soffriva periodicamente fin dai tempi dei viaggi della Mermaid, non lo esplorò personalmente, ma vi inviò due uomini che confermarono la sua supposizione. Cunningham lo chiamò Spicers Gap in onore di Peter B. Spicer, sovrintendente dei forzati. Attraverso un altro passo, che poi sarebbe stato chiamato Cunningham's Gap, il gruppo scese nei Darling Downs, seguendo per qualche giorno il corso del fiume che lo irrigava (Cunningham lo battezzò Condamine River, in onore di Thomas de la Condamine, ex aiuto di campo del governatore); quindi si accamparono in una valle ad est del fiume (Logan Valley, in onore del comandante dell'insediamento di Moreton Bay) per far recuperare uomini e cavalli. Era infatti ora di tornare indietro, cosa che fecero seguendo una via più occidentale rispetto a quella dell'andata, rientrando a Segenhoe dopo un viaggio di tredici settimane. Cunningham poté presto verificare di persona la praticabilità della via di collegamento che aveva intravvisto. Nel 1828 andò ad erborizzare a Moreton Bay con il botanico della colonia Charles Fraser; a luglio partivano in spedizione con il comandante Logan, un soldato, cinque forzati e molte provviste. Dirigendosi verso sud, raggiunsero il Logan River, scoperto dal capitano due anni prima, e il monte Barney, che Logan già aveva tentato inutilmente di scalare. Questa volta ci riuscì. Dopo aver esplorato per qualche giorno l'area intorno all'attuale Boonah, Fraser e Logan tornarono a Brisbane; Cunningham invece si addentò nelle montagne e varcò il passo che aveva scoperto nel 1827. La strada che egli percorse è oggi diventata un'autostrada, e ovviamente porta il suo nome: Cunningham Highway. Cunningham tornò a Moreton Bay ancora nel 1829, per esplorare l'alto corso del Brisbane River. Anche nel 1828 e nel 1829 non mancarono i consueti viaggi botanici a Bathurst e Illawarra. Tra maggio e settembre egli visitò anche l'isola Norfolk. Trattenuto nell'isola oltre il previsto dal cattivo tempo, poté fare un inventario molto ampio della sua flora (nel suo diario elenca 104 specie che ritiene native e 38 che considera introdotte). Visitò anche la vicina isola Phillip, dove fu derubato di gran parte dell'equipaggiamento e delle provviste da alcuni forzati. Fin nel 1828 aveva chiesto di poter tornare in Inghilterra (ricordo che l'aveva lasciata nell'ormai lontano 1814); il permesso gli fu finalmente accordato nel novembre 1830. Dopo un'ultima visita a Illawarra e alla Cox Walley e i saluti agli amici (erano tanti che richiesero non meno di una settimana), partì da Sydney il 25 febbraio e arrivò in Inghilterra a luglio. Qui si stabilì non lontano da Kew, dedicandosi alla sistemazione del suo erbario e alla stesura di vari articoli. Nel 1832 fu ammesso alla Linnean Society. Lo stesso anno morì Charles Fraser, e gli fu offerto di succedergli come botanico della colonia, ma egli rifiutò a favore del fratello minore Richard. Anche quest'ultimo era un ottimo botanico, entrato appena quindicenne a Kew. In Australia non mancò di partecipare a diverse spedizioni e visitò anche la Nuova Zelanda (dove tra l'altro scoprì l'orchidea che porta il suo nome Dendrobium cunninghamii), ma infine fu vittima di un tragico incidente. Nell'aprile 1835 si unì alla spedizione Mitchell, inviata ad esplorare il corso del fiume Darling. Nei pressi del Bogan River, si allontanò dal gruppo per erborizzare e non fece mai più ritorno. Più tardi si scoprì che, perdutosi e probabilmente in preda al delirio, si era unito ad alcuni indigeni che più tardi, terrorizzati dal suo strano comportamento notturno, lo avevano ucciso. Quando la notizia della morte di Richard giunse in Inghilterra, il posto di botanico della colonia fu nuovamente offerto a Allan Cunningham, che questa volta accettò e ritornò a Sidney nel febbraio 1837. Tra i suoi compiti, c'era anche la direzione del Giardino del governatore; Fraser aveva cominciato a trasformarlo in orto botanico (il futuro Sydney Royal Botanic Garden), ma era ancora soprattutto un parco pubblico e un orto per la coltivazione di verdure per la mensa del governatore; dopo qualche mese, Cunningham diede le dimissioni, proclamando che non "avrebbe più tollerato di essere un mero coltivatore di cavoli e rape". Nell'aprile 1838 si imbarcò sulla corvetta francese L'Héroine alla volta della Nuova Zelanda; trovò tempo pessimo e ritornò Sidney in ottobre gravemente malato. Nonostante la sua salute continuasse a peggiorare, progettava di accompagnare il capitano John Wickam della Beagle in una nuova ricognizione della costa nord-occidentale. Ormai stava così male che la nave partì senza di lui; il suo successore e amico James Anderson lo fece trasportare in un piccolo cottage situato nell'Orto botanico, dove Cunningham si spense il 27 giugno 1839. Nel 1844 in sua memoria venne eretto un obelisco commemorativo, alla cui base nel 1901 vennero traslate le sue ceneri. Si trova al centro di un piccolo stagno affiancato da boschetto di una delle tante piante da lui scoperte, la palma Archontophoenix cumminghamiana. Gli è intitolata anche la rivista scientifica dell'Orto botanico di Sydney "Cunninghamia".  Una piccola pianta per un grande raccoglitore Insieme a Robert Brown, Allan Cunningham è considerato il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento; ne esplorò le coste settentrionali, gran parte del Nuovo Galles del Sud, il Queensland meridionale, la Tasmania, nonché le isole Norfolk e Phillips e alcune aree della nuova Zelanda. Secondo il suo amico e primo biografo Robert Heward, le specie da lui raccolte ammontano a 3000. I suoi invii di semi, bulbi, piante vive a Kew furono così importanti che una serra, prima destinata alle piante africane, venne invece riservata alle sue australiane. Moltissime delle specie da lui raccolte erano ignote alla scienza, e non poche gli sono state dedicate. Ricordiamo almeno Casuarina cunninghamiana, Archotophoenix cunninghamiana, Araucaria cunninghamii, Crotalaria cunninghamii, Actinodium cunninghamii, Adenanthos cunninghamii, Alsophila cunninghamii, Angianthus cunninghamii, Banksia cunninghamii, Cassinia cunninghamii, Clematis cunninghamii, Eucalyptus cunninghamii, Nothofagus cunninghamii, Solanum cunninghamii. A una scelta di queste magnifiche piante è dedicata la gallery a fine post. Anche se i continui viaggi e la brevità del soggiorno in Inghilterra gli permisero di pubblicare solo una minima parte delle sue raccolte, gli si devono 139 denominazioni valide: 6 generi (Ackama, Alseuosmia, Corokia, Fieldia, Rabdothamnus, Hoheria), 133 specie (la più nota delle quali è probabilmente Grevillea rosmarinifolia) e una varietà. Si basano invece su raccolte di Cunningham più di 300 denominazioni di altri autori, tra cui 6 generi. A Cunningham sono stati dedicati due generi: Cunninghamia R.Br., che condivide con il quasi omonimo James Cuninghame (ne ho parlato in questo post) e Alania Endl., un genere monospecifico della famiglia Boryaceae, la cui unica rappresentante ha la ventura di ricordare il nostro protagonista sia nel nome generico sia nell'epiteto: è infatti Alania cunninghamii, un'erbacea rizomatosa del Nuovo Galles del Sud. Come ci ricorda Endlicher, Cunnigham la raccolse all'inizio del suo soggiorno australiano, nel 1818, "in campi aridi nei pressi delle Blue Mountains". E' una perenne cespitosa con foglie lineari, infiorescenze ascellari di piccoli fiori bianchi a stella con perianzio formato da sei tepali liberi, sei stami inseriti alla base con filamenti lunghi quanto i tepali. E' endemica delle Blue Mountains settentrionali; eliofila, tende a formare tappeti espandendosi con i rizomi. Qualche informazione in più nella scheda. Per gli uomini del Rinascimento nati al di là delle Alpi, adottare uno pseudonimo classico era quasi un obbligo, soprattutto se il loro nome suonava barbaro a orecchie latine: così Philipp Schwarzerdt divenne Filippo Melantone, e, tra i botanici, Hieronimus Bock divenne Tragus e Jakob Dietrich di Bergzabern si trasformò in Tabaernemontanus. Giunto a Firenze negli ultimi anni del regno di Cosimo I, anche il "simplicista" (ovvero esperto di piante medicinali) Jodocus de Goethuysen adottò un nome più pronunciabile da bocche italiane, facendosi chiamare Giuseppe Casabona o Benincasa. Grande raccoglitore di piante, è noto soprattutto per un viaggio che nel 1590 lo portò a Creta, dove fece importanti raccolte. Al suo ritorno divenne prefetto dell'orto dei semplici di Pisa. E fu appunto uno dei suoi successori, il botanico fiorentino Gustavo Savi, a celebrarlo con la dedica del genere Benincasa (Curcubitaceae). 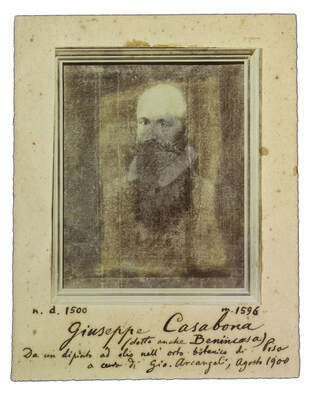 Un simplicista viaggiatore, dall'Italia a Creta Per i naturalisti del Cinquecento, l'Italia era la meta più ambita: era qui che i medici umanisti avevano riscoperto gli antichi, era qui che erano nati i primi orti botanici, era qui che una natura generosa elargiva tesori botanici a non finire, senza dimenticare che la penisola era anche il punto d'arrivo delle piante del Mediterraneo orientale, alcune delle quali vi si erano da lungo tempo naturalizzate. I collezionisti fiamminghi e tedeschi vi inviavano i loro emissari a cercare piante per arricchire i loro giardini; molti giovani medici venivano a perfezionarsi a Padova, o almeno a visitare i nuovi orti botanici, o magari ad erborizzare in luoghi presto celebri in tutta Europa come il Monte Baldo. Qualche "oltremontano", qualsiasi fosse il motivo che l'aveva portato in questa terra promessa della botanica, vi trovava lavoro e vi piantava radici. E' il caso del prussiano Melchiorre Guilandino, il secondo prefetto dell'orto patavino, e - con un percorso diverso - del fiammingo Jodocus Goedenhuyse (o Goethuysen), quinto prefetto di quello di Pisa. Non ne conosciamo la data di nascita e non sappiamo come e quando sia arrivato in Italia, forse adolescente. Al contrario di Guilandino, non era medico, anzi non possedeva una formazione né umanistica né universitaria: era un "pratico", un giardiniere e simplicista, ovvero erborista ed esperto di piante medicinali. Probabilmente intorno al 1570 (forse quindicenne) entra al servizio del nobile fiorentino Niccolò Gaddi, amico e consulente di Cosimo I per le sue collezioni d'arte, che possedeva un rinomato giardino noto come "paradiso dei Gaddi" per la ricchezza di piante e la raffinatezza degli ornamenti. Qui Goedenhuyse fa il suo apprendistato e incomincia a farsi chiamare con un nome meno ostico per bocche e orecchie italiane, Giuseppe Casabona, o anche Benincasa. Per incarico di Gaddi intraprende le prime escursioni botaniche che lo portano sul monte Pisano, nel Livornese e a Barga. Intorno al 1578, passa al servizio del granduca Francesco I, appassionato di chimica e arti sperimentali, lavorando dapprima nel giardino del Casino poi in quello detto "delle Stalle", ovvero nel giardino dei semplici fondato da Luca Ghini per Cosimo I. Ormai è un simplicista rinomato e per arricchire le collezioni ducali intraprende una serie di spedizioni sempre più a largo raggio: nell'estate-autunno del 1578 visita le Alpi Apuane, risalendo fino ai confini con la Liguria e il Piemonte; tra maggio e giugno 1579 è la volta di Grossetano, Argentario, Piombino e isola d'Elba, quindi nuovamente delle Apuane; nella primavera 1581 visita il Veneto (Padova, Bassano, Vicenza) spingendosi fino al Trentino; nell'estate 1583 un lungo giro lo vede in Garfagnana, nelle montagne del Parmense, sui colli Euganei, sul monte Summano, quindi a Padova e Venezia. Secondo Olmi, viene probabilmente anche coinvolto nelle "attività distillatorie" delle fonderie medicee, dove si producevano sostanze medicamentose sia per l'uso della famiglia granducale, sia come prestigiosi doni ai potentati d'Europa. Come abilissimo raccoglitore e scopritore di piante rare, che scambia all'occasione con altri studiosi (anche se sembra con una certa riluttanza) incomincia a corrispondere con naturalisti del calibro di Aldrovandi e Pinelli in Italia, Camerarius il giovane e Clusius al di là delle Alpi. Gli ultimi due lo mettono in contatto con il loro protettore Guglielmo IV di Assia-Kassel: forse non gli spiacerebbe passare al suo servizio, visto il misero stipendio e il crescente disinteresse per gli orti botanici da parte di Francesco I. Con l'ascesa al trono granducale di Ferdinando I, la sua situazione però migliora: il nuovo granduca fa costruire una comoda casa per il suo simplicista e la sua famiglia (sposato con una fiorentina, Casabona ne ha diversi figli) e il giardiniere-erborista fiammingo riprende a viaggiare, anche per rifornire i nuovi giardini di Villa Medici a Firenze: nell'estate del 1588 torna in Veneto per esplorare i monti dei territori della Repubblica, incluso il monte Baldo; tra i suoi accompagnatori, Girolamo Cappello, fratello della defunta granduchessa di Toscana Bianca, che gli fornirà l'occasione del viaggio a Creta. Nell'aprile 1590, lo troviamo all'orto botanico di Pisa, allora diretto da Lorenzo Mazzanga, forse impegnato in lavori che preludono al trasferimento nella nuova sede; nell'estate di quell'anno visita la Liguria, Monaco e Nizza, quindi si sposta a Venezia per affrontare il suo viaggio più importante: quello a Creta, ordinatogli dal granduca per "cercare le piante più eleganti e finora sconosciute in Europa e portarle a Firenze". Di passaggio a Padova, cerca di convincere il nipote di Camerarius, Joachim Jungermann, ad accompagnarlo. Ma il giovane tedesco (purtroppo per lui, visto che è destinato a morire mentre si reca a Costantinopoli) rifiuta. Casabona salpa da Venezia il 17 settembre 1590, imbarcandosi sulla nave che porta a Candia il nuovo governatore, appunto Girolamo Cappello. Durante il viaggio, esplora varie località costiere di Istria, Dalmazia e Albania, e il 22 novembre sbarca a Candia. Da quel momento, per quasi un anno, batterà l'isola in lungo e in largo, andando "per boschi et monti et circando simplici". Ne raccoglie più che può e alcuni li fa disegnare da Georg Dyckman, un mercenario tedesco al servizio della Serenissima che aveva qualche abilità artistica (ne rimangono 35 nel codice 464 conservato presso l'orto botanico di Pisa). Anche se l'erbario cretese non ci è giunto, siamo relativamente informati sulle sue attività grazie alle lettere inviate al granduca, a funzionari medicei, a diversi nobili personaggi di cui cerca i favori, ma soprattutto agli amici naturalisti Clusius, Camerarius e Aldrovandi. Di nuovo in Italia nel novembre 1591, l'anno successivo è nominato prefetto dell'orto di Pisa, anche se non è né medico né laureato: segno della grande stima in cui lo tiene il granduca, che gli affida il trasferimento delle piante nella nuova sede, quella attuale di via Santa Maria. Un lavoro spossante che si conclude nel 1595. Ne è testimonianza ancora il codice 464 che contiene 69 disegni a penna di attrezzi di giardinaggio e progetti di aiuole e labirinti. Casabona muore alla fine di quell'anno, dopo un ultimo viaggio autunnale in Corsica.  Zucche d'Oriente Fu il botanico fiorentino Gaetano Savi, prefetto dell'orto di Pisa a partire dal 1814, a voler ricordare il suo antico predecessore con la dedica del genere Benincasa (una forma alternativa del cognome italianizzato del nostro, molto meno usata di Casabona). Questo piccolo genere della famiglia Cucurbitaceae comprende solo due specie di zucche, diverse per dimensioni e caratteristiche ma entrambe coltivate e consumate in Asia. B. fistulosa (sin. Praecitrullus fistulosus), nota con il nome indiano tinda, ma anche come zucca indiana, zucca o melone tondo indiano, zucca mela, nativa dell'India e della Tailandia, è una liana annuale con foglie profondamente dentate e molto pelose che produce piccole zucche quasi tonde dal diametro di 4-8 cm, molto popolari in India e Pakistan come ingredienti di curry e altri piatti salati; se ne consumano anche i semi. Più importante nella cucina orientale è B. hispida, nota come zucca cerosa o zucca invernale, forse originaria di Malaysia, Nuova Guinea, Australia orientale e delle isole del Pacifico, ma introdotta in Asia orientale già in epoca preistorica; è particolarmente popolare in Cina. Come le altre zucche, anch'essa è una liana annuale a rapida crescita, che può raggiungere i 6 metri, con grandi foglie intere con cinque lobi poco accentuati, grandi fiori gialli maschili e femminili, questi ultimi seguiti da grandi frutti ovoidali, allungati o cilindrici lunghi anche 80 cm. Sono ricoperti di peli ispidi e urticanti, che una volta eliminati lasciano il posto a una superfice lucida e cerosa. La polpa è bianca, croccante, ma quasi insapore. Si conserva per molti mesi, da cui il nome zucca invernale. E' l'ingrediente di innumerevoli piatti nelle cucine orientali, sia salati come zuppe e stufati, sia dolci; in Cina i canditi di B. hispida sono consumati nelle festività del Capodanno e costituiscono il ripieno tradizionale dei mooncake. Nel 1978, l'astronomo russo Nikolaj Stepanovič Černych scopre un nuovo asteroide della fascia principale; decide di battezzarlo 3195 Fedchenko in onore di una eccezionale famiglia di scienziati: l'esploratore, glaciologo, zoologo e antropologo Aleksej Pavlovič Fedčenko; sua moglie, la botanica Ol'ga Aleksanderovna Fedčenko; e il figlio di entrambi, Boris Alekseevič Fedčenko, anch'egli botanico. Tutti e tre furono scienziati eminenti, anche se la figura più affascinante è probabilmente Ol'ga, coraggiosa compagna d'avventura del marito prima, tenace curatrice del suo lascito dopo l'improvvisa morte di lui, ma soprattutto grande botanica, la prima donna a studiare le piante in modo professionale nel suo paese, esperta di fama mondiale della flora del Turkestan. Esploratori della ricca flora dei monti dell'Asia centrale, madre e figlio sono ricordati anche da numerosi eponimi: fedtschenkoi o fedtschenkoanus in onore di Boris, fedtschenkoae o più spesso olgae in onore di Ol'ga, che è anche celebrata dall'unico genere valido dedicato al trio: il genere Olgaea, che raggruppa una quindicina di specie di grandi cardi asiatici.  Una coppia nella vita e nella scienza Nella Russia degli zar, l'Università era preclusa alle donne. Tuttavia Ol'ga Aleksandrovna Armfeld (1845-1925) poté giovarsi di un ambiente familiare eccezionalmente aperto e stimolante. Suo padre, Aleksandr Osipovič Armfeld, discendente da una famiglia di origine tedesca, era uno stimato professore di medicina legale all'Università di Mosca, e dal 1838 svolgeva anche il ruolo di ispettore dell'Istituto Nikolaevskij, una scuola secondaria per ragazze di buona famiglia che preparava all'insegnamento. La madre Anna Vasilievna Dmitrovskaja, che a sua volta era stata educata nel famosa scuola femminile Ekaterinskij, era l'animatrice di un frequentatissimo salotto, uno dei centri della vita artistica e culturale della città, con ospiti del calibro di Gogol', Lermontov e Lev Tolstoj. Insieme alle sorelle, Ol'ga (era la terza di una nidiata di ben nove tra figli e figlie) inizialmente venne educata in casa, ma nel 1857, a dodici anni, iniziò a frequentare l'Istituto Nikolaevskij, concentrandosi soprattutto sulle lingue straniere, la musica, il disegno e la pittura. Nel curriculum le scienze naturali, troppo "maschili", non erano previste, ma Ol'ga le scoprì e se ne innamorò durante i soggiorni estivi nella tenuta di famiglia a Možajsk. Incominciò a collezionare minerali, conchiglie, insetti e uova d'uccelli, e creò il suo primo erbario, così ben fatto che Nikolaj Kaufman lo incluse nella sua Moskovsakaja flora: un risultato notevole per una ragazzina sedicenne che stava studiando la botanica da autodidatta, traducendo le descrizioni dai grandi repertori stranieri. Nel 1864 Ol'ga si diplomò con il grado di candidat, e rimase al Nikolaevskij come insegnante di lingue. Lo stesso anno (all'epoca aveva diciannove anni) fu tra i fondatori della Società degli amanti delle scienze naturali, antropologia, etnografia (più tardi Società delle scienze naturali di Mosca), nota con la sigla OLEAE, un'associazione sorta attorno all'Università di Mosca tra i cui soci figuravano scienziati ma anche colti dilettanti. Incominciò anche a collaborare come volontaria al Museo di zoologia, aiutando a tenere in ordine le collezioni, traducendo in russo testi scientifici dal francese, dal tedesco, dall'inglese, curando la corrispondenza con studiosi europei e disegnando illustrazioni naturalistiche. Un altro dei fondatori dell'OLEAE era Aleksej Pavlovič Fedčenko (1844-1873), un giovane naturalista che si era appena laureato all'Università di Mosca. Aleksej era nato a Irkustsk, in Siberia, ma nel 1860 si era trasferito a Mosca, dove già viveva un fratello maggiore; insieme a lui, nel 1863 Aleksej fece la sua prima escursione scientifica nella regione dei laghi salati della Russia meridionale, appassionandosi di entomologia e raccogliendo una notevole collezione di imenotteri e ditteri, oggetto della sua prima pubblicazione. Dopo la laurea, entrò al Nikolaevskij come insegnante di scienze naturali. Ol'ga e Aleksej si innamorarono e divennero una coppia di scienza e di vita. Nel 1867 si sposarono. Nel frattempo, su richiesta del governatore del Turkestan Kaufman, l'OLEAE aveva varato una spedizione scientifica in quella regione recentemente annessa all'Impero russo e decise di affidarne la direzione a Aleksej Fedčenko, la persona più indicata per la vastità degli interessi che spaziavano dalla zoologia alla geologia all'antropologia. Ol'ga volle accompagnarlo, come membro ufficiale ma non pagato della spedizione. Era una decisione inaudita: non solo nessuna donna russa prima di lei aveva partecipato a una grande spedizione scientifica, ma il territorio da esplorare era particolarmente difficile e pericoloso. Largamente inesplorato, impervio, con una popolazione per lo più ostile agli occupanti russi, era anche un luogo strategico in cui si incontravano (e scontravano) le aspirazioni russe e quelle britanniche alla base del "grande gioco". I Fedčenko si prepararono seriamente alla missione visitando musei e collezioni in patria e all'estero. Il viaggio di nozze li portò in Finlandia e in Svezia. Infine, nell'ottobre del 1868 partirono per il Turkestan: Aleksej si sarebbe occupato della geografia, della zoologia, dell'antropologia; Ol'ga della botanica, delle carte e delle illustrazioni. All'epoca anche i collegamenti con quella remota regione erano difficili, e il viaggio in vettura di posta richiese più di cinquanta giorni. La spedizione vera e propria iniziò dalla valle dello Zeravshan (attuale provincia di Samarcanda nell'Uzbekistan), da pochissimo annessa alla Russia; i Fedčenko si muovevano a cavallo, accompagnati da una scorta di cosacchi. Dopo aver esplorato le aree attorno alle città di Tashkent e Samarcanda, si spostarono nel deserto del Kizilkum, il vastissimo bassopiano arido che separa i bacini dell'Amu Darya e del Syr Darya, al confine tra Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. L'esplorazione continuò con i Monti Zeravshan, la fertile valle di Fergana e i Trans-Alaj, la catena dorsale che separa la valle dell'Alaj dal Pamir. I Fedčenko si muovevano tra scenari mozzafiato, con laghi, ghiacciai immensi e cime che superano i 7000 metri d'altitudine. Aleksej scoprì (e Ol'ga disegnò) la vetta maggiore del sistema, il Monte Kaufman (dal nome del governatore del Turkestan), poi Picco Lenin e oggi Picco Ibn Sina (7134 m sul livello del mare). Avrebbero voluto proseguire per il Pamir, il "tetto del mondo", che faceva sognare gli europei fin dal tempo di Humboldt. Ma dovettero tornare indietro: non aveano più provviste ("abbiamo fatto lo sciopero della fame per due giorni", annotò Aleksej). La spedizione era finita. Dopo tre anni esatti dalla partenza, nel novembre 1871 i Fedčenko erano di ritorno a Mosca con un immenso bottino; le sole piante raccolte da Ol'ga erano più di 1500, con molte specie nuove per la scienza. Iniziava il lavoro per la pubblicazione dei risultati. Nel dicembre 1871 Aleksej presentò alla Imperiale società geografica russa una relazione che destò sensazione per le informazioni inedite sul Pamir. Grande interesse fu suscitato anche dal padiglione dedicato al Turkestan, allestito dai Fedčenko nel 1872 per l'Esposizione politecnica panrussa di Mosca. Subito dopo, i coniugi partirono per un viaggio di studio in Europa occidentale. La prima tappa fu la Francia, quindi Lipsia, dove a Aleksej fu offerto un lavoro nel laboratorio dell'Università e Ol'ga seguì lezioni di botanica. Proprio a Lipsia, a dicembre, nacque l'unico figlio della coppia, Boris. Nell'estate, con il neonato si spostarono a Heidelberg e quindi in Svizzera, dove Aleksej intendeva studiare i ghiacciai per prepararsi a una nuova spedizione nel Pamir. Il 2 settembre 1873, accompagnato da due guide locali, Aleksej mosse da Chamonix per raggiungere il ghiacciaio del Gigante. Proprio mentre si trovavano sul ghiacciaio, il tempo peggiorò all'improvviso e Fedčenko ebbe un malore. Le guide, piuttosto inesperte e a loro volta esauste, decisero di lasciarlo a se stesso e scesero in cerca di soccorsi. Quando questi arrivarono, lo trovarono già morto. Ol'ga era invece convinta che fosse ancora vivo, e che se le autorità locali avessero inviato un medico, avrebbe potuto essere salvato. Al momento della morte, Aleksej Pavlovič aveva 29 anni. Fu sepolto a Chamonix e sulla sua tomba Ol'ga fece collocare una lapide con l'epigrafe "Dormi, ma le tue fatiche non saranno dimenticate".  Vedova, madre, ma soprattutto botanica! Subito dopo la mesta cerimonia, Ol'ga ritornò a Mosca con il piccolo Boris. Negli anni successivi, una serie di sventure colpì la famiglia Armfeld; la più dolorosa fu l'arresto della sorella minore Natal'ja, impegnata nel movimento populista, seguito dalla deportazione in Siberia e dalla morte. Le condizioni economiche di Ol'ga Fedčenko peggiorarono, e la donna fu costretta a mantenere se stessa e il figlio con una modesta rendita. Ancora nel 1873, pubblicò il suo primo lavoro: la traduzione di Sketch of the geography and history of the Upper Amu-Daria di Henry Yule, con le note di Aleksej. Un lavoro eccellente che le guadagnò una medaglia della Società Geografica. Molto successo godettero anche i suoi disegni e le sue vedute dei monti del Turkestan, Nonostante le difficoltà personali, Ol'ga si era data un compito sacro: assicurare la catalogazione, lo studio e la pubblicazione dei materiali raccolti durante la spedizione in Turkestan. Aleksej aveva fatto in tempo solo a scrivere Viaggio in Turkestan (che fu pubblicato nel 1875). Nella Russia di fine Ottocento, era impensabile che una donna dirigesse un lavoro così impegnativo e così costoso. Tuttavia il presidente dell'OLEAE riuscì a convincere il governatore Kaufman che la signora Fedčenko era l'unica a poter garantire il successo dell'impresa; ufficialmente, a curare la pubblicazione fu un comitato editoriale ad hoc, ma Ol'ga ne faceva parte ed era lei a coordinare tutte le attività e a corrispondere con i diversi autori coinvolti nel progetto. Solo grazie al suo impegno e alla sua perseveranza, tra il 1874 e il 1902 uscirono i venti volumi dedicati alla spedizione, con le descrizioni della geografia, della geologia, della flora e della fauna della regione. I volumi dedicati alle piante si devono a Ol'ga Fedčenko, che ormai era una botanica internazionalmente riconosciuta. In questi anni, si occupò anche dell'erbario dell'Orto botanico dei farmacisti di Mosca e pubblicò una catalogo dei muschi dell'Orto botanico di San Pietroburgo. Ma Ol'ga aveva ancora un sogno: tornare in Pamir e riprendere quel viaggio interrotto. Per tornare sul campo dovette aspettare quasi vent'anni, fino al 1891. Ora accanto a lei c'era un nuovo compagno: suo figlio Boris, che si era appena iscritto all'Università di Mosca dove studiava botanica. Il loro primo viaggio, tra il 1891 e il 1892, li portò negli Urali sudoccidentali, una regione con caratteristiche geologiche e una flora molto varia, dalle comunità delle steppe a quelle di alta montagna. L'anno dopo erano in Crimea, e quello successivo nel Caucaso. Nel 1897 (adesso Boris era assistente all'Università di Mosca) madre e figlio andarono nel Tian Shan. Ol'ga trascorse i due anni successivi a studiare le collezioni degli orti botanici e degli erbari dell'Europa occidentale, inclusi quelli di Parigi, Berlino e Londra, mentre Boris veniva assunto come botanico principale dell'Imperiale orto botanico di Pietroburgo. Finalmente, nel 1901 i Fedčenko poterono intraprendere la sognata esplorazione del Pamir. A cinquantacinque Ol'ga ritrovava i paesaggi che l'avevano affascinata quando era una giovane donna. La regione era ancora largamente inesplorata e sottoposta all'occupazione militare, ma era divenuta meno irraggiungibile, grazie alla ferrovia che ora arrivava a Tashkent. La spedizione durò cinquantadue giorni e li portò fino al confine dell'Afghanistan. Ol'ga cavalcò per intere giornate, riposandosi il minimo indispensabile, e sostentandosi con tè e pane secco. I risultati della spedizione furono pubblicati da Ol'ga Fedčenko in Flora Pamira (1903-1905) e Definizione delle piante del Pamir (1910). A quattro mani con Boris è l'imprescindibile Conspectus Florae Turkestanicae (1913), pubblicato contemporaneamente in russo e in tedesco, che copre 4145 specie. Adesso Ol'ga viveva con suo figlio a San Pietroburgo, dove dal 1905 Boris era diventato capo dell'erbario (il cui fiore all'occhiello erano proprio le collezioni dei Fedčenko), ma soggiornava spesso nella tenuta degli Armfeld a Možajsk. Qui, a partire dal 1895, madre e figlio avevano creato un eccezionale orto botanico privato, chiamato Ol'gino: era un giardino di acclimatazione, dove coltivavano e studiavano le piante raccolte durante le spedizioni; erano anche molto generosi nel distribuirne i semi ad altri orti botanici. Le piante preferite di Ol'ga erano le Iris, gli Allium e gli Eremurus. Nel 1906 Ol'ga divenne membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo: la seconda donna, e la prima naturalista, ad ottenere questo onore. Seguirono ancora due viaggi nell'amato Turkestan, sempre con Boris, uno nel 1910 e l'altro nel 1915. Alla vigilia della guerra, nel corso del suo ultimo viaggio in Europa, visitò anche l'Italia e erborizzò nei dintorni di Napoli. Nonostante la salute declinante e i rovesciamenti politici, rimase attiva fino alla morte nel 1921. Aveva appena fatto in tempo a pubblicare il suo sessantaduesimo lavoro, una monografia sull'amato genere Eremurus. Una sintesi della vita della prima botanica professionista russa nella sezione biografie. Per concludere, qualche riga su Boris Alekseevič Fedčenko, a sua volta uno dei più importanti botanici della sua generazione. Come ho già detto, nel 1902 era stato nominato curatore dell'erbario dell'Orto botanico di San Pietroburgo; gli fu affidata anche la direzione della rivista dell'Istituto, Bulletin of the Imperial Institute. Nel 1908, insieme al micologo A. A. Elenkin e al botanico A. F. Flerov, iniziò a pubblicare una rivista indipendente, Journal Russe de Botanique, che uscì fino al 1915, quando fu costretto a chiudere in seguito allo scoppio della Prima guerra mondiale. Sempre con Flerov, tra il 1908 e il 1910 pubblicò Flora Evropejskoj Rossii ("Flora della Russia europea"), che contiene 3.542 nuove specie, e una flora dell'Oka. Questi volumi furono criticati da alcuni colleghi per le descrizioni essenziali; era una scelta voluta, per mantenere loro un formato tascabile, che li rese un bestseller tra appassionati e escursionisti, Negli anni '20, Fedčenko fu impegnato in escursioni sul campo nella Russia asiatica, grazie alle quali poté completare Flora Asiatskoj Rossii "Flora della Russia asiatica" (1912-1924), ancora con Flerov. Nel 1931, quando l'Orto botanico e il Museo Botanico di Leningrado vennero fusi per creare l'Istituto Komarov, sotto la direzione dello stesso Vladimir Komarov, Fedčenko lo sostituì come editore capo della grandiosa Flora dell'Unione sovietica, di cui curò diversi volumi fino alla sua morte nel 1947.  Olgaea, un ritratto vegetale? Aleksej Pavlovič Fedčenko era soprattutto uno zoologo ed è onorato dall'epiteto fedtschenkoi (la barbara grafia si deve alla trascrizione tedesca del cirillico) di alcune specie di animali; come geografo e glaciologo, a ricordarlo è soprattutto il ghiacciaio Fedčenko, il maggiore del Pamir, anzi il più grande al di fuori dei Poli, scoperto nel 1878. Le numerose piante con nome specifico fedtschenkoi o più raramente fedtschenkoanus sono invece dedicate a suo figlio Boris. Probabilmente la più famosa è Kalanchoe fedtschenkoi, una specie malgascia che nel 1915 fu dedicata dallo scopritore Perrier de la Bâthie al "sapiente e gentile dottor Fedčenko dell'Orto imperiale di San Pietroburgo". Nel 1941 Kudrjasev gli dedicò inoltre il genere Fedtschenkiella, oggi sinonimo di Dracocephalum. Moltissimi onori sono giustamente andati a sua madre Ol'ga Armfeld Fedčenko, una grande botanica di fama europea. Il primo omaggio venne nel 1878 da Regel, il botanico tedesco che dirigeva l'orto botanico di San Pietroburgo, con Rosa fedtschenkoana, una bellissima specie nativa dalle regioni coraggiosamente esplorate da Ol'ga e Aleksej. Nel 1882 replicò con il genere Fedtschenkoa, oggi sinonimo di Strigosella. La maggior parte delle piante che la ricordano hanno però una denominazione basata sul suo nome personale: sono un centinaio le specie di trenta famiglie diverse che portano in suo onore l'eponimo olgae. Nella maggior parte dei casi, si tratta di piante delle steppe e delle montagne dell'Asia centrale, da lei scoperte nel corso dei suoi viaggi. Tra di esse, non poteva mancare Eremurus olgae, un altro omaggio di Regel. Non fanno eccezione alcune specie del genere Olgaea, omaggio postumo di M. M. Ilijn (1922). Questo piccolo genere di cardi della famiglia Asteraceae comprende infatti una quindicina di specie distribuite tra l'Asia centrale, l'Himalaya e le aree temperate dell'Asia orientale; ma il loro territorio di elezione, il centro di diversità, sono proprio le impervie montagne dell'antica regione del Turkestan, oggi divisa tra varie repubbliche. Sono erbacee perenni piuttosto imponenti, assai ramificate e piuttosto spinose, con fiori viola o blu che ricordano quelli dei carciofi, adattate a resistere all'aridità e a condizioni climatiche estreme, con inverni glaciali ed estati torride. Sono piante bellissime e austere, che credo non sarebbero spiaciute alla tenace e coraggiosa dedicataria, di cui potrebbero anche essere un occulto ritratto vegetale. Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1805, nel momento di massima ascesa dell'astro napoleonico, lo zar Alessandro I e i suoi consiglieri guardano a Oriente. E' in questo contesto che, con enorme spesa, parte per la Cina un'elefantiaca ambasceria, nella speranza di impressionare i cinesi e di strappare condizioni più favorevoli per il commercio russo. Sarà un disastro: l'ambasciatore Jurij Golovkin e il suo seguito non vanno oltre Urga (oggi Ulan-Bator), capitale dello stato tributario della Mongola. A fermare il conte Golovkin, esattamente come lord Macartney dodici anni prima e lord Amherst dieci anni dopo, il rifiuto di eseguire il kotow, l'umiliante cerimonia della prosternazione al figlio del Cielo. Dal punto di vista scientifico, però, le cose vanno diversamente. I numerosi studiosi che accompagnano l'ambasceria, non potendo proseguire per la Cina, si sparpagliano per la Siberia e fanno incontri inaspettati: Julius Klaproth getta le basi per una brillante carriera di orientalista; lo zoologo Mikhail Adams guida una spedizione nella Siberia orientale, risale la Lena e scopre il primo esemplare intatto di mammut; il botanico Johann Redowsky vorrebbe andare in Kamčatka ma ad attenderlo c'è la nera signora. Anche per Joseph Rehmann, il medico della spedizione, il viaggio non è inutile: si impegna nella vaccinazione antivaiolosa, studia le acque termali, il commercio del rabarbaro e del muschio bianco e alcune erbe medicinali siberiane; ma soprattutto, incontra gli ospitali buriati e i loro medici-lama, depositari della tradizione medica tibetana. Un'esperienza fondamentale che lascerà un'impronta nella sua futura attività terapeutica. Tra le erbe usate nella medicina tibetana (e cinese) c'è anche Rehmanniae radix, ovvero la radice essiccata di Rehmannia glutinosa. Dunque la dedica di questo genere a colui che fu uno dei primi ad interessarsi di questa tradizione medica risulta assai opportuna. Russia e Cina, l'incontro atteso che non ci sarà Nei primi anni del regno di Alessandro I, la Russia incominciò a guardare ad Oriente, anche come reazione all'espansione francese, che stava erodendo la sfera d'influenza russa nell'Europa orientale. Insieme alla spedizione Krusenstern e al contestuale invio di una delegazione diplomatica in Giappone (ne ho parlato qui), il terzo tassello della politica orientale russa fu una grande ambasceria in Cina, che nelle intenzioni dello zar e dei suoi consiglieri avrebbe dovuto ridisegnare totalmente le relazioni diplomatiche e commerciali tra i due paesi. Il vecchio trattato di Khiakta, che prevedeva che tutti i commerci sino-russi transitassero da questo posto di frontiera e un'unica carovana di mercanti raggiungesse Pechino ogni tre anni, stava ormai stretto alla Russia, che ora controllava l'intera Siberia orientale e aveva appena creato promettenti avamposti in Alaska. Il ministro del Commercio Nikolaj Rumjancev e il vice ministro degli Esteri Adam Czartoryski fissarono obiettivi molto ambiziosi: la libera navigazione sul fiume Amur, che avrebbe assicurato un facile collegamento tra Irkutsk e il golfo di Okhotsk; una sede diplomatica permanente a Pechino; una seconda stazione commerciale in Mongolia, sul fiume Buktharna; l'autorizzazione a commerciare direttamente nel porto di Canton, senza passare attraverso intermediari britannici. Ancor meno realisticamente, speravano che la Cina concedesse ai Russi l'apertura di una via commerciale che, attraverso il Tibet, raggiungesse l'India; tutto politico era poi l'obiettivo di riaprire il paese ai gesuiti. Czartoryski credeva fermamente nel progetto, e, consapevole delle difficoltà, lesse avidamente le relazioni della missione Macartney (fallita nel 1793 a causa del rifiuto del diplomatico britannico di eseguire il rituale kotow). Nella tradizione illuminista, volle che l'ambasceria fosse anche una spedizione scientifica, con la partecipazione di un nutrito gruppo dei studiosi scelti dall'Accademia delle scienze: tra di essi, l'astronomo Friedrich Theodor von Schubert, lo zoologo Michail Adams, il botanico Johann Redowsky, il mineralogista Lorenz von Pansner e l'orientalista Julius Klaproth. L'Accademia fissò anche gli obiettivi scientifici: quelli del botanico Redowsky prevedevano tra l'altro la raccolta di tutte le informazioni possibili sulla coltivazione del tè e l'acquisto di pianticelle, nella speranza di importare la coltivazione in Russia. Al gruppo degli scienziati, con il quale collaborò in vari modi, va aggiunto il medico ufficiale dell'ambasceria, il tedesco Joseph Rehmann. Come responsabile scientifico, Czartoryski nominò un connazionale, il conte polacco Jan Potocki (l'autore del celebre romanzo "gotico" Manoscritto trovato a Saragozza), uomo di cultura enciclopedica, curioso di tutto, che, come esperto viaggiatore, si ritagliò un ruolo di consulente del capo ufficiale della missione, il conte Jurij Golovkin. Superficiale, frivolo, arrogante, privo di tatto, costui era la classica persona sbagliata nel posto sbagliato. Nato in Svizzera da una famiglia immigrata, allevato a Parigi e imparentato con l'alta nobiltà di mezza Europa, non parlava una parola di russo e si circondava di aristocratici e profittatori del suo stesso stampo. Quando Potocki lo invitò a leggere gli scritti dei gesuiti e dei diplomatici che erano stati in Cina, rispose che non era necessario, perché "sotto qualsiasi cielo, non c'è nulla che valga di più di un buon cuoco e di vini pregiati". Contava di abbagliare i cinesi con "la magnificenza dell'equipaggio, il prestigio dello zar e il proprio talento" (le parole sono di A. Peyrefitte in L'impero immobile). L'ambasciatore pretese un seguito principesco che dilatò le spese (si calcola che la missione sia costata all'erario russo un milione di rubli) e il numero dei partecipanti, che superò le trecento persone. Pessima mossa, che nei cinesi non destò meraviglia ma sospetto. La notizia dell'enorme corteo, partito da San Pietroburgo nel maggio 1805, spinse l'interlocutore diretto dei russi, il wang di Urga (ovvero il principe tributario della Mongolia) a scrivere a Golovkin una serie di lettere in cui gli ingiungeva di ridurre il suo seguito a non più di settanta persone. Con un tira e molla tipicamente orientale, che costrinse la delegazione russa a sostare nei pressi di Khiakta per quasi tre mesi, alla fine i cinesi concessero una delegazione di centoventiquattro persone, a patto che l'ambasciatore si impegnasse formalmente ad eseguire il kotow. Il 18 dicembre il corteo russo varcò finalmente la frontiera cinese, salutato da fuochi d'artificio. Faceva così freddo che nelle tazze sulla superficie del tè appena versato si formavano cristalli di ghiaccio. I russi furono invitati a una festa all'aperto che si sarebbe tenuta due giorni dopo a Urga (l'attuale Ulan Bator). Golovkin si presentò accompagnato da una splendida cavalcata. Il wang lo condusse di fronte a un tavolo su cui ardevano incensi profumati, e lo invitò ad eseguire come lui la cerimonia del kotow. L'ambasciatore rifiutò: era disposto a prostrarsi di fronte all'imperatore, ma non a quel simulacro; sottoporsi a quel rito avrebbe significato equiparare lo zar di Russia, che egli rappresentava, a un vassallo della Cina, come lo stesso wang. Golovkin, mal informato dal suo servizio segreto, era convinto che si trattasse di un'alzata di ingegno del principe mongolo, e attese per venti giorni, in un clima glaciale da ogni punto di vista, che arrivasse la risposta ufficiale da Pechino. Che fu totalmente negativa: ai russi veniva ingiunto di sottomettersi, o di tornare indietro. A Golovkin e alla sua infreddolita compagnia non rimase che ritornare sui propri passi fino a Irkustk. L'imperatore Alessandro (da poco reduce dalla batosta di Austerlitz) non la prese bene: a Golovkin fu ordinato di rimanere in Siberia, e solo nell'autunno gli fu concesso di rientrare in Russia.  Un trio di medici e naturalisti in cammino verso la frontiera Insomma, sul piano diplomatico il fallimento fu totale. Non così su quello scientifico. Per i giovani studiosi che accompagnavano la missione, si trattò di una importante esperienza formativa, che alcuni di loro non vollero interrompere dopo la conclusione della missione ufficiale. Ad esempio, Julius Klaproth, che aveva appena ventidue anni al momento della partenza e stava apprendendo il cinese da autodidatta, si giovò moltissimo degli insegnamenti degli interpreti dell'ambasciata; durante il viaggio attraverso la Siberia e nei tre mesi trascorsi a Khakta, incominciò a studiare le lingue locali, a raccogliere materiali etnografici e riuscì anche a procurarsi molti libri. Così, al suo ritorno a Pietroburgo, fu ammesso all'Accademia delle Scienze come associato e immediatamente spedito nelle regioni caucasiche recentemente annesse all'Impero russo per studiarne i popoli e le lingue. Negli anni successivi, divenne uno dei più eminenti orientalisti europei. Ancora più inattesi gli incontri che attendevano i due naturalisti e il medico ufficiale della spedizione: Michail Adams, Johann Redowsky e Joseph Rehmann. Quando fu scelto per la missione come zoologo, Adams aveva venticinque anni, ma aveva già esperienza di ricerca sul campo. Nato a Mosca, ma di lingua madre tedesca (il suo nome di nascita era Johann Friedrich Michael Adam), adolescente studiò presso l'Accademia medico-chirurgica di San Pietroburgo e ventenne partecipò alla spedizione nel Caucaso diretta da Apollo Musin-Puškin e dal maresciallo von Bieberstein (1800-02); oltre che uno zoologo, era anche un eccellente botanico. I suoi due compagni di avventura appartenevano all'entourage del conte Aleksej Razumovskij, alla cui raccomandazione dovettero probabilmente la nomina rispettivamente a botanico e medico dell'ambasceria. Johann Redowsky, ventottenne, era un tedesco del Baltico nato a Memel, in Lituania. Aveva studiato a Königsberg e a Jena, dove si era laureato in medicina. Nel 1799 si trasferì a Mosca (prendendo il nome russo Ivan Redovskij) e nel 1803 fu assunto da Razumovskij prima come assistente poi come curatore del suo giardino botanico privato; situato a Gorenki, non lontano da Mosca, all'interno dell'immensa tenuta di famiglia, e fondato appena nel 1798, nell'arco di pochi anni divenne il più importante dell'Impero russo. Sotto la gestione di Redowsky, anche grazie ai numerosi contatti con botanici europei, le collezioni crebbero rapidamente, come risulta anche dal primo catalogo, da lui redatto nel 1803, in cui sono elencate 2486 specie. Il ventiseienne Joseph Rehmann, discendente da una illustre famiglia di medici, era nato a Donaueschingen nel Baden-Württemberg, dove il padre era il medico personale dei principi Fürstenberg; aveva però studiato a Vienna, dove si era laureato in medicina nel febbraio 1802. Fresco di laurea, era stato assunto come medico personale da Andrej Razumovskij, l'inviato russo alla corte di Vienna (nonché mecenate di Beethoven e dedicatario dei "Quartetti Razumovsky") e lo aveva accompagnato a Mosca, dove era entrato al servizio della sua famiglia. Entusiasta della nomina, Rehmann si affrettò a presentare al Collegio dei medici una memoria in cui proponeva di affiancare alla missione una campagna di vaccinazione antivaiolosa, soprattutto nelle aree della Siberia in cui la "felice scoperta" non era ancora sufficientemente praticata. Il progetto fu approvato, anche se fu respinta la sua richiesta di un secondo medico che potesse sostituirlo durante la permanenza in Cina. Nel corso del viaggio di avvicinamento alla frontiera, che toccò successivamente Kazan, Ekaterinburg, Krasnojarsk e infine Irkutsk, secondo le istruzioni ricevute, Rehmann visitò puntigliosamente gli ospedali militari e incoraggiò le vaccinazioni, praticandole egli stesso dove i medici locali erano troppo tiepidi. Con Redowsky e Adams formò una squadra molto affiatata: mentre lui si dedicava soprattutto ai suoi compiti medici, i due naturalisti misero insieme una notevole collezione botanica; da Irkustk, tra settembre e ottobre, visitarono le rive del lago Baikal, dove Redowsky raccolse semi per Gorenki. Durante la lunga sosta nei pressi di Kiatka, Rehmann, oltre a interrogare i mercanti locali sul commercio del rabarbaro e del muschio bianco, fu impegnatissimo nelle vaccinazioni, con l'aiuto di un abile chirurgo militare di nome Petrov. Fu grazie a quest'ultimo, che ne parlava la lingua e se ne era già conquistata la fiducia, che il medico tedesco incontrò i Buriati, la popolazione di origine mongola che viveva (e vive tuttora) lungo la frontiera tra Russia e Cina intorno al lago Baikal. Al contrario dei russi, spesso diffidenti verso la vaccinazione, i Buriati - consapevoli delle devastanti conseguenze del vaiolo - l'avevano accolta con entusiasmo. Così, tra ottobre e dicembre 1805, Rehmann vaccinò personalmente 792 persone, di cui 91 russi e gli altri buriati. Come egli racconta nella sua relazione al ministero dell'Interno, per questi ultimi la vaccinazione era una festa collettiva: "Quando arriva il vaccinatore, tutti i candidati del circondario si raccolgono nella casa di uno dei lama o dei taisha [ovvero i capi della comunità], vestiti con i loro abiti più belli, le donne e le ragazze adornate con una quantità di coralli; allora tutti quelli che non hanno mai avuto il vaiolo, giovani e vecchi, sono vaccinati in massa [...]. Venire a partecipare a questa operazione salutare è per loro una festa!" E prosegue lodando l'ospitalità di questo popolo che si dimostra molto più saggio e civile dei russi: "I personaggi più considerevoli mi sono sempre venuti incontro a cavallo. Appena entravo in una jurta, mi offrivano latte, acquavite e una specie di tè che mescolano con grasso e sale. E ogni volta che mi sono recato al tempio del Lama, sono sempre stato ricevuto al suono della musica del servizio dei loro dei. E' impossibile lodare a sufficienza la premura, l'ospitalità e la dolcezza di carattere di questo popolo". Dai Buriati, come medico Rehmann aveva anche altro da imparare. Il buddismo era arrivato nella regione nella seconda metà del Seicento, grazie ad alcuni lama tibetani che insieme alla religione avevano importato i principi della medicina tibetana. Benché le basi teoriche rimontassero al Collegio di medicina dei monasteri di Lhasa e Labrang, i medici-lama buriati avevano saputo adattare la farmacopea tibetana alle condizioni locali. Come spiegarono a Rehmann, l'80% degli ingredienti usati nella regione del Baikal erano di raccolta locale; inoltre le medicine, che potevano comprendere anche 40 diversi ingredienti, tenevano conto del clima, della dieta e del metabolismo dei pazienti. Rehmann fu così affascinato dalla sapienza medica dei dottori buriati da invitare uno di loro, Tsultim Tseden, a venire a studiare all'Accademia medico-chirurgica di San Pietroburgo, un progetto che non si realizzò a causa della morte di Tsultim. Inoltre acquistò una farmacia portatile contenente 60 semplici, si informò delle loro proprietà presso i medici buriati e cercò di identificare le sostanze con l'aiuto del suo amico Redowsky. Sperava anche di introdurre la vaccinazione antivaiolosa in Cina, nonostante sapesse che i cinesi di Canton si erano opposti ai medici inglesi che la praticavano. Da bravo illuminista, contava di convincerli con argomenti razionali: scrisse e fece tradurre da uno degli interpreti un proclama in cui raccontava la storia della scoperta e della diffusione della vaccinazione in tutti i paesi della Terra. 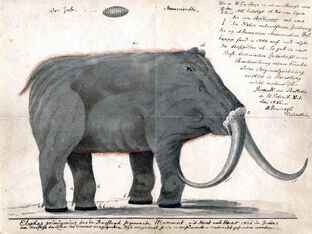 La spedizione continua: altri incontri inaspettati Anche il suo sogno, come quello di Golovkin, si infranse a Urga. I tre amici presero mestamente la via di Irkutsk insieme allo scornato ambasciatore. Lungo la strada, nel febbraio 1806, Rehmann studiò le acque minerali di Turkic, e, probabilmente con l'aiuto di Adams e Redovsky, la fauna ed la flora della regione circostante. Mentre una parte del corteo (tra cui una banda musicale al completo) riprendeva la via di Mosca, essi furono tra quelli che rimasero a Irkutsk con il seguito dell'ambasciatore, in attesa della primavera e di nuove istruzioni. Infine, dall'Accademia delle Scienze arrivò l'ordine di riprendere le ricerche: Adams avrebbe esplorato la Siberia orientale, per poi proseguire lungo la dorsale dei monti Stanovoy; Redowsky, accompagnato dal geodeta Ivan Kozevin, avrebbe dovuto raggiungere la Kamčatka dove si sarebbe unito ad alcuni membri della spedizione Krusenstern per un'ampia missione di tre anni nella penisola, lungo la costa pacifica, nelle Curili e a Sakhalin. Forse per farsi perdonare, l'ambasciatore Golovkin diede tutto il sostegno possibile a Redowsky, curando personalmente l'equipaggiamento di strumenti scientifici, polvere da sparo, denaro, merci da scambiare, doni per le popolazioni locali. Infine, il botanico fu pronto a partire a il 20 maggio. Secondo alcune fonti, Adams fece il primo tratto di strada con lui, ma è difficile pensarlo, visto che, dopo aver visitato le regioni di Nerčinsk e Tunkinskij, a giugno si trovava già a Jakustk, nella Siberia centrale. Fu qui che apprese che qualche anno prima presso la foce della Lena era stata rinvenuta la carcassa di uno strano animale conservato nel ghiaccio. Accompagnato da tre cosacchi, risali rapidamente il fiume, si recò sul posto e, anche se buona parte della carne nel frattempo era stata mangiata dai lupi o data ai cani, riuscì a recuperare lo scheletro quasi intatto e quasi 20 kg di peli del primo mammut rinvenuto intatto; spedito a San Pietroburgo, dove fu ricostruito da Tilesius, lo scheletro venne esposto nel gabinetto delle meraviglie dell'Accademia delle scienze, divenendone il reperto più celebre, con il nome di "mammut di Adams". L'anno successivo Adams scrisse un resoconto della spedizione e del ritrovamento, quindi terminò la sua carriera come professore di botanica presso l'Accademia medico-chirurgica di San Pietroburgo. Nel frattempo Redowsky, nella sua marcia di avvicinamento al Pacifico, esplorò la cresta di Aldan e la costa del Mare di Okhotsk, raccogliendo piante, pesci e campioni di minerali. Il 9 settembre era a Okhotsk, da dove spedì via mare il grosso delle attrezzature, intenzionato a raggiungere la Kamčatka via terra. All'inizio del 1807 si trovava a Gižiginsk, dove morì inaspettatamente l'otto febbraio. Sulla sua morte ci sono molte versioni: si sparse la voce che i locali, avendolo scambiato per una spia russa, lo avessero avvelenato con sublimato corrosivo; secondo altri, annegò mentre tentava di attraversare il fiume Gižiga; secondo Langsdorff, che avrebbe dovuto unirsi a lui in Kamčatka, si suicidò; altri ancora pensano a una malattia. L'unica certezza è che a soli trentun anni si spense una sicura speranza della botanica russa. Quanto a Rehmann, presumibilmente rimase con l'ambasciatore Golovkin fino all'autunno del 1806, visto che la sua relazione sulla campagna vaccinale è datata "Irkutsk, 25 settembre 1806". Tornato a Mosca, riprese i suoi doveri di medico della famiglia Razumovskij e aprì una piccola clinica privata, in cui sperimentava con alterno successo i rimedi appresi dai colleghi buriati e siberiani: la scorza del melograno come sostituto economico della corteccia di Cinchona; la Ballota lanata (oggi Panzerina lanata) come rimedio per l'idropisia associata a casi di cirrosi. Le sue esperienze in Siberia e in Mongolia sono anche alla base di una copiosa produzione di saggi: su un trattato cinese di ostetricia; sul commercio del rabarbaro e del muschio bianco; su un'epidemia di vaiolo bovino avvenuta i Siberia nel 1805-6. Il più interessante è indubbiamente quello dedicato alla farmacia portatile acquistata in Buriazia, con i nomi originali e traslitterati, un tentativo di identificazione (per circa il 50% dei semplici trattati) e informazioni su loro uso nella medicina tibetana. Si tratta del primo scritto occidentale dedicato a questa antica tradizione medica. Nel 1810, quando il suo patrono Aleksej Razumovskij fu nominato Ministro dell'Istruzione, Rehmann lo seguì a Pietroburgo. Poco dopo divenne uno dei medici personali dello zar Alessandro, che accompagnò in diversi viaggi all'estero. Nel 1817 fu nominato professore di farmacologia presso l'Accademia medico-chirurgica, dove ritrovò l'amico Adams. Più tardi divenne capo del servizio medico civile. Morì a San Pietroburgo di colera nel 1831. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Rehmannia, salute e bellezza in giardino La terminologia botanica ricorda in vario modo i tre amici. Ad Adams furono dedicati due diversi generi Adamsia, da Willdenow nel 1808 e da Steudel nel 1821, oggi rispettivamente sinonimi di Puschkinia (un genere creato proprio da Adams) e di Geum. E' ricordato però dall'eponimo di alcune specie, come il siberiano Rhododendron adamsii, che vive anche sulle sponde del lago Baikal. Redowsky fu invece ricordato da Chamisso, che dopo la sua morte pubblicò una parte delle sue raccolte botaniche, con il genere Redowskia, oggi sinonimo di Smelovskia. Lo ricordano però i nomi specifici di diverse piante, come Coriospermum redowskii, Erysimum redowskii, Rhododendron rodowskianum. L'unico ad essere omaggiato da un genere valido è dunque Joseph Rehmann, dedicatario di Rehmannia. La storia di questa dedica è anch'essa curiosa. Il primo a descrivere e nominare Rehmannia glutinosa, una specie molto importante della medicina tradizionale cinese, fu Joseph Libosch, medico personale dello zar Alessandro I, morto prima di poterla pubblicare (1824). Anni dopo il suo erbario e i suoi manoscritti furono esaminati da Friedrich Fischer e da Carl Anton Meyer, che pubblicarono genere e specie nel 1835. Entrambi medici dello zar, Libosch e Rehmann erano colleghi e sicuramente si saranno scambiati pareri medici e informazioni; ed è anche possibile che la radice di Rehmannia glutinosa, ovvero Radix Rehmanniae, sia una delle radici non identificate contenute nella piccola farmacia portatile buriato-tibetana. In ogni caso, la dedica di questo piccolo genere endemico cinese a un medico affascinato dalla tradizione medica cinese e tibetana è sicuramente azzeccata. Infatti Rehmannia glutinosa è una delle cinquanta erbe fondamentali della farmacopea cinese, che ne usa la radice, con proprietà antinfiammatorie e depurative. Nei nostri giardini, invece, da qualche anno è arrivata R. elata, spesso venduta con il nome un po' improprio "digitale cinese"; è una bellissima erbacea perenne semirustica con grandi fiori a campana rosa-porpora. In effetti, in passato il genere Rehmannia fu assegnato alla stessa famiglia e alla stessa tribù di Digitalis (famiglia Scrophulariaceae, tribù Digitalideae), ma non senza controversie; altri botanici infatti lo inclusero nelle Gesneriaceae. Più recentemente, sulla base delle analisi molecolari è stato trasferito nella famiglia Orobanchaceae, di cui costituisce uno dei soli tre generi non parassiti. Altre informazioni nella scheda. I maggiori risultati della spedizione "nuziale" in Brasile non furono raggiunti dagli scienziati austriaci (con l'eccezione del ribelle Natterer, che disobbedì agli ordini e rimase nel paese sudamericano quasi vent'anni), ma dai naturalisti bavaresi Spix e Martius. La loro fu una delle più fortunate e celebri spedizioni dell'epoca, seconda solo a quella di Bompland e Humboldt. Non solo i due amici ritornarono in patria con straordinarie collezioni, ma i loro studi successivi diedero un contributo eccezionale alla conoscenza della fauna e della flora del Sud America. Martius divenne uno dei botanici più importanti della sua generazione; la sua squisita Storia naturale delle palme è stata definita "la più superba trattazione delle palme che sia mai stata prodotta" e gli ha guadagnato il soprannome "padre delle palme". Quanto all'immensa Flora Brasiliensis, di cui fu il primo curatore e che coinvolse oltre sessanta botanici di diversi paesi, ancora oggi è il testo di riferimento per la flora brasiliana ed una delle opere più importanti della storia della botanica. I colleghi gli dedicarono molti generi, creando un nodo gordiano di sinonimi e omonimi che è stato risolto solo nel Novecento con la creazione del genere Martiodendron.  Un viaggio epico Verso la fine del 1816, il re di Baviera Massimiliano I Giuseppe fu invitato a un matrimonio: le nozze per procura dell'arciduchessa Maria Leopoldina d'Austria con l'erede al trono del Portogallo. A Vienna seppe che si stava preparando una grande spedizione scientifica che avrebbe accompagnato la principessa in Brasile. Il sovrano bavarese era di idee progressiste (era stato il principale alleato di Napoleone in Germania) ed era un grande ammiratore di Humboldt. Già da tempo pensava a una spedizione in Sud America che, partita da Buenos Aires, avrebbe dovuto dirigersi in Cile e in Perù, per poi rientrare in Europa imbarcandosi in Venezuela o in Messico. La situazione politica e difficoltà finanziarie lo avevano costretto a desistere. Ora si presentava l'occasione di riprendere quel progetto su nuove basi, aderendo all'iniziativa austriaca. Fu così che sull'Austria, salpata da Trieste il 10 aprile 1817, si imbarcarono anche due scienziati bavaresi, lo zoologo Johann Baptist Spix e il botanico Carl Friedrich Philipp Martius. Al momento della partenza, Spix aveva 35 anni ed era già uno studioso riconosciuto, allievo di Cuvier a Parigi e curatore delle collezioni zoologiche dell'Accademia delle scienze di Monaco di Baviera. Martius, che avrebbe compiuto 23 anni pochi giorni dopo la partenza da Trieste, era assistente all'orto botanico monacense. I due si erano conosciuti a Erlangen, la città natale di Martius, quando questi era uno studente diciottenne. Figlio del farmacista di corte, era stato introdotto alla botanica da un amico del padre, Johann von Schreber, uno degli ultimi allievi di Linneo. Dopo la morte di Schreber, la famiglia propose l'acquisto delle sue collezioni naturalistiche al re di Baviera; nel 1812, per condurre la trattativa venne inviata a Erlanger una commissione formata dal botanico ed entomologo Franz Paula von Schrank e da Spix. Entrambi furono colpiti dal giovane Martius, un brillante ragazzo prodigio, e ne raccomandarono l'ammissione come allievo all'Accademia delle Scienze di Monaco. Martius si trasferì nella capitale, dove nel 1814 si laureò in medicina e chirurgia e divenne assistente di Schrank all'orto botanico. Poco prima di partire per il Brasile pubblicò il suo primo lavoro scientifico, una monografia sulle crittogame dell'area di Erlangen. Il gruppo di Spix e Martius, insieme al professor Mikan, fu il primo a giungere in Brasile, nel luglio 1817. Nell'attesa dell'arrivo del resto della spedizione, i naturalisti incominciarono a prendere confidenza con la natura tropicale e incontrarono diversi membri della comunità tedesca di Rio, primo fra tutti il barone Langsdorff, la cui casa ai piedi delle colline alla periferia della città si trasformò nel loro quartier generale. Subito dopo aver assistito alle nozze di Leopoldina e don Pedro, Martius e Spix iniziarono le raccolte nelle immediate vicinanze della capitale, quindi trascorsero qualche giorno a Mandioca, la tenuta di Langsdorff a nord della baia di Guanabara; a novembre tornarono a Rio, dove appresero che il governo austriaco aveva deciso di dividere la spedizione in piccoli gruppi; da Monaco arrivò l'ordine di non protrarre il soggiorno in Brasile oltre due anni. L'otto dicembre, accompagnati dal pittore Thomas Ender, dal direttore delle miniere del Brasile Wilhelm von Eschwege e da un certo Dürming, console tedesco ad Anversa, i due bavaresi lasciarono Rio alla volta di Sao Paulo, dove arrivarono l'ultimo giorno dell'anno. Nel primi mesi del 1818 il gruppo esplorò il sud dello stato di Bahia, poi si spostò verso nordest per raggiungere la zona mineraria; a maggio, Ender, in seguito a una caduta da cavallo, si fratturò una gamba e fu costretto a rientrare a Rio in compagnia di Dürming. Il trio Martius, Spix e Eschwege continuò per Diamantina, Minas Novas e Montes Claros. Secondo gli accordi con gli austriaci, a questo punto avrebbero dovuto tornare a Rio, ma i due bavaresi decisero di continuare da soli. Salutato Eschwege, penetrarono nell'interno in direzione nord-nordovest fino a Carinhanha, punto di partenza per un ampio giro della Serra Geral, una delle catene costiere della Mata Atlantica; tornati a Carinhanha, raggiunsero la costa a el Salvador, dove si trovavano alla fine dell'anno. A febbraio 1819 ripartirono verso nord, percorrendo la parte settentrionale degli Stati di Bahia, Pernambuco e Piaui; l'attraversamento di questa zona estremamente arida fu uno dei momenti più duri dell'intero viaggio. All'inizio di maggio, a São Gonçalo do Amarante, nello stato di Cearà, Martius si ammalò gravemente. Una settimana dopo, Spix, che aveva contratto la bilharziosi, rischiò di morire. Appena si furono ripresi, si spostarono nel Maranhão e navigando lungo il Rio Itapicuru raggiunsero São Luis, la prima vera città che vedevano da mesi. Qui poterono spedire le collezioni a Rio, riscuotere le lettere di credito e mettere insieme i rifornimenti per la parte più eccitante dell'impresa: l'esplorazione del bacino del Rio delle Amazzoni. Il 20 luglio si imbarcarono per Belem. Dopo qualche giorno dedicato ad esplorare i dintorni della città e l'isola di Marajó, il 21 agosto erano pronti a ripartire. Viaggiando parte a dorso di mulo, parte in canoa, raggiunsero un ramo del Rio delle Amazzoni a Gurupà. Risalirono poi il fiume toccando Porto de Moz e Santarém e il 22 novembre erano a Manaus, alla confluenza con il Rio Negro. Navigarono poi lungo il Rio Solimões fino a Tefé, dove decisero di separarsi. Spix risalì il corso del Solimões fino a Tabatinga e rientrò a Manaus nel febbraio 1820, mentre Martius esplorava il Rio Japorà e a marzo si riuniva all'amico. Qualche giorno prima, la sua canoa si era rovesciata e aveva rischiato di morire annegato. Ad aprile i due ardimentosi naturalisti erano di nuovo a Belem e a giugno si imbarcarono per l'Europa con le casse delle raccolte e una coppia di ragazzi indios; il 23 agosto erano a Lisbona e prima di Natale a casa, a Monaco. Avevano percorso oltre 10.000 km, a piedi, a cavallo, a dorso di mulo, in canoa e raccolto oltre 3500 di esemplari di animali, da 25 a 30000 esemplari d'erbario ripartiti su oltre 7300 specie. La loro collezione mineralogica andò a costituire le basi della Mineralogische Staatssammlung di Monaco, così come le collezioni etnografiche quelle del Museum für Völkerkunde, oggi "Museo dei cinque continenti". 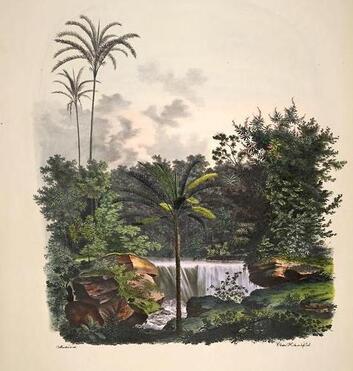 Due opere monumentali I due naturalisti furono ricevuti con grande onore dal re di Baviera. Entrambi furono nobilitati e ricevettero une pensione vitalizia. Nel 1826 Martius divenne professore di botanica all'Università di Monaco e dal 1832 direttore dell'Orto botanico. Intanto, i due amici lavoravano alacremente alla pubblicazione delle loro raccolte. A quattro mani scrissero il resoconto del loro viaggio, Reise in Brasilien, in tre volumi (1823, 1828, 1831). Spix morì mentre stavano preparando il secondo, ma Martius poté completare l'opera utilizzando le note proprie e del compagno. Morto a soli 45 anni nel 1826, Spix aveva fatto in tempo a scrivere quattro monografie, dedicate rispettivamente alle scimmie e ai pipistrelli, alle testuggini e agli anfibi, agli uccelli e ai serpenti raccolti durante la spedizione. Complessivamente descrisse da 500 a 600 specie, dando il nome a numerose specie nuove; alcune portano il suo nome, come la rarissima ara di Spix Cyanopsitta spixii che gli fu dedicata dallo zoologo Wagler. Gli furono dedicati anche due generi botanici Spixia (da Leandro e da Schrank) ma nessuno dei due è oggi valido. Diversamente dal compagno di viaggio, Martius ebbe lunga vita e poté diventare uno dei più eminenti botanici della sua generazione, autore di opere che superano in importanza persino la sua prodigiosa attività di raccoglitore. Oltre al resoconto del viaggio, pubblicò saggi sull'economia, la medicina, la cultura degli indigeni del Brasile, scrisse un romanzo rimasto inedito e, ovviamente, una lunga serie di articoli e monografie sulle piante raccolte durante la spedizione. Esordì nel 1823 con Genera et species palmarum quas in itinere per Brasiliam [...] collegit [...] C.F.P. Martius: le palme, esplorando il bacino del Rio dell'Amazzoni, la regione del globo più ricca di Arecaceae, erano diventate le sue piante preferite; seguì Nova genera et species plantarum, quas in itinere per Brasiliam [...] collegit C.F.P. Martius, in tre volumi (1824–1832); nel 1827 uscì un'opera dedicata al primo amore di Martius, le crittogame, Icones selectae plantarum cryptogamicarum. Ma intanto l'attivissimo botanico stava lavorando al suo capolavoro, Historia naturalis palmarum, in tre spettacolari volumi in folio pubblicati a Lipsia tra il 1823 e il 1850. E' un'opera monumentale con più di 550 pagine di testo e 240 cromolitografie, una tecnica all'epoca appena agli esordi; molti dei disegni del secondo volume si devono allo stesso Martius. Nel primo volume il botanico getta le basi della prima classificazione sistematica delle palme e fornisce una mappa della distribuzione geografica della famiglia; nel secondo descrive le palme del Brasile; nel terzo, intitolato Expositio Systematica, descrive tutte le specie allora note, basandosi sia sulle proprie raccolte sia su tutto ciò che era stato scritto da altri botanici. Questa pietra miliare dello studio delle palme ha guadagnato a Martius il soprannome di "padre delle palme" e ha fatto dire a Humboldt: "Finché le palme saranno apprezzate e conosciute, il nome di Martius sarà famoso". L'opera suscitò anche l'ammirazione di Goethe, che probabilmente ne fu influenzato nelle sue ricerche sulle metamorfosi delle piante; del resto, l'ammirazione era reciproca: lo stesso Martius durante il viaggio in Brasile scriveva poesie, inviò diversi esemplari brasiliani al poeta e si recò a fargli visita a Weimar. Ancora più grandiosa l'impresa cui Martius si accinse a partire dal 1839: la pubblicazione di una flora complessiva del Brasile. Per realizzarla, chiamò a raccolta i più importanti botanici europei. Si tratta infatti di un'opera collettiva, che andò molto oltre la vita del suo promotore, impegnando tre generazioni di studiosi e 65 collaboratori. E' considerata una delle opere botaniche più importanti di tutti i tempi ed è ancora oggi il testo di riferimento per la flora del Brasile; fino al 2004, quando uscì Flora Rupublicae popularis Sinicae, rimase la più ampia flora mai pubblicata. La gigantesca opera fu finanziata dall'imperatore d'Austria Ferdinando I, dal re di Baviera Ludovico I e dall'imperatore del Brasile Pietro II; inizialmente fu diretta da Martius e Endlicher, che però morì già nel 1849. Martius ne rimase il solo curatore fino alla morte (1868) e curò la pubblicazione di 46 fascicoli su 130; alla sua morte gli succedettero prima August Wilhelm Eichler quindi Ignatz Urban. Completata nel 1906, Flora Brasiliensis comprende più di 20.000 pagine con la trattazione di 22.767 specie, per lo più angiosperme, non solo brasiliane, ma anche dei paesi limitrofi (Venezuela, Ecuador e Perù). Quasi 6000 all'epoca erano nuove per la scienza. Il testo è arricchito da disegni, incisioni e acquarelli di artisti come Thomas Ender, Benjamin Mary e Johan Jacob Steinmann e dalle fotografie di George Leuzinger, che ne fanno una vera opera d'arte. Membro di innumerevoli società scientifiche, Martius divenne anche una figura piuttosto nota dell'ambiente culturale monacense. Era in contatto con scienziati di tutto il mondo, che ospitava volentieri a casa sua. Ogni anno, in occasione del compleanno di Linneo (il 23 maggio) vi organizzava un festival in onore del principe dei botanici, con discorsi, poesie e canzoni. Tra i suoi lasciti, non possiamo dimenticare l'erbario. Già prima che partisse per il Brasile era ragguardevole; l'avventura brasiliana gli fruttò circa 12.000 esemplari. Anche se dopo il ritorno a Monaco non viaggiò più, continuò ad arricchire l'erbario grazie ad acquisti, invii di altri botanici e scambi. Alla sua morte, con circa 300.000 esemplari e 65.000 specie, era uno degli erbari privati più importanti del mondo. Acquistato dal Belgio, è oggi custodito nell'Orto botanico di Bruxelles ed è oggetto di un importante progetto di digitalizzazione, The Martius Project. Martius riposa nel cimitero di Monaco di Baviera. Sulla sua tomba una lastra con due palme e l'epigrafe latina In palmis semper virens resurgo, "Tra le palme risorgo sempreverde". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Martiodendron, un'esplosione di fiori d'oro Molti colleghi dedicarono a Martius un genere botanico; si contano non meno di sei Martia, due Martiusia, cui vanno aggiunti Martiusella e Suitramia (dallo pseudonimo Suitram che Martius usava con gli amici e in alcuni documenti). Si venne così a creare un intrico di omonimi e sinonimi e si generò una confusione che rischiava di privare il grande botanico del giusto riconoscimento; per rimediare a tanta ingiustizia nel 1935 lo statunitense H.A. Gleason rinominò Maritiodendron un genere di Fabaceae sudamericane che nel 1818 Bentham aveva battezzato Martia e nel 1840 aveva rinominato Martiusia. Martiodendron riunisce cinque specie di alberi presenti in vari habitat del Sud America atlantico : dalla foresta pluviale alle foreste stagionalmente inondate alla savana; molto opportunamente, tra le zone di diffusione (Guyane, Venezuela meridionale, Brasile amazzonico, nord-est brasiliano) ci sono anche le due principali aree visitate da Martius, il bacino del Rio delle Amazzoni e gli Stati brasiliani di Bahia, Piauí, Maranhão. Sono alberi da medi a grandi la cui chioma svetta nello strato superiore della foresta, con robusti tronchi che in alcune specie si allargano in contrafforti; hanno foglie imparipennate con foglioline da ovate a ellittiche, da coriacee a membranacee. A farsi notare sono soprattutto le infiorescenze panicolate, fitte di fiori giallo oro con cinque petali imbricati alla base, corolla lievemente zigomorfa e lunghi stami. Le due specie più diffuse sono le amazzoniche M. parvifolium e M. elatum; si dice che la fioritura di quest'ultimo lungo le rive del fiume Tapajós, nello stato di Pará, all'inizio della stagione delle piogge, offra uno spettacolo senza uguali. Se Martius lo vide in tanta gloria, sicuramente sarà contento di questa complicata, ma più che meritata dedica. Qualche informazione in più nella scheda. Tra gli scienziati venuti in Brasile al seguito dell'arciduchessa Leopoldina c'era anche un botanico italiano, il fiorentino Giuseppe Raddi. Giunto con gli ultimi e partito con i primi, la sua partecipazione fu breve, ma straordinariamente fruttuosa per quantità e qualità. Grazie alle raccolte brasiliane e agli studi che ne ricavò, Raddi divenne una figura assai riconosciuta a livello europeo, come testimoniano i vari generi che gli furono dedicati. I due che oggi sono ancora validi ci fanno conoscere alcuni inattesi bambù, compreso quello che è considerato il più piccolo del mondo. 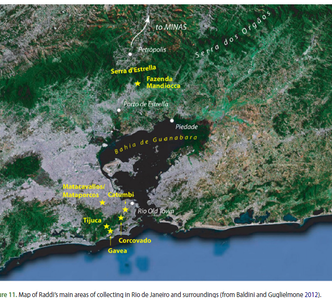 Dalle crittogame toscane alle piante del Brasile Gli Asburgo-Lorena erano assai legati alla Toscana. L'imperatore Leopoldo II, figlio cadetto di Maria Teresa d'Austria e Francesco Stefano di Lorena, per venticinque anni era stato granduca di Toscana (con il nome Pietro Leopoldo) e in Toscana erano nati ed erano stati educati i suoi figli, compreso l'imperatore Francesco II. Così fu del tutto naturale che nel suo viaggio nuziale alla volta del Brasile l'arciduchessa Leopoldina facesse tappa nella seconda patria della sua famiglia, dove fu accolta da suo zio, il granduca Ferdinando III. E fu proprio quest'ultimo a pensare che la partecipazione alla grande spedizione scientifica brasiliana avrebbe dato lustro al suo piccolo Stato. Tanto più che, per una volta, c'era la persona giusta al posto giusto. Nel 1817, Giuseppe Raddi aveva quasi cinquant'anni ed era uno studioso riconosciuto soprattutto come esperto di crittogame e funghi. Di modesta origine, si era avvicinato alla botanica grazie a Ottaviano Targioni Tozzetti, che aveva preso sotto la sua ala protettrice lui e l'amico d'infanzia Gaetano Savi. Nel 1785, a quindici anni, aveva incominciato a lavorare come assistente di Zuccagni al Giardino dei semplici di Firenze; dopo dieci anni di gavetta, era stato nominato custode del Museo di Storia naturale di Firenze. Assunto questo incarico, Raddi studiò il latino e le principali lingue europee e approfondì gli studi di botanica, dedicandosi soprattutto alle crittogame e ai funghi, un campo peculiare della botanica toscana nel quale si erano già distinti Pier Antonio Micheli (1679–1737), Giovanni Targioni Tozzetti (1712–1783) e il figlio di quest'ultimo Ottaviano. Le sue prime pubblicazioni, a partire dal 1806, sono appunto dedicate a nuove specie di crittogame e funghi scoperte nei dintorni da Firenze. Erano anni politicamente difficili. Nel 1799 l'esercito francese aveva occupato il Granducato, costringendo Ferdinando III all'esilio. Gli intellettuali si divisero tra filofrancesi e legittimisti; tra questi ultimi Raddi che nel 1808, con l'annessione della Toscana al Regno d'Italia e la soppressione del Museo, perse il lavoro. Nonostante le difficoltà economiche, continuò le sue ricerche e si mantenne in corrispondenza con importanti studiosi europei, compreso de Candolle, nonostante le opposte opinioni politiche. Il purgatorio di Raddi durò fino al 1814 quando Ferdinando III recuperò il trono e il botanico venne reintegrato nell'incarico di curatore delle collezioni scientifiche del Museo di storia naturale. In una situazione più tranquilla, poté così completare la sua prima importante monografia Jungermanniografia Etrusca (1817), dedicata alle crittogame toscane: un lavoro così importante che Nees von Esenbeck salutò Raddi "padre dell'epaticologia". L'opera fu presentata nel giugno 1817, poco prima dell'arrivo in Toscana di Leopoldina e del suo seguito; fu certamente essa ad attirare l'attenzione del granduca, che invitò Raddi ad unirsi alla spedizione in Brasile. Con strumenti, libri, mappe geografiche, ma senza alcun assistente, il botanico toscano si imbarcò sul San Sebastiano, uno dei vascelli portoghesi che dovevano condurre la principessa a Rio de Janeiro; salpata da Livorno il 13 agosto 1817, la piccola flotta austro-portoghese si fermò per pochi giorni a Madeira (11-13 settembre), dando modo a Raddi di raccogliere 150 specie di vegetali, compresa una nuova epatica; dopo 82 giorni di navigazione, giunse a Rio il 5 novembre. Subito dopo l'arrivo, il botanico toscano, oltre ai colleghi imbarcati sull'Austria, che si trovavano a Rio già da vari mesi, conobbe il console russo Georg von Langsdorff, che lo invitò a visitarlo nella sua fazenda Mandioca. Un altro incontro importante fu quello con il carmelitano Leandro do Santíssimo Sacramento, professore di botanica alla Real Academia de Medicina. Contrariamente ai colleghi austriaci e tedeschi, Raddi disponeva di un budget estremamente limitato. Il costo della vita nella colonia, anche a causa dell'arrivo della comitiva nuziale, era proibitivo. Non avendo abbastanza denaro per assumere aiutanti sul posto, egli dovette muoversi da solo, approfittando dell'ospitalità di amici brasiliani e soprattutto di Langsdorff. I suoi viaggi ebbero dunque un raggio limitato, tanto nei dintorni della città, quanto nell'area di Mandioca. Le località di raccolta più citate nel suo diario di campo sono, in ordine alfabetico, Catumby, un villaggio a ovest di Enseada da Glória; il monte Corcovado; la Serra de Estrela, un gruppo di montagne a nord della Baia di Guanabara; il monte Gavia, a sud di Rio de Janeiro; Mandioca, la valle a ovest di Rio da Janeiro dove si trovava la fazenda di Langsdorff; le piste di Matacavallos e Mataporcos nella foresta pluviale a nord della capitale; Nossa Senhora da Piedade Inhumirin, a nord del porto di Estrella; la foresta di Tijuca, che circondava il palazzo reale; si aggiungano alcune località tra Rio e Petropolis, inclusa la Serra dos Órgãos. Nonostante tutte le difficoltà, le raccolte di Raddi nei sette mesi che trascorse in Brasile furono imponenti: 4000 piante, 2230 insetti, 49 rettili, 65 minerali, manufatti, frutti; raccolse anche i semi di circa 340 specie, con l'intenzione di propagarli una volta tornato in Toscana. Nell'orto botanico di Firenze sono ancora oggi coltivate alcune specie di Begonia, compresa la popolarissima B. maculata Raddi, e un esemplare di Psidium guineense, discendenti da piante nate da semi portati da Raddi dal Brasile. Dopo aver inutilmente sollecitato nuovi finanziamenti, il 1 giugno 1818 Raddi dovette rassegnarsi a tornare in Europa insieme a Mikan, ai pittori e all'ambasciatore d'Austria von Eltz. Il 19 agosto sbarcò a Genova con diverse casse di esemplari e tre barili di cachaça usati per conservare pesci e anfibi.  Un importante contributo scientifico Le sue vicissitudini non erano finite. Di origini sociali modeste, autodidatta, era guardato con sufficienza dai colleghi più titolati, che invidiavano la sua fama crescente al di fuori del provinciale ambiente fiorentino, Al suo ritorno in città, Raddi scoprì che il custode del Museo, il paleontologo Filippo Nesti, non aveva trattato con la dovuta cura i materiali spediti dal Brasile; nonostante ciò, la catalogazione delle collezioni venne affidata, invece che al raccoglitore, allo stesso Nesti, che per altro non aveva competenze né in botanica né in zoologia. Raddi si vide retrocesso al rango di impiegato amministrativo con un modestissimo stipendio. Soltanto a partire dal 1820, quando venne abolito l'incarico di custode del Museo, pur mantenendo lo stesso stipendio, gli venne riconosciuto il ruolo di "fisico", ovvero di ricercatore, con l'incarico di studiare le proprie raccolte brasiliane. Lasciato il lavoro al Museo, si trasferì al Canto di Candeli in Borgo Pinti per dedicarsi interamente a questo compito. A una prima monografia sulle felci brasiliane, Synopsis Filicum Brasiliensium, uscita già nel 1819, seguì l'importante Agrostografia Brasiliensis sive enumeratio plantarum ad familias naturales graminum et ciperiodarum spectantium quas in Brasilia collegit et descripsit (1823), il primo studio sulle erbe neotropicali, che comprende 65 Poaceae (tra cui 5 nuovi generi) e 26 Cyperaceae. Infine nel 1825 uscì Plantarum Brasilensium Nova Genera et Species Novae, vel minus cognitae che Raddi concepiva come prima parte di un lavoro più ampio. A questi lavori maggiori si affianca una notevole produzione di articoli e memorie, pubblicati negli atti di società scientifiche come la Società Italiana delle Scienze di Modena. Raddi vi approfondì lo studio di numerose altre famiglie di piante, con un approccio innovativo che dava grande importanza alla sistematica attraverso l'analisi e l'interpretazione di vasti gruppi. Il botanico fiorentino si inserì così autorevolmente nel dibattito europeo sulla classificazione naturale. Notevole fu anche il suo contributo alla zoologia, con la descrizione di diverse nuove specie di rettili. La precisione delle descrizioni e la profondità delle interpretazioni diedero risonanza europea a Raddi, che fu in corrispondenza con molti colleghi di primo piano; egli fu anche ammesso a numerose società scientifiche in Italia e all'estero. Non doveva però essere totalmente appagato, oppure non si era spento il suo desiderio di avventura, se nel 1828, quando aveva già quasi sessant'anni, accettò di affrontare una nuova sfida. Nel 1827, due egittologi, il toscano Ippolito Rosellini e il francese Jean François Champollion, il decifratore della stele di Rosetta, proposero ai rispettivi governi una spedizione in Egitto. Ne nacque così la Missione archeologica franco-toscana che per 15 mesi (18 agosto 1828-27 novembre 1829) esplorò la valle del Nilo toccando tutti i più celebri siti noti all'epoca. Con Rosellini e Champollion c'era un vasto gruppo di archeologi, architetti, disegnatori, naturalisti. Uno di loro era il nostro Giuseppe Raddi, che della spedizione era il botanico ufficiale. Anche in Egitto, Raddi si dimostrò un raccoglitore instancabile, raccogliendo nell'arco di otto mesi circa 450 specie di piante. Dapprima esplorò i dintorni di Alessandria e di Rosetta, quindi con i suoi compagni risalì il Nilo fino alla prima cataratta. Qui abbandonò la spedizione per tornare in Basso Egitto, dove la vegetazione era più abbondante. Il 29 giugno 1829 partì da Rosetta per raggiungere il Wadi el-Natrun ma durante il viaggio fu colto da una violenta infezione intestinale. Costretto a rientrare al Cairo, continuò ad aggravarsi, tanto da decidere di tornare in Italia. Il 23 agosto si imbarcò a Alessandria ma durante il viaggio di ritorno morì a Rodi il 6 settembre. Qualche anno dopo, un gruppo di amici volle porre una lapide in suo ricordo a Santa Croce, che lo saluta come "ornamento d'Italia". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Bambù piccoli e lillipuziani Della grande stima internazionale goduta da Raddi testimoniano anche le numerose dediche di generi che gli furono tributate. Era una stima che andava non solo allo scienziato, ma anche alla persona, lodata per la modestia, la coerenza e la nobiltà d'animo. Contava anche la riconoscenza per la generosità di Raddi, che per quanto poté - il regolamento del Museo di storia naturale poneva gravi limiti - condivise con larghezza i suoi esemplari con i colleghi. Tra i beneficiati Antonio Bertoloni, amico personale di Raddi e Savi, cui il botanico fiorentino inviò più di 200 esemplari per la sua Flora italica, molti dei quali appartenenti a specie mai descritte, in particolare crittogame. La stima reciproca è testimoniata da uno scambio di dediche: nel 1812 Bertoloni dedicò al collega Raddia, famiglia Poaceae (ne riparliamo tra poco); l'anno dopo Raddi ricambiò con Bertolonia, famiglia Melostomataceae. Il secondo omaggio giuse dal franco-statunitense Rafinesque, che nel 1814 dedicò al botanico fiorentino Radiana (Aizoacaeae), oggi sinonimo di Sesuvium L. Anche la terza dedica si deve a un collega che ebbe rapporti personali con Raddi, quel frate Leandro do Santíssimo Sacramento che lo aveva guidato alla scoperta della flora brasiliana. E ancora una volta, si tratta di uno scambio di cortesie: nel 1820 Raddi pagò il suo debito di riconoscenza con Leandro dedicandogli Leandra, un'altra Melastomatacea; l'anno successivo il brasiliano si sdebitò con Raddisia (Celastraceae), oggi sinonimo di Salacia L. Il genere di Leandro fu ripreso da de Candolle (come abbiamo visto, assiduo corrispondente e estimatore dell'attività scientifica di Raddi) che lo corresse in Raddia. Nel 1822 il francese Achille Richard aggiunse Radia (Amaryllidaceae), oggi sinonimo di Vellozia Vand. Di tutti questi generi l'unico oggi valido è Raddia Bertoloni. E' una dedica particolarmente opportuna per il primo studioso delle graminacee sudamericane. A questo genere appartengono infatti una dozzina di specie di bambù, diffusi tra Venezuela, Guyana e Brasile. Anche se siamo abituati ad associare i bambù all'estremo oriente, anche l'America tropicale è particolarmente ricca di specie di questi vasto gruppo di Poaceae. Sono americani (e dell'Oceania) i cosiddetti bambù erbacei, appartenenti alla tribù Olyreae, con una ventina di generi, uno dei quali è appunto Raddia. Anche se alcune specie crescono a Trinidad e Tobago, in Guyana, in Venezuela e nell'Amazzonia brasiliana, il centro di diversità di questo genere è la costa atlantica orientale del Brasile, in particolare tra gli Stati di Bahia e Espìrito Santo. Sono bambù erbacei, alti non più di un metro, cespugliosi, con colmi eretti, che crescono in piccoli gruppi, soprattutto nelle foreste stagionalmente aride. La specie più diffusa è probabilmente R. brasiliensis, una specie molto polimorfa assai diffusa nelle foreste costiere da Cearà a Rio de Janeiro, con qualche popolazione sparsa nel Brasile occidentale. Qualche approfondimento nella scheda. La tribù Olyreae ha una tassonomia piuttosto complicata, ed è stata sottoposta a continue revisioni. Nell'ambito di una di esse, nel 1948 Jason Richard Swallen creò il genere Raddiella, in cui nome allude alla somiglianza con Raddia, ma in miniatura. Insieme a Mniochloa questo genere comprende infatti i bambù più piccoli del mondo. Il più piccolo in assoluto è R. vanessiae, una specie della Guyana francese che a maturità non supera i due cm. A distribuzione più settentrionale rispetto alla cugina maggiore (si fa per dire), sono native dell'America centrale e del Sud America settentrionale, fino a Trinidad. In genere comprende una quindicina di specie da piccole a minuscole; solitamente sono perenni cespugliose che formano colmi, per lo più striscianti; R. vanessiae, oltre ad essere il più piccolo bambù nel mondo, è anche l'unico sicuramente annuale. Altre informazioni nella scheda. Nel 1817, il matrimonio dell'arciduchessa Maria Leopoldina d'Asburgo con l'erede al trono del Portogallo offre l'occasione per organizzare la prima grande spedizione scientifica in Brasile, le cui frontiere fino ad allora erano rimaste chiuse agli scienziati stranieri. Di grande significato politico e propagandistico per l'Austria, vede anche la partecipazione di due naturalisti bavaresi e di un botanico italiano. Le tensioni interne al gruppo e la turbolenta situazione politica (sono proprio gli anni in cui il Brasile diventa indipendente) ridimensioneranno in parte gli obiettivi; tuttavia, i risultati saranno grandiosi e segneranno una tappa decisiva per la conoscenza della natura brasiliana. Dei cinque botanici coinvolti in questa grande avventura, tre sono dedicatari di generi validi; li ritroveremo in altrettanti post riservati solo a loro, per dedicare almeno un ricordo e un pensiero a Leopoldina, che da adolescente sognò di diventare naturalista e morì forse di dolore, forse di femminicidio da imperatrice del Brasile. A renderle omaggio le svettanti palme del genere Leopoldinia. 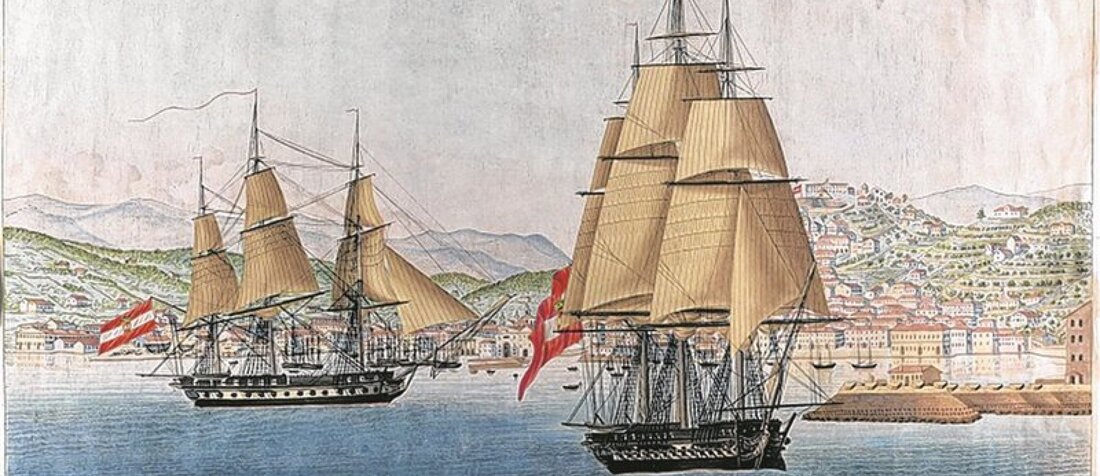 Un matrimonio imperiale e una spedizione in terre lontane Dopo la prova del fuoco delle guerre napoleoniche, l'Austria si ritrovò superpotenza. Certo, aveva dovuto subire terribili umiliazioni e Francesco II non era più Imperatore dei Romani, ma semplicemente Imperatore d'Austria; tuttavia governava un territorio raddoppiato, perno della Santa Alleanza, con l'assoluta egemonia sull'Italia. Vienna, sede dell'omonimo congresso, era la capitale diplomatica (e modaiola) d'Europa. Era ora di guardare più lontano. Così, quando il re di Portogallo chiese in moglie una principessa asburgica per l'erede al trono, Pietro di Braganza, Francesco II pur avendo qualche titubanza (le notizie sul pretendente non erano del tutto rassicuranti), convinto dal cancelliere e ministro Metternich, finì per accettare, sacrificando una delle figlie alla ragion di stato. L'alleanza conveniva ad entrambi: al Portogallo, che sperava di limitare l'egemonia economica inglese e cercava aiuto contro il movimento liberale; all'Austria, che contava d'estendere la propria sfera d'influenza all'America latina. Il re del Portogallo era infatti anche re del Brasile, e dal 1808, quando Napoleone aveva occupato la penisola iberica, si era rifugiato con la corte a Rio de Janeiro, divenuta la capitale di fatto del Regno. La scelta cadde sull'arciduchessa Maria Leopoldina. Per lei era ora di sposarsi. Aveva già 19 anni (il futuro marito ne aveva uno in meno) e fino ad allora non aveva avuto proprio la coda di pretendenti. Intelligente, colta, seria, fosse stato per lei avrebbe preferito un destino ben diverso: era appassionata di scienze naturali, soprattutto botanica e mineralogia, e sognava di dirigere la Collezione imperiale dei minerali, un'aspirazione impensabile per una donna del suo tempo. Quando seppe che l'attendeva un matrimonio nel lontano Brasile, l'accettò di buon grado, non solo per senso del dovere, ma anche per il fascino esotico di quella terra, uno scrigno i tesori naturali. La pensava così anche il cancelliere Metternich, appassionato di scienze naturali e amico personale di Humboldt; propose dunque all'Imperatore di approfittare dell'occasione per inviare in Brasile, insieme al seguito di Leopoldina, una spedizione scientifica in grande stile. Fino ad allora le frontiere brasiliane erano state ermeticamente chiuse alla scienza e sponsorizzare la prima spedizione scientifica ufficiale in quel paese avrebbe dato grande prestigio alla monarchia asburgica, con importanti ricadute economiche: accesso a risorse minerarie, legnami pregiati, animali esotici per lo zoo imperiale, piante per i giardini ma anche da naturalizzare, a giovamento dell'agricoltura nazionale, Francesco II, fin da bambino cultore di botanica, tanto da essersi guadagnato il soprannome "imperatore dei fiori", accettò con entusiasmo, affidando a Metternich l'organizzazione logistica della spedizione, incluso l'itinerario, e a Karl Franz Anton von Schreibers, il direttore dell'Imperiale gabinetto di storia naturale, la direzione scientifica. Per l'impresa vennero scelti lo zoologo Johann Natterer, con l'assistenza del cacciatore imperiale e tassidermista Ferdinand Dominik Sochor; il mineralogista e botanico Johann Baptist Emanuel Pohl; il giardiniere Heinrich Wilhelm Schott; il pittore paesaggista Thomas Ender e l'illustratore Johann Buchberger. La spedizione avrebbe dovuto essere diretta da Natterer, ma l'imperatore impose la presenza e la direzione di Johann Christian Mikan, professore di storia naturale a Praga. Una scelta che fu vissuta da Natterer come un affronto personale. Intanto, il re di Baviera Massimiliano I, che si trovava a Vienna per il Congresso, venne a sapere della spedizione e raccomandò due giovani naturalisti bavaresi, lo zoologo Johann Baptist von Spix e il botanico Carl Friedrich Philipp von Martius, che vennero così ad aggiungersi alla lista dei partecipanti. Il 13 maggio 1817 Leopoldina si sposò per procura; insieme al suo seguito, che comprendeva due dei suoi insegnanti, il mineralogista Rochus Schüch e il pittore Frick, tre dame di compagnia, l'ambasciatore imperiale conte von Eltz, Pohl e Buchberger, partì per Livorno, dove avrebbe atteso la flotta portoghese che doveva condurla a Rio. Circa un mese prima, il 9 aprile, il grosso degli scienziati si era già imbarcato a Trieste sulle fregate Austria e Augusta.  Scienziati litigiosi e raccolte naturalistiche Dopo due giorni di navigazione, i due vascelli austriaci incapparono in una violenta tempesta e dovettero rifugiarsi per riparazioni una a Chioggia, l'altra a Pola. Quindi l'Austria, su cui erano imbarcati Mikan, Ender e i due bavaresi, fece direttamente rotta per il Brasile, con una sosta a Malta, giungendo a Rio il 14 giugno. In attesa dei compagni, si dedicarono all'organizzazione logistica della spedizione; un contatto particolarmente utile fu quello con il console russo, il barone Langsdorff, che divenne un punto di riferimento anche nei mesi successivi. Quanto all'Augusta, su cui viaggiavano Natterer, Socor e Schott, fece vela per Gibilterra, dove sostò ad aspettare delle navi portoghesi. L'attesa si prolungò oltre ogni aspettativa. Infatti i vascelli Joao VI e São Sebastião, con a bordo la principessa e il suo seguito, salparono da Livorno solo il 5 agosto. A bordo troviamo anche una new entry: il botanico Giuseppe Raddi, cui il granduca di Toscana aveva ordinato di unirsi alla spedizione. Le tre navi si ricongiunsero a Gibilterra e salparono insieme per Rio solo il 1 settembre; erano finalmente a destinazione il 4 dicembre dopo una difficile navigazione durata ben 82 giorni. L'inizio della spedizione vera e propria ne risultò fortemente ritardato. Poiché si prevedeva che le fregate austriache avrebbero lasciato il Brasile per il viaggio di ritorno alla fine di marzo o all'inizio di aprile, in accordo con l'ambasciatore von Eltz, i naturalisti optarono per brevi spedizioni, in modo da poterne approfittare per un primo invio. Per ottimizzare le forze, si divisero in tre gruppi; una decisione dovuta anche alle tensioni interne, alimentate dalla rivalità tra Natterer e Mikan e dall'autoritarismo di quest'ultimo. Accompagnati da guide, portatori, personale ausiliario, i tre gruppi poterono mettersi in marcia solo alla fine di gennaio; i due bavaresi, insieme al pittore Ender, si diressero a São Paulo; i due gruppi austriaci, formati uno da Mikan, Schott e Buchberger, l'altro da Natterer, Sochor e Pohl, si divisero l'esplorazione della provincia di Rio, all'epoca ancora ricca di foreste e terre vergini. Raddi, che l'avaro granduca aveva dotato di finanziamenti insufficienti, fu costretto a fare parte per se stesso. Lo ritroveremo in un prossimo post. Il gruppo di Mikan fu costretto a rientrare già all'inizio di marzo, a causa di una brutta caduta da cavallo di Buchberger , mentre la assai più fruttuosa spedizione di Natterer e compagni si protrasse fino ad aprile. Il primo giugno 1818 l'Austria e l'Augusta ripartirono per l'Europa, con varie casse di animali imbalsamati, piante essiccate, conchiglie, semi, qualche animale curioso vivo e vasi di piante rare raccolte da Schott e Pohl. A bordo c'erano anche i due pittori, gravemente malati; Raddi, rimasto senza fondi; e Mikan, cui l'ambasciatore von Eltz aveva ordinato di rientrare a causa della pessima atmosfera creata dal suo autoritarismo. Quando la notizia arrivò in Europa, anche se il rientro di Mikan venne diplomaticamente attribuito al suo stato di salute, chi non aveva simpatia per l'Austria incominciò a mormorare di fallimento. Non era proprio così, ma certamente si trattava di un ridimensionamento degli obiettivi iniziali. In Brasile rimanevano un nutrito gruppo di scienziati austriaci e i due bavaresi. Questi ultimi, non riuscendo a concordare un itinerario comune, si separarono dagli altri e si diressero a nord, intenzionati a esplorare l'Amazzonia. Anche a loro sarà dedicato un post a parte. Gli austriaci concordarono con l'ambasciatore di rimanere in Brasile ancora un anno e mezzo o due anni; tuttavia era chiaro che neppure l'esautorazione di Mikan aveva trasformato quell'insieme di individualisti in una squadra affiatata. Il più disciplinato era indubbiamente Schott, che obbedì a malincuore all'ordine di rimanere a Rio a creare e curare un giardino di acclimatazione per i semi e le piante raccolti nei dintorni; solo dopo circa un anno, quando da Vienna venne inviato in suo aiuto il giardiniere Schücht, poté affrontare alcuni viaggi più lunghi, in compagnia del pittore Frick che si era offerto di sostituire Buchberger come illustratore botanico. Natterer e Socor erano ormai una affiatatissima squadra; avevano intenzione di visitare il Mato Grosso, ma, non avendo ottenuto il necessario passaporto, si diressero a São Paulo, dove misero insieme una ragguardevole raccolta soprattutto di uccelli e insetti, per poi spostarsi a Soracaba e Ipanema. Anche Pohl era molto attivo, anche se i suoi interessi dalla botanica andarono via via allargandosi alle miniere e all'etnografia; nell'arco di circa due anni, i suoi viaggi lo portarono nelle province di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goias, Bahia. Tuttavia a causa del deterioramento della situazione politica dopo il rientro di Giovanni VI in Portogallo, alla fine del 1820 von Elck convocò i naturalisti a Rio de Janeiro e ordinò loro di rientrare prontamente in Europa. Pohl e Schott obbedirono: il primo si imbarcò nell'aprile 1821 per Amsterdam insieme a Schücht e una coppia di indios Botocudo, che al loro arrivo a Vienna divennero l'attrazione del giorno; il secondo a maggio si imbarcò per Lisbona, con 35 casse di materiali raccolti da Pohl e 30 da lui stesso. Natterer e Socor decisero invece di rimanere in Brasile e proseguirono le ricerche, ormai non più al servizio dell'Impero d'Austria, ma come esploratori indipendenti. Rimasto solo per la morte del fedele Sochor (1826), Natterer riuscì a penetrare nel bacino del Rio delle Amazzoni, spingendosi fino al confine con la Bolivia. Il suo viaggio avventuroso, che tra mille difficoltà si sarebbe protratto fino al 1835, segnò una tappa decisiva nella conoscenza della fauna brasiliana, con la scoperta di decine e decine di nuove specie. Non poche portano il suo nome: molti uccelli, come il colibrì gola-cannella Phaethornis nattereri, la pispola petto-ocra Anthus nattereri, il motmot amazzonico Momotus momota nattereri; diversi pipistrelli, come Vampyressa nattereri; il pesce siluride boliviano Farlowella nattereri. Notarella botanica a mo' d'epilogo Tutti i botanici che parteciparono a questa avventura ebbero la fortuna di tornare in patria, di vivere ancora a lungo e di pubblicare le piante che avevano raccolto in contributi di diversa importanza. Tra tutti spicca la monumentale Flora brasiliens diretta da von Martius, che sarà oggetto di un prossimo post, così come i lavori di Raddi e Schott. Ci rimangono dunque Mikan e Pohl. Johann Christian Mikan (1769-1844), boemo, era figlio d'arte: suo padre era infatti Joseph Gottfried Mikan, professore di botanica e chimica presso l'università di Praga e direttore dell'orto botanico praghese. Studiò medicina e botanica; incominciò a insegnare scienze naturali nella sua alma mater fin dal 1796, divenendo ordinario di storia naturale nel 1800 e di botanica dal 1812, al pensionamento del padre. Nonostante la brevità della sua partecipazione all'impresa brasiliana, le sue scoperte sulla fauna e sulla flora del paese sudamericano, pubblicate in Delectus Florae et Faunae Brasiliensis (1820-1825), sono tutt'altro che trascurabili; tra l'altro, vi si trova la prima descrizione scientifica della scimmia leonina nera Leontopithecus chrysopygus. Tuttavia, era più uno zoologo che un botanico. I generi botanici Kanimia Gardner, Mikania Willd. e Mikaniopsis Milne-Redh. non sono dedicati a lui, ma a suo padre, un botanico molto noto per i suoi lavori sulla flora boema. Molto maggiore per quantità e qualità, in ogni caso, il contributo di Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-1834). Anche lui boemo e formatosi all'Università di Praga, nel 1808 si era laureato in medicina. Iniziò la sua carriera di naturalista come bibliotecario e curatore delle collezioni della principessa Kinsky; contemporaneamente insegnava botanica all'Università. Lavorò anche come medico presso gli ospedali militari di Náchod e Praga. Era un naturalista a 360 gradi, che prima della spedizione in Brasile pubblicò lavori sulla flora ceca, sull'anatomia animale e sui fossili. Come abbiamo visto in precedenza, in Brasile fu instancabile, soprattutto nei viaggi in solitaria tra 1819 e 1821. Le sue imponenti collezioni, con oltre 4000 esemplari botanici, andarono ad arricchire il Gabinetto di storia naturale e il Brasilianum, il Museo allestito per esporre al pubblico le raccolte della spedizione. Di entrambi fu nominato curatore. Il suo Reise im Innern von Brasilien "Viaggio nel Brasile interno", in due volumi (1817-1821), fu molto letto e influì grandemente sull'immagine del Brasile in Europa. Alle piante brasiliane dedicò Plantarum Brasiliae icones et descriptiones (1827), un'opera molto curata anche dal punto di vista iconografico, in cui pubblicò diversi nuovi generi. Spiace che questo interessante naturalista non sia celebrato da alcun genere valido. Pohlana Mart. & Nees è infatti stato ridotto a sinonimo di Zigophyllum. Lo ricordano nell'epiteto diverse specie sudamericane, come la brasiliana carapià Stenandrium pohlii, ma anche l'europea Taraxacum pohlii.  La mineralogista mancata che divenne imperatrice Ma allora di cosa stiamo parlando, se dei colleghi di Mikan e Pohl si parlerà altrove? C'è ancora una persona degna di essere ricordata, cui non manca la gloria di un genere celebrativo. Chi? Proprio lei, l'arciduchessa Maria Leopoldina Giuseppa Carolina d'Asburgo Lorena, alias Dona Leopoldina, prima imperatrice del Brasile. La principessa che sognava di diventare direttrice del reale gabinetto di minerali arrivò in Brasile piena di sogni e di speranze. Del neosposo gli avevano fatto un ritratto elogiativo, e a prima vista non rimase delusa. Pedro era indubbiamente un bel ragazzo, ma, ahimè, niente di più. Era rozzo, incolto, e sebbene Leopoldina parlasse fluentemente quattro lingue, finché non padroneggiò anche il portoghese fu difficile persino comunicare. Sembra che a interessarlo fossero solo i cavalli e le belle ragazze (la scialba Leopoldina con il prominente labbro asburgico non rientrava nella categoria). Con il senso del dovere che le era stato inculcato fin dall'infanzia, la principessa si adattò serenamente alla nuova vita. Tra una gravidanza e l'altra (in nove anni di matrimonio ebbe sette figli) cercava di mantenere vivi i suoi interessi naturalistici: leggeva, dipingeva acquarelli botanici, collezionava molluschi, faceva quotidiane passeggiate nella foresta di Tijuca alla ricerca di orchidee; cavalcando all'amazzone andava a caccia e aiutava i tassidermisti a impagliare uccelli e piccoli mammiferi. Nella Fazenda Imperiale di Santa Cruz creò una moderna postazione zootecnica; nel palazzo di Boa Vista, fece allestire una biblioteca costantemente aggiornata con volumi di botanica e mineralogia che ordinava in Europa e un gabinetto di storia naturale, diretto dal suo maestro Rochus Schüch. Diede impulso alla creazione del Museo di Storia naturale, istituito con decreto reale nel 1818. Dona Leopoldina, come la chiamano in Brasile, divenne anche una figura molto amata. Nel 1821, quando Giovanni VI e la corte rientrarono in Portogallo, anziché approfittarne per tornare in Europa, preferì rimanere a fianco del marito e successivamente giocò un ruolo importante negli eventi che portarono alla Dichiarazione di indipendenza. Mentre Pietro si trovava a San Paolo, il 2 settembre 1822 arrivò a Rio il decreto reale che imponeva al principe di tornare in Portogallo e ripristinava lo stato di colonia del Brasile; nella sua posizione di reggente, Leopoldina riunì il Consiglio dei ministri e inviò al marito questo messaggio: "Il frutto è pronto. E' il momento della raccolta". Appena ricevuta la lettera, il 7 settembre, Pietro dichiarò l'indipendenza e si proclamò primo imperatore del Brasile. Secondo lo storico Paulo Rezzutti, molto del merito va proprio a Leopoldina: "Abbracciò il Brasile come suo paese, i brasiliani come suo popolo e l'Indipendenza come sua causa". Sul piano personale, gli ultimi anni di Leopoldina furono molto infelici. Pochi giorni prima dell'Indipendenza, a São Paulo Pietro conobbe una giovane donna, Domitila da Castro, e ne fece la sua amante. Non fu l'unica relazione extraconiugale di Pietro, che aveva già avuto e ebbe contemporaneamente a Domitila molte altre amanti, ma certamente fu la più scandalosa: non solo l'imperatore riconobbe pubblicamente la paternità di una figlia avuta da Domitilla, ma nobilitò l'amante, la nominò dama di compagnia della moglie e all'inizio del 1826 ne impose la presenza in occasione di viaggio ufficiale a Bahia. Leopoldina, come possiamo ricavare dalle lettere alle sorelle, si sentì totalmente umiliata. La sua vita era diventata un inferno; secondo le male lingue, non contento di offenderla di fronte a tutta la corte, Pietro prese anche a maltrattarla e picchiarla. Leopoldina morì non ancora trentenne nel dicembre 1826, dieci giorni dopo un aborto. Su questa morte si accavallarono le dicerie; se la causa più probabile fu una setticemia, secondo alcuni l'infelice arciduchessa, ormai priva di ogni desiderio di vivere, si sarebbe lasciata morire; secondo altri fu vittima di femminicidio: l'aborto che l'avrebbe portata alla morte sarebbe infatti stato causato da un violento calcio del marito. Meglio, molto meglio per lei, se fosse rimasta a Vienna a dirigere il reale Gabinetto dei minerali. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Una palma brasiliana per la principessa che si fece brasiliana A ricordare questa amica della scienza, questa donna intelligente e coraggiosa che il Brasile amò e non ha mai dimenticato, c'è anche un genere di piante, Leopoldinia, che von Martius le dedicò nel 1824 nella sua monografia sulle palme. Per una volta, si tratta di una dedica meritatissima, al di là del solito omaggio cortigiano a una sovrana. Il genere Leopoldinia della famiglia Arecaceae comprende tre specie di palme diffuse nel bacino del Rio delle Amazzoni tra Venezuela, Colombia e Brasile nord-occidentale, nella foresta tropicale umida periodicamente allagata: L. major, L. pulchra e L. piassaba. Le prime due crescono su isole rocciose e sulle rive del Rio Negro e di alti fiumi dalle acque nere e hanno fusto cespuglioso. L. piassaba, che ha fusto unico, cresce invece su isole sabbiose solitamente non allagate, in gruppi cospicui. Mentre la chioma di L. major, una specie rara nota solo in poche stazioni del bacino dei Rio Negro, può emergere sullo stato alto della foresta, le altre due sono specie tipiche del sottobosco. Hanno foglie basali molto fibrose, tanto che le fibre ricavate da L. piassaba, conosciuta come palma da fibra, sono utilizzare per cestini, scope, corde, cappelli e altri prodotti intrecciati. Hanno eleganti foglie pennate, pendule, lunghe fino a 5 metri. Per lo più monoiche, portano fiori maschili e femminili in infiorescenze diverse distribuite alternativamente lungo lo stesso ramo; talvolta tuttavia i fiori maschili spuntano vicino al tronco, mentre quelli femminili all'apice. Raramente possono avere fiori ermafroditi o essere dioiche. Qualche informazione in più nella scheda. Citato per diritto e per traverso, noto anche a chi non ha letto il romanzo, l'incipit di Anna Karenina è uno dei più celebri della letteratura mondiale: "Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo". Eppure sfido il grande Leo a trovare un amore felice simile a quello di Kate e Townshend Brandegee, che si innamorarono a quarant'anni sotto l'egida della botanica e per quasi altrettanti formarono una famiglia felice a modo loro. E a modo suo vive anche Brandegea bigelovii, tenace Curcurbitacea a suo agio nei deserti tra Stati Uniti e Messico.  Townshend prima di Kate, Kate prima di Townshend Fu la botanica a far incontrare Mary Katharine Layne Curran (1844-1920) e Townshend Stith Brandegee (1843-1925), e fu la botanica a farli innamorare. Entrambi erano sulla quarantina, nel pieno di una carriera che ne faceva personalità riconosciute nel loro campo. Ma i veri traguardi li avrebbero raggiunti insieme. Townshend era un ingegnere, ma, figlio di un medico che era anche un agricoltore, fin da bambino si era appassionato di storia naturale e aveva incominciato a creare un erbario. Dopo aver combattuto giovanissimo nella guerra civile, studiò ingegneria, ma anche botanica, alla Yale University’s Sheffield Scientific School; durante gli anni universitari, raccolse piante nella zona di New Haven, incluse alcune specie rare. Dopo la laurea, nel 1871 si trasferì a Cañon City in Colorado, come agrimensore della contea e ingegnere della città; anche qui continuò ad erborizzare, inviando piante a vari corrispondenti, incluso Asa Grey. Anche grazie alla raccomandazione di quest'ultimo, fu assunto come assistente topografo nella spedizione geografica nota come Hayden Survey, che tra il 1871 e il 1873 esplorò l'area che sarebbe diventata il parco di Yellowstone. Poté così lavorare fianco a fianco con il botanico della spedizione, John Coulter. Fu l'inizio di una carriera di ingegnere e topografo, al servizio delle compagnie ferroviarie e del servizio forestale; viaggiando in molte regioni ancora poco note degli Stati Uniti occidentali, ebbe anche occasione di esplorarne la flora. Fu anche incaricato di disegnare le mappe forestali di diverse regioni; nell'inverno 1886-87 fu inviato in California a rilevare le risorse forestali e cercare alcune essenze; visitò le isole di Santa Cruz e Santa Rosa, dove raccolse campioni per Charles Sprague Sargent. La scoperta della particolarissima flora delle isole lo convinse a stabilirsi a San Francisco e ad abbandonare la carriera di ingegnere civile per diventare un botanico a tempo pieno. Per saperne qualcosa di più, visitò l'erbario dell'Accademia delle scienze californiane. E lì avvenne l'incontro fatidico con Kate. Dopo aver raccontato di "Townshend prima di Kate", è dunque ora di parlare di "Kate prima di Townshend". Mary Katharine Layne aveva avuto un'infanzia errabonda. La famiglia Layne era approdata in California all'epoca della corsa all'oro, quando Kate aveva cinque anni, ma aveva continuato a cambiare sede al seguito di un padre inquieto. Nonostante l'educazione discontinua, la ragazza era diventata insegnante e nel 1866, a 22 anni, si era sposata con il poliziotto Hugh Curran, che purtroppo amava alzare il gomito e dopo sei anni la lasciò vedova. Kate, che adesso si chiamava ufficialmente Mary Katharine Curran, decise di trasferirsi a San Francisco e di iscriversi alla scuola di medicina, che aveva appena aperto le porte alle donne; lei fu la terza ad approfittarne. Nel 1878 si laureò. All'epoca, l'insegnamento della tradizionale "materia medica", ovvero della botanica applicata alla farmacia, faceva ancora parte del curriculum di medicina. Grazie a un professore eccezionale, Hans Hermann Behr, un convinto evoluzionista, la giovane donna incominciò ad interessarsi di piante e apprese il metodo rigoroso che poi sempre l'avrebbe contraddistinta. Behr la introdusse all'Accademia delle Scienze e al suo erbario, dove Katharine incominciò a prestare la sua opera come volontaria. Quando scoprì che per una donna era difficile esercitare la professione medica, questo divenne il suo lavoro. Nel 1879 divenne assistente del curatore dell'erbario, Albert Kellogg, e dal 1883, quando egli andò in pensione, gli succedette come curatrice e responsabile del dipartimento di botanica dell'Accademia; era una posizione eccezionale per una donna. All'epoca, nell'intera California, le botaniche professioniste erano solo due. Oltre a lavorare intensamente al riordino e all'accrescimento delle collezioni con escursioni sul campo, per presentare le nuove scoperte la dottoressa Curran ebbe l'idea di creare una rivista che scriveva di fatto da sola, Bulletin of the California Academy of Sciences; ufficialmente era solo la curatrice, e non il direttore responsabile, perché l'Accademia era riluttante a riconoscere che la sua principale pubblicazione era diretta da una donna. Fin a quel momento, l'autorità di Asa Gray e di Harvard era tale che all'Ovest nessuno osava pubblicare una nuova specie senza consultare quell'oracolo. La rivista fornì un veicolo per pubblicare più rapidamente le nuove specie e diede un grande contributo alla coscienza di sé e all'indipendenza della botanica californiana. Determinata, dotata di leadership e grinta, quando incontrò Towshend, la dottoressa Curran era una delle poche donne a dirigere una importante istituzione scientifica, senza tirarsi indietro anche quando si trattava di dare battaglia per conquistare un finanziamento. Vedova, senza figli, divideva il suo tempo tra il lavoro quotidiano all'erbario, la redazione di articoli scientifici e del Bollettino, le spedizioni sul campo.  Un'unione di cuore e di mente Il fatidico incontro tra Towshend e Kate dovette avvenire nell'inverno 1886. Non conosciamo i particolari del loro innamoramento, che dovette essere profondo e fulminante, nonché piuttosto inconsueto per l'epoca, tanto da destare battutine e pettegolezzi. Katharine confessò a una sorella di essere "innamorata in modo folle" e i sentimenti di Townshend, benché fosse un uomo discreto e taciturno, non dovettero essere diversi. Presto decisero di sposarsi, ma lontano dal pettegolo ambiente dell'Accademia; dunque non a San Francisco, ma a San Diego, dove nel maggio 1889 Kate raggiunse Towshend di ritorno dalla sua prima spedizione botanica in Baja California per conto dell'Accademia delle Scienze. Dopo la cerimonia, officiata da un pastore, iniziarono la loro vita di coppia con un inconsueto viaggio di nozze: da San Diego a San Francisco, raccogliendo piante lungo la strada; una bella camminata, se si pensa che le due città sono separate da oltre 800 km! Oltre che innamorati e devoti l'uno all'altro, anche come botanici i Brandegee erano perfettamente complementari. Il punto forte di Towshend era il lavoro sul campo, la vasta conoscenza della flora degli Stati Uniti occidentali acquisita in quasi vent'anni di viaggi e raccolte; quello di Kate, che aveva erborizzato solo nella California centrale, era l'eccezionale competenza di tassonomista. Inizialmente la coppia rimase a San Francisco; Kate, che adesso si firmava Katharine Layne Brandegee, continuò a lavorare all'erbario; Townshend entrò a far parte dell'Accademia delle Scienze. Nel 1890 ricevette una piccola eredità; grazie a questa somma, Kate poté fondare una propria rivista scientifica, Zoe; tuttavia, ufficialmente come direttore responsabile figurava il marito, perché la comunità scientifica non era ancora pronta ad accettare una rivista diretta da una donna. Nel 1891 Katharine fondò il California Botanical Club, aperto anche agli amatori, la prima associazione di questo tipo della West Coast. Entrambi i coniugi intensificarono le attività di raccolta, lui soprattutto in Baja California, lei prevalentemente nella California centrale. Durante un'escursione, Townshend incontrò una giovane botanica canadese, Alice Eastwood, e la presentò alla moglie, che esaminando il piccolo erbario raccolto dalla ragazza a Denver, rimase colpita dalla sua qualità. Rinunciando a una parte dello stipendio, la assunse come assistente, finché nel 1892 l'Accademia l'assunse ufficialmente come curatrice aggiunta. Potendo affidare molto del lavoro di routine ad Alice, ora Katharine poteva concentrarsi su ciò che più la interessava: la descrizione, l'identificazione e la classificazione delle piante. Profondamente consapevole che le specie possono presentare un altro grado di variabilità, secondo l'esposizione, il suolo, le condizioni climatiche, era convinta che, prima di denominare una nuova specie, bisognasse studiarne le crescita in situazioni differenti, raccogliendo e confrontando il maggior numero possibile di esemplari cresciuti in diverse condizioni ambientali. Di conseguenza, non sopportava i botanici egocentrici che moltiplicavano le denominazioni al puro scopo di aggiudicarsi l'effimera gloria di una nuova scoperta. Contro di loro, lanciò i suoi strali su Zoe, divenendo celebre - potremmo dire famigerata - per la ferocia delle sue critiche. Nel suo rigore, arrivò a lamentarsi persino del marito che "ha descritto come nuova una specie contro la mia volontà". Townshend si specializzò nella flora del Messico, in particolare della Baja California, che percorse in numerose spedizioni, divenendone il massimo esperto. Tra aprile e maggio 1893 insieme a altri cinque botanici esplorò la Sierra San Pedro Mártir nella Baja California settentrionale; lo stesso anno, tra settembre e ottobre, fece due viaggi da San Jose del Cabo nelle montagne della regione del Capo; al primo partecipò anche Katharine, che fotografie del tempo ritraggono a cavallo di una mula vestita in abiti maschili. Mentre rientrava da sola da questo viaggio, la sua imbarcazione naufragò. Fu forse considerano questi rischi e la distanza di San Francisco dal Messico che i Brandegee decisero di trasferirsi a San Diego; Katharine diede le dimissioni dall'erbario (come curatrice le succedette Alice Eastwood) e nel marzo 1894 acquistarono un vasto terreno non edificato sull'altopiano alle spalle della città, la mesa, con vista sulla baia di San Diego. Il loro primo pensiero, prima ancora di costruire la casa, fu per l'erbario, per ospitare il quale fecero costruire un padiglione di mattoni, mentre loro vivevano in una tenda. Fu poi la volta della casa e di una serra. Tutto attorno uno straordinario orto botanico, con piante raccolte in natura e portate qui dalle spedizioni della coppia in Messico e nella California meridionale. Era in primo luogo un laboratorio all'aria aperta, dove le piante raccolte durante le spedizioni venivano coltivate riproducendo le diverse condizioni naturali di crescita, in modo da osservarne le variazioni e giungere a una classificazione corretta. Ma era anche un giardino bellissimo, che così è stato descritto da un ospite: "Un paradiso botanico, con fiori rari da tutte le parti, e i canti di tordi beffeggiatori, quaglie e altri uccelli canori nativi a rendere l'aria musicale". Nel 1896, l'appassionato raccoglitore di piante di origine tedesca Carl A. Purpus scrisse a Katharine per chiedere l'identificazione di diverse specie; la cortese ed esperta risposta della botanica fu l'inizio di una collaborazione e di un'amicizia. Da quel memento la casa di San Diego divenne la base delle spedizioni di Purpus in Messico; in cambio, egli arricchì il giardino e l'erbario dei Brandegee con continui invii di piante dei deserti messicani, che i due botanici studiavano, coltivavano, classificavano. Townshend rinunciò alle faticose spedizioni in Messico, ma continuò ad esplorare assiduamente i dintorni di San Diego. Unica eccezione, una spedizione del 1902 in compagnia di Kate Sessions, una intraprendente e creativa vivaista dalla quale i Brandegee al loro arrivo a San Diego avevano acquistato alcune piante. Insieme a lei, Townshend ritornò nella regione del Capo per visitare alcune località trascurate nelle spedizioni precedenti; dopo aver raggiunto San Jose del Capo in battello, si addentrarono sulle montagne a dorso d'asino; fu così che scoprirono una palma ancora ignota, Brahea brandegeei. Lo stesso anno, Sessions fu incaricata dalla Città di San Diego di piantare un nuovo parco (Balboa Park) e convinse il botanico a prestare la sua consulenza per la scelta delle piante. Avvicinandosi la sessantina, i Brandegee cominciarono a pensare al futuro del loro amatissimo erbario, a cui dedicavano molte ore della giornata e che adesso comprendeva circa 76.000 esemplari. Decisero di farne dono, insieme alla biblioteca, all'Università della California a Berkeley, a condizione di poter continuare a lavorarvi fino alla fine dei loro giorni. Nonostante la munificenza del dono, le trattative si trascinarono per quattro anni. I Brandegee dovettero farsi carico anche delle spese di trasporto e non vennero aiutati neppure a trovare una casa. Poco prima della data fissata per il trasloco, nell'aprile 1906, avvenne il disastroso terremoto di San Francisco. Fortunatamente Berkeley e il campus subirono danni limitati e entro la fine dell'anno il trasferimento era completato. Fino a tarda età marito e moglie continuarono a lavorare gratuitamente ogni giorno all'erbario, di cui Townshend era stato nominato curatore onorario, e finché fu possibile continuarono anche le spedizioni botaniche; nel 1913, anche se soffriva di diabete in una forma sempre più grave, Katharine fece ancora una lunga spedizione in California alla ricerca di esemplari-tipo, per sostituire quelli andati perduti nell'incendio di San Francisco. Per molti anni, a occupare le giornate di lui fu anche la pubblicazione delle piante raccolte da Purpus in Messico, nella imponente Plantae Mexicanae Purpusianae, in 12 volumi (1909-1924). Quando completò l'opera, era già rimasto solo. Kate se ne era andata per prima, nel 1920, a 76 anni. Townshend la raggiunse nel 1925. Chi li conobbe durante gli anni di Berkeley, notò che anche da vecchi continuavano a mostrare "lo stesso indomabile amore per il pensiero critico e difficile che li aveva caratterizzati già da giovani". A rimanere invariato fino alla fine era stato anche l'amore reciproco, che li aveva sorprendentemente uniti quasi quarant'anni prima. Una sintesi delle loro vite tutte dedite alla scienza nella sezione biografie.  Brandegea, una deserticola variabile Il lascito di Townshend Brandegee sta soprattutto nelle piante che scoprì nelle sue spedizioni: gli è accreditata la scoperta di circa 225 piante della Baja California. Parecchie lo ricordano nel nome specifico. Abbiamo già incontrato Brahea brandegeei; tra le californiane, aggiungiamo Salvia brandegeei, una notevole Salvia dell'isola di Santa Rosa che è stata anche introdotta nei giardini per il grande valore ornamentale; tra le messicane, Echinocactus brandegei, una specie molto variabile che sembra fatta apposta per confermare le teorie di Katharine Layne Brandegee. Anche Katharine scoprì diverse piante notevoli, come Eriastrum brandegeeae, una rara Polemoniacea della catena costiera californiana. Ma questa grandissima botanica è ancora più importante come ricercatrice, tassonomista, teorica; giocò un ruolo enorme nell'emancipare la botanica californiana e diede un contributo altrettanto incisivo agli studi tassonomici, soprattutto sul piano metodologico. Di valore incalcolabile è poi il lascito comune di entrambi: il grande erbario ora custodito a Berkeley. Quanto al giardino di San Diego, purtroppo passò in altre mani che lo lasciarono morire, e non ne rimane nulla. Né Townshend né Katharine cercavano fama e onori; a loro interessava unicamente il progresso della scienza. Così la piccola pianta del deserto che li celebra appare straordinariamente adatta a ricordarli. A rigori, fu dedicata solo a lui, ma poiché vive sia in California sia nel Messico settentrionale, le aree di cui i due botanici erano specialisti, possiamo considerarlo un omaggio a entrambi. Durante la sua prima spedizione in Baja California, Townshend raccolse una cucurbitacea dai fiori molto minuti che pubblicò come Cyclanthera monosperma Brandegee; poco dopo, l'importante tassonomista belga Célestin Alfred Cogniaux, esperto di Cucurbitaceae, la unì a una specie già nota come Elaterium bigelovii S. Watson, creando il genere Brandegea con due specie, B. bigelovii (S.Watson) Cogn. e B. monosperma (Brandegee) Cogn. Oggi al genere Brandegea, una liana della famiglia Cucurbitaceae, con profondissime radici a fittone, sottili fusti volubili, piccole foglie verde scuro profondamente palmate, ma molto variabili nella forma e nelle dimensioni, piccolissimi fiori bianchi con cinque petali appuntiti, minuscoli frutti secchi spinosi, è assegnata una sola specie, B. bigelovii. Come molte piante del deserto, che devono affrontare condizioni estreme e molto differenziate nel corso delle stagioni e da un anno all'altro, anch'essa è estremamente variabile, tanto che in passato i botanici, meno prudenti di Katharine Layne Brandegee, le avevano assegnato almeno quattro specie, con una foresta di sinonimi. E' dunque anch'essa una conferma vivente della correttezza del metodo di questa grande botanica, che ne diventa così la co-dedicataria onoraria. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|
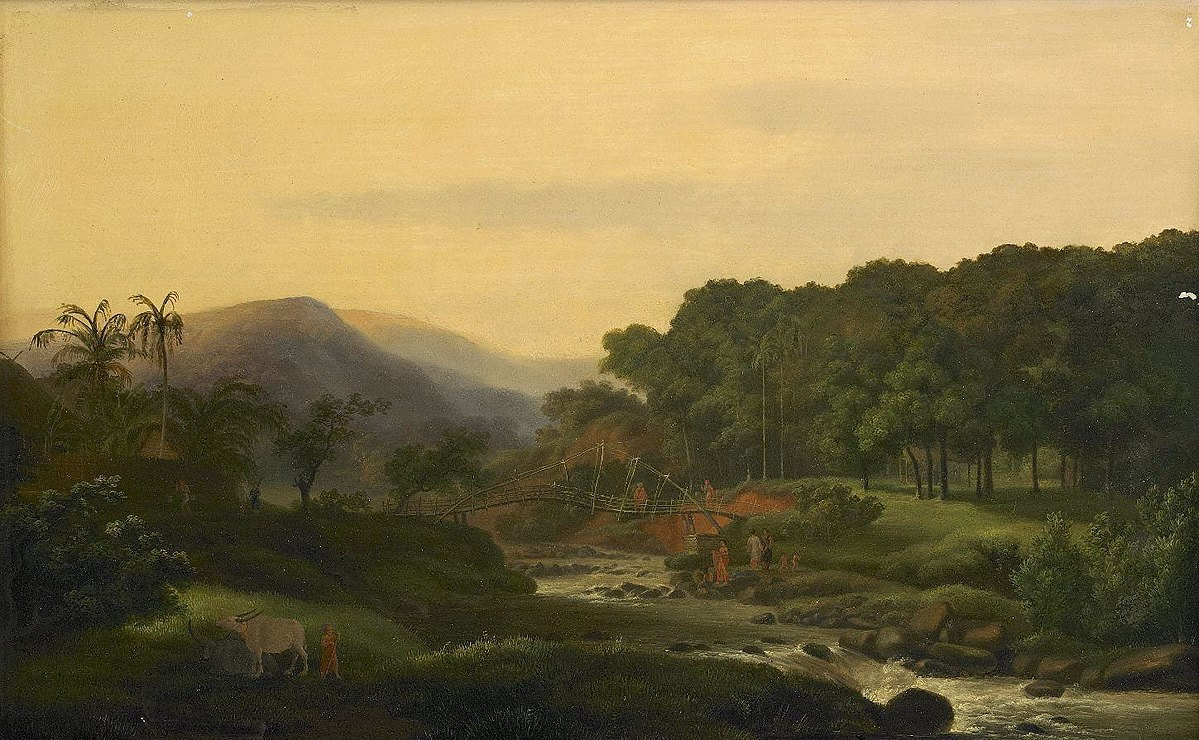





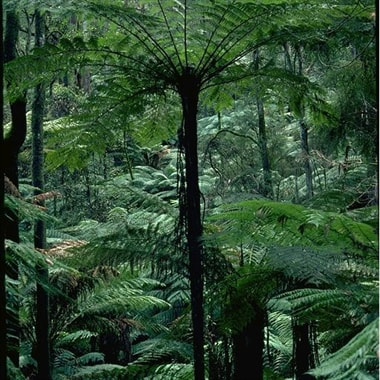



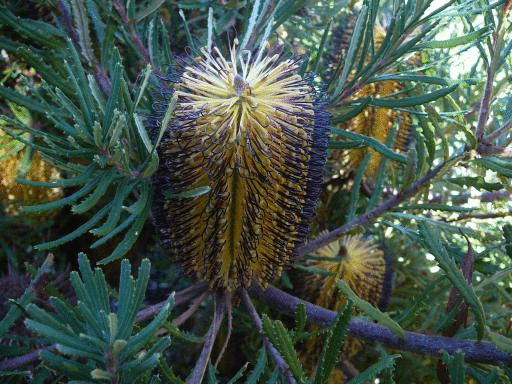



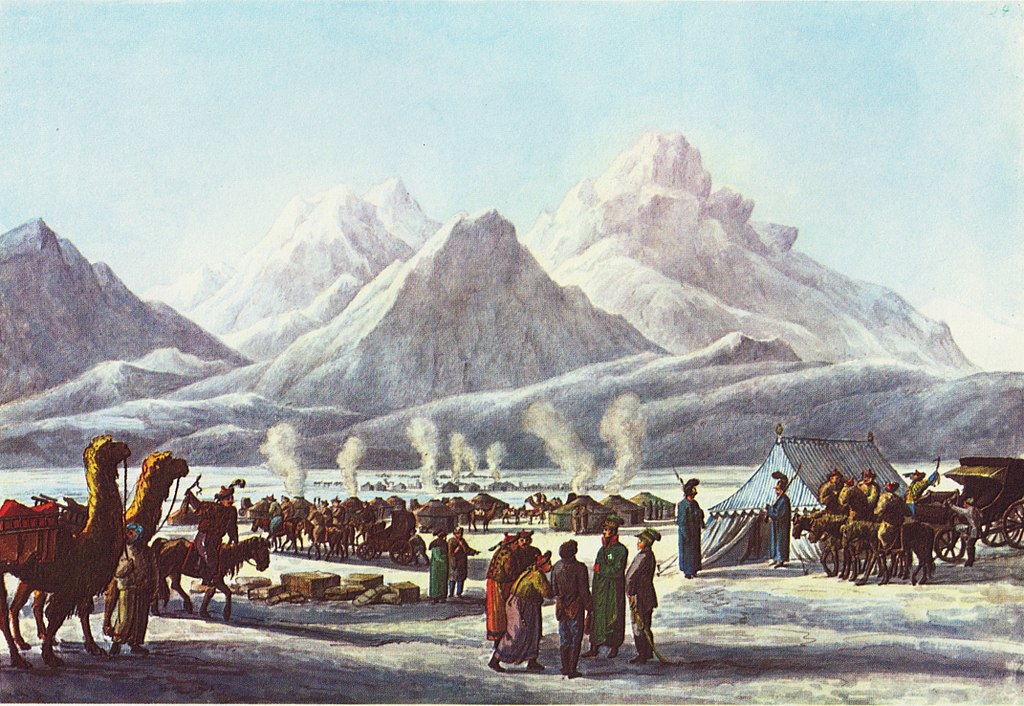
 RSS Feed
RSS Feed