|
A Bex i Thomas non erano i soli a raccogliere piante e a commercializzare campioni d'erbario e semi di piante alpine. A far loro concorrenza, negli ultimissimi anni del Settecento e nei primi due decenni dell'Ottocento, c'era il farmacista di origini tedesche Johann Christoph Schleicher, che fu il primo ad avere l'idea di pubblicizzare il suo commercio prima con annunci in riviste scientifiche, poi con un catalogo che comprendeva circa 2000 piante e giunse a quattro edizioni. Pubblicò anche a più riprese cataloghi specifici per le crittogame. Per qualche anno ottenne un notevole successo, come testimonia la presenza dei suoi campioni negli erbari di moltissime istituzioni e di qualche pianta nata dai suoi semi nei cataloghi dei vivai inglesi. Poi si fecero sentire l'età e la concorrenza del molto più giovane e aguerrito Emmanuel Thomas, tanto che fu costretto a vendere il suo erbario e terminò i suoi giorni in miseria. Oltre all'eponimo di diverse specie, lo ricorda il genere asiatico Schleichera (Sapindaceae). 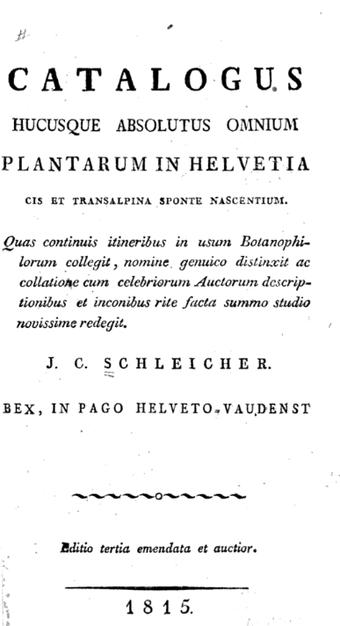 Campioni d'erbario e semi a modico prezzo Intorno al 1790, si stabilì a Bex nel Vaud un giovane di origine tedesca, Johann Christoph Schleicher (1768/70-1834), che nella nuova patria si sarebbe fatto chiamare anche Jean Charles. Talvolta viene definito dottore, ma era piuttosto farmacista, e difficilmente, per la giovane età, avrà avuto una formazione completa. Dei suoi primi anni sappiamo pochissimo. Incerta è la stessa data di nascita, 1768 secondo alcune fonti, 1770 secondo altre. Nato a Hofgeismar nell'Assia da Anna Marie Sawitzky, ebbe inizialmente il cognome materno per poi assumere quello con cui è noto quando fu adottato da un certo Carl Schleicher. Nulla sappiamo della sua formazione; secondo varie fonti, incluso il data base biografico dell'Università di Gottinga, il botanico Heinrich Schräder sarebbe stato il suo padrino; la notizia è certamente priva di fondamento per banali ragioni anagrafiche: i due erano praticamente coetanei, essendo nato Schräder nel 1767. Al momento dell'arrivo di Schleicher, a Bex il ricordo (e il magistero) di Albrecht von Haller era tenuto vivo, oltre che dall'attività commerciale della famiglia Thomas, dai medici Bernard Jean François e Jean David Ricou. Bernard Jean François Ricou (1730-1798), medico cittadino, farmacista e capo chirurgo dell'ospedale, negli anni '50 era stato uno dei raccoglitori di von Haller, per il quale aveva erborizzato nelle valli di Saint-Nicolas e di Bagnes e nelle regioni del Sempione, del Gran San Bernardo, di Alesse e di Fully. Nel 1764, insieme al pastore Abram-Louis Decoppet, pubblicò nelle "Memorie della società economica" di Berna una lista di 128 piante della flora elvetica con i nomi in dialetto, francese e latino (Essai d'une collection de noms vulgaires ou patois des principales plantes de Suisse). Certamente si deve a lui la creazione del "bell'erbario" segnalato nel 1804 nella guida della Svizzera di Johann Gottfried Ebel, all'epoca di proprietà del figlio Jean David, anch'egli medico. Schleicher dovette legarsi strettamente alla famiglia Ricou (probabilmente lavorò per loro come aiuto farmacista e nel 1797 sposò Julie, figlia di Jean David) e fu probabilmente l'esempio delle raccolte di Bernard Jean François a spingerlo a sua volta a percorrere le montagne alla ricerca di piante rare. Il suo scopo era chiaramente commerciale: l'opera di von Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici e degli amatori sulla flora elvetica e il mercato di campioni d'erbario era fiorente. Dotato di notevole spirito imprenditoriale, ispirato dall'esempio di raccoglitori di piante tedeschi, già nel 1794, nel numero 41 della rivista di Lipsia "Annalen der Botanik" Schleicher, sotto forma di lettera ai signori Le Royer e Tingry, proprietari di un'importante farmacia di Ginevra, offrì in vendita, al prezzo di 2 talleri francesi, una centuria di piante svizzere, assicurando la consegna in 4-6 settimane. Altre due centurie avrebbero fatto seguito nel numero successivo, pubblicato lo stesso anno. Nel 1796, ancora su "Annalen der Botanik" la snelle centurie si trasformarono in una più ambiziosa lista di quasi 700 "piante raccolte nel Vallese e nelle Alpi vicine nel 1795 da Schleicher", indicate con un nome binomiale, preceduto però (tranne un'appendice di una quarantina di specie scoperte successivamente alla pubblicazione di quest'opera) dal numero con cui compaiono in Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata di von Haller; non compaiono più né prezzi né indicazioni esplicite del fine commerciale, non perché Schleicher avesse cambiato intenzioni, ma probabilmente perché aveva ormai una clientela consolidata. Due anni dopo, sempre sulla stessa rivista, comparve una seconda lista sotto il titolo "Indice delle piante raccolte nel Vallese e nella Svizzera transalpina nel 1796 da C. Schleicher"; le modalità erano le stesse, ma la lista si era allungata, passando da 9 a 12 pagine, e, soprattutto, ora compariva a parte un elenco di 84 Musci & Algae (in realtà ci sono anche felci e numerosi licheni). Si trattava di un nuovo segmento di mercato che, come vedremo, sarebbe diventato una specialità del raccoglitore tedesco. Poi, nel 1800, il salto di qualità. Con quello che dovette essere un notevole impegno anche finanziario, Schleicher pubblicò a Bex quello che è considerato il primo catalogo commerciale di piante svizzero, Catalogus plantarum in Helvetia cis- et transalpina sponte nascentium; il sottotitolo precisa: "raccolte dall'autore con continui viaggi ad uso dei botanofili e verificate con sommo studio sulle descrizioni e le immagini degli autori più celebri". Nel volumetto di una settantina di pagine sono elencate circa 2000 piante, con il nome binomiale seguito dal nome d'autore e preceduto, nella maggior parte dei casi, dal rinvio numerico all'opera di Haller. Mentre le felci sono elencate nel catalogo generale, sono presentate nuovamente a parte alcune centinaia di Musci, Algae et Fungi. A chiudere il catalogo, una selezione di semi "raccolti e offerti da Schleicher"; come facevano anche i Thomas, anche i semi, come i campioni d'erbario, erano per lo più raccolti in natura. Anzi, da questo punto di vista sembra che Schleicher non andasse tanto per il sottile; secondo una nota pubblicata nel "Bulletin de l’Association pour la protection des plantes" del 1884, "distrusse [appositamente] diverse specie al solo scopo di aumentare il valore dei campioni che vendeva agli erbari, rendendole rare". Almeno alcune piante tuttavia dovevano essere coltivate nell'orto botanico che Schleicher aveva creato a Bévieux, non lontano dalla salina. Sempre secondo la guida di Ebel, meritava una visita; dopo aver parlato dell'erbario di Ricou, egli ci informa inoltre che "Suo genero M. Schleicher, abile erborizzatore che ha percorso gran parte delle montagne della Svizzera occidentale e meridionale, ha un consideravole magazzino di piante essiccate che vende per un luigi il centinaio. Ha scoperto una quantità di specie prima sconosciute in Svizzera". Per qualche anno il commercio di piante di Schleicher dovette andare a gonfie vele; numerosi suoi campioni sono presenti nei principali erbari europei; era in corrispondenza con molti importanti botanici (vendette molti esemplari a Balbis e ci è rimasta una lettera a Persoon); forniva semi al celebre vivaio londinese Loddiges che lo cita come fornitore di varie piante alpine offerte per la prima volta sul mercato britannico. L'ampliamento dell'offerta è testimaniato dalle successive edizioni del catalogo (1807, 1815, 1821, le ultime due con il titolo Catalogus hucusque absolutus omnium plantarum in Helvetia cis et transalpina sponte nascentium), e da una serie di cataloghi specifici, uno riservato ai salici (1807) e diversi alle crittogame (Plantae Cryptogamicae Helvetiae 1803-1807), parzialmente riprodotti nella rivista diretta da Schräder "Neues Journal für die Botanik", nella quale nel 1805 Schleicher pubblicò anche il resoconto di un viaggio nella Svizzera italiana. Nelle liste delle crittogame si precisa che esse erano state reccolte e essicate da Schleicher; la precisazione è significativa se considerimo che al raccoglitore tedesco si deve l'introduzione del sublimato corrosivo (cloruro di mercurio) per la trattazione dei campioni d'erbario. Tra riedizioni, supplementi e cataloghi specifici, le pubblicazioni si intensificarono tra il 1803 e il 1808, poi intorno al 1815 il successo dovette cominciare a declinare. Ne è spia la curiosa iniziativa che Schleicher prese nel 1816: una lotteria il cui premio era costituito da exsiccata. Probabilmente, incominciava a farsi sentire la concorrenza dei fratelli Thomas, che avevano pubblicato il loro primo catalogo intorno al 1806. Seguendo il loro esempio, nel catalogo del 1815, Schleicher aggiunse all'offerta minerali e plantule di conifere; c'erano anche campioni di erbario di piante esotiche, provenienti da Francia meridionale, Italia e Ungheria, e prezzi differenziati: cento esemplari costavano 36 lire francesi per acquisti di meno di 200 campioni, 30 lire da 200 a meno di 400, solo 24 lire da 400 in su. Offriva inoltre erbari completi della flora Svizzera, collezioni di piante medicinali, i semi di "tutte le piante che si coltivano o si possono coltivare in giardino" al costo di 24 lire il centinaio, piante a radice nuda pronte da piantare a 6 soldi l'una quelle erbacee, 9 soldi quelle arbustive e arboree. L'offerta non finiva qui. Leggiamo infatti: "Quest'anno e i seguenti, se Dio vorrà, a casa mia nel villaggio subalpino di Bex, darò lezioni di botanica - un corso completo di questa scienza - ai giovani botanici che me ne faranno richiesta. Quando il tempo lo permetterà, accompagnerò gli allievi in escursioni botaniche, non solo perché vedano e raccolgano le piante nel loro luogo natale, ma anche perché osservino con me le caratteristiche della flora d'altitudine. Mostrerò loro il metodo per essiccare le piante durante il viaggio stesso, in modo che conservate nel modo più perfetto possano ornare l'erbario". Lezioni in lingua francese e prezzi da concordare. Sei anni dopo, nella quarta e ultima edizione, escursioni botaniche e lezioni private non ci sono più (ora Schleicher era sulla cinquantina, e probabilmente non se la sentiva più). Scompaiono anche i minerali, mentre rimangono inalterati prezzi e offerta di exisiccata, erbari completi, semi e piante vive. Compare invece una nuova postilla che ci informa su cosa coltivasse Schleicher nel suo giardino botanico: "Oltre alle piante svizzere, coltivo un grande numero di sassifraghe esotiche, indicate in una speciale appendice in calce al catalogo. In questo giardino spuntano già diverse specie dei generi Aconithum, Delphinium, Narcissus e Allium di cui gli amanti di questi generi possono trovare presso di me un catalogo annuale, sia delle specie che possiedo sia di una moltitudine di piante esotiche che giungono per scambi con gli amici". Non abbiamo traccia di questi cataloghi annuali (erano forse manoscritti? o non furono mai realizzati?). In ogni caso, gli anni felici erano orami alle spalle. Vecchio e malato, Schleicher non poteva più salire in montagna e per sopravvivere dovette smantellare il suo prezioso erbario personale. Contrasse molti debiti; tra i suoi creditori c'era anche Emmanuel Thomas, al quale fu costretto a cedere, come pagamento, tutte le crittogame dell'erbario e diversi generi di fanerogame. Nel 1832 si rivolse al Consiglio di Stato per mettere in vendita quanto rimaneva: "Dal momento che la mia età e la mia salute non mi consentono più di salire in montagna e di continuare il mio commercio di piante, mi vedo costretto a vendere la mia biblioteca e il mio erbario per vivere". Le autorità incaricarono della perizia il direttore delle saline Jean de Charpentier, che provvide con l'assistenza dell'amico Emmanuel Thomas; nella sua relazione, emerge che l'erbario delle piante straniere (circa 10.000) "un tempo veramente magnifico, ha considerevolmente perso valore perché ne sono state tolte le specie più rare e interi generi"; per contro, il lotto di 4073 specie e varietà della flora svizzera "era ed è ancora unico nel suo genre, perché è senza discussione la collezioni più completa e curata della Svizzera. Vi si trovano non solo le piante selvatiche, ma anche le variazioni che subiscono in coltivazione". La vendita andò in porto e l'erbario delle fanerogame fu acquistato dal Museo di scienze naturali di Losanna. Schleicher investì una parte del ricavato per riscattare gli esemplari che aveva dovuto cedere a Emmanuel Thomas. Morì due anni dopo, nel 1834; nel 1837 gli eredi vendettero allo stesso museo l'erbario delle crittogame. La parte più preziosa di questa collezione è costituita dai licheni; nella proposta d'acquista dei conservatori del museo leggiamo: "Questa collezione, composta da più di 1060 campioni, la maggior parte su pietra o legno, è preziosa da ogni punto di vista [...]. Ha grande valore agli occhi dei botanici perché i campioni sono stati determinati con cura e perché è il frutto del lavoro di molti anni ed ha potuto essere formata solo a prezzo di pene, cure e spese".  Dalla Svizzera all'Asia sud-orientale Il significativo ruolo per la conoscenza della flora elvetica di questo farmacista divenuto cacciatore e commerciante di piante alpine è testimoniato dalla sua notevole presenza nella nomenclatura botanica. In primo luogo, anche se i suoi cataloghi sono meri elenchi, grazie al riferimento numerico alla flora di Haller (che, lo ricordo, usava nomi polinomiali, quindi non validi) ha introdotto alcuni nomi validi, come Hieracium canescens e Cnicus nudiflorus. Più numerose le denominazioni risalenti a lui ma introdotte attraverso altri autori che lo conobbero, erborizzarono con lui o furono sui clienti, come Campanula excisa introdotto da Murith, Phyteuma umile, Pedicularis ascendens e Festuca valesiaca introdotti da Gaudin, Lotus alpinus introdotto da Ramond. Una ventina di taxa portano in suo onore gli epiteti schleicheri e schleicherianus; si tratta di specie delle Alpi elvetiche per lo più presenti nei suoi cataloghi o nel suo erbario, ma in qualche caso anche da lui introdotte nei giardini britannici attraverso i vivai che acquistavano i suoi semi. Quattro sono tuttora validi: Alpagrostis schleicheri, Erigeron schleicheri, Fumaria schleicheri, Rubus schleicheri. Nel 1806 Willdenow, direttore di uno degli orti botanici cui forniva campioni e sementi, quello di Berlino, gli dedicò il genere Schleichera, purtroppo senza esplicitare la motivazione; si limitò infatti a scrivere "Ho nominato questo genere in memoria del celebre Schleicher, svizzero". Con questo genere monotipico della famiglia Sapindaceae ci allontaniamo dalle Alpi svizzere per spostarci sulle pendici dell'Himalaya, sull'altopiano del Deccan e nelle foreste del sudest asiatico. Il suo unico rappresentante S. oleosa è infatti un albero tropicale presente soprattutto nelle aree aride e aperte del subcontinente indiano, di Ceylon, della Thailandia e dell'Indonesia. L'epiteto è dovuto all'alto contenuto di olio dei suoi semi; quest'ultimo, noto come olio di kusum, dal nome più comune della pianta in India, viene utilizzato per la cura dei capelli, ma anche come combustibile, in cucina e come unguento medicinale.
0 Comments
Non è raro che un genere celebrativo onori allo stesso tempo due persone: un padre e un figlio, come Tradescantia per i due John Tradescant, due fratelli come Bauhinia per Jean e Gaspard Bauhin, magari due ricercatori che hanno collaborato, come Whitesloanea per gli specialisti di Cactaceae A. C. White e B. L. Sloane. Tuttavia è certo eccezionale il caso del genere Thomasia che celebra ben cinque persone, ovvero tre generazioni della stessa famiglia, quella dei raccoglitori e commercianti di piante svizzeri Thomas. A inaugurare la serie è a metà Settecento Pierre, guida e raccoglitore di Albrecht von Haller; quindi suo figlio Abraham, che ne prosegue l'attività e collabora con molti botanici affascinati dalle piante alpine; infine i suoi tre figli Philippe, esploratore della flora sardo-corsa, Louis, grande raccoglitore della flora calabra e collaboratore di Tenore, e Emmanuel, che trasformò la raccolta di piante e semi in un'impresa commerciale di successo. Tutti insieme scrissero una pagina importante della scoperta delle piante svizzere (ma anche italiane). I fondatori: Pierre e Abraham Nel 1754 il grande scienziato Albrecht von Haller venne nominato sovrintendente delle saline del distretto di Aigle nel Vaud, di proprietà del cantone di Berna. Egli prese molto sul serio l'incarico, benché gli garantisse entrate più che modeste: gli permetteva infatti di ritrovare l'amato paesaggio delle Alpi, alle quali in gioventù aveva dedicato un celebre poema, e di riprendere le ricerche sulla flora svizzera, in vista della seconda edizione ampliata della sua Enumeratio metodica stirpium Helvetiae indigenarum (la prima edizione era uscita nel 1742). Dal 1758 al 1764 visse nel castello di Roche, come un po' pomposamente veniva chiamata la dimora del sovrintendente, vi traferì la sua immensa biblioteca, il suo studio e il suo laboratorio; finché l'età e la salute glielo permisero, percorreva regolarmente le foreste e le montagne del distretto, sia per assolvere le sue funzioni sia per raccogliere piante e studiarle dal vivo. A fargli da guida erano le guardie forestali dipendenti dalle saline, alle quali demandò la raccolta di piante, quando per lui si fece difficile salire in montagna, o, come si espresse poeticamente, "alzarsi come un uccello sulle altezze". Insegnò loro a raccogliere e seccare correttamente gli esemplari, a distinguere le piante rare, a osservare e annotare i luoghi di raccolta, le condizioni di crescita, gli habitat. Nella prefazione a Historia Stirpium Indigenarum Helvetiae Inchoata, Haller ricordò con gratitudine i nomi di alcuni di loro; tra tutti spiccano quelli di Pierre Thomas (1708-1781) e di suo figlio Abraham (1740-1824). Pierre era un montanaro di Frenières; abitava con la moglie Madeleine in uno chalet della frazione di Les Plans, situata a circa 1000 metri in una valle circondata da imponenti monti calcarei; dai documenti risulta che fu assunto ufficialmente come guardia forestale delle saline nel 1761, ma il suo incontro con Haller risale a diversi anni prima. Anche se la sua istruzione era quella modesta dell'abitante di un piccolo villaggio di montagna, era dotato di intelligenza naturale, di una grande capacità di osservazione ed era un camminatore instancabile; a cementare l'insolita amicizia tra questo montanaro taciturno e il patrizio bernese Haller, il comune amore per la montagna e le sue piante. Pierre dapprima lo accompagnò alla scoperta delle montagne che circondano Les Plains, poi percorse per lui alla ricerca di piante il Vallese, i Grigioni e si spinse fino alle Alpi italiane. Ecco l'itinerario di uno di questi viaggi: nel 1763, partito da Bex, Pierre attraverso il passo di Cheville che collega il Vaud con il Vallese raggiunse Zermatt, quindi passò in Valtournenche, rientrando attraverso il colle del Gran San Bernardo. Gli era compagno il figlio Abraham, che partecipava alle raccolte paterne fin da bambino; era così abile e sveglio che appena diciottenne fu inviato da Haller ad esplorare da solo l'area del Furka. L'opera di Haller aveva attirato l'attenzione dei botanici sulla flora delle montagne svizzere e il ritorno dello studioso a Berna (il suo incarico terminò nel 1764) non mise fine alle attività botaniche di Pierre ed Abraham, che anzi si traformarono in un piccolo commercio. I Thomas accompagnavano i visitatori come guide in spedizioni botaniche, raccoglievano e preparavano esemplari per i collezionisti; si deve probabilmente a Abraham la creazione di un piccolo orto botanico dove seminava piante alpine destinate soprattutto alla produzione di sementi e piante vendute a radice nuda. Nel 1775, per essere più vicini ai potenziali clienti, i Thomas trasferirono la loro abitazione a Fenalet, a metà strada tra i Plans e Bex. Pierre incominciava a sentire il peso dell'età; nel 1764 chiese alla direzione delle saline di essere affiancato come guardia forestale dal figlio, che nel 1779 gli subentrò. Due anni dopo Pierre moriva all'età di 73 anni. Grazie alle testimonianze dei diversi visitatori che nell'ultimo quarto del secolo frequentarono la casa di Fenalet, trasformata in un vero e proprio cenacolo di botanica da Abraham, conosciamo il figlio molto meglio del padre. Il giardiniere e botanico Thomas Blaikie (il creatore del parco di Bagatelle) che fu più volte ospite dei Thomas nel 1775, ha scritto di lui: "superava suo padre in intelligenza. Era dotato di un'agilità, di un vigore e di una memoria stupefacenti, accompagnati da un vero genio per l'osservazione". Un altro habitué, il poeta tedesco Matthison, afferma: "quest'uomo conosce a memoria e in modo esatto la flora alpina [...]. Mostrategli una qualsiasi montagna del Vallese o del distretto di Aigle: vi indicherà in modo infallibile le piante di ogni zona, il mese di fioritura, se all'ombra o al sole, nelle paludi o vicino a una sorgente, nel bosco o tra le rocce". Furono molti i visitatori che approfittarono della sua sapienza (e della sua agilità: sempre secondo Matthison, già vecchio nelle arrampicate ancora sfidava camosci e stambecchi)le della generosa ospitalità di sua moglie Marie-Susanne-Catherine Echenard - una grande appassionata di mitologia, sempre con un libro in mano mentre si occupava della cucina e delle faccende di casa: il botanico ginevrino Jacques Roux, il naturalista di Nechâtel Louis Perrot, il pastore e botanico Gaudin, autore di Flora helvetica, l'allievo di questi Jacques Étienne Gay, il canonico Laurent-Joseph Murith, autore del primo libro dedicato alla flora del Vallese, Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais, che molto deve all'assistenza di Abraham Thomas e di suo figlio Louis, costante compagno di viaggio del canonico. Murith collezionava anche minerali, conchiglie e fossili, che probabilmente su suo suggerimento andarono ad aggiungersi agli oggetti naturali raccolti e forniti dai Thomas. In quarant'anni di attività, Abraham fece progredire la conoscenza delle piante alpine, percorrendo e ripercorrendo le valli di Saas, Saint-Nicolas, Bagnes, Anniviers, Hérens e Binn, le pendici del Gran San Bernardo, del Cervino, del Monte Moro e i passi del Sempione, del Gries, del Furka, del Grimsel, della Gemmi, e molti altri. Stimato dai concittadini, nel 1781 fu nominato "giustiziere e consigliere di Bex per la competenza di Fenalet". Intorno al 1802, la famiglia si spostò ai Dévens, dove Abraham fece costruire per la comodità dei suoi ospiti la "casa rossa", attorno alla quale trasferì il suo orto botanico alpino. Una sola cosa mancava a quest'uomo ammirevole: il senso degli affari. Era troppo generoso con i suoi clienti, che considerava più che tali amici ed ospiti, per arricchirsi con il commercio di exsiccata, sementi, minerali, conchiglie, e di un "tè svizzero" la cui formula gli era stata insegnata da von Haller in persona. Mme la justicière trattava fin troppo generosamente i visitatori che, tra una scalata e l'altra, erano ospiti dello chalet di Fenalet e il marito non di rado inseriva una pianta rara, a titolo gratuito, nel plico di un invio. Intanto la famiglia cresceva: la coppia Thomas ebbe sette figli, due femmine e cinque maschi, ma solo tre raggiunsero l'età adulta: in ordine di età, Philippe, Louis e Emmanuel. .  I figli: Philippe, Louis e Emmanuel Come il nonno e il padre, i tre ragazzi Thomas avevano la botanica nel DNA. Fin da piccoli furono abituati a percorrere le montagne e ad imparare a distinguere le piante direttamente dal libro della natura, ma contrariamente a loro poterono anche viaggiare e godere di un'educazione formale. Quello che conosciamo meno è il maggiore dei tre sopravvissuti, Philippe (Pierre-Philippe-Louis, 1782-1831), al quale finora non è stato dedicato alcun studio approfondito, nonostante la sua importanza tra i primi esploratori della flora corso-sarda. Sappiamo che studiò medicina e che, oltre che in Svizzera e sulle Alpi, fece raccolte nei Pirenei. Nel 1814 fu la guida di William Jackson Hooker in un ampio viaggio in Svizzera. In una lettera di diversi anni dopo a Henry Fox Talbot, Hooker lo ricorda così: "Il Thomas che mi accompagnò in larghissima parte della Svizzera era Philippe; lo considero un compagno eccellente e onorevole, profondo conoscitore della botanica dell'intero paese [...]. Thomas intendeva visitare alcune isole del Mediterraneo". Qualche anno dopo avrebbe realizzato il suo sogno trasferendosi come medico a Cagliari, dove giunse tra il 1823 e il 1825. Presto entrò in contatto con Moris, di cui divenne uno dei più assidui collaboratori; in Flora sardoa, è citato quasi cento volte per esemplari raccolti sia in Sardegna, sia (sono i più numerosi) in Corsica. Doveva spedire regolarmente le sue raccolte al fratello Emmanuel che vendette piante sarde a musei, orti botanici e collezionisti. Ne troviamo un elenco nei due cataloghi (Catalogue des plantes de Sardaigne, qui se vendent chez Emmanuel Thomas, à Bex), pubblicati da Emmanuel rispettivamente nel 1837 e nel 1841. All'epoca però Philippe era già morto; morì infatti a Cagliari nel 1831. Un ruolo ancora più importante di quello di Philippe per la flora sardo-corsa ebbe Louis (Charles-François-Louis-Alexandre, 1784-1823) per la flora del regno di Napoli. Anch'egli naturalmente ricevette l'addestramento paterno en plein air e fu frequente compagno di escursioni del canonico Murith, che fu dunque il suo secondo maestro. Aveva ereditato dal nonno e dal padre l'occhio clinico e ancora ragazzo scoprì nuove specie. Ma fece anche buoni studi: studiò latino e scienze naturali, quindi si spostò a Parigi e al Jardin des Plantes seguì le lezioni di botanica di Desfontaines e quelle di mineralogia di Haüy. Quindi viaggiò nel sud della Francia, nella Repubblica di Genova, in Piemonte e in Lombardia, dove frequentò per qualche tempo l'università di Pavia. Ritornato in patria, fu nominato guardia forestale del distretto di Aigle. Probabilmente progettava di rimanere in Svizzera e di rilanciare su basi economicamente più solide l'attività di famiglia. Seguendo l'esempio di un vicino e concorrente, J.-C. Schleicher, un farmacista di origine tedesca considerato l'inventore del primo catalogo commerciale di piante, Louis predispose e fece stampare il primo Catalogue de plantes suisses, pubblicato intorno al 1806. Nell'avvertenza ai lettori, Louis scrive: «Sull'esempio di mio padre, al quale l'immortale Haller ispirò il gusto per la botanica, consacrandone il nome nei suoi scritti, anch'io, fin dalla più tenera giovinezza ho dedicato gran parte del mio tempo a percorrere diverse parti della Svizzera, e soprattutto le Alpi, nelle cui vicinanze abito. Avendo così formato una numerosa collezione di piante, di cui posso fornire agli amatori esemplari ben preparati, così come semi e radici di specie rare che io coltivo a tale scopo in un giardino, ho ritenuto di dover porre sotto gli occhi del pubblico il catalogo di queste piante. Avrei potuto aumentarlo con un gran numero di specie comuni che non mi è sembrato necessario nominare; tuttavia coloro che desiderano procurasi un erbario completo della Svizzera lo troveranno presso di me». Forse alla fine del 1806 o all'inizio del 1807, il giovane botanico slesiano Berger, in viaggio per le Calabrie da poco riconquistate dai francesi, di passaggio in Svizzera propose a Louis di unirsi a lui nell'esplorazione della flora di quella regione ancora tutta da scoprire. Egli accettò e i due, muniti di salvacondotti, poterono fare ampie raccolte, che poi affidarono per la pubblicazione a Michele Tenore. Sulla strada del ritorno, erborizzarono in Puglia, quindi rientrarono a Bex dove si divisero. Ma Louis non rimase a lungo in patria; egli soffriva di una grave forma di asma, aggravata dal rigido clima alpino. In Italia era entrato in contatto con Louis Reynier, un funzionario originario del Vaud, appassionato di botanica; nel 1808 Murat lo nominò direttore delle poste e responsabile delle foreste. In questa veste, egli offrì a Louis Thomas l'incarico di ispettore forestale delle due Calabrie. Egli assolse così bene questa funzione che il governo borbonico gli mantenne l'incarico, aggiungendovi anzi la direzione di una salina. Con le sue raccolte della flora calabra, diede un prezioso e imponente contributo alla Flora napoletana di Tenore che così scrive di lui "diligentissimo e dotto botanico, corrispondente al Real Giardino per le Calabrie", arrivando addirittura a definirlo "divus Thomas". Anche se non pubblicò nulla, il suo contributo è ricordato dalle numerose specie da lui scoperte e dedicatogli da Tenore: Crocus thomasii, Sison thomasii, Cerastium thomasii, Quercus thomasii, Ranunculus thomasii, Campanula thomasii. Purtroppo anche in Calabria la sua asma andò progressivamente aggravandosi e Louis Thomas morì nel 1823, a soli 39 anni. A portare avanti gli affari di famiglia rimaneva il solo Emmanuel (Abraham Louis Emmanuel 1788-1859). Aveva ricevuto la stessa educazione dei fratelli e ne condivideva la competenza botanica e l'occhio del raccoglitore, ma in più aveva il senso degli affari. Fu lui a trasformare il piccolo commercio avviato dal nonno e dal padre in un'impresa commerciale di risonanza europea. Come il nonno Pierre aveva scoperto la botanica grazie a Haller, così Emmanuel trovò un amico in un grande studioso, Jean de Charpentier. Nominato direttore delle saline nel 1813, egli le rilanciò, sostituendo l'estrazione diretta del salgemma allo sfutttamento delle acque delle sorgenti salate che andavano progressivamente esaurendosi. Appena arrivato a Dévens, in attesa che la direzione delle saline gli costruisse una casa, Charpentier si stabilì al primo piano della casa rossa, mentre i Thomas abitavano al piano terra. Tra Emmanuel Thomas e Charpentier si stabilì una grande amicizia e uno scambio scientifico, che andava nelle due direzioni: grazie a Charpentier, Thomas divenne un eccellente conoscitore dei minerali della Svizzera, mentre a sua volta incoraggiò Charpentier a creare un erbario e lo assisté nella stesura della sua unica opera di botanica (Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans les districts d'Aigle). Ma soprattutto, la presenza di Charpentier (divenuto una celebrità europea per i suoi studi sui ghiacciai) attirò ai Dévens molti rinomati naturalisti. La casa rossa e la casa del direttore delle saline sorgevano l'una vicina all'altra e le piante - alpine ma anche esotiche - passavano da un giardino all'altro, così come i visitatori. Tra di loro, per citare solo qualche nome più familiare agli amanti della botanica, troviamo Alphonse de Candolle, Adrien de Jussieu, Jean Gaudin, Jean Muret, creatore del più completo erbario della flora svizzera; tra i geologhi, Charles Lardy, Elie de Beaumont, Leopold von Buch, Louis Agassiz. L'attività commerciale di Emmanuel è testimoniata dai tre cataloghi (Catalogue des plantes suisses qui se vendent chez Emmanuel Thomas à Bex) che egli pubblicò tra il 1818 e il 1841, cui vanno aggiunti i due già citati cataloghi di piante sarde e due supplementi, usciti rispettivamente nel 1842 e nel 1853. Il più ricco è quello del 1837 che offre più di 600 generi e quasi 2000 specie. Il grosso è costituito da gimnosperme e angiosperme, ma c'è anche una discreta scelta di felci e qualche equiseto e licopodio. Il catalogo del 1841 è invece interamente dedicato alle crittogame e ai licheni, per reggere la concorrenza di Scleicher che era uno specialista di muschi e licheni. Per mettere insieme le collezioni, Emmanuel Thomas continuava a raccogliere in natura, viaggiava molto raccogliendo anche in Piemonte, nelle Alpi italiane, in Austria; per curare le relazioni con la sua clientela internazionale (musei, orti botanici, studiosi, grandi collezionisti) fu anche a Vienna, Parigi, Londra, dove visitò l'esposizione universale. Una parte dello stock di piante vive e semi, probabilmente minoritaria, era coltivata nel giardino-vivaio di Dévens, di cui però non conosciamo l'estensione (dunque neppure le capacità produttive). I prezzi erano modici e le consegne relativamente rapide. Una delle specialità erano le conifere. Nel 1807 già Abraham Thomas pubblicò una memoria sull'utilità di pini e abeti per il rimboschimento. Tra il 1835 e il 1872, la famiglia Thomas consegnò 250.000 pianticelle e più di quattro tonnellate di semi di larice, abete rosso e bianco, pino cembro e altre conifere. Il cliente più importante era il cantone del Vaud, ma molte piante venivano inviate in altre parti della Svizzera, in Francia o addirittura in Inghilterra. Il commercio delle conifere acquistò sempre più importanza mano a mano che ne perdeva quello di exsiccata e piante rare. Dopo la morte di Emmanuel nel 1859, la ditta continuò sotto la direzione del figlio Jean-Louis (1824-1886) e poi dei suoi discendenti, ma i tempi d'oro erano terminati. Gli erbari dei musei e dei grandi orti botanici possedevano già esemplari anche delle piante svizzere più rare e tenere un erbario non era più un hobby alla moda, la concorrenza era sempre più forte e nessuno cercava più guide alpine esperte di piante. Il cliente principale divenne il vivaio Vilmorin, al quale i Thomas inviavano piante vive e sementi. Sempre più in crisi, resistettero fino al 1900, quando la ditta cessò di esistere. Ai Dévens si possono ancora vedere la casa rossa e la casa grigia, che Emmanuel fece costruire intorno al 1825, poco dopo la nascita dell'unico figlio maschio Jean-Louis. L'orto botanico di Abraham e Emmanuel è tornato ad essere un semplice orto. Tuttavia nel 1891 per iniziativa della città di Bex il botanico Ernest Wilczek, direttore dell'orto botanico di Losanna, creò un orto botanico alpino nella Valle di Nant, al di sopra dei Plans-sur-Bex, dove era iniziata l'epopea dei Thomas. Battezzato in loro onore La Thomasia, ospita un arboreto e una collezione di quasi 3000 piante alpine provenienti da tutto il mondo.  Un genere australiano per i botanici delle Alpi Abbiamo già visto che Tenore dedicò al "divus Thomas" diverse specie. Lo stesso onore è toccato ai fratelli Philippe, ricordato da specie della flora corsa come Armeria thomasii (oggi A. leucocephala) o sarda come Olopitum thomasii, ed Emmanuel, ricordato da una quindicina di specie alpine. Fu però un antico ospite della famiglia, il botanico Jacques Étienne Gay, nato nel Vaud ma fattosi parigino, a celebrare allo stesso tempo tre generazioni della famiglia con la dedica cumulativa del genere Thomasia: "Ho consacrato questo genere agli svizzeri Pierre e Abraham Thomas, contemporaei di Haller, nonché ai fratelli Philippe, Louis e Emmanuel Thomas, figli di Abraham e nipoti di Pierre, che, presi da fervido amore per la botanica, per un sessantennio non cessarono di percorrere le montagne e di conquistare piante per l'uso dei botanofili, che infine, grazie allo loro operosità, diedero un catalogo della flora svizzera tale che oggi essa è considerata tra le più ricche della superficie terrestre". A questi instancabili raccoglitori della flora elvetica però Gay non dedicò un genere svizzero e neppure alpino: le circa trenta specie del genere Thomasia (famiglia Malvaceae, in precedenza Sterculiaceae) sono infatti endemiche dell'Australia sud-occidentale, eccetto T. petalocalyx che è nativa del Victoria nell'Australia sud-orientale. Vivono in diversi ambienti, che vanno dalle dune sabbiose e gli affioramenti rocciosi, come T. sarotes, al sottobosco delle boscaglie come T. solanacea, alle brughiere come T. purpurea, alle foreste di eucalipti come T. petalocalyx. Sono arbusti da nani a medi, spesso con foglie molto decorative e fiori dai colori pastello resi spettacolari non dai petali, assenti o piccoli e non appariscenti, ma dai sepali che formano corolle a coppa o a campana piatta che ricordano un po' quelle dei Solanum. Tra le più notevoli, T. purpurea che al momento della fioritura si ricopre letteralmente di racemi color malva; T. quercifolia, con foglie molto attraenti e fiori rosa-porpora; T. pygmaea, che forma cespugli bassi e compatti ed è adatta anche alla coltivazione in contenitori. Molto apprezzate dal giardinaggio australiano, anche perché molte sono piante da sottobosco che ben si adattano agli angoli ombrosi, sono praticamente sconosciute in Europa. Alcune specie erano commercializzate nei cataloghi ottocenteschi e risulta che nel giardino Ricasoli sul Monte Argentario verso la fine del secolo si coltivasse, insieme a moltissimi altri arbusti australiani, anche T. solanacea. A parte qualche vivaio californiano, oggi non sembra siano commercializzate al di fuori dell'Australia. All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia). 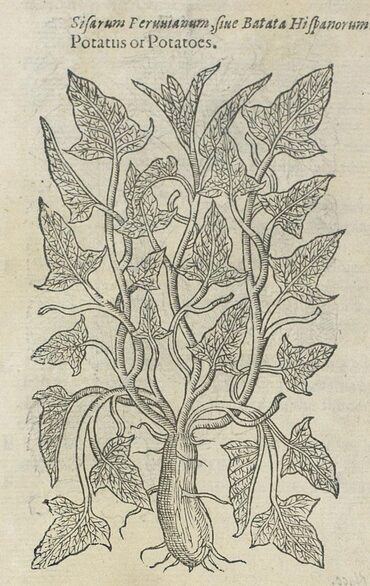 Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa. 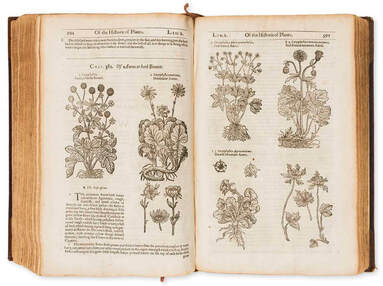 Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice. Se nella generazione dei fondatori del vivaio the Vineyard di Lee e Kennedy la figura di maggior spicco fu James Lee, nella seconda generazione a mettersi in luce fu John Kennedy. Mentre il suo socio si occupava abilmente della conduzione del vivaio, Kennedy badava a far conoscere le ultime novità con i testi di The botanist repository, illustrati da suo genero Henry C. Andrews. A partire dal 1803, il vivaio incominciò a rifornire di piante esotiche il giardino della Malmaison e Kennedy divenne consulente dell'imperatrice Giuseppina, che stava ridisegnando il parco secondo i canoni del giardino all'inglese. Tra le tante esotiche che, a dispetto della guerra e del blocco continentale, the Vineyard continuò a spedire all'imperatrice dei francesi c'erano indubbiamente anche rose, sebbene forse meno di quanto comunemente si crede. Alla collaborazione con Mme Bonaparte Kennedy deve anche la dedica del genere Kennedia, istituito da Ventenat nel bellissimo Le jardin de la Malmaison, illustrato da Redouté.  Piante nuove e rare da tutto il mondo Il momento di massimo fulgore di the Vineyard coincise con la gestione del secondo dei Kennedy, John (1759–1842), figlio del fondatore Lewis. Dovette iniziare a lavorare nel vivaio fin da ragazzino, e nel 1782, alla morte del padre, gli succedette alla testa dell'azienda a fianco di James Lee e poi, alla morte di questi nel 1795, del figlio James junior. Certo, anche quest'ultimo dovette essere un validissimo uomo d'affari, come lo era stato il padre, se lasciò ai figli un notevole patrimonio che permise loro di rilevare l'intero vivaio, quando John Kennedy si ritirò; ma certamente dopo la morte di James Lee senior il volto ufficiale della ditta, il nome più riconosciuto anche a livello internazionale, fu quello di Kennedy. La seconda generazione di the Vineyard rimase fedele alla strategia già adottata dai fondatori: cercare, moltiplicare e commercializzare piante "nuove e interessanti" e "novità di valore", come si legge in una lettera di James Lee junior a William Aiton. Un documento di grande interesse per conoscere le introduzioni del vivaio a cavallo dei due secoli sono i primi cinque fascicoli di The botanist repository, i cui testi furono redatti in gran parte dallo stesso John Kennedy. La rivista, che uscì tra il 1797 e il 1814, come ben specifica il sottotitolo for new and rare plants, era specificamente dedicata alle piante di recentissima introduzione e fu il più serio concorrente del Curtis's Botanical Magazine, rispetto al quale aveva meno pretese di scientificità: le illustrazioni, disegnate da Henry Cranke Andrews, che era anche l'editore, erano di grande impatto visivo, ma spesso imprecise e mancanti di particolari utili all'identificazione, così come i testi erano diseguali e privi di sinonimi e rimandi bibliografici. La rivista infatti non si rivolgeva tanto ai botanici quanto agli amatori e ai proprietari di giardini. Le illustrazioni di Andrews sono accompagnate da una breve descrizione bilingue (in latino e in inglese) e da un testo inglese con informazioni sulle peculiarità più desiderabili della pianta, la sua provenienza, le date di introduzione e di prima fioritura, le esigenze di coltivazione. Come ho anticipato, i testi dei primi cinque fascicoli, anche se non sono firmati, furono con grande probabilità scritti da John Kennedy; quelli del vol. 6 si devono a Adrian Haworth e quelli dei voll. 7-10 a George Jackson (voll. 7-10). Andrews forse fu incoraggiato a intraprendere l'impresa proprio da John Kennedy, che nel 1801 divenne suo suocero. Nei volumi curati da Kennedy, usciti tra il 1797 e il 1811, 40 specie risultano direttamente introdotte o almeno coltivate nel vivaio di Hammersmith (citato invece una sola volta nei volumi successivi). Ci sono parecchie bulbose, piante da fiore, arbusti, qualche succulenta, alcune orchidee, ma non sembra prevalere un indirizzo preciso nella scelta delle specie. La data di introduzione più bassa è il 1772, la più alta il 1800 (l'unica specie citata nei volumi successivi risale invece al 1813). Diciassette specie (42.5%) provengono dal Capo di Buona speranza; dodici (30%) dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, il resto dal Nord America, dalle Barbados, dalla Giamaica, dal Brasile, dalla Crimea e da Madera. Spesso il testo si limita a indicare che la pianta è stata introdotta da Lee e Kennedy o che è fiorita per la prima volta nel loro vivaio, ma talvolta ci sono indicazioni più specifiche, illuminanti per ricostruire le vie di introduzione. I due vivaisti potevano all'occorrenza rifornirsi da altri vivai: è il caso di Gladiolus praecox (oggi G. watsonius), acquistato nel 1791 presso Voorhelm & Co. di Haarlem, un vivaio olandese specializzato in bulbi da fiore; o di Rhododendron punctatum (oggi R. minus var. minus), reperito presso il vivaio dell'introduttore, il celebre vivaista e cacciatore di piante James Fraser. Più spesso però ricorrevano agli invii di viaggiatori o residenti all'estero a vario titolo: l'orchidea Prosthechea cochleata fu inviata dalla Giamaica dal botanico dell'isola Thomas Dancer, tramite una certa Mrs. Barrington; un'altra orchidea, Orchis ciliaris (oggi Platanthera ciliaris) fu spedita da Filadelfia da John Lyon, che all'epoca lavorava ancora come giardiniere; diverse piante sudafricane furono procurate da John Pringle, funzionario della Compagnia delle Indie al Capo; la brasiliana Amaryllis reticulata (oggi Hippeastrum reticulatum) fu spedita dal Portogallo da Edward Whitaker Gray. futuro curatore delle collezioni naturali del British museum, all'epoca residente ad Oporto dove aveva sposato l'erede di un importante esportatore di vini. Lee e Kennedy però avevano anche relazioni con orti botanici e studiosi: Pallas inviò i semi di due specie dalla Crimea e i semi di due piante del Capo furono forniti dal curatore dei giardini imperiali di Vienna, ovvero da von Jacquin. Non mancavano gli apporti di collezionisti, probabilmente al tempo stesso fornitori e clienti: è il caso di lady Sophia de Clifford, celebre per la sua collezione di piante esotiche, che condivise con Lee e Kennedy i bulbi di Ixia crispifolia flore coeruleo (oggi Codonorhiza corymbosa) appena ricevuti dal Capo e procurò altre piante sudafricane; oppure di Thomas Jones, creatore del giardino di Hafod in Galles che procurò Geranium punctatum (oggi Pelargonium punctatum). Tra questi contributori illustri, spicca il colonnello William Paterson, dal 1791 al 1793 governatore dell'isola di Norfolk, da cui inviò semi sia a Kew sia ai vivai Lee e Kennedy e Colvill; è citato per più piante tra cui Bignonia pandorana (oggi Pandorea pandorana). Quello di Paterson è l'unico nome menzionato per l'Australia (all'epoca Nuova Olanda); gli altri invii potrebbero essere dovuti a cacciatori di piante, quelli antecedenti il 1792 (l'anno della sua morte) forse a David Burton, che sappiamo lavorò sia per Kew sia per Lee e Kennedy. Potrebbe essere un cacciatore di piante l'altrimenti ignoto Mr. J. Elcock cui si deve l'invio di due specie dalle Barbados tra il 1789 e il 1791. Alcuni degli invii dal Sudafrica e forse anche uno da Madera potrebbero risalire a Francis Masson, che però è citato esplicitamente solo per Protea formosa (oggi Leucospermum formosum). Anche se non è citato in The botanist repository, diverse piante sudafricane furono presumibilmente procurate da James Niven, che nel 1798 o 1799 fu inviato al Capo dal ricco appassionato George Hibbert,per poi tornarvi nel 1805 finanziato da un consorzio di appassionati, giardinieri e vivaisti che, oltre a Hibbert, includeva Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Fornitore della Malmaison Siamo così arrivati alla più celebre dei clienti di the Vineyard: Joséphine de Beauharnais, la prima moglie di Napoleone. Nel 1799, mentre il marito si trovava in Egitto, ricorrendo a un prestito, essa acquistò il castello e il parco della Malmaison, a una quindicina di km da Parigi. Durante il consolato, divenne la residenza dei Bonaparte e tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuileries, fu sede del governo francese, prima di essere sostituita dal più istituzionale Saint Cloud. Per Joséphine era il luogo del cuore, e dopo il divorzio nel 1809 divenne la sua casa. I grandi lavori di trasformazione erano iniziati fin da subito. A partire dal 1800, venne costruita un'aranciera in stile neoclassico, così grande da poter ospitare 500 vasi di ananas; il parco venne ridisegnato secondo lo stile paesaggistico inglese; l'imperatrice si affidò dunque a specialisti britannici come il capo giardiniere Alexander Howatson eil giardiniere paesaggista scozzese Thomas Blaikie, che viveva in Francia da tempo e prima della rivoluzione aveva creato il giardino di Bagatelle per il conte di Artois e il parco Monceau per il duca d' Orlèans. Fu forse proprio Blakie a mettere in contatto Joséphine con Lee e Kennedy. La Malmaison era un giardino sperimentale ricco di piante provenienti da tutto il mondo. Molte piante australiane (ma anche animali) giunsero in seguito alla spedizione Baudin: l'allora prima console aveva ordinato che gli esemplari più belli, anziché al Museo di storia naturale, fossero portati alla Malmaison, il cui parco cominciò a popolarsi di eucalipti e mimose, tra cui scorrazzavano emù e canguri mentre sul laghetto si dondolavano cigni neri. Per avere un angolo da riservare alla sua passione per la botanica, tra il 1803 e il 1805 l'imperatrice fece costruire la Petite Malmaison, che comprendeva una grande serra calda per le esotiche, il primo edificio in Francia a fare ampio uso di vetrate. Contemporaneamente assunse come intendente il botanico Étienne Pierre Ventenat, il curatore del giardino-vivaio di Jacques Cels a Montrouge. Proprio come Lee e Kennedy in Inghilterra (con i quali corrispondeva) Cels era specializzato nella coltivazione e nella propagazione delle piante esotiche riportate dai naturalisti viaggiatori come Michaux o dai grandi viaggi di esplorazione. Egli si riforniva anche dai vivai inglesi ed era in ottime relazioni, nonostante lo stato quasi permanente di guerra, con Joseph Banks. Di questi contatti inglesi poterono approfittare anche il giardino della Malmaison e la sua proprietaria quando la pace di Amiens portò un breve periodo di tregua (marzo 1802-maggio 1804). Attraverso Ventenat, Joséphine si mise in contatto con Banks, che promise il suo aiuto nonché piante di Kew. In una lettera dell'aprile 1803, che accompagna il primo volume dello splendido catalogo Le Jardin de la Malmaison, con i suoi testi e le illustrazioni di Redouté, il botanico ringrazia Banks per le piante finora fornite e esprime l'augurio che la collaborazione posso continuare. Lo stesso anno, Lee e Kennedy ricevettero il primo ordine di piante per il giardino, per l'ammontare di 2600 sterline. Nel 1804, l'imperatrice lamentò accorata che un invio di semi era stato catturato e trattenuto, ma è uno dei rari incidenti di percorso: anche più tardi, quando il blocco continentale in teoria chiuse i porti di Francia ai vascelli inglesi, si continuò a fare eccezione per le navi che trasportavano le piante per i giardini dell'imperatrice. Un altro contatto inglese era George Hibbert, che, consultato per la progettazione del giardino all'inglese, dovette consigliare all'imperatrice di rivolgersi a Kennedy non solo come fornitore, ma anche come giardiniere paesaggista. Da quel momento, come consulente di Joséphine James Kennedy iniziò a fare la spola tra i due paesi, magari per accompagnare di persona qualche pianta particolarmente delicata, e suo figlio Lewis Kennedy (1789-1877) lavorò addirittura per qualche tempo sia alla Malmaison sia a Navarre, la tenuta normanna donata all'ex imperatrice dopo il divorzio (un po' come compensazione, un po' per tenerla lontana da Parigi in occasione delle seconde nozze dell'imperatore). Tra i più importanti risultati della collaborazione tra Mme Bonaparte e il vivaio inglese ci fu l'invio in Sudafrica del raccoglitore James Niven, che probabilmente ritornò al Capo nel 1805 e vi rimase fino al 1812, arricchendo il vivaio di Hammersmith e il giardino parigino soprattutto di eriche (il suo viaggio sudafricano però merita un post a parte). Tutti sanno che la piante preferite di Joséphine erano le rose; lo sanno tutti, ma non è detto che sia vero. Mentre conosciamo bene le piante esotiche coltivate alla Malmaison grazie al già citato catalogo curato di Ventenat e Redouté, proprio la collezione di rose è mal documentata, tanto da essere ritenuta da alcuni più un mito che una realtà. Coloro che visitarono il giardino subito dopo la morte non ne parlano; il celebre Les roses di Redouté, che di solito è ritenuto una sorta di catalogo del roseto dell'imperatrice, in realtà fu creato dal pittore dopo la sua morte (i tre volumi uscirono tra il 1817 e il 1824), ritraendo le rose coltivate in vari giardini e vivai parigini; in precedenza ne aveva dipinte alla Malmaison solo due - R. berberifolia e R. gallica purpurea veluntina. Anche se in molti testi si parla di una collezione di 250 diverse varietà di rose (e alcuni si spingono a specificare quali), le accurate ricerche del collezionista di rose antiche François Jouyaux hanno potuto identificarne solo una minima parte. Lee & Kennedy, insieme a molte esotiche, procurarono certamente all'imperatrice anche rose, in particolare le cinesi rifiorenti che in Francia erano ancora una novità, mentre avevano già incominciato a raggiungere l'Inghilterra da qualche anno - la prima fu introdotta proprio da loro nel 1787; dagli archivi nazionali risultano come introdotte tramite il vivaio di Hammersmith Rosa chinensis, R. multiflora ‘Cornea’, R. semperflorens (generalmente nota come Slaters Crimson China) e la rosa muschiata R. centifolia ‘muscosa alba’ (nota come Shailers White Moss). Dai documenti d'archivio, risulta inoltre che Joséphine importò tramite fornitori non identificati R. pendulina, R. virginiana, tre rose muschiate, una centifolia nota come ‘Unique’. Un altro esperto, Auguste de Pronville, ha aggiunto alla lista R. damascena carnea, una varietà della scozzese R. spinosissima e R. berberifolia. Presumibilmente, l'imperatrice si rifornì anche da vivai parigini, come Cels, Boursault e Vilmorin, ma negli archivi sono testimoniati acquisti solo dal coltivatore di rose amatoriale André du Pont che tra il 1808 e il 1809 procurò molte rose; purtroppo le fatture non ne riportano il nome. Un genere australiano per un grande introduttore di australiane
Anche se l'idea che la malinconica ex-imperatrice abbia acceso la scintilla della coltivazione delle rose in Francia è probabilmente sopravvalutata (a diffonderla, dopo la sua morte, sarebbero stati gli ibridatori di rose come Vibert, alla ricerca di un precedente romantico e nobilitante), resta il fatto che Lee & Kennedy lasciarono il segno nella storia della coltivazione delle rose diffondendo anche nel continente le cinesi: gli ibridatori francesi, incrociandole tra loro e con altre rose, avrebbero prodotto il primo ceppo di rose rifiorenti, le ibride perpetue. Non è alle rose, ma forse più giustamente a un'esotica australiana che John Kennedy deve il suo ingresso nel pantheon dei dedicatari di generi di piante. Il genere Kennedia è un tributo di Ventenat che in Le jardin de la Malmaison così scrive: "Devo i frutti di questa pianta e delle due successive allo zelo e alla benevolenza di M. Kennedy", definito in un altro passo "abile botanico e celebre vivaista inglese" e ripetutamente citato nel libro come fornitore di piante e semi. Kennedia (Fabaceae) è un genere endemico dell'Australia che comprende circa 14 specie di arbusti prostrati, ricadenti o rampicanti con sottili fusti legnosi, foglie composte per lo più tomentoso, solitamente trifoliate, e vistosi fiori papilionacei in technicolor: K. lateritia li ha rosso vivo, K. coccinea rosso aranciato con ali rosa e centro giallo, K. procurrens da viola a blu, K. prorepens da viola ad azzurro chiaro, K. nigricans quasi neri con macchie gialle e arancio; a diminare è comunque il rosso in infinite sfumature. Molte Kennedia sono vigorosi rampicanti che in Australia vengono anche utilizzati in interventi di rivegetazione: K. rubicunda può raggiungere un'altezza di cinque metri in una sola stagione. Relativamente rustica, è talvolta proposta anche dai nostri viavai, così come K. coccinea, di portamento prostrato e utilizzabile come tappezzante. Una selezione di specie e qualche informazione in più nella scheda. Verso la metà del Settecento, due intraprendenti giardinieri scozzesi, Lewis Kennedy e James Lee, fondano ad Hammersmith, un villaggio non lontano da Londra, il vivaio the Vineyard, destinato a scrivere una pagina importante nella storia dell'importazione delle piante esotiche in Europa. In questo settore non ha rivali, ed è ben noto anche all'estero, grazie soprattutto a Lee, che ha una tale conoscenza enciclopedica delle piante da poter tradurre in inglese (è il primo a farlo) un'opera teorica di Linneo, contribuendo largamente alla diffusione del sistema linneano in Gran Bretagna. Meritava come minimo la dedica di un genere: e infatti la dedica linneana arrivò, anche se attraverso la mediazione di un altro botanico. Per questo specialista di piante esotiche, ecco dunque l'esotica Leea (Vitaceae). 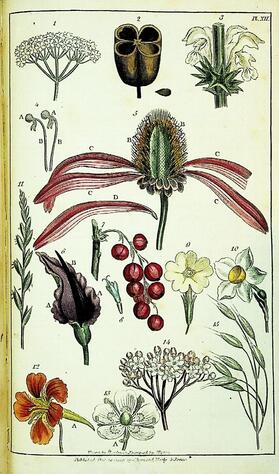 Pollice verde, abilità negli affari e competenza botanica Per circa settant'anni, dalla seconda metà del Settecento al 1820, il vivaio the Vineyard di Hammersmith fu il più reputato d'Inghilterra, anzi, a sentire Loudon, "il primo del mondo". Anche se sopravvisse fino al 1904, con una diversa ragione sociale e in terreni ridotti dall'espansione di Londra, fu quello il suo momento di gloria. A crearlo furono due giardinieri scozzesi, James Lee (1715-1795) e Lewis Kennedy (1721-1782), che in precedenza avevano lavorato per la grande nobiltà: Lee per il duca di Somerset a Syon House e per il duca di Argyll a Whitton Park, Kennedy per lord Wilmington a Chiswick. Sulle circostanze e l'esatta data di fondazione c'è però qualche incertezza. Secondo diverse fonti, il vivaio sarebbe nato nel 1745 per iniziativa di Lewis Kennedy, cui più tardi, per consiglio di lord Argyll, si sarebbe associato Lee. Tuttavia, E. J. Wilson ha osservato che all'epoca Lewis aveva solo 24 anni e ha suggerito che il fondatore sia piuttosto un suo parente, ovvero lo zio omonimo Lewis Kennedy, giardiniere di lord Wilminghton, cui il nipote potrebbe essere subentrato dopo la sua morte nel 1754. D'altra parte, il primo documento sicuro dell'esistenza del vivaio (un ordine di fruttiferi, orticole e altre piante per Croxadale) risale al 1750; quindi è possibile che la data di fondazione vada spostata in avanti di qualche anno, tanto più che è noto che Lewis Kennedy nipote si trasferì a Londra solo nel 1748. Alcune fonti parlando addirittura del 1760. I due soci erano giardinieri sperimentati e di talento, con un notevole fiuto per gli affari. Kennedy apparteneva a una famiglia di giardinieri, attiva a Muthill nel Pertshire da almeno tre generazioni; il padre Thomas era il capo giardiniere di Drummond Castle, mentre il fratello maggiore John lavorava a Croxdale Hall. Il nostro Lewis Kennedy avrà imparato il mestiere in famiglia, lavorando a fianco di entrambi fin da bambino. James Lee invece era nato a Selkirk e giovanissimo aveva attirato l'attenzione dell'earl of Islay, più tardi duca di Argyll, un grande appassionato di giardini, che gli aveva messo a disposizione la sua ricca biblioteca e l'aveva fatto venire a Londra, dove il ragazzo era diventato apprendista di Philip Miller al Chelsea Physic Garden. Il vivaio sorgeva a Hammersmith, un villaggio situato lungo il Tamigi a ovest di Londra, di cui è ora un distretto, in un fertile terreno di circa sei acri che fino dal 16 secolo ospitava una vigna, che ancora all'inizio del Settecento produceva una buona quantità di vino rosso. Comprendeva infatti un edificio a due piani, con una cantina per conservare le botti e una rivendita del vino a piano terra. Lee e Kennedy trasformarono la vigna in un vivaio specializzato nella coltivazione di piante esotiche, anche se nel catalogo pubblicato nel 1774 (Catalogue of plants and seeds sold by Kennedy and Lee, nursery and seedmen, at the Vineyard, Hammersmith) non mancano piante da frutto, orticole e persino foraggere. La creazione del vivaio coincise con la nascita del nuovo giardino paesaggistico, e i due scozzesi seppero cavalcare l'onda fornendo tanto alberi e arbusti per i parchi ridisegnati da Capability Brown quanto esotiche da serra calda e fredda per gli appassionati alla ricerca di novità. I due partner condividevano gusti, abilità professionale e talento per gli affari, ma, anche se il "senior partner" era Kennedy (la ragione sociale era "Kennedy and Lee"), la figura più in vista era certo James Lee. Mentre Kennedy si occupava delle questioni legali ed amministrative e viaggiava parecchio nel paese per visitare e assistere la clientela (come giardiniere paesaggista sono noti suoi interventi a Croxdale Hall, Durham e Callaly Castle), Lee curava i contatti con importatori, mercanti, cacciatori di piante, altri giardinieri e corrispondeva con molti botanici in patria e all'estero. Come il suo maestro Philip Miller, oltre ad essere un pollice verde, possedeva una notevole cultura botanica, che gli permise di affrontare l'impresa di essere il primo a tradurre un'opera di Linneo in inglese: nel 1760, a quanto pare su suggerimento di Ann Monson, che forse lo aiutò a tradurre i termini tecnici, pubblicò una libera traduzione di Philosophia botanica sotto il titolo An Introduction to the Science of Botany. Il libro, oltre a segnare una tappa importante della diffusione delle idee di Linneo in Inghilterra (fu il primo a presentare al grande pubblico il suo sistema sessuale), diede fama internazionale a Lee, che incominciò a corrispondere con diversi botanici, tra cui lo stesso Linneo, cui inviava informazioni sulle nuove introduzioni, esemplari, semi e disegni eseguiti da sua figlia Ann, un'eccellente illustratrice botanica. E' significativo il fatto che nel ritratto che, come d'uso, fu anteposto al frontespizio dell'eediione postuma del 1810, è ritratto mentre, imparruccato e vestito con un sobrio abito scuro, osserva con una lente una pianta: dunque come gentiluomo dedito allo studio della botanica, non come giardiniere e vivaista. Grazie all'ampia offerta di piante esotiche e alla profonda conoscenza delle piante di Lee, già a metà degli anni '60 il vivaio era diventato una meta obbligata tanto per gli appassionati quanto per gli studiosi; tra i frequentatori più assidui, anche il giovane Joseph Banks, che attraverso Lee conobbe il pittore Sidney Parkinson, che sarebbe poi stato uno dei suoi compagni del primo viaggio di Cook; ma a the Vineyard o a casa di Lee conobbe anche Harriet Blosset, una pupilla del vivaista, che promise di sposare al suo ritorno; al vivaista promise invece di raccogliere semi di nuove piante per lui. Tre anni dopo, quando tornò dall'Australia nelle vesti di eroe del giorno, aveva cambiato idea e ruppe il fidanzamento; ma non l'amicizia con Lee, che ottenne i sospirati semi e rimase in ottimi rapporti con il direttore ufficioso di Kew, tanto da essere coinvolto nella preparazione della sfortunata spedizione del Bounty. Soprattutto, poté giovarsi della rete di raccoglitori dei giardini reali per incrementare le collezioni del vivaio. Lui stesso uno dei fornitori di Kew e amico del capo giardiniere William Aiton (come lui, un allievo di Miller), probabilmente su invito di Banks, attorno al 1773 pubblicò un opuscolo di quattro pagine intitolato Rules for Collection and Preserving Seed from Botany Bay; era particolarmente interessato alle piante australiane, che fu uno dei primi a coltivare, e fu uno dei finanziatori dello sfortunato David Burton, che si trasferì in Australia come sorvegliante dei forzati, raccolse sia per Kew sia per The Vineyard e si ferì a morte ricaricando un fucile. Anche Masson gli spedì piante sia dal Sudafrica (tra cui i primissimi Mesembryanthemum) sia dalla Macaronesia. Inoltre Lee e Kennedy finanziarono cacciatori di piante in proprio, come James Niven che operò al Capo a fine Settecento. La seconda edizione del catalogo di Kew Hortus kewensis (pubblicata nel 1810 dal figlio omonimo di William Aiton) elenca come introdotte dai "sig. Lee e Kennedy" ben 135 tra specie e varietà. Tra quelle più famose, troviamo Buddleja globosa, introdotta dal Cile nel 1774, la prima rosa cinese, giunta nel 1784, e Fuchsia magellanica, messa in vendita l'anno successivo per una ghinea al pezzo. Attorno a quest'ultima, è fiorita una storia, di cui esistono varie versioni (una fu raccolta anche da Dickens); grosso modo la trama è la seguente: un cliente in visita a Hammersmith parlò a James Lee di una bellissima pianta che aveva visto su un davanzale di Wapping; il vivaista si precipitò a vederla e se ne innamorò all'istante. La pianta apparteneva alla moglie (alla vedova o alla madre, le versioni divergono) di un marinaio che gliel'aveva portata dall'America ed ora era nuovamente in mare; insomma, un caro ricordo che la donna rifiutò a lungo di vendere, finché Lee le offrì tutto ciò che conteneva il suo borsellino, ovvero otto ghinee, e le promise di portarle una delle prime talee che ne avrebbe ricavato. Portò poi il suo bottino a Hammersmith, tolse fiori e boccioli, ne trasse tutte le talee possibili, e da queste altre ancora, e così via; un anno dopo, nel vivaio fiorivano trecento fucsie. Lee ne scelse due e le portò nella sala dove esponeva le piante più belle e rare. Presto gli fece visita una nobildonna; credette che quelle fossero le uniche disponibili, e ne acquistò senza battere ciglio un esemplare per una ghinea. Ovviamente la mise in bella mostra nella sua serra e se ne vantò con un'amica, che si precipitò a sua volta ad Hammersmith, dove a fare bella mostra c'erano di nuovo due fucsie. Anche lei ne acquistò una, e così tanti altri clienti, ripagando l'astuto Lee che nell'arco di quella sola stagione moltiplicò per venti il suo investimento. La storia, pubblicata per la prima volta sul Lincoln Herald del 4 novembre 1831, circa quarant'anni dopo la morte del suo protagonista, è certamente apocrifa; c'è anzi il sospetto che sia stata divulgata a bella posta per nascondere il fatto che Lee avesse ricevuto le prime talee da Aiton (il quale ottenne la pianta nel 1788 e la pubblicò nel 1789 come Fuchsia coccinea); inoltre non è chiaro se la specie originariamente commercializzata a the Vineyard fosse Fuchsia coccinea o la più rustica F. magellanica (all'epoca c'era molta confusione tra le due specie). In ogni caso, l'aneddoto testimonia la fama di Lee come abile giardiniere e ancor più abile ed astuto imprenditore.  Un genere esotico per uno specialista di esotiche All'epoca dell'affare della fucsia, c'era già stato un cambio della guardia ai vertici del vivaio. Lewis Kennedy era morto nel 1782, ed era stato sostituito come socio dal figlio maggiore John (1759-1842), che fin da ragazzino lavorava a the Vineyard. In lui James Lee trovò un socio molto brillante, sui cui successi sarà bene tornare in un altro post. Per ora, riassumiamo le vicende successive. James Lee morì a sua volta nel 1795, e gli subentrò il figlio omonimo (1754-1824), che nel 1818 rilevò l'intera proprietà da John Kennedy. I suoi figli John e Charles continuarono a gestire il vivaio fino al 1885, quando il terreno venne acquistato dalla National Agricultural Hall Company per costruirvi il centro espositivo noto come Olympia. Quanto rimaneva passò poi a un figlio di Charles, che gestì la ditta di famiglia fino all'inizio del '900. Ma ormai il momento di gloria era finito da un pezzo. Esso era infatti coinciso con le gestioni dei Kennedy e dei due James Lee, e si era di fatto concluso intorno al 1820, quando The Vineyard si era trovata ad affrontare la concorrenza di altre firme, prima fra tutte Loddiges. Rimaneva alla famiglia la soddisfazione di aver scritto una pagina importante del vivaismo britannico, sancita anche dalla dedica a James Lee di un genere botanico. A dimostrazione della sua reputazione europea, è per così dire a quattro mani: il genere Leea fu infatti pubblicato da Linneo nel 1767 sia in Mantissa plantarum sia nella 12 ed. di Systema naturae, ma fu determinato dal botanico olandese David van Royen, nipote del suo amico Adrieen van Royen, cui succedette come curatore dell'orto botanico di Leida. Purtroppo nessuno dei due ha spiegato la motivazione del tributo, ma possiamo ragionevolmente supporre che sia un riconoscimento del duplice ruolo di James Lee come divulgatore del sistema linneano e come introduttore di tante piante esotiche. Esotico è anche ovviamente il genere Leea (un tempo attribuito a una famiglia propria Leeaceae, oggi alle Vitaceae). Con una trentina di specie riconosciute, è infatti distribuito tra le aree tropicali e subtropicali del Vecchio mondo (Africa, subcontinente indiano, Indocina, Indonesia) e il Pacifico occidentale (Nuova Guinea, Australia, Polinesia), con centro di diversità in Malesia. Sono arbusti, talvolta piccoli alberi o erbacee erette o striscianti, diffusi soprattutto lungo i corsi d'acqua e le foreste secondarie, spinosi o meno, con foglie semplici o composte e piccoli fiori raccolti in cime piatte, seguiti da bacche a volte dai colori vistosi. Molte specie hanno proprietà medicinali e sono utilizzate nelle medicine tradizionali; ad esempio, L. indica è frequentemente coltivata in India e in Cina come pianta officinale (le foglie hanno proprietà digestive e lenitive, le radici sono antipiretiche e diaforetiche). Da altre specie, come L. macrophylla, si estraggono coloranti. Non mancano gli usi ornamentali: L. guineensis nella forma giovanile ha foglie rosso bordeaux, e ne sono state selezionate alcune cultivar; originaria dell'Africa e dell'Asia tropicale, può essere coltivata all'aperto solo in zone miti, dove viene utilizzata per formare siepi, o come pianta da vaso; l'attrattiva maggiore è data dal fogliame, ma sono interessanti anche le bacche che a maturazione diventano scarlatte. Ognuno ha i suoi talenti. Quelli di Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria e imperatore più di nome che di fatto, non erano né la politica né le armi, ma gli affari (per i quali è considerato addirittura un genio), le arti e le scienze. Fu un grande mecenate e lasciò la sua impronta più visibile nel parco di Schönbrunn, dove volle ci fossero anche un serraglio e un orto botanico ricchi di animali e piante esotiche. Su suggerimento dell'archiatra van Swieten, a crearlo furono due giardinieri olandesi, Adrianus van Stekhoven e Ryk van der Schot. Per popolare gabbie e aiuole, l'imperatore progettò di persona e finanziò una spedizione nelle Antille che ebbe grandissimo successo, certo grazie alla competenza e alle capacità organizzative del botanico von Jacquin, ma anche all'ingegno del giardiniere van der Schot che riuscì nell'impresa, rara all'epoca, di fare arrivare vive decine e decine di piante rare. Meritatissima dunque la dedica dell'esotico e sfavillante genere Schotia. 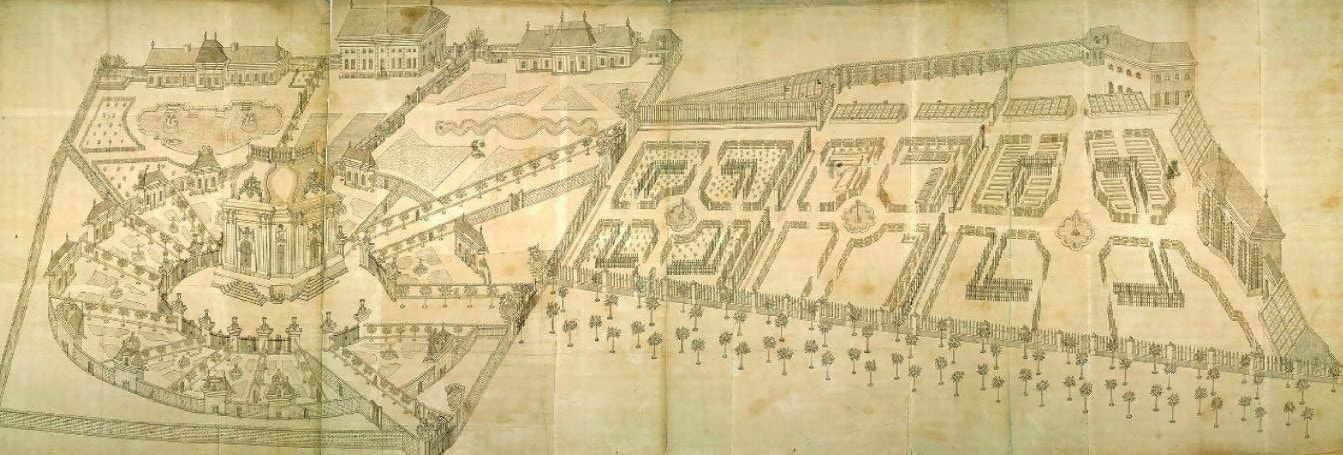 La nascita di un giardino imperiale Avere tempo libero può essere un ottimo affare. Francesco Stefano di Lorena, il marito francese dell'imperatrice Maria Teresa, anche dopo essere stato nominato imperatore come Francesco I, lasciò la cura dello stato alla consorte, che se ne intendeva molto più di lui, e si dedicò a consolidare il patrimonio familiare (abilissimo, lo separò da quello statale e lo moltiplicò, divenendo multimilionario grazie agli ottimi investimenti e a manifatture all'avanguardia) e alle sue svariate passioni. Patito cacciatore e coureur de femmes, buon violinista e mecenate di musicisti e compositori, amante del teatro, fu soprattutto collezionista) collezionava monete e medaglie) e protettore delle scienze. Quando divenne granduca di Toscana, acquistò per 40.000 scudi il ‘Cabinét de curiosités’ dell'erudito Jaen de Baillou, un'ampissima collezione di minerali, fossili, conchiglie, insetti ed altre curiosità naturali, e lo fece venire a Vienna insieme allo stesso Baillou come direttore della sua collezione privata, il primo nucleo del futuro Naturistorische Museum. Gli esemplari vennero sistemati in un palazzo sulla Wallnerstrasse (noto come Kaiserhaus) dove Francesco Stefano aveva i quartieri privati in cui poteva ricevere discretamente diplomatici e i suoi vari emissari, nonché gli scienziati che amava riunire attorno a sé; disponeva di una biblioteca e di un laboratorio ben attrezzato, dove venivano condotti esperimenti utili alle sue attività commerciali. Uno dei frequentatori più assidui era sicuramente l'archiatra van Swieten e probabilmente fu lui a suggerirgli di trasformare anche una parte del parco di Schönbrunn in un vero e proprio centro di ricerca, con un serraglio e un orto botanico. Il palazzo di Schönbrunn era inizialmente un casino di caccia, molto caro dall'imperatrice cui era stato ceduto dal padre, l'imperatore Carlo VI, quando era una giovane sposa; a partire dal 1743, la sovrana ordinò grandi ampliamenti per trasformarlo nella residenza estiva della famiglia imperiale, sontuosa come Versailles ma allo stesso tempo più intima e familiare. Della sistemazione dei giardini si occupò il marito, che si avvalse di diversi artisti fatti venire dalla Lorena. Era un giardino formale alla francese, con viali diagonali che confluivano al centro lungo un asse longitudinale. Di fronte alla facciata sud del palazzo, si allungava un vasto parterre con aiuole a disegni (parterre de broderie), delimitato lateralmente dai "boschetti", stanze verdi con siepi ed alberi potati in forme geometriche. Questa era la parte pubblica e di rappresentanza del parco. C'erano poi giardini riservati alla sola famiglia imperiale, tra cui proprio il settore a vocazione scientifica voluto da Francesco Stefano. Intorno al 1750 egli acquistò dalla comunità di Hietzing un terreno situato all'estremità occidentale del parco. In primo luogo vi fece allestire il serraglio; costruito nel 1751 su disegno dell'architetto lorenese Jean-Nicolas Jadot, ha pianta radiale; il centro è occupato da un padiglione da cui si godeva una vista a 360° sui viali a stella che portavano alle singole gabbie e voliere; è una leggenda che nel sotterraneo si trovasse un laboratorio imperiale segreto. Inaugurato con un grande ricevimento nell'estate del 1752 e, benché trasformato, ancora esistente, è considerato il più antico giardino zoologico del mondo. Nel 1753, iniziarono i lavori per l'annesso orto botanico. Su suggerimento di Van Swieten, fu assunto un esperto orticultore di Leida, la città natale dell'archiatra: Adrianus van Stekhoven (o, alla tedesca, Adrian Steckhoven, 1704/05-1782) arrivò a Vienna insieme al suo assistente Ryk (o Richard) van der Schot (1733-1790), nativo di Delft; portavano con loro 10.000 bulbi e una collezione di piante esotiche, tra cui una palma con una storia. Stekhoven sosteneva che nel 1684 l'avesse fatta venire dall'India lo Statolder Guglielmo d'Orange, poi Guglielmo III d'Inghilterra; all'epoca, la pianta aveva un'eta stimata di 30 anni. Nel 1702 fu donata al re Federico I di Prussia; nel 1739 il suo successore l'aveva donata a lui. Egli la trapiantò nel giardino viennese nel 1753 e nel 1765, con assidue cure, riuscì a farla fiorire e persino a fruttificare. Da quel momento fu per tutti la "palma di Maria Teresa". Scomparsa da molto tempo, non è mai stata identificata con certezza, anche se è stato supposto potesse trattarsi di Corypha umbraculifera, una palma monocarpica nota per la crescita lenta e per aver l'infiorescenza ramificata più grande del mondo. In tal caso, sarà morta poco dopo la prodigiosa fioritura. Ma torniamo al giardino che, creato da maestranze olandesi, è noto come "Giardino olandese". Aveva pianta grosso modo rettangolare; separato dal serraglio sul lato nord da una palizzata, era diviso in tre riquadri, ciascuno dei quali comprendeva quattro aiuole simmetriche, con una fontana centrale, nel punto d'intersezione dei sentieri; nel primo riquadro vennero piantati i bulbi portati dall'Olanda e altri fiori, in quello centrale orticole e piante da fiore, nell'ultimo specie delicate da proteggere in inverno, non ci è noto se in piena terra o in vaso. Al di fuori del giardino, lungo il lato occidentale, c'erano piante da frutto; altri fruttiferi, potati a spalliera, erano coltivati lungo il muro orientale. All'estremità del giardino venne costruita una grande serra, cui più tardi vennero aggiunte due ali; sul lato occidentale, c'erano quattro serre più piccole, forse più simili a cassoni vetrati, e sul fondo la casa del capo giardiniere. Nell'arco di un anno, il giardino fu pronto. Era certo ben organizzato, con le piante sistemate in modo scientifico, secondo il modello dell'orto botanico di Leida, ma appariva ancora molto vuoto, e un po' troppo casalingo e troppo simile simile a un orto. Francesco Stefano avrebbe voluto qualcosa di decisamente più imperiale. Stando alle memorie che Nikolaus Joseph von Jacquin dettò al figlio Joseph Franz, non gli sfuggì che quel giovanotto frequentava assiduamente il recentissimo giardino: ne stava infatti catalogando le piante secondo il sistema di Linneo, ancora ignoto negli Stati austriaci (del resto, Species plantarum è del 1753). Sentito il solito van Swieten, capì che era la persona giusta per popolare quelle aiuole e quelle gabbie troppo vuote. Gli propose di partire per le Indie occidentali a fare incetta di piante e animali esotici. Von Jacquin accettò, e il 9 dicembre 1754, munito di precise istruzioni imperiali e accompagnato dal solo aiuto giardiniere van der Schot, partì all'avventura. Mi riservo di raccontare questa spedizione in un altro post, per concentrarmi qui sul giardino e i suoi giardinieri. Basti ora dire che la spedizione si protrasse per cinque anni e toccò gran parte delle Antille; Von Jacquin si rivelò un ottimo organizzatore e inviò periodicamente a Vienna animali, piante e casse di curiosità naturali; il primo invio dalla Martinica giunse già nell'agosto 1755. All'inizio del 1756, era pronto un invio particolarmente prezioso: 266 tra alberi e arbusti, di 40 specie differenti, in gran parte ancora ignoti in Europa; mediamente gli alberi erano alti un metro, con un tronco del diametro di un braccio e più. Van der Schot li aveva accuratamente preparati al viaggio, estirpandoli dal terreno con una gran parte delle radici; le zolle, che potevano pesare anche 100 libbre, venivano poi avvolte in foglie di banano e assicurate con corde di Hibiscus tiliaceus. Inoltre, per limitare al massimo il fabbisogno d'acqua, le chiome erano state accuratamente potate, mantenendo la forma naturale. Nonostante questi preparativi, se nessuno se ne fosse preso cura durante il viaggio oceanico quelle piante sarebbero in gran parte perite. Ecco perché ad accompagnarle fu van der Schot in persona, che il 28 febbraio si imbarcò con il prezioso carico alla volta dell'Europa su un vascello dal nome ben augurante, l'Espérance. Oltre alle piante c'erano 27 uccelli esotici, un formichiere, un uistitì e dieci casse di conchiglie, pesci essiccati, fossili, minerali e oggetti etnografici. Le piante erano state preparate così bene e seguite con tanta cura che, ad eccezione delle Heliconia divorate dai ratti di bordo, arrivarono tutte sane e salve: uno straordinario successo per l'epoca dei velieri, quando la percentuale di piante vive che riusciva a superare i viaggi transoceanici era bassissima. Von Jacquin spedì a Vienna in tutto sette invii. Con l'ultimo, partito dall'Havana nel gennaio 1759, viaggiava egli stesso, insieme all'ultimo dei suoi compagni, l'uccellatore toscano Barculli. Grazie alla fortunatissima spedizione, il serraglio e il giardino olandese si trovarono d'un colpo a eguagliare se non a superare le collezioni dei giardini reali di Parigi o Londra. Nominato giardiniere imperiale e direttore del giardino di Schönbrunn, Van Stekhoven lo diresse abilmente per molti anni, intervenendo anche nel resto del parco, dove aggiunse tra l'altro una grotta artificiale al di sopra della bella fontana che gli dà il nome. Anche se nel 1765 l'imperatore morì all'improvviso, le collezioni continuarono a crescere; le conosciamo grazie al catalogo manoscritto redatto da Richard var der Schott tra il 1774 e il 1779. Finché, in una fredda giornata del novembre 1780, si produsse un increscioso incidente: mentre van Stekhoven, ormai anziano, giaceva a letto per un attacco di gotta e van der Schot era influenzato, uno degli aiuti dimenticò di ricaricare la stufa della grande serra; al mattino, il capo giardiniere accorse e completò il disastro caricandola troppo: così le piante che erano sopravvissute al gelo morirono per il caldo eccessivo. Non c'è da stupirsi se fu messo a riposo e sostituito da van der Schot, che diresse i giardini imperiali fino alla morte nel 1790, inaugurando anche una dinastia di giardinieri; suo figlio Joseph tra il 1794 e il 1804 fu il capo giardiniere dell'orto botanico universitario di Vienna. In precedenza, era stato uno dei membri della spedizione Märter, decisa da Giuseppe II proprio per rimediare i guasti dell'incidente del 1780. Oltre a lavorare nei giardini imperiali, padre e figlio furono attivi come progettisti di giardini in Boemia. Nel 1785 Richard van der Schot disegnò il parco all'inglese del castello di Veltrus per il conte Johann Chotek, mentre all'inizio dell'Ottocento il figlio passò alle dipendenze del principe di Liechenstein che lo mandò in America a fare incetta di piante per trasformare il parco di Lednice in stile paesaggistico.  Splendide fioriture Van Stekhoven è ricordato da una via di Vienna (Steckovengasse) ma da nessuna pianta, al contrario di van der Schot, onorato dal genere Schotia, istituito da von Jacquin con una dedica che ben testimonia la sua stima per l'antico compagno di viaggio: "Questo alberetto che nel mese di ottobre fiorisce copiosamente e in modo assai elegante nella serra calda del giardino imperiale di Schönbrunn costituisce un nuovo genere; perciò gli ho dato un nuovo nome, desunto dall'eccellente Richard van der Schot, giardiniere imperiale e prefetto del giardino imperiale di Schönbrunn, un tempo mio compagno di viaggio in America, grazie alla cui cura indefessa e all'eccezionale abilità in quel giardino sono oggi coltivate tante piante rare che ogni anno producono fiori". Von Jacquin espresse la sua stima anche scegliendo una pianta particolarmente bella, come lo sono tutte le quattro specie di questo piccolo genere di Fabaceae endemico dell'Africa meridionale. Sono alberi da piccoli a grandi, con vistose fioriture, scarlatte per Schotia afra, S. brachypetala e S. capitata, rosa per S. latifolia. I colori giusti per attirare i loro principali impollinatori, gli uccelli nettarinidi. In effetti producono enormi quantità di nettare, un richiamo e una risorsa anche per api e altri insetti, ma un problema quando vengono piantati in aree pavimentate. Il fogliame decorativo e il portamento aggraziato ne fanno ottime piante da ombra nelle aree non soggette a gelate; nei paesi d'origine hanno però molti alti usi: i semi di tutte le specie sono eduli, e i baccelli vengono raccolti ancora verdi e poi arrostiti; la corteccia di alcune specie veniva usata per produrre coloranti; corteccia, e talvolta foglie e radici, hanno proprietà medicinali. Qualche approfondimento nella scheda. L'orto botanico dell'università di Bonn ha da poco festeggiato il bicentenario. Nacque infatti nel 1818 per iniziativa congiunta del fondatore dell'università, il ministro dell'istruzione della Prussia Karl von Altenstein, e del botanico Nees von Esenbeck. Ma la sua realizzazione e la sua rapida crescita sarebbero state impossibili senza l'abile e energico Wilhelm Sinning che fu prima capo giardiniere poi ispettore capo del giardino renano per oltre mezzo secolo. Nees von Esenbeck espresse la sua stima dedicandogli la bellissima Sinningia helleri, specie tipo del nuovo genere Sinningia, di cui fa parte una delle Gesneriaceae più coltivate, la "gloxinia dei giardinieri", ovvero Sinningia speciosa. 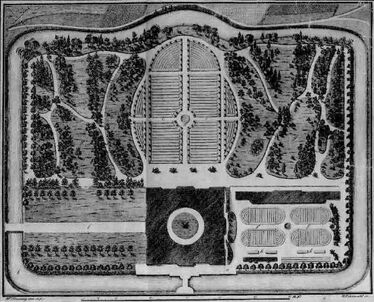 Nascita di un orto botanico Nell'estate del 1818, il botanico Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck, che all'epoca insegnava scienze naturali all'università di Erlangen, in Baviera, fu eletto presidente dell'Accademia leopoldina; quindi si accordò con il ministro dell'istruzione prussiano Karl von Stein zum Altenstein, che aveva appena decretato l'istituzione di un'università a Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität), per il trasferimento dell'Accademia, della sua biblioteca e delle collezioni naturalistiche presso il neonato ateneo, sotto l'egida della Prussia. In cambio ottenne sia la cattedra di botanica e scienze naturali, sia la responsabilità dell'organizzazione e dello sviluppo delle istituzioni scientifiche dell'università, in particolate di un Museo di storia naturale e di un orto botanico. Quest'ultimo venne ricavato trasformando il parco di piacere del castello di Poppelsdorf, alla periferia sud della città, che quello stesso anno era stato donato all'Università di Bonn dal principe-arcivescovo di Colonia, di cui era la residenza estiva. Intorno al palazzo arcivescovile, un giardino dovette esistere almeno dal 1578, come attesta un bozzetto a penna, ma presumibilmente andò distrutto come il palazzo stesso durante la cosiddetta Guerra di Colonia (1583-1588). Solo dopo la fine della Guerra dei trent'anni, nel 1650, fu impiantato un nuovo giardino formale, che poi nel 1720 fu ristrutturato in stile barocco, per fare da cornice al Clemensruh, la residenza nello stesso stile costruita dall'architetto francese Robert de Cotte per il principe arcivescovo Joseph Clemens di Baviera e il nipote e successore August Clemens. Dopo aver risolto il contenzioso con la Baviera, che cercò di impedire il trasferimento della biblioteca e delle collezioni della Lepoldina, von Esenbeck arrivò a Bonn nel dicembre 1818, si stabilì con la famiglia al secondo piano del castello e si impegnò immediatamente nella ristrutturazione del parco per adattarlo alla nuova destinazione didattico-scientifica. I lavori iniziarono già quell'inverno e nell'arco di un anno lo sterro era completato, così come la costruzione delle prime serre. Alla fine del 1819, von Esenbeck stimava che le specie e varietà ospitate ammontassero già a 4500. Lavori così celeri e un risultato tanto eclatante erano stati possibili perché von Esenbeck aveva trovato un collaboratore d'eccezione nel capo giardiniere Wilhelm Sinning (1791– 1874). Ne conosciamo piuttosto bene la formazione e il percorso professionale. La sua carriera inizia a quindici anni come apprendista giardiniere nei giardini ducali di Bernburg (Sassonia-Anhalt); nel 1809, diciottenne, completa l'apprendistato nel giardino d'inverno di Lipsia; celebre all'epoca, era il giardino-vivaio creato dal vivaista Christian August Breiter, specializzato in piante esotiche, coltivate in serre con temperature differenziate. In città Sinning ha anche modo di frequentare l'accademia di disegno, dove probabilmente apprende i primi rudimenti della progettazione di giardini. Nel 1810 è promosso Kunstgärtner (letteralmente "giardiniere d'arte"), termine che all'epoca definiva un giardiniere specializzato in piante ornamentali, in contrapposizione ai giardinieri comuni che erano anche orticultori e frutticoltori. Segue un periodo in cui il giovane giardiniere, forse desideroso di nuove esperienze professionali o condizionato dall'inquieta situazione politica (sono gli anni in cui la Germania è uno dei principali teatri delle guerre napoleoniche), cambia ogni anno sede e datore di lavoro: nel 1810 lavora nel giardino ducale di Dresda, nel 1811 in quella della residenza dei Sassonia-Gotha a Altenburg, dal 1812 al 1814 all'Hofgarten di Düsseldorf, proprio negli anni in cui il capo giardiniere e architetto paesaggista Maximilian Friedrich Weyhe stava trasformando l'antico giardino principesco nel primo parco pubblico della Germania. Con questo ampio ventaglio di esperienze, nel 1814 passa finalmente al servizio del re di Prussia. Dal 1814 al 1819 lavora nell'Orangerie e nel giardino del castello di Brühl, famoso per il Jardin Secret con piante mediterranee ed esotiche. Nel 1818, presenta la propria candidatura come capo giardiniere del costruendo orto botanico di Bonn e deve sostenere una prova esame che consiste proprio nella progettazione del nuovo giardino. Evidentemente il progetto piace, e ottiene il posto. Nei primi mesi del 1819 lo troviamo già al lavoro al fianco di Nees von Esenbeck; mentre a questi spetta la direzione scientifica, a lui vengono affidati il disegno del progetto e la direzione dei lavori, nonché delle semine e dei trapianti. Il suo progetto, che per molti aspetti si rifà a quello del suo maestro Wehye per l'Hofgarten di Düsseldorf, cerca di conciliare l'eredità barocca del giardino con le esigenze scientifiche e il gusto paesaggistico "all'inglese". Sinning allestisce anche una serra in legno e vetro con quattro ambienti, uno caldo, due temperati e uno freddo, utilizzando probabilmente le vetrate delle serre di Brühl. Già nella primavera insieme ai suoi aiutanti provvede alle prime semine; il prestigio scientifico di Esenbeck, ma anche il peso politico della monarchia prussiana fanno affluire semi da molti orti botanici tedeschi, ma anche stranieri (Londra, Parigi, persino la lontana Madrid). Non mancano invii di privati: una selezione di 126 semi arrivò "come dono del consigliere privato von Goethe", ovvero del poeta Goethe, amico e corrispondente di Esenbeck; il principe esploratore Maximilian zu Wied-Neuwied contribuì con i semi di oltre 200 piante raccolte nei suoi viaggi in Brasile, mentre un altro titolato, Joseph Salm-Dyck, donò quasi 300 esemplari della sua celebre collezione di succulente, che nel 1821 Sinning andò prelevare e preparare di persona per il viaggio. Molte piante vive vennero trapiantate dal giardino di Brühl. Anche se le difficoltà finanziarie, logistiche e politiche non mancarono (soprattutto andò a rilento la vera e propria attività didattica), le collezioni continuarono a crescere vigorosamente. Nel 1820 uscì il primo catalogo del giardino, curato da Christian Gottfried Nees von Esenbeck e dal fratello minore Theodor Friedrich Ludwig, che egli aveva fatto assumere come ispettore del giardino botanico. Nel 1821 le specie e varietà erano quasi 6000. Nel 1824 uscì una silloge illustrata delle più rare piante del giardino, Plantarum in horto medico Bonnensi nutritarum icones selectae, firmata anche da Sinning che aggiunse alle descrizioni dei fratelli Esenbeck le sue note colturali. Nel 1829 uno scandalo mise precipitosamente fine alla carriera prussiana del maggiore degli Esenbeck; quando emerse una relazione extraconiugale con la moglie di un collega, fu costretto a lasciare la Prussia; si trasferì a Breslavia, scambiando la cattedra con Ludolph Christian Treviranus, che così divenne il nuovo capo di Sinning. Il più giovane degli Esenbeck, che nel frattempo era diventato a suo volta professore di botanica, rimase invece a Bonn e nel 1833 fu nominato condirettore dell'orto botanico. Nel 1834 firmò a quattro mani con Sinning la magnifica raccolta Sammlung schönblühender Gewächse für Blumen- und Gartenfreunde, con 100 litografie e la presentazione di altrettante piante; a cura di Sinning, nuovamente le note orticole. Intanto i direttori passavano: Treviranus si scontrò con il personale e dopo pochi anni, pur mantenendo la cattedra di botanica, lasciò la direzione del giardino, e Theodor Friedrich Ludwig von Esenbeck morì in giovane età di tisi; e mentre altri ne arrivavano e si succedevano per brevi periodi, a garantire la continuità dell'istituzione era proprio il capo giardiniere, che fu la colonna del giardino di Bonn per più di mezzo secolo, dal 1819 al 1871, quando andò in pensione. Nel 1833 fu promosso ispettore. Tra il 1849 e il 1851 curò la sostituzione della vecchia serra, ormai precaria e cadente, con una più moderna serra in ghisa e vetro, ispirata ai modelli inglesi di Loudon e Paxton; dal 1847 al 1874 tenne anche la cattedra di botanica all'Università di agraria, istituita nel 1847 sempre a Poppelsdorf. In ricordo di colui che disegnò il giardino e ne fu l'anima per mezzo secolo, uno dei sentieri dell'orto botanico si chiama Sinning-Weg. 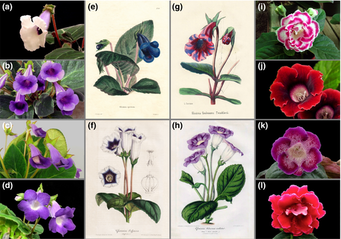 Splendide e variabili Sinningia Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck aveva grandissima stima del suo capo giardiniere. In una lettera scritta da Breslau al suo antico protettore Altstein nel 1832, si compiace che il suo successore Treviranus ne abbia finalmente riconosciuto i meriti e scrive: "[in questo modo] mostra un encomiabile cambiamento di opinione. In precedenza aveva dichiarato che un giardiniere dovrebbe essere solo il servitore e lo strumento senza volontà propria del direttore, il che è certamente sbagliato. Invece un giardiniere preparato e dotato di spirito di iniziativa è il vero principio di vita di un giardino, è ciò che fa del giardino un giardino, altrimenti, sotto la maggior parte dei direttori, sarebbe solo una specie di erbario molto costoso". Da parte sua, aveva espresso il suo apprezzamento anche in altro modo. Tra tanti semi che affluivano al neonato orto botanico, nel 1824 il direttore dell'orto botanico di Würzburg Franz Xaver Heller spedì dei semi giunti dal Brasile etichettati come Columnea. L'abile Sinning li seminò e ne nacque una bellissima pianta dai fiori bianchi; era certo una Gesneriacea, ma non una Columnea; anzi, apparteneva a un nuovo genere che von Esenbeck chiamò in suo onnore Sinningia con le seguenti parole: "La nostra nuova pianta è destinata a conservare la memoria del sig. Wilhelm Sinning, giardiniere dell’università di Bonn, le cui cure infaticabili e lo zelante amore per la scienza stanno facendo avanzare così bene questo stabilimento, fondato e diretto sotto i miei occhi sulla base dei suoi disegni”. Era così nato il genere Sinningia, uno dei più importanti della famiglia, con una ottantina di specie distribuite dal Messico all'Argentina settentrionale, con centro di diversità in Brasile, di cui è endemica o nativa la maggior parte delle specie. Per lo più tuberose, hanno fiori tubolari o a coppa molto attraenti, che ne fanno eccellenti piante d'appartamento o da serra. La specie di gran lunga più nota e coltivata è S. speciosa, nota a giardinieri e coltivatori come glossinia, gloxinia o gloxinia dei giardinieri, perché, quando fu importata in Inghilterra dal Brasile nel 1817, il vivaista Loddiges la denominò Gloxinia speciosa, nome che mantenne per sessant'anni, finché W. P. Hier la assegnò correttamente al genere Sinningia. Dopo la Saintpaulia, è probabilmente la specie più coltivata della famiglia, grazie ai suoi grandi fiori a coppa dai petali vellutati. Sono il risultato delle coltivazione e delle selezioni dei vivaisti; in natura, benché sia piuttosto diffusa e alquanto variabile, questa specie ha fiori molto più piccoli, penduli, con corolla tubolare, asimmetrica e lobi meno accentuati, in colori che vanno dal bianco al rosa a varie sfumature di viola. In coltivazione, fino dalla metà dell'Ottocento, si è invece sviluppata la forma pelorica, con corolla attinomorfa, eretta e molto più aperta; la gamma dei colori si è allargata al rosso e al blu; sono state introdotte forme con gola macchiettata, con lobi arricciati o marginati di bianco, con fiori doppi. Estremamente popolare nelle serre ottocentesche, scatenò la fantasia di ibridatori e vivaisti, che ne produssero decine e decine di varietà, sontuosamente raffigurate nelle riviste illustrate dell'epoca. Tra i maggiori realizzatori, troviamo senza dubbio il belga Van Houtte, che ne selezionò moltissime e le propagandò nelle pagine della sua rivista Flore des serres. La bellezza e la diffusione di S. speciosa non deve però farci dimenticare le altre specie. Come spesso in questa famiglia, anche Sinningia è un genere morfologicamente vario, che si è adattato a habitat diversi. La maggior parte vive sulle pareti rocciose, ma ci sono anche specie terrestri e qualche epifita; alcune vivono nel sottobosco della foresta, o addirittura sulle pareti di grotte (è il caso di S. tuberosa), altre lungo i corsi d'acqua, alcune addirittura sommerse per parte dell'anno (è il caso di S. glazoviana). Per lo più sono dotate di rizoma, in alcuni casi così sviluppato da essere assimilato a un caudice (è il caso di S. leucotrichia o S. cooperi); possono essere erette, striscianti o pendule, basse, acauli e con foglie a rosetta, o al contrario, piuttosto alte con verticilli di foglie ai nodi. Anche le dimensioni variano assai: alcune sono minuscole, come S. pusilla che non supera i 5 cm d'altezza, altre imponenti, dei veri e propri arbusti, come S. mauroana, che può raggiungere i due metri. I fiori si presentano in forme diverse, anche in relazione ai differenti impollinatori (colibrì, imenotteri, falene). I colori delle corolle comprendono il bianco, il giallo, il lavanda, il viola, il rosa, l'arancio e il rosso. Qualche approfondimento, una selezione di specie e link selezionati nella scheda. Sir Joseph Banks, grande patron della spedizione Flinders, ebbe cura di raccomandare al capitano di offrire ai "gentiluomini scienziati" molte opportunità di scendere a terra per esplorare le risorse naturali. Come botanico e direttore in pectore dei Kew Gardens, contava anche di arricchire i giardini reali di nuove specie; così, accanto al già affermato pittore botanico Ferdinand Bauer e al promettente botanico Robert Brown, a bordo dell'Investigator c'era anche l'eccellente giardiniere Peter Good, che aveva già dimostrato di sapersi prendere cura delle piante vive in lunghi viaggi oceanici. I tre formarono una formidabile squadra di raccoglitori, con all'attivo circa 2000 esemplari. Purtroppo Good fu una delle vittime della dissenteria che imperversò a bordo dopo lo scalo a Timor e molte delle sue raccolte andarono perdute in seguito al naufragio del Purpoise; tuttavia era riuscito a fare arrivare a Kew tanti semi da permettere a Aiton di elencare più di cento "australiane" nel catalogo dei giardini reali; belle e rare, spinsero Salisbury a rendere un commosso omaggio a Good con la dedica del genere Goodia. 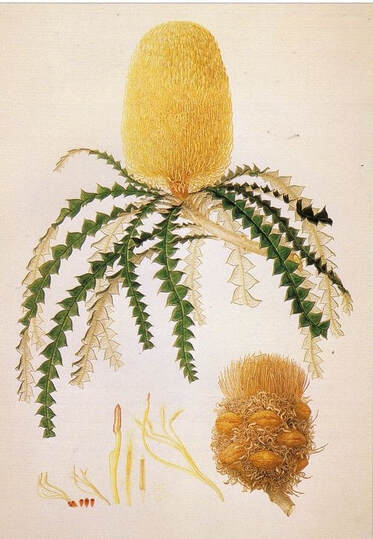 Una piccola squadra di scienziati Rispetto al dispiegamento di ben ventidue tra scienziati ed artisti della spedizione Baudin, lo staff scientifico dell'Investigator appariva modesto: in tutto sei uomini, ovvero l'astronomo John Crosley, il naturalista Robert Brown, il mineralogista John Allen, il giardiniere Peter Good e i pittori Ferdinand Bauer e William Westall. Se consideriamo che Crosley, Brown, Bauer e Westall erano accompagnati da un servitore ciascuno, l'équipe sale a dieci persone in tutto, che però presto si ridussero a otto. Infatti l'astronomo soffrì talmente il mal di mare che a Città del Capo fu lasciato a terra. Assistente all'Osservatorio di Greenwich, assegnato all'Ufficio della longitudine, aveva partecipato come osservatore alla spedizione Vancouver; in Sudafrica fece alcune osservazioni sulle coordinate, quindi, ritornato a Londra, divenne assistente dell'astronomo reale a Greenwich e si segnalò come eminente matematico, divenendo anche presidente della Spitalfields Mathematical Society. Tutti gli altri erano legati in un modo o nell'altro a Banks, che li aveva scelti personalmente. Da tempo il gentiluomo, che come primo investigatore della flora australiana e ideatore del progetto di trasformare il Nuovo Galles del Sud in una colonia penale, se ne considerava il patrono, pensava a una spedizione all'interno del paese. Contava di affidarla a Mungo Park, che alla fine del 1797 era rientrato dall'Africa coronato di gloria per aver scoperto la sorgente del Niger. Due fatti lo costrinsero a ripensarci: il governatore Hunter gli scrisse per sconsigliare una spedizione terrestre, per la quale la giovane colonia non aveva né gli uomini né le strutture; inoltre Park si scontrò con l'ammiragliato circa la sua paga e decise di sposarsi; poco dopo, come abbiamo visto qui, Flinders suggerì il progetto alternativo della circumnavigazione della Terra australis e Banks lo fece proprio con entusiasmo. Insistette però che a bordo dell'Investigator ci fosse uno staff scientifico e che durante la navigazione fossero previste soste sufficienti per esplorare le risorse naturali. A stargli particolarmente a cuore era ovviamente la flora, e non a caso come naturalista scelse un promettente botanico, il medico scozzese Robert Brown (1773-1858); dopo essersi laureato ad Edimburgo, Brown si era arruolato nell'esercito e da cinque anni serviva come medico militare in Irlanda. Meticoloso e interessato a tutte le scienze, era però affascinato soprattutto dalla botanica, in particolare delle crittogame. Aveva iniziato a corrispondere con eminenti botanici tra cui William Withring, James Edward Smith, James Dickson e José Correia da Serra. Nel 1798, quando Park rinunciò, fu proprio quest'ultimo a suggerire Brown come sostituto "In questo cambio, a guadagnarci sarà la scienza; Mr. Brown è un naturalista di professione; inoltre è scozzese, adatto a perseguire uno scopo con costanza e mente fredda". Brown (che nel frattempo era anche entrato a far parte della Linnean Society) era dunque il candidato ideale come naturalista della spedizione Flinders. Nel dicembre 1800 Banks gli scrisse per proporgli il posto; il dottore accettò e venne a Londra, dove trascorse i mesi che precedettero la partenza a leggere tutti i libri sull'argomento, a studiare le piante australiane di Banks e a scegliere con Dryander (il segretario di Banks) i doppioni da riunire in un erbario da portare con sé a bordo dell'Investigator. Anche Bauer, oltre ad essere uno dei più raffinati pittori botanici del suo tempo, poteva essere considerato un naturalista a tutti gli effetti: austriaco, era stato introdotto alla tassonomia linneana e all'uso del microscopio da von Jacquin, quindi tra il 1786 e il 1787 aveva accompagnato in Grecia il professore di Oxford John Sibthorp; il risultato fu la spettacolare Flora Graeca. A confronto, il pittore paesaggista William Westall (1781-1850) era una seconda, anzi una terza scelta. Inizialmente Banks aveva offerto il posto all'affermato paesaggista Ibbeston; al suo rifiuto, si era rivolto William Daniell, che aveva già molto viaggiato ed era specializzato in soggetti marini; questi dapprima aveva accettato, poi si era tirato indietro e forse su suo suggerimento fu rimpiazzato dal giovanissimo Westall, appena diciannovenne al momento della partenza. Allen era invece arrivato all'ultimo momento; Banks non aveva pensato a un mineralogista, finché a sottolineare la necessità di raccogliere campioni di rocce e minerali fu Flinders; sir Joseph allora scrisse a suo zio, William Milnes, che amministrava la sua tenuta di Overton, il quale scelse un giovane minatore, eccezionalmente istruito, appunto John Allen, forse all'epoca venticinquenne. Pagato meno dei suoi compagni e non considerato uno scienziato a tutti gli effetti, era un po' il parente povero del gruppo, tanto più che i minerali non interessavano per nulla a Banks e poco a Brown, nominato capo dell'intera équipe, che in una lettera a sir Joseph ebbe a scrivere sprezzantemente "sinceramente, è di ben poca utilità". Pensava tutto il contrario dell'ultimo membro della squadra, il giardiniere Peter Good (non ne conosciamo né la data di nascita né l'età), voluto da Banks con l'obiettivo dichiarato di arricchire i giardini reali di specie nuove e rare. Good era uno dei caposquadra di Kew ed era stato suggerito a Banks dal giardiniere capo William Aiton per la sua esperienza in viaggi oceanici: aveva infatti portato con successo a Calcutta una selezione di piante coltivate a Kew e nel viaggio di ritorno ne aveva riportato piante indiane preparate dal botanico Christopher Smith. Good e Allen condividevano la stessa cabina e secondo il loro contratto, a differenza degli altri, avrebbero dovuto mangiare con i sottoufficiali tecnici; ma, dato che sull'Investigator non ce n'erano, condividevano anche loro la tavola del comandante con i "gentiluomini scienziati".  Formidabili raccolte L'Investigator salpò da Spithead il 18 luglio 1801. A bordo c'erano anche casse di semi e una serra portatile con piante in vaso da consegnare a Port Jackson. Lungo la rotta per città del Capo l'unico scalo fu quello di Madera: il 2 agosto Flinders, Brown e Bauer scesero a terra sull'isola di Bugio nelle Ilhas Desertas, dove Brown osservò la natura porosa delle rocce e la luminescenza delle meduse; quindi il giorno dopo l'Investigator gettò l'ancora nel porto di Funchal, dove si sarebbe trattenuta fino al 7 agosto. Brown, Bauer, Allen e Good ne approfittarono per esplorare le vicinanze della capitale, erborizzare e scalare la maggiore montagna dell'isola, il Pico Ruivo. Brown era deluso di non aver trovato piante diverse da quelle raccolte da Banks durante lo scalo a Madera del primo viaggio di Cook, ma redasse scrupolosamente una lista della flora locale. Durante il viaggio, che proseguì tranquillo fino a Città del Capo, raggiunta il 16 ottobre, Brown si tenne occupato studiando i libri della biblioteca di bordo sulla Nuova Olanda e insegnando a Good il francese, in previsione di un incontro con gli uomini di Baudin. Fin dal 17 ottobre, Brown, Allen e Good scesero a terra; stupefatti dalla bellezza e varietà della flora del Capo, raccolsero insetti, minerali e una grande quantità di piante. Brown passò diverso tempo nella sua cabina a classificarle, mentre Good continuava le raccolte. I naturalisti trovarono anche modo di esplorare le montagne più vicine alla città, Table Mountain e Devil's Mountain, nonostante la scalata fosse resa difficile dal fango e dalla nebbia. La preparazione e la classificazione delle numerose piante raccolte da lui stesso e da Good fu la principale occupazione di Brown durante la traversata dell'Oceano Indiano. C'erano anche due nuove specie di Proteaceae, Serruria fascicularis e S. foeniculacea. Lasciata False Bay il 4 novembre, l'Investigator avvistò la costa della Nuova Olanda all'altezza del Capo Leeuwin il 6 dicembre. Flinders iniziò immediatamente la ricognizione idrografica, concentrando la sua attenzione sul King George Sound, dove la nave rimase all'ancora presso la Seal Island dall'8 dicembre al 5 gennaio 1802. La lunga sosta e la stagione non troppo avanzata permisero a Brown e Good di raccogliere il più cospicuo bottino dell'intera spedizione: circa 500 esemplari di piante, 175 di semi, mentre Bauer poté completare una cinquantina di disegni. Tra gli altri, Brown scoprì otto nove specie di Banksia. Botanico e giardiniere lavoravano in piena armonia; quando il primo si tratteneva a bordo per classificare gli esemplari, il secondo continuava le ricerche e andava a caccia di semi, dimostrando un ammirevole senso del dovere; anche Bauer (e talvolta Allen e Westall) contribuiva alle raccolte. Il 6 gennaio il viaggio riprese in direzione est; le frequenti soste per esplorare baie, isole e isolotti offrirono altre opportunità di raccolta ai naturalisti. La prima si presentò il 10 gennaio, quando essi poterono scendere a terra nei pressi dell'attuale Cape le Grand, dove trovarono una nuova specie di Cycadacea (Macrozamia riedlei), la raccolta dei cui semi diede parecchio filo da torcere a Good. L'11 gennaio l'Investigator gettò l'ancora a Lucky Bay, dove rimase per quattro giorni. Brown, Bauer e Good ne approfittarono per penetrare nell'interno fino a scalare il Frenchman Peak, una cupola granitica posta a circa 6 km dalla baia, che ospita anche una grotta, e ne ritornarono con circa 150 esemplari di piante diverse, tra cui Verticordia brownii. Il resto del mese di gennaio fu trascorso ad esplorare le isole dell'Arcipelago della Recherche, con ancoraggi a Middle e Goose Island. Ora la stagione era più avanzata, le temperature diurne potevano superare i 35° e spesso soffiavano forti venti; la vegetazione era inaridita e le raccolte botaniche si fecero molto più sporadiche. Il 17 gennaio entrarono nella Grande Baia australiana, caratterizzata da alte falesie, dove fu impossibile trovare un ancoraggio fino a Fowlers Bay (19 gennaio); Brown scese a terra, ma poté osservare ben poche piante, soprattutto specie alofile come Zotera muelleri. Mentre il caldo si faceva sempre più torrido, toccando 52°, l'Investigator continuò l'esplorazione attraverso le isole Nuyts, con ancoraggi in diverse isole che fruttarono a Brown poche nuove specie. Poté invece rifarsi durante gli scali a Memory Cove (22-24 febbraio 1802) e Port Lincoln (26 febbraio-6 marzo) dove lui e Good raccolsero 35 e 85 specie (incluso il nuovo genere Ixodia). Tra il 10 e l'11 marzo, mentre l'Investigator era ancorato all'estremità settentrionale dello Spencer Gulf, l'intero gruppo degli artisti e degli scienziati scalò una montagna situata a una ventina di km all'interno, prontamente battezzata da Flinders Mount Brown. Fu un'impresa faticosa e pericolosa: rimasti senza viveri e acqua, dovettero trascorrere la notte sulla montagna. I due pittori però poterono dipingere splendide vedute. Secondo il racconto di Good, dal punto di vista botanico la gita fu un po' deludente: non solo trovarono una varietà di vegetali inferiore alle aspettative, ma molte delle piante raccolte giunsero a bordo ormai appassite. Si trattava comunque di una sessantina di specie, cui se ne aggiunsero altrettante al successivo ancoraggio dell'isola dei Canguri (21-22 marzo e 1-7 aprile). Qui Brown poté anche tornare al suo primo amore, raccogliendo diversi interessanti licheni. Dopo il fatidico incontro con il capitano Baudin, la navigazione proseguì lungo la costa del Victoria con un breve ancoraggio all'isola King e uno più lungo a Port Phillip. Insieme al capitano e a Westall, Brown scalò la collinetta che domina la baia nota come Arthur's Seat; al termine della piacevole escursione, oltre a uno splendido panorama, godettero anche un picnic a base di ostriche fresche. In questo distretto, Brown e Good aggiunsero alle collezione un altro centinaio di specie. La prima fase dell'esplorazione era conclusa e il 2 maggio l'Investigator lasciava Port Phillip per Port Jackson. La lunga sosta necessaria per raddobbare la nave fu utilizzata da pittori e naturalisti per completare i disegni e organizzare le raccolte; Good fu anche impegnato nella preparazione dei semi da inviare a Londra. Non mancò però il tempo per qualche escursione nei dintorni e a Parramatta, ad alcune delle quali partecipò anche il francese Leschenault de La Tour, divenuto buon amico di Brown, Il 22 luglio 1802 l'Investigator salpava per la seconda, meno fortunata, parte della spedizione. Le raccolte di Brown e del suo team lungo la costa orientale e settentrionale sono state studiate meno in dettaglio rispetto a quelle della costa meridionale; grazie al diario dello stesso Brown e al suo General remarks on the botany of Terra Australis sappiamo che in entrambe le aree vennero raccolte circa 500 specie, moltissime delle quali nuove per la scienza, trattandosi di regioni scarsamente o per nulla esplorate in precedenza. Per la costa nord-orientale al di sopra del 21° grado sud, Brown cita come luoghi di raccolta Port Curtis, Keppel Bay, Port Bowen, Stronge-tide Passage e soprattutto Broad Sound, dove egli raccolse la pianta che dedicò al capitano Flinders, Flindersia australis. Ricorda anche gli scali in due delle isole Northumberland e in una delle isole Cumberland. Anche la costa settentrionale, almeno prima che il deprecabile stato dello scafo dell'Investigator costringesse Flinders a ripiegare su Timor e poi a rientrare in tutta fretta a Port Jackson, offrì ai naturalisti diverse opportunità di raccolta sia lungo la costa (tra le zone citate, Melville Bay e Caledon Bay) sia in varie isole, una delle quali venne battezzata Good's Island in onore dell'ottimo giardiniere. In effetti, anche se le raccolte sono in genere ascritte a Brown, sappiamo che si trattò di un'impresa collettiva cui molto contribuì Peter Good, ma probabilmente anche Bauer, egli stesso un appassionato raccoglitore. Oltre alle piante, che occupavano il centro d'interesse di Briwn, vennero raccolti anche insetti, uccelli e altri animali, e sicuramente Allen si occupò delle rocce, anche se non sappiamo nulla delle sue raccolte (andate perdute nel naufragio del Purpoise).  Un omaggio meritato Come agli sfortunati membri della spedizione Baudin, la sosta a Timor fu fatale a diversi uomini di Flinders. Tra di essi proprio Good, che poco dopo la partenza dall'isola si ammalò di dissenteria; non si riprese e morì nella baia di Sydney il 12 giugno 1803 pochi giorni dopo il rientro dell'Investigator. Brown lo rimpianse molto e gli dedicò Banksia goodii. Gran parte delle sue raccolte di piante vive, che egli aveva amorosamente curato finché aveva potuto, sistemate nella serra mobile dell'Investigator, furono caricate sulla Purpoise e andarono perdute nel naufragio della nave, insieme a una cassa di semi. Con i semi inviati in precedenza, Good aveva però fatto in tempo ad arricchire i giardini di Kew (e quindi indirettamente d'Inghilterra) di molte specie australiane, soprattutto provenienti dalla costa meridionale. Nella seconda edizione di Hortus kewnesis, Aiton elenca ben 103 piante da lui introdotte nei giardini reali. Molte prosperavano ancora nella Australian House ai tempi di Hooker. Si salvò invece l'erbario, che Brown aveva incorporato nel proprio. Infatti, mentre Westall e Allen si imbarcarono con Flinders sulla sfortunata Purpoise, Brown e Bauer decisero di rimanere in Australia, un po' perché convinti che il capitano sarebbe tornato presto, un po' per rintegrare le collezioni perdute, ma soprattutto perché ritenevano che ci fosse ancora molto da scoprire. Non si sbagliavano: nei due anni che seguirono, aggiunsero alle loro raccolte altre 2000 specie e centinaia di disegni. Ne riparleremo in un altro post. E' ora di conoscere il genere che, presumibilmente su suggerimento di Brown, Salisbury dedicò all'attivissimo giardiniere con queste parole: "Secondo la mia opinione, nessuno ha maggior diritto che la sua memoria sia perpetuata da una pianta che porta il suo nome di un industrioso giardiniere botanico, specialmente quando la sua vita è caduta in sacrificio per le sue fatiche in lontani climi. Non so nulla di Peter Good tranne che, avendo raccolto semi per sua maestà nel Nuovo Galles del Sud, dove morì, Kew gli deve un ricchissimo lascito delle migliori e più rare piante di quel paese, ciascuna delle quali porta l'etichetta con il suo nome". Goodia è un piccolo genere della famiglia Fabaceae che comprende sei specie di arbusti endemici dell'Australia, da medi a grandi. Sono caratterizzati da foglie composte trifogliate, spesso di colore glauco; un'altra caratteristica distintiva è la presenza di stipole effimere o persistenti alla base del picciolo. I fiori papilionacei, con il vessillo più o meno circolare e le due ali più strette, sono gialli con marcature rosse, verdi o porpora. La specie più diffusa è Goodia lotifolia, un alto e folto arbusto eretto che in fioritura può ricordare le ginestre; endemico dell'Australia sud-orientale, è largamente presente in Tasmania e lungo la costa del Victoria e del Nuovo Galles del Sud meridionale. Recentemente un secondo genere si è aggiunto a celebrare indirettamente l'ottimo giardiniere: Paragoodia ("simile a Goodia"), separato nel 2011 da Muelleranthus; è un genere monotipico, rappresentato unicamente da P. crenulata, un'erbacea prostrata con foglie composte trifogliate e fiori con marcature che possono ricordare quelli di Goodia; endemica dell'Australia occidentale, è nota in un unico sito a sud del Mt Holland. L'Università di Oxford vanta il più antico orto botanico della Gran Bretagna, fondato nel 1621, uno dei primissimi al mondo, nato addirittura prima di quello di Parigi. Ma per essere operativo ci mise vent'anni e per diventare un vero orto botanico universitario quasi mezzo secolo. A coltivarlo e custodirlo, due eccentrici personaggi: Jacob Bobart il vecchio e il giovane. Forse quasi tutto quello che si racconta su di loro appartiene più alla leggenda che alla realtà, ma sarebbe un peccato. In ogni caso, Linneo ne aveva abbastanza stima da onorarli con l'interessante genere Bobartia.  Bobart padre e figlio: due eccentrici? Nel 1621 un gentiluomo della corte di Carlo I Stuart, Henry Danvers, primo conte di Danby, fece dono all'Università di Oxford di 250 sterline per affittare un terreno dove allestire un «vivaio dei semplici, dove un professore di botanica passa leggere le piante e mostrare i loro usi e virtù agli uditori». Sicuramente guardava ai modelli italiani; sappiamo che suo fratello minore John era un grande appassionato di giardini e ne aveva creato uno raffinatissimo a Chelsea, appunto sul modello italiano. Tuttavia la benemerita impresa partì con il piede sbagliato: fu scelto un terreno appartenente al Magdalene College situato sulla riva del fiume Cherquell soggetto a periodiche inondazioni; fu necessario bonificarlo con centinaia e centinaia di carrettate di buona terra e proteggerlo con un muro. Prima che fosse pronto, erano passati dodici anni. Di pianta quadrata, era un hortus conclusus al quale si accedeva da una porta monumentale, diviso in quattro quadranti da due viali perpendicolari. Era costato 5000 sterline, e ormai il generoso donatore era a corto di quattrini. Fu così che solo nel 1641 poté ingaggiare un abile giardiniere per prendersi cura del giardino, Aveva pensato addirittura a John Tradescant, che però mori prima di assumere l'incarico. Ripiegò allora sul tedesco Jacob Bobart. Le fonti lo dicono nativo di Brunswick, un ex soldato arrivato in Inghilterra per sfuggire alla guerra dei Trent'anni. Il contratto stipulato con Danby gli concedeva il diritto di usare e vendere i frutti del giardino. Ma già nel 1644 il nobiluomo morì, mentre ormai imperversava la guerra civile. Le sue proprietà furono poste sotto sequestro dai seguaci del Parlamento, e Bobart si trovò senza stipendio. A permettergli di mantenere se stesso e la numerosa famiglia (sposato due volte, ebbe due figli e una nidiata di sei figlie) più ancora dei prodotti dell'hortus medicus, o Physic garden, erano il commercio di piante medicinali e esotiche e la locanda The Greyound Inn, situata proprio di fonte al giardino. Era un giardiniere appassionato e di talento, ma anche alquanto bizzarro: ostentava una lunga barba, che nei giorni di festa ornava con tasselli d'argento, e come animale da compagnia, anziché un cane, teneva un caprone. Per venticinque anni, fu il signore e padrone del giardino, che trasformò in un paradiso terrestre: ai lati della porta monumentale, dispose una coppia di tassi a mo’ di guardiani, creò mirabili sculture verdi in topiaria, piantò tutte le piante esotiche che poté procurarsi nonostante il periodo difficile. Nel 1648 ne pubblicò il primo catalogo, anonimo: le specie e varietà, menzionate con il nome comune e una frase descrittiva in latino, sono 1639. Circa seicento sono native, ma ci sono anche numerose specie nordamericane. Poi la guerra finì, e così l'effimera Repubblica inglese. Nel 1660 Carlo II recuperò il trono e tornò in Inghilterra accompagnato dal medico personale e botanico reale Robert Morison. Proprio lui nel 1669 (48 anni dopo la fondazione) divenne il primo professore di botanica di Oxford e il primo direttore dell'orto botanico (praefectus horti). Bobart il vecchio era già sulla settantina e non sappiamo come prese la convivenza. Forse, a collaborare con il neo professore, più che lui, fu suo figlio Jacob il giovane, che già nel 1658 aveva aiutato il padre a scrivere una seconda edizione del catalogo. Morison era un grande botanico, ma era anche celebre per la sua alterigia: come Ray, era alla ricerca di un metodo naturale per classificare le piante e riteneva che tutti i botanici del presente e del passato che si erano imbarcati nella stessa impresa avessero scritto solo fregnacce (allucinazioni, Hallucinationes, diceva lui). Riuscì a convincere l'Università di Oxford a pubblicare la sua ambiziosissima Historia Plantarum Universalis Oxoniensis, in cui intendeva presentare tutte le piante note, catalogandole in gruppi naturali sulla base dei frutti e dei semi. Il compito dei Bobart era procurargli le piante e allestire l'erbario. Probabilmente Jacob il giovane (non risulta invece che lo avesse fatto il padre) lo assisteva durante le dimostrazioni delle piante (anche a Parigi le lezioni pratiche erano impartite dal capo giardiniere). Nel 1680 succedette al padre come curatore del giardino e nel 1683, alla morte improvvisa di Morison in seguito a un incidente stradale, ne divenne praefectus; fu nominato professore assistente e l'Università gli affidò il completamento di Historia Plantarum Universalis. Morison aveva fatto in tempo a pubblicare solo il secondo volume; Bobart riuscì a completare il terzo, mentre il primo non fu mai scritto. Senza essere un botanico di primo piano, se la cavò con scrupolo e onore, aggiungendo anche molte piante nuove, ma ebbe cura di espungere i feroci attacchi di Morison contro gli "allucinati" botanici del passato e del presente. Tuttavia, la costosissima impresa editoriale portò la casa editrice universitaria sull'orlo del fallimento. Vissuto fino in tarda età, poco prima della morte fu costretto alle dimissioni, con grande rincrescimento di William Sherard che era stato suo allievo e ne aveva grande stima. Il suo maggiore merito è la creazione di un grande erbario, che costituisce il primo nucleo dell'Erbario dell'Università di Oxford. Su di lui si racconta un curioso aneddoto: avendo trovato nel giardino un grosso topo morto, ne alterò la testa e la coda e ne distese la pelle per simulare due ali, in modo che assomigliasse all’immagine tipica di un drago. Esaminato dai professori di Oxford, l’artefatto fu creduto autentico e celebrato in versi nelle società erudite; qualcuno ne spedì persino una descrizione a Antonio Magliabechi, bibliotecario del granduca di Toscana. Solo a questo punto Bobart confessò l’inganno. Un visitatore lamentò che, con la mani e la faccia sporche di terra, più che un grande botanico, sembrava un qualsiasi giardiniere. 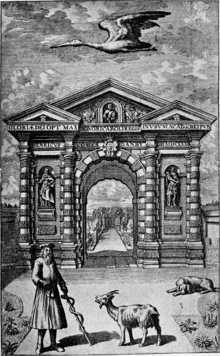 Leggenda e realtà Fin qui l'immagine tradizionale dei due Bobart: due eccentrici dai modi anticonvenzionali, due figure pittoresche. Ma come capita spesso, quando una storia è troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. La studiosa tedesca Karin Seber, che ha attentamente studiato le poche fonti disponibili su Jacob il vecchio, è giunta alla conclusione che quasi tutto ciò che sappiamo su di lui è falso o va interpretato in modo totalmente diverso. In primo luogo, non era affatto un oscuro soldato tedesco senza né arte né parte giunto in Inghilterra dalla natia Brunswick. Apparteneva a un'eminente famiglia (il nome originale è Bobert) di mercanti di Danzica, e forse era addirittura figlio del borgomastro della città; uno dei suoi parenti - forse un fratello - commerciava con l'Olanda; come dimostrano i libri che lasciò al figlio e furono poi da questi donati all'Univeristà, già in patria aveva studiato botanica medica. Seber ipotizza che si sia trasferito in Inghilterra come mercante, forse già specializzato nel commercio di piante medicinali e altri semplici. Difficile pensare che lord Danby, che avrebbe voluto ingaggiare John Tradescant, giardiniere del re e massimo esperto di giardinaggio del tempo, abbia assunto al suo posto un signor nessuno. Forse già prima di entrare al suo servizio, Bobart aveva affittato (o acquistato) la locanda, utilizzandone i terreni per coltivare piante medicinali e i locali come base del suo commercio, facendosi notare per la sua grande competenza di giardiniere e esperto di piante officinali. Secondo Seber, anche le sue abitudini bizzarre vanno rilette; nel frontespizio di Vertumnus, un poema di Abel Evans in onore di Jacob il giovane, alla sinistra della porta monumentale del giardino è stato rappresentato il suo primo custode con una chioma fluente e una lunga barba; nella mano sinistra impugna il bastone di Asclepio, simbolo della medicina. Accanto a lui, una capra (simbolo della voracità naturale domata dalle arti del giardiniere?); più oltre un cane addormentato. Dunque, quei tratti eccentrici fanno parte di una voluta autorappresentazione come depositario e custode dei segreti delle erbe medicinali. Ovviamente, anche la storia del drago di Oxford è stata rimessa in discussione dagli scettici, che fanno notare che la prima attestazione scritta (nella Biographical history of England di Granger e Walpole) è del 1774, più di mezzo secolo dopo la morte del suo protagonista; inoltre non è mai stato trovato neppure uno degli scritti che gli sarebbero stati dedicati dalle società erudite. Forse dunque l'aneddoto è altrettanto posticcio quanto il topo-dragone. D'altra parte, sta a testimoniare la fama di eccentricità che circondava i Bobart, padre e figlio.  I fiori effimeri di Bobartia Linneo in persona li stimava abbastanza da dedicare loro il genere Bobartia, della famiglia Iridaceae. Con una quindicina di specie, tutte sudafricane, anzi ristrette alle Provincia del Capo, questo piccolo genere è caratterizzato da sottili rizomi orizzontali o eretti, ciuffi di foglie sottili che in alcune specie ricordano il giunco, lunghi scapi fiorali con infiorescenze terminali di fiori lievemente asimmetrici con sei tepali solitamente gialli (ad eccezione di B. lilacina, che li ha lilla chiaro). Sono graziosi, ma di breve durata (meno di una giornata). Forse questo spiega perché le specie di questo genere sono raramente coltivate. Vivono per lo più in ambienti montani, con terreni sabbiosi e poveri di nutrienti, e tendono a fiorire più copiosamente dopo gli incendi. Qualche informazione in più nella scheda. Nella nostra galleria di personaggi legati agli anni ruggenti dell'orchimania, accanto a cacciatori di piante e collezionisti, entra finalmente anche un giardiniere: il tedesco naturalizzato francese Gustave Adolphe Lüddemann. Dopo aver imparato a coltivare le orchidee dirigendo le serre di Pescatore, aprì un proprio vivaio, grazie al quale gli amatori francesi poterono finalmente affrancarsi dal mercato inglese. Per la perfezione delle sue piante e la rarità delle sue proposte si fece ben conoscere anche al di fuori dei confini nazionali; a dimostrazione della sua fama stanno le numerose dediche di nomi specifici tributategli sopratutto da botanici tedeschi, tra cui spicca Reichenbach, cui lo legò una lunga amicizia. A lui e a Linden si deve anche l'omaggio di un piccolo genere di orchidee epifite sudamericane, Lueddemannia. 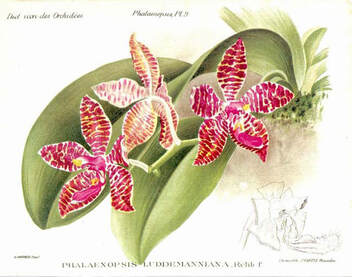 Un vivaio sui boulevard Nel 1864 il vivaio Hugh Low & Co. di Clapton mette in vendita un lotto di orchidee provenienti dalle Filippine, etichettate come Phalaenopsis rosea (oggi sinonimo di P. equestris). Tra gli appassionati che se le aggiudicano anche il giardiniere parigino Gustave Adolphe Lüddemann; e sarà proprio il suo esemplare il primo a fiorire, anticipando di almeno un anno tutti gli altri. Egli fa pervenire i fiori al grande orchidologo Heinrich Gustav Reichenbach che esaminandoli capisce che si tratta di una nuova specie; in onore di colui che definisce "amicissimus" la battezza Phalaenopsis lueddemanniana. Oggi è una delle specie più note del genere, e ha reso familiare il nome del dedicatario agli appassionati di orchidee. Come vedremo meglio tra poco, non è il solo omaggio di Reichenbach a Lüddemann. I due si erano conosciuti quando Lüddemann era il capo giardiniere di Pescatore a Celles Saint Cloud; nato nel 1819 (o nel 1821, secondo altre fonti), era ancora molto giovane quando arrivò a Celles, ma si dimostrò subito un orticultore brillante, con una notevole competenza anche teorica. Nel 1846, ci informa il Bollettino della Société d'Horticulture della Seine et Oise, ottenne una medaglia d'oro per una selezione di 25 piante coltivate nelle serre di Pescatore ed esposte all'esposizione parigina della Società, tra cui spiccavano cinque spettacolari esemplari di Dracaena ferrea (= Cordyline fruticosa), Aechmea fulgens, Begonia fuchsioides, Maranta albo-lineata, Lilium lancifolium. Già all'epoca, però, Pescatore aveva cominciato ad appassionarsi di orchidee, e Lüddemann divenne un grande esperto nella loro coltivazione. Nel 1848, affiancò Linden nella redazione delle note colturali di Pescatoria, la grande opera illustrata sulle orchidee cui collaborò anche Reichenbach. Risale sicuramente a quegli anni l'amicizia tra i due. Nel 1855, alla morte di Pescatore, Lüddemann decise di rendersi indipendente e aprì un proprio vivaio, con sede prima in Boulevard des Gobelins quindi in Boulevard d'Italie. Dall'anno successivo, il suo nome incomincia a comparire regolarmente nei Bollettini della Societé d'Horticulture. Un catalogo del 1865 ci informa che la produzione del vivaio comprendeva sei sezioni: piante diverse di serra fredda e serra calda, bromeliacee, felci e licopodiacee, gesneriacee, orchidee, palme e cicadacee. Lo stabilimento divenne presto ben noto agli appassionati della regione parigina, che potevano finalmente procurarsi eccellenti esemplari di piante esotiche, perfettamente coltivati, senza doverli andare a cercare in Inghilterra. Anche se Lüddemann non coltivava solo orchidee (sembra che nelle sue serre sia fiorita per la prima volta in Europa Aechmea spectabilis), queste rimanevano le sue piante preferite. Produceva sia esemplari da collezione, sia fiori per bouquet, che erano diventati molto di moda in quegli anni. Un gruppo di appassionati tedeschi che visitò lo stabilimento nell'inverno 1862 vide in fioritura diverse specie di Phalaenopsis, tra cui 20 o 30 esemplari di P. schilleriana e P. grandiflora (oggi P. amabilis subsp. amabilis), e poi piante di Cattleya, Aerides, Saccolabium e Vanda. Nel 1882, quando Lüddemann espose per l'ultima volta alla Societé d'Horticulture, vincendo una medaglia d'oro "per un bellissimo lotto di orchidee, bromeliacee, e altre piante da serra calda", nel suo stand era esposte Vanda, Cattleya, Cypripedium, Oncidium, Selenipedium "in perfetta salute e di coltivazione eccellente". Per se stesso, nel corso degli anni Lüddemann aveva costruito una pregevole collezione ricca di varietà rare, tutte etichettate con precisione. Nel 1882, quando si ritirò dall'attività e si trasferì a Bourg-la-Reine, a sud di Parigi, la portò con sé. Con sua grande rammarico, durante il trasporto diverse piante, soprattutto le Phalaenopsis, ebbero a soffrire. Ma soprattutto il vecchio vivaista si rammaricava di essersi dovuto trasferire in una località malsana, con scarso ricambio d'aria, dove doveva moltiplicare gli sforzi per mantenerle in salute. Nei lunghi e dolorosi mesi di malattia che precedettero la morte, nel 1884, il suo pensiero andava sempre alle sue amatissime piante e scongiurava i parenti di non disperdere la collezione, vendendola almeno ad un solo acquirente. La sua volontà fu rispettata. Il duca di Massa poté così aggiudicarsi la collezione per solo 16.800 franchi, una cifra giudicata molto bassa: le piante, vendute singolarmente, avrebbero fruttato almeno il doppio.  Tante dediche, e infine Lueddemannia Lüddemann, rinomato per la sapienza di coltivatore ma anche per la profonda cultura botanica, fu in corrispondenza con diversi studiosi del suo tempo. Il legame più lungo e profondo fu con Reichenbach, al quale nell'arco di un'amicizia più che trentennale inviò innumerevoli esemplari. Il botanico tedesco ricambiò con la dedica di alcune orchidee: oltre a Phalaenopsis lueddemanniana, Cattleya lueddemanniana e Warczewiczella lueddemanniana (oggi Cochleanthes lueddemanniana). Altri omaggi arrivarono da Prillieux con Schomburgkia lueddemannii (oggi Laelia lueddemannii), Koch con Pironneava lueddemanniana (oggi Aechmea lueddemanniana), Baker con Cryptanthus bivittatus var. luddemannii, Regel con Odontoglossum lueddemannii (oggi Rhynchostele cordata). Sempre a Reichebanch (insieme a Linden) si deve la dedica di Lueddemannia pescatorei, che riunisce nella stessa denominazione i nomi di Lüddemann e del suo principale, Jean-Pierre Pescatore. Al genere Lueddemannia, originario delle foreste pluviali del Sud America settentrionale (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù) sono oggi assegnate tre specie di orchidee epifite con grandi infiorescenze pendule di piccoli fiori profumatissimi giallo-aranciato: L. dalessandroi, L. striata e L. pescatorei. Quella di quest'ultima specie, la sola ad essere solitamente presente in coltivazione, sono impressionanti per le dimensioni (possono arrivare anche a 1 metro) e il colore sgargiante. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
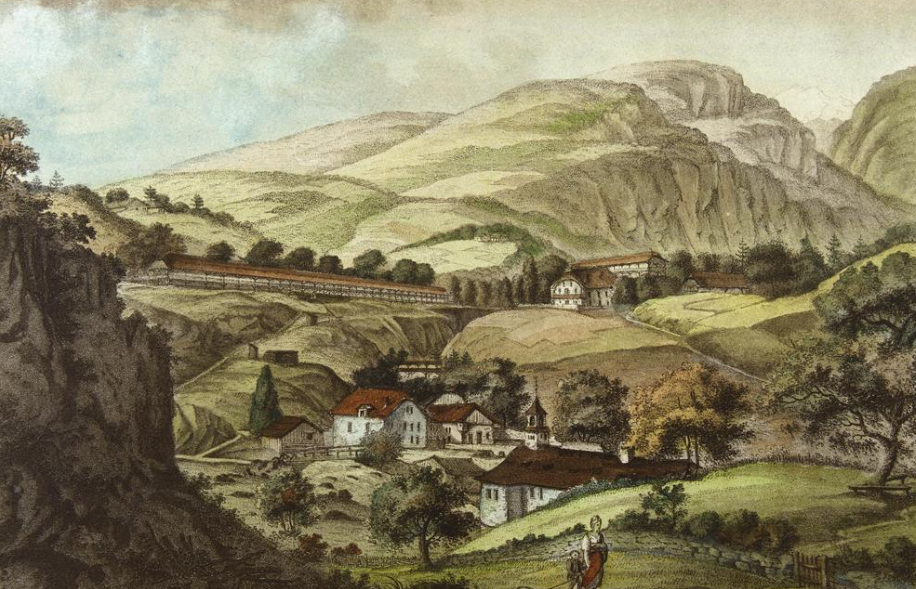
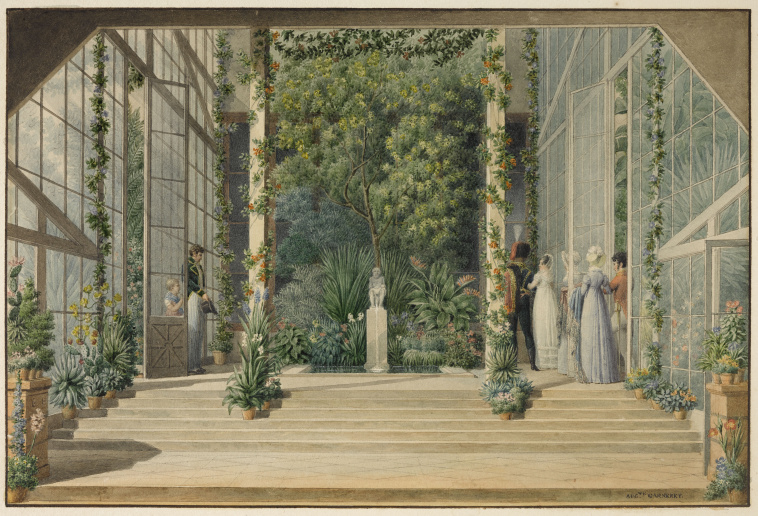


 RSS Feed
RSS Feed