|
Approfittando di una breve periodo di pace durante le guerre napoleoniche e della sua amicizia con David Lance, direttore della factory britannica di Canton, Banks decise di inviare nel porto cinese un giardiniere, che soggiornandovi qualche anno, oltre ad inviare in patria le piante più desiderabili, potesse studiare le avanzate tecniche orticole del paese di mezzo. La sua scelta cadde su William Kerr, giovane e abile giardiniere di origine scozzese. Kerr rimase a Canton per otto anni, per poi essere nominato curatore dell'orto botanico di Colombo, nell'isola di Ceylon, dove sarebbe morto poco dopo; se la sua impresa sia stata un successo o meno, è motivo di discussione. Alcune fonti lo dipingono come un instancabile procacciatore di piante, cui si dovrebbe l'introduzione in Europa di 238 nuove specie. La sua morte in giovane età sarebbe dovuta a una di quelle malattie che tanto spesso decimarono gli europei nei paesi tropicali. Secondo John Livingstone, chirurgo della factory, che lo conobbe molto bene, la realtà sarebbe un po' meno rosea. Entusiasta e attivo nei primi tre o quattro anni, poi in seguito ad alcune "cattive abitudini", sarebbe diventato via via sempre più abulico, fino ad essere incapace di assolvere i suoi compiti. Per quanto Livingstone non lo dica in modo esplicito, gli studiosi ne hanno dedotto che Kerr fosse diventato oppiomane (e questa sarebbe anche la causa della sua morte). D'altra parte, i cataloghi di Kew ridimensionano di molto la quantità delle sue introduzioni; tuttavia si tratta quasi sempre di specie molto importanti, di secolare coltivazione in Cina, che egli si era procurato presso i vivai locali. Tra le altre, anche l'arbusto che porta il suo nome, Kerria japonica, di cui introdusse in Europa la forma a fiore doppio.  A caccia di piante nei vivai cinesi Nel 1802 venne firmata la pace di Amiens tra Francia e Gran Bretagna; Joseph Banks, che dieci anni prima aveva dovuto registrare il fallimento dell'ambasciata Macartney, pensò che fosse giunto il momento di tentare un'altra strada per arricchire Kew di piante cinesi. Ogni tanto qualcuna arrivava grazie ai capitani e agli equipaggi delle navi della Compagnia Britannica delle Indie Orientali (British East India Company) che ogni anno facevano il lungo viaggio dal porto di Canton - l'unico aperto pur con molti limiti agli occidentali - ma egli sperava in risultati più eclatanti. Tanto più che il capo dell'emporio inglese (british factory) era un amico, David Lance. L'idea era di inviare a Canton uno dei giardinieri di Kew che, risiedendo sul posto per un periodo relativamente lungo, avrebbe potuto non solo procurarsi le piante più desiderabili (e desiderate), ma anche apprendere le tecniche orticole dei Cinesi, universalmente considerati maestri dell'agricoltura intensiva. Per la delicata missione Banks scelse un giovane giardiniere scozzese, William Kerr, che aveva potuto appezzare per la sua competenza, la sua passione e, cosa non secondaria, la robustezza fisica. Nell'aprile 1803, nell'atto di comunicargli la nomina a Giardiniere reale, nelle sue istruzioni gli raccomandò diligenza, sobrietà, frugalità, facendogli balenare la prospettiva di migliorare di molto il suo destino, se avesse ben meritato. Seguiva una lista minuziosa di richieste: avrebbe dovuto osservare il modo in cui i cinesi coltivano i frutti utili; scoprire il loro metodo per trarre concime dagli escrementi umani; studiare le modalità cinesi per fabbricare corde, le migliori del mondo; apprendere le tecniche per mantenere le piante nane (ovvero coltivare bonsai). Suo compito principale, ovviamente, era arricchire i giardini reali di piante "belle, curiose e utili", con particolare riguardo a quelle del nord della Cina che supponeva più adatte al clima inglese. Banks era ben consapevole che il suo giardiniere non avrebbe avuto libertà di movimento, anzi gli consigliava grande prudenza, vista la sospettosità dei cinesi; era tuttavia convinto che egli avrebbe comunque potuto procurarsi piante interessanti nei mercati e nei vivai aperti agli stranieri. Gli raccomandava, se possibile, di farsi assegnare un giardino, dove propagare le piante e prepararle per gli invii annuali, nel maggior numero possibile e pronte per affrontare il lungo e difficile viaggio in vasi e cassette appositamente allestiti. Seguiva poi una lunga e dettagliata lista di piante più o meno desiderabili, tanto per la loro utilità quanto per la loro bellezza, contrassegnate da un numero crescente di asterischi (da uno a cinque). Kerr dovette partire poco dopo, visto che era a Canton (o, se preferite, Guangzhou) all'inizio del 1804. John Livingstone, chirurgo nella factory britannica (uno dei tredici empori concessi agli europei) che fece il viaggio con lui lo descrive come un giovane entusiasta, un giardiniere e un botanico molto preparato, di notevole vigore fisico, tanto da affrontare scalate sotto il sole a picco, come dimostrò a Macao, l'ultima sosta prima entrare nel Fiume delle perle e unico territorio cinese dove fosse possibile studiare e raccogliere piante in natura, visto che gli stranieri non potevano muoversi liberamente al di fuori della piccola enclave costituita dagli empori. Arrivato in Cina, Kerr si mise subito al lavoro con solerzia, procurandosi piante nei mercati e nei bellissimi vivai che sorgevano sull'altra riva del fiume, a due o tre miglia dalla concessione. Aperti agli stranieri, anzi largamente pensati per soddisfare le loro esigenze, questi vivai di Canton, noti come Fa Tee, erano una delle meraviglie della città. Tra le numerose descrizioni che ce ne sono giunte, la più dettagliata si deve al famoso cacciatore di piante Robert Fortune, che li visitò negli anni '40: di piccole dimensioni, vi si vedevano centinaia e centinaia di piante in vaso, allineate su due file lungo sentieri pavimentati, scelte soprattutto tra quelle più vistose e apprezzate da cinesi e stranieri, come camelie, magnolie, peonie arboree; c'erano anche bonsai e fiori recisi, soprattutto per abbellire le chiatte e le case che sorgevano lungo il fiume durante le feste come il Capodanno. Un'altra possibile fonte di approvvigionamento erano i giardini privati dei grandi hong, i mercanti cinesi autorizzati a commerciare con gli europei; quelli più ricchi possedevano mirabili giardini, dove venivano coltivate piante difficilmente reperibili nei viavai. Sicuramente Kerr visitò quello di Pinkaqua II, cui, tramite Lance, Banks aveva fatto pervenire numerosi doni. Il mercante lo ricambiò con diversi oggetti di raffinato artigianato, un bonsai ultracentenario e alcune rare peonie moutan. A poche settimane dal suo arrivo in Cina, Kerr era già in grado di rispondere ad alcuni degli interrogativi di Banks e di predisporre un primo invio che partì già a febbraio a bordo della nave della compagnia delle Indie Henry Addington, dove era stata allestita una specie di serra viaggiante. Non fu un viaggio facile; infatti nel frattempo tra Francia e Inghilterra erano ricominciate le ostilità e le navi britanniche, che avevano fatto il viaggio di andata in tempo di pace ed erano prive di salvacondotti, il 14 febbraio, mentre incrociavano nel mar della Cina presso Pulo Aura, furono attaccate da un'imponente flotta francese e dovettero aprirsi la strada a cannonate. Dopo la lunga traversata, arrivarono ai Docks di Londra ad agosto; marinai e comandanti furono festeggiati come eroi nazionali e premiati con denaro e oggetti simbolici; quel che più conta per noi, molte piante "belle, interessanti e utili", come si sarebbe espresso Banks, andarono ad arricchire le aiuole di Kew. Ecco l'elenco (tra parentesi i nomi attuali): Gardenia spinosa (Catunaregam spinosa), Gardenia radicans (G. jasminoides), Pittosporum tobira, Lilium japonicum, Lililium tigrinum (L. lancifolium), Nandina domestica, Dianthus japonicus, Crataegus glabra (Photinia glabra), Aster hispidus, Sagittaria obtusifolia (Limnophyton obtusifolium), Begonia discolor (B. grandis subsp. grandis), Pinus lanceolata (Cunninghamia lanceolata), Juniperus chinensis, Taxus macrophylla (Podocarpus macrophyllus). Insieme a loro, viaggiarono le lettere di Kerr per Aiton e Banks (ho potuto consultare l'indice, ma non il testo), contenenti una lista delle piante inviate (che saranno state molto più numerose, se corrisponde al vero l'affermazione di Livingstone che solo una pianta su 100.000 aveva la speranza di arrivare viva in Inghilterra) e note sui bonsai, la fabbricazione di corde, il giardinaggio cinese e il giardino di Pinkaqua, il metodo per preparare il terriccio per la coltivazione in vaso, l'uso del letame. Un altro invio raggiunse l'Inghilterra l'anno successivo, a bordo della Winchelsea; per il 1805 gli invii registrati nel catalogo di Kew sono solo tre: Mussaenda pubescens, Nymphea pigmaea (N. tetragona), Corchorus japonicus (Kerria japonica). 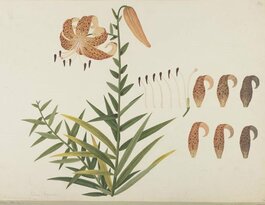 Un destino e una fine misteriosi Un invio tanto modesto sarà da imputare alle vicissitudini del viaggio per mare, ma altri segni ci dicono che qualcosa doveva cominciare a non funzionare. Sappiamo dal diario di viaggio di Kerr, l'unico conservato, che nel febbraio 1805 egli partì da Macao per l'isola di Luzon nelle Filippine, dove si trovò coinvolto in infinite discussioni con le autorità per avere il permesso di inviare in Inghilterra semi e piante vive; si trattenne nell'isola fino alla fine dell'estate, visitando varie località e raccogliendo diversi esemplari, di cui quasi nulla arrivò vivo in patria. Lo stesso anno dovette visitare anche Giava, ma non abbiamo informazioni precise in merito. Questo viaggio potrebbe essere indizio del crescente disagio della sua situazione a Canton, Secondo il dottor Linvingstone, che è la nostra principale fonte sul soggiorno cinese di Kerr, la sua posizione sociale fece di lui un disadattato. La rigida stratificazione in classi della società britannica del tempo vigeva anche nelle factories di Canton; da una parte c'erano i gentiluomini: gli impiegati di alto livello della Compagnia delle Indie, i mercanti accreditati, i capitani e gli ufficiali delle navi, i visitatori ricchi e altolocati; dall'altra c'era la bassa manovalanza di impiegati, nonché uno stuolo di servitori cinesi. Nonostante l'altisonante titolo di Giardiniere di sua Maestà britannica, Kerr era fuori posto con gli uni e con gli altri; inoltre il suo stipendio di 100 sterline annue, buono per un giardiniere in patria, era poca cosa in Cina, dove tutto era carissimo; non gli bastava neppure per rinnovare il guardaroba, tanto che per la sua estrema povertà cominciò ad essere guardato con disprezzo dai suoi stessi servitori cinesi. Sempre secondo Livingstone, dopo tre o quattro anni in cui si mostrò solerte e attivo, incominciò a cambiare carattere; era svogliato, procrastinava ogni cosa; avendo contratto "cattive abitudini estranee al suo carattere" cominciò a incorrere in frequenti cadute, riportando ferite e contusioni che lo rendevano inabile al lavoro per giorni. Qualche studioso ha pensato all'alcool, ma l'indiziato più accreditato è l'oppio. Questa tesi è stata abbracciata con entusiasmo dal romanziere Amitav Ghosh nel suo Il fiume dell'oppio, dove uno dei personaggi, il giardiniere cinese Ah Fey, si vanta di essere stato il fornitore di Kerr tanto per le piante quanto per l'oppio. Quello che è certo è che gli invii documentati dal catalogo di Kew si fanno sempre più magri: nel 1806, a bordo della Hope arrivano Gardenia macrantha (Euclinia longiflora) e Lonicera japonica e a bordo della Wilmer Caske Paederia foetens. Nel 1807, a bordo della Cuffnells è la volta diRosa banksiae, nella forma bianca a fiori doppi, e di una Camellia sasanqua; in date che non è possibile precisare, si aggiungono Cupressus pendula Thun. e Bletia hyacinthina (Bletilla striata). Oltre che in patria, Kerr dovette inviare qualche pianta anche al giardino botanico di Calcutta; sappiamo inoltre che fece eseguire da alcuni artisti cinesi delle illustrazioni di piante, che per qualche anno furono custodite nel Museo della Compagnia delle Indie. Secondo il Gardener Magazine, gli si devono inoltre l'introduzione di diverse varietà di crisantemi, di alcune peonie arboree e di Enkianthus quinqueflorus. Come si vede, siamo lontanissimi dalle 238 specie attribuitegli da molte fonti. Del resto, non risulta alcun invio dopo il 1807, anche se Kerr rimase a Canton fino al 1812. Nel 1810, per volontà di Banks, nell'Isola degli schiavi presso Colombo (Sri Lanka) era stato fondato un giardino botanico e quell'anno Kerr ne venne nominato primo soprintendente. Una decisione che può stupire, se davvero egli era divenuto oppiomane, abbandonando la vita di dedizione al lavoro e sobrietà tanto raccomandata da sir Joseph. Tuttavia è possibile che Banks, sempre molto corretto verso i suoi dipendenti e sollecito verso i suoi protetti, possa aver visto in questo incarico un modo per salvare Kerr, allontanandolo dalle cattive abitudini. Ma ormai era tardi. Il giardiniere morì a Ceylon già nel 1814, poco più di un anno dopo aver assunto l'incarico. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Per concludere, una piccola curiosità: una distilleria di Hawick, il paesino dei Borders scozzesi dove Kerr era nato in una data imprecisata, gli ha dedicato il William Kerr's Border Gin; inutile dire che l'azienda presenta Kerr come un eroe locale, raccoglitore instancabile che introdusse in Europa 238 piante, di cui si vuole celebrare "il coraggio e il senso di avventura, senza menzionare l'esploratore interiore che è in tutti noi".  Kerria, simbolo di primavera e di cadicità Quando ero bambina, nel giardino di mia nonna c'erano grandi cespugli dai fiori gialli che lei chiamava Corchorus. Solo più tardi ho scoperto che si trattava di Kerria japonica (quei cespugli ci sono ancora, e uno lo vedete nella fotografia qui accanto). Nel 1771, sulla base di un esemplare d'erbario, Linneo aveva attribuito questo arbusto di apparente origine giapponese, con fiori bianchi simili a quelle delle fragole, al genere Rubus con il nome R. japonicus. Nel 1784, Thunberg, sulla base di un esemplare d'erbario da lui raccolto in Giappone, presumibilmente mal conservato, lo ribattezzò Corchorus japonicus; una solenne cantonata, se si pensa che i veri Corchorus sono Malvaceae. A rimettere le cose a posto pensò de Candolle che nel 1817 in una comunicazione alla Linnean Society lo assegnò correttamente alla famiglia Rosaceae e lo attribuì a un genere proprio, Kerria, in onore di "William Kerr che, secondo la testimonianza di Robert Brown, ha introdotto in Europa dalla Cina un gran numero di piante, tra cui in particolare proprio quella di cui ci stiamo occupando". Per chissà quale strane ragioni, il vecchio sinonimo di Thunberg si è insinuato nei cataloghi dei vivai, dove a volte è ancora usato. Kerria japonica (L.) DC. è l'unica specie del genere Kerria. E' di origine cinese, ma deve essersi naturalizzata in Corea e in Giappone da tempi immemorabili. Nei giardini è comune soprattutto 'Pleniflora', la varietà a fiori doppi, simili a pon-pon dorati; di origine orticola, era coltivata da secoli in Cina quando Kerr la importò in Europa, avendola presumibilmente acquistata in un Fa-Tee. La forma selvatica ha invece cinque petali e arrivò in Europa qualche decennio più tardi. Meno vigorosa della sorella a fiori doppi, continua ad essere meno comune nei giardini, così come la forma con foglie variegate, 'Variegata' (detta anche 'Picta'). Ne esiste anche una forma con fiori bianchi, 'Alba'; è rara ed è improbabile che l'esemplare su cui lavorò Linneo vi appartenesse; più facilmente, come ipotizzò de Candolle, i fiori originariamente gialli si erano scoloriti seccando (del resto, i fiori di Kerria tendono a sbiadire al sole, motivo che consiglia di scegliere per loro una posizione un poco ombreggiata). In ogni caso, soprattutto nella forma doppia, continua ad essere uno degli arbusti più popolari nei giardini, anche perché è adattabile e capace di prosperare per decenni quasi senza cure. I fiori sono di un colore fin troppo sfacciato, accettabile tuttavia come solare araldo della primavera. Ha un ruolo importante nella cultura giapponese, che con il poetico nome di Yamabuki ("brezza di montagna") la celebra con liriche e dipinti e le ha assegnato connotazioni simboliche contraddittorie. Fiore della primavera dal colore dell'oro, associato dunque al rigoglio e alla ricchezza, è anche simbolo malinconico di caducità, di transitorietà: la sua ricchezza è soltanto un'illusione, poiché i suoi fiori non danno frutto (nella forma doppia è infatti sterile). Nella scheda qualche notizia in più su altre varietà.
0 Comments
Subito dopo l'indipendenza, il più bel giardino d'America era Woodlands, alla periferia di Filadelfia, creato dal ricco proprietario terriero e collezionista d'arte William Hamilton che, a quanto pare, vi faceva coltivare circa 10.000 specie tra native ed esotiche. Jefferson, che ammirava Woodlands e lo considerava il solo giardino al di qua dell'Oceano a poter competere con quelli britannici, volle che nelle sue aiuole e nelle sue serre venisse coltivata e moltiplicata una parte delle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Il nostro protagonista, tuttavia, non è Hamilton (gli furono dedicati ben tre generi, ma nessuno oggi valido), bensì il sovrintendente di Woodlands, il giardiniere scozzese John Lyon, che, dopo qualche anno trascorso a lavorare qui, si trasformò in un infaticabile cacciatore di piante indipendente, al quale Aiton in Hortus Kewensis attribuisce l'introduzione in Europa di oltre trenta specie. Tra le più note oggi, Phlox paniculata e Pieris floribunda. Assai affine a Pieris è Lyonia (Ericaceae), il genere che ne preserva il ricordo.  Dalle aiuole alle montagne del Nord America Al ritorno da un viaggio in Europa, in gran parte dedicato a visitare parchi e giardini britannici, il facoltoso proprietario terriero e collezionista William Hamilton (1749-1813) decise di far ricostruire la casa padronale della tenuta di Woodlands, nei pressi di Filadelfia, secondo lo stile di Adam; anche il parco venne ridisegnato secondo i canoni del giardino paesaggistico d'oltre Oceano. In pochi anni, le collezioni di piante, native o fatte venire dall'Europa, dall'Asia e dal Sud Africa, giunsero a comprendere diecimila specie. Nel 1807 Jefferson, grande ammiratore di Hamilton (Woodlands sarà uno dei modelli di Monticello), chiese a McMahon, cui aveva affidato i semi raccolti durante la spedizione di Lewis e Clark, di dividerli equamente con lui, per aumentare le possibilità di riuscita, vista l'esperienza e i mezzi di Hamilton. Quest'ultimo, del resto, era già in relazione con i due esploratori, che nel 1804 gli avevano inviato da Fort Mandan alcune talee di Maclura pomifera (arancio degli Osagi). Sappiamo che Hamilton ricevette i semi di almeno 19 specie, che includevano diverse varietà di Ribes e il tabacco selvatico Nicotiana quadrivalvis. Un anno dopo, egli informava il presidente che non tutti i semi erano germogliati, mentre le piante di Maclura prosperavano. Dopo la morte di Hamilton, quella magnifica collezione andò rapidamente in rovina; una parte del parco fu venduta dagli eredi e intorno al 1840 molto di ciò che rimaneva venne trasformato in un cimitero rurale; è un luogo affascinante e caro ai cittadini di Filadelfia, ma certo molto diverso rispetto ai suoi anni d'oro. Molte informazioni sulla sua storia in questo sito. Ma il nostro protagonista non è Hamilton; certamente questo patrono dei giardini attirò l'attenzione dei botanici che gli dedicarono ben tre generi Hamiltonia: nel 1806 il conterraneo Muhlenberg, nel 1824 Roxburgh, nel 1838 Harvey; nessuno dei tre oggi è però valido. Dunque la nostra attenzione si sposta su una figura forse più interessante, e sicuramente più simpatica: il sovrintendente, o capo giardiniere, di Woodlands, lo scozzese John Lyon. Nulla sappiamo della sua vita prima che fosse assunto da Hamilton nel 1785; ignoriamo persino se si trovasse già in America, o se abbia incontrato il futuro datore di lavoro in patria. Ci mancano notizie anche sul primo decennio trascorso a lavorare a Woodlands; la nostra principale fonte informativa è infatti il suo diario di campo, che inizia nel 1799. E' probabile che in quei sedici anni egli già affiancasse alla cura del giardino - di cui fu evidentemente il principale realizzatore - escursioni nei dintorni, per incrementare le collezioni di piante native. Il primo viaggio documentato è proprio di quell'anno, quando Hamilton lo inviò sugli Allegheny della Pennsylvania alla ricerca di Pyrularia pubera, una pianta emiparassita con semi oleosi e tossici di potenziale interesse farmacologico, che il collezionista non era riuscito fino ad allora a far germinare. La spedizione si concluse con un nulla di fatto. E' possibile che già allora Lyon mordesse il freno; preparato, intelligente, industrioso e di spirito indipendente, incominciava a sentirsi soffocare al servizio di un uomo arrogante, esigente e imperioso, tanto più che la figura sociale del capo giardiniere in America non godeva della stessa considerazione sociale che forse aveva potuto sperimentare in patria. A partire dal 1802, e per i successivi dodici anni, non avrebbe mai cessato di viaggiare, dapprima per conto di Hamilton, poi in proprio. Erano viaggi faticosi e pieni di insidie, in zone spesso poco conosciute e non segnate sulle carte. Lyon si muoveva a cavallo, alloggiava talvolta all'aperto, ma più spesso in locande o presso case ospitali; portava con sé provviste minime, carta per gli esemplari pressati, mentre le collezioni di radici e semi andavano crescendo. Gli incidenti non mancarono: fu morso da un cane rabbioso e dovette curare da sé la ferita infetta cauterizzandola con un ferro rovente; si intossicò gravemente raccogliendo semi del velenoso Rhus michauxii; affrontò una bufera così forte da abbattere gli alberi; perse più volte il cavallo. Viaggiava per lo più da solo, ma spesso faceva tappa presso altri botanici o appassionati, che talvolta gli facevano da guida o lo accompagnavano per qualche tratto. I suoi viaggi, in tutto dieci, lo portarono ad esplorare buona parte degli Stati centrali e meridionali dell'America atlantica, in particolare, oltre alla Pennsylvania e alla Virginia, le due Caroline, la Georgia e la Florida settentrionale, con una predilezione per le montagne che fanno da confine tra North Carolina e Tennessee; solo un viaggio lo portò a Nord, verso i grandi laghi. Tra i luoghi ricorrenti, dove si fermava presso amici, cui spesso affidava le sue raccolte o preparava i materiali per le spedizioni, Silk Hope, in North Carolina, dove abitava l'amico Stephen Elliott, che fu anche suo compagno di viaggio in diverse occasioni; le città portuali di Savannah in Georgia e Charleston nella Carolina del Sud, da dove spediva per nave a Filadelfia le sue raccolte; Nashville e Asheville, rispettivamente in Tennessee e North Carolina, punto di partenza per l'esplorazione delle amate montagne; Lancaster, tappa obbligata sulla via del ritorno per visitare l'amico Henry Muhlenberg. Le spedizioni più ampie e importanti sono probabilmente quelle del 1803-1804 e del 1807. Durante la prima Lyon percorse 2250 miglia, giungendo fino in Florida e esplorando anche, oltre a diverse aree montane, buona parte della costa e delle isole della Georgia. Proprio durante questo viaggio, nel 1803, fu l'ultima persona a vedere in natura alcuni esemplari di Franklinia alatamaha (e potrebbe avere qualche responsabilità nella sua estinzione). Durante la seconda, percorse 2500 miglia, muovendosi lungo le montagne sui confini tra North Carolina e Tennessee (dove sarebbe tornato altre volte e sarebbe morto); tra i suoi ospiti, la colonia morava della Cherokee Country, e tra gli incontri notevoli, quelli con Moses Fisk, pioniere degli insediamenti nel Tennessee, e con il pastore e botanico Samuel Gottlieb Kramsch. Una narrazione più dettagliata dei suoi viaggi nella vita. 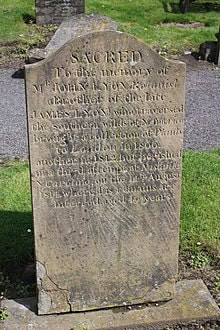 Collezioni di piante e spirito imprenditoriale Lyon è una figura interessante anche perché si distacca dagli altri cacciatori di piante per la sua indipendenza e intraprendenza. Mentre i suoi colleghi erano finanziati da sovrani, istituzioni pubbliche, mecenati oppure, sempre più spesso, lavoravano per qualche ditta commerciale, Lyon era un libero professionista che si assumeva le spese e i rischi e provvedeva da sé alla vendita delle sue raccolte. Probabilmente lasciò Hamilton (per il quale tornò a lavorare occasionalmente anche in seguito, ma solo come giardiniere) nella seconda metà del 1803; nel frattempo era stato sostituito con Frederick Pursh. Da quel momento, Lyon prese a creare una propria collezione, con l'obiettivo di commercializzarla in Inghilterra. In natura raccoglieva piante vive (in quantità che a noi fanno accapponare la pelle, come le 200 radici di Podophyllum di cui fece incetta nel 1804 in Georgia), ma ancora più semi; questi ultimi erano destinati alla vendita, ma anche alla riproduzione. In effetti, alla fine del 1804 il giardiniere avrebbe voluto imbarcarsi per l'Inghilterra, ma non trovando un imbarco si fermò a Filadelfia per quasi un anno, dedicato a seminare e curare le plantule da portare con sé in patria. A tal fine, si appoggiò al vivaista David Landreth (fondatore nel 1784 della più antica ditta sementiera statunitense), da cui affittò una parte del vivaio. Alla fine del 1805 Lyon poté finalmente imbarcarsi per Londra, via Dublino. Nella capitale inglese dimostrò ottime capacità imprenditoriali; per vendere le sue piante, si affidò non solo a una clientela privata, ma a un'asta pubblica, pubblicizzata con annunci su sette giornali e con la stampa di un catalogo, in cui le piante nuove (sp. nova!) sono ben evidenziate. Forte di questo successo, ritornò subito in America, dove investì i guadagni in nuovi viaggi, che si mossero principalmente lungo le predilette montagne tra North Carolina e Tennessee. Dopo cinque anni di fatiche aveva creato una seconda, ancora più ricca, collezione, che portò con sé in Inghilterra nell'inverno 1811-12. La clientela inglese fu impressionata dalla qualità e dalla quantità dell'offerta, anche questa volta venduta con un'asta pubblica (ce n'è rimasto il catalogo). L'infaticabile Lyon tornò quasi immediatamente in America, dove fece ancora due viaggi nei luoghi prediletti; ammalatosi probabilmente di febbre gialla, si spense a Asheville (North Carolina) nel 1814. Non conosciamo il luogo della sua sepoltura, ma i parenti gli eressero una lapide nel cimitero di Dundee, dove è ancora conservata. Nelle testimonianze dei contemporanei, l'importanza del suo contributo all'introduzione delle specie americane in Europa appare imponente. Secondo la seconda edizione di Hortus Kewensis, redatto da William T. Aiton, le specie nuove messe in vendita nel 1806 e nel 1812 sono 31; spesso non si tratta davvero di novità (molte erano già arrivate in Europa, in particolare grazie ai Michaux che avevano raccolto nelle stesse aree), ma piuttosto di reintroduzioni, rese però disponibili da Lyon in modo ben più massiccio. Nell'elenco figurano tra l'altro (uso le denominazioni attuali) Desmanthus illinoensis, Amsonia tabernemontana var. salicifolia, Asclepias pedicellata, Calycanthus floridus var. glaucus, Dicentra eximia, Hamamelis virginiana, Iris fulva, Cliftonia monophylla, Calycocarpum lyonii, Tradescantia subaspera. Ho lasciato volutamente per ultime le introduzioni più importanti e durature: Phlox paniculata, Pieris floribunda e Magnolia macrophylla (ma potrebbe trattarsi di una specie affine che vive nelle stesse aree, Magnolia fraseri var. pyramidata). Entrambe sono oggi considerate relativamente rare in natura, forse anche a causa del contributo di Lyon, che nel suo viaggio del 1809 in North Carolina ne raccolse ben 3600 esemplari. Amabile Lyonia
In questo atteggiamento predatorio verso la natura, Lyon era un figlio del suo tempo, e lo perdoneremo, tanto più che, come abbiamo visto, pagò di persona il suo accanimento di cacciatore di piante indipendente con la fatica, le malattie, la solitudine e infine con la morte precoce. La puntigliosa registrazione delle entrate e delle uscite annotata nel diario ci dice anche che, se la sua impresa non fu in perdita, neppure gli assicurò un largo guadagno. Come al suo datore di lavoro, anche a lui furono dedicati tre omonimi generi Lyonia; nel 1808 da Rafinesque; nel 1817 dall'amico Elliott; nel 1818 da Nuttall. Per una volta ad essere accettato da botanici è il più recente. Questa la dedica: "Per commemorare il nome del fu Mr. John Lyon, un raccoglitore infaticabile del Nord America, che cadde vittima di un'epidemia perniciosa in mezzo a quelle montagne selvagge e romantiche che erano state tanto spesso teatro delle sue fatiche". Numerose sono poi le specie che lo ricordano nel nome specifico, come Chelone lyonii o Rosa carolina var. lyonii. Lyonia Nutt. (famiglia Ericaceae) comprende circa 35 specie di piccoli alberi o arbusti diffusi nelle boscaglie dell'area himalayana, in Asia orientale, nel Nord America e nelle Antille. E' molto affine a Pieris, in cui in passato è anche confluito (oggi studi molecolari ne confermano l'indipendenza). Decidue o sempreverdi, le piante di questo genere hanno foglie alternate, intere, coriacee e lucide e graziosi fiori penduli tubolari o a forma di urna raccolti in racemi terminali, solitamente bianchi. Tra le specie americane vale la pena di ricordare L. ligustrina, nativa degli Stati Uniti orientali dal Maine alla Florida, notevolmente adattabile ad ambienti diversi e capace, grazie ai rizomi, di resistere agli incendi (molto frequenti nelle pinete in cui vive abitualmente); L. mariana, sempre degli Stati Uniti orientali, usata dai Cherokee come pianta medicinale, e oggi minacciata in Pennsylvania e Connecticut; L. lucida, la specie più nota e diffusa, raccolta anche da Lyon, presente nelle pianure costiere degli Stati Uniti orientali dalla Virginia alla Florida e alla Louisiana e nell'isola di Cuba, con graziosi fiori penduli cilindrici portati su rami arcuati, bianchi, ma anche rosa o rossi. Sono tutti arbusti, mentre può diventare un vero albero l'asiatica L. ovalifolia, diffusa nell'India himalayana, in Cina e in Giappone. Una curiosità: un tempo Lyonia viveva anche in Europa. Alcuni frutti fossili di †Lyonia danica, attribuiti al Miocene medio, sono stati infatti trovati nello Jutland centrale (Danimarca). Qualche approfondimento nella scheda. Nei primi giorni di primavera, è in fioritura anche una vecchia ospite dei nostri giardini, la maonia, o meglio Mahonia aquifolium, una pianta che siamo talmente abitati a vedere che forse dimentichiamo che ben pochi altri arbusti sono così poco esigenti e capaci di rallegrare anche un giardino d'ombra durante tutto l'arco dell'anno; in primavera appunto con i fiori dorati e dolcemente profumati, in estate con le bacche blu profondo, in autunno con le foglie rossastre, in inverno con il fogliame sempreverde. Arrivò nei giardini europei nel 1822, pochissimi anni dopo che Lewis e Clark la scoprirono nelle Montagne rocciose; a darle il nome fu un altro esploratore della flora del Nord America, Thomas Nuttall, che volle così onorare un pioniere del giardinaggio americano, Bernhard McMahon. Vivaista a Filadelfia, egli produsse il primo catalogo di sementi del paese e scrisse il manuale di giardinaggio più letto negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento, un best seller il cui successo durò mezzo secolo. Tra i suoi clienti anche Jefferson, che lo stimava tanto da affidargli, perché li coltivasse e li moltiplicasse, i semi di numerose piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark.  Un vivaista intraprendente Per volontà del presidente Jefferson, che considerava la botanica la "più utile delle scienze", le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark non solo furono inviate alla American Philosophical Society e Benjamin S. Barton perché le studiasse (scelta infelice, come abbiamo visto in questo post), ma semi, radici e bulbi vennero affidati a abili giardinieri perché li coltivassero e moltiplicassero. Qualche specie rimase nelle aiuole di Monticello, la tenuta del presidente, ma il grosso venne distribuito tra il ricco piantatore William Hamilton, proprietario di un celebre orto botanico privato nei pressi di Filadelfia, e Bernhard McMahon, che nella stessa città gestiva un vivaio e una ditta di sementi. Emigrato dall'Irlanda nel 1796, McMahon fondò la sua impresa nel 1802; avendo lavorato per qualche tempo presso un giornale, era consapevole dell'importanza della stampa e decise di pubblicizzare i suoi prodotti con un catalogo, il primo del genere negli Stati uniti; Catalogue of Garden Grass, Herb, Flower, Tree & Shrub-Seeds, Flower Roots, &c, pubblicato nel 1802-03, comprende 720 specie e varietà di semi, nella maggioranza dei casi di piante di origine europee. Una maggiore attenzione alle piante native si nota già nella seconda edizione (1804). Uomo di notevole intraprendenza e intelligenza, McMahon cominciò anche a seguire le lezioni di Benjamin S. Barton, che, proprietario della prima serra della città, divenne uno dei suoi clienti. Appassionato raccoglitore oltre che coltivatore, spesso inviò al professore esemplari di piante interessanti trovate nei dintorni della città, che scambiava anche con altri botanici come Henry Muhlenberg. Intanto aveva incominciato a lavorare alla sua opera più nota, The American Gardener's Calendar: Adapted to the Climates and Seasons of the United States, la cui prima edizione uscì nel 1806; un testo di grande successo, come testimoniano le sue undici edizioni, l'ultima delle quali pubblicata quarantanni dopo la morte dell'autore. Modellato su analoghe opere britanniche, in particolare Gardener's Dictionary di P. Miller e Every Man his own Gardener di J. Abercrombie, segue la tradizionale presentazione dei lavori mese per mese, con indicazioni per la preparazione del suolo, le semine, gli impianti, le potature. Il capitolo "Ornamental Designs and Plantings", ritenuto il primo saggio sulla progettazione dei giardini paesaggistici pubblicato in America, contribuì largamente alla diffusione oltreoceano della nuova moda del giardino paesaggistico e naturalistico. Anche se la maggior parte delle piante illustrate nel calendario erano quelle tradizionalmente coltivate in Europa, McMahon incoraggiava i suoi lettori a imitare la natura e ad accogliere le specie americane, lodando in particolare la bellezza degli alberi, degli arbusti da fiore e dei fiori selvatici, di cui sottolineava la robustezza e la maggiore adattabilità alle roventi estati americane. In ciò incontrava le inclinazioni di Jefferson, che seguì le sue indicazioni quando creò la bordura fiorita e le aiuole ovali di Monticello; con il vivaista, divenuto anche il suo principale fornitore di piante e sementi, scambiò una cordiale corrispondenza e, come ho già anticipato, lo scelse per coltivare e custodire parte delle collezioni vive di Lewis e Clark. Tra i primi invii, giunti già nel 1805 da Fort Mandan, il "tabacco di Mandan", ovvero Nicotiana quadrivalvis, e Linum lewisii. Nel 1807, quando, in vista della pubblicazione del resoconto ufficiale della spedizione, si cercava un illustratore botanico, fu McMahon a suggerire il tedesco Frederick Pursh, che all'epoca lavorava per Barton come curatore dell'erbario e raccoglitore. Pursh si stabilì a casa sua, per poter ritrarre sia gli esemplari essiccati sia le piante coltivate nel vivaio, di cui scrisse anche le descrizioni; rimase ospite di McMahon fino alla fine del 1808, sempre più nervoso e impaziente mano a mano che capiva che probabilmente Barton non avrebbe mai scritto i capitoli sulla flora che Jefferson si attendeva da lui. Nella sua corrispondenza con il presidente, McMahon espresse grande entusiasmo per l'alta qualità dei semi ricevuti da Lewis; nel 1807 ne coltivava 20 nuove specie e 5 o 6 nuovi generi; particolarmente interessanti riteneva alcuni nuovi tipi di ribes e uva spina, tra cui il magnifico Ribes aureum, con fragranti fiori gialli. Nel 1808, acquistò 20 acri di terreno a Germantown Road per costruire un vivaio più ampio e un giardino botanico che, in onore di Linneo e della sua università, chiamò Upsal Botanic Garden; secondo la testimonianza di Muhlenberg, incominciò a impiantarlo l'anno successivo. Nel 1815, usciva una nuova edizione del catalogo di sementi. McMahon morì l'anno successivo, con un solo cruccio. Le piante che gli erano state affidate da Jefferson e coltivava con tanta dedizione erano di proprietà federale, non poteva né commercializzarle né pubblicarle; dopo la tragica morte di Lewis, non aveva esitato a restituire a Clark tutti gli esemplari essiccati depositati presso di lui, nella speranza che Barton, o qualche altro botanico americano, pubblicasse finalmente le piante raccolte durante la famosa spedizione; a farlo invece fu Frederick Pursh, che nel 1811 si era trasferito a Londra, portando con sé i disegni e le descrizioni, e nel 1813 vi pubblicò Flora America septentrionalis che contiene le immagini e le descrizioni di 130 delle specie raccolte da Lewis. Dopo la morte di McMahon (una sintesi della sua vita nella sezione biografie), il vivaio fu gestito dalla vedova Ann e più tardi dal figlio Thomas P., che continuò a rivedere e pubblicare il calendario (l'ultima edizione è del 1857). Berberis o Mahonia? Un dibattito secolare
Durante la spedizione nel nord-ovest erano stati raccolti tre arbusti che Pursh assegnò al genere Berberis, con i nomi B. aquifolium, B. nervosus e B. repens. Nel 1818 Thomas Nuttall in The genera of North America ne separò le prime due, creando per loro il genere Mahonia, in onore del nostro valente vivaista, con questa motivazione: "In memoria del fu Bernhard McMahon, la cui passione per la botanica e l'introduzione, coronata dal successo, di piante utili e ornamentali negli Stati Uniti rivendica la pubblica stima". Era l'inizio di un dibattito durato due secoli. Mentre le Mahoniae facevano la conquista dei nostri giardini, i botanici si combattevano a colpi di dotti articoli, assegnandole ora a un genere proprio ora includendole in Berberis. Le differenze tra i due generi sono sottili: i fiori sono identici, ma Berberis ha foglie semplici e fusti spinosi, Mahonia foglie composte e fusti privi di spine. Alla fine del XX secolo, la bilancia - con dolore di appassionati, vivaisti e giardinieri - sembrava propendere per un vastissimo genere Berberis, con circa 600 specie; i sostenitori di questa tesi, che non convinse l'intera comunità scientifica ma fu accolta dai maggiori repertori come Plant list o Plants of the World, sottolineavano come i due generi si incrociano tra loro, producendo gli ibridi x Mahoberberis (che però, va ricordato, sono tendenzialmente sterili). Tuttavia il dibattito continuava. Tra chi era meno convinto, i botanici cinesi - la Cina è il centro di diversità di Mahonia, con circa il 50% delle specie sul suo territorio; fu così che un'équipe dell'Università di Taiwan, diretta dal professor Yu, decise di studiare a fondo il gruppo di Mahoniae più problematico, quello che più si avvicina a Berberis, Mentre le altre Mahoniae vivono in aree boschive, l'habitat di questo gruppo sono i deserti tra Stati Uniti meridionali e Messico; hanno foglie composte ma sono dotate di spine. Dopo sette anni di lavoro sul campo e in laboratorio per le analisi del DNA, l'importante studio è stato pubblicato nel 2017, ribaltando la situazione. Mahonia viene ristabilito come genere indipendente, più antico di Berberis di cui è presumibilmente l'antenato; ma ne vengono separati due piccoli generi nuovi: Moranothamnus (prima Mahonia claireae) e Alloberberis (prima Mahonia sezione horridae). Dunque, finalmente Mahonia. Nei limiti in cui è stato ridefinito, diventa il secondo genere per numero di specie della famiglia Berberidaceae, con circa sessanta rappresentanti tra Asia orientale (31 specie in Cina, di cui 27 endemiche), Asia himalayana, America settentrionale e centrale. Sono arbusti, in genere alti e espansi, con foglie pinnate e fiori raccolti in racemi, solitamente gialli. Molti sono popolari piante da giardino, a cominciare da Mahonia aquifolium, la specie tipo, arrivata in Europa nei prima anni '20 dell'Ottocento, divenendo subito molto comune, tanto da spontaneizzarsi in diverse aree. Più recente, almeno da noi, il successo delle più imponenti specie asiatiche a fioritura invernale, come M. japonica e soprattutto l'ibrida M. x media, la cui cultivar più nota è probabilmente 'Charity'. Qualche approfondimento su queste e alcune altre specie nella scheda. Arrivano dalle foreste pluviali dell'Asia e dalle praterie del Mediterraneo Molineria e Molineriella, i due generi dedicati a Ignazio Molineri, giardiniere dell'orto botanico di Torino, appassionato ricercatore di piante che contribuì forse più di ogni altro alla conoscenza della flora piemontese. Gli resero omaggio botanici del calibro di Allioni - che assistette per decenni, prestandogli i suoi occhi acuti -, Balbis e Parlatore.  Una dinasty dell'orto botanico di Torino Tra i dedicatari dei nomi botanici, sono relativamente rari gli esponenti di una categoria senza la quale nessun giardino, tanto meno un orto botanico, potrebbe prosperare e addirittura sopravvivere: quella dei giardinieri. Tra le fortunate eccezioni, Ignazio Molineri che a cavallo tra Settecento e Ottocento lavorò all'orto botanico di Torino per un quarantennio, percorrendo tutte le tappe della carriera da apprendista a giardiniere capo. Approfittiamone per conoscere più da vicino lui e i suoi compagni di lavoro in un giardino di fama europea, ma di dimensioni modeste e soprattutto di scarsi mezzi finanziari (ancora nell'Ottocento, i curatori lamentavano che i finanziamenti non erano neppure sufficienti per un adeguato riscaldamento delle serre, per non parlare dell'acquisto di piante esotiche). Intorno al 1730 (l'orto era stato istituito nel 1729) il personale era costituito da Sante Andreoli o Andreola, "giardiniere di botanica o erbolaio", Pietro Cornaglia, aiuto giardiniere e erbolaio in seconda, e due garzoni, Francesco Peyroleri e un altro di cui non conosciamo il nome, cui potevano aggiungersi all'occasione avventizi e lavoratori a giornata. Accanto alle competenze orticole necessarie per dirigere il lavoro di assistenti e garzoni, all'erbolaio era richiesta una perfetta conoscenza pratica e teorica delle piante, soprattutto officinali; tra i suoi compiti infatti rientrava la raccolta in natura di piante, sia per accrescere le collezioni, sia per fornire i semplici destinati allo studio e alla coltivazione; inoltre doveva assistere il professore di botanica e direttore dell'orto supportandolo durante le lezioni di materia medica. Non a caso, Bartolomeo Caccia (1695-1746, il primo direttore dell'orto di Torino), in assenza di personale già formato nella capitale sabauda, fece venire Andreoli dall'orto botanico di Padova; appartenente a una famiglia di giardinieri dell'istituzione patavina, egli era già in età avanzata e quindi Caccia ritenne opportuno affiancargli Pietro Cornaglia, che poi alla morte di Andreoli, di cui non conosciamo con precisione la data, gli succedette come primo erbolaio. Cornaglia accompagnò Donati in diversi viaggi; in particolare nel 1751 fu con lui ad erborizzare in val di Susa, sul Moncenisio, in Moriana, in Tarantasia, sul Gran San Bernardo e in Val d'Aosta. Quanto a Francesco Peyroleri, che intorno al 1750 fu nominato secondo erbolaio, avendo dimostrato un notevole talento per il disegno, la sua attività principale divenne quella di "disegnatore delle piante botaniche". Autore di centinaia di tavole dell'Iconographia taurinensis, d'altra parte Peyroleri partecipò attivamente all'esplorazione botanica del territorio sabaudo, anche per procurarsi le piante vive da ritrarre; ancora nel 1764 (all'epoca si avvicinava ai sessant'anni) lo troviamo come compagno di viaggio di Bellardi tra Val d'Aosta e Savoia (ne ho parlato in questo post). Ma sulla figura del disegnatore, che andava ormai differenziandosi da quella di giardiniere, avremo occasione di tornare in un'altra occasione. E' ora infatti che entri in scena il nostro protagonista. Cornaglia era originario di Montaldo di Mondovì, un paesino di montagna descritto dai contemporaneo come "selvaggio e alpestre"; com'era uso all'epoca, scelse come collaboratori alcuni parenti. Il primo fu un nipote, Paolo Cornaglia, che nel 1759 fu aggregato come giardiniere alla spedizione di Donati in Oriente; purtroppo, come ho raccontato in questo post, non andò più lontano di Venezia, dove giunse già malato e morì. Ben più fortunate furono le vicende dei fratelli Molineri, che di Cornaglia erano cugini. Il primo ad arrivare a Torino dalla nativa Montaldo fu Pietro (nato nel 1736), che percorse una dopo l'altra le tappe ormai istituzionalizzate della carriera di giardiniere dell'orto torinese: nel 1758 fu assunto come garzone straordinario; nel 1761 divenne allievo; nel 1777 aiutante erbolaio; nel 1781 (e fino alla morte, 1800) giardiniere capo o custode. Qualche anno dopo lo raggiunse il fratello minore Ignazio, che nel 1767 risulta in forza come allievo giardiniere. Le opere di Allioni (direttore dal 1763 al 1781) sono prodighe di elogi per i due fratelli, definiti "giovani assai pazienti alle fatiche, dotati di ingegno e di corpo robusto, abili orticultori". Allioni stesso li istruì nel sistema di Linneo e i due divennero naturalisti compiuti. Il contributo di entrambi all'esplorazione del territorio piemontese fu inestimabile, tanto che in Flora pedemontana e in Auctarium ad floram pedemontanam sono citati come raccoglitori quasi ad ogni pagina. La predilezione di Pietro andava all'entomologia e numerosissimi sono gli insetti che fornì ad Allioni (la cui collezione pare si aggirasse sui 4000 esemplari); egli scoprì anche alcune nuove specie che poi furono pubblicate da Fabricius. La passione di Ignazio era invece la botanica; raccoglitore entusiasta, percorse molte contrade del Piemonte, raccogliendo ben 127 specie diverse. Tra le sue scoperte più notevoli, Saxifraga florulenta, la rara sassifraga dell'Argentera. Tra i suoi compiti, anche l'allestimento e la cura degli esemplari essiccati che andarono a costituire il primo nucleo dell'Erbario dell'orto torinese. Quando l'avanzare dell'età e l'affaticamento causato dal continuo uso del microscopio danneggiarono la vista di Allioni, fu Ignazio - di cui ancora una volta il professore loda la perizia e la diligenza nella raccolta e nello studio delle piante - a prestargli i suoi occhi, consentendogli di completare le sue opere. Non ultimo merito di Ignazio fu aver preservato le raccolte stesse dell'orto negli anni di trascuratezza dovuti alla malattia di Dana e alla guerra. Nel 1801, morto il fratello, gli succedette come giardiniere capo iniziando una fervida collaborazione con il nuovo direttore, Giovanni Battista Balbis. Fu anzi proprio lui, con il suo entusiasmo, il suo aiuto e il suo sostegno a incoraggiare Balbis - desolato di fronte allo spettacolo di tanta rovina - a intraprendere l'impresa di fare rivivere e restituire ai passati fasti l'orto torinese. Benché fosse ormai sulla sessantina, lo accompagnò anche in diverse escursioni tutt'altro che agevoli sulle montagne piemontesi; Balbis volle preservarne la memoria dedicandogli Poa molinerii e Iberis molinerii. Nel suo catalogo dell'orto (1810) ne scrisse una lode che è anche il più ampio ritratto del valente giardiniere. Oltre a riconoscere apertamente che, senza di lui e il suo paziente lavoro di raccoglitore, non ci sarebbero state né le opere di Allioni né le sue, ricorda come questo autodidatta, nato in un villaggio di montagna, oltre ad essere un botanico di eccezionale valore, dominasse il francese e il latino; avesse imparato del greco almeno quanto era necessario per comprendere l'etimologia dei termini botanici; padroneggiasse la geografia, tanto importante per la raccolta delle piante legate a determinati habitat; avesse voluto completare le sue conoscenze con lo studio di geometria e astronomia. In tanta stima lo aveva Balbis che lo propose come membro della Commissione di scienze ed arti incaricata di stendere un progetto generale di istruzione pubblica. Nel 1802, quando venne creata la scuola di veterinaria presso il Valentino, la commissione esecutiva lo nominò dimostratore delle piante, ovvero insegnante di botanica. Morì in tarda età circondato dalla stima generale nel 1818. Una sintesi di questa vita contemporaneamente semplice ed eccezionale nella sezione biografie.  Molineria, foglie dal fascino tropicale Qualche anno dopo la sua morte, nel 1826, un nuovo omaggio giunse da Colla. Nel suo giardino di Rivoli egli coltivava Curculigo sumatrana, un'erbacea orientale procuratagli da un corrispondente. Poiché non gli risultava che nessuno l'avesse pubblicata fino a quello momento e le sue caratteristiche differivano a suo parere da quelle delle altre Curculigo, egli ritenne appartenesse a un nuovo genere, che dedicò a Molineri "già custode dell'Orto botanico, i cui grandi meriti per la botanica patria sono attestati dalla celeberrima Flora pedemontana di Allioni e dalle aggiunte dell'insigne Balbis". Anche se Colla si sbagliava (Curculigo sumatrana Roxb. continua a chiamarsi così), il genere fu adottato da botanici successivi ed è tuttora valido. Appartenente alla famiglia Hypoxidaceae, comprende sette specie di monocotiledoni erbacee native del subcontinente indiano, della Cina, del Sud est asiatico e dell'Oceania, con centro di diversità in India dove sono presenti tutte le specie. Sono piante rizomatose con grandi foglie che ricordano quelle dell'Aspidistra e fiori a stella assai decorativi, ma poco visibili perché crescono raso terra e sono nascosti dal fogliame. La specie più diffusa e nota è M. capitulata, detta in inglese palm grass per le grandi foglie lanceolate (lunghe anche un metro), fibrose e con marcate venature parallele, che possono ricordare quelle di una giovane palma; originaria del sottobosco delle foreste umide di gran parte dell'Asia orientale e della Nuova Guinea, è stata introdotta in altri paesi tropicali, dove si è dimostrata fin troppo volenterosa. Nei giardini a clima mite può essere utilizzata come notevole tappezzante per la capacità di colonizzare rapidamente il terreno. Nei paesi d'origine, le foglie vengono utilizzate per creare cesti e altri manufatti. Qualche informazione in più nella scheda.  La minuscola Molineriella Nel 1850, anche Parlatore si ricordò di Molineri, creando un secondo genere Molineria per M. minuta, una minuscola Poacaea. La motivazione è davvero interessante: "Ho voluto con questo ricordar nella scienza il nome d'Ignazio Molineri, già custode del R. Giardino botanico di Torino, il quale arricchì di numerose scoperte la flora italiana con i suoi frequenti viaggi nelle Alpi e nella Liguria. Ho prescelto una pianta piccola con l'epiteto minuta per indicare l'acutezza del suo occhio osservatore, a cui nulla sfuggiva per quanto piccolo e minuto". Poiché nel frattempo la denominazione di Colla, benché applicata ad altre specie, si era affermata, quella proposta da Parlatore risultava illegittima. Ma a risolvere la questione a favore del nostro bravissimo giardiniere-botanico dalla vista acuta fu il francese Georges Rouy che nel 1913 ne mutò la denominazione in Molineriella. Questo genere della famiglia Poaceae comprende tre specie di erbe annuali dell'area mediterranea, con centro di diversità in Spagna dove sono presenti tutte. Nel nostro paese cresce la sola M. minuta, nota con il nome volgare di "nebbia di Molineri" per le aeree infiorescenze, un'erba che raramente supera i 20 cm, presente in tutte le regioni del centro e del sud, dove cresce negli incolti e nei prati di annuali. Qualche approfondimento nella scheda. Alla storia di James Dickson, il quarto e ultimo dei padri fondatori della RHS ad essere onorato da un nome generico valido, si adatterebbe il titolo "Dalla vanga al milione". Nato in una povera famiglia scozzese, non solo si trasformò nell'agiato proprietario di un vivaio e di un negozio di piante e sementi, ma acquisì reputazione internazionale come pioniere degli studi di un ramo ancora trascurato della botanica, quello delle crittogame. A ricordarlo, grazie a un botanico francese innamorato dei giardini inglesi, le stupefacenti felci arboree del genere Dicksonia. Con un'appendice sul misterioso botanico polacco Zier e la sua Zieria.  Un giardiniere con il bernoccolo degli affari Al contrario di quanto accadde a Richard Salisbury e William Forsyth, nessuna polemica polemica sfiorò James Dickson, che seppe guadagnarsi la stima dei contemporanei tanto negli affari quanto nella scienza, tanto che nel suo necrologio James Edward Smith, presidente della Linnean Society, e suo intimo amico, ebbe a definirlo "un uomo di integrità senza macchia". La sua storia sembra quasi uscire da uno di quei racconti edificanti che si facevano leggere ai ragazzi nell'Ottocento per dimostrare che "volere è potere". Nato in una famiglia scozzese povera, cominciò la sua carriera come apprendista nel giardino del signorotto locale, il conte di Torquay. Un giorno sentì un altro garzone chiedere a un compagno più esperto il nome di una pianta; rimase affascinato dalla risposta competente e decise di saperne di più, dedicando tutto il suo tempo libero allo studio della botanica. Diventato adulto, proprio come Forsyth e centinaia di altri giardinieri scozzesi, emigrò a Londra dove trovò lavoro come giardiniere presso il vivaio Jeffrey and Co., a Kensington; più tardi lavorò in un vivaio di Hammersmith, probabilmente il celebre "The Vineyard" di Lee & Kennedy. Lavorando anche in diverse grandi proprietà, mise insieme abbastanza risparmi da aprire, nel 1772, un proprio negozio di piante e sementi al Covent Garden; una scelta che dimostra il suo fiuto per gli affari: era un'area frequentatissima, con caffè, teatri e il più importante mercato di Londra. Infatti al nuovo negozio arrise subito il successo, attirando clienti importanti, come lo stesso Forsyth (all'epoca sovrintendente dell'orto botanico di Chelsea) e James Edward Smith. Ma l'incontro più importante fu quello con Joseph Banks, che gli divenne amico e lo coinvolse nel suo circolo di studiosi e appassionati di botanica. Nel 1781, quando l'amministrazione del British Museum era alla ricerca di un nuovo giardiniere, sempre su suggerimento di Banks, Dickson presentò la sua candidatura; poiché la sua offerta risultò la più competitiva, ottenne l'appalto, mantenendo l'incarico fino alla morte. Negli anni '90, la sua posizione economica divenne ancora più solida, con l'acquisto di un grande vivaio a Croydon, che gestì fino al 1799, quando si ritirò dall'attività (ma mantenendo il negozio di Covent Garden, che alla morte lasciò al figlio, con una cospicua eredità a lui e alle figlie).  Il fascino discreto delle briofite Quest'uomo d'affari di successo seppe anche diventare un botanico di rinomanza internazionale. Anche in questo caso, c'è lo zampino di Banks, che oltre a metterlo in contatto con il Gotha della botanica britannica, ne incoraggiò gli studi mettendogli a disposizione la sua ricca biblioteca. Fu ancora Banks a coinvolgerlo nel 1788 nella fondazione della Linnean Society (creata e presieduta da un altro amico, James Edward Smith) e nel 1804 della Horticultural Society, di cui Dickson fu eletto vicepresidente. In tal modo, egli è l'unico - oltre a Banks, ça va sans dire - ad essere annoverato tra i padri fondatori di entrambe le istituzioni. Intorno al 1780 Dickson cominciò a interessarsi a quello che sarebbe diventato il suo campo di elezione: le crittogame. In un'epoca in cui l'interesse dei botanici era indirizzato piuttosto verso le fanerogame, i suoi studi ebbero un ruolo pionieristico. Questa passione singolare lo riportava alla sua terra d'origine, la Scozia. Per la sua posizione geografica, la varietà climatica e la diversa natura dei suoli, la Scozia è infatti il paradiso delle briofite: la costa occidentale è ricca di specie di muschi e licheni dell'area oceanica; i banchi assolati del sud-est ospitano specie mediterranee; nelle aree montane - quelle più ricche di specie - a dominare sono quelle nivali e alpine; le montagne delle Higlands nordoccidentali ospitano una comunità unica al mondo, denominata "Northern Hepatic Mat", dominata da una serie di licheni rari, alcuni dei quali vivono solo qui, nell'Himalaya e nelle montagne del British Columbia in Canada (a migliaia di km di distanza). Con le sue 920 specie di briofite, non sorprende che la Scozia abbia dato i natali ai pionieri degli studi di muschi, epatiche e licheni: Archibald Menzies, Robert Brown, William Hooker e, naturalmente, il nostro James Dickson. Per raccogliere e studiare le sue piante predilette, tra il 1785 e il 1791 Dickson ritornò più volte in Scozia, esplorandone i diversi ambienti, comprese le isole Ebridi, talvolta da solo, talvolta con alcuni amici (J. E. Smith, che lo vide in azione, lo soprannominò "Dickson occhio di lince" per l'acume con cui sapeva scovare nuove specie). Nel 1789, fu accompagnato dal giovane cognato diciottenne, lo studente di medicina Mungo Park. Più tardi, lo presentò a Banks, che ne fece uno dei suoi cacciatori di piante. Si deve dunque a Dickson l'inizio della carriera del celebre esploratore scozzese. I risultati della ricerche di Dickson furono presentati nei quattro Fasculi Plantarum Crytogamicarum Britanniae, usciti rispettivamente nel 1785, 1790, 1793 e 1801, in cui vengono descritte circa 400 specie di muschi, epatiche, licheni, alghe e funghi delle isole britanniche; se per le prime categorie Dickson attinse soprattutto al materiale raccolto nelle spedizioni scozzesi (con moltissime specie descritte per la prima volta), per le alghe e i funghi si appoggiò sulle raccolte di amici e corrispondenti, soprattutto nell'Inghilterra meridionale. All'epoca, soprattutto se si desiderava diffondere le proprie opere a livello internazionale, la lingua della scienza era ancora il latino, una lingua estranea a Dickson, un self made man privo di preparazione accademica. Perciò, per la stesura dei primi tre fascicoli si avvalse della collaborazione del misterioso botanico polacco Jan Zier e per l'ultimo di quella di Robert Brown, che scrissero le descrizioni tecniche in latino. I volumi erano illustrati dagli acquarelli del grande pittore botanico James Sowerby. L'importanza dei contributi di Zier e Brown (semplici "traduttori" o autori veri e propri) è oggetto di discussione. Il primo fascicolo è aperto dalla dedica a Joseph Banks "baronetto, presidente della Royal Society, curatore del British Museum, principe dei botanici". Seguono le descrizioni delle specie, divise in tre categorie: Musci (che comprende anche altre briofite, come le epatiche), Algae (che curiosamente comprende anche i licheni), Fungi. In un'appendice solo elencate le piante scozzesi segnalate per la prima volta nel corso dei suoi viaggi, con la denominazione linneana. Oltre a diversi contributi pubblicati sulle Transactions della Linnean Society e della Horticultural Society, Dickson fu autore anche di due opere sulla flora britannica che divulgarono il sistema linneano: A Collection of Dried Plants, named on the authority of the Linnaean Herbarium, and other original collections, pubblicato tra il 1787 e il 1799, in 17 fascicoli; Hortus Siccus Britannicus, in 19 fascicoli usciti tra il 1793 e il 1802. Alla sua morte, avvenuta nel 1822, fu commemorato da un necrologio del suo vecchio amico James Edward Smith. Una sintesi della sua lunga e operosa vita nella sezione biografie.  L'Heritiér de Brutelle e la Dicksonia di Sant'Elena Come Dickson giunse a donare il suo nome al magnifico genere Dicksonia, che comprende spettacolari felci arboree, la più nota delle quali è la neozelandese D. anctartica, è un'altra bella storia da raccontare. Nel maggio 1771, sulla rotta di casa, l'Endevour, la nave del primo viaggio di Cook, fece scalo a Sant'Elena per rifornimenti; Banks e l'amico Solander ne approfittarono per erborizzare. Li colpirono le magnifiche felci arboree che rivestivano le parti più alte dell'isola e ne raccolsero le spore; arrivate a Londra, germinarono, e alcuni anni dopo alcuni esemplari della felce ancora senza nome erano la gloria dei giardini di Kew. Fu lì che la vide nel 1786 il botanico francese L'Héritier de Brutelle, che si era rifugiato a Londra con l'erbario di Dombey piuttosto di restituirlo alla corona spagnola. I botanici britannici lo accolsero a braccia aperte e L'Héritier volle ripagare la cortesia dedicando ad alcuni di loro diversi nuovi generi nel suo Sertum anglicum (1788), in cui descrisse alcune specie di Dombey insieme a piante rare che aveva visto nei giardini inglesi. A Dickson - forse perché era un esperto di crittogame, anche se non di felci - toccò la felce di Sant'Elena, ribattezzata Dicksonia arborescens. Il genere Dicksonia, appartenente a una famiglia propria (Dicksoniaceae), comprende circa 25 specie di felci con rizomi solitamente eretti, simili a tronchi, ma talvolta striscianti, che culminano con un morbido ciuffo di lunghe fronde. La sua distribuzione geografica è singolare: con centro di irradiazione probabilmente in Nuova Guinea (dove si trovano 5 specie), si spinge a nord in Indocina, poi a est attraverso il Pacifico, raggiungendo le Filippine, l'Australia, la Nuova Zelanda (con le specie più rustiche, quindi più note e coltivate da noi), la Nuova Caledonia, quindi, varcato l'Oceano, in Messico, America centrale, Perù, Brasile. Come si arrivata a Sant'Elena, nessuno lo sa: l'isola dove fu relegato Napoleone dista 1900 km dalla costa africana (in questo continente le Dicksoniae non sono mai arrivate) e 3250 dalla costa del Brasile, dove vive la specie più vicina, D. sellowiana. Del resto, queste bellissime felci hanno avuto il tempo per viaggiare: sono piante antichissime, la cui origine si fa risalire al Giurassico e al Cretaceo (almeno 150 milioni di anni fa). Qualche approfondimento nella scheda.  Il misterioso Zier e l'elusiva Zieria Ma è ora di strappare all'oblio Jan (o John) Zier, collaboratore o gost writer di Dickson. Su di lui c'è arrivato davvero pochissimo: la data di morte, le sibilline motivazioni della dedica del genere Zieria, un manoscritto dimenticato, qualche notizia sparsa che trapela qua e là dalle pubblicazioni del tempo. Le maggiori informazioni su di lui si devono a una nota di G. Jameson, pubblicata nel 1810, che ci informa che era polacco, definendolo "un botanico valente e industrioso". Quando e dove fosse nato, non si sa, né quando e perché sia approdato in Inghilterra. In un manoscritto che inviò non sappiamo quando né perché a Menzies (in sostanza, il manoscritto delle descrizioni scritte per i fascicoli di Dickson) Zier dice di essere amico di J.F. Ehrhart, direttore dell'orto botanico di Hannover. Dato che il re d'Inghilterra era anche Principe elettore di Hannover, e nel 1780 Ehrhart fu nominato Botanico reale e elettorale, potrebbe essere stato lui a fare da tramite al trasferimento di Zier in Inghilterra. E' possibile che vi giungesse nel 1785, anno in cui uscì il primo fascicolo dell'opera di Dickson sulle crittogame. Nell'Hortus kewensis (ovvero il catalogo di Kew) del 1787, risultano come procurate da lui alcune piante provenienti dall'Europa centrale, in particolare dall'Austria e dalla Pannonia. Nel 1788, in occasione della seconda riunione della Linnean Society, vi fu ammesso su proposta del presidente, James Edward Smith, segno che all'epoca era già un botanico rinomato. In una nota scritta diversi anni dopo nella Cyclopedia di Rees, lo stesso Smith sostiene che siano di mano di Zier anche le descrizioni della Flora londinensis di Curtis uscita in sei volumi tra il 1777 e il 1798, un'insinuazione che non trova riscontri in altre fonti. Un altro amico di Zier fu il botanico John Sims, che ne ereditò l'erbario (che comprende anche alcune briofite); secondo il già citato Jameson, nel 1796 (o forse alla fine del 1795) Zier si accingeva a tornare in Polonia, dove gli era stata assegnata una cattedra quando, consunto da una malattia cronica, morì, ancora in età abbastanza giovane. Poco dopo, nel 1798, James Edward Smith volle ricordarlo dedicandogli il genere Zieria in Transactions of the Linnean Society, dicendo esplicitamente che era un modo di sottrarlo all'oblio, visto che le sue fatiche erano diventate celebri sotto il nome di altri (allusione a Dickson e forse anche a Curtis?). Inoltre, lo specifico zieri è stato assegnato ad alcune briofite da lui descritte nei fascicoli di Dickson. Zieria è un piccolo genere della famiglia Rutaceae che comprende una quarantina specie, tutte endemiche dell'Australia orientale, tranne Z. chevalieri, presente in Nuova Caledonia. Sono graziosi arbusti dal portamento prostrato o piccoli alberi, con foglie opposte e composte, trifoliate con la fogliolina centrale lievemente maggiore delle due laterali. I fiori, raccolti in infiorescenze all'ascella fogliare, hanno quattro sepali fusi, quatto petali alternati con i sepali e quattro stami. E' molto simile all'affine Boronia, da cui si distingue per le foglie, il numero di stami (quattro in Zieria, otto in Boronia) e alcune particolarità dei frutti; come quelli di Boronia, anche le foglie e i fiori di alcune specie di Zieria sono ricchi di olio essenziale, con usi medicinali e in profumeria. In continuità con il loro elusivo dedicatario, sono piante decisamente di nicchia: molte sono endemismi di piccole aree a rischio di estinzione; alcune sono state identificate e descritte solo da pochissimi anni; soppiantate dalle più vistose Boroniae, anche nei guardini australiani, con qualche eccezione, non sono molte diffuse; nei giardini di altri continenti non sono mai arrivate. Qualche informazione in più e una selezione di specie nella scheda. Curioso destino, quello di William Forsyth: reputato dai contemporanei un'autorità indiscussa soprattutto nel campo delle piante da frutto, scrisse un best seller che resistette per decenni, stampato e ristampato; un successo professionale che raggiunse il suo apice con la creazione del Forsyth's plaister, che inizialmente gli procurò fama, onori e denaro, ma poi finì per rovinare i suoi ultimi anni (e la sua reputazione presso i posteri). Ora è ricordato soprattutto grazie alla solare forsizia, che con le sue esplosive fioriture annuncia l'arrivo della primavera.  Un prototipo di giardino roccioso... Abbiamo incontrato William Forsyth tra i sette padri fondatori della (futura) Royal Horticultural Society: a lui si rivolse Wedgwood per chiedergli di coinvolgere Banks, e sicuramente fu lui il principale organizzatore della fatidica riunione del 7 marzo 1804. Del resto, in quel momento era un'autorità: curatore dei giardini reali di Kensington e Saint James, autore di un volume di successo sull'arboricoltura, godeva del sostegno di membri del parlamento e dell'ammiragliato. Ma andiamo con ordine. Nato nel 1737 a Old Medrum, nei pressi di Aberdeen, Forsyth era uno dei numerosissimi giardinieri scozzesi che a partire dalla seconda metà del Settecento per circa un secolo quasi monopolizzarono l'orticultura inglese. Come molti conterranei, venne a cercare fortuna a Londra. Dopo aver perfezionato la sua formazione con Philip Miller al Chelsea Physic Garden, nel 1763 fu nominato capogiardiniere di Syon House, il grande parco londinese di proprietà del duca di Northumberland che proprio in quegli anni veniva riplasmato come giardino paesaggistico da Capability Brown. Nel 1771, quando l'ottuagenario Miller fu costretto al pensionamento dal Comitato dei farmacisti, gli subentrò come giardiniere capo a Chelsea; la sua assunzione fu subordinata all'accettazione di regole ferree imposte dal Comitato, che mal aveva sopportato l'indipendenza e il caratteraccio di Miller; il Comitato si riservava di decidere ogni particolare della sistemazione del giardino, e Forsyth doveva chiederne l'autorizzazione per ogni più piccolo spostamento, oltre che per scambiare piante e semi con altre istituzioni. Nonostante questo (e le condizioni finanziarie poco brillanti, con una paga annua di 50 sterline), si trattava di un incarico prestigioso: all'epoca - Kew era ai suoi esordi - Chelsea era il più importante orto botanico del paese. Forsyth lo curò per 13 anni. Durante la sua gestione, il giardino si arricchì di nuove specie, soprattutto tropicali, grazie ai buoni rapporti con vivaisti (come Gordon e Lee), collezionisti come lo stesso duca di Northumberland e Fothergill, e lo staff di Kew (il capo giardiniere Aiton e, ovviamente, lo stesso Banks). Forsyth stimolò anche l'attività di cacciatori di piante, come John Fraser. Tra le piante esotiche che giunsero in quegli anni a Chelsea, Caesalpinia pulcherrima, il pimento (Pimenta dioica), l'anatto (Bixa orellana), il mogano (Swietenia mahagoni), Guaiacum officinale, Senna alata. Sull'esempio del suo predecessore, Forsyth mantenne inoltre fitte relazioni e scambi con altre istituzioni botaniche e singoli studiosi nel resto d'Europa. Due furono le imprese più impegnative in cui si trovò coinvolto: in primo luogo, la ricollocazione delle piante che a partire dal 1773 ricevettero una collocazione sistematica basata sul sistema di Linneo; in secondo luogo, la creazione di quello che è considerato il più antico giardino roccioso europeo. Nel 1771 la Società dei Farmacisti decise infatti di creare un'area adatta alla coltivazione di piante che richiedono un substrato roccioso. Il progetto probabilmente si deve non Forsyth - che ebbe un ruolo di esecutore - ma a Stanesby Alchorne, il prefetto dell'orto, e a Uriah Bristow, membro del Comitato e più tardi Maestro della Società. Poiché i farmacisti non avevano fondi, per la costruzione si ripiegò inizialmente su materiali di recupero, in particolare pietre provenienti dalla Torre di Londra (che Alchorne pagò di tasca sua). Venne poi in soccorso Joseph Banks, che nel 1772 donò un carico di pietra lavica trasportato dall'Islanda. Con questi materiali Forsyth creò un monticello ovale di pietra dal diametro di appena 40 passi, che venne decorato con un assortimento di oggetti bizzarri: minerali insoliti; madrepore e coralli; una conchiglia gigante portata da Cook dai mari del Sud (che esiste tuttora); un busto dello stesso Banks. Chiamato semplicemente The Rock e costruito nel corso dell'estate del 1773, fu la prima struttura del genere in Europa. Sfortunatamente, non ci sono rimaste né informazioni su quali piante vi crescessero né illustrazioni d'epoca (la più antica è del 1890). Sotto l'opprimente tutela del Comitato e con una paga sempre più insoddisfacente mano a mano che la sua famiglia cresceva insieme alla sua reputazione di eccellente giardiniere, Forsyth si trovò a combattere con difficoltà economiche e organizzative: nel 1774 riuscì a strappare all'avaro Comitato il permesso di vendere le piante eccedenti e di coltivare una parte dell'orto a proprie spese e per il proprio uso; nel 1775, mentre continuavano i grandi lavori di trapianto richiesti dalla ricollocazione sistematica, ottenne l'assunzione di un terzo aiuto giardiniere, ma solo da marzo a ottobre. Nel 1777 rimase senza esito la sua richiesta di un aumento salariale, rimasto invariato da anni nonostante il rincaro del costo della vita.  Un mastice miracoloso? A sollevarlo da queste difficoltà giunse nel 1784 la nomina a Sovrintendente dei giardini reali di Kensington e St. James; in questa nuova veste, Forsyth dovette occuparsi della coltivazione di verdure e della cura delle piante da frutto. Molte erano vecchie, in cattive condizioni, affette da cancri e altre malattie del legno. Per riportarle in salute, oltre a rimuovere accuratamente le parti malate, Forsyth mise a punto la ricetta di un particolare mastice che, a suo dire, non solo chiudeva i fori e consolidava l'albero, ma consentiva la ricrescita di legno nuovo e sano. Il ritrovato (Forsyth ne manteneva segreta la composizione) suscitò l'immediato interesse delle alte sfere: disporre di alberi sani, in particolare querce, era essenziale per la marina inglese, civile e miliare, specie dopo la perdita delle colonie americane, che si aggiungeva alla costante diminuzione delle foreste britanniche. Nel luglio del 1789 (una decina di giorni dopo la presa della Bastiglia) i due rami del parlamento incaricarono un comitato di vagliare l'efficacia del mastice (noto come Forsyth's plaister) e di riferirne al Tesoro; visto il parere favorevole, nel maggio 1791 quest'ultimo dispose il pagamento a Forsyth di un premio di 1500 sterline in cambio della ricetta miracolosa. Eccola: uno staio di letame fresco, mezzo staio di calce, mezzo staio di cenere di legna, una sedicesima parte di sabbia di fiume, cui potevano aggiungersi, per rendere la miscela più fluida, urina e sapone. Per quanto possa apparirci bizzarra, non è molto dissimile dalle ricette in uso all'epoca (e da certi mastici e paste per tronchi ancora oggi usati, tra l'altro, nell'agricoltura biodinamica). L'opinione pubblica si divise: ad alcuni pareva uno spreco di denaro pubblico, per non dire una soperchieria o un caso di manifesta corruzione, che si fosse pagata una cifra enorme - vi ricordate la paga di Forsyth a Chelsea? - per un prodotto ben poco dissimile da quelli usuali. Altri - come capita anche oggi - furono invece sedotti proprio dalla semplicità della procedura e dal basso costo degli ingredienti di un prodotto che si voleva miracoloso, tanto più che a metterlo a disposizione di tutti aveva pensato lo stesso Forsyth, rivelandone pubblicamente la formula in appendice a Observation on the diseases, defects, and injuries in all kinds of Fruit and Forest Trees ("Osservazioni sulle malattie, i difetti, le lesioni di ogni tipo degli alberi da frutto e forestali"), uscito sempre nel 1791. A difendere a spada tratta il ritrovato di Forsyth (oltre a uomini politici, membri dell'ammiragliato e uomini della strada) fu soprattutto l'agronomo James Anderson nel suo Recreation in agricolture (1799). Sul versante opposto, il critico più reciso fu Thomas Andrew Knigth che nel 1801, nella seconda edizione di A Treatise on the Culture of Apple and Pear ("Trattato sulla coltivazione delle mele e delle pere"), avanzò alcuni dubbi, ribaditi più estesamente l'anno successivo in Some doubts relative to the efficacy of Mr. Forsyth's plaister in filling up the holes in trees ("Alcuni dubbi sull'efficacia del mastice di Forsyth nel riempire i buchi degli alberi"). Grande esperto di alberi da frutto (è considerato il padre della pomologia britannica), studioso della fisiologia vegetale che per alcuni aspetti anticipò Mendel, prove sperimentali alla mano, Knight dimostrò che il preteso mastice miracoloso non era certo in grado di far rinascere il legno morto; era solo una pasta che riempiva i buchi in modo tale che "era impossibile distinguere il legno nuovo dal vecchio". La risposta di Forsyth non si fece attendere; in appendice alla sua fortunata opera A Treatise on the culture and management of Fruit-Trees ("Trattato sulla coltivazione e la gestione degli alberi da frutto"), uscito anch'esso nel 1792, attaccò, senza nominarlo esplicitamente, il "libello" di Knight e allegò le testimonianze dell'efficacia del suo mastice, che gli giungevano da ogni dove, da San Pietroburgo a Madras. Knight, a sua volta, rincarò la dose, giungendo a insinuare che Anderson fosse in combutta con Forsyth. La polemica si trascinò per anni, sempre più violenta. Intanto, il trattato di arboricoltura di Forsyth conosceva uno strepitoso successo: senz'altro il più letto e più influente manuale sull'argomento di primo Ottocento, fu ristampato per almeno un trentennio, ne fu pubblicata un'epitome negli Stati Uniti e traduzioni in altri paesi. Anche se oggi molte delle pratiche che vi sono consigliate (prima tra tutte il trattamento delle lesioni del legno) sono superate, ne emerge chiaramente la profonda padronanza del soggetto da parte dell'autore. Il quale, probabilmente, non era dunque né un ciarlatano né un imbroglione: credeva in buona fede che il suo mastice fosse in grado di rigenerare il legno, senza rendersi conto che le piante non traevano giovamento dal plaister in quanto tale, ma dall'accurata rimozione delle parti malate. Quanto a Knight, Forsyth se ne vendicò come poté: come organizzatore della riunione che portò alla nascita dell'Horticultural Society, usò tutta la sua influenza per escluderne l'arcinemico, benché fosse uno scienziato rinomato e un protetto di Banks. Del resto, una vendetta di breve durata; Forsyth mori pochi mesi dopo (una sintesi della sua vita nella sezione biografie) e Knight non solo entrò a fare parte della Society, ma a partire dal 1811 ne divenne presidente (incarico che mantenne per 27 anni).  Alla scoperta delle solari forsizie In una simile atmosfera polemica, è improbabile che un botanico britannico avrebbe dedicato un genere a Forsyth; a commemorarlo tuttavia pensò il danese Martin Vahl che nel stesso anno della sua morte gli dedicò Forsythia, riconoscendo come appartenente a un nuovo genere Syringa suspensa, un arbusto giapponese descritto per la prima volta da C. P. Thunberg nel 1784. Il genere Forsythia, della famiglia Oleaceae, comprende una decina di specie di arbusti di origine soprattutto orientale (Cina, Corea, Giappone), con l'eccezione di F. europaea, nativa della penisola balcanica. Oggi è difficile immaginare un giardino o un parco senza le immancabili forsizie, che con le loro prorompenti fioriture color oro sono un vero e proprio araldo della primavera. Eppure sono arrivate da noi da meno di 150 anni. Dopo la segnalazione di Thunberg, bisogna aspettare un altro grande divulgatore della flora giapponese, Franz von Siebold, perché la prima Forsythia asiatica raggiunga l'Europa: è ancora F. suspensa, importata in Olanda intorno al 1830 e approdata in Inghilterra, nei famosi vivai Veitch, nel 1855. Nel 1864, il cacciatore di piante Robert Fortune introduce la varietà eretta (F. suspensa var. fortunei). Lo stesso Fortune, nel suo primo viaggio in Cina (1844-45) in un vivaio cinese si era imbattuto nella seconda specie decisiva per i moderni ibridi, F. viridissima. F. suspensa e F. viridissima sono infatti i genitori di F. x intermedia, nata da un incrocio casuale nell'orto botanico di Gottinga in Germania nel 1878. Nei decenni seguenti, numerosi altri ibridi x intermedia vengono attenuti dai vivaisti tedeschi; il più fiorifero e vigoroso di tutti è probabilmente 'Spectabilis', creato nel 1908 dal vivaio tedesco Spath, ancora oggi molto diffuso. Dopo la prima guerra mondiale, sono invece gli ibridatori statunitensi a dominare il campo; tra le cultivar più note, 'Lynwood' (nata da uno sport di 'Spectabilis' in Irlanda, ma resa popolare da vivaisti americani) e 'Arnold Giant', creata nell'Arnold Arboretum nel 1946. Ancora più tardiva è la conoscenza e la diffusione delle altre specie. F. europaea fu scoperta nel 1897 in Albania; la scoperta di F. giraldiana, un'altra specie cinese, si deve invece al missionario italiano Giuseppe Giraldi, che la raccolse nello Shanxi nel 1897. Solo nel Novecento di aggiungeranno la giapponese F. japonica, descritta nel 1914 da Tomitaro Makino, lettore di botanica all'Università di Tokio, e la coreana F. ovata, raccolta nel 1917 da Takenoshi Nakai sulla Montagna di Diamante nella Corea centrale. Altri approfondimenti nella scheda. Nell'Inghilterra del Settecento, con la diffusione del giardino all'inglese ricco di essenze esotiche di grande impatto paesaggistico - primi fra tutti gli arbusti da fiore e gli alberi che si rivestono di spettacolari colori autunnali - il giardinaggio, da moda per ricchi aristocratici e eccentrici appassionati, incomincia a trasformarsi in una passione nazionale. In un momento di grande espansione economica, non manca chi, per procurarsi una pianta rara prima di tutti i suoi amici, è disponibile a sborsare somme notevoli. Nasce il vivaismo ornamentale. Così, un giardiniere di talento come James Gordon può mettersi in proprio e diventare ricco grazie alla riproduzione e alla vendita di piante esotiche; celebrato come il miglior giardiniere d'Inghilterra, desta l'ammirazione di botanici e collezionisti, diventa amico di Ellis, Collinson e Solander e corrispondente di Linneo. E conquista la dedica di una pianta "difficile" dalle spettacolari fioriture.  Un vivaista di successo Il 30 giugno 1760, il pomeriggio stesso del suo arrivo a Londra, uno stupefatto Daniel Solander, accompagnato dal mercante svedese Abraham Spalding e da John Ellis (il più assiduo corrispondente di Linneo a Londra), visita il vivaio di Mile End, alla periferia orientale della città, creato dal giardiniere James Gordon. Nella sua lettera del giorno successivo a Linneo, descriverà le serre, gli impianti, le magnifiche fioriture. A entusiasmarlo sono i numerosissimi alberi e cespugli esotici, soprattutto americani: in quel momento sono in fioritura Calycanthus, magnolie, Rhododendron maximum, due tipi di Kalmia, Tetragonotheca. Solander è ammirato dai lettorini caldi che permettono di coltivare, nutrire e proteggere le piante più delicate all'aria aperta. Ma a stupirlo più di tutto è che il proprietario del vivaio si sia arricchito vendendo piante, e che gli inglesi siano disposti a pagare cifre incredibili per le piante più rare. James Gordon, che Solander descrive intento a identificare alcune piante insieme al proprio figlio, servendosi delle opere di Linneo, fu probabilmente il più importante vivaista britannico della seconda metà del Settecento. Scozzese (lo erano quasi tutti i giardinieri del tempo, con grande disappunto dei colleghi inglesi), era stato al servizio prima di James Sherard, il cui giardino di Eltham, ricco di piante rare, era considerato tra i più belli del paese, poi di Robert James lord Petre, il celeberrimo collezionista di piante. Come giardiniere capo di Thorndon, aveva aiutato Petre a creare una magnifica collezione di alberi e arbusti esotici, molti dei quali giunti dall'America grazie alla rete di Peter Collinson. Dopo la morte precoce di lord Petre (1742), queste esperienze avevano permesso a Gordon di aprire un proprio vivaio a Mile End. Grazie alla sua stupefacente abilità nel riprodurre le piante da talea e da seme, si creò un'immensa fama. La sua reputazione era tale che Fothergill, benché avesse al suo servizio quindici giardinieri, si rivolse a lui per far germogliare i semi di un raro corbezzolo greco; Collinson invece si appoggiava a lui per la riproduzione delle nuove piante che affluivano dall'America grazie a Bartram: ad esempio, gli affidò i semi dell'appena scoperta e battezzata Dionaea muscipula (anche se in questo caso, a quanto pare, senza molto successo). In una lettera a Linneo, lo stesso Ellis dichiara che Gordon aveva "più conoscenze sulle piante di tutti i giardinieri e gli scrittori di giardinaggio d'Inghilterra messi insieme", in ciò superiore anche a Miller del Chelsea Physic Garden (è vero che tra i due non correva buon sangue); solo la sua modestia gli aveva impedito di pubblicare qualcosa. Invita poi Linneo ad inviargli qualche pianta rara, certo di essere generosamente ricambiato da Gordon che è un suo ammiratore e un seguace del suo sistema. E in effetti negli anni successivi, probabilmente anche grazie all'intermediazione di Solander (il giovane svedese per qualche tempo abitò presso Gordon, in una casa annessa al vivaio), tra il grande scienziato e il vivaista scozzese ci sarà uno scambio di lettere e di piante rare. Giardiniere dall'abilità quasi magica, nel suo vivaio riuscì a far prosperare e a portare a maturità e a fioritura piante esotiche di tutto il mondo. Fu il primo a coltivare in Europa piante orientali come Ailanthus, Gingko, Styphnolobium japonicum, ovvero la sofora del Giappone, e molte specie di arbusti e alberi americani, come Ulmus americana, diversi tipi di magnolia e rododendri, procurati da Collinson. Rese popolare la Camellia japonica: dopo la morte di lord Petre, portò con sé talee delle prime camelie mai fiorite in Inghilterra e le riprodusse per anni nel proprio vivaio. Riuscì a moltiplicare per talea la Gardenia, mentre tutti i suoi colleghi avevano fallito. Stupiva l'amico Collinson per la insuperabile abilità con cui riusciva a riprodurre da seme arbusti difficili come kalmie, rododendri e azalee. Oltre che capace giardiniere, del resto era un abile uomo d'affari: nel 1759, le talee di Gardenia gli frutteranno mille sterline; l'anno prima, ne aveva guadagnate 500 vendendo 100 esemplari di Magnolia grandiflora, ottenuti a partire da quattro talee; dopo trent'anni, negli anni settanta, le piante di camelia gli fruttavano ancora quattro scellini l'una. Per propagandare le sue piante, intorno al 1770 fu anche tra i primi a stampare un catalogo. Grazie alle sue abili cure, molte piante prosperavano e fruttificavano, producendo grandi quantità di sementi. Gordon decise quindi di diversificare l'attività, aprendo un negozio di semi a Fenchurch Street. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. In un'epoca in cui la passione per le piante esotiche dilagava in Inghilterra, Gordon fu tra i primi a coglierne la portata economica, trasformandola da aristocratica moda per pochi in una vera e propria produzione industriale, in ciò aprendo la strada ai grandi vivaisti dell'Ottocento, come i Veitch.  Gordonia, una colonna di fiori d'argento Per una volta, è molto facile individuare il legame tra Gordon e il genere che lo celebra, Gordonia. La sola specie nota all'epoca era un endemismo dei boschi umidi americani che Linneo, nel 1753, in Species plantarum, aveva battezzato Hypericum lasianthus. Nel 1771 John Ellis, riconoscendo che non aveva nulla a che fare con gli iperici (in effetti, si tratta di una Theacea, la famiglia della Camellia), la spostò nel nuovo genere Gordonia. Il motivo della dedica è semplice: nel 1763, dopo un ventennio di tentativi, Gordon era stato il primo a coltivare con successo la pianta partendo dai semi. Gordonia è un genere di alberi sempreverdi a colonna con grandi e vistosi fiori bianchi, il cui status tassonomico è assai discusso. Fino a qualche anno fa gli veniva assegnata una quarantina di specie, tutte native del sudest asiatico, a parte G. lasianthus, nordamericana, e almeno un'altra specie. Una recente revisione, basata su indagini filogenetiche, propone tuttavia di riservare la denominazione Gordonia alle specie americane, trasferendo le specie asiatiche in Polyspora o Laplacea (cui sono attribuite anche alcune delle specie del Nuovo mondo). Una situazione complicata; è molto semplice invece innamorarsi della specie tipo, G. lasianthus , quella che Gordon riuscì con tenacia a riprodurre. E' un albero di grande bellezza, purtroppo noto per la sua difficoltà di coltivazione: nativo di zone umide (come ricorda il nome comune americano, loblolly bay, ovvero "alloro delle paludi"), con suolo acido, amante degli inverni miti e delle estati fresche con alto tasso di umidità, difficilmente si adatta ad altre condizioni. Il suo splendore in piena fioritura è decritto in una pagina dei Travels di William Bartram, che erborizzando in Florida, nei pressi di Lake George si imbatté in una pineta mista con G. lasianthus e magnolie: "L'alta, svettante, Gordonia lasianthus, che ora mi stava davanti in tutto il suo splendore, è degna di ammirazione da ogni punto di vista. Il suo denso fogliame, di colore verde scuro, è punteggiato di grandi fiori bianco latte profumati, portati su steli lunghi, snelli ed elastici all'estremità dei suoi numerosi rami; ogni mattina la fioritura si rinnova e in questa incredibile profusione l'albero pare d'argento, mentre il suolo è un tappeto di fiori caduti". Le foglie, che si rinnovano nel corso dell'anno, aggiungono un tocco di rosso allo splendore cromatico di questa bella schizzinosa. Qualche approfondimento nella scheda. Una delle più note piante d'appartamento celebra un altrimenti dimenticato giardiniere: lei è la Dieffenbachia, tanto amata per le grandi foglie variegate quanto temuta per la fama di tossicità; lui è Joseph Dieffenbach, giardiniere capo del Giardino botanico dell'Università di Vienna per almeno un trentennio.  Giardiniere vs botanico Statisticamente, tra i dedicatari di generi botanici predominano cattedratici e raccoglitori; i giardinieri sono rare eccezioni. Uno di loro è Joseph Dieffenbach, giardiniere viennese onorato dalla notissima Dieffenbachia. Per un lunghissimo periodo (dal 1820 e almeno fino al 1850) fu capo giardiniere dell'Orto botanico di Vienna (Hortus Botanicus Vindobonensis) ed ebbe modo di collaborare con i numerosi studiosi che si succedettero alla testa dell'istituzione. Ebbe un ruolo importante nelle grandi ristrutturazioni che a metà secolo ridisegnarono l'impianto originale del giardino; sotto la direzione di S. L. Endlicher, negli anni '40, esso fu trasformato secondo lo stile del giardino paesaggistico inglese con alberi, arbusti e piante erbacee raggruppate seguendo il sistema di classificazione elaborato dallo stesso Endlicher; negli anni '50, Eduard Fenzl affiancò ai criteri sistematici una maggiore attenzione agli ambienti e alla distribuzione geografica. Sotto tanti direttori e in mezzo a tante trasformazioni, nella sua lunghissima vita lavorativa come giardiniere capo Dieffenbach fu sicuramente un punto di riferimento, tanto che nel 1850 fu insignito di un'onorificenza imperiale. Ma a immortalare il suo nome aveva provveduto molti anni prima Heinrich Wilhelm Schott, grande esperto di Araceae che nel 1829, in uno dei suoi importanti lavori su questa famiglia, stabilì il nuovo genere Dieffenbachia. All'epoca Joseph Dieffenbach era ancora giovane (la data di nascita è incerta; alcune fonti la collocano nel 1790, altre nel 1796) e forse la dedica, più che ai suoi meriti di giardiniere, si deve ascrivere ad altri motivi. Il predecessore di Dieffenbach nel ruolo di capo giardiniere del giardino botanico viennese non era altri che Heinrich Schott (morto nel 1819), il padre di Heinrich Wilhelm, il quale per qualche anno aveva collaborato con lui e proprio come giardiniere aveva partecipato alla spedizione austriaca in Brasile (1817-1821) grazie alla quale aveva cominciato ad appassionarsi allo studio delle Araceae. Non è inverosimile che Dieffenbach - prima di diventare a sua volta capo giardiniere dopo la morte di Schott padre - avesse lavorato alle sue dipendenze; in tal caso, presumibilmente era amico del quasi coetaneo Schott figlio; la circostanza è confermata da una pubblicazione di inizio Novecento sulle Araceae, in cui la dedica a Dieffenbach è attribuita ai suoi meriti come curatore del giardino e all'amicizia di Schott. Le notizie reperibili in rete su questo oscuro personaggio sono pochissime e, al solito, confuse. Intanto, Dieffenbach, come si è visto, era il capo giardiniere dell'Orto botanico e non del giardino di Schönbrunn come viene spesso riportato; non fu mai alle dipendenze di H. W. Schott, che diresse invece proprio quel giardino dal 1845; dunque questi non poté certo dedicargli il genere (nel 1829!) come riconoscimento per la sua perizia nel collaborare con lui. Meno che mai la Dieffenbachia è dedicata a Ernst Dieffenbach (1811-1855), botanico tedesco noto per una spedizione in Nuova Zelanda, che è invece ricordato dai nomi specifici dieffenbachianus, dieffenbachii (come Aciphylla dieffenachii, una graziosa apiacea della Nuova Zelanda). Insomma, per una volta, il giardiniere l'ha avuta vinta sul botanico e cacciatore di piante. Come al solito, una sintesi della vita di Joseph Dieffenbach - brevissima, vista l'esiguità delle notizie - nella sezione biografie.  Dieffenbachia, pianta killer? Per il loro fogliame lussureggiante e la relativa adattabilità alle condizioni delle nostre case, molte Araceae tropicali sono popolari piante d'appartamento. Dieffenbachia non fa eccezione: la sua specie più nota, D. seguine (in genere commercializzata con i sinonimi D. amoena, D. maculata, D. picta) è un ornamento consueto nelle case, negli uffici, nei corridoi degli ospedali, nei locali pubblici, grazie alle enormi foglie variegate dall'indubbio fascino tropicale e alla facilità di coltivazione. Il genere comprende una cinquantina di specie di erbacee originarie delle foreste umide dell'America tropicale, dal Messico all'Argentina passando per le Antille. La prima a essere nota e descritta fu proprio D. seguine, pubblicata nel 1693 da Plumier con il nome di Arum seguine; per il riconoscimento del genere, come si è visto, dovevano passare più di 130 anni, con Schott (1829). Soprattutto nella seconda metà del Novecento, in particolare negli Stati Uniti, questa specie è stata oggetto di un vasto programma di selezioni e ibridazioni, volto a ottenere foglie con variegature particolari (macchiettate, marezzate, crema, bianco, argento) e un portamento più compatto e cespuglioso. Delle circa 100 cultivar introdotte nel corso degli anni, tuttavia, solo una ventina sono effettivamente reperibili in commercio. D'altra parte, benché rimanga una pianta diffusa, è forse un po' meno popolare di qualche anno fa, probabilmente soprattutto per la sinistra fama di essere tossica. Foglie e fusto contengono alte concentrazioni di ossalato di calcio (sotto forma di cristalli simili ad aghi, detti rafidi); se masticati o ingeriti, i rafidi possono causare forti dolori, irritazione delle mucose della bocca, della gola e dello stomaco, e addirittura una temporanea paralisi della lingua. A questa sgradevole proprietà fa riferimento il nome inglese dumb cane, "canna dei muti"; si dice che i piantatori delle Antille la usassero per punire gli schiavi ribelli, che venivano obbligati a masticarne i fusti. Qualche anno fa, la povera Dieffenbachia è stata addirittura oggetto di una bufala del web, in cui veniva descritta come una pianta killer capace di uccidere un bambino in meno di un minuto e un adulto in un quarto d'ora; i possessori venivano invitati a liberarsene e a bruciare le proprie piante. Si tratta di notizie infondate, o estremamente esagerate. Da evitare solo nelle case in cui ci siano bambini piccoli o animali curiosi che ne potrebbero masticare le foglie, per tutti gli altri l'unica precauzione è utilizzare i guanti e lavarsi le mani quando si asportano foglie avvizzite o si preparano talee, godendo senza timore della sua bellezza. Qualche informazione in più nella scheda. Quando a un genere o a una specie vengono assegnati due o più nomi da botanici diversi, vale la legge della priorità: buona la prima! Ma qualche volta stabilire quale nome sia arrivato primo non è facile. Per decidere se un genere di splendide Asclepiadaceae deve chiamarsi Sperlingia o Hoya sarebbe occorso il fotofinish. Ma alla fine fu Hoya, preservando il ricordo del buon giardiniere Thomas Hoy, mentre al povero Sperling è rimasta l'onta di una morte ignominiosa.  Atto primo: Copenhagen, 1804-1818 Nella lunga storia della botanica, capita abbastanza di frequente che due o più studiosi studino, descrivano e assegnino indipendentemente un diverso nome alla stessa pianta. E' per questo motivo che, accanto al nome ufficialmente riconosciuto, alcune specie siano identificate anche da uno o più sinonimi, comunque interessanti da un punto di vista storico. Ma ovviamente il nome scientificamente valido deve essere uno solo e per decidere qual è occorrono precise regole. Così nel 1867, organizzato da Alphonse Pyrame de Candolle, figlio del celebre tassonimista Augustin, si riunisce a Parigi il primo Congresso botanico internazionale, con lo scopo di individuare regole condivise; lo scopo è raggiunto con la pubblicazione delle Lois de la nomenclature botanique, redatte dallo stesso de Candolle. Nel caso di due denominazioni in conflitto, valide sotto ogni altro aspetto, vige la regola della priorità: il nome valido è quello che è stato pubblicato per primo in un testo a stampa o almeno divulgato in un'istituzione botanica i cui atti siano accessibili agli studiosi. Stabilire la priorità non è sempre semplice. Ad esempio, nel caso del genere che siamo abituati a chiamare Hoya ci troviamo di fronte a un piccolo giallo. E' certo che il primo nome assegnatogli non è Hoya, ma Sperlingia. Ad attribuirglielo fu Martin Vahl, allievo di Linneo: membro della Società di storia naturale (Naturhistorische-Selskabet) di Copenhagen, poco prima di morire nel 1804 aveva consegnato diversi articoli, tra cui quello in cui descriveva alcune specie di Sperlingia e ne stabiliva il nome, all'amico Niels Tonder-Lund che stava curando la pubblicazione del 6° volume del Bollettino della società. Sono gli anni delle guerre napoleoniche, la Società si dissolve con la morte di Vahl e la pubblicazione va a rilento: Tonder-Lund, funzionario governativo (per un periodo fu anche capo della polizia danese), ha mille incombenze; infine perisce in un naufragio mentre si sta recando a Christiania (oggi Oslo). Soltanto nel 1810 la rivista è pronta per la pubblicazione; lo zoologo Jens Rathke vi premette una prefazione con un lungo necrologio di Tonder-Lund, in cui alcuni passaggi contengono critiche al botanico Erik Viborg (rivale storico di Vahl, cui aveva "soffiato" la prima cattedra di botanica danese). Viborg chiede che i passi incriminati siano tagliati; tra un tira e molla e l'altro, finalmente la rivista, con l'articolo di Rathke epurato, esce nel 1818. Dalla morte dell'autore, sono passati 14 anni. 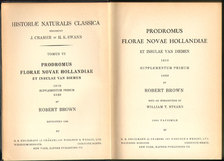 Atto secondo: Londra, 1810 Nel frattempo, nel marzo del 1810 a Londra, l'attivissimo Robert Brown (tutti lo ricordiamo come scopritore del "moto browniano") pubblica il suo fondamentale Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, la prima descrizione sistematica della flora australiana. Nel volume, fra l'altro, distacca dalla famiglia delle Apocynaceae la nuova famiglia delle Asclepiadaceae e assegna al nuovo genere Hoya (che corrisponde alla Sperlingia di Vahl) alcune specie da lui individuate nel suo viaggio australiano intorno al 1802. Vuole così onorare un amico, come lui membro della Linnean Society, Thomas Hoy, capogiardiniere di Syon House "i cui meriti come coltivatore intelligente e di successo sono da tempo noti a tutti i botanici del paese". Ecco che la nostra pianta è diventata ufficialmente Hoya. Ma... in effetti c'è un ma. Nella Biblioteca botanica di Copenhagen si trova una copia, l'unica finora conosciuta, del sesto volume del Bollettino della società di storia naturale con la prefazione di Rathke non censurata; data di pubblicazione: 1810. Insomma, il nome legittimo potrebbe essere Sperlingia, anche se finora nessuno è riuscito a scoprire quante copie siano state stampate e esattamente in quale giorno. D'altra parte, alla fine del 1809 Brown aveva letto una memoria sulle Asclepiadaceae alla Linnean Society, dove già compariva Hoya. Con dati tanto incerti e visto che il nome Hoya è quello universalmente usato, la maggioranza dei botanici tende a considerarlo quello valido. Tanto più che il dedicatario di Sperlingia, il medico e botanico Otto Sperling (1602-81) è una figura maledetta, che finì i suoi giorni in carcere per alto tradimento, anche se probabilmente la sua unica colpa fu di essere intimo del cancelliere Ulfeldt (che di alto tradimento sia era macchiato veramente). Peccato per me: sarebbe stato più appassionante raccontare la sua vita, anziché la scarna biografia dell'ottimo e onesto giardiniere Thomas Hoy. E, come magra consolazione, la denominazione Sperlingia è stata assegnata a una delle sezioni del genere Hoya.  Una tropicale con una foresta di sinonimi A guadagnarci naturalmente è lei, la bellissima Hoya R. Brown (= Sperlingia Vahl), cui la sorte e i pasticci dei curatori delle riviste di botanica hanno assegnato un nome breve ed eufonico. Il genere è originario del Sud est asiatico e dell'Australia; molto adattabile, vive in una varietà di habitat, che vanno dalle foreste pluviali alle pendici dell'Himalaya alle zone semidesertiche dell'Australia. Accanto alle rampicanti, che sono quelle a noi più familiari, contiene anche arbusti e ricadenti epifitiche. Appartiene alla sottofamiglia delle Asclepiadoideae (che con buona pace di Brown, i genetisti hanno declassato a sottofamiglia delle Apocynaceae). Le più note sono indubbiamente le rampicanti H. lanceolata subsp. bella e H. carnosa, ma oggi grazie a coltivatori ed appassionati altre specie incominciano ad essere reperibili anche da noi. Tuttavia, dato che si tratta di introduzioni recenti - dopo il 1990 - provenienti per lo più da habitat non del tutto esplorati delle foreste pluviali del sudest asiatico, il numero esatto delle specie non è noto; d'altra parte, spesso ogni introduttore assegna un proprio nome, creando una foresta di sinonimi che rendono la classificazione ancora più complicata. Ad esempio, la stessa specie può essere chiamata da diversi venditori H. gracilis, H. davidcummingammi, H. angustifolia. Del resto, niente da stupirsi, con una storia simile alle spalle! Come sempre, approfondimenti nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|



 RSS Feed
RSS Feed