|
Quando arrivò in Brasile come giardiniere della spedizione austriaca, Heinrich Wilhemn Schott era un giovanotto di ventitré anni. Quell'avventura che sognava fin da bambino, quando, malato, aveva ricevuto la visita del grande Humboldt, cambiò per sempre la sua vita, facendogli incontrare le piante a cui avrebbe dedicato quasi mezzo secolo di studio meticoloso ed appassionato: le Araceae. Prima di lui, erano ancora poco conosciute e mal classificate; basandosi tanto su esemplari d'erbario, quanto sulle piante vive che coltivava nel giardino di Schönbrunn, di cui era capo giardiniere, fu il primo ad analizzarne in modo comparativo infiorescenze, fiori e frutti, stabilendo molti generi validi anche oggi e gettando le basi della tassonomia della famiglia. A ricordarlo non potevano che essere due generi di Araceae, originarie di Sarawak, nel Borneo settentrionale: Schottarum e Schottariella.  Una passione iniziata nel segno di Humboldt Sull'infanzia di Heinrich Wilhelm Schott, brillante giardiniere imperiale e grande tassonomista, si racconta un aneddoto dal sapore di fiaba. Nato a Brno in Moravia, a sette anni aveva raggiunto a Vienna il padre, capo giardiniere dell'Orto botanico universitario; poco dopo cadde malato e sembrò in punto di morte. Quando seppe che l'uomo che più ammirava al mondo, il grande Alexander von Humboldt, si trovava in città, espresse il desiderio di conoscerlo. Suo padre scongiurò il direttore dell'orto botanico, Nicholas Joseph von Jacquin, di intercedere presso lo scienziato perché visitasse il piccolo malato. Humboldt acconsentì prontamente; rivolse al bimbo parole così giuste e incoraggianti da risvegliare la sua forza vitale. Heinrich Wilhem guarì e giurò che avrebbe dedicato la sua vita a studiare la natura e le sue intime relazioni, sull'esempio del suo idolo. Negli anni successivi segui le lezioni di botanica, agricoltura e chimica all'Università, senza però conseguire alcun titolo, visto che adolescente incominciò a lavorare come aiuto giardiniere agli ordini del padre. Nel 1815 (all'epoca aveva ventun anni) divenne giardiniere del Palazzo Belvedere, dove gli fu assegnata la cura delle piante native. Due anni dopo, Joseph Franz von Jacquin lo raccomandò come giardiniere della spedizione austriaca in Brasile: era la persona ideale, unendo solide basi teoriche e abilità pratica. In Brasile il compito principale di Schott fu l'allestimento di un giardino di acclimatazione annesso all'ambasciata austriaca a Rio de Janeiro, dove coltivava le piante raccolte dai membri della spedizione e le preparava per il lungo e difficile viaggio verso l'Europa. Egli stesso si procurava semi e piantine in brevi spedizioni nei dintorni, ma, affascinato dall'esuberante natura tropicale, avrebbe desiderato spingersi più lontano. Solo dopo circa un anno, quando arrivò da Vienna l'aiuto giardiniere Schücht, poté soddisfare questo desiderio, con qualche missione a più largo raggio in compagnia del pittore Frick. Il suo diario di campo, notevole per la precisione delle descrizioni e arricchito da informazioni sulla geografia, l'economia e l'etnografia delle aree visitate, fu pubblicato a Brno nel 1822, dopo il rientro in Austria. Schott era infatti tornato a casa nell'estate del 1821. A Vienna, riprese il suo lavoro al Belvedere; nel 1828 fu promosso Hofgärtner, ovvero capo giardiniere. Ma intanto in Brasile aveva incontrato le piante del suo destino: le Araceae. Da quel momento avrebbe alternato al lavoro di giardiniere lo studio delle sue piante preferite; oltre al metodo rigoroso e a una brillante capacità di mettere a confronto una grande quantità di piante, a facilitargli il compito fu proprio la sua doppia veste di tassonomista e giardiniere; come capo dei giardini imperiali (nel 1845 venne nominati direttore del Giardino Imperiale di Schönbrunn, di cui diresse anche la trasformazione in giardino all'inglese) aveva accesso a una vasta collezione di piante esotiche, che egli stesso ebbe cura di incrementare grazie agli invii dei suoi numerosi corrispondenti. Così, poteva studiare le piante non solo su esemplari d'erbario o conservati sott'alcool, ma anche dal vivo, sperimentando diverse condizioni di coltivazione e osservando tutti gli stadi di sviluppo. Inoltre, come giardiniere, diede un importante contributo all'introduzione nei nostri giardini e nelle nostre case di piante oggi molto popolari, come Dieffenbachia, Anthurium scherzerianum, Schindapsus aureus. Grande esperto di piante tropicali, era anche appassionato di piante alpine e a palazzo Belvedere creò uno dei primi giardini ad esse dedicato. Una sintesi della sua vita operosa nella sezione biografie.  Araceae, fortissimamente Araceae Schott iniziò a studiare le Araceae fin dal suo ritorno dal Brasile, a partire dalle sue raccolte brasiliane e dalle collezioni di N.J. von Jacquin nelle Indie occidentali. All'epoca, questo gruppo di piante era ancora poco conosciuto. La famiglia è diffusa in tutto il mondo, ma il 90% delle specie proviene dai tropici. Alcune specie europee erano note fin dall'antichità e i botanici prelinneani, come Dodoens, tendevano a unirle tutte insieme sotto l'etichetta Arum, un nome di etimologia incerta, dal gr. aron, che indicava qualche pianta di questo gruppo, forse Dracunculus vulgaris. All'inizio del Settecento, Tournefort circoscrisse i tre generi europei Arum, Dracunculus, Arisaema e li raggruppò in una "classe" caratterizzata da un unico petalo; la struttura fiorale delle Araceae non era infatti ancora stata compresa e la brattea che avvolge lo spadice, l'infiorescenza tipica della famiglia, fu scambiata per un petalo sia da lui sia da Linneo. Quest'ultimo, in Species Plantarum (1753) ne descrisse 26 specie (oggi ne conosciamo circa 3750 distribuite in oltre 120 generi) distribuite nei quattro generi Arum, Dracontium, Calla, Pothos, cui l'anno successivo aggiunse Pistia; descrisse anche Orontium e Acorus, di cui però, come per Pistia, non riconobbe un'affinità con Arum. Intanto, con il moltiplicarsi delle spedizioni botaniche nei paesi tropicali molte nuove specie affluivano in Europa. Nel 1789 Antoine Laurent Jussieu fu il primo a riconoscere che il cosiddetto fiore è in realtà un'infiorescenza composta da uno spadice con numerosissimi minuscoli fiorellini avvolto in una brattea, o spata. A lui si deve anche la creazione della famiglia Araceae. Nel frattempo erano stati riconosciuti diversi nuovi generi, ma il primo a studiare sistematicamente questo gruppo di piante fu appunto Heinrich Wilhelm Schott, che può fregiarsi a ragione del titolo di "papà delle Araceae". Esordì con una serie di brevi articoli pubblicati in una rubrica intitolata Für Liebhaber der Botanik, "Per gli amanti della botanica", sulla rivista culturale Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode; benché solitamente molto brevi e rivolti a un pubblico generalista, sono molto importanti perché Schott vi venne via via pubblicando molti nuovi generi. Nel 1832 pubblicò la prima monografia sulle Araceae, Meletemata botanica (in collaborazione con Stephan Ladislaus Endlicher, all'epoca direttore dell'orto botanico di Vienna), uscito in sole sessanta copie; in questo lavoro, dedicato a una miscellanea di piante tropicali di recente raccolta, Schott riconobbe 40 generi e incominciò a delineare l'organizzazione della famiglia in sottofamiglie e sezioni. Seguì uno iato di vent'anni, nel corso del quale il botanico pubblicò solo due lavori estranei alla famiglia, uno sulle Rutaceae e l'altro sulle felci. In realtà, era tutt'altro che inattivo ma stava perfezionando con cura meticolosa il suo sistema di classificazione; era in contatto con molti colleghi che operavano in zone tropicali e gli inviavano nuove Araceae che studiava e spesso coltivava nelle serre di Schönbrunn; supervisionava il lavoro dei disegnatori e degli illustratori che, a sue spese, lo assistevano preparando i disegni e gli acquarelli per le future pubblicazioni. Così, a partire dal 1853, incominciarono a susseguirsi a breve intervallo diverse importanti monografie illustrate; la serie fu aperta tra il 1853 e il 1857 da Aroideae, con sessanta tavole; continuò con Synopsis Aroidearum (1856) e Genera Aroidearum Exposita (1858) e culminò con Prodromus Systematis Aroidearum (1860), in cui Schott portò a conclusione il sistema di classificazione perfezionato nell'arco di uno studio quarantennale. Contemporaneamente, diede alle stampe una magnifica raccolta di litografie in 4 volumi, Icones Aroidearum (1857-58). In questo periodo di iperattività, pubblicò anche dozzine di brevi articoli, usciti prevalentemente su Oersterichisches Botanisches Wochenblatt. Nel 1878, 14 anni dopo la sua morte, venne infine pubblicato, a cura di J.J. Peyritsch, un magnifico in folio illustrato con testi di Schott, dedicato alle Araceae raccolte nel Brasile orientale durante la spedizione finanziata nel 1859-60 dall'arciduca Ferdinando Massimiliano, più tardi imperatore del Messico come Massimiliano I. Il contributo di Schott alla conoscenza delle Araceae è incalcolabile; nel suo capolavoro, Prodromus Systematis Aroidearum, pubblicato a proprie spese all'età di 66 anni, trattò 110 generi, la maggioranza dei quali è tuttora valido o come genere o come sottogenere; si calcola che circa una terzo dei generi di questa famiglia debbano il loro nome a Schott, a testimonianza della vastità e della serietà del suo lavoro scientifico. I suoi lavori hanno gettato le basi della tassonomia delle Araceae e sono rimasti imprescindibili per tutti i botanici che sono venuti dopo di lui.  Resistere alle correnti Stranamente, questo grandissimo botanico ha rischiato di non ricevere il "solo onore che spetta a un botanico", come lo definiva Linneo, ovvero la dedica di un genere celebrativo. Certo, sono decine le piante che si fregiano degli eponimi schottii o schottianus come Philodendron schottii o Aphelandra schottiana; ma fino a tempi recenti un genere mancava. A rimediare a tanta ingiustizia hanno provveduto tra il 2008 e il 2009 i botanici P.C. Boyce e S.Y. Wong che in due studi dedicati alle Araceae del Borneo hanno voluto ricordalo con altrettanti generi: Schottarum e Schottariella. Appartenenti alla tribù Schismatoglottideae, sono molto simili tra loro e condividono l'habitat e le caratteristiche ecologiche. Sono piccole erbacee che crescono sulle ripide sponde argillose di corsi d'acqua dalle correnti impetuose, tributari di fiumi maggiori; le piante di questi habitat sono dette reofite, dal greco rèos "corrente" + phytòn "pianta". Riescono a sopravvivere in un ambiente così difficile grazie all'apparato radicale, molto profondo ed esteso, e alle foglie strette, allungate, flessibili e talvolta sfrangiate; nel descriverle, Beccari, che fu tra i primi a studiare la flora di Sarawak, nella parte nord occidentale dell'isola, ha definito questo carattere "stenofillia". Le foreste del Borneo sono insolitamente ricche di specie di Araceae (ne sono state recensite circa 130), tra cui numerose reofite. Sono ancora poco note perché spesso limitate a poche località, ma anche difficili da studiare perché le rive dei fiumi dove vivono possono essere totalmente sommerse per molti mesi all'anno, senza contare che le loro acque sono infestate dai coccodrilli. I due nuovi generi dedicati a Schott sono entrambi endemici di Sarawak, rari e presenti in poche stazioni. Schottarum comprende due specie, S. josefii e S. sarikense; Schottariella una sola, S. mirifica. Tutte sono piccole erbacee acquatiche con profondo ed esteso apparato radicale strisciante che consente di abbarbicarsi al substrato argilloso, con una rosetta di molte foglie strette e allungate, infiorescenze solitarie ma spesso numerose con spata a conchiglia e spadice subcilindrico. I due generi differiscono tra loro per alcuni particolari dei fiori apprezzabili solo al microscopio. Nei periodi di piena le piante possono trovarsi completamente sommerse, e quando emergono trattengono residui di fango sulle foglie; nei periodi di siccità, quando le acque scendono di molto e i corsi d'acqua si riducono a rigagnoli, possono trovarsi completamente all'asciutto. Anzi, coltivata in laboratorio, Schottariella mirifica ha dimostrato di essere in grado di rivivere anche dopo essere rimasta totalmente senza foglie e con l'apparato radicale inaridito per la siccità prolungata. Qualche approfondimento su Schottarum e Schottariella nelle rispettive schede.
1 Comment
Tra gli scienziati venuti in Brasile al seguito dell'arciduchessa Leopoldina c'era anche un botanico italiano, il fiorentino Giuseppe Raddi. Giunto con gli ultimi e partito con i primi, la sua partecipazione fu breve, ma straordinariamente fruttuosa per quantità e qualità. Grazie alle raccolte brasiliane e agli studi che ne ricavò, Raddi divenne una figura assai riconosciuta a livello europeo, come testimoniano i vari generi che gli furono dedicati. I due che oggi sono ancora validi ci fanno conoscere alcuni inattesi bambù, compreso quello che è considerato il più piccolo del mondo. 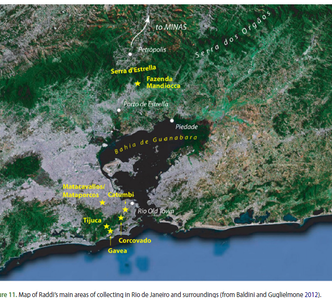 Dalle crittogame toscane alle piante del Brasile Gli Asburgo-Lorena erano assai legati alla Toscana. L'imperatore Leopoldo II, figlio cadetto di Maria Teresa d'Austria e Francesco Stefano di Lorena, per venticinque anni era stato granduca di Toscana (con il nome Pietro Leopoldo) e in Toscana erano nati ed erano stati educati i suoi figli, compreso l'imperatore Francesco II. Così fu del tutto naturale che nel suo viaggio nuziale alla volta del Brasile l'arciduchessa Leopoldina facesse tappa nella seconda patria della sua famiglia, dove fu accolta da suo zio, il granduca Ferdinando III. E fu proprio quest'ultimo a pensare che la partecipazione alla grande spedizione scientifica brasiliana avrebbe dato lustro al suo piccolo Stato. Tanto più che, per una volta, c'era la persona giusta al posto giusto. Nel 1817, Giuseppe Raddi aveva quasi cinquant'anni ed era uno studioso riconosciuto soprattutto come esperto di crittogame e funghi. Di modesta origine, si era avvicinato alla botanica grazie a Ottaviano Targioni Tozzetti, che aveva preso sotto la sua ala protettrice lui e l'amico d'infanzia Gaetano Savi. Nel 1785, a quindici anni, aveva incominciato a lavorare come assistente di Zuccagni al Giardino dei semplici di Firenze; dopo dieci anni di gavetta, era stato nominato custode del Museo di Storia naturale di Firenze. Assunto questo incarico, Raddi studiò il latino e le principali lingue europee e approfondì gli studi di botanica, dedicandosi soprattutto alle crittogame e ai funghi, un campo peculiare della botanica toscana nel quale si erano già distinti Pier Antonio Micheli (1679–1737), Giovanni Targioni Tozzetti (1712–1783) e il figlio di quest'ultimo Ottaviano. Le sue prime pubblicazioni, a partire dal 1806, sono appunto dedicate a nuove specie di crittogame e funghi scoperte nei dintorni da Firenze. Erano anni politicamente difficili. Nel 1799 l'esercito francese aveva occupato il Granducato, costringendo Ferdinando III all'esilio. Gli intellettuali si divisero tra filofrancesi e legittimisti; tra questi ultimi Raddi che nel 1808, con l'annessione della Toscana al Regno d'Italia e la soppressione del Museo, perse il lavoro. Nonostante le difficoltà economiche, continuò le sue ricerche e si mantenne in corrispondenza con importanti studiosi europei, compreso de Candolle, nonostante le opposte opinioni politiche. Il purgatorio di Raddi durò fino al 1814 quando Ferdinando III recuperò il trono e il botanico venne reintegrato nell'incarico di curatore delle collezioni scientifiche del Museo di storia naturale. In una situazione più tranquilla, poté così completare la sua prima importante monografia Jungermanniografia Etrusca (1817), dedicata alle crittogame toscane: un lavoro così importante che Nees von Esenbeck salutò Raddi "padre dell'epaticologia". L'opera fu presentata nel giugno 1817, poco prima dell'arrivo in Toscana di Leopoldina e del suo seguito; fu certamente essa ad attirare l'attenzione del granduca, che invitò Raddi ad unirsi alla spedizione in Brasile. Con strumenti, libri, mappe geografiche, ma senza alcun assistente, il botanico toscano si imbarcò sul San Sebastiano, uno dei vascelli portoghesi che dovevano condurre la principessa a Rio de Janeiro; salpata da Livorno il 13 agosto 1817, la piccola flotta austro-portoghese si fermò per pochi giorni a Madeira (11-13 settembre), dando modo a Raddi di raccogliere 150 specie di vegetali, compresa una nuova epatica; dopo 82 giorni di navigazione, giunse a Rio il 5 novembre. Subito dopo l'arrivo, il botanico toscano, oltre ai colleghi imbarcati sull'Austria, che si trovavano a Rio già da vari mesi, conobbe il console russo Georg von Langsdorff, che lo invitò a visitarlo nella sua fazenda Mandioca. Un altro incontro importante fu quello con il carmelitano Leandro do Santíssimo Sacramento, professore di botanica alla Real Academia de Medicina. Contrariamente ai colleghi austriaci e tedeschi, Raddi disponeva di un budget estremamente limitato. Il costo della vita nella colonia, anche a causa dell'arrivo della comitiva nuziale, era proibitivo. Non avendo abbastanza denaro per assumere aiutanti sul posto, egli dovette muoversi da solo, approfittando dell'ospitalità di amici brasiliani e soprattutto di Langsdorff. I suoi viaggi ebbero dunque un raggio limitato, tanto nei dintorni della città, quanto nell'area di Mandioca. Le località di raccolta più citate nel suo diario di campo sono, in ordine alfabetico, Catumby, un villaggio a ovest di Enseada da Glória; il monte Corcovado; la Serra de Estrela, un gruppo di montagne a nord della Baia di Guanabara; il monte Gavia, a sud di Rio de Janeiro; Mandioca, la valle a ovest di Rio da Janeiro dove si trovava la fazenda di Langsdorff; le piste di Matacavallos e Mataporcos nella foresta pluviale a nord della capitale; Nossa Senhora da Piedade Inhumirin, a nord del porto di Estrella; la foresta di Tijuca, che circondava il palazzo reale; si aggiungano alcune località tra Rio e Petropolis, inclusa la Serra dos Órgãos. Nonostante tutte le difficoltà, le raccolte di Raddi nei sette mesi che trascorse in Brasile furono imponenti: 4000 piante, 2230 insetti, 49 rettili, 65 minerali, manufatti, frutti; raccolse anche i semi di circa 340 specie, con l'intenzione di propagarli una volta tornato in Toscana. Nell'orto botanico di Firenze sono ancora oggi coltivate alcune specie di Begonia, compresa la popolarissima B. maculata Raddi, e un esemplare di Psidium guineense, discendenti da piante nate da semi portati da Raddi dal Brasile. Dopo aver inutilmente sollecitato nuovi finanziamenti, il 1 giugno 1818 Raddi dovette rassegnarsi a tornare in Europa insieme a Mikan, ai pittori e all'ambasciatore d'Austria von Eltz. Il 19 agosto sbarcò a Genova con diverse casse di esemplari e tre barili di cachaça usati per conservare pesci e anfibi.  Un importante contributo scientifico Le sue vicissitudini non erano finite. Di origini sociali modeste, autodidatta, era guardato con sufficienza dai colleghi più titolati, che invidiavano la sua fama crescente al di fuori del provinciale ambiente fiorentino, Al suo ritorno in città, Raddi scoprì che il custode del Museo, il paleontologo Filippo Nesti, non aveva trattato con la dovuta cura i materiali spediti dal Brasile; nonostante ciò, la catalogazione delle collezioni venne affidata, invece che al raccoglitore, allo stesso Nesti, che per altro non aveva competenze né in botanica né in zoologia. Raddi si vide retrocesso al rango di impiegato amministrativo con un modestissimo stipendio. Soltanto a partire dal 1820, quando venne abolito l'incarico di custode del Museo, pur mantenendo lo stesso stipendio, gli venne riconosciuto il ruolo di "fisico", ovvero di ricercatore, con l'incarico di studiare le proprie raccolte brasiliane. Lasciato il lavoro al Museo, si trasferì al Canto di Candeli in Borgo Pinti per dedicarsi interamente a questo compito. A una prima monografia sulle felci brasiliane, Synopsis Filicum Brasiliensium, uscita già nel 1819, seguì l'importante Agrostografia Brasiliensis sive enumeratio plantarum ad familias naturales graminum et ciperiodarum spectantium quas in Brasilia collegit et descripsit (1823), il primo studio sulle erbe neotropicali, che comprende 65 Poaceae (tra cui 5 nuovi generi) e 26 Cyperaceae. Infine nel 1825 uscì Plantarum Brasilensium Nova Genera et Species Novae, vel minus cognitae che Raddi concepiva come prima parte di un lavoro più ampio. A questi lavori maggiori si affianca una notevole produzione di articoli e memorie, pubblicati negli atti di società scientifiche come la Società Italiana delle Scienze di Modena. Raddi vi approfondì lo studio di numerose altre famiglie di piante, con un approccio innovativo che dava grande importanza alla sistematica attraverso l'analisi e l'interpretazione di vasti gruppi. Il botanico fiorentino si inserì così autorevolmente nel dibattito europeo sulla classificazione naturale. Notevole fu anche il suo contributo alla zoologia, con la descrizione di diverse nuove specie di rettili. La precisione delle descrizioni e la profondità delle interpretazioni diedero risonanza europea a Raddi, che fu in corrispondenza con molti colleghi di primo piano; egli fu anche ammesso a numerose società scientifiche in Italia e all'estero. Non doveva però essere totalmente appagato, oppure non si era spento il suo desiderio di avventura, se nel 1828, quando aveva già quasi sessant'anni, accettò di affrontare una nuova sfida. Nel 1827, due egittologi, il toscano Ippolito Rosellini e il francese Jean François Champollion, il decifratore della stele di Rosetta, proposero ai rispettivi governi una spedizione in Egitto. Ne nacque così la Missione archeologica franco-toscana che per 15 mesi (18 agosto 1828-27 novembre 1829) esplorò la valle del Nilo toccando tutti i più celebri siti noti all'epoca. Con Rosellini e Champollion c'era un vasto gruppo di archeologi, architetti, disegnatori, naturalisti. Uno di loro era il nostro Giuseppe Raddi, che della spedizione era il botanico ufficiale. Anche in Egitto, Raddi si dimostrò un raccoglitore instancabile, raccogliendo nell'arco di otto mesi circa 450 specie di piante. Dapprima esplorò i dintorni di Alessandria e di Rosetta, quindi con i suoi compagni risalì il Nilo fino alla prima cataratta. Qui abbandonò la spedizione per tornare in Basso Egitto, dove la vegetazione era più abbondante. Il 29 giugno 1829 partì da Rosetta per raggiungere il Wadi el-Natrun ma durante il viaggio fu colto da una violenta infezione intestinale. Costretto a rientrare al Cairo, continuò ad aggravarsi, tanto da decidere di tornare in Italia. Il 23 agosto si imbarcò a Alessandria ma durante il viaggio di ritorno morì a Rodi il 6 settembre. Qualche anno dopo, un gruppo di amici volle porre una lapide in suo ricordo a Santa Croce, che lo saluta come "ornamento d'Italia". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Bambù piccoli e lillipuziani Della grande stima internazionale goduta da Raddi testimoniano anche le numerose dediche di generi che gli furono tributate. Era una stima che andava non solo allo scienziato, ma anche alla persona, lodata per la modestia, la coerenza e la nobiltà d'animo. Contava anche la riconoscenza per la generosità di Raddi, che per quanto poté - il regolamento del Museo di storia naturale poneva gravi limiti - condivise con larghezza i suoi esemplari con i colleghi. Tra i beneficiati Antonio Bertoloni, amico personale di Raddi e Savi, cui il botanico fiorentino inviò più di 200 esemplari per la sua Flora italica, molti dei quali appartenenti a specie mai descritte, in particolare crittogame. La stima reciproca è testimoniata da uno scambio di dediche: nel 1812 Bertoloni dedicò al collega Raddia, famiglia Poaceae (ne riparliamo tra poco); l'anno dopo Raddi ricambiò con Bertolonia, famiglia Melostomataceae. Il secondo omaggio giuse dal franco-statunitense Rafinesque, che nel 1814 dedicò al botanico fiorentino Radiana (Aizoacaeae), oggi sinonimo di Sesuvium L. Anche la terza dedica si deve a un collega che ebbe rapporti personali con Raddi, quel frate Leandro do Santíssimo Sacramento che lo aveva guidato alla scoperta della flora brasiliana. E ancora una volta, si tratta di uno scambio di cortesie: nel 1820 Raddi pagò il suo debito di riconoscenza con Leandro dedicandogli Leandra, un'altra Melastomatacea; l'anno successivo il brasiliano si sdebitò con Raddisia (Celastraceae), oggi sinonimo di Salacia L. Il genere di Leandro fu ripreso da de Candolle (come abbiamo visto, assiduo corrispondente e estimatore dell'attività scientifica di Raddi) che lo corresse in Raddia. Nel 1822 il francese Achille Richard aggiunse Radia (Amaryllidaceae), oggi sinonimo di Vellozia Vand. Di tutti questi generi l'unico oggi valido è Raddia Bertoloni. E' una dedica particolarmente opportuna per il primo studioso delle graminacee sudamericane. A questo genere appartengono infatti una dozzina di specie di bambù, diffusi tra Venezuela, Guyana e Brasile. Anche se siamo abituati ad associare i bambù all'estremo oriente, anche l'America tropicale è particolarmente ricca di specie di questi vasto gruppo di Poaceae. Sono americani (e dell'Oceania) i cosiddetti bambù erbacei, appartenenti alla tribù Olyreae, con una ventina di generi, uno dei quali è appunto Raddia. Anche se alcune specie crescono a Trinidad e Tobago, in Guyana, in Venezuela e nell'Amazzonia brasiliana, il centro di diversità di questo genere è la costa atlantica orientale del Brasile, in particolare tra gli Stati di Bahia e Espìrito Santo. Sono bambù erbacei, alti non più di un metro, cespugliosi, con colmi eretti, che crescono in piccoli gruppi, soprattutto nelle foreste stagionalmente aride. La specie più diffusa è probabilmente R. brasiliensis, una specie molto polimorfa assai diffusa nelle foreste costiere da Cearà a Rio de Janeiro, con qualche popolazione sparsa nel Brasile occidentale. Qualche approfondimento nella scheda. La tribù Olyreae ha una tassonomia piuttosto complicata, ed è stata sottoposta a continue revisioni. Nell'ambito di una di esse, nel 1948 Jason Richard Swallen creò il genere Raddiella, in cui nome allude alla somiglianza con Raddia, ma in miniatura. Insieme a Mniochloa questo genere comprende infatti i bambù più piccoli del mondo. Il più piccolo in assoluto è R. vanessiae, una specie della Guyana francese che a maturità non supera i due cm. A distribuzione più settentrionale rispetto alla cugina maggiore (si fa per dire), sono native dell'America centrale e del Sud America settentrionale, fino a Trinidad. In genere comprende una quindicina di specie da piccole a minuscole; solitamente sono perenni cespugliose che formano colmi, per lo più striscianti; R. vanessiae, oltre ad essere il più piccolo bambù nel mondo, è anche l'unico sicuramente annuale. Altre informazioni nella scheda. Nel 1817, il matrimonio dell'arciduchessa Maria Leopoldina d'Asburgo con l'erede al trono del Portogallo offre l'occasione per organizzare la prima grande spedizione scientifica in Brasile, le cui frontiere fino ad allora erano rimaste chiuse agli scienziati stranieri. Di grande significato politico e propagandistico per l'Austria, vede anche la partecipazione di due naturalisti bavaresi e di un botanico italiano. Le tensioni interne al gruppo e la turbolenta situazione politica (sono proprio gli anni in cui il Brasile diventa indipendente) ridimensioneranno in parte gli obiettivi; tuttavia, i risultati saranno grandiosi e segneranno una tappa decisiva per la conoscenza della natura brasiliana. Dei cinque botanici coinvolti in questa grande avventura, tre sono dedicatari di generi validi; li ritroveremo in altrettanti post riservati solo a loro, per dedicare almeno un ricordo e un pensiero a Leopoldina, che da adolescente sognò di diventare naturalista e morì forse di dolore, forse di femminicidio da imperatrice del Brasile. A renderle omaggio le svettanti palme del genere Leopoldinia. 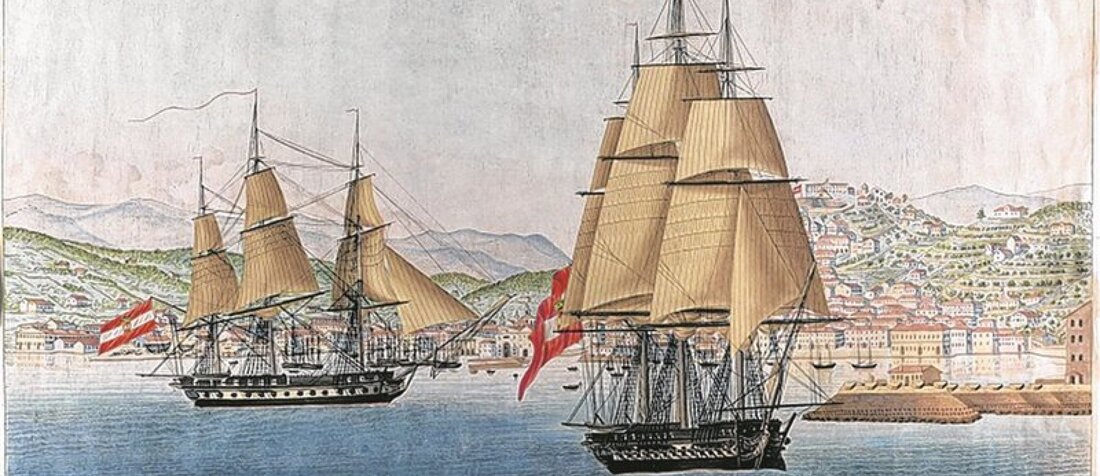 Un matrimonio imperiale e una spedizione in terre lontane Dopo la prova del fuoco delle guerre napoleoniche, l'Austria si ritrovò superpotenza. Certo, aveva dovuto subire terribili umiliazioni e Francesco II non era più Imperatore dei Romani, ma semplicemente Imperatore d'Austria; tuttavia governava un territorio raddoppiato, perno della Santa Alleanza, con l'assoluta egemonia sull'Italia. Vienna, sede dell'omonimo congresso, era la capitale diplomatica (e modaiola) d'Europa. Era ora di guardare più lontano. Così, quando il re di Portogallo chiese in moglie una principessa asburgica per l'erede al trono, Pietro di Braganza, Francesco II pur avendo qualche titubanza (le notizie sul pretendente non erano del tutto rassicuranti), convinto dal cancelliere e ministro Metternich, finì per accettare, sacrificando una delle figlie alla ragion di stato. L'alleanza conveniva ad entrambi: al Portogallo, che sperava di limitare l'egemonia economica inglese e cercava aiuto contro il movimento liberale; all'Austria, che contava d'estendere la propria sfera d'influenza all'America latina. Il re del Portogallo era infatti anche re del Brasile, e dal 1808, quando Napoleone aveva occupato la penisola iberica, si era rifugiato con la corte a Rio de Janeiro, divenuta la capitale di fatto del Regno. La scelta cadde sull'arciduchessa Maria Leopoldina. Per lei era ora di sposarsi. Aveva già 19 anni (il futuro marito ne aveva uno in meno) e fino ad allora non aveva avuto proprio la coda di pretendenti. Intelligente, colta, seria, fosse stato per lei avrebbe preferito un destino ben diverso: era appassionata di scienze naturali, soprattutto botanica e mineralogia, e sognava di dirigere la Collezione imperiale dei minerali, un'aspirazione impensabile per una donna del suo tempo. Quando seppe che l'attendeva un matrimonio nel lontano Brasile, l'accettò di buon grado, non solo per senso del dovere, ma anche per il fascino esotico di quella terra, uno scrigno i tesori naturali. La pensava così anche il cancelliere Metternich, appassionato di scienze naturali e amico personale di Humboldt; propose dunque all'Imperatore di approfittare dell'occasione per inviare in Brasile, insieme al seguito di Leopoldina, una spedizione scientifica in grande stile. Fino ad allora le frontiere brasiliane erano state ermeticamente chiuse alla scienza e sponsorizzare la prima spedizione scientifica ufficiale in quel paese avrebbe dato grande prestigio alla monarchia asburgica, con importanti ricadute economiche: accesso a risorse minerarie, legnami pregiati, animali esotici per lo zoo imperiale, piante per i giardini ma anche da naturalizzare, a giovamento dell'agricoltura nazionale, Francesco II, fin da bambino cultore di botanica, tanto da essersi guadagnato il soprannome "imperatore dei fiori", accettò con entusiasmo, affidando a Metternich l'organizzazione logistica della spedizione, incluso l'itinerario, e a Karl Franz Anton von Schreibers, il direttore dell'Imperiale gabinetto di storia naturale, la direzione scientifica. Per l'impresa vennero scelti lo zoologo Johann Natterer, con l'assistenza del cacciatore imperiale e tassidermista Ferdinand Dominik Sochor; il mineralogista e botanico Johann Baptist Emanuel Pohl; il giardiniere Heinrich Wilhelm Schott; il pittore paesaggista Thomas Ender e l'illustratore Johann Buchberger. La spedizione avrebbe dovuto essere diretta da Natterer, ma l'imperatore impose la presenza e la direzione di Johann Christian Mikan, professore di storia naturale a Praga. Una scelta che fu vissuta da Natterer come un affronto personale. Intanto, il re di Baviera Massimiliano I, che si trovava a Vienna per il Congresso, venne a sapere della spedizione e raccomandò due giovani naturalisti bavaresi, lo zoologo Johann Baptist von Spix e il botanico Carl Friedrich Philipp von Martius, che vennero così ad aggiungersi alla lista dei partecipanti. Il 13 maggio 1817 Leopoldina si sposò per procura; insieme al suo seguito, che comprendeva due dei suoi insegnanti, il mineralogista Rochus Schüch e il pittore Frick, tre dame di compagnia, l'ambasciatore imperiale conte von Eltz, Pohl e Buchberger, partì per Livorno, dove avrebbe atteso la flotta portoghese che doveva condurla a Rio. Circa un mese prima, il 9 aprile, il grosso degli scienziati si era già imbarcato a Trieste sulle fregate Austria e Augusta.  Scienziati litigiosi e raccolte naturalistiche Dopo due giorni di navigazione, i due vascelli austriaci incapparono in una violenta tempesta e dovettero rifugiarsi per riparazioni una a Chioggia, l'altra a Pola. Quindi l'Austria, su cui erano imbarcati Mikan, Ender e i due bavaresi, fece direttamente rotta per il Brasile, con una sosta a Malta, giungendo a Rio il 14 giugno. In attesa dei compagni, si dedicarono all'organizzazione logistica della spedizione; un contatto particolarmente utile fu quello con il console russo, il barone Langsdorff, che divenne un punto di riferimento anche nei mesi successivi. Quanto all'Augusta, su cui viaggiavano Natterer, Socor e Schott, fece vela per Gibilterra, dove sostò ad aspettare delle navi portoghesi. L'attesa si prolungò oltre ogni aspettativa. Infatti i vascelli Joao VI e São Sebastião, con a bordo la principessa e il suo seguito, salparono da Livorno solo il 5 agosto. A bordo troviamo anche una new entry: il botanico Giuseppe Raddi, cui il granduca di Toscana aveva ordinato di unirsi alla spedizione. Le tre navi si ricongiunsero a Gibilterra e salparono insieme per Rio solo il 1 settembre; erano finalmente a destinazione il 4 dicembre dopo una difficile navigazione durata ben 82 giorni. L'inizio della spedizione vera e propria ne risultò fortemente ritardato. Poiché si prevedeva che le fregate austriache avrebbero lasciato il Brasile per il viaggio di ritorno alla fine di marzo o all'inizio di aprile, in accordo con l'ambasciatore von Eltz, i naturalisti optarono per brevi spedizioni, in modo da poterne approfittare per un primo invio. Per ottimizzare le forze, si divisero in tre gruppi; una decisione dovuta anche alle tensioni interne, alimentate dalla rivalità tra Natterer e Mikan e dall'autoritarismo di quest'ultimo. Accompagnati da guide, portatori, personale ausiliario, i tre gruppi poterono mettersi in marcia solo alla fine di gennaio; i due bavaresi, insieme al pittore Ender, si diressero a São Paulo; i due gruppi austriaci, formati uno da Mikan, Schott e Buchberger, l'altro da Natterer, Sochor e Pohl, si divisero l'esplorazione della provincia di Rio, all'epoca ancora ricca di foreste e terre vergini. Raddi, che l'avaro granduca aveva dotato di finanziamenti insufficienti, fu costretto a fare parte per se stesso. Lo ritroveremo in un prossimo post. Il gruppo di Mikan fu costretto a rientrare già all'inizio di marzo, a causa di una brutta caduta da cavallo di Buchberger , mentre la assai più fruttuosa spedizione di Natterer e compagni si protrasse fino ad aprile. Il primo giugno 1818 l'Austria e l'Augusta ripartirono per l'Europa, con varie casse di animali imbalsamati, piante essiccate, conchiglie, semi, qualche animale curioso vivo e vasi di piante rare raccolte da Schott e Pohl. A bordo c'erano anche i due pittori, gravemente malati; Raddi, rimasto senza fondi; e Mikan, cui l'ambasciatore von Eltz aveva ordinato di rientrare a causa della pessima atmosfera creata dal suo autoritarismo. Quando la notizia arrivò in Europa, anche se il rientro di Mikan venne diplomaticamente attribuito al suo stato di salute, chi non aveva simpatia per l'Austria incominciò a mormorare di fallimento. Non era proprio così, ma certamente si trattava di un ridimensionamento degli obiettivi iniziali. In Brasile rimanevano un nutrito gruppo di scienziati austriaci e i due bavaresi. Questi ultimi, non riuscendo a concordare un itinerario comune, si separarono dagli altri e si diressero a nord, intenzionati a esplorare l'Amazzonia. Anche a loro sarà dedicato un post a parte. Gli austriaci concordarono con l'ambasciatore di rimanere in Brasile ancora un anno e mezzo o due anni; tuttavia era chiaro che neppure l'esautorazione di Mikan aveva trasformato quell'insieme di individualisti in una squadra affiatata. Il più disciplinato era indubbiamente Schott, che obbedì a malincuore all'ordine di rimanere a Rio a creare e curare un giardino di acclimatazione per i semi e le piante raccolti nei dintorni; solo dopo circa un anno, quando da Vienna venne inviato in suo aiuto il giardiniere Schücht, poté affrontare alcuni viaggi più lunghi, in compagnia del pittore Frick che si era offerto di sostituire Buchberger come illustratore botanico. Natterer e Socor erano ormai una affiatatissima squadra; avevano intenzione di visitare il Mato Grosso, ma, non avendo ottenuto il necessario passaporto, si diressero a São Paulo, dove misero insieme una ragguardevole raccolta soprattutto di uccelli e insetti, per poi spostarsi a Soracaba e Ipanema. Anche Pohl era molto attivo, anche se i suoi interessi dalla botanica andarono via via allargandosi alle miniere e all'etnografia; nell'arco di circa due anni, i suoi viaggi lo portarono nelle province di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goias, Bahia. Tuttavia a causa del deterioramento della situazione politica dopo il rientro di Giovanni VI in Portogallo, alla fine del 1820 von Elck convocò i naturalisti a Rio de Janeiro e ordinò loro di rientrare prontamente in Europa. Pohl e Schott obbedirono: il primo si imbarcò nell'aprile 1821 per Amsterdam insieme a Schücht e una coppia di indios Botocudo, che al loro arrivo a Vienna divennero l'attrazione del giorno; il secondo a maggio si imbarcò per Lisbona, con 35 casse di materiali raccolti da Pohl e 30 da lui stesso. Natterer e Socor decisero invece di rimanere in Brasile e proseguirono le ricerche, ormai non più al servizio dell'Impero d'Austria, ma come esploratori indipendenti. Rimasto solo per la morte del fedele Sochor (1826), Natterer riuscì a penetrare nel bacino del Rio delle Amazzoni, spingendosi fino al confine con la Bolivia. Il suo viaggio avventuroso, che tra mille difficoltà si sarebbe protratto fino al 1835, segnò una tappa decisiva nella conoscenza della fauna brasiliana, con la scoperta di decine e decine di nuove specie. Non poche portano il suo nome: molti uccelli, come il colibrì gola-cannella Phaethornis nattereri, la pispola petto-ocra Anthus nattereri, il motmot amazzonico Momotus momota nattereri; diversi pipistrelli, come Vampyressa nattereri; il pesce siluride boliviano Farlowella nattereri. Notarella botanica a mo' d'epilogo Tutti i botanici che parteciparono a questa avventura ebbero la fortuna di tornare in patria, di vivere ancora a lungo e di pubblicare le piante che avevano raccolto in contributi di diversa importanza. Tra tutti spicca la monumentale Flora brasiliens diretta da von Martius, che sarà oggetto di un prossimo post, così come i lavori di Raddi e Schott. Ci rimangono dunque Mikan e Pohl. Johann Christian Mikan (1769-1844), boemo, era figlio d'arte: suo padre era infatti Joseph Gottfried Mikan, professore di botanica e chimica presso l'università di Praga e direttore dell'orto botanico praghese. Studiò medicina e botanica; incominciò a insegnare scienze naturali nella sua alma mater fin dal 1796, divenendo ordinario di storia naturale nel 1800 e di botanica dal 1812, al pensionamento del padre. Nonostante la brevità della sua partecipazione all'impresa brasiliana, le sue scoperte sulla fauna e sulla flora del paese sudamericano, pubblicate in Delectus Florae et Faunae Brasiliensis (1820-1825), sono tutt'altro che trascurabili; tra l'altro, vi si trova la prima descrizione scientifica della scimmia leonina nera Leontopithecus chrysopygus. Tuttavia, era più uno zoologo che un botanico. I generi botanici Kanimia Gardner, Mikania Willd. e Mikaniopsis Milne-Redh. non sono dedicati a lui, ma a suo padre, un botanico molto noto per i suoi lavori sulla flora boema. Molto maggiore per quantità e qualità, in ogni caso, il contributo di Johann Baptist Emanuel Pohl (1782-1834). Anche lui boemo e formatosi all'Università di Praga, nel 1808 si era laureato in medicina. Iniziò la sua carriera di naturalista come bibliotecario e curatore delle collezioni della principessa Kinsky; contemporaneamente insegnava botanica all'Università. Lavorò anche come medico presso gli ospedali militari di Náchod e Praga. Era un naturalista a 360 gradi, che prima della spedizione in Brasile pubblicò lavori sulla flora ceca, sull'anatomia animale e sui fossili. Come abbiamo visto in precedenza, in Brasile fu instancabile, soprattutto nei viaggi in solitaria tra 1819 e 1821. Le sue imponenti collezioni, con oltre 4000 esemplari botanici, andarono ad arricchire il Gabinetto di storia naturale e il Brasilianum, il Museo allestito per esporre al pubblico le raccolte della spedizione. Di entrambi fu nominato curatore. Il suo Reise im Innern von Brasilien "Viaggio nel Brasile interno", in due volumi (1817-1821), fu molto letto e influì grandemente sull'immagine del Brasile in Europa. Alle piante brasiliane dedicò Plantarum Brasiliae icones et descriptiones (1827), un'opera molto curata anche dal punto di vista iconografico, in cui pubblicò diversi nuovi generi. Spiace che questo interessante naturalista non sia celebrato da alcun genere valido. Pohlana Mart. & Nees è infatti stato ridotto a sinonimo di Zigophyllum. Lo ricordano nell'epiteto diverse specie sudamericane, come la brasiliana carapià Stenandrium pohlii, ma anche l'europea Taraxacum pohlii.  La mineralogista mancata che divenne imperatrice Ma allora di cosa stiamo parlando, se dei colleghi di Mikan e Pohl si parlerà altrove? C'è ancora una persona degna di essere ricordata, cui non manca la gloria di un genere celebrativo. Chi? Proprio lei, l'arciduchessa Maria Leopoldina Giuseppa Carolina d'Asburgo Lorena, alias Dona Leopoldina, prima imperatrice del Brasile. La principessa che sognava di diventare direttrice del reale gabinetto di minerali arrivò in Brasile piena di sogni e di speranze. Del neosposo gli avevano fatto un ritratto elogiativo, e a prima vista non rimase delusa. Pedro era indubbiamente un bel ragazzo, ma, ahimè, niente di più. Era rozzo, incolto, e sebbene Leopoldina parlasse fluentemente quattro lingue, finché non padroneggiò anche il portoghese fu difficile persino comunicare. Sembra che a interessarlo fossero solo i cavalli e le belle ragazze (la scialba Leopoldina con il prominente labbro asburgico non rientrava nella categoria). Con il senso del dovere che le era stato inculcato fin dall'infanzia, la principessa si adattò serenamente alla nuova vita. Tra una gravidanza e l'altra (in nove anni di matrimonio ebbe sette figli) cercava di mantenere vivi i suoi interessi naturalistici: leggeva, dipingeva acquarelli botanici, collezionava molluschi, faceva quotidiane passeggiate nella foresta di Tijuca alla ricerca di orchidee; cavalcando all'amazzone andava a caccia e aiutava i tassidermisti a impagliare uccelli e piccoli mammiferi. Nella Fazenda Imperiale di Santa Cruz creò una moderna postazione zootecnica; nel palazzo di Boa Vista, fece allestire una biblioteca costantemente aggiornata con volumi di botanica e mineralogia che ordinava in Europa e un gabinetto di storia naturale, diretto dal suo maestro Rochus Schüch. Diede impulso alla creazione del Museo di Storia naturale, istituito con decreto reale nel 1818. Dona Leopoldina, come la chiamano in Brasile, divenne anche una figura molto amata. Nel 1821, quando Giovanni VI e la corte rientrarono in Portogallo, anziché approfittarne per tornare in Europa, preferì rimanere a fianco del marito e successivamente giocò un ruolo importante negli eventi che portarono alla Dichiarazione di indipendenza. Mentre Pietro si trovava a San Paolo, il 2 settembre 1822 arrivò a Rio il decreto reale che imponeva al principe di tornare in Portogallo e ripristinava lo stato di colonia del Brasile; nella sua posizione di reggente, Leopoldina riunì il Consiglio dei ministri e inviò al marito questo messaggio: "Il frutto è pronto. E' il momento della raccolta". Appena ricevuta la lettera, il 7 settembre, Pietro dichiarò l'indipendenza e si proclamò primo imperatore del Brasile. Secondo lo storico Paulo Rezzutti, molto del merito va proprio a Leopoldina: "Abbracciò il Brasile come suo paese, i brasiliani come suo popolo e l'Indipendenza come sua causa". Sul piano personale, gli ultimi anni di Leopoldina furono molto infelici. Pochi giorni prima dell'Indipendenza, a São Paulo Pietro conobbe una giovane donna, Domitila da Castro, e ne fece la sua amante. Non fu l'unica relazione extraconiugale di Pietro, che aveva già avuto e ebbe contemporaneamente a Domitila molte altre amanti, ma certamente fu la più scandalosa: non solo l'imperatore riconobbe pubblicamente la paternità di una figlia avuta da Domitilla, ma nobilitò l'amante, la nominò dama di compagnia della moglie e all'inizio del 1826 ne impose la presenza in occasione di viaggio ufficiale a Bahia. Leopoldina, come possiamo ricavare dalle lettere alle sorelle, si sentì totalmente umiliata. La sua vita era diventata un inferno; secondo le male lingue, non contento di offenderla di fronte a tutta la corte, Pietro prese anche a maltrattarla e picchiarla. Leopoldina morì non ancora trentenne nel dicembre 1826, dieci giorni dopo un aborto. Su questa morte si accavallarono le dicerie; se la causa più probabile fu una setticemia, secondo alcuni l'infelice arciduchessa, ormai priva di ogni desiderio di vivere, si sarebbe lasciata morire; secondo altri fu vittima di femminicidio: l'aborto che l'avrebbe portata alla morte sarebbe infatti stato causato da un violento calcio del marito. Meglio, molto meglio per lei, se fosse rimasta a Vienna a dirigere il reale Gabinetto dei minerali. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Una palma brasiliana per la principessa che si fece brasiliana A ricordare questa amica della scienza, questa donna intelligente e coraggiosa che il Brasile amò e non ha mai dimenticato, c'è anche un genere di piante, Leopoldinia, che von Martius le dedicò nel 1824 nella sua monografia sulle palme. Per una volta, si tratta di una dedica meritatissima, al di là del solito omaggio cortigiano a una sovrana. Il genere Leopoldinia della famiglia Arecaceae comprende tre specie di palme diffuse nel bacino del Rio delle Amazzoni tra Venezuela, Colombia e Brasile nord-occidentale, nella foresta tropicale umida periodicamente allagata: L. major, L. pulchra e L. piassaba. Le prime due crescono su isole rocciose e sulle rive del Rio Negro e di alti fiumi dalle acque nere e hanno fusto cespuglioso. L. piassaba, che ha fusto unico, cresce invece su isole sabbiose solitamente non allagate, in gruppi cospicui. Mentre la chioma di L. major, una specie rara nota solo in poche stazioni del bacino dei Rio Negro, può emergere sullo stato alto della foresta, le altre due sono specie tipiche del sottobosco. Hanno foglie basali molto fibrose, tanto che le fibre ricavate da L. piassaba, conosciuta come palma da fibra, sono utilizzare per cestini, scope, corde, cappelli e altri prodotti intrecciati. Hanno eleganti foglie pennate, pendule, lunghe fino a 5 metri. Per lo più monoiche, portano fiori maschili e femminili in infiorescenze diverse distribuite alternativamente lungo lo stesso ramo; talvolta tuttavia i fiori maschili spuntano vicino al tronco, mentre quelli femminili all'apice. Raramente possono avere fiori ermafroditi o essere dioiche. Qualche informazione in più nella scheda. Alice Eastwood è stata probabilmente la più nota botanica statunitense: per quasi sessant'anni diresse il dipartimento di botanica dell'Accademia delle Scienze di California, fu la massima esperta della flora degli Stati Uniti occidentali, descrisse e classificò 395 specie, scrisse oltre 300 tra articoli e libri. E soprattutto, fece risorgere letteralmente dalle ceneri l'erbario dell'Accademia, di cui la terribile mattina del terremoto di San Francisco riuscì a salvare il nucleo più prezioso con un impulsivo atto eroico. A ricordarla, l'epiteto di numerose specie e sottospecie, e due generi: Eastwoodia e Aliciella. Una preziosa collezione strappata alle fiamme All'alba del 18 aprile 1906 un violento terremoto si abbatté sulla città di San Francisco, con due scosse successive, la seconda delle quali violentissima. Moltissimi edifici furono lesionati, altri crollarono e centinaia di persone (non sapremo mai esattamente quante) rimasero sotto le macerie; ma i danni peggiori non furono causati dal sisma, bensì dal terribile incendio (negli Stati Uniti è passato alla storia come Great Fire) che continuò ad ardere per quattro giorni e quattro notti, distruggendo circa 25.000 edifici. Tra gli abitanti della città che in quella mattina tragica persero tutto c'era anche Alice Eastwood, la curatrice dell'erbario dell'Accademia delle Scienze della California. Preoccupata per la sorte delle collezioni di cui era la custode, si precipitò in Market Street, dove sorgeva la sede dell'Accademia. Dato che il ponticello che dava accesso all'ingresso principale del Museo era crollato, Alice si portò sul retro, dove si era raccolto un gruppetto di curatori e assistenti dei vari dipartimenti dell'Accademia. Nel cortile invaso dai detriti, tutti guardavano in su, impotenti e desolati. L'edifico era lesionato, e la scala in marmo che dava accesso ai piani superiori era parzialmente crollata. Anche se non c'era pericolo di crollo immediato, alcuni edifici vicini erano già in fiamme ed era evidente che presto l'incendio avrebbe raggiunto anche il Museo. Impossibile mettere in salvo la biblioteca, i documenti, le inestimabili collezioni naturalistiche, tutti custoditi ai piani superiori. Vedendo che il lavoro suo e degli scienziati che avevamo fatto di quella istituzione la più importante degli Stati Uniti occidentali stava per essere distrutto, Alice Eastwood prese una rapida decisione. Durante la sua gestione, aveva inaugurato una pratica all'epoca inconsueta: quella di custodire a parte gli esemplari tipo, ovvero quelli usati per descrivere e determinare le nuove entità. Almeno quello, il nucleo più prezioso dell'erbario, doveva essere salvato. Ma come raggiungerlo, visto che si trovava al sesto piano, nell'ufficio della curatrice? Con un coraggio che rasenta l'incoscienza, insieme al suo assistente Robert Porter, Alice (era un'alpinista provetta) salì sulla ringhiera di ferro della scala semicrollata e si arrampicò fin lassù mettendo i piedi tra i pioli. Dal suo ufficio prese un solo oggetto, un paio di occhiali, e incominciò a impacchettare i preziosi esemplari che poi vennero calati in cortile con l'aiuto di corde improvvisate. In tal modo salvò 1497 esemplari tipo, che vennero poi trasportati in un edificio sicuro; nel pomeriggio l'incendio si estese all'Accademia che arse per tre giorni, distruggendo tutto il resto, compresa la collezione personale della coraggiosa botanica. Diciannove giorni dopo Eastwood scrisse: "Non sento la perdita come qualcosa di personale, ma è una grande perdita per il mondo scientifico e una perdita irreparabile per la California. Non mi lamento del mio lavoro che è andato perduto, dato che per me è stato una gioia quando l'ho fatto, e lo sarà di nuovo quando ricomincerò". E sarebbe stato proprio così.  Ritratto di una botanica da giovane Abbiamo già incontrato Alice Eastwood parlando di Townshend e Catharine Brandegee. E' ora di conoscerla meglio. Alice era nata in Canada, a Toronto, ma adolescente si era trasferita con la famiglia a Denver in Colorado. Mentre ancora studiava alla scuola superiore, un casuale soggiorno in montagna l'aveva fatta innamorare delle piante delle Montagne rocciose e l'aveva spinta a studiare botanica da autodidatta sui pochi manuali disponibili e a creare un erbario. Anche se era una studentessa brillante, le condizioni economiche della famiglia le impedivano di andare all'Università; così, dopo il diploma rimase a insegnare al Shawa Convent Catholic High School, la scuola dove aveva studiato. Era una supplente sottopagata, cui veniva richiesto di insegnare ogni tipo di materia e di correggere una montagna di compiti. Tutto il poco che riusciva a risparmiare lo destinava ad acquistare libri di botanica e a pagarsi le vacanze estive, che trascorreva arrampicandosi su colline e montagne alla ricerca delle amate piante. Poco alla volta, incominciò a farsi un nome come esperta della flora del Colorado. Nel 1887 guidò sul Gray's Peak il celebre naturalista inglese Alfred Russel Wallace, che si trova negli Stati Uniti per un tour di conferenze. Nel 1889 accompagnò il naturalista Theodore Alison Cockerell a botanizzare nella Wet Mountain Valley, e grazie a lui fu nominata segretaria della Colorado Biological Association. Divenuta amica della famiglia Wetherill, che possedeva un ranch nella Mesa verde, ne fece la sua base per numerose escursioni nella cosiddetta Four Corner Region, l'area al confine tra Colorado, Utah, Arizona e New Mexico. Ormai sulla trentina, Alice desiderava lasciare l'insegnamento e diventare una botanica di professione. Alcuni investimenti le avevano permesso di farsi una piccola rendita che la rendeva economicamente indipendente. Nell'inverno 1890-91 visitò per la prima volta la California e incontrò i Brandegee. Katharine Brandegee, impressionata dalla qualità del suo erbario, le chiese di scrivere degli articoli per la sua rivista e le propose di lavorare con lei, ma Alice era piuttosto riluttante a lasciare il Colorado, tanto più che proprio in quel periodo stava scrivendo un libro, uscito nel 1893 con il titolo A popular flora of Denver, Colorado. Nell'estate del 1892, accompagnata da Al Wetherill fece una lunga escursione nell'Utah sudoccidentale alla ricerca di piante del deserto. Solo nel dicembre di quell'anno si trasferì definitivamente a San Francisco, come curatrice aggiunta dell'erbario, poi, dal 1894, al ritiro della signora Brandegee, come curatrice e capo del dipartimento di botanica dell'Accademia delle Scienze. Oltre a occuparsi della gestione dell'erbario e a scrivere articoli per varie riviste, in questo periodo Alice fece importanti raccolte botaniche, in particolare esplorando la allora poco studiata Catena costiera meridionale fino alla regione di Big Sur, che all'epoca non era collegata da nessuna strada. Escursionista e alpinista instancabile, era anche una colonna di associazioni di appassionati come il Sierra Club (con il quale nel 1903 scalò il Monte Withney, la cima più alta degli Stati Uniti esclusa l'Alaska) e il Botanical Club, per il quale scrisse anche una guida al riconoscimento delle piante selvatiche. Ottima divulgatrice, nel 1905 pubblicò A Handbook of the Trees of California, nella cui prefazione scrisse: "L'obiettivo è sempre stato la brevità e la chiarezza, il desiderio di aiutare piuttosto che di brillare".  La ricostruzione dell'erbario Ad eccoci tornati a quel maledetto 18 aprile 1906 quando tutte le collezioni dell'Accademia delle Scienze andarono in fumo, ad eccezione dei 1497 esemplari botanici salvati da Alice e di pochi documenti. Appena possibile, incominciò la ricostruzione. Mentre veniva costruita la nuova sede nel Golden Gate Park, Alice Eastwood andò a studiare nei più importanti erbari statunitensi ed europei: il Gray Herbarium di Harvard, gli erbari del New York Botanical Garden, del British Museum, di Kew e del Museo di storia naturale di Parigi. Questi viaggi le permisero anche di stabilire rapporti personali con molti colleghi. Così nel 1912, quando la nuova sede venne inaugurata e le fu nuovamente offerto il posto di curatrice del Dipartimento di botanica, era pronta per ricominciare. Il suo asso nella manica era l'eccezionale ricchezza della flora californiana, una delle regioni floristiche più ricche del pianeta, con quasi 4700 specie native di cui 1400 endemismi. Alice Eastwood percorse lo stato in centinaia di escursioni, da sola o alla guida di gruppi di cui era allo stesso tempo cuoca, organizzatrice, guida e responsabile scientifico. Esplorò i deserti e le montagne, gli angoli con caratteristiche geologiche peculiari, le zone minacciate dall'espansione urbana e agricola, la cui flora rischiava di sparire prima ancora di essere conosciuta. Le vacanze erano riservate a spedizioni più ampie negli Stati Uniti occidentali (Alaska, Arizona, Utah, Idaho). Grazie a queste estensive raccolte, Eastwood poté realizzare un intenso programma di scambi con altri orti botanici, in particolare con Harward e Kew. Infatti, mentre i primi esemplari andavano a incrementare la collezione dell'Accademia delle Scienze, i duplicati venivano scambiati con altri erbari in giro per il mondo. In cambio delle piante native della West Coast, ricercava soprattutto esemplari che la aiutassero ad identificare correttamente le numerose specie esotiche tropicali e subtropicali che fin dall'Ottocento erano venute a popolare i giardini e i vivai californiani, non di rado naturalizzandosi. Per ricostruire gli itinerari di queste piante migratrici, studiò a fondo i documenti sulle prime spedizioni europee in California. Nel 1949, quando andò in pensione, era riuscita ad aggiungere all'erbario 340.000 esemplari, più di tre volte tanto quelli perduti nell'incendio. I suoi sforzi furono diretti anche a ricostruire la biblioteca, che era andata totalmente distrutta. Lei stessa scrisse moltissimo: la sua bibliografia conta più di trecento titoli, tanto scientifici quanto divulgativi. Appassionata di giardinaggio, cercò di creare un ponte tra il mondo scientifico, i coltivatori e gli amatori. Per rendere popolare la botanica, volle che nell'atrio dell'Accademia si alternassero mostre di fiori freschi. Si impegnò per diffondere la coltivazione delle piante native nei giardini californiani e per la loro salvaguardia, battendosi per la creazione del Parco nazionale del Monte Tamalpais, una delle sue aree di raccolta preferite. Nel 1929 fu tra i soci fondatori della Fuchsia American Society e promosse il censimento delle specie e varietà di fucsie coltivate in California e l'introduzione di nuove varietà. Quando aveva 73 anni fu investita da un'automobile, riportando la frattura di un ginocchio; da quel momento, dovette servirsi di un bastone e rinunciò alle scarpinate. Ma non certo alle escursioni. Adesso, invece che a piedi o a cavallo, si muoveva in automobile, una Ford T, e mentre il suo assistente Thomas Howell si spingeva più lontano, si accontentava di erborizzare nei pressi. In piena salute fino quasi alla morte, andò in pensione nel 1949, a novant'anni, ma continuò a scrivere e a frequentare il suo vecchio ufficio all'Accademia. Nel 1950, il Settimo congresso internazionale di botanica, tenutosi a Stoccolma, la elesse Presidente onoraria (una specie di Oscar alla carriera); per rimarcare tanto onore, venne fatta sedere sul seggio che era stato di Linneo.  L'elegante Eastwoodia e le rare Aliciella Come autrice di nomi botanici, Alice Eastwood è stata una delle botaniche più prolifiche, con 652 taxa e 395 specie. Si tratta di endemismi delle Montagne rocciose e dell'Utah, da lei scoperti in gioventù, e ovviamente di piante californiane. Dato che tra le sue preferite c'erano le Liliaceae, cui dedicò vari importanti studi, vorrei citare le specie endemiche di Allium che scoprì, studiò e nominò: Allium cratericola Eastw., Allium hickmenii Eastw., Allium howellii Eastw., Allium yosemitense Eastw. Sono numerose anche le specie, sottospecie e varietà che la ricordano; tra di esse Fritillaria eastwoodiae, un endemismo della Sierra Nevada, della Cascade Mountains e dell'Oregon meridionale; Erigeron aliceae, una perenne dei pascoli e delle boscaglie del Nord-ovest pacifico; Ranunculus eastwoodinus, nativo dell'Alaska. Veniamo infine ai due generi che si fregiano del suo nome. Il primo in ordine di tempo è Eastwoodia, che gli fu dedicato nel 1894 da Townshend Brandegee. La sua unica specie, E. elegans, endemica di ambienti aridi delle praterie e delle colline della California centrale, negli anni precedenti era stata raccolta da diversi raccoglitori, tra i quale anche Alice Eastwood. Appartenente alla famiglia Asteraceae, è un arbustino alto fino a un metro, molto ramificato e con piccolissime foglie, che al momento della fioritura si fa notare per i numerosissimi capolini gialli globosi, composti unicamente di flosculi ligulati. Una sintetica presentazione nella scheda. Più complicate le vicende del secondo genere dedicato alla nostra protagonista. Nel 1892, erborizzando in Utah, Eastwood scoprì una nuova specie di Gilia che pubblicò come Gilia triodon. Nel 1905 il botanico tedesco August Brand ritenne che si differenziasse abbastanza dalle altre Gilia per essere assegnata a un nuovo genere, che denominò Aliciella in onore della scopritrice. La proposta di Brand non fu generalmente accettata, e il nuovo genere fu presto abbandonato. Tuttavia, in anni recenti è stato ripristinato sulla base di studi genetici. Appartenente alla famiglia Polemoniaceae, gli sono oggi assegnate oltre venti specie, distribuite in varie aree degli Stati Uniti occidentali, dall'Utah al New Mexico. Sono piccole annuali, biennali e perenni dei deserti o delle montagne, adattate ad ambienti molto specifici, il che le rende fragili e minacciate. Alcune sono anche molto belle, e l'eccessiva raccolta è uno dei pericoli che le insidia. La maggior parte delle specie cresce tra le fessure delle rocce o sui ghiaioni; sono terreni spesso instabili, cui si ancorano penetrando in profondità con le lunghe radici a fittone, talvolta più sviluppate della parte aerea. In questi habitat apparentemente inospitali, dove ben poche piante riescono a crescere, queste fragili bellezze non devono affrontare la concorrenza di altre specie. Mentre le specie annuali sono in genere abbastanza insignificanti, molte tra le perenni sono dei piccoli gioielli dalle fioriture smaglianti. Tra le più notevoli, anche le due più rare: A. caespitosa, un endemismo della Wayne County in Utah che cresce tra le fessure delle rocce di arenaria, oggi nota in solo sei stazioni; e la minuscola e bellissima A. sedifolia delle San Juan Mountains in Colorado, di diffusione così limitata che fino al 2007 si pensava fosse estinta. Ne furono poi scoperte due sole stazioni. Nella scheda qualche informazione anche su altre specie di notevole impatto estetico. Minuscole, tenaci, eleganti, sono tutte perfette per celebrare Alice Eastwood, che non solo amava gli ambienti impervi dove vivono, ma era lei stessa piccola di statura, piena di energia, sempre elegante anche durante le escursioni più avventurose. E da vera signora, non usciva mai senza cappello. Citato per diritto e per traverso, noto anche a chi non ha letto il romanzo, l'incipit di Anna Karenina è uno dei più celebri della letteratura mondiale: "Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo". Eppure sfido il grande Leo a trovare un amore felice simile a quello di Kate e Townshend Brandegee, che si innamorarono a quarant'anni sotto l'egida della botanica e per quasi altrettanti formarono una famiglia felice a modo loro. E a modo suo vive anche Brandegea bigelovii, tenace Curcurbitacea a suo agio nei deserti tra Stati Uniti e Messico.  Townshend prima di Kate, Kate prima di Townshend Fu la botanica a far incontrare Mary Katharine Layne Curran (1844-1920) e Townshend Stith Brandegee (1843-1925), e fu la botanica a farli innamorare. Entrambi erano sulla quarantina, nel pieno di una carriera che ne faceva personalità riconosciute nel loro campo. Ma i veri traguardi li avrebbero raggiunti insieme. Townshend era un ingegnere, ma, figlio di un medico che era anche un agricoltore, fin da bambino si era appassionato di storia naturale e aveva incominciato a creare un erbario. Dopo aver combattuto giovanissimo nella guerra civile, studiò ingegneria, ma anche botanica, alla Yale University’s Sheffield Scientific School; durante gli anni universitari, raccolse piante nella zona di New Haven, incluse alcune specie rare. Dopo la laurea, nel 1871 si trasferì a Cañon City in Colorado, come agrimensore della contea e ingegnere della città; anche qui continuò ad erborizzare, inviando piante a vari corrispondenti, incluso Asa Grey. Anche grazie alla raccomandazione di quest'ultimo, fu assunto come assistente topografo nella spedizione geografica nota come Hayden Survey, che tra il 1871 e il 1873 esplorò l'area che sarebbe diventata il parco di Yellowstone. Poté così lavorare fianco a fianco con il botanico della spedizione, John Coulter. Fu l'inizio di una carriera di ingegnere e topografo, al servizio delle compagnie ferroviarie e del servizio forestale; viaggiando in molte regioni ancora poco note degli Stati Uniti occidentali, ebbe anche occasione di esplorarne la flora. Fu anche incaricato di disegnare le mappe forestali di diverse regioni; nell'inverno 1886-87 fu inviato in California a rilevare le risorse forestali e cercare alcune essenze; visitò le isole di Santa Cruz e Santa Rosa, dove raccolse campioni per Charles Sprague Sargent. La scoperta della particolarissima flora delle isole lo convinse a stabilirsi a San Francisco e ad abbandonare la carriera di ingegnere civile per diventare un botanico a tempo pieno. Per saperne qualcosa di più, visitò l'erbario dell'Accademia delle scienze californiane. E lì avvenne l'incontro fatidico con Kate. Dopo aver raccontato di "Townshend prima di Kate", è dunque ora di parlare di "Kate prima di Townshend". Mary Katharine Layne aveva avuto un'infanzia errabonda. La famiglia Layne era approdata in California all'epoca della corsa all'oro, quando Kate aveva cinque anni, ma aveva continuato a cambiare sede al seguito di un padre inquieto. Nonostante l'educazione discontinua, la ragazza era diventata insegnante e nel 1866, a 22 anni, si era sposata con il poliziotto Hugh Curran, che purtroppo amava alzare il gomito e dopo sei anni la lasciò vedova. Kate, che adesso si chiamava ufficialmente Mary Katharine Curran, decise di trasferirsi a San Francisco e di iscriversi alla scuola di medicina, che aveva appena aperto le porte alle donne; lei fu la terza ad approfittarne. Nel 1878 si laureò. All'epoca, l'insegnamento della tradizionale "materia medica", ovvero della botanica applicata alla farmacia, faceva ancora parte del curriculum di medicina. Grazie a un professore eccezionale, Hans Hermann Behr, un convinto evoluzionista, la giovane donna incominciò ad interessarsi di piante e apprese il metodo rigoroso che poi sempre l'avrebbe contraddistinta. Behr la introdusse all'Accademia delle Scienze e al suo erbario, dove Katharine incominciò a prestare la sua opera come volontaria. Quando scoprì che per una donna era difficile esercitare la professione medica, questo divenne il suo lavoro. Nel 1879 divenne assistente del curatore dell'erbario, Albert Kellogg, e dal 1883, quando egli andò in pensione, gli succedette come curatrice e responsabile del dipartimento di botanica dell'Accademia; era una posizione eccezionale per una donna. All'epoca, nell'intera California, le botaniche professioniste erano solo due. Oltre a lavorare intensamente al riordino e all'accrescimento delle collezioni con escursioni sul campo, per presentare le nuove scoperte la dottoressa Curran ebbe l'idea di creare una rivista che scriveva di fatto da sola, Bulletin of the California Academy of Sciences; ufficialmente era solo la curatrice, e non il direttore responsabile, perché l'Accademia era riluttante a riconoscere che la sua principale pubblicazione era diretta da una donna. Fin a quel momento, l'autorità di Asa Gray e di Harvard era tale che all'Ovest nessuno osava pubblicare una nuova specie senza consultare quell'oracolo. La rivista fornì un veicolo per pubblicare più rapidamente le nuove specie e diede un grande contributo alla coscienza di sé e all'indipendenza della botanica californiana. Determinata, dotata di leadership e grinta, quando incontrò Towshend, la dottoressa Curran era una delle poche donne a dirigere una importante istituzione scientifica, senza tirarsi indietro anche quando si trattava di dare battaglia per conquistare un finanziamento. Vedova, senza figli, divideva il suo tempo tra il lavoro quotidiano all'erbario, la redazione di articoli scientifici e del Bollettino, le spedizioni sul campo.  Un'unione di cuore e di mente Il fatidico incontro tra Towshend e Kate dovette avvenire nell'inverno 1886. Non conosciamo i particolari del loro innamoramento, che dovette essere profondo e fulminante, nonché piuttosto inconsueto per l'epoca, tanto da destare battutine e pettegolezzi. Katharine confessò a una sorella di essere "innamorata in modo folle" e i sentimenti di Townshend, benché fosse un uomo discreto e taciturno, non dovettero essere diversi. Presto decisero di sposarsi, ma lontano dal pettegolo ambiente dell'Accademia; dunque non a San Francisco, ma a San Diego, dove nel maggio 1889 Kate raggiunse Towshend di ritorno dalla sua prima spedizione botanica in Baja California per conto dell'Accademia delle Scienze. Dopo la cerimonia, officiata da un pastore, iniziarono la loro vita di coppia con un inconsueto viaggio di nozze: da San Diego a San Francisco, raccogliendo piante lungo la strada; una bella camminata, se si pensa che le due città sono separate da oltre 800 km! Oltre che innamorati e devoti l'uno all'altro, anche come botanici i Brandegee erano perfettamente complementari. Il punto forte di Towshend era il lavoro sul campo, la vasta conoscenza della flora degli Stati Uniti occidentali acquisita in quasi vent'anni di viaggi e raccolte; quello di Kate, che aveva erborizzato solo nella California centrale, era l'eccezionale competenza di tassonomista. Inizialmente la coppia rimase a San Francisco; Kate, che adesso si firmava Katharine Layne Brandegee, continuò a lavorare all'erbario; Townshend entrò a far parte dell'Accademia delle Scienze. Nel 1890 ricevette una piccola eredità; grazie a questa somma, Kate poté fondare una propria rivista scientifica, Zoe; tuttavia, ufficialmente come direttore responsabile figurava il marito, perché la comunità scientifica non era ancora pronta ad accettare una rivista diretta da una donna. Nel 1891 Katharine fondò il California Botanical Club, aperto anche agli amatori, la prima associazione di questo tipo della West Coast. Entrambi i coniugi intensificarono le attività di raccolta, lui soprattutto in Baja California, lei prevalentemente nella California centrale. Durante un'escursione, Townshend incontrò una giovane botanica canadese, Alice Eastwood, e la presentò alla moglie, che esaminando il piccolo erbario raccolto dalla ragazza a Denver, rimase colpita dalla sua qualità. Rinunciando a una parte dello stipendio, la assunse come assistente, finché nel 1892 l'Accademia l'assunse ufficialmente come curatrice aggiunta. Potendo affidare molto del lavoro di routine ad Alice, ora Katharine poteva concentrarsi su ciò che più la interessava: la descrizione, l'identificazione e la classificazione delle piante. Profondamente consapevole che le specie possono presentare un altro grado di variabilità, secondo l'esposizione, il suolo, le condizioni climatiche, era convinta che, prima di denominare una nuova specie, bisognasse studiarne le crescita in situazioni differenti, raccogliendo e confrontando il maggior numero possibile di esemplari cresciuti in diverse condizioni ambientali. Di conseguenza, non sopportava i botanici egocentrici che moltiplicavano le denominazioni al puro scopo di aggiudicarsi l'effimera gloria di una nuova scoperta. Contro di loro, lanciò i suoi strali su Zoe, divenendo celebre - potremmo dire famigerata - per la ferocia delle sue critiche. Nel suo rigore, arrivò a lamentarsi persino del marito che "ha descritto come nuova una specie contro la mia volontà". Townshend si specializzò nella flora del Messico, in particolare della Baja California, che percorse in numerose spedizioni, divenendone il massimo esperto. Tra aprile e maggio 1893 insieme a altri cinque botanici esplorò la Sierra San Pedro Mártir nella Baja California settentrionale; lo stesso anno, tra settembre e ottobre, fece due viaggi da San Jose del Cabo nelle montagne della regione del Capo; al primo partecipò anche Katharine, che fotografie del tempo ritraggono a cavallo di una mula vestita in abiti maschili. Mentre rientrava da sola da questo viaggio, la sua imbarcazione naufragò. Fu forse considerano questi rischi e la distanza di San Francisco dal Messico che i Brandegee decisero di trasferirsi a San Diego; Katharine diede le dimissioni dall'erbario (come curatrice le succedette Alice Eastwood) e nel marzo 1894 acquistarono un vasto terreno non edificato sull'altopiano alle spalle della città, la mesa, con vista sulla baia di San Diego. Il loro primo pensiero, prima ancora di costruire la casa, fu per l'erbario, per ospitare il quale fecero costruire un padiglione di mattoni, mentre loro vivevano in una tenda. Fu poi la volta della casa e di una serra. Tutto attorno uno straordinario orto botanico, con piante raccolte in natura e portate qui dalle spedizioni della coppia in Messico e nella California meridionale. Era in primo luogo un laboratorio all'aria aperta, dove le piante raccolte durante le spedizioni venivano coltivate riproducendo le diverse condizioni naturali di crescita, in modo da osservarne le variazioni e giungere a una classificazione corretta. Ma era anche un giardino bellissimo, che così è stato descritto da un ospite: "Un paradiso botanico, con fiori rari da tutte le parti, e i canti di tordi beffeggiatori, quaglie e altri uccelli canori nativi a rendere l'aria musicale". Nel 1896, l'appassionato raccoglitore di piante di origine tedesca Carl A. Purpus scrisse a Katharine per chiedere l'identificazione di diverse specie; la cortese ed esperta risposta della botanica fu l'inizio di una collaborazione e di un'amicizia. Da quel memento la casa di San Diego divenne la base delle spedizioni di Purpus in Messico; in cambio, egli arricchì il giardino e l'erbario dei Brandegee con continui invii di piante dei deserti messicani, che i due botanici studiavano, coltivavano, classificavano. Townshend rinunciò alle faticose spedizioni in Messico, ma continuò ad esplorare assiduamente i dintorni di San Diego. Unica eccezione, una spedizione del 1902 in compagnia di Kate Sessions, una intraprendente e creativa vivaista dalla quale i Brandegee al loro arrivo a San Diego avevano acquistato alcune piante. Insieme a lei, Townshend ritornò nella regione del Capo per visitare alcune località trascurate nelle spedizioni precedenti; dopo aver raggiunto San Jose del Capo in battello, si addentrarono sulle montagne a dorso d'asino; fu così che scoprirono una palma ancora ignota, Brahea brandegeei. Lo stesso anno, Sessions fu incaricata dalla Città di San Diego di piantare un nuovo parco (Balboa Park) e convinse il botanico a prestare la sua consulenza per la scelta delle piante. Avvicinandosi la sessantina, i Brandegee cominciarono a pensare al futuro del loro amatissimo erbario, a cui dedicavano molte ore della giornata e che adesso comprendeva circa 76.000 esemplari. Decisero di farne dono, insieme alla biblioteca, all'Università della California a Berkeley, a condizione di poter continuare a lavorarvi fino alla fine dei loro giorni. Nonostante la munificenza del dono, le trattative si trascinarono per quattro anni. I Brandegee dovettero farsi carico anche delle spese di trasporto e non vennero aiutati neppure a trovare una casa. Poco prima della data fissata per il trasloco, nell'aprile 1906, avvenne il disastroso terremoto di San Francisco. Fortunatamente Berkeley e il campus subirono danni limitati e entro la fine dell'anno il trasferimento era completato. Fino a tarda età marito e moglie continuarono a lavorare gratuitamente ogni giorno all'erbario, di cui Townshend era stato nominato curatore onorario, e finché fu possibile continuarono anche le spedizioni botaniche; nel 1913, anche se soffriva di diabete in una forma sempre più grave, Katharine fece ancora una lunga spedizione in California alla ricerca di esemplari-tipo, per sostituire quelli andati perduti nell'incendio di San Francisco. Per molti anni, a occupare le giornate di lui fu anche la pubblicazione delle piante raccolte da Purpus in Messico, nella imponente Plantae Mexicanae Purpusianae, in 12 volumi (1909-1924). Quando completò l'opera, era già rimasto solo. Kate se ne era andata per prima, nel 1920, a 76 anni. Townshend la raggiunse nel 1925. Chi li conobbe durante gli anni di Berkeley, notò che anche da vecchi continuavano a mostrare "lo stesso indomabile amore per il pensiero critico e difficile che li aveva caratterizzati già da giovani". A rimanere invariato fino alla fine era stato anche l'amore reciproco, che li aveva sorprendentemente uniti quasi quarant'anni prima. Una sintesi delle loro vite tutte dedite alla scienza nella sezione biografie.  Brandegea, una deserticola variabile Il lascito di Townshend Brandegee sta soprattutto nelle piante che scoprì nelle sue spedizioni: gli è accreditata la scoperta di circa 225 piante della Baja California. Parecchie lo ricordano nel nome specifico. Abbiamo già incontrato Brahea brandegeei; tra le californiane, aggiungiamo Salvia brandegeei, una notevole Salvia dell'isola di Santa Rosa che è stata anche introdotta nei giardini per il grande valore ornamentale; tra le messicane, Echinocactus brandegei, una specie molto variabile che sembra fatta apposta per confermare le teorie di Katharine Layne Brandegee. Anche Katharine scoprì diverse piante notevoli, come Eriastrum brandegeeae, una rara Polemoniacea della catena costiera californiana. Ma questa grandissima botanica è ancora più importante come ricercatrice, tassonomista, teorica; giocò un ruolo enorme nell'emancipare la botanica californiana e diede un contributo altrettanto incisivo agli studi tassonomici, soprattutto sul piano metodologico. Di valore incalcolabile è poi il lascito comune di entrambi: il grande erbario ora custodito a Berkeley. Quanto al giardino di San Diego, purtroppo passò in altre mani che lo lasciarono morire, e non ne rimane nulla. Né Townshend né Katharine cercavano fama e onori; a loro interessava unicamente il progresso della scienza. Così la piccola pianta del deserto che li celebra appare straordinariamente adatta a ricordarli. A rigori, fu dedicata solo a lui, ma poiché vive sia in California sia nel Messico settentrionale, le aree di cui i due botanici erano specialisti, possiamo considerarlo un omaggio a entrambi. Durante la sua prima spedizione in Baja California, Townshend raccolse una cucurbitacea dai fiori molto minuti che pubblicò come Cyclanthera monosperma Brandegee; poco dopo, l'importante tassonomista belga Célestin Alfred Cogniaux, esperto di Cucurbitaceae, la unì a una specie già nota come Elaterium bigelovii S. Watson, creando il genere Brandegea con due specie, B. bigelovii (S.Watson) Cogn. e B. monosperma (Brandegee) Cogn. Oggi al genere Brandegea, una liana della famiglia Cucurbitaceae, con profondissime radici a fittone, sottili fusti volubili, piccole foglie verde scuro profondamente palmate, ma molto variabili nella forma e nelle dimensioni, piccolissimi fiori bianchi con cinque petali appuntiti, minuscoli frutti secchi spinosi, è assegnata una sola specie, B. bigelovii. Come molte piante del deserto, che devono affrontare condizioni estreme e molto differenziate nel corso delle stagioni e da un anno all'altro, anch'essa è estremamente variabile, tanto che in passato i botanici, meno prudenti di Katharine Layne Brandegee, le avevano assegnato almeno quattro specie, con una foresta di sinonimi. E' dunque anch'essa una conferma vivente della correttezza del metodo di questa grande botanica, che ne diventa così la co-dedicataria onoraria. Qualche approfondimento nella scheda. Quando scoprì la vocazione di naturalista, Ynés Mexía aveva superato la cinquantina, e usciva da un decennio di depressione e instabilità emotiva. Grazie alle piante, ritrovò l'amore per la vita e divenne una raccoglitrice formidabile. Nel breve arco di tredici anni - tanto durò la sua carriera - percorse le America dall'Alaska alla Terra del fuoco, raccolse oltre 145.000 esemplari, scoprì 500 nuove specie e un nuovo genere (che le è stato dedicato con il nome Mexianthus); coraggiosa, tenace, caparbia, preferiva mete non battute, viaggiando per lo più da sola in modo spartano. A chi dubitava che una donna potesse farlo, nell'America latina di quasi un secolo fa, rispondeva semplicemente "Perché no?" 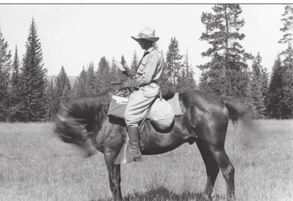 Dare senso alla vita raccogliendo piante La vita può ricominciare anche a cinquant'anni, quanti ne aveva Ynés Mexía quando scoprì la sua vera vocazione. Nata negli Stati Uniti da un diplomatico messicano e una statunitense, aveva avuto una vita abbastanza complicata a cavallo tra i due paesi. In crisi per la separazione dal secondo marito, che prima del divorzio l'aveva anche rovinata economicamente, si era trasferita a San Francisco. Per un decennio, fu afflitta da una grave forma di depressione. Quando aveva quasi cinquant'anni, decise di iscriversi al Sierra Club e, partecipando ad escursioni all'aria aperta insieme a persone innamorate della natura, incominciò a recuperare la salute del corpo e dello spirito. La natura californiana l'affascinò tanto che nel 1921, a cinquantun anni, decise di iscriversi al corso di Scienze naturali all'Università di Berkeley. Nel 1922, partecipando a una spedizione paleontologica, scoprì il fascino delle piante e della loro raccolta; si iscrisse a un corso sulle piante da fiore presso la Hopkins Marine Station e prese parte alle escursioni organizzate dal Calipso Club, il club degli studenti di botanica. Sicuramente determinante fu l'incoraggiamento di Alice Eastwood, curatrice dell'erbario dell'Accademia della Scienze californiana e capo del dipartimento di botanica, che le insegnò come raccogliere e preparare gli esemplari. La prima spedizione ufficiale arrivò nel luglio 1925; Mexía, che quell'anno compiva 55 anni, si unì a un viaggio botanico nello stato di Sinaloa in Messico organizzato dall'Università di Stanford e guidato da un'altra botanica, Roxanna Ferris. Come oriunda messicana, conosceva bene la lingua e il paese, ma soprattutto rivelò un vero talento come raccoglitrice: aveva un occhio acuto nel riconoscere le piante ed era molto meticolosa e abile nel preparare gli esemplari. Ne aveva già raccolti più di 500, quando cadde da una scogliera, ferendosi una mano e fratturandosi alcune costole. Dovette forzatamente abbandonare la spedizione, ma al suo ritorno negli Stati Uniti, impressionato dalla qualità delle sue raccolte, il capo dell'erbario dell'Università della California le commissionò un secondo viaggio, di nuovo in Messico. Strinse anche amicizia con un'assistente dell'Erbario dell'Accademia delle Scienze della California, Nina Floy Bracelin, che si offrì di aiutarla a catalogare le future raccolte. A questo punto, Ynés Mexía era ormai una raccoglitrice professionista, con un lavoro che dava senso alla sua vita: "Ho un lavoro che produce qualcosa, e qualcosa di duraturo". Nel settembre 1926 si imbarcò alla volta di Mazatlan sulla costa pacifica del Messico, da dove iniziò una spedizione di sei mesi in zone dell'interno poco conosciute; viaggiava sola, servendosi di guide locali, che erano anche ottimi informatori. Muovendosi ora a piedi ora a cavallo, alla fine del viaggio, nell'aprile 1927, aveva raccolto oltre 3000 esemplari, tra cui 50 specie non ancora descritte, e un genere sconosciuto, che in suo onore sarà denominato Mexianthus. Mexía, che non amava il lavoro di scrivania e definiva se stessa più un'avventuriera che una botanica, affidò la "post produzione" a Nina Floy Bracelin, che riordinava le collezioni, etichettava gli esemplari e li inviava ad esperti per l'identificazione; in tal modo divenne anche la sua agente e mantenne i rapporti con una vasta rete di botanici. Nell'estate del 1928, sempre per l'Università della California, si spostò in Alasaka, nel Mount Mc Kinley Park, dove raccolse oltre 6000 esemplari. Alla fine dello stesso anno, fu in Messico per la terza volta. Nell'autunno del 1929, si imbarcò per il Brasile, dove esplorò le terre alte per circa un anno e mezzo; per qualche tempo, si accompagnò con un'altra botanica autodidatta come lei, Mary Agnes Chase, un'esperta di graminacee; ma tutte e due erano troppo testarde per andare d'accordo, tanto più che Mary Agnes preferiva viaggiare in treno e dormire in un albergo decente, mentre Ynés era a suo agio viaggiando a cavallo e dormendo sotto una tenda. Ancora il Brasile fu la meta della spedizione del 1931, quella più celebre; l'obiettivo era risalire il corso del Rio delle Amazzoni. La prima parte della navigazione si svolse a bordo di un comodo piroscafo, un vero lusso rispetto alle abitudini di questa viaggiatrice spartana. Dopo 24 giorni, Mexía sbarcò a Iquitos in Perù, assunse tre guide e quattro rematori, per risalire il Maranon in canoa: era esattamente il percorso fatto da La Condamine nel Settecento, ma al contrario: non lasciarsi trasportare dalla corrente del grande fiume, ma risalirlo remando controcorrente: una scelta audace perfettamente in linea con il carattere di Ynès. Dopo aver superato il temibile Pongo de Manseriche , all'inizio della stagione delle piogge Mexía stabilì la sua base a Rio Santiago; esplorò il fiume e i suoi affluenti, scalò la Sierra del Pongo, senza farsi spaventare dalle pareti a strapiombo. E ovviamente, raccolse piante su piante. L'ingrossamento delle acque rendeva impossibile affrontare il viaggio di ritorno in canoa; Mexía convinse i rematori a costruire una grande zattera di legno di balsa. A bordo di questa imbarcazione scese il fiume fino a Iquitos, da dove spedì le raccolte in California. Lei prese un'altra strada: prima in aereo, poi a dorso di mulo, quindi in automobile, infine in treno, arrivò a Lima dove si imbarcò per San Francisco; era di ritorno nel marzo 1932. Questa spedizione, probabilmente la più importante tra quelle intraprese dall'indomita raccoglitrice, fruttò 65.000 esemplari. Non rimase a casa a lungo. Nel 1933 si accontentò di una breve spedizione casalinga in Nevada, Utah, Arizona e California con Alice Eastwood e il suo assistente, John Thomas Howell, a bordo di una Ford T. Tuttavia già nel 1934 tornò in Sud America per incarico dell'Ufficio per le piante industriali del Dipartimento di Agricoltura che aveva stabilito una stazione sperimentale in Ecuador; il suo compito era raccogliere le diverse specie di Cinchona e soprattutto cercare una rara palma della cera, Ceroxylum ventricusum, che vive a oltre 3000 metri d'altitudine nelle foreste pluviali d'altura tra Colombia e Ecuador. Con un assistente viaggiò in treno da Quito a Ibarra, poi in automobile fino a Tulcàn, dove assunse una guida locale e affittò dei cavalli per risalire le pendici del Chiles, un vulcano al confine tra i due paesi, dove era stata segnalata la pianta. La pioggia incessante li costrinse ad accamparsi in una torbiera, creando una tenda improvvisata con vestiti e bagagli; nel cuore della notte, furono risvegliati da un terremoto. Come se non bastasse, Ynés rischiò di morire per aver ingerito alcune bacche avvelenate. Per fortuna, uno degli accompagnatori riuscì a fargliele rigettare solleticandole la gola con una piuma di gallina. Tutti ormai volevano tornare indietro, tranne l'ostinata cacciatrice di piante, che convinse gli altri a continuare. E alla fine, trovò la sospirata palma. Il suo viaggio proseguì poi attraverso il Perù, la Bolivia, l'Argentina, il Cile fino allo Stretto di Magellano, con la raccolta di altri 15.000 esemplari. Nel 1938, l'ultima spedizione, di nuovo in Messico, questa volta negli Stati di Guerrero e Oaxaca. Ynés, che probabilmente era malata da tempo senza saperlo, incominciò a soffrire di dolori allo stomaco, che la costrinsero riluttante a rientrare negli Stati Uniti, dove le diagnosticarono un cancro ai polmoni; morì appena un mese dopo. Del resto, lei che nelle sue spedizioni preferiva dormire all'aperto anche quando era disponibile una sistemazione più comoda, non si sarebbe rassegnata a una lunga degenza in un ospedale. Nel suo testamento, lasciò un lascito all'Accademia delle Scienze, in modo che la fedele Nina fosse assunta come assistente di Alice Eastwood. Ynés Mexía fu sicuramente il più importante raccoglitore della flora sudamericana della sua epoca. Un risultato tanto più straordinario se si pensa che la sua carriera durò solo tredici anni, dal 1925 al 1938. Percorrendo il continente dall'Alaska alla Terra del fuoco, raccolse oltre 145,000 esemplari, incluse 500 nuove specie, 50 delle quali portano il suo nome. Anche se non si laureò mai, era spesso invitata a parlare dei suoi viaggi, di cui pubblicò resoconti in varie riviste, e il suo nome divenne molto conosciuto tra i botanici. Occasionalmente partecipò a spedizioni di gruppo, ma, come abbiamo già visto, preferiva viaggiare da sola (cosa inaudita per una donna a quei tempi), come spiegò essa stessa: "Un ben noto raccoglitore e esploratore ha asserito che era impossibile per una donna viaggiare da sola nell'America Latina. Io ho deciso che se volevo conoscere meglio il continente sud-americano il modo migliore era aprirmi la strada da me. Bene, perché no?". Una sintesi della sua vita avventurosa nella sezione biografie.  A caccia di piante rare: Mexianthus mexicanus Buona parte delle piante scoperte da Ynés Mexía sono rari endemismi, spesso minacciati. Del resto, come abbiamo visto, preferiva andarle a scovare in territori difficili da raggiungere, ancora inesplorati o almeno poco battuti. Non fa eccezione Mexianthus, il genere che raccolse nella sua prima spedizione solitaria, nel 1925, e che le fu dedicato nel 1928 da Benjamin Lincoln Robinson dell'Erbario di Harvard, con la seguente motivazione: "E' un piacere dedicare questa notevole pianta alla sua scopritrice, la sig.a Ynes Mexia, la cui coraggiosa esplorazione di parti poco note della Sierra Madre ha portato alla luce molte piante sconosciute alla scienza o altrimenti di speciale interesse". Nella flora messicana, che conta ben 30.000 specie, il dieci per cento è costituito da Asteraceae, con circa 3000 specie e ben 1300 endemismi. Tra di essi anche il raro Mexianthus mexicanus, l'unica specie di questo genere endemico dello stato di Jalisco, dove è stato raccolto solo in tre stazioni nei pressi di Puerto Villarta, a circa 500 metri d'altitudine, dove vive su substrato vulcanico nelle foreste subtropicali decidue. Purtroppo in rete sono disponibili solo fotografie di esemplari d'erbario. E' un'alta perenne suffruticosa, con foglie alternate da ovate a ellittiche, con punta acuminata e margini dentati. A renderla speciale sono le infiorescenze, con capolini con un singolo flosculo e corolla bianca, riuniti in sinfiorescenze globose, a loro volta portate in un'infiorescenza secondaria terminale a spiga sparsa. I frutti sono acheni con pappi scagliosi. Una breve presentazione nella scheda. Sarà perché iniziano a fiorire già in inverno, sarà perché crescono in fretta e si arrampicano dappertutto, sarà per l'allegria dei loro grappoli viola: fatto sta che nel mondo anglosassone i rampicanti del genere Hardenbergia sono noti con il nome comune happy wanderer, "vagabondo felice". Anche l'uomo che suggerì il nome botanico, il barone Hügel, era un vagabondo, o almeno un viaggiatore, ma tutt'altro che felice; si era messo in viaggio per guarire dal mal d'amore. Per sua volontà, l'allegra vagabonda è stata dedicata a sua sorella, la contessa von Hardenberg, sulla quale - come capita troppo spesso alle donne - sappiamo davvero troppo poco. Un cuore infranto e un viaggio intorno al mondo Nel bel mondo della Vienna effervescente degli anni venti dell'Ottocento, che il congresso omonimo aveva trasformato nella capitale europea della diplomazia e del walzer, il barone Carl von Hügel era una figura molto nota. Come il fratello maggiore, direttore dell'Archivio di Stato, apparteneva al circolo del cancelliere Metternich. In gioventù, oltre a combattere con onore nelle campagne contro Napoleone, aveva molto viaggiato in Europa, sviluppando un raffinato gusto di collezionista e una grande passione per le piante. Dopo la morte del padre, nel 1826, venuto in possesso di un cospicuo patrimonio, acquistò una vasta proprietà nel sobborgo viennese di Hietzing; vi fece costruire una splendida villa e creò un giardino botanico privato, dove sperimentava la coltivazione di piante esotiche. Intorno al 1830, si fidanzò con una bella e volitiva contessa ungherese, Melanie Zichy-Ferraris. Ma la madre di lei mise gli occhi su un partito molto più promettente: niente meno che il principe Metternich, da poco rimasto vedovo per la seconda volta. Melanie riuscì a fare breccia nel suo cuore e ruppe il fidanzamento con Hügel per sposarsi con il cancelliere (che aveva trentadue anni più di lei). Tradito dalla donna amata e da un uomo che ammirava e considerava un amico, a Hügel non restava che partire. Non per l'Europa, che del resto conosceva già bene, ma per il Levante e oltre. Per prepararsi al viaggio, visitò brevemente l'Inghilterra e la Francia, e nel maggio 1831 si imbarcò a Tolone alla volta delle Grecia. Visitò poi Creta, Cipro, la valle del Nilo, la Palestina e la Siria. Nella primavera del 1832 era in India. Visitò Decca, Goa, Mysore, scalò le Blue Mountains, e percorse la costa del Malabar da Travancore a Capo Camorin. Passò poi a Ceylon, dove si trattenne quattro mesi. Seguendo la costa del Coromandel raggiunse Pondicherry e Madras, da dove si imbarcò per l'Indonesia e l'Australia. Nell'Australia occidentale Hügel intendeva raccogliere semi e piante per il suo giardino. Il primo impatto con il paesaggio australiano, allo sbarco nel porto di Fremantle nel novembre 1833, fu una cocente delusione: "Mi aspettavo fiduciosamente praterie verdi immacolate, alberi e arbusti coperti di fiori e frutti all'inizio dell'estate australe, tutto il paese un quadro della Natura non toccato dall'uomo". Invece ciò che vide era una terra "totalmente priva di vita", grigia, dove "tutto era immobile escluso il mare ribollente e minaccioso". Ma tutto cambiò quando si inoltrò nel bush: "A poche centinaia di passi dalla città inizia la vegetazione. La particolarità delle piante della Nuova Olanda è che la bellezza delle forme e i colori dei fiori si rivelano solo quando li si osserva attentamente a breve distanza. Dunque, la ricchezza e la varietà della flora in tutto il suo splendore colpisce l'occhio solo a uno sguardo ravvicinato. Il triste grigio-verde si trasforma nelle più varie sfumature di verde, dal più chiaro e luminoso al più scuro e lussureggiante, mescolati a fiori brillanti di ogni tipo, in numero indicibile. Mi aggiravo in quel mondo di colori come intossicato". Stranamente, è un mondo allo stesso tempo estraneo e familiare: estraneo per la sua inattesa varietà e bellezza, familiare perché il barone incontra ad ogni passo piante che già conosce, per averle coltivate nel suo giardino. Infatti, la bellezza delle flora dell'Australia occidentale non era sfuggita ai primi coloni, e diverse specie avevano incominciato a fare la loro comparsa nelle serre europee fin dalla fine del Settecento. Immerso in quella flora di sogno, il nostro viaggiatore infelice ritrova la felicità: "Per la prima volta dopo anni - lunghi anni penosi - vissi per un'ora nella piena delizia del momento. La mano sinistra stringeva un enorme mazzo di splendidi fiori, mentre la destra ancora si protendeva a raccogliere varietà sempre nuove". Il barone si trattenne circa un mese nell'area dello Swan River, esplorandone la foce, le isole all'imboccatura, i dintorni di Perth e spingendosi all'interno fino a Darlington e alle colline della Darling Scarp. Continuò poi per mare lungo il King George Sound, visitando l'area di Albany, incluse le valli inferiori del King River e del Kalgan River. Raccolse centinaia di specie, ma a colpire il suo cuore più di ogni cosa furono i grappoli rossi e viola di alcune leguminose rampicanti, su cui torneremo. Il suo viaggio australiano proseguì fino all'ottobre 1834, toccando la Terra di Van Demen (ovvero la Tasmania), l'Isola Norfolk e il Nuovo Galles del Sud. Seguirono la Nuova Zelanda, Manila e nuovamente l'India. Lo attendeva la parte più importante della spedizione: il lungo viaggio che da Calcutta lo portò ad attraversare l'India settentrionale, fino al Punjab, con un'ampia deviazione fino alle alte terre himalayane al confine tra Tibet e Kashmir. Sempre accumulando ricche collezioni di materiali di ogni genere, osservando usi e costumi, visitando personalità incluso il Maharaja Ranjit Singh, acquisì una profonda conoscenza, per molti aspetti inedita, della storia, della geografia fisica e umana, della natura, delle risorse economiche del Kasmir. Dalla terra dei Sikh, scese a Delhi, quindi a Bombay, dove nel 1836 iniziò il viaggio di ritorno. Attraverso il Capo di Buona Speranza e l'isola di Sant'Elena, nel 1837, dopo sei anni di assenza, era di nuovo a casa, dove poté riabbracciare la madre. 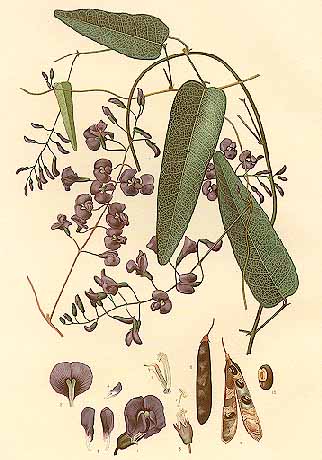 Piante australiane ed altre avventure Ora giungeva il tempo dello studio e del riordino della collezioni. Insieme a lui, a Vienna erano arrivate centinaia e centinaia di casse di opere d'arte, oggetti etnologici, animali impagliati, esemplari d'erbario. E finalmente entra in scena la dedicataria della nostra pianta. Per riordinare le collezioni botaniche, il barone si affidò alla sorella minore, Franziska detta Fanny, che durante la sua assenza si era sposata con il conte Anton August von Hardenberg, ed era ora la contessa von Hardenberg. Poco sappiamo di lei, tranne che assolse il compito con zelo e che dovette avere qualche conoscenza di botanica se Bentham (cui, come vedremo, si deve la dedica) dice di lei "con il suo ingegno orna la nostra scienza". Il barone divideva il suo tempo tra la stesura del suo capolavoro, Kaschmir und das Reich der Siek ("Il Kasmir e il regno dei Sikh"), in quattro volumi (1840-48), grazie al quale nel 1849 fu premiato dalla Royal Geographical Society come "intraprendente esploratore del Kashmir", gli impegni mondani, la cura del giardino e la promozione dell'orticultura austriaca. Ad occuparsi di pubblicare la sua collezione di piante australiane, riordinata con tanta cura da Fanny, fu un gruppo di botanici capeggiato da Stephan Endlicher: oltre allo stesso Enclicher, ne facevano parte l'inglese George Bentham e gli austriaci Eduard Fenzl e Heinrich Schott. Il risultato fu Enumeratio plantarum quas in Novae Hollandiæ ora austro-occidentali ad fluvium Cygnorum et in sinu Regis Georgii collegit Carolus Liber Baro de Hügel (1837), in cui vennero pubblicate quasi trecento specie raccolte dal Barone tra lo Swan River e il King George Sound. Tra di esse, le amate leguminose del Fiume dei Cigni. In realtà, non erano una novità assoluta in Europa, perché già da qualche anno alcune specie erano arrivate nelle serre europee, classificate come Glycine poi come Kennedia. Sulla base delle sue raccolte in Australia, Hügel suggerì a Bentham (che si occupò della pubblicazione delle Leguminose) di dividerle in quattro generi: oltre a Kennedia, Physolobium, Zichya e Hardenbergia. Due di questi nuovi generi dovevano ricordare le due donne più importanti della sua vita: la mai dimenticata ex fidanzata Melanie Zichy-Ferraris e la sorella Fanny, ora contessa Hardenberg. Provvide egli stesso a creare il genere Zichya sulla rivista della società botanica austriaca, mentre Hardenbergia venne pubblicata da Bentham appunto in Enumeratio plantarum. Per inciso, oggi sia Physolobium sia Zichya sono stati riassorbiti da Kennedia, mentre Hardenbergia continua da essere riconosciuto come un genere indipendente, come vedremo meglio tra poco. Ma prima di concludere, ancora due parole sul barone e sua sorella Fanny. Le cronache del tempo descrivono il giardino di Hietzing come uno dei più belli d'Europa, ricco di piante esotiche riportate dal viaggio intorno al mondo. All'ingresso, di fronte al soggiorno, circondata da pilastri con piante rampicanti, c'era una terrazza pavimentata, con una grande varietà di piante coltivate tra le lastre, e aiuole con bulbi, erbacee ed arbusti scelti con grande cura perché fiorissero quasi tutto l'anno, tra cui una notevole collezione di camelie; un prato con molti alberi e arbusti esotici; serre fredde e riscaldate con la collezione di piante australiane. Non mancava un orchidarium, che nel 1842 contava 83 generi e quasi 200 specie. Molto ammirato era il cosiddetto Giardino rococò, con aiuole formali bordate di tufo, parterre, fontane e statue. Il barone si dava da fare per diffondere il gusto per il giardinaggio e le piante esotiche non solo con l'esempio; riprendendo un progetto che già accarezzava prima di partire, nel 1837 fondò la Österreichische Gartenbau-Gesellschaft, la società di giardinaggio austriaca, di cui dettò lo statuto e fu il primo presidente. Le prime mostre organizzate dalla società si tennero proprio nel parco di Hietzing. Gli eventi del 1848 misero fine a un tranquillo decennio di studio e giardinaggio; Hügel riprese servizio nell'esercito e partecipò alla guerra in Italia (dal nostro punto di vista, la prima guerra d'Indipendenza); era però a Vienna nei giorni tumultuosi in cui Metternich rischiò di essere linciato dalla folla e, insieme all'amata Melanie, lo portò in salvo nascondendolo nella sua carrozza. Forse disgustato da questi eventi, abbracciò la carriera diplomatica, servendo per molti anni prima a Firenze, poi a Bruxelles. Quando si ritirò, preferì trasferirsi in Inghilterra insieme alla moglie, un'irlandese molto più giovane di lui che aveva conosciuto in India e sposato a Firenze, e ai figli. Il giardino e la villa, passati di mano in mano, fatalmente andarono in rovina e vennero dispersi dalla lottizzazione. Quanto a Fanny, la sua vita ha lasciato ben poche tracce nelle cronache del tempo. Sappiamo che, dopo il matrimonio con il conte von Hardenberg, un gentiluomo della corte di Hannover, lo accompagnò nelle varie sedi cui fu assegnato (le fonti dell'epoca citano Berlino e Dresda) e soggiornò spesso nella tenuta di campagna di Rettkau, in Slesia. Proprio qui si rifugiò e morì il fratello maggiore, Clemens Wenzel, collaboratore di Metternich, travolto dalla disgrazia del cancelliere. Nel 1849 Franziska rimase vedova e, presumibilmente senza figli, decise di raggiungere Carl, vivendo per qualche tempo nella sua casa di Vienna, per poi trasferirsi insieme a lui a Firenze. Qui morì nel 1852. Una sintesi di queste poche notizie nella sezione biografie.  Finalmente, Hardenbergia Ovviamente, anche il barone Hügel, come raccoglitore e collezionista, nonché promotore dell'orticoltura, ha avuto la sua parte nella nomenclatura botanica. Un genere Huegelia gli fu dedicato sia da Robert Brown, sia da Reichenbach, sia da Bentham; nessuno dei tre è oggi accettato. A resistere più a lungo è stato forse Huegelia Rchb., oggi confluito in Trachymene Rudge. La specie più nota è probabilmente Trachymene coerulea, spesso ancora indicata con il sinonimo Huegelia coerulea. Un manipoli di piante neppure troppo esiguo ricorda invece il barone nel nome specifico: sono per lo più australiane, come Alyogyne huegelii, il cosiddetto ibisco blu, oppure Melaleuca huegelii. Ed eccoci infine arrivati alla nostra protagonista verde, la felice vagabonda Hardenbergia. Appartenente alla sottotribù Kennediinae della famiglia Fabaceae, è in effetti molto affine a Kennedia; le piante di entrambi i generi sono liane originarie dell'Australia. Ad Hardenbergia sono assegnate tre specie: H. comptoniana, nativa dell'Australia sudoccidentale (che è la specie raccolta da Hügel lungo lo Swan River); H. perbrevidens, endemica del Queensland; H. violacea, nativa dell'Australia meridionale e orientale. Rampicanti, volubili o ricadenti, sono sempreverdi con foglie alterne, ovate ma anche palmate, piuttosto coriacee; a fine inverno e all'inizio della primavera producono copiose pannocchie di fiori papilionacei dai colori sgargianti: da malva a porpora con marcature bianche H. comptoniana; da malva a viola scuro con marcature gialle al centro la rara H. perbrevidens; da viola a porpora, ma anche rosa e bianchi H. violacea. Questa è la specie più coltivata e ne sono state selezionate molte cultivar, compresa una bicolore. Viene coltivata all'aperto dove non gela, come nella nostra riviera, altrove in serra temperata o in posizione protetta contro un muro. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|



 RSS Feed
RSS Feed