|
Morto a soli 35 anni senza aver pubblicato nulla, il botanico inglese Edmund Davall - visse però gran parte della sua vita adulta in Svizzera - non avrebbe lasciato molte tracce di sè se non fosse stato amico e assiduo corrispondente di James Edward Smith, presidente e fondatore della Linnean Society. Una selezione delle sue lettere, pubblicata nelle memorie di Smith, ci fanno conoscere da vicino questo giovane di grande sensibilità e humour, un vero figlio del preromantcismo diviso tra l'entusiasmo per la natura e la malinconia di quello che considerava un vero e proprio esilio. Grazie a Smith, a ricordarlo ci sono soprattutto le bellissime felci del genere Davallia. Una vita attraverso le lettere Nel 1832, la vedova di James Edward Smith, Pleasance Reeve Smith, completò e pubblicò le memorie del defunto consorte, che includono una scelta della sua ampissima corrispondenza. Come sottolineava Mme de Lessens nella sua recensione di Memoirs and Correspondence of Sir James Edward Smith, "tra i corrispondenti più gradevoli di Mr. Smith, c'è un giovane svizzero, Mr. Davall di Orbe, entusiasta della botanica, della natura e del grande apprezzamento che ricevono in Inghilterra. Le sue lettere sono assai piacevoli". Queste lettere sono quasi tutto ciò che rimane di questo sfortunato botanico, morto troppo presto e senza aver potuto pubblicare nulla. Al contrario di quanto scrive Mme de Lessens, Edmund Davall (1762-1798) non era propriamente svizzero, ma piuttosti anglo-elvetico. Era infatti nato a Londra dall'omonimo Edmund Davall, ufficiale di approvvigionamento dell'ammiragliato, e da Charlotte Thomasset, figlia di una vedova svizzera che si era trasferita nella capitale inglese dove insieme alle sue figlie gestiva con un certo successo una scuola per giovinette. Come racconta egli stesso in una delle sue lettere al "più caro degli amici" Smith, benché avesse un'inclinazione per le scienze naturali, il loro studio non aveva fatto parte della formazione del giovane Edmund. Si interessava però di giardinaggio, e aveva acquistato una copia di The Gardeners Calendar di Miller, dove per la prima volta vide uno schema del sistema linneano, Ne fu "istantaneamente ispirato" e decise di "perseguire uno studio che certamente mi avrebbe procurato maggior felicità di qualsiasi progetto volto a un vantaggio pecuniario". Iniziò dunque a studiare la botanica da autodidatta e nel febbraio 1784 arrivò in Svizzera, deciso a esplorare la flora delle sue montagne. Si stabilì a Orbe, nella casa delle sue numerose zie Thomasset che erano tornate in Svizzera intorno al 1777; pochi mesi dopo, il padre morì in seguito a un'ampitazione e la madre decise di tornare in patria. Quattro anni dopo sarebbe morta anche lei, lasciando definitivamente legato il figlio a Orbe e alle "buone vecchie zie", di cui nelle lettere egli traccia un memoriabile ritratto dolce-amaro. Se in Inghilterra erano considerate povere, in Svizzera un piccolo patrimonio e qualche terra al sole le facevano senz'altro rientrare nella "bonne societé". Amavano ricevere e trascorrevano ore intere a giocare alle carte. A sentire il nipote, il jeu de Quadrille era la loro unica passione e il loro unico argomento di conversazione, al punto che una di loro sarebbe "letteralmente morta con le carte in mano". La migliore stanza della casa era dedicata alle interminabili partite di carte che riunivano il "gregge troppo numeroso" della buona società di Orbe, "eternamente desideroso di ammazzare il tempo che non sapeva come impiegare" e che esprimeva "la sua stima per chi aveva interessi intellettuali con un'alzata di spalle". Per sfuggire alla noia, Davall si gettò più che mai nella botanica. Creò un giardino che curava personalmente e intensificò le escursioni alla ricerca di piante da trapiantare e da montare nel suo erbario. Orbe sorge in un'amena posizione nel cuore del Giura svizzero; con una breve passeggiata si può raggiungere la cima del Suchet, dalla quale si gode uno splendido panorama sugli altopiani del Giura e su tutto l'arco alpino. Sulle sue pendici calcaree Davall trovò una flora particolare e interessante. Nell'estate del 1787 scoprì alcune piante rare in compagnia di Albrecht von Haller junior, il figlio omonimo del grande von Haller. Davall avea infatti cominciato a farsi conoscere nell'ambiente dei botanici svizzeri, in ciò incoraggiato da Charles Victor de Bonstetten, ultimo balivo di Nyon e membro del "gruppo di Coppet", un sodalizio intellettuale informale che si riuniva attorno a Mme de Stael e Benjamin Constant. Entrò così in contatto con il pastore e naturalista di Berna Jakob Samuel Wyttenbach, con il pastore, bibliotecario e botanico di Ginevra Jean Senebier e con il professore di anatomia e botanica dell'Università di Basilea Werner de Lachenal. Saussure nel suo Voyage dans les Alpes ricorda di avergli fatto visita ad Orbe. Nel 1784, munito di lettere di presentazione di Wyttenbach e Senebier, Davall partì per Londra e si presentò a James Edward Smith che aveva da poco creato la Linnean Society. Smith lo accolse con grande affabilità, lo ospitò in casa sua, lo presentò ai suoi amici e lo fece entrare nella Linnean Society, di cui Davall fu così uno dei primissimi membri. Da parte sua, Davall intodusse Smith presso la marchesa di Rockingham, con la quale forse era in contatto grazie alla posizione del padre all'ammiragliato. La nobildonna, grande appassionata di piante esotiche, avrebbe poi ispirato a Smith le magnifiche Icones pictae, in cui Sowerby ritrasse numerose piante coltivate nelle serre e nei giardini di Hillingdon. I giardini inglesi con le loro collezioni di piante esotiche, le società scientifiche con le loro animate discussioni, la grande considerazione in cui era tenuta la botanica entusiasmarono Davall e fecero del soggiorno londinese "il periodo più memorabile e felice della mia vita", nonostante cominciassero già amanifetarsi imprimi segni di una salute malferma. Lui e Smith erano quasi coetanei e strinsero una profonda amicizia, destinata a durare quanto la sua vita, anche se dopo il suo ritorno a Orbe non si sarebbero mai più incontrati. Continuarono invece a scriversi con assiduità; le lettere di Davall, pervase dall'entusiasmo e dal sentimento religioso per la natura, ma anche da quello che egli stesso definisce mal du pays, ovvero dalla nostalgia per l'Inghilterra, piacevolissime e spesso piene di humour, informano di gioie e dolori (il matrimonio, la nascita dei figli, la dolorosissima morte della primogenita a soli undici mesi), dei fastidi di una piccola vita di provincia, delle aspirazioni intellettuali presto frustrate da un ambiente chiuso, dalle necessità pratiche, ma soprattutto da una salute sempre più traballante. Nella casa di Orbe, dove il salotto buono rimaneva intoccabile santuario all'eterno gioco di carte, poté ricavare per sè solo un piccolo studio, dove un "angolo sacro" riuniva le opere di Linneo, il suo modesto erbario e due prezosi cimeli incorniciati sotto vetro: un esemplare di Diapensia lapponica, raccolto da Linneo in persona, dono dell'amico Smith ("un frammento della vera croce è meno prezioso per un cattolico bigotto"), e uno di Smithia sensitiva. Una grande fonte di piacere era il giardino, che egli coltivava di persona dedicandogli molto tempo e cura; e un'altra le escursioni botaniche in montagna. Ne riportava piante per il suo giardino ed esemplari che essiccava per il suo erbario e che spediva regolarmente all'amico Smith. Visitò ripetutamente il Suchet, ma le lettere documentano anche viaggi a più ampio raggio: attraversò il ghiacciaio di Valsorey nel Vallese alla ricerca di una pianta segnalata da von Haller e si spinse fino al Gran San Bernardo. Sappiamo che lavorò a lungo a un saggio sulla flora svizzera, ma non riuscì a terminarlo. Più ancora delle contingenze della vita materiale, a impedirglielo furono i problemi di vista sempre più gravi e una salute sempre più precaria. Le lettere stesse incominciarono a diradarsi. Davall iniziò l'ultima il 13 febbraio 1798. Ma ormai stava così male che non poté finirla; Smith l'avrebbe ricevuta solo dopo la sua morte. Certo avrà letto con grande commozione le ultime righe: "a lungo la mia più cara e unica speranza è stata quella di incontrare il mio amico in un mondo diverso e migliore". A informarci degli ultimi mesi di Davall sono le lettere a Smith di un altro amico comune: il veterinario Bracy Clark. Tra il 1797 e il 1798 egli fu impegnato in un grand tour continentale, anche se le condizioni di guerra gli impedirono di visitare la Francia. Soggiornò invece per qualche tempo in Svizzera; nel dicembre 1797 a Berna fece visita a Wyttenbach che lo informò che l'amico di Smith Davall aveva sofferto gravemente, forse di una paralisi, e gli scrisse una lettera di presentazione per lui. Il cattivo tempo e copiose nevicate impedirono a Clark di recarsi ad Orbe fino alla fine di marzo. Davall lo accolse cordialmente e lo ospitò a casa sua; era assai provato nel corpo e profondamente turbato dalla situazione politica, con i venti della rivoluzione che soffiavano anche in Svizzera. Durante l'estate, che Clark trascorse per lo più a Orbe, sembrò migliorare; poi la situazione precipitò e il 27 settembre Davall morì, ad appena 35 anni. Onorando le sue ultime volontà, la vedova fece pervenire a Smith la lettera mai terminata, l'erbario, i libri e i manoscritti del marito. Quest'ultimi sono tuttora conservati nella biblioteca della Linnean Society, mentre l'erbario è andato perduto. Nel pubblicare la corrispondenza di Davall con il marito, Pleasance Reeve scrive: "Assomigliava all'amico scelto dal suo cuore nel calore e nella devozione degli affetti, ma poté resistere meno di lui ai mali della vita. Molti passi delle lettere [...] mostrano il valore, la tenerezza, il raro affetto, la devozione alla scienza, il suo amore per la natura strettamente legato all'amore di Dio [...]. Se qualcuno considerasse [questi sentimenti] troppo acuti o riprovevoli, si ricordi che «quei teneri desideri che assorbivano la sua anima, logoravano il suo spirito, minavano la sua salute», erano i dolori di un uomo esiliato. Lasciamo che coloro che possono comandare a piacimento tanto il piacere quanto la società contemplino con profonda compassione il generoso e disinteressato Davall".  Rizomi con la pelliccia Nella speranza che l'amico con le sue opere occupasse prima o poi il posto che gli spettava nella scienza delle piante, fin dal 1793 Smith aveva provveduto ad eternarne il nome con la dedica del genere Davallia, scrivendo: "Ho dedicato questo nuovo genere con grandissimo piacere al botanico instancabile e acutissimo, amabile di carattere, così come illustre per scienza, Edmund Davall, membro della Linnean Society, che vive in Svizzera". Gli dedicò anche Carex davalliana, una specie che cresceva copiosa nelle aree unide di orbe e che Davall aveva distinto per primo. Al contrario della insignificante Smithia - una dedica lievemente maligna, come ho raccontato in questo post, di cui il presidente della Linnean Society avrebbe volentieri fatto a meno - il genere dedicato all'amico del cuore è davvero un dono sontuoso. Davallia è l'unico genere della famiglia Davalliaceae (alcuni studiosi però preferiscono classificarla nelle Polypodiaceae, intese in senso largo) e raggruppa una cinquantina di specie di felci epifite o litofite delle aree tropicali e subtropicali del Vecchio mondo e dell'Australia. La caratteristica più evidente sono i lunghi rizomi aerei grazie ai quali si abbarbicano sulla corteccia degli alberi o si insinuano nelle fessure delle rocce. Intricati e solitamente ricoperti da fitte squame simili a una pelliccia, le hanno guadagnato nomignoli come "felce ragno", "felce zampa di coniglio", "felce zampa di scoiattolo". Curiose e molto decorative, diverse specie sono apprezzate come piante da interni. Alcune però sono rustiche e possono essere coltivate in giardino. È il caso della giapponese D. mariesii, una piccola felce decidua con sottili rizomi pelosi e fronde triangolari, che può essere utilizzata come coprisuolo in angoli ombrosi e umidi. Meno resistente al freddo è invece D. canariensis, una specie originaria della Macaronesia e del Mediterraneo occidentale (Marocco e penisola iberica occidentale), che in natura cresce sui tronchi e i rami degli alberi e sulle rocce silicee umide e muschiose, soprattutto dove può godere dell'umidità oceanica. Da noi viene solitamente coltivata in vaso o anche su zattera o bark per orchidee, in modo da godere dell'intrico delle radici che si interesecano e pendono al di fuori. Tra le specie solitamente coltivate all'interno, la più nota è probabilmente D. solida var. fejeensis, originaria delle isole Figi, un'epifita caratterizzata da rizomi densamente ricoperti da squame grigio-rosate e da brevi fronde triangolari. Per mettere in risalto la bellezza dei rizomi, è spesso coltivata in cestini appesi, così come D. tyermannii, originaria della Cina e dell'Asia orientale, nota anche come felce tarantola o felce ragno per l'intrico di lunghi rizomi pelosi che evocherebbero a questi animali.
0 Comments
Secondo il folklore locale, è nella brulla brughiera di Brodie che Banco e Macbeth incontrarono il loro destino sotto forma di tre streghe. Poco lontano sorge il castello di Brodie, oggi gestito dal National Trust e famoso per la collezione di narcisi del suo giardino. Fino a qualche anno fa, era la sede ufficiale dei capi del clan Brodie; tra la seconda metà del Settecento e il primo Ottocento, il ruolo fu ricoperto da James Brodie, uomo politico non indimenticabile e botanico dilettante appassionato di crittogame nonché corrispondente di James Edward Smith e William Jackson Hooker. Tutto sommato, non indimenticabile neppure come botanico. Eppure l'amico Smith gli dedicò il grazioso genere Brodiaea: per meriti reali? per amicizia? per un intrigo di cui non sappiamo quanto il gentiluomo scozzese fosse consapevole? In ogni caso caso, a torto o a ragione, è questo il nome che la comunità scientifica riconosce. Prevalentemente californiano, e spesso confuso con l'affine Triteleia, offre fiori bellissimi che prolungano la stagione delle bulbose.  Un gentiluomo scozzese, tra politica e passione botanica In una seduta della Linnean Society dell'aprile 1808, il presidente James Edward Smith lesse la descrizione di un nuovo genere, denominato Brodiaea in onore di James Brodie, un gentiluomo i cui meriti, secondo lui, non richiedevano una particolare spiegazione. Per lui e per i membri della Society (di cui anche Brodie faceva parte) sarà stato così; ma non per noi, visto che il personaggio in questione non pubblicò nulla e della sua attività come botanico rimangono solo tracce sparse nella corrispondenza di botanici più illustri e qualche esemplare da lui raccolto nell'erbario dell'orto botanico di Edimburgo. James Brodie, o meglio James Brodie of Brodie (1744-1824), era il 21° capo del clan Brodie. Apparteneva a un ramo cadetto e a 15 anni ereditò inaspettatamente il titolo e la tenuta in seguito alla morte in giovane età del 20° capo, il secondo cugino Alexander; questi era figlio del membro forse più illustre della famiglia, il 19° capo Alexander Brodie of Brodie, che sedette alla Camera dei Comuni per 34 anni come sostenitore del governo e per 27 anni fu Lord Lyon King of Arms, il grado più basso dei grandi ufficiali di stato della Scozia, con il compito di regolamentarne l'araldica. Questo grande personaggio viveva al di sopra dei suoi mezzi, sicché James Brodie con il titolo ereditò una tenuta fortemente gravata da debiti e per tutta la vita dovette fare i conti con una situazione finanziaria difficile. Né lo aiutò il matrimonio con Lady Margareth Duff, sorella del conte di Fife, una delle figure dominanti della Scozia nord orientale, contrario al matrimonio. Anzi, Brodie si schierò con gli oppositori di Fife, tra i quali troviamo anche il fratello minore Alexander che, entrato al servizio della Compagnia delle India, al contrario di lui fece fortuna in India. Grazie a lui, James Brodie entrò in contatto con Henry Dundas, il braccio destro di William Pitt, con il sostegno del quale a partire dal 1794 fu eletto alla Camera dei comuni come rappresentate dell'Elginshire. Vi sedette per tre successivi mandati fino al 1807; sembra che non fosse molto assiduo e non prese la parola nemmeno una volta. Era per lo più schierato con il governo, ma non senza ambiguità. Insomma, una carriera politica tutt'altro che brillante, dovuta al fratello ricco (a sua volta deputato) e ad amici influenti. A Londra preferiva la Scozia, dove ebbe anche incarichi militari come tenente colonnello della milizia di Ross, e soprattutto alla politica preferiva le scienze naturali, cui probabilmente sia era accostato negli anni degli studi, prima alla Elgin academy, poi all'università di Saint Andrews. Si specializzò nelle crittogame (alghe, felci, muschi) e scoprì un certo numero di nuove specie sia nei dintorni di Edimburgo sia nella sua tenuta di Brodie. Qui aveva una discreta biblioteca, un gabinetto di curiosità e un erbario; su una delle torrette del castello fece installare un telescopio. Condivideva volentieri le sue scoperte ed corrispondeva con diversi eminenti botanici del tempo, tra cui appunto James Edward Smith e William Jackson Hooker. In English Botany Smith lo cita per Pyrola uniflora (oggi Moneses uniflora), di cui fu il primo a raccogliere un esemplare nelle isole britanniche, e per Ulva defracta, un'alga "trovata sulla costa orientale della Scozia dal nostro liberale corrispondente James Brodie"; in Flora scotica Hooker lo cita per una decina di alghe raccolte nel Firth of Forth e in altre località scozzesi. Nel 1795 Brodie fu ammesso alla Linnean Society e nel 1797 alla Royal Society. La sua vita personale fu funestata da due tragedie: nel 1786 la moglie morì in un incendio a Brodie House; nel 1801 il figlio maggiore James, che si trovava in India al servizio della Compagnia delle Indie, morì annegato in seguito al ribaltamento di un battello nei pressi di Madras. James Brodie morì nel 1824 all'età di 79 anni. Una parte del suo erbario è conservata all'Orto botanico di Edimburgo; si tratta di un'ottantina di esemplari, per lo più di piante palustri, in gran parte carici. 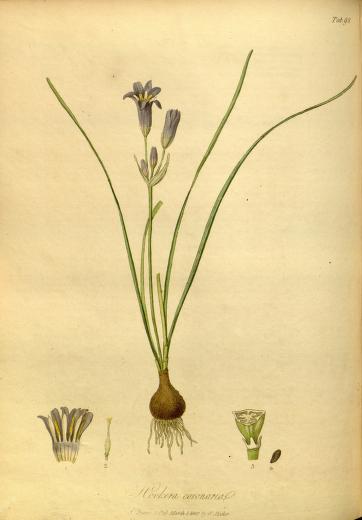 Una denominazione intricata Come ho anticipato, questo botanico dilettante è entrato nel gotha dei dedicatari di un genere botanico grazie all'amico e corrispondente James Edward Smith, che istituì il genere Brodiaea con queste parole: "Poiché queste piante formano indubbiamente un nuovo genere delle Liliaceae, o ordine patrizio, l'ho chiamato Brodiaea, per James Brodie della Britannia settentrionale, un gentiluomo i cui meriti scientifici, le cui varie scoperte, le cui generose comunicazioni in ogni occasione utile a illuminare la botanica soprattutto del suo paese, non richiedono una elaborata spiegazione per i membri della Linnean Society". Non si trattava però di una specie scozzese. Esemplari della futura Brodiaea furono raccolti per la prima volta nel 1792 nei pressi dello Strait of Georgia da Archibald Menzies, il botanico della Spedizione Vancouver. Nel 1807, nella sua An introduction to physiological and systematical botany, Smith fece riferimento a quello che già riteneva un nuovo genere per sostenere che i tepali delle liliacee sono sepali piuttosto che petali; però non gli diede un nome. La prima descrizione formale di una specie del genere fu pubblicata all'inizio dell'anno successivo da Richard Salisbury in Paradisus Londinensis come Hookera coronaria (in onore dell'illustratore William Hooker e non del botanico William Jackson Hooker). Immediatamente dopo Smith chiamò Hookeria un genere di muschi e appunto nell'aprile 1808 lesse la descrizione del genere Brodiaea alla Linnean Society; per la pubblicazione a stampa nelle Transactions si dovette aspettare il 1810. Stando alle regole della priorità, Hookera Salisb. dovrebbe essere il nome accettato, mentre Brodiaea e Hookeria (troppo simile a Hookera) dovrebbero essere respinti, Sarebbe così, se Salisbury non fosse stato il paria della botanica in seguito al fattaccio con Robert Brown; l'establishment botanico accettò i nomi di Smith e respinse quello di Salisbury. Secondo George Boulger, le mosse di Smith furono deliberatamente intese a privare il rivale - che detestava ferocemente - della paternità del nuovo genere, e riuscì pienamente nel suo intento. Da allora Hookera Salisbury è nomen rejiciendum, Brodiaea Sm. nomen coservandum. Unica parziale vittoria di Salisbury il successivo ripristino dell'epiteto in base alla legge della priorità: Brodiaea grandiflora Sm. oggi si chiama ufficialmente Brodiaea coronaria (Salisb.) Jeps. Chissà se James Brodie era al corrente dell'intrigo; è possibile, visto che proprio in una lettera rivolta a lui Smith definì Salisbury "quel rettile", e precisò "più calpesti uno str...o più puzza". Da parte mia, temo che la dedica a Brodie sia più giustificata dall'amicizia e forse dalla complicità (dopo tutto lo scozzese era un politico di lungo corso non alieno da manovre e camarille) più che da meriti che "non richiedono una elaborata spiegazione".  Fiori azzurri dalla California Lasciamo da parte questa vicenda decisamente squallida per passare al bellissimo genere Brodiaea, anche se, oltre al suo nome, ha fatto discutere anche la sua collocazione tassonomica. Smith lo collocò "indubitabilmente" nelle Liliaceae, e i botanici successivi ora nelle Liliaceae, ora nelle Alliaceae, ora nelle Amaryllidaceae. Unico bastian contrario, ancora Salisbury che pensava che appartenesse a una famiglia propria, che egli stesso istituì e denominò Themidaceae (dal genere monotipicoThemis rappresentato unicamente da T. ixioides). Solo verso la fine del Novecento con gli studi filogenetici molecolari è emerso con chiarezza che a vederci giusto era stato proprio Salisbury (magari rettile, ma di certo grande botanico). Di conseguenza, nel 1996 la famiglia Themidaceae venne ripristinata; più di recente, è passata al rango di sottofamiglia delle Asparagaceae con il nome Brodiaeoideae. La sottofamiglia, di cui Brodiaea è ora il genere tipo, comprende 12 generi di erbacee perenni diffusi unicamente lungo la costa pacifica dell'America settentrionale, dal British Columbia al Guatemala; i due più grandi sono Triteleia (16 specie) e Brodiaea (18 specie) che sono anche quelli più comunemente coltivati nei giardini. Tratti comuni a tutta la sottofamiglia sono il cormo amidaceo che si rinnova ogni anno a partire da quello vecchio; le foglie lineari, talvolta carnose; i fiori bisessuali, con 6 tepali in due giri di tre, raccolti in infiorescenze ad ombrella; 6 stami fertili o 3 stami alternati a 3 staminoidi; ovario supero triloculare; frutto a capsula che si apre lungo le suture dei carpelli; semi ricoperti da uno strato duro di colore nero. Poiché i confini tra i diversi generi della sottofamiglia non sono netti e Brodiaea fu il primo ad essere stabilito, in passato ne hanno fatto parte molte specie via via trasferite in altri generi; è il caso anche diTriteleia laxa, la specie più coltivata dell'intero gruppo, che è spesso ancora commercializzata sotto il sinonimo Brodiaea laxa, tanto che per molti è la Brodiaea per antonomasia anche se da tempo non appartiene più a questo genere. Non di rado sono commercializzate come Brodiaea anche le specie e gli ibridi di Dichelostemma. Themis non esiste più e T. ixioides, dopo essersi chiamata tra l'altro Brodiaea ixioides, è ora Triteleia ixioides. Brodiaea è presente lungo la costa pacifica dell'America settentrionale dal British Columbia alla Baja California, con centro di diversità nella California settentrionale. Alcune specie endemiche della California si sono adattate a suoli con particolare composizione chimica, hanno limitata diffusione e sono a rischio di estinzione. Diverse sono coltivate come piante da giardino, apprezzate sia per il raro colore azzurro delle corolle sia perché prolungano la stagione di fioritura delle bulbose primaverili; infatti, più che in primavera tendono a fiorire all'inizio dell'estate. In primavera dal cormo emergono da una a sei foglie lineari. Solitamente ogni cormo produce un singolo scapo fiorale privo di foglie che porta alla sommità un'infiorescenza a ombrella, composta di fiori a stella con sei tepali azzurri o viola, congiunti alla base a formare un tubo con sei lobi liberi alla gola, i tre esterni più stretti dei tre interni. La maggior parte delle specie presenta tre stami fertili e tre staminoidi simili a piccoli petali, ciascuno opposto a uno dei tepali esterni. E' questa la caratteristica più distintiva del genere, che lo distingue tra l'altro da Triteleia che invece possiede sei stami fertili. Da Dichelostemma invece si distingue per lo scapo diritto anziché ricurvo e per l'ombrella aperta anziché densa e compatta. Le specie più frequentemente coltivate sono Brodiaea californica, la più grande, con corolle a calice stellato in colori che variano dal bianco al lavanda e occasionalmente al rosa; B. coronaria (sin. B. grandiflora), con corolle a campana dai petali ricurvi, da blu a viola a rosa porpora; B. elegans, con tepali blu-violetto che contrastano con gli staminoidi bianchi. Altre informazioni nella scheda. Nella prima metà dell'Ottocento, il numero di piante esotiche coltivate in Europa cresce esponenzialmente. Orti botanici, grandi vivai, istituzioni scientifiche sono in prima fila per inviare alla loro ricerca cacciatori di piante; ma ci sono anche raccoglitori indipendenti desiderosi di piazzare le loro scoperte (siano semi o esemplari d'erbario) ad un prezzo accettabile. A mettere in contatto raccoglitori e potenziali acquirenti - siano essi privati o istituzioni - e a mediare tra le loro esigenze si inserisce una nuova figura professionale: l'agente botanico. A rappresentarla nel modo migliore, stando alle testimonianze, dovette essere l'eccellente John Hunneman, dedicatario del genere Hunnemannia.  Come un libraio inventò un nuovo mestiere Nel 1827, una settimana prima di Natale, Johann Heinrich Friedrich Link, direttore dell'orto botanico di Berlino, scrive al suo omologo di Kew, William Jackson Hooker, per informarlo che, avendo saputo che era alla ricerca di semi di Nelumbo speciosum [oggi N. nucifera, il loto], ha raccolto per lui tutti quelli disponibili e glieli ha inviati, insieme a semi di Euryale ferox e alcuni altri che coltiva nel suo giardino, tramite Mr John Hunneman, 9 Queen Street, Soho Square, Londra. La cortese lettera di Link, oggi conservata nell'archivio dei Kew Gardens, è solo una delle numerose testimonianze della preziosa attività di mediazione svolta dal libraio e agente botanico John Hunneman (ca. 1760-1839) . Anche se oggi non conosciamo molto della sua vita personale, il nome di Hunneman (scritto anche Hunnemann e talvolta Hunneyman) era ben noto negli ambienti botanici della prima metà dell'Ottocento, e ricorre frequentemente nella corrispondenza e nelle riviste dell'epoca. Anche se era presumibilmente nato a Londra, come si può dedurre dal cognome era di origine tedesca, forse parente del pittore Christopher William Hunneman, che negli ultimi anni del Settecento viveva a Soho Square dove, come si legge nella lettera di Link, si trovava anche la libreria di John Hunneman. Il negozio era specializzato in testi di botanica, soprattutto importati dal continente, ma Hunneman aveva anche clienti all'estero cui procurava libri e riviste inglesi. Era particolarmente abile a trovare per gli uni e gli altri testi rari. In tal modo egli venne a trovarsi al centro di una rete di scambi tra botanici britannici e continentali; godeva di fama di grande affidabilità e a un certo punto oltre ai libri incominciò a trattare stampe botaniche, esemplari d'erbario e parcelle di piante vive. Almeno dal 1816 organizzò diversi ingenti trasporti di piante - in gran parte provenienti dai vivai Loddiges o in subordine da vivai tedeschi - per il parco e le serre di Eisenstadt come "agente botanico e orticolo" del principe Esterházy. Dai documenti conservati nell'archivio del genero William Pamplin, che fu suo stretto collaboratore e alla sua morte ne proseguì l'attività, a partire dal 1817 risultano pagamenti da parte di Christoff Friedrich Otto, ispettore dell'orto botanico di Berlino, per invii di piante e semi provenienti da vari vivai inglesi. Ma almeno dagli anni '20 il ruolo più tipico di Hunneman fu quello di "agente botanico" che metteva i raccoglitori di piante indipendenti in contatto con i possibili acquirenti, curandosi degli invii e dei trasporti e del rispetto dei contratti e dei pagamenti. Come tale figura in un'inserzione pubblicata nel 1829 su The Gardener's magazine in cui si comunica che un certo Mr. Fanning "proprietario dell'orto botanico di Caracas" ha portato con sé varie piante "molte delle quali nuove per questo paese"; entro poche settimane sarebbe rientrato a Caracas, ma "nel frattempo, sarebbe stato felice di entrare in corrispondenza con i naturalisti interessati. Il suo agente è Mr. Hunneman di Queen Street, Soho". Sappiamo che almeno alcuni di quegli esemplari furono acquistati da Lambert, nel cui erbario si trovano ancora. Tra i botanici-raccoglitori, il suo cliente più celebre è senza dubbio Nathaniel Wallich, che, tra la fine degli anni '20 e gli anni '30, grazie alla sua mediazione riuscì a vendere esemplari d'erbario agli orti botanici di Berlino, Liverpool, Londra ed Edimburgo, nonché a collezionisti privati. Probabilmente era entrato in contatto con lui attraverso William Jackson Hooker, quando questi era ancora professore a Glasgow. Infatti in The American journal of science and arts del 1820 leggiamo l'annuncio della prossima pubblicazione di due volumi in folio dedicati alle felci dell'India orientale, curati da Hooker e basati su raccolte di Wallich e Wight; a ricevere le sottoscrizioni dall'estero sarà "John Hunneman, Esq., No. 9 Queen street, London". Il volume non uscì mai e non sappiamo se Hunneman era stato coinvolto anche come potenziale editore; come tale figura invece nel frontespizio del secondo e del terzo volume di The genera and species of orchidaceous plants di John Lindley. Insomma, seppe rendersi indispensabile in vari modi ai botanici al di qua e al di là della Manica, come è evidente dal necrologio pubblicato dopo la sua morte nel 1839 sulla rivista della Botanical society: "Dobbiamo lamentare [...] la morte del nostro eccellente socio Mr John Hunneman. Non potrebbe esistere persona che più volentieri si prendesse ogni genere e grado di disturbo per compiacere i suoi amici e per stabilire utili scambi tra i botanici europei; [...] la sua perdita sarà un grave ostacolo alla libera comunicazione che da molti anni esiste tra loro. Era conosciuto da tutti, amato da tutti, e quella reciprocità di gentilezza che aveva il diritto di aspettarsi la rivolgeva spontaneamente a ogni botanico che desiderava introdurre nella confraternita scientifica che aveva fondato e che desiderava allargare".  Papaveri d'oro dal Messico La medesima stima, riconoscenza ed ammirazione era stata espressa qualche anno prima (1828) da Robert Sweet nel terzo volume di The British flower garden nel dedicare al libraio e agente botanico il genere Hunnemannia: "Lo abbiamo nominato in onore del nostro amico Mr John Hunnemann, il quale, attraverso i suoi numerosi corrispondenti in vari paesi, è stato strumentale all'introduzione nelle nostre collezioni di un numero di piante maggiore di ogni altro individuo, tanto che siamo un po' sorpresi che nessun genere gli sia stato dedicato in precedenza". Per creare il nuovo genere, Sweet si basò su una pianta di cui aveva ricevuto i semi da Robert Barclay, un ricco birraio e proprietario di un raffinato giardino, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal Messico. Si tratta di Hunnemannia fumariifolia, una della due specie di questo genere della famiglia Papaveraceae; a lungo è stata l'unica nota. Affine a Eschscholzia, è un papavero piuttosto alto con grandi fiori dorati a coppa e foglie glauche finemente divise, endemico degli altipiani del Messico (deserto di Chihuahua e Sierra madre orientale) tra 1500 e 2000 metri di altitudine. Relativamente rustico, è una perenne di breve vita solitamente coltivata come annuale. La seconda specie, Hunnemannia hintoniorum, fu scoperta e pubblicata solo nel 1992. Endemica del Nuevo León, differisce dalla precedente perché più bassa, scaposa, con fusti non ramificati e foglie più strette e limitate alla rosetta basale. Fu Marcello Malpighi a notare ed osservare per primo al microscopio i minuscoli pori (o stomata) che punteggiano la pagina inferiore delle foglie. Ma a capire quale ne fosse la funzione fu Stephan Hales, che si considerava un modesto parroco di campagna, ma fu anche un grande scienziato sperimentale che si era formato a Cambridge nello spirito di Newton. Convinto seguace della sua impostazione meccanicista, andò alla ricerca delle forze sottostanti alcune funzioni vitali delle piante e degli animali, applicando a quelle che chiamò "statica dei vegetali" e "emostatica" il metodo sperimentale, ovvero osservando, paragonando, misurando. I suoi risultati maggiori sono, nel campo della fisiologia vegetale, di cui è considerato uno dei fondatori, la scoperta della traspirazione delle piante e la prima misurazione della pressione della linfa, nel campo della fisiologia animale la prima misurazione della pressione del sangue. Fu anche un ingegnosissimo inventore, che inventò molti dei suoi strumenti di laboratorio, inclusa la vaschetta pneumatica, ma anche molti oggetti di utilità pratica, tra cui un ventilatore che poteva essere azionato a mano o collegato a una pompa idraulica, per rendere meno malsana l'aria viziata di ambienti chiusi come le navi e le prigioni. Era infatti anche un filantropo, preoccupato del benessere dei suoi simili, che cercava anche di convincere ad abbandonare l'alcool. John Ellis, come lui membro della Royal Society, convinse Linneo a dedicargli il bellissimo genere Halesia dalle campanelle bianco-argento. 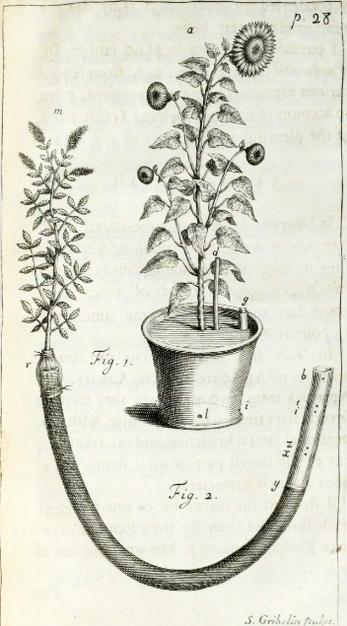 Il parroco che fece parlare le piante Il grande botanico e storico della botanica Julius von Sachs ha scritto di Stephen Hales (1677-1761), "Si può dire che abbia fatto parlare le piante stesse; per mezzo di esperimenti concepiti con intelligenza e condotti con abilità, le ha costrette a rivelare le forze che operano in esse attraverso effetti percepibili alla vista e a mostrare che forze di tipo veramente particolare sono in costante attività negli organi della vegetazione, apparentemente quieti e passivi". E' un'immagine assai suggestiva che rivela tutta l'ammirazione di Sachs, lui stesso considerato il padre della fisiologia botanica sperimentale, per l'ingegno dell'uomo che mosse i primi passi in questo ramo della botanica. Stephan Hales non era uno scienziato di professione. Era un pastore anglicano che per circa mezzo secolo resse (a quanto pare con competenza e dedizione al suo gregge) la parrocchia di Teddington nel Middlesex, non troppo distante da Richmond e oggi parte della Grande Londra. Ma negli anni di formazione a Cambridge, dove divenne fellow del Corpus Christi College, si era innamorato delle scienze sperimentali e ne aveva appreso i metodi e gli strumenti. Agli studi di teologia necessari per essere ordinato sacerdote, insieme all'amico William Stuckley, che poi sarebbe diventato medico e uno dei fondatori dell'archeologia britannica, alternava l'osservazione degli astri usando il telescopio installato da Newton in persona sulla Great Gate, gli esperimenti di ottica e le dissezioni di animali. Soprattutto imparava ad osservare, a tradurre le osservazioni in dati misurabili e ad annotare i risultati con scrupolo, secondo il metodo di Newton, il vero genius loci della Cambridge di quegli anni. Così, nel 1708, quando fu nominato parroco di Teddington (vi sarebbe rimasto fino alla morte nel 1761) creò un proprio laboratorio dove poter continuare i suoi esperimenti, per condurre i quali, uomo pratico e assai ingegnoso, creò egli stesso molti dei suoi strumenti. Si interessava di molti rami delle scienze, ma tre sono i campi in cui ottenne i risultati più rilevanti: la fisiologia vegetale, la misurazione dei gas, la fisiologia animale. Mentre a Cambridge si era concentrato maggiormente su quest'ultima insieme a Stuckely, a Teddington si rivolse alle piante, quelle più comuni e disponibili nell'orto parrocchiale (girasoli, cavoli, zucche, luppolo), nel frutteto (viti, meli, peschi, pruni, fichi, cotogni, ciliegi), nei boschi dei dintorni (querce, olmi, frassini), con l'apporto occasionale di qualche esotica: un limone e Musa arbor, ovvero un platano (Musa acuminata) delle Indie occidentali. Non gli erano estranee preoccupazioni pratiche sull'influsso di temperatura, suolo, umidità, aria e luce sulla crescita e il vigore dei vegetali , ma soprattutto era mosso dalla volontà di comprendere le leggi meccanico-fisiche sottostanti, secondo la concezione matematica e meccanicistica appresa da Newton. Per farlo, non bastava osservare: occorreva tradurre le osservazioni in dati numerici, misurabili e paragonabili. Ecco allora Hales misurare la temperatura non solo in diverse stagioni dell'anno a diverse ore della giornata, ma costruire speciali termometri con tubo lungo da 45 a 120 cm e bulbo posto alla base, per confrontare la temperatura dell'aria con quella del suolo rilevata in cinque diverse profondità. Allo stesso modo pesò e misurò la quantità di umidità contenuta nel suolo in diverse condizioni. Fu il primo passo per studiare il meccanismo oggi noto come traspirazione delle piante. Malpighi era stato il primo ad osservare al microscopio e a descrivere i pori (stomata) presenti sulla pagina inferiore delle foglie, ma non ne conosceva la funzione. Hales fu il primo a comprendere che attraverso di essi le piante rilasciano acqua nell'atmosfera; per sostituirla, altra acqua risale dalle radici attraverso i vasi legnosi, spinta da una pressione ("la forza della linfa") che il parroco misurò attraverso ingegnosi esperimenti, così come misurò e collegò con la traspirazione l'estensione della superficie delle foglie e il volume delle radici, anch'essi misurati in modi allo stesso tempo semplici e ingegnosi. Ripeté esperimenti e misurazioni su piante diverse, scoprendo che la quantità della traspirazione varia con la temperatura e l'esposizione nonché da una specie all'altra; ad esempio le piante sempreverdi, o anche le bulbose primaverili, hanno una linfa più vischiosa e una traspirazione minore. Comprese inoltre che il flusso avviene in una sola direzione (dalle radici alle foglie), quindi non si può parlare per le piante di un vero sistema circolatorio come quello degli animali. Ma le piante scambiano con l'ambiente non solo acqua, ma anche gas. Per misurarne la quantità, Hales inventò un altro strumento, la vaschetta pneumatica. Gli esperimenti gli resero chiaro che le piante traggono nutrimento non solo dalla terra, per mezzo dalle radici, ma anche dall'aria, sotto forma di gas, e che nel meccanismo ha qualche ruolo anche la luce: "E forse anche la luce, entrando liberamente nelle superfici espanse delle foglie e dei fiori, contribuisce molto a nobilitare i principi dei vegetali". E' una delle prime intuizioni della fotosintesi clorofilliana. Accanto alla fisiologia vegetale, Hales sviluppò così un interesse più generale per i gas, con esperimenti di tipo quantitativo - non vertono sul tipo di gas rilasciato, ma sulla sua quantità - sui gas sviluppati nelle fermentazioni e nelle combustioni, che la sua ingegnosa vaschetta pneumatica rendeva possibile catturare, misurare e studiare. Era uno strumento rivoluzionario, che presto divenne indispensabile in ogni laboratorio, aprendo la strada alla scoperta dell'idrogeno da parte di Cavendish e alle successive scoperte di Lavoisier. Hales espose i risultati delle sue ricerche sulla fisiologia vegetale e sui gas nella sua prima pubblicazione, Vegetable Statikcs, uscita nel 1727 e anticipata da letture tenute alla Royal Society, di cui era membro fin dal 1718. Nel 1733 la ripubblicò come prima parte di Statical Essays, la cui seconda parte è costituita da Haemastaticks, dedicata alla fisiologia animale, in cui espose diversi esperimenti sulla respirazione e la circolazione. A dargli maggior fama fu la prima misurazione della pressione del sangue, realizzata su diversi animali inserendo sottili tubi nelle arterie e misurando l'altezza raggiunta dal sangue nelle fasi di diastole e sistole. I suoi esperimenti su animali vivi, cruenti e talvolta letali, non mancarono di suscitare le critiche di alcuni dei suoi contemporanei, tra cui il poeta Alexander Pope, che pure era uno dei suoi amici e considerava Hales il modello dell'uomo di Dio. Egli in effetti era impegnato in prima persona in molte cause filantropiche. Nel 1722 divenne membro corrispondente della Società per la promozione della conoscenza cristiana e dall'anno seguente consigliere, occupandosi soprattutto della creazione di biblioteche nelle colonie americane. Dopo che due dei suoi fratelli finirono in carcere per debiti, si impegnò anche in attività a favore dei "debitori onesti e industriosi". Nel 1732 fu nominato membro del consiglio di fondazione della nuova colonia della Georgia; presa così coscienza dei problemi dati dal sovraffollamento delle navi, inventò uno speciale ventilatore a campana per aerare gli ambienti malsani e sovraffollati, nonché un distillatore per trarre acqua dolce dall'acqua di mare. Fu anche uno dei membri fondatori della Società per l'incoraggiamento di arti, manifatture e commercio (più tardi Royal Society of Arts). Soprattutto si impegnò molto attivamente contro il consumo degli alcoolici, un grave problema sociale nell'Inghilterra del Settecento, pubblicando molti articoli anonimi, il più notevole dei quali è intitolato '"Friendly Admonition to the Drinker of Brandy and other Distilled Spirituous Liquors" (Un'ammonizione amichevole al bevitore di brandy e altri distillati alcoolici). Definiva il gin la "rovina della nazione" e avrebbe voluto che ne fossero bandite la produzione e la vendita; dovette accontentarsi del Gin Act del 1736 con il quale il parlamento impose un'imposta al dettaglio e licenze annuali per i venditori di gin. Ampiamente disattesa, la legge fu per altro abolita già nel 1743.  Halesia, ovvero campanelle d'argento Grazie a queste battaglie e ai suoi risultati scientifici, Hales era comunque una figura molto riconosciuta. Come si è già visto, era membro della Royal Society, che nel 1737 gli assegnò la prestigiosa Copley Medal per le sue ricerche; era inoltre socio corrispondente delle Accademie delle scienze di Parigi e Bologna. Si dice che il principe di Galles Frederick, incuriosito dalla sua fama, amasse fargli visita a sorpresa nel suo laboratorio. Rimasta vedova, la principessa Augusta scelse Hales come proprio confessore e cappellano del figlio maggiore (il futuro Giorgio III) e lo consultò per i suoi progetti a Kew. Dopo la sua morte, anche se egli aveva voluto essere sepolto nella chiesa di Teddington, lo onorò con un monumento nell'abbazia di Westminster. Di questi riconoscimenti da parte di contemporanei fa parte anche la dedica del genere Halesia, fortemente voluta da John Ellis, che la suggerì a Linneo. La pianta che oggi si chiama Halesia carolina era già stata disegnata e descritta da Catesby come Frutex padi foliis non serratis, floribus monopetalis albis, campaniformibus (Arbusto con foglie simili al pado, non seghettate, con fiori monopetali bianchi campaniformi), ma non aveva ancora un nome; tanto meno era mai stata coltivata in Europa, finché nel 1756 il dottor Garden (l'amico di Ellis cui impose a Linneo la dedica di Gardenia) ne inviò ad Ellis una descrizione e molti semi, che egli provvide a distribuire tra giardinieri e appassionati. L'abilissimo giardiniere Gordon la coltivò con successo, dimostrando anche la sua adattabilità al clima inglese. Due anni dopo Henry Ellis, secondo governatore della Georgia (omonimo, ma a quanto pare non parente) gli spedì una seconda specie, caratterizzata da frutti con due ali anziché quattro (Linneo la chiamò infatti Halesia diptera "con due ali). John Ellis nel 1760 le pubblicò entrambe nelle Transactions della Royal Society; era però stato anticipato da Linneo che, su suo suggerimento, nel 1759 aveva creato il genere Halesia nella decima edizione di Systema naturae. Linneo non spiega in alcun modo la motivazione del nome, mentre Ellis si limita a scrivere "mi sono preso la libertà di darle il nome del nostro caro amico il dr. Stephen Hales di Teddington", ma certo la rinomanza in patria e all'estero del pastore-scienziato era una ragione sufficiente. Del resto, Ellis non era stato il primo a onorare Hales con una dedica vegetale: prima di lui, per tutt'altre piante, ci avevano pensato Patrick Browne nel 1756 e Loefling nel suo Iter hispanicum, pubblicato postumo da Linneo nel 1758. Ma poiché queste pubblicazioni precedenti ebbero scarsa circolazione, nonostante la legge della priorità, il nome da conservare (nomen conservandum) è quello di Ellis-Linneo. Halesia Ellis ex L. è un piccolo genere di arbusti della famiglia Sterculiaceae. Il numero di specie e la distribuzione geografica hanno fatto discutere; fino a qualche anno fa, comprendeva anche una specie cinese, H. macgregorii, che tuttavia nel 2016 è stata trasferita in un genere a sé, Perkinsiodendron come P. macgregorii. Sono così rimaste nel genere Halesia solo le specie americane, tutte endemiche degli Stati Uniti sud-orientali, il cui numero varia però da una fonte all'altra. Flora of the Southeastern United States, il sito curato dall'orto botanico del North Carolina, che presenta anche chiare chiavi dicotomiche, le attribuisce tre specie: H. carolina, H. diptera e H. tetraptera; invece Plants of the World on line le riduce a due, H. carolina e H. diptera, mentre considera H. tetraptera sinonimo di H. carolina. Altri autori aggiungono come specie indipendente H. monticola, in genere classificata come sottospecie o varietà di H. carolina o H. tetraptera. Lasciando da parte queste discussioni tassonomiche, a mettere d'accordo tutti è la bellezza di queste piante: questi grandi arbusti, o addirittura piccoli alberi, hanno dalla loro la bellezza della corteccia che si sfalda, le foglie che d'autunno si tingono d'oro, gli interessanti frutti alati, ma soprattutto danno spettacolo al momento della fioritura quando i loro rami si ricoprono di campanelle bianco-argento (quelle che hanno loro guadagnato il nome inglese silverbells, campanelle d'argento); sono rustiche ed amano i climi freschi e umidi. All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia). 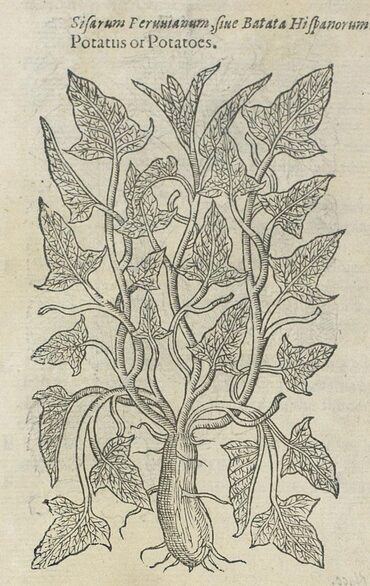 Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa. 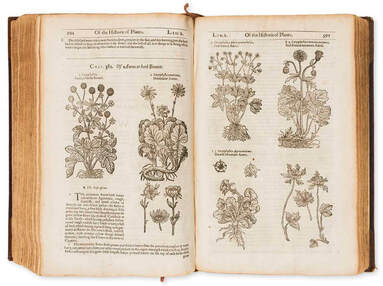 Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice. Nel quindicennio tra il 1798 e il 1812, lo scozzese James Niven fu un prolifico ed efficiente cacciatore di piante in Sudafrica. Prima al servizio di George Hibbert, poi di un consorzio che includeva il vivaio Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina, raccolse migliaia di semi e esemplari di erbario, introducendo nei giardini europei molte nuove specie, in particolare Ericaceae e Proteaceae. Nella realtà fu un giardiniere, poi un raccoglitore, infine forse un commerciante morto troppo presto; nel mito, chissà perché, la sua scarna biografia si colora di particolari da fantasiosi a melodrammatici. A ricordarlo il reale e bellissimo genere Nivenia, endemico della provincia del Capo occidentale, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae. 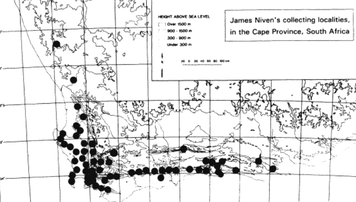 Un raccoglitore prolifico e coscienzioso Nel fascicolo del 1827 della rivista di orticultura edita da Longman e curata da Loudon The Gardener's Magazine i lettori poterono leggere il necrologio di Mr. James Niven, morto il 9 gennaio di quell'anno, corredato da una breve biografia. Ancora oggi è il resoconto più ampio della vita di questo giardiniere e cacciatore di piante; a firmarlo è J. M., ovvero James Main, che doveva aver conosciuto Niven di persona, visto che entrambi per qualche tempo avevano lavorato per il ricco collezionista di piante George Hibbert. Eppure, come vedremo meglio più avanti, le notizie fornite da Main sono da prendere con beneficio d'inventario. Figlio di un tessitore di Penicuik, non lontano da Edimburgo, James Niven (1776-1827) dovette ricevere la relativamente accurata educazione garantita dalle scuole pubbliche scozzesi; poi probabilmente lavorò come ragazzo giardiniere presso vari giardini, finché diciannovenne completò il suo apprendistato presso l'orto botanico di Edimburgo, dove rimase per circa un anno. Nel 1796 si trasferì a Londra dove fu assunto come giardiniere a Syon House, la splendida proprietà del duca di Northumberland, sotto il capo giardiniere Thomas Hoy. In qualche modo dovette attirare l'attenzione di George Hibbert che decise di inviarlo in Sudafrica a caccia di piante. Secondo Nelson e Rourle che, in assenza di un diario di campo, hanno cercato di ricostruire i suoi movimenti sulla base delle sue note d'erbario, Niven dovette arrivare al Capo alla fine del 1798 o all'inizio del 1799, dato che il suo primo esemplare datato risale all'agosto 1799. Secondo Main, presto si impadronì tanto dell'olandese quanto del khoi, tanto da poter servire come interprete e guida alle truppe del generale Craig. E' il primo mito che troviamo in questa storia: almeno un anno prima che Niven vi arrivasse, Craig, dopo aver brillantemente diretto l'occupazione inglese della Colonia del Capo, sottratta alla Repubblica batava, ed esserne stato per due anni governatore, era stato destinato al Bengala e aveva lasciato il Sudafrica per Madras. E' molto probabile (anzi certo secondo Nelson e Rourle) che al Capo Niven abbia invece incontrato un altro botanico scozzese, William Roxburgh, che vi era arrivato da Calcutta nel 1798 insieme a suo figlio John; mentre il padre lasciò il paese alla fine del 1799, il figlio vi rimase fino al 1804 a raccogliere esemplari per l'orto botanico di Calcutta. Nelson e Rourle ipotizzano che, essendo conterranei e avendo interessi comuni, Niven e i Roxburgh abbiano botanizzato insieme, anche se è difficile da dimostrare, perché, al contrario di quelli di Niven, per gli esemplari dei due Roxburgh la località di raccolta è spesso indicata in modo molto generico; una prova indiretta è il fatto è che nel suo erbario Niven usò alcuni binomiali inediti di Roxburgh, Nel 1803, in seguito al trattato di Amiens, la colonia del Capo fu restituita alla Repubblica batava; Niven, che ora non poteva più muoversi liberamente nel paese, rientrò in Inghilterra, ma, sempre stando a Main, dopo solo tre mesi tornò in Sudafrica, al servizio di un consorzio che comprendeva il vivaio Lee & Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Anche questa notizia è imprecisa; secondo Nelson e Rourle, egli invece dovette tornare in Sudafrica nel 1805. Infatti per poter raccogliere nel paese tornato sotto controllo olandese era necessario un permesso; quest'ultimo venne rilasciato a Niven in data 3 aprile 1805, limitatamente alle piccole aree di Riebeek-Kaastel e Roodezand. Tuttavia già nel gennaio 1806 i britannici rioccuparono la colonia, e dal quel momento Niven potè muoversi liberamente; vi sarebbe rimasto per altri sei anni, fino al 1812. Durante i due soggiorni sudafricani, Niven esplorò gran parte della colonia del Capo; a nord si spinse fino al Kamiesberg, il massiccio più elevato del Namaqualand, dove raccolse Vexatorella alpina (pubblicata da Knight come Protea alpina); a est percorse le catene che corrono lungo la costa (monti di Riviersonderend, Langeberg e Outeniqua) e ancora più a est, attraverso la valle Langekloof, dove raccolse Protea tenax, raggiunse Kromme River e Gamtoos River, il punto più orientale dei suoi viaggi, Tuttavia raccolse la maggior parte degli esemplari in un raggio di 150 km da Città del Capo; i suoi luoghi di raccolta preferiti risultano i distretti di Tulbagh, le catene Drakenstein e Hottentots Holland e il monte di Worcester. I suoi committenti desideravano soprattutto semi e bulbi, Ciò significava esplorare ciascuna area almeno due volte: la prima durante la stagione di fioritura per identificare le specie e raccogliere esemplari d'erbario, la seconda qualche mese più tardi per raccogliere i semi. Per ritrovare con facilità le piante e identificarle con sicurezza, Niven creò per se stesso un erbario di campo: su ogni foglio di pesante carta grigiastra incollava più esemplari (mediamente tre) corredati da precise note sul luogo di raccolta, la stagione di fioritura, l'habitat, le caratteristiche ecologiche, talvolta il tipo di suolo. Le raccolte di Niven sono particolarmente importanti per due famiglie largamente presenti in Sudafrica, le Proteaceae e le Ericaceae. Grazie alle sue raccolte delle prime, George Hibbert ne poté vantare la più ampia collezione europea, Knight specializzarsi nella loro coltivazione, Salisbury e Brown pubblicare decine di nuove specie. Una delle più rare è Leucospermum grandiflorum, che nel 1799 fu raccolta sia da Roxburgh sia da Niven. Secondo Salisbury, che la descrisse in Paradisus Londinensis nel 1808, i semi raccolti da Niven furono seminati nella serra di Hibbert dove prosperarono. Anche per le Ericaceae (molte furono pubblicate da Henry Cranke Andrews nei sei volumi di The Heathery, le raccolte di Niven hanno grande importanza storica. Secondo Aiton, le specie di Erica introdotte da Niven in Gran Bretagna sono 31, un risultato notevole se si pensa che Masson nel corso dei suoi tre viaggi ne aveva già introdotte 86. E se i numeri sono inferiori, in compenso i dati relativi ai luoghi di raccolta e agli habitat sono di gran lunga più accurati rispetto a quelli del suo predecessore. Secondo la testimonianza del curatore dell'orto botanico di Edimburgo William McNab, che ebbe con lui molte conversazioni sull'argomento dopo il suo ritorno in Scozia, "il mio molto compianto amico James Niven certamente sapeva sulla natura e sulla coltivazione di questo genere più di ogni altro uomo che io abbia mai incontrato". 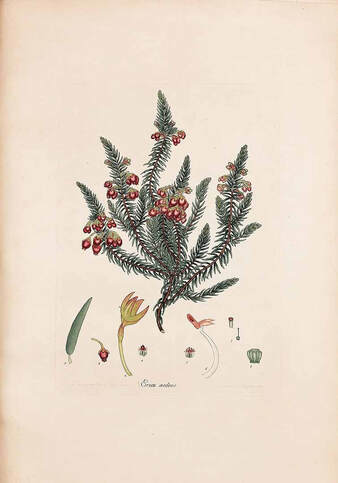 Miti e affabulazioni Dopo il suo ritorno in patria, sempre stando a Main, Niven "abbandonò le sue attività botaniche e orticole" e ritornò a Penicuik, dove aprì un'attività (non sappiamo di che genere) insieme a un fratello. Nel 1817 sposò Alison Abernethy (lo sposo aveva 40 anni, la sposa 26), da cui ebbe 5 figli; nel 1827, ad appena 50 anni morì. Main non manca di aggiungere un particolare melodrammatico: non appena la sua bara lasciò la casa, la vedova morì all'istante, lasciando cinque piccoli orfani. Documenti alla mano, è un altro mito: forse davvero per il dolore la donna ebbe un infarto o un ictus, ma morì e fu sepolta quattro settimane dopo il marito. La situazione dei bambini era comunque difficile, e i loro tutori furono costretti a vendere l'erbario; l'acquirente fu il già citato William McNab; passato al figlio John, capo giardiniere dell'orto botanico di Edimburgo, poi al nipote William Ramsay McNab, l'erbario finì a Dublino quando il suo ultimo possessore ottenne la cattedra di botanica al Collegio reale d'Irlanda. Alla sua morte precoce nel 1889, la vedova fu costretta a mettere in vendita la biblioteca, gli strumenti scientifici e l'erbario del marito, che comprendeva anche quello di Niven. In parte fu acquistato dal Museo nazionale irlandese (oggi è custodito all'erbario di Glasnevin), in parte dai Kew Gardens. Una serie di duplicati, forse in qualche modo acquisiti da Harvey, si trovano invece al Trinity College. L'erbario, già diviso, fu ulteriormente smembrato, e in parte rimase sconosciuto fino agli anni '70 del Novecento, quando venne in un certo senso "riscoperto" e studiato da un altro specialista di Proteaceae ed Ericacae, Ernest Charles Nelson dell'erbario dell'orto botanico di Glasnevin a Dublino, che si è anche incaricato di sfatare alcuni dei miti che hanno offuscato la vera storia di James Niven, Ne rimane uno, forse il più diffuso e tenace. Tra i personaggi più noti dell'orticultura irlandese troviamo Ninian Niven (1799-1879), che ridisegnò Phoenix Park, diresse per qualche anno l'orto botanico di Glasnevin, per poi diventare un affermato vivaista e un famoso architetto di giardini, nonché per diversi anni segretario della Royal Horticultural Society. Non è chiaro per quali ragioni, contro ogni evidenza, nel loro Biographical Index of British and Irish Botanists (1889) Boulger e Britten asserirono che Ninian Niven era figlio del nostro James Niven. Eppure Ninian Niven era nato a Kelvin Growe, presso Glasgow e suo padre, che si chiamava anche lui Ninian, era uno dei giardinieri di Keir House vicino a Stirling e non fu mai un cacciatore di piante. Senza contare che nel 1799 il nostro Niven aveva appena 22 anni ed era giusto arrivato in Sudafrica. I registri parrocchiali di Penicuik non lasciano dubbi: James Niven, come già sappiamo, si sposò quasi vent'anni dopo e nessuno dei suoi cinque figli era ovviamente Ninian Niven. Stranamente questa leggenda orticola è dura a morire: nel Dictonary of British Biography si legge: "suo padre, anche lui Ninian Niven, era un giardiniere di Keir House presso Stirling, e visitò due volte il Capo di Buona speranza raccogliendo piante per George Hibbert e l'imperatrice Giuseppina". Per concludere, un altro mito cinematografico. Nel notevole film Proteus, del regista canadese John Greyson, che racconta in modo romanzato la storia di due prigionieri giustiziati per sodomia in Sudafrica, compare un botanico scozzese chiamato Virgil Niven, ispirato a James Niven. A dispetto del fatto che la tragica vicenda sia avvenuta nel 1735, quarant'anni prima della sua nascita.  Iridaceae arbustive con fiori color cielo Il contributo di James Niven alla botanica e ai giardini britannici, da lui arricchiti di tante specie notevoli, è riconosciuto tanto da William Aiton, quando da Salisbury e Robert Brown, per una volta concordi. Lo ricordano gli eponimi di non molte specie sudafricane (Acmadenia nivenii, Erica niveniana, Serruria nivenii) e un genere ugualmente sudafricano, Nivenia. Glielo dedicò Ventenat sulla base di una delle molte specie da lui raccolte in Sudafrica e approdate alla Malmaison; in Decas Generum Novorum (1808) il botanico francese scrive: “questa specie è stata fornita dall’egregio Kennedy; perciò l’ho nominata dallo scopritore J. Niven, giardiniere inglese” (d'accordo, era scozzese, ma errore più errore meno...). Rispetto a questa laconica dedica, è ben più eloquente quella di Robert Brown per un secondo genere Nivenia (ovviamente non valido per la regola della priorità); dopo aver spiegato in che cosa il nuovo genere differisce da Paranomus di Salisbury, egli infatti scrive: "L’ho dunque nominato in onore di Mr. James Niven, un osservatore intelligente e un raccoglitore instancabile, con il quale i botanici sono indebitati di molte nuove specie delle due estese famiglie sudafricane delle Ericaceae e delle Proteaceae”. Nivenia Vent. è un piccolo genere della famiglia Iriaceae; insieme a Klattia e Witsenia, è uno dei soli tre generi della famiglia (tutti endemici del Sudafrica) a essere veri e propri arbusti sempreverdi, con fusti legnosi che producono vegetazione secondaria. Raggruppati nella sottofamiglia Niveoinioideae, tutti insieme comprendono appena quindici specie, contro le 1600 dell'intera famiglia (900 nel solo Sudafrica). Il genere più vasto del gruppo è proprio Nivenia, con undici specie accettate. Hanno tutte fiori azzurri e sono arbusti di medie dimensioni, con l'eccezione di tre specie a cuscino che crescono in habitat rocciosi aridi di montagna: N. levynsiae nelle Betty Bay-Kleimond Mountains, N. concinna al Viljoen Pass e N. fruticosa nel Lagenberg. Quest'ultima, di habitus quasi erbaceo e con un'infiorescenza poco vistosa di appena due fiori, fu la prima specie ad essere raccolta e descritta, da Peter Thunberg che la assegnò al genere Ixia. All'estremo opposto troviamo la specie più nota, l'unica coltivata al di fuori del Sudafrica, N. corymbosa, che cresce a Bain's Kloof e nelle montagne circostanti: gli esemplari più vecchi possono avere rami con un diametro di 4-5 cm lunghi anche tre metri. L'infiorescenza è un grande corimbo di circa 120 fiori in diverse tonalità di blu, che attirano folle di impollinatori, in particolare l'ape Amegilla fallax, dotata di una lunga ligula che le permette di raggiungere il nettare posto alla base del lungo tubo florale. A metà tra questi due specie estreme, si colloca la bella N. stokoei, un arbusto dal portamento arrotondato, che in aree protette può raggiungere il metro e mezzo, ma in aree aperte rimane molto più basso. Ha strette foglie lanceolate disposte a ventaglio che tradiscono immediatamente l'appartenenza alla famiglia, e fiori blu purissimo. E' un endemismo della Riserva della Biosfera Kogelberg. Tutte endemiche del Capo occidentale, spesso di aree estremamente limitate, purtroppo diverse specie di Nivenia sono in pericolo per la restrizione del loro habitat e anche per le conseguenze del cambiamento climatico. Tutte le sue undici specie sono incluse nella lista rossa delle piante sudafricane, due sono classificate come vulnerabili e cinque come rare. A differenza della vicina Virginia, la cui flora aveva destato l'interesse di botanici e appassionati fin dall'inizio del Seicento, perché iniziassero le ricerche naturalistiche in Maryland si dovette attendere la fine del secolo e la trasformazione in colonia reale. Evento decisivo fu la nomina a governatore di Francis Nicholson, patrono delle arti e delle scienze e deciso sostenitore della chiesa anglicana. Il vescovo Compton ne approfittò per inviare nella colonia il giovane pastore gallese Hugh Jones, nella speranza che, come Banister in Virginia, riuscisse a unire con successo l'attività pastorale alle raccolte botaniche. Ma, al contrario di Banister, Jones non sapeva nulla di piante e, nonostante la buona volontà e l'insegnamento a distanza di Petiver, ebbe molta difficoltà a conciliare i due compiti. A supportarlo nel 1698 giunsero da Londra ben due naturalisti: William Vernon, designato dalla Royal Society, e David Krieg, amico e agente di Petiver. Anche se il loro soggiorno nella colonia fu breve, segnò il vero inizio dell'esplorazione della flora del Maryland, con la raccolta di diverse centinaia di specie, in parte pubblicate da Ray nel terzo volume di Historia Plantarum. Sia Krieg sia Vernon sono celebrati da generi validi della famiglia Asteraceae: Krieg dal piccolo Krigia e Vernon dal grande Vernonia e, indirettamente, da Vernoniopsis e Vernonanthura.  Un pastore e apprendista botanico La tragica morte di John Banister fu un duro colpo per il vescovo Compton e per i botanofili londinesi che si riunivano nel Temple Coffee House Botanical Club; con essa si interrompeva il flusso di nuove piante americane garantito dalle raccolte del solerte pastore. Due anni dopo, nel 1694, la nomina a governatore del Maryland di Francis Nicholson, che durante il suo mandato in Virginia aveva favorito l'attività di Banister e più in generale l'esplorazione delle risorse naturali, riaccendeva le speranze. Si cercò un ecclesiastico che, come il defunto, potesse unire all'attività pastorale le raccolte naturalistiche. Su segnalazione di Edward Lhwyd, curatore dell'Ashmolean Museum di Oxford, un candidato non ideale ma passabile fu individuato nel gallese Hugh Jones (ca. 1671-1701), assistente di Lhwyd nella raccolta di fossili. Di piante non sapeva nulla e aveva seguito i corsi di teologia per non più di un anno, eppure il vescovo Compton, ritenendo imminente la partenza della flotta del tabacco diretta in Virginia, si affrettò ad ordinarlo pastore. Invece, a causa della guerra con la Francia, la partenza fu rinviata di mesi, permettendo al neo-reverendo di frequentare il Club e ricevere almeno un'infarinatura di zoologia e di botanica. Doody, Petiver e James Ayrey (un mercante e collezionista il cui negozio era vicino a quello di Petiver) lo accompagnarono a cercare fossili nella cava di calce di Charlton presso Greenwich e ad erborizzare nel Kent. Doody gli procurò un termometro e forse un densimetro, Petiver gli impartì istruzioni su come raccogliere e conservare ogni sorta di "collezione filosofica" e gli diede una copia della sue centurie e forse altri libri, nonché materiali come la carta necessaria per essiccare gli esemplari e bottiglie per conservare gli animali sotto spirito. Jones giunse in Maryland solo nel giugno 1696. La situazione, da ogni punto di vista, era più complessa rispetto alla Virginia. Il Maryland, la cui economia si basava principalmente sulla coltivazione del tabacco, era molto meno florido della colonia gemella; la popolazione era costituita principalmente da servi bianchi a contratto, in gran parte maschi, frequentemente falcidiati da malattie ed epidemie; l'importazione di schiavi neri era appena agli inizi ma in crescita. Le piantagioni erano per lo più piccoli appezzamenti circondati da foreste e gli spostamenti rimanevano difficili. Fino al 1689 la colonia era stata amministrato da un governatore-proprietario cattolico della famiglia Calvert, che aveva favorito una certa tolleranza religiosa; oltre a cattolici, c'erano quaccheri, non conformisti, e anche anglicani, ma senza una chiesa organizzata. Questa fu stabilita solo nel 1691, quando il Maryland divenne un colonia reale; così, quando Jones arrivò ad Annapolis, la capitale, per presentarsi al governatore Nicholson, scoprì che i suoi doveri ecclesiastici sarebbero stati tutt'altro che una sinecura. Gli fu affidata la grande Christ Church Parish, ancora scarsamente abitata ma geograficamente vasta, con due sedi che lo costringevano a faticosi spostamenti. I doveri ecclesiastici assorbirono gran parte del suo tempo, lasciandone ben poco alle "collezioni filosofiche", già di per sé problematiche per un novellino immerso in un ambiente pressoché sconosciuto e in gran parte selvaggio. I suoi sponsor londinesi furono delusi: decisamente, Jones non era un nuovo Banister: nell'autunno e nell'inverno del suo primo anno in Maryland inviò pochi esemplari, imperfettamente conservati, per lo più già noti e non accompagnati dalle dettagliate note naturalistiche e dai disegni a cui li aveva abitati il compianto pastore-naturalista. Petiver cercò di ovviare con una specie di corso per corrispondenza, inviando a Jones liste di esemplari, doppioni della sua collezione, istruzioni pratiche e libri di botanica tra cui, oltre ai suoi Musei petiveriani, Historia plantarum di Ray e Paradisus batavus di Hermann. Oltre a doni come formaggi e generi di prima necessità, nei suoi pacchi c'erano anche medicinali, visto che un pastore in quella colonia ancora in via di formazione doveva occuparsi della cura non solo delle anime, ma anche dei corpi. Due nuovi invii di Jones raggiunsero l'Inghilterra alla fine del 1697 e nel 1698, per lo più in cattive condizioni a causa del lungo viaggio; finalmente nell'autunno del 1698 Petiver ricevette una collezione ben preparata e ben conservata, anche se lamentò che si trattasse essenzialmente di fiori, senza frutti e semi, "dai quali si ricavano le caratteristiche più essenziali o la denominazione". Preoccupato di perdere la priorità rispetto al rivale Plukenet, che in Almagestum botanicum (1696) aveva già pubblicato diverse specie virginiane raccolte da Banister, sollecitò Jones a intensificare le raccolte; gli chiese anche di inviargli il maggior numero possibile di esemplari della medesima pianta, in modo che egli potesse restituirgli i doppioni con le sue osservazioni. Qualche invio giunse ancora, ma a quel punto alle difficoltà che già conosciamo si era aggiunto il declino fisico: il giovane ecclesiastico gallese si ammalò di tisi e ne morì all'inizio del 1701. 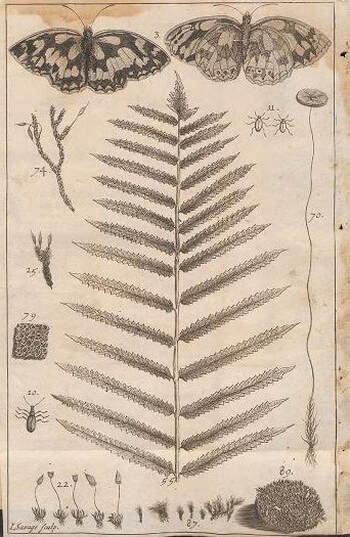 Due raccoglitori sono meglio di uno Già prima di questo infausto esito, Petiver e i suoi amici-rivali del Botanical Club e della Royal Society avevano deciso di affiancare al troppo indaffarato e troppo inesperto Jones un naturalista più preparato, ma soprattutto impegnato a tempo pieno. Nella seduta del 10 novembre 1697 della Royal Society, William Byrd II (figlio di William Byrd I, il piantatore virginiano che era stato amico, ospite ed esecutore testamentario di Banister) riferì che il governatore Nicholson intendeva offrire 25 sterline annue a un naturalista per "fare osservazioni e descrizioni di tutti i prodotti naturali di queste parti, e scriverne la storia" e chiedeva alla Royal Society di individuare la persona adatta. La scelta cadde su William Vernon (ca. 1667-ca. 1715), membro del St Peter's College di Cambridge, noto soprattutto come raccoglitore e studioso di muschi e già lodato da Ray per la profonda conoscenza della flora britannica. Ottenuti due o tre anni di congedo dall'Università, Vernon accettò l'incarico e si preparò a partire al più presto per l'America, dove contava di rimanere almeno due anni. La sua missione era sponsorizzata dalla Royal Society, quindi indirettamente dal Temple Coffee House Botanical Club; ma come sappiamo i suoi membri (in particolare Hans Sloane e James Petiver) erano divisi da una forte rivalità. Fu così che Petiver decise di giocare una seconda carta, inviando in Maryland un altro naturalista a lui legato: il medico tedesco David Krieg (1667-1713). Nato in Sassonia, quest'ultimo, dopo aver studiato all'Università di Lipsia, si era trasferito a Riga, diventando uno dei corrispondenti di Petiver, che lo aveva ospitato a casa sua quando nel 1696 egli si era spostato a Londra; inoltre lo aveva introdotto al Botanical Club e gli aveva fornito lettere di presentazione per Jacob Bobart, il prefetto dell'orto di Oxford, e per John Ray, che viveva nel suo rifugio di Black Nottley. Sicuramente nel novembre 1697, poco prima della partenza di entrambi per il Maryland, incontrò anche Vernon, ma i due viaggiarono separatamente e anche più tardi non raccolsero insieme, divisi da una presumibile rivalità; l'inglese arrivò in colonia nel marzo 1698, il tedesco (accompagnato dal "cacciatore di farfalle" di Petiver, un ragazzo chiamato Isaac) vi giunse due settimane dopo. Si era pagato il viaggio servendo come chirurgo di bordo, mentre il giovane Isaac forse viaggiò come ragazzo di cabina. Krieg dovette mettersi immediatamente all'opera, mentre Vernon, che dipendeva dal governatore e era tenuto a concordare le sue mosse con lui, dovette iniziare le raccolte solo a maggio. Non conosciamo nei particolari gli itinerari di nessuno dei due. Certamente visitarono Annapolis e i suoi dintorni ed esplorarono la costa orientale della baia di Chesapeake. L'unica lettera superstite di Krieg, scritta a maggio, ne attesta la presenza nel basso corso del Choptank River, mentre da una lettera inviata a luglio da Vernon a Sloane sappiamo che egli al momento si trovava ad Annapolis ed aveva già deciso di tornare in Inghilterra alla fine dell'estate. Non conosciamo le ragioni di questo rientro anticipato: alcuni hanno parlato di dissapori con il governatore Nicholson, altri al contrario ritengono che Vernon abbia preferito rinunciare piuttosto che rimanere in quella difficile colonia dopo la partenza del suo protettore; Nicholson infatti si accingeva a lasciare il Maryland per assumere nuovamente il governo della Virginia. Dunque, dopo circa cinque mesi di raccolte, lasciata l'America forse a settembre o a ottobre, tra novembre e dicembre sia Vernon sia Krieg erano nuovamente a Londra. Vernon presentò alcuni esemplari in una delle sedute del venerdì del Temple Coffee House Botany Club e gli sponsor si spartirono il bottino: Petiver fece la parte del leone, ricevendo da Krieg piante, insetti e conchiglie e molti esemplari anche da Vernon; altri li ottenne Sloane, altri ancora il vescovo Compton (che però lamentò che ci fossero pochi semi) e l'arcivescovo di Canterbury Tenison. Attraverso Sloane e Petiver, diverse centinaia di nuove specie furono inviate per l'identificazione a Ray, che incontrò molte difficoltà sia per l'incompletezza degli esemplari sia per la mancanza di note di accompagnamento; in ogni caso, nel terzo volume di Historia plantarum (uscito nel 1704) poté elencare 450 specie originarie del Maryland e determinarne 225. Tra il 1698 e il 1702 diverse specie furono inoltre pubblicate sulle Transactions della Royal Society da Petiver. Né Ray né Petiver (né Plukenet, che a sua volta pubblicò alcune specie del Maryland in Almatheum Botanicum, uscito nel 1705) indicano il nome dei raccoglitori, quindi non sappiamo che cosa fu raccolto rispettivamente da Jones, Vernon e Krieg. Nonostante il cambiamento di programma e le difficoltà incontrate da Ray, le raccolte dei due "inviati speciali" dovettero soddisfare a sufficienza le aspettative della Royal Society: nella seduta dell'11 gennaio 1699 fu deliberata sia l'ammissione di Krieg sia lo stanziamento di 20 sterline per inviare Vernon a caccia di piante nelle Canarie. Quasi immediatamente, egli si recò a Deale per imbarcarsi, ma mancò la partenza della flotta. Quando scoprì che non erano previste altre partenze prima di novembre, decise di rimanere a fare raccolte nel Kent e nei dintorni di Canterbury fino all'autunno. Ma ormai aveva perso la voglia di viaggiare. La missione alle Canarie sfumò, Vernon continuò per qualche anno a raccogliere in Inghilterra, specializzandosi in briofite e nel 1702 ritornò a Cambridge. Poco alla volta anche i suoi contatti con l'ambiente dei botanici e dei botanofili vennero meno, tanto che non sappiamo praticamente nulla dei suoi ultimi anni, neppure dove e quando morì. Il destino di Krieg dopo l'avventura americana fu amaro. Rimase a Londra ancora qualche mese, occupato a riordinare le sue raccolte e forse a fare disegni per Petiver; a maggio si imbarcò per Riga, dove era di ritorno il 14 giugno 1699. Per due anni esercitò la medicina nella città baltica, che offriva ben poche opportunità a un naturalista, come lamenta nelle lettere all'amico Petiver. Nel 1701 fu assunto come medico personale da Louis de Guiscard-Magny, ambasciatore della Francia in Svezia; lo raggiunse a Stoccolma e lo accompagnò a Parigi, dove ebbe modo di frequentare il Jardin des Plantes e conoscere Plumier e Vaillant. Quando scoprì che l'ambasciatore lo voleva al suo fianco come medico militare nella campagna prevista per l'anno successivo, decise di tornare a Riga. Lo faceva con riluttanza; avrebbe preferito un clima più caldo, magari un viaggio nelle Antille al servizio dell'amico Petiver. Lasciata Parigi nella primavera del 1702, dopo una breve visita a Strasburgo, dove viveva un fratello chirurgo, e alla famiglia a Schwarzeburg, nel gennaio 1703 era di ritorno a Riga. Anche se erano anni difficili per la città baltica a causa della Grande guerra del Nord tra Russia e Svezia, continuò a fare raccolte naturalistiche, nella speranza di scrivere una storia naturale della Livonia; si mantenne in contatto con gli amici inglesi, inviando loro curiosità, insetti e minerali, e ricevendo in cambio libri e strumenti. Il suo sogno era lasciare quella città provinciale dove nessuno condivideva i suoi interessi e tornare in America, o per lo meno a Londra. Ma rimase appunto un sogno. Nel 1710 Riga fu posta sotto assedio dai Russi; in città scoppiò una pestilenza che, insieme alla fame, fece 22.000 vittime. Una di loro era Krieg.  Asteraceae grandi e piccole Nessun botanico ha pensato di rendere omaggio a Jones, mentre sia Krieg sia Vernon sono onorati da almeno un genere di Asteraceae. Krigia e Vernonia, ben diversi per grandezza e distribuzione, si devono al botanico tedesco Johann Christian Daniel von Schreber, che li pubblicò nel 1791 nella sua riedizione del linneano Genera Plantarum, purtroppo senza alcuna dedica esplicita. Krigia è un piccolo genere di 7 specie, distribuite tra il Canada sud-orientale, gli Stati Uniti centrali e orientali e il Messico nord-orientale. Sono erbacee perenni o annuali, con una radice fibrosa o a fittone da cui emergono gambi eretti e solitamente non ramificate, con foglie lanceolate, dentate o lobate a rosetta e capolini per lo più solitari, gialli o arancione, molto simile a quelli dei generi Hieracium e Pilosella. Vernonia è invece un grande genere cosmopolita cui sono attribuite quasi 350 specie, ma inteso in senso lato è giunto a comprenderne anche 1000; va inoltre considerato che le specie in aree in contatto tendono ad ibridarsi con facilità. Gli studi hanno identificato due centri di biodiversità: uno in America, l'altro in Africa e nell'Asia sud-orientale. Possono essere erbacee annuali o perenni, spesso di grandi dimensioni, arbusti da piccoli a grandi, rampicanti o piccoli alberi, con foglie alternate semplici, da lanceolate a strettamente lineari. I capolini, raccolti in cime o corimbi terminali o ascellari, sono composti da un involucro a coppa o cilindrico formato da 5-6 serie di brattee embricate che proteggono il ricettacolo sul quale si inseriscono i flosculi tubolosi, usualmente bisessuali e fertili. La corolla tubolare e lobata può essere viola, blu o anche bianco-crema. I frutti sono acheni dotati di pappo. Diverse specie nordamericane sono coltivate nei giardini. Tra di esse V. arkansana (spesso commercializzata come V. crinita), originaria degli Stati Uniti centrali, un'alta perenne che tra agosto e settembre produce grandi capolini viola dall'aspetto un po' scompigliato; la rusticissima V. fasciculata, nativa di una fascia che va dal Manitoba in Canada agli Stati Uniti centro-settentrionali, che produce alti steli non ramificati che culminano in un denso corimbo di fiori magenta; V. lettermannii, originaria dell'Arkansas e dell'Oklahoma, con foglie filiformi e centinaia di piccoli fiori viola scuro; simile è V. noveboracensis, che tende ad espandersi con stoloni sotterranei, con fiori viola, ma anche lilla e bianchi. Diverse specie africane, come V. colorata, sono utilizzate come verdura da foglia; dato che crescono rapidamente e si rigenerano dopo i tagli, producendo una grande massa di foraggio che resiste molto bene alla siccità, sono note, oltre che con diversi nomi locali, con il nome inglese ironweed, erba di ferro, dovuto ai fusti rigidi e talvolta color ruggine, ma anche alla veloce crescita e alla robustezza. La specie più importante di questo gruppo, la più consumata nonché ingrediente dello Ndolé, il piatto nazionale del Cameroon, V. amygdalina, è stata trasferita al genere Gymnanthemum come G. amygdalinum; è anche una importante pianta medicinale. Secondo Plants of the World on line (ma l'accordo non è universale) va ricondotta a questa specie come sinonimo anche Vernonia condensata, poi Vernonanthura condensata, in precedenza ritenuta un endemismo brasiliano, mentre si tratta appunto di una specie africana, introdotta all'epoca della tratta degli schiavi. Dai semi di V. galamensis viene invece ricavato un olio con un alto contenuto di acido vernolico, utilizzato nell'industria delle vernici e come plastificante. Oltre ad essere il patrono dell'importantissimo genere Vernonia, William Vernon è celebrato indirettamente anche da due dei tanti generi che ne sono stati separati, Vernoniopsis e Vernonanthura. Il primo ("simile a Vernonia") è un genere endemico del Madagascar, con una o due specie di arbusti o piccoli alberi con corimbi terminali di numerosi capolini con lungo ricettacolo e corolla biancastra. Il secondo (da Vernonia + anthura, da anthera e oura "coda", in riferimento alle antere con base frequentemente caudata) è un grande genere separato nel 1995 da Vernonia, da cui differisce per la distribuzione più meridionale (dal Messico all'Argentina, passando per le Antille), le infiorescenze piramidali o tirsoidi anziché corimbose, l'habitus tipicamente arbustivo con steli legnosi fin dalla base anziché erbacei, e appunto le antere con code prominenti alla base. Il genere comprende una sessantina di specie; la più nota era probabilmente Vernonanthura condensata che, come abbiamo visto è stata trasferita a Gymnanthemum ed è per lo più ritenuta sinonimo di G. amygdalinum. Anche in questo genere troviamo piante interessanti per i nostri giardini, come V. nudiflora (in precedenza Vernonia angustifolia), un arbusto originario del Brasile e dell'Argentina, con foglie lineari e bei fiori viola. V. polyanthes ci ricorda invece quanto è pericoloso introdurre specie aliene in ambienti fragili: nativa del Brasile, all'inizio degli anni '90 del Novecento è stata introdotta in Mozambico come pianta nettarifera per le api; da qui si è diffusa nel vicino Zimbabwe e in diversi ambienti è rapidamente diventata una specie dominante ai danni della vegetazione nativa. Dopo la tulipomania, che nel Seicento bruciò tanti capitali, nel Settecento infuriò la giacintomania. Tra le sue vittime, sir James Justice, un legale scozzese che dilapidò tutta la sua fortuna per coltivare piante rare, tra cui appunto i preziosi giacinti doppi che acquistava a caro prezzo in Olanda. Grande sperimentatore di tecniche di coltivazione, fu probabilmente il primo a far fruttificare gli ananas in Scozia, creando per loro una serra riscaldata all'avanguardia. Un successo che gli guadagnò la quasi immediata ammissione alla Royal Society. Nell'arco di pochi anni, alle prese con debiti sempre più enormi, fu costretto a vendere la tenuta di Crichton dove aveva creato il più raffinato giardino di Scozia. Seguirono processi, un divorzio, l'ignominia del carcere per debiti, l'espulsione dalla Royal Society per morosità. Alla sua morte, alla vedova e al figlio bambino rimase un capitale di 60 sterline, ovvero il prezzo a cui veniva venduto al momento della sua apparizione il giacinto 'Gloria florum suprema'. A ricordare Justice rimangono il notevole The Scots Gardiners Director, ma soprattutto il genere Justicia, oggi il più vasto della famiglia Acanthaceae.  Giacinti e giacintomania Il 22 ottobre 1730 la Royal Society ammise un nuovo membro, presentato dal presidente in persona sir Hans Sloane, dal capo giardiniere di Chelsea Philip Miller e da John Martyn, che due anni dopo sarebbe stato nominato professore di botanica a Cambridge. Il nuovo socio era un legale scozzese, sir James Justice (1698-1763), alto funzionario della corte di Edimburgo (Principal Clerk to the Court of Sessions), ma soprattutto appassionato giardiniere. Ad attirare l'attenzione di sponsor tanto prestigiosi erano stati i suoi esperimenti orticoli. Sfidando il rigido clima scozzese, nella sua tenuta di Crichton, a circa 20 km a sud di Edimburgo, egli si era fatto costruire una serra riscaldata all'avanguardia (tra l'altro, una delle poche all'epoca ad avere anche il tetto vetrato) dove era riuscito a fare fruttificare gli ananas. Vi coltivava anche banani, guaiave, piante del cacao e del caffè; era riuscito a far fruttificare anche queste ultime, che avevano dato semi fertili da cui erano nate pianticelle. Fu il momento di massima gloria di Justice, che per tutta la vita (anche quando, come vedremo, non ne aveva più diritto) fece sempre orgogliosamente seguire al suo nome la sigla FRS, Fellow of Royal Society. All'epoca aveva poco più di trent'anni e aveva cominciato i suoi esperimenti orticoli forse intorno al 1727. Apparteneva a una facoltosa famiglia di mercanti e legali scozzesi, la cui parabola - tanto per rimanere nei cliché - ricorda quella dei Buddenbrook. All'inizio, ovviamente, c'è un fondatore, in questo caso il mercante James Justice (morto nel 1711) che fu bailie (magistrato municipale) e prevosto di Edimburgo e acquistò la proprietà di Crichton. Il rappresentante della seconda generazione, anche lui James, entrò a fare parte della nobiltà di toga, aggiungendo un titolo baronale alla tenuta e divenendo Principal Clerk to the Court of Sessions, incarico che mantenne fino al 1727, quando vendette la carica e la riacquistò per il figlio; la terza generazione è appunto quella di James il botanico. Infine la dinastia si chiude con il quarto James, l'unico figlio sopravvissuto, militare noto come "Captain Justice", eccentrico quanto il padre (anche se la sua passione andava più alle fanciulle che ai fiori). La passione del padre James III per l'orticultura era nata in Olanda, dove era stato inviato a laurearsi in giurisprudenza, secondo una consuetudine abituale nella Scozia del tempo. Mentre non provava alcun interesse per la carriera legale, si innamorò dell'orticoltura e del vivaismo olandesi. Per impadronirsi delle tecniche di coltivazione più aggiornate, oltre a frequentare assiduamente i vivai di Haarlem, in un lungo grand tour orticolo dovette visitare anche la Francia ( dove si interessò soprattutto della coltivazione a spalliera di peschi e altri alberi da frutto) e l'Italia. Non conosciamo le date di questo viaggio, che probabilmente si protrasse per diversi anni. Al suo rientro in Scozia, Justice era un raffinato gentiluomo per padroneggiava l'inglese senza "scotismi", il latino, l'olandese e il francese, conosceva bene la letteratura botanica del tempo e le nuove tecniche orticole messe a punto nel continente. Era ansioso di sperimentarle per "migliorare" la tenuta di Crichton. Come il padre era infatti membro della Honourable Society of Improvers in the Knowledge of Agriculture in Scotland, che si proponeva di migliorare l'orticoltura scozzese introducendo tecniche che aumentassero le rese. Certamente piantò alberi e introdusse migliorie nella gestione della tenuta, ma soprattutto si concentrò sulla coltivazione delle esotiche, facendo costruire per loro una serra all'epoca quasi avveniristica. Il suo interesse principale dovette però transitare ben presto alle piante da fiore, in particolare le bulbose. Nel 1730 infatti lo troviamo a Bruxelles, per studiare le tecniche di coltivazione di François Beaulinx, specialista nella produzione di tulipani Bizard da seme. Altri contatti nelle Fiandre e in Olanda erano Jan van Leuwen di Rotterdam, famoso per i suoi Iris persica azzurri, e soprattutto i vivai van Zompel e Voorhelm di Haarlem. Questi ultimi furono all'origine della giacintomania che infuriò in Olanda nella prima metà del Settecento. I giacinti Hyacinthus orientalis all'epoca erano abbastanza diversi da quelli che coltiviamo oggi. Quelli a fiore singolo avevano pannocchie piuttosto rade, con fiori piccoli, ancora simili alle forme selvatiche; occasionalmente nascevano piante a fiore doppio, che inizialmente non suscitarono alcun interesse, anzi i vivaisti si affrettavano a scartarle perché sterili. Nel 1684 il vivaista di Haarlem Peter Voorhelm cadde ammalato, lasciando il vivaio per qualche tempo abbandonato a se stesso; quando poté occuparsi della cernita dei giacinti, ne trovò uno doppio particolarmente bello; scoprì anche che ai suoi clienti piaceva ed erano disposti a pagarlo di più degli altri. Continuò a coltivarlo e a sviluppare nuove varietà. La prima ad aver successo e a scatenare la giacintomania fu 'Koning for Groot Brittanien' (così chiamata in onore di Guglielmo d'Orange, re d'Inghilterra come Guglielmo III), con fiori bianchi e cuore rosa intenso, una robusta varietà ancora segnalata da Loudon all'inizio dell'Ottocento. Al suo apparire, nel 1702, un singolo bulbo costava l'equivalente di 100 sterline. I prezzi erano così alti perché i giacinti doppi erano rari, ci volevano cinque anni per portarli a fioritura, e con il loro insieme di colori eccitavano il gusto del bizzarro, proprio come i tulipani variegati all'origine della tulipomania. La giacintomania raggiunse il suo apice negli anni '20-'30 del 1700, ovvero esattamente nel periodo in cui Justice frequentò l'Olanda prima come studente poi come acquirente di bulbi. I Voorhelm continuavano ad essere il vivaio leader di questa produzione, ma ora erano affiancati da molti altri produttori che ogni anno immettevano sul mercato centinaia di varietà. Tuttavia, avevano imparato la lezione dal crollo della bolla dei tulipani, e nei loro cataloghi offrivano un'ampia gamma di giacinti dai prezzi diversificati, riuscendo a mantenere alti quelli delle novità più pregiate. Così due produzioni dei Voorhelm (molto ammirate da Justice) 'Gloria Mundi', azzurro chiaro con cuore blu scuro, e 'Gloria Florum suprema', bianco neve con cuore scarlatto, al loro apparire furono venduti rispettivamente a 500 e 600 fiorini a bulbo, cioè 50 e 60 sterline. I prezzi raggiunsero il picco tra il 1733 e il 1736, per poi crollare quasi all'improvviso: il mercato ormai era saturo, le varietà veramente di valore erano introvabili, e per vendere i vivaisti furono costretti a tagliare i prezzi. Nei cataloghi del 1738 vediamo 'Staaten General' passare da 210 a 20 fiorini e 'Gekroont Salomon’s Jewel' da 80 a 3. 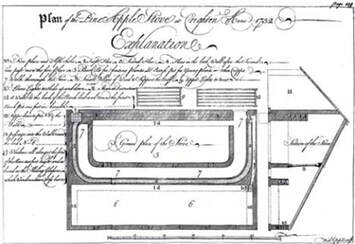 Rovinarsi per le piante In Olanda Justice si era innamorato dei giacinti e non se li fece mancare nel giardino di Crichton, in stile francese, considerato il più bello e raffinato della Scozia. Quanto avesse pagato i suoi giacinti e le innumerevoli altre bulbose che li affiancavano non sappiamo. Ma certo fu vittima, se non della sola giacintomania, della sua irresistibile passione per il giardinaggio. Non badava a spese per far venire bulbi dall'Olanda e per acquistare piante e semi tanto a Londra quanto in Scozia. I guai arrivarono presto; i debiti erano tanti che, per salvare il salvabile, il padre James II predispose un atto di successione a favore del nipote anziché del figlio e si risolse a vendere la tenuta. Nel 1738, poco più di un anno dopo la sua morte, la vendita fu infine conclusa dal nostro James III, con un ricavo di 7000 sterline. Egli tentò anche di impugnare l'atto paterno, ma vi rinunciò, vedendo che era insufficiente a tacitare i creditori. Pagati almeno una parte dei debiti, investì quanto gli rimaneva in una tenuta di minore estensione chiamata Ugston nella parrocchia di Channelkirk (Berwikshire) che da quel momento fu ribattezzata Justicehall. Anche qui piantò alberi e coltivò bulbose, tanto che uno studioso di storia locale ha raccolto la voce che facesse addirittura arrivare la terra dall'Olanda per offrire agli amati bulbi la terra natìa; la notizia è improbabile (come vedremo, tra i più importanti esperimenti di Justice vi era la produzione di terricci su misura per le varie coltivazioni), ma ci dice molto sulla fama di eccentricità del personaggio. A rovinare del tutto la sua reputazione, ai debiti si aggiunse lo scandalo: iniziò una relazione con una giovane domestica e la moglie chiese il divorzio. Ne seguì un'intricata vicenda processuale in cui Justice arrivò ad accusare un ex amico di aver tentato di assassinarlo. Erano condotte che la puritana società scozzese non era disposta a tollerare; così, nell'ottobre 1744 Justice se ne andò in volontario esilio nell'Inghilterra settentrionale, con il risultato di contrarre altri debiti. Tornato in Scozia nel novembre 1746, prese in affitto una casa con giardino ad Edimburgo; era sempre più perseguitato dai creditori (in una lettera li chiama "diavoli") e nel 1748 subì anche una breve incarcerazione per debiti, da cui fu liberato grazie alla malleveria di lord Milton, alto magistrato e suo lontano cugino; con il suo aiuto, cercò inutilmente di liberarsi dell'odiato lavoro in tribunale. Nel 1750 si sposò con la ragazza dello scandalo, che però presto si ammalò e dopo appena due anni lo lasciò vedovo. Seguì un terzo matrimonio, e nel 1755, ormai quasi sessantenne, gli nacque l'unico figlio superstite (il maggiore era morto nel 1750). Nel 1757, non avendo pagato da anni la quota associativa, subì lo smacco di essere espulso dalla Royal Society. Nel 1758 si trasferì nella sua ultima casa, nel distretto di Leigh, dove sarebbe morto nel 1763. Anche qui c'era un giardino, che riempì di fiori, tra cui una spettacolare collezione di auricola; erano piante di grande valore, su cui contava per garantire un gruzzoletto alla moglie e al figlioletto dopo la sua morte. Invece quando la vedova le mise in vendita, ne ricavò solo 20 sterline, un terzo dell'eredità che le rimaneva.  Una guida per i giardinieri scozzesi Nel 1754, a suo dire cedendo alle pressioni di amici ed estimatori, Justice si risolse a mettere per iscritto quanto aveva appreso dalle sue esperienze trentennali in ogni campo dell'orticoltura, trasfondendole in una guida all'orto famigliare e al giardino, The Scots Gardiners Director. Anche se l'identità dell'autore era un segreto di Pulcinella, inizialmente la pubblicò anonima (era pur sempre un rispettabile funzionario); il nome compare nell'edizione del 1759, intitolata The British Gardener's New Director; nell'edizione riveduta del 1764 (uscita postuma) tutte le remore sono cadute: sir James arriva a reclamizzare e porre in vendita alcune delle sue produzioni. Il libro è interessante da diversi punti di vista. Era una delle prime pubblicazioni del genere in Scozia (grazie ad essa, Justice è stato definito il padre dell'orticultura scozzese) ed ebbe un notevole successo, venendo ristampato anche in Irlanda. Era anzi la prima ad essere concepito appositamente per il clima e i terreni della Scozia, tanto diversi da quelli della più temperata e fertile Inghilterra. Soprattutto, non aveva nulla di libresco e si basava su esperienze di prima mano, esposte dall'autore in modo dettagliato e potremmo dire generoso. Così, le pagine di The Scots Gardiners Director sono per noi una specie di macchina del tempo per conoscere le pratiche orticole del Settecento, i successi e i fallimenti di sir James e il mondo del vivaismo olandese (egli vi riportò interi cataloghi delle loro produzioni, in particolare quelle dell'amico Joris Voorhelm, autore a sua volta di uno dei primi trattati sui giacinti). Il volume è diviso i due parti. La prima è dedicata all'orto famigliare; è un orto-frutteto, un walled garden recintato da muri che lo proteggono dal rigido clima settentrionale. Justice fornisce dettagliate istruzioni sull'esposizione ideale, sulla scelta dei fruttiferi più adatti, sulla coltivazione a spalliera e la potatura; spiega come allestire lettorini caldi (incluso uno per i funghi) e muri riscaldati dotati di intercapedini dove far passare aria calda per far maturare l'uva e altri frutti che non riuscirebbero a farlo nel clima scozzese. Non dimentico del suo primo successo, non trascura la coltivazione degli ananas e offre ai lettori due progetti di serre calde. La prima parte si conclude con la rassegna delle orticole e delle erbe aromatiche. La seconda parte (è una novità non trascurabile) è interamente dedicata alla coltivazione dei fiori; si intitola etimologicamente Anthologia, selezione di fiori, e occupa un po' di più della metà del volume. Mentre le piante da aiuola, ad eccezione di poche specie, sono trattate spesso sommariamente, a fare la parte del leone sono le bulbose, che Justice espone seguendo il ritmo delle stagioni, iniziando con l'aconito d'inverno, ovvero Eranthis hyemalis, e i bucaneve, per terminare con i colchici autunnali. E così, con dovizia di indicazioni sulle varietà, la coltivazione, la semina, la preparazione dei terreni, ecco sfilare le epatiche, a proposito delle quali Justice confessa un insuccesso: ripetendo le semine per molti anni, è riuscito a ottenere diversi colori e forme semidoppie, ma mai le varietà doppie disponibili in Olanda; gli economici crochi che l'amico Voorhelm (ne propone 12 varietà) vende a 1 fiorino per 100 bulbi; gli aristocratici iris persiani, che si acquistano a Rotterdam ed è impossibile riprodurre da seme, ma possono essere forzati in vaso per ornarne la casa all'inizio della primavera; i narcisi, di cui ci sono innumerevoli varietà e tipi, da piantare in massa 100 alla volta; i ciclamini rustici; il colchico di Spagna, ovvero Bulbocodium vernum; il dente di cane Erythronium dens-canis. Su Fritillaria meleagris si dilunga per illustrare le tecniche di semina che gli hanno permesso di ottenere sette varietà del tutto nuove entrate a far parte del catalogo Voorhelm; segue la corona imperiale F. imperialis, gloria dei vivai olandesi che la chiamano William Rex e ne offrono almeno quindici varietà. Tra le rarità dei loro cataloghi c'è anche quello che chiamano Lilium persicum, in cui riconosciamo F. persica. A questo punto entrano in scena i giacinti "una delle principali bellezze della primavera". Justice - dichiara subito che sono la sua pianta preferita - dedica loro moltissime pagine, con dettagliate istruzioni su come trattare i bulbi giunti dall'Olanda, su come allestire una root-room per conservarli e moltiplicare i bulbi, sulle semine e sul terriccio ideale, che egli prepara secondo una ricetta di sua elaborazione che comprende sabbia, letame maturo e compost di foglie. Ne aveva già parlato nel suo primo scritto noto, Directions for propagating Hyacinths, pubblicato nel 1743 nelle Transactions della Hourable Society of Improvers. Per i giacinti Justice ha speso capitali, ma anche ottenuto grandi successi; mentre i suoi conterranei, sono costretti a sostituire continuamente i bulbi, lui grazie al suo terriccio e alle perfette tecniche di coltivazione riesce a mantenere i fiori grandi come il primo anno; non parliamo poi delle semine, che gli hanno permesso di ottenere novità di pregio. Nel 1764 Voorhelm gliene dedicherà una commemorativa, 'Mijnherr Justice', un bianco singolo con tocchi di rosa. Justice spiega anche come forzare i bulbi in caraffe di vetro, una tecnica messa a punto pochi anni prima in Svezia e introdotta nel Regno unito dal corrispondente Philip Miller. Per pagine e pagine, egli si profonde quindi nella descrizione di dozzine di varietà; quelle a fiore singolo (10 bianchi, 10 rosa, 16 blu scuro e 20 azzurro chiaro) ammette di averle coltivate tutte; ovviamente va pazzo (e sappiamo fino a che punto) per quelle a fiore doppio, ma forse neppure lui avrà sperimentato tutte le 86 varietà offerte nel 1752 da Voorhlem e van Zompel, che però descrive puntigliosamente, certo in più di un caso per conoscenza diretta. Tra di esse le costosissime 'Gloria mundi' e 'Gloria florum suprema. Ma a suo parere "i più belli dei doppi per il loro colore ammirevole" sono i rossi, di cui menziona 9 varietà. Dopo i giacinti, tocca ai tulipani. Forse sono stati una passione giovanile, e non li trascura, ma è chiaro che il suo cuore va ai giacinti, tanto che non hai mai provato a riprodurli per seme. A paragone, dedica più spazio ai ranuncoli, di cui invece ha praticato la semina su larga scala, ottenendo parecchie pregevoli varietà. Lasciate le bulbose, come si è detto la trattazione si fa più scarna, con qualche eccezione, come le primule orecchie d'orso (Primula auricola); negli ultimi anni della sua vita, quando non disponeva più dei larghi spazi delle tenute di campagna, ma solo di un piccolo giardino urbano, hanno sostituito nel suo cuore i giacinti e per ospitarle degnamente ha persino inventato un apposito scaffale con ripiani doppi. Un'altra eccezione è l'astro della Cina Callistephus chinensis; si trattava in effetti di una new entry nei giardini europei. I primi semi erano approdati dalla Cina al Jardin des plantes di Parigi intorno al 1730 (se ne attribuisce erroneamente l'invio a padre Incarville, che però all'epoca viveva in Canada); qui se li era procurati Philip Miller che aveva incominciato subito a seminarli e a sperimentare la creazione di diverse varietà, ottenendo dopo molti anni le prime doppie. Probabilmente Justice ottenne i semi da lui e ne sperimentò la semina ripetuta, separando i semi delle piante più promettenti, fino a riuscire a produrre addirittura una forma doppia bicolore, che secondo la sua biografa Priscilla Minay rivaleggia con le migliori varietà moderne.  Un grande genere pantropicale Anche se ci è rimasta solo una delle lettere di Justice a Miller, scritta poco dopo l'amissione alla Royal Society, è probabile che i due abbiano corrisposto per molti anni; erano uniti dalle origini scozzesi e da un approccio molto simile all'orticoltura, fatto di prove ed esperimenti ripetuti con tenacia e caparbietà. Forse un conoscente comune era un terzo scozzese, il chirurgo William Houstoun; in un passo di The Scots Gardiners Director Justice mostra di conoscere le sue ricerche su Mirabilis jalapa, mentre Houstoun lo stimava abbastanza da dedicargli uno dei suoi generi di piante americane. Fatto proprio e validato da Linneo, Justicia è oggi il più vasto genere della famiglia Acanthaceae. Distribuito nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo, comprende al momento attuale oltre 900 specie di erbacee perenni, arbusti e suffrutici di morfologia piuttosto variabile; tra i tratti comuni, foglie con nervature molto evidenti e fiori tubolari caratterizzati da una corolla bilabiata con labbro superiore bilobato e labbro inferiore trilobato. Nella sua storia tassonomica, i confini di questo genere si sono più volte modificati. Nella prima metà del Novecento, prevaleva la linea di riconoscere come separati una serie di generi più piccoli, i più noti dei quali per giardinieri e appassionati sono Jacobinia e Beloperone. Nel 1988, uno studio di W. A. Graham ha inaugurato la linea opposta, con un vastissimo genere Justicia diviso in 16 sezioni e 7 sottosezioni, in cui sono confluiti molti generi minori. La soluzione continua a prevalere ed è stata confermata da studi recenti, ma è anche contestata sulla base di evidenze molecolari che dimostrano che Justicia nel senso di Graham è largamente parafiletico, ovvero artificiale. In attesa di cambiamenti che non mancheranno, godiamoci la bellezza di queste piante, apprezzate in natura da farfalle, api e colibrì e da tutti noi nei giardini o nelle serre (purtroppo, con l'eccezione parziale di J. americana, non sono rustiche). E' probabile che molti giardinieri e appassionati conoscano le due specie più note e coltivate sotto i vecchi nomi. La prima è Justicia carnea, in precedenza Jacobinia carnea, un arbusto di origine brasiliana (uno dei centri di diversità del genere) apprezzato per le spettacolari spighe di fiori tubolari rosa. La seconda è Justicia brandegeeana, in passato Beloperone guttata, nota nei paesi anglofoni con il curioso nomignolo shrimp plant, ovvero pianta gamberetto. A suggerirlo sono la forma e il colore delle brattee che sottendono i fiori sovrapposti come i segmenti della corazza di questo crostaceo. Comunque la si voglia chiamare, è un arbusto piacevole e dalle fioriture singolari, che dove il clima lo consente si protraggono per mesi. Tra le altre specie di questo numerosissimo genere, vale la pena di ricordare J. aurea, simile a J. carnea, ma con infiorescenze gialle; J. floribunda, un piccolo arbusto con fiori tubolari penduli bicolori gialli e scarlatti che qualcuno chiama molto impropriamente "fuchsia brasiliana"; la messicana J. spicigera, propria delle foreste aride, con brillanti infiorescenze aranciate, nota anche per le sue proprietà medicinali come depurativo e stimolante. Approfondimenti su queste e altre specie nella scheda. Per Robert Brown, la partecipazione alla spedizione Flinders segnò l'inizio di una lunga e operosa carriera scientifica. Dopo il viaggio e le raccolte, venne il momento dello studio e delle pubblicazioni, la più ceelebre delle quali è Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van-Diemen che ne fa il padre della botanica australiana. Successivamente bibliotecario e curatore delle collezioni della Linnean Society, ultimo bibliotecario di Banks, curatore delle collezioni banksiane del British Museum, capo del Dipartimento di botanica dello stesso, presidente della Linnean Society, fu una figura di spicco della botanica britannica, anche se il suo carattere schivo e la meticolosa lentezza del suo lavoro tesero a isolarlo dalle nuove generazioni. Di grande importanza i suoi contributi alla tassonomia e gli studi sul polline, il nucleo cellulare, la differenza tra gimnosperme e angiosperme. Mentre studiava il polline al microscopi, le sue osservazioni sconfinarono nella fisica, con la scoperta di quello che più tardi verrà chiamato "moto browniano". A ricordarlo, oltre a diverse località, australiane o meno, e moltissimi eponimi, i generi australiani Brunonia e Brunoniella. 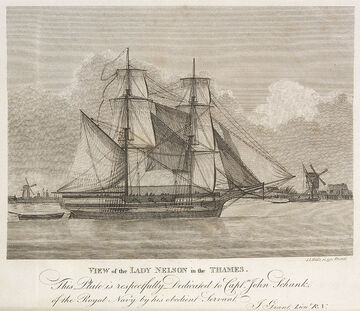 L'ultimo viaggio: Tasmania Quando Robert Brown accettò la proposta di Banks di unirsi alla spedizione Flinders, anche se il suo nome era già piuttosto noto nei circoli botanici britannici, soprattutto come esperto di crittogame (varie felci e muschi da lui raccolti furono pubblicati in Fasciculi plantarum cryptogamaticarum Britanniae da Dickson, con il suo permesso, ma senza citarlo), come aiuto chirurgo di un reggimento di stanza in Irlanda non aveva molte prospettive. La spedizione in Australia fu la grande occasione che attendeva. In tre anni e mezzo, con l'aiuto del giardiniere Good e del pittore Ferdinand Bauer, raccolse più di 3400 esemplari botanici (cui vanno aggiunti animali e minerali), anche se una parte considerevole di queste raccolte andò perduta durante il naufragio del Purpoise, Già prima di quella sventura, lui e Bauer avevano deciso di accettare l'invito del governatore King di continuare ad esplorare la flora della colonia. Per qualche mese, alternò l'esplorazione dei dintorni di Port Jackson con la sistemazione delle proprie raccolte, descrivendo molte piante, momentaneamente classificate secondo il sistema linneano, nel manoscritto intitolato Descriptorium plantarum Novae Hollandiae que in fasciculis parvis Continentur, finché il 28 novembre 1803 si imbarcò sulla Lady Nelson, inviata a Port Phillipp per trasferire in Tasmania i coloni di quell'insediamento che si era rivelato poco propizio. Non appena la nave raggiunse lo stretto di Bass, incontrò un tempo così ostile che fu costretta a rifugiarsi nelle isole del Kent Group, dove rimase bloccata per quasi un mese. Brown approfittò della sosta forzata per esplorare la flora della Deal Island, soprattutto le piante marine. Verso la fine del mese, sopraggiunse la Francis, diretta a Port Dalrymple sulla costa settentrionale della Tasmania. A bordo c'era un gruppo di esploratori incaricati di verificare se la zona era adatta a ospitare la nuova colonia. Poiché la nave era stata alquanto danneggiata dalla tempesta, fu deciso che sarebbe rientrata a Port Jackson per riparazioni, mentre la Lady Nelson l'avrebbe sostituita nella missione, dirigendosi a sua volta a Port Dalrymple, dove gettò l'ancora il giorno di Capodanno 1804. Sino al 18 gennaio, quando salpò per Port Phillipp, vennero esplorate la baia e il corso del fiume Tamar; Brown partecipò a varie spedizioni, ma la stagione già avanzata limitò le sue raccolte. Gli esploratori si trovarono alle prese con un incendio e ci furono anche diversi incontri non molto amichevoli con gruppi di indigeni. Quando infine la Lady Nelson arrivò a Port Phillipp, il governatore Collins aveva già deciso che il nuovo insediamento sarebbe sorto alla foce del fiume Derwent (si tratta dell'odierna Hobart). Così il 30 gennaio la nave ripartì per trasportarvi il primo contingente di coloni. A bordo c'era anche Robert Brown, che nei successivi sei mesi avrebbe esplorato il monte Wellington (che all'epoca era chiamato Table Mountain per la sua somiglianza con la montagna che domina Città del Capo), il fiume che ora porta il suo nome Brown River, la bassa valle del Derwent e l'estuario dell'Huon. Di ritorno a Port Jackson nell'agosto 1804, riprese a visitarne i dintorni, a volte insieme al botanico ufficiale della colonia George Caley, spingendosi a nord fino al fiume Hunter. Il 23 maggio 1805 si imbarcò alla volta dell'Inghilterra sul rabberciato Investigator insieme a Ferdinand Bauer, rientrato dalle isole Norfolk. Portava con se un erbario di 1200 piante, semi, minerali e collezioni zoologiche. 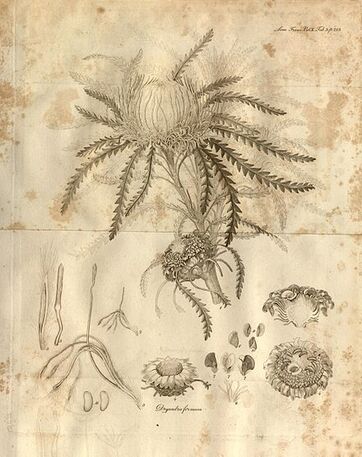 Prime pubblicazioni: uno scandalo e un disastro finanziario Ad ottobre i due amici erano di ritorno in Inghilterra. Per entrambi era giunto il momento di passare per uno dagli schizzi agli acquarelli, per l'altro dalla raccolta allo studio. Il progetto comune era la pubblicazione di una Flora complessiva dell'Australia, con i testi di Brown e le illustrazioni di Bauer. Il botanico poté dedicarsi quasi a tempo pieno al progetto grazie alla Linnean Society, che lo assunse come impiegato e bibliotecario. Era ancora ben lontano dalla meta quando, nel 1808, Dryander (il segretario e bibliotecario di Banks) gli chiese di scrivere una monografia sulle Proteaceae, in modo che egli potesse utilizzare le sue denominazioni nella nuova edizione di Hortus Kewensis che stava allestendo con il capo giardiniere Aiton. Brown accettò, studiando in modo molto accurato non solo le Proteaceae che aveva raccolto personalmente in Australia e in Sud Africa, ma anche le piante vive della collezione del mercante George Hibbert, gli erbari di Banks, Smith, Lambert e altri; poté anche esaminare brevemente le raccolte di Labillardière. Il saggio fu pronto all'inizio del 1809 e Brown lo lesse nel corso di quattro sedute della Linnean Society, tra gennaio e marzo. La pubblicazione però tardò fino al marzo 1810, quando apparve sia nella rivista della società con il titolo On the Proteaceae of Jussieu sia come volume a sé con il titolo On the natural order of plants called Proteaceae. Com'è chiaro da questi titoli, Brown non segue più la classificazione linneana (che già lo aveva lasciato insoddisfatto in Australia, ma che aveva provvisoriamente conservato per comodità) ma quella "naturale" di Antoine Laurent de Jussieu. Egli propone una nuova classificazione della famiglia, servendosi per la prima volta anche dell'analisi del polline; ne discute la distribuzione geografica; stabilisce due sottofamiglie, basandosi sulla contrapposizione tra frutti deiscenti e indeiscenti; descrive 404 specie e 38 generi, 18 dei quali nuovi. Il saggio segnò il riconoscimento scientifico di Brown, ma fu anche seguito da aspre polemiche. Poco dopo le conferenze alla Linnean Society, quindi molti mesi prima della pubblicazione a stampa del saggio di Brown, uscì On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, dopo una breve parte iniziale realmente dedicata alla coltivazione di queste piante firmata da Joseph Knigth, il giardiniere di Hibbert, presentava un'ampia revisione tassonomica della famiglia. Non era firmata ma l'autore fu facilmente identificato in Richard Salisbury che già in Paradisus londinensis (1806) aveva trattato diverse Proteaceae. Egli aveva assistito alle conferenze di Brown e, secondo la ricostruzione corrente, aveva memorizzato il nomi dei suoi nuovi generi; ora ne anticipava la pubblicazione, "rubandoli" al vero autore. Accusato di plagio, fu di fatto ostracizzato dalla botanica britannica. Brown stesso fu profondamente scioccato e scrisse di Salisbury in questi termini: "Non so che cosa pensare di lui tranne che sia un briccone e un pazzo". Nel 1810 Brown finalmente terminò quella che riteneva la prima parte della sua flora australiana; la pubblicò a proprie spese, senza illustrazioni, come Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, vol. 1; la numerazione del testo iniziava a p. 145, perché egli prevedeva una prefazione da aggiungere in ristampa. Le vendite furono così scarse che il botanico ritirò il volume dal commercio e rinunciò a scrivere sia la prefazione sia i volumi successivi. Solo vent'anni dopo sarebbe uscito un supplemento, dedicato alle Proteaceae scoperte nel frattempo. Anche il volume con le illustrazioni di Bauer (1813) fu un fiasco totale. Nonostante il disastro finanziario, il libro di Brown è una pietra miliare della botanica che segna il vero inizio dello studio sistematico della flora australiana, con la pubblicazione di 2040 specie, oltre metà delle quali nuove, e importanti contributi anche metodologici alla sistematica; vengono stabilite nuove famiglie (all'epoca si chiamavano ordini), molte delle quali tuttora accettate, e definiti in modo più preciso i criteri di classificazione delle famiglie stesse, all'epoca ancora piuttosto fluidi, 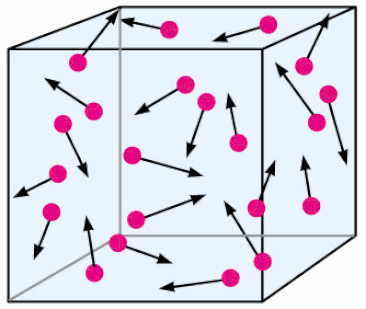 Brown diventa il Giove della botanica Il 1810 segnò per Brown anche un'importante svolta professionale. In seguito alla morte di Dryander, Banks lo assunse come segretario e bibliotecario, con uno stipendio annuo di 200 sterline e l'uso di un alloggio privato a Soho Square. Occuparsi di quella immensa biblioteca e di quel grandioso erbario, garantendone l'accesso ai numerosi visitatori, era tutt'altro che una sinecura. Per Brown, significò anche allargare i suoi interessi a nuove piante e nuove aree geografiche. Ad esempio, nel 1814 in appendice di A voyage to Abyssinia di Henry Salt pubblicò una lista di 146 piante abissine e nel 1818 l'erbario raccolto da Christian Smith in Congo. Nel 1820, alla morte di Banks, Brown ne ereditò la biblioteca e l'erbario con la clausola che, alla sua stessa morte, fossero trasferiti al British Museum. Nel 1827 egli anticipò la volontà del suo benefattore facendone dono al Museo, garantendosene però il controllo come Curatore delle collezioni banksiane; nel 1837, quando il dipartimento di Storia naturale venne diviso in tre sezioni, egli fu nominato primo curatore del dipartimento di botanica, incarico che mantenne fino alla morte. La sua posizione al British Museum ne faceva una delle figure più importanti della botanica britannica e gli permetteva di continuare a fare ciò che più amava: studiare meticolosamente le piante e le loro strutture microscopiche. Non a caso per ben due volte rifiutò una cattedra universitaria: non solo quella di Edimburgo, che implicava l'insegnamento della medicina, ma anche quella di botanica di Glasgow, per la quale caldeggiò la candidatura di William Jackson Hooker. Brown era un grande osservatore, uno sperimentatore metodico e rigoroso, uno scienziato aperto all'innovazione. Queste qualità emergono pienamente dalle sue scoperte degli anni '20 e '30. Nel 1827, in un saggio dedicato al nuovo genere Kingia, fu il primo a riconoscere le differenze fondamentali tra gimnosperme e angiosperme (anche se lui non le chiamava ancora così): mentre le ultime hanno semi racchiusi in un ovario (solitamente il frutto), le prime non hanno né fiori né frutti e i semi si presentano "nudi" e disposti sulle scaglie di un cono o pigna. E' sempre del 1827 la scoperta più celebre al di fuori della botanica. Mentre studiava al microscopio granuli di polline di Clarkia pulchella in sospensione acquosa, egli notò che essi erano in continuo movimento e che tale movimento avveniva in direzioni casuali. Dapprima pensò che i granuli fossero vivi, ma poi ripeté l'esperimento con moltissimi materiali diversi, organici e inorganici, verificando che il movimento avveniva sempre nello stesso modo. Egli non propose una spiegazione del fenomeno, tranne osservare che doveva essere un riflesso della struttura molecolare della materia. La spiegazione di quello che è noto come "moto browniano" arriverà molti anni dopo: nel 1905 da parte di Albert Einstein. Nel 1831, mentre studiava i meccanismi di impollinazione di piante delle famiglie Orchidaceae e Asclepiadeaceae, Brown notò nella cellule delle orchidee la presenza di un struttura che poi osservò anche in altre piante e la denominò "nucleo" della cellula. Il nucleo era già stato osservato in precedenza, forse fin dal Seicento dal microscopista olandese Leeuwnhoek; lo aveva notato e disegnato anche Franz Bauer a partire dal 1802, ma Brown fu il primo a dargli il nome. Sia lui sia Bauer però pensavano che fosse presente solo nelle monocotiledoni. Brown era altamente apprezzato dai suoi contemporanei; Humboldt lo definì "botanicorum facile princeps" e von Martius "Jupiter Botanicus", certo in riferimento anche al suo ruolo di padre padrone del dipartimento di botanica del British Museum. Come figura anche istituzionale, fu membro di molte società scientifiche come la Reale accademia svedese delle Scienza, la Reale accademia olandese delle Scienze e delle Arti, l'Accademia americana delle Arti e delle Scienze. Aveva un particolare legame con la Linnean Society: nel 1822 si era dimesso da impiegato, era stato immediatamente accolto come membro, poi entrò a far parte del Consiglio e nel 1828 fu nominato vicepresidente, presidente dal 1849 al 1853, quindi nuovamente vicepresidente fino alla morte. Brown era innegabilmente un grande scienziato, che qualcuno considera addirittura il maggiore botanico del suo tempo; ma la sua meticolosità e la sua dedizione al lavoro ebbero anche un risvolto negativo. Non amava delegare, con il risultato che molti esemplari raccolti da botanici e viaggiatori delle generazioni successive finivano di attendere il loro turno nei depositi del British Museum, in attesa che potesse occuparsene. Era il caso in particolare delle piante australiane, che egli tendeva a considerare la sua riserva di caccia. Il risultato fu che molte delle sue stesse raccolte rimasero inedite e che la prima opera importante sulla flora australiana dopo il Prodromus, Flora australiensis di George Bentham, iniziò ad uscire solo dopo la sua morte. Quale fosse l'atteggiamento dei naturalisti più giovani verso questo mostro sacro (anche fisicamente: era alto, imponente, severo, di poche parole e di spirito tagliente) ce lo racconta un aneddoto che ha per protagonista Charles Darwin. Nel corso del famoso viaggio attorno al mondo a bordo del Beagle, aveva visitato anche l'Australia e sapeva che il vecchio botanico era ansioso di aver da lui qualche esemplare stuzzicante. Ma lui, convinto che sarebbero finiti a prendere polvere nei magazzini del British, non aveva nessuna intenzione di accontentarlo. Così, quando alla fine lo incontrò, lo distrasse regalandogli un po' di legno fossile (i fossili erano una passione comune). In una lettera commentò: "Credo che il mio legno silicizzato abbia disselciato il cuore di Mr. Brown". 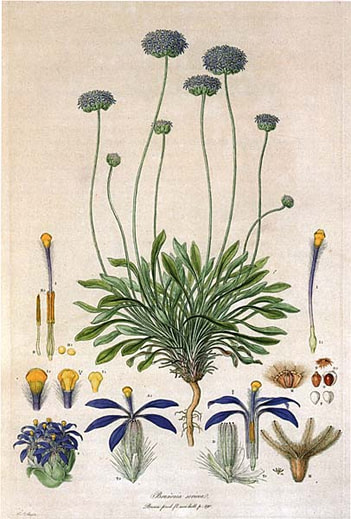 Omaggi floreali e no Robert Brown morì ottantacinquenne nel 1858 nell'alloggio di Soho Square dove abitava dal 1810. A ricordarlo vi è stata posta una targa, ma i luoghi a lui legati sono molti altri: nell'Australia meridionale il monte Brown che scalò durante la spedizione Flinders e oggi ospita un parco nazionale a lui dedicato e in Tasmania il fiume Brown; non mancano località che mai visitò, come il Capo Brown in Groenlandia, così denominato in suo onore da William Scoresby, o il monte Brown in Canada, omaggio di David Douglas, Le piante con eponimo brownii o brownianus si contano a centinaia; ci sono poi due generi, ovviamente australiani. A dedicargli il primo fu James Edward Smith che lo chiamò Brunonia; scopriamo perché grazie alle frasi iniziali del suo An Account of a new Genus of New Holland Plants named Brunonia, letto durante la seduta del 6 febbraio 1810 della Linnean Society, di cui Smith era fondatore e presidente: "Per la conoscenza della pianta che mi accingo a presentare, sono obbligato a Mr. Brown, bibliotecario della Società, che la scoprì nel corso delle sue ricerche botaniche in Nuova Olanda. Una parte assai interessante della sua ricca messe in quel paese occupa un'ampia porzione di questo volume delle nostre Transactions. Con una simile prova del suo genio e della sua abilità davanti ai nostri occhi, qualsiasi testimonianza in tal senso da parte mia sarebbe superflua, ma sono ansioso di cogliere l'opportunità, che egli ha accettato dietro mia ardente sollecitazione, di rendere giustizia ai suoi meriti dedicandogli questo genere nuovo e molto particolare. Poiché esiste già un genere Brownea in memoria dello studioso della storia naturale della Giamaica [Patrick Browne], per evitare ogni ambiguità e mantenere la massima somiglianza possibile con il suo nome, sono obbligato a ricorrere all'espediente, non eccezionale e autorizzato da precedenti, di chiamare il mio genere Brunonia". L'espediente usato da Smith consiste nell'usare l'equivalente latino di Brown, Bruno (gen, Brunonis). Qualche mese più tardi, Brown usò i nomi di Smith nel Prodromus; poiché la conferenza di Smith venne pubblicata solo nel 1811, la priorità di pubblicazione del genere spetta a lui stesso, e non a Smith. In tal modo involontariamente Brown ha violato un tabù della terminologia botanica, dedicando un genere a se stesso. Brunonia R.Br. (oppure Brunonia Smith ex R.Br.) è un genere curioso al di là di questo aneddoto. Smith lo aveva scelto perché costituiva un vero enigma tassonomico. Sembrava infatti in relazione con molte famiglie naturali, ma era difficile attribuirla con certezza all'una piuttosto che all'altra. L'incertezza non si è sciolta con il passare del tempo. In passato è stato attribuito a una famiglia propria, Brunoniaceae, ma a partire dal 2003 è stato trasferito nelle Goodeniaceae, dalle quali per altro differisce perché è l'unico con fiori a simmetria radiale, ovario supero e semi privi di endosperma. Oggi gli è attribuita un'unica specie, B. australis, un'erbacea annuale o perenne con foglie riunite in una rosetta basale, da cui emergono esili scapi che portano alla sommità una densa infiorescenza a capolino di numerosi piccoli fiori blu cielo o più raramente malva. Piuttosto diffusa, è presente in tutto il paese; predilige suoli sabbiosi o rocciosi e ambienti aridi e aperti, ma non ne è esclusiva. Si trova infatti anche in boscaglie e foreste aperte. Le infiorescenze ricordano quelle delle Scabiosa o della Knautia, da cui il nome comune blue pincushion. Un secondo omaggio è arrivato in tempi molto più recenti. Nel 1964 l'olandese Bremekamp decise di creare un nuovo genere per accogliere le specie australiane del genere soppresso Aporuellia (famiglia Acanthaceae). Poiché tre di queste specie erano state raccolte e descritte per la prima volte da Robert Brown (che le aveva assegnate al genere Ruellia) lo chiamò Brunoniella in suo onore. Comprende sei specie, cinque endemiche dell'Australia e una della Nuova Caledonia. Sono perenni tuberose, prostrate o erette, quasi tutte nane, con rami spesso scanalati longitudinalmente o appiattiti, foglie in coppie opposte ai nodi e fiori con corolla imbutiforme solitari o raccolti in spighe lasche. L'ambiente tipico è il sottobosco delle boscaglie e delle foreste umide dell'Australia settentrionale o nord-orientale. Anche se esistono anche altri colori, anche per questo genere il colore dominante dei fiori è l'azzurro, Sir Joseph Banks, grande patron della spedizione Flinders, ebbe cura di raccomandare al capitano di offrire ai "gentiluomini scienziati" molte opportunità di scendere a terra per esplorare le risorse naturali. Come botanico e direttore in pectore dei Kew Gardens, contava anche di arricchire i giardini reali di nuove specie; così, accanto al già affermato pittore botanico Ferdinand Bauer e al promettente botanico Robert Brown, a bordo dell'Investigator c'era anche l'eccellente giardiniere Peter Good, che aveva già dimostrato di sapersi prendere cura delle piante vive in lunghi viaggi oceanici. I tre formarono una formidabile squadra di raccoglitori, con all'attivo circa 2000 esemplari. Purtroppo Good fu una delle vittime della dissenteria che imperversò a bordo dopo lo scalo a Timor e molte delle sue raccolte andarono perdute in seguito al naufragio del Purpoise; tuttavia era riuscito a fare arrivare a Kew tanti semi da permettere a Aiton di elencare più di cento "australiane" nel catalogo dei giardini reali; belle e rare, spinsero Salisbury a rendere un commosso omaggio a Good con la dedica del genere Goodia. 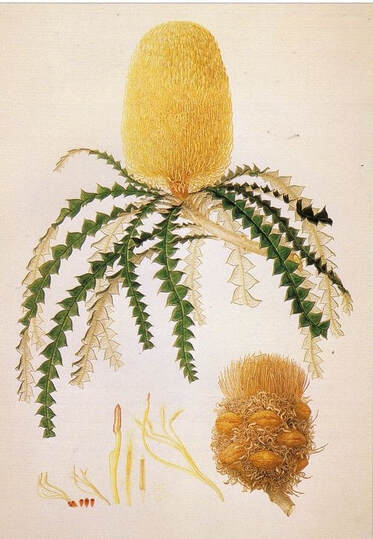 Una piccola squadra di scienziati Rispetto al dispiegamento di ben ventidue tra scienziati ed artisti della spedizione Baudin, lo staff scientifico dell'Investigator appariva modesto: in tutto sei uomini, ovvero l'astronomo John Crosley, il naturalista Robert Brown, il mineralogista John Allen, il giardiniere Peter Good e i pittori Ferdinand Bauer e William Westall. Se consideriamo che Crosley, Brown, Bauer e Westall erano accompagnati da un servitore ciascuno, l'équipe sale a dieci persone in tutto, che però presto si ridussero a otto. Infatti l'astronomo soffrì talmente il mal di mare che a Città del Capo fu lasciato a terra. Assistente all'Osservatorio di Greenwich, assegnato all'Ufficio della longitudine, aveva partecipato come osservatore alla spedizione Vancouver; in Sudafrica fece alcune osservazioni sulle coordinate, quindi, ritornato a Londra, divenne assistente dell'astronomo reale a Greenwich e si segnalò come eminente matematico, divenendo anche presidente della Spitalfields Mathematical Society. Tutti gli altri erano legati in un modo o nell'altro a Banks, che li aveva scelti personalmente. Da tempo il gentiluomo, che come primo investigatore della flora australiana e ideatore del progetto di trasformare il Nuovo Galles del Sud in una colonia penale, se ne considerava il patrono, pensava a una spedizione all'interno del paese. Contava di affidarla a Mungo Park, che alla fine del 1797 era rientrato dall'Africa coronato di gloria per aver scoperto la sorgente del Niger. Due fatti lo costrinsero a ripensarci: il governatore Hunter gli scrisse per sconsigliare una spedizione terrestre, per la quale la giovane colonia non aveva né gli uomini né le strutture; inoltre Park si scontrò con l'ammiragliato circa la sua paga e decise di sposarsi; poco dopo, come abbiamo visto qui, Flinders suggerì il progetto alternativo della circumnavigazione della Terra australis e Banks lo fece proprio con entusiasmo. Insistette però che a bordo dell'Investigator ci fosse uno staff scientifico e che durante la navigazione fossero previste soste sufficienti per esplorare le risorse naturali. A stargli particolarmente a cuore era ovviamente la flora, e non a caso come naturalista scelse un promettente botanico, il medico scozzese Robert Brown (1773-1858); dopo essersi laureato ad Edimburgo, Brown si era arruolato nell'esercito e da cinque anni serviva come medico militare in Irlanda. Meticoloso e interessato a tutte le scienze, era però affascinato soprattutto dalla botanica, in particolare delle crittogame. Aveva iniziato a corrispondere con eminenti botanici tra cui William Withring, James Edward Smith, James Dickson e José Correia da Serra. Nel 1798, quando Park rinunciò, fu proprio quest'ultimo a suggerire Brown come sostituto "In questo cambio, a guadagnarci sarà la scienza; Mr. Brown è un naturalista di professione; inoltre è scozzese, adatto a perseguire uno scopo con costanza e mente fredda". Brown (che nel frattempo era anche entrato a far parte della Linnean Society) era dunque il candidato ideale come naturalista della spedizione Flinders. Nel dicembre 1800 Banks gli scrisse per proporgli il posto; il dottore accettò e venne a Londra, dove trascorse i mesi che precedettero la partenza a leggere tutti i libri sull'argomento, a studiare le piante australiane di Banks e a scegliere con Dryander (il segretario di Banks) i doppioni da riunire in un erbario da portare con sé a bordo dell'Investigator. Anche Bauer, oltre ad essere uno dei più raffinati pittori botanici del suo tempo, poteva essere considerato un naturalista a tutti gli effetti: austriaco, era stato introdotto alla tassonomia linneana e all'uso del microscopio da von Jacquin, quindi tra il 1786 e il 1787 aveva accompagnato in Grecia il professore di Oxford John Sibthorp; il risultato fu la spettacolare Flora Graeca. A confronto, il pittore paesaggista William Westall (1781-1850) era una seconda, anzi una terza scelta. Inizialmente Banks aveva offerto il posto all'affermato paesaggista Ibbeston; al suo rifiuto, si era rivolto William Daniell, che aveva già molto viaggiato ed era specializzato in soggetti marini; questi dapprima aveva accettato, poi si era tirato indietro e forse su suo suggerimento fu rimpiazzato dal giovanissimo Westall, appena diciannovenne al momento della partenza. Allen era invece arrivato all'ultimo momento; Banks non aveva pensato a un mineralogista, finché a sottolineare la necessità di raccogliere campioni di rocce e minerali fu Flinders; sir Joseph allora scrisse a suo zio, William Milnes, che amministrava la sua tenuta di Overton, il quale scelse un giovane minatore, eccezionalmente istruito, appunto John Allen, forse all'epoca venticinquenne. Pagato meno dei suoi compagni e non considerato uno scienziato a tutti gli effetti, era un po' il parente povero del gruppo, tanto più che i minerali non interessavano per nulla a Banks e poco a Brown, nominato capo dell'intera équipe, che in una lettera a sir Joseph ebbe a scrivere sprezzantemente "sinceramente, è di ben poca utilità". Pensava tutto il contrario dell'ultimo membro della squadra, il giardiniere Peter Good (non ne conosciamo né la data di nascita né l'età), voluto da Banks con l'obiettivo dichiarato di arricchire i giardini reali di specie nuove e rare. Good era uno dei caposquadra di Kew ed era stato suggerito a Banks dal giardiniere capo William Aiton per la sua esperienza in viaggi oceanici: aveva infatti portato con successo a Calcutta una selezione di piante coltivate a Kew e nel viaggio di ritorno ne aveva riportato piante indiane preparate dal botanico Christopher Smith. Good e Allen condividevano la stessa cabina e secondo il loro contratto, a differenza degli altri, avrebbero dovuto mangiare con i sottoufficiali tecnici; ma, dato che sull'Investigator non ce n'erano, condividevano anche loro la tavola del comandante con i "gentiluomini scienziati".  Formidabili raccolte L'Investigator salpò da Spithead il 18 luglio 1801. A bordo c'erano anche casse di semi e una serra portatile con piante in vaso da consegnare a Port Jackson. Lungo la rotta per città del Capo l'unico scalo fu quello di Madera: il 2 agosto Flinders, Brown e Bauer scesero a terra sull'isola di Bugio nelle Ilhas Desertas, dove Brown osservò la natura porosa delle rocce e la luminescenza delle meduse; quindi il giorno dopo l'Investigator gettò l'ancora nel porto di Funchal, dove si sarebbe trattenuta fino al 7 agosto. Brown, Bauer, Allen e Good ne approfittarono per esplorare le vicinanze della capitale, erborizzare e scalare la maggiore montagna dell'isola, il Pico Ruivo. Brown era deluso di non aver trovato piante diverse da quelle raccolte da Banks durante lo scalo a Madera del primo viaggio di Cook, ma redasse scrupolosamente una lista della flora locale. Durante il viaggio, che proseguì tranquillo fino a Città del Capo, raggiunta il 16 ottobre, Brown si tenne occupato studiando i libri della biblioteca di bordo sulla Nuova Olanda e insegnando a Good il francese, in previsione di un incontro con gli uomini di Baudin. Fin dal 17 ottobre, Brown, Allen e Good scesero a terra; stupefatti dalla bellezza e varietà della flora del Capo, raccolsero insetti, minerali e una grande quantità di piante. Brown passò diverso tempo nella sua cabina a classificarle, mentre Good continuava le raccolte. I naturalisti trovarono anche modo di esplorare le montagne più vicine alla città, Table Mountain e Devil's Mountain, nonostante la scalata fosse resa difficile dal fango e dalla nebbia. La preparazione e la classificazione delle numerose piante raccolte da lui stesso e da Good fu la principale occupazione di Brown durante la traversata dell'Oceano Indiano. C'erano anche due nuove specie di Proteaceae, Serruria fascicularis e S. foeniculacea. Lasciata False Bay il 4 novembre, l'Investigator avvistò la costa della Nuova Olanda all'altezza del Capo Leeuwin il 6 dicembre. Flinders iniziò immediatamente la ricognizione idrografica, concentrando la sua attenzione sul King George Sound, dove la nave rimase all'ancora presso la Seal Island dall'8 dicembre al 5 gennaio 1802. La lunga sosta e la stagione non troppo avanzata permisero a Brown e Good di raccogliere il più cospicuo bottino dell'intera spedizione: circa 500 esemplari di piante, 175 di semi, mentre Bauer poté completare una cinquantina di disegni. Tra gli altri, Brown scoprì otto nove specie di Banksia. Botanico e giardiniere lavoravano in piena armonia; quando il primo si tratteneva a bordo per classificare gli esemplari, il secondo continuava le ricerche e andava a caccia di semi, dimostrando un ammirevole senso del dovere; anche Bauer (e talvolta Allen e Westall) contribuiva alle raccolte. Il 6 gennaio il viaggio riprese in direzione est; le frequenti soste per esplorare baie, isole e isolotti offrirono altre opportunità di raccolta ai naturalisti. La prima si presentò il 10 gennaio, quando essi poterono scendere a terra nei pressi dell'attuale Cape le Grand, dove trovarono una nuova specie di Cycadacea (Macrozamia riedlei), la raccolta dei cui semi diede parecchio filo da torcere a Good. L'11 gennaio l'Investigator gettò l'ancora a Lucky Bay, dove rimase per quattro giorni. Brown, Bauer e Good ne approfittarono per penetrare nell'interno fino a scalare il Frenchman Peak, una cupola granitica posta a circa 6 km dalla baia, che ospita anche una grotta, e ne ritornarono con circa 150 esemplari di piante diverse, tra cui Verticordia brownii. Il resto del mese di gennaio fu trascorso ad esplorare le isole dell'Arcipelago della Recherche, con ancoraggi a Middle e Goose Island. Ora la stagione era più avanzata, le temperature diurne potevano superare i 35° e spesso soffiavano forti venti; la vegetazione era inaridita e le raccolte botaniche si fecero molto più sporadiche. Il 17 gennaio entrarono nella Grande Baia australiana, caratterizzata da alte falesie, dove fu impossibile trovare un ancoraggio fino a Fowlers Bay (19 gennaio); Brown scese a terra, ma poté osservare ben poche piante, soprattutto specie alofile come Zotera muelleri. Mentre il caldo si faceva sempre più torrido, toccando 52°, l'Investigator continuò l'esplorazione attraverso le isole Nuyts, con ancoraggi in diverse isole che fruttarono a Brown poche nuove specie. Poté invece rifarsi durante gli scali a Memory Cove (22-24 febbraio 1802) e Port Lincoln (26 febbraio-6 marzo) dove lui e Good raccolsero 35 e 85 specie (incluso il nuovo genere Ixodia). Tra il 10 e l'11 marzo, mentre l'Investigator era ancorato all'estremità settentrionale dello Spencer Gulf, l'intero gruppo degli artisti e degli scienziati scalò una montagna situata a una ventina di km all'interno, prontamente battezzata da Flinders Mount Brown. Fu un'impresa faticosa e pericolosa: rimasti senza viveri e acqua, dovettero trascorrere la notte sulla montagna. I due pittori però poterono dipingere splendide vedute. Secondo il racconto di Good, dal punto di vista botanico la gita fu un po' deludente: non solo trovarono una varietà di vegetali inferiore alle aspettative, ma molte delle piante raccolte giunsero a bordo ormai appassite. Si trattava comunque di una sessantina di specie, cui se ne aggiunsero altrettante al successivo ancoraggio dell'isola dei Canguri (21-22 marzo e 1-7 aprile). Qui Brown poté anche tornare al suo primo amore, raccogliendo diversi interessanti licheni. Dopo il fatidico incontro con il capitano Baudin, la navigazione proseguì lungo la costa del Victoria con un breve ancoraggio all'isola King e uno più lungo a Port Phillip. Insieme al capitano e a Westall, Brown scalò la collinetta che domina la baia nota come Arthur's Seat; al termine della piacevole escursione, oltre a uno splendido panorama, godettero anche un picnic a base di ostriche fresche. In questo distretto, Brown e Good aggiunsero alle collezione un altro centinaio di specie. La prima fase dell'esplorazione era conclusa e il 2 maggio l'Investigator lasciava Port Phillip per Port Jackson. La lunga sosta necessaria per raddobbare la nave fu utilizzata da pittori e naturalisti per completare i disegni e organizzare le raccolte; Good fu anche impegnato nella preparazione dei semi da inviare a Londra. Non mancò però il tempo per qualche escursione nei dintorni e a Parramatta, ad alcune delle quali partecipò anche il francese Leschenault de La Tour, divenuto buon amico di Brown, Il 22 luglio 1802 l'Investigator salpava per la seconda, meno fortunata, parte della spedizione. Le raccolte di Brown e del suo team lungo la costa orientale e settentrionale sono state studiate meno in dettaglio rispetto a quelle della costa meridionale; grazie al diario dello stesso Brown e al suo General remarks on the botany of Terra Australis sappiamo che in entrambe le aree vennero raccolte circa 500 specie, moltissime delle quali nuove per la scienza, trattandosi di regioni scarsamente o per nulla esplorate in precedenza. Per la costa nord-orientale al di sopra del 21° grado sud, Brown cita come luoghi di raccolta Port Curtis, Keppel Bay, Port Bowen, Stronge-tide Passage e soprattutto Broad Sound, dove egli raccolse la pianta che dedicò al capitano Flinders, Flindersia australis. Ricorda anche gli scali in due delle isole Northumberland e in una delle isole Cumberland. Anche la costa settentrionale, almeno prima che il deprecabile stato dello scafo dell'Investigator costringesse Flinders a ripiegare su Timor e poi a rientrare in tutta fretta a Port Jackson, offrì ai naturalisti diverse opportunità di raccolta sia lungo la costa (tra le zone citate, Melville Bay e Caledon Bay) sia in varie isole, una delle quali venne battezzata Good's Island in onore dell'ottimo giardiniere. In effetti, anche se le raccolte sono in genere ascritte a Brown, sappiamo che si trattò di un'impresa collettiva cui molto contribuì Peter Good, ma probabilmente anche Bauer, egli stesso un appassionato raccoglitore. Oltre alle piante, che occupavano il centro d'interesse di Briwn, vennero raccolti anche insetti, uccelli e altri animali, e sicuramente Allen si occupò delle rocce, anche se non sappiamo nulla delle sue raccolte (andate perdute nel naufragio del Purpoise).  Un omaggio meritato Come agli sfortunati membri della spedizione Baudin, la sosta a Timor fu fatale a diversi uomini di Flinders. Tra di essi proprio Good, che poco dopo la partenza dall'isola si ammalò di dissenteria; non si riprese e morì nella baia di Sydney il 12 giugno 1803 pochi giorni dopo il rientro dell'Investigator. Brown lo rimpianse molto e gli dedicò Banksia goodii. Gran parte delle sue raccolte di piante vive, che egli aveva amorosamente curato finché aveva potuto, sistemate nella serra mobile dell'Investigator, furono caricate sulla Purpoise e andarono perdute nel naufragio della nave, insieme a una cassa di semi. Con i semi inviati in precedenza, Good aveva però fatto in tempo ad arricchire i giardini di Kew (e quindi indirettamente d'Inghilterra) di molte specie australiane, soprattutto provenienti dalla costa meridionale. Nella seconda edizione di Hortus kewnesis, Aiton elenca ben 103 piante da lui introdotte nei giardini reali. Molte prosperavano ancora nella Australian House ai tempi di Hooker. Si salvò invece l'erbario, che Brown aveva incorporato nel proprio. Infatti, mentre Westall e Allen si imbarcarono con Flinders sulla sfortunata Purpoise, Brown e Bauer decisero di rimanere in Australia, un po' perché convinti che il capitano sarebbe tornato presto, un po' per rintegrare le collezioni perdute, ma soprattutto perché ritenevano che ci fosse ancora molto da scoprire. Non si sbagliavano: nei due anni che seguirono, aggiunsero alle loro raccolte altre 2000 specie e centinaia di disegni. Ne riparleremo in un altro post. E' ora di conoscere il genere che, presumibilmente su suggerimento di Brown, Salisbury dedicò all'attivissimo giardiniere con queste parole: "Secondo la mia opinione, nessuno ha maggior diritto che la sua memoria sia perpetuata da una pianta che porta il suo nome di un industrioso giardiniere botanico, specialmente quando la sua vita è caduta in sacrificio per le sue fatiche in lontani climi. Non so nulla di Peter Good tranne che, avendo raccolto semi per sua maestà nel Nuovo Galles del Sud, dove morì, Kew gli deve un ricchissimo lascito delle migliori e più rare piante di quel paese, ciascuna delle quali porta l'etichetta con il suo nome". Goodia è un piccolo genere della famiglia Fabaceae che comprende sei specie di arbusti endemici dell'Australia, da medi a grandi. Sono caratterizzati da foglie composte trifogliate, spesso di colore glauco; un'altra caratteristica distintiva è la presenza di stipole effimere o persistenti alla base del picciolo. I fiori papilionacei, con il vessillo più o meno circolare e le due ali più strette, sono gialli con marcature rosse, verdi o porpora. La specie più diffusa è Goodia lotifolia, un alto e folto arbusto eretto che in fioritura può ricordare le ginestre; endemico dell'Australia sud-orientale, è largamente presente in Tasmania e lungo la costa del Victoria e del Nuovo Galles del Sud meridionale. Recentemente un secondo genere si è aggiunto a celebrare indirettamente l'ottimo giardiniere: Paragoodia ("simile a Goodia"), separato nel 2011 da Muelleranthus; è un genere monotipico, rappresentato unicamente da P. crenulata, un'erbacea prostrata con foglie composte trifogliate e fiori con marcature che possono ricordare quelli di Goodia; endemica dell'Australia occidentale, è nota in un unico sito a sud del Mt Holland. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed