|
Nella storia australiana, Allan Cunningham è noto soprattutto come esploratore, per aver aperto nuove vie di comunicazione e scoperto diversi valichi, tra cui quello che porta il suo nome (Cunningam's Gap); tuttavia, anche dopo essere stato coinvolto dal governatore Brisbane nell'esplorazione del territorio della colonia, egli continuò a sentirsi in primo luogo un botanico che, come scrisse a Kew, aveva trovato il modo di "mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". Finite le spedizioni marittime guidate del capitano King, tra il 1822 e il 1829 Cunningham perlustrò gran parte del Nuovo Galles del sud, per poi essere incaricato di trovare vie di collegamento con il Queensland, e prese parte a più di venti spedizioni, almeno una delle quali diretta e organizzata da lui stesso. Un viaggio lo portò anche in Nuova Zelanda. Senza però mai smettere di raccogliere piante: secondo l'amico e primo biografo Robert Heward, durante i suoi quindici anni australiani furono oltre 3000 specie. Moltissime sono quelle che lo ricordano nel nome specifico, Alania cunninghamii anche in quello generico. Senza dimenticare il genere Cunninghamia, che divide con il quasi omonimo James Cunighame.  Tra fatiche e speranza Il 25 aprile 1822, con il rientro a Sydney della Bathurst, si concludeva la prima fase delle avventure australiane di Allan Cunnigham, quella marittima (l'ho raccontata in questo post). L'infaticabile botanico del re rivolgeva ora la sua attenzione all'interno del paese. Dopo aver dedicato qualche mese a preparare i materiali da spedire a Kew (fase a cui dedicava ogni attenzione e che sempre lo preoccupava sommamente, per il lunghissimo viaggio che attendeva i suoi campioni e le fragili piante vive), già a settembre era di partenza: superate le Blue Mountains, per tutto il mese fu impegnato ad erborizzare nell'area compresa tra Bathurst e il fiume Cudgegong, spingendosi anche a oriente di quest'ultimo. I risultati di questa spedizione attirarono l'attenzione del nuovo governatore del Nuovo Galles del Sud, sir Thomas Brisbane, che lo incaricò di cercare una via di collegamento tra Bathurst e le Liverpool Plains scoperte da Oxley nel 1818. Cunningham, che da tempo coltivava la passione per l'esplorazione, accettò di buon grado e scrisse a Kew: "'Ho scoperto di poter mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". L'appoggio logistico offerto dal governatore tornava per altro comodo, visto il magro salario e gli scarsi finanziamenti londinesi. Nel marzo 1823 Cunningham, accompagnato da cinque servitori e altrettanti robusti cavalli da soma, partì da Bathurst dirigendosi verso nord in direzione del Lawson's Goulburn River, poi a est fino alle sorgenti del fiume Hunter. Da qui risalì la Liverpool Range alla ricerca di un valico; dal Mount Macarthur (oggi Mount Moan) vide a est un punto in cui catena di abbassava e decise di muovere in questa direzione, ma il cammino si fece sempre più difficile, finché risultò bloccato da ogni parte da ripidi burroni. Non restava che tornare indietro fino al Mount Macarthur, per cercare un passaggio in direzione nord-ovest. L'infruttuosa deviazione era costata tre settimane e tre giorni. Dopo altri sei giorni di cammino lungo la catena, il 2 giugno Cunningham decise di salire nuovamente su una cima: guardandosi intorno, a non più di tre miglia scorse una notevole depressione, al di là della quale si intravvedevano pianure aperte. Cunningham aveva scoperto il Pandora's Pass: gli diede questo nome pensando, da una parte, alle privazioni e alle difficoltà del viaggio, dall'altra alla piccola speranza che aveva trovato alla fine, che gli facevano pensare al mito di Pandora che, quando apre il suo vaso, sparge nel mondo ogni male, ma in fondo le rimane la speranza. Raggiunto il valico il 9 giugno, ritornò infine a Bathrust il 27 giugno, dopo undici settimane di arduo cammino. Relazionò poi i due viaggi da Bathurst in A Specimen of the Indigenous Botany […] between Port Jackson and Bathurst, e in Journal of a Route from Bathurst to Liverpool Plains (1825); significativamente, il focus del primo sono le piante, del secondo l'esplorazione. Dopo questa epica spedizione, fu la volta di una serie escursioni più brevi, per lo più in distretti già esplorati, in cui la botanica tornava in primo piano: a novembre raccolse esemplari nelle Blue Mountains lungo la Bells Line; nel gennaio 1824 tornò a Bathrust a raccogliere semi maturi. Poco dopo il suo ritorno a Parramatta, attraccò a Port Jackson il battello francese Coquille, che stava circumnavigando il globo al comando di Louis Isidore Duperrey. Con grande gioia, Cunningham fece conoscenza con il naturalista ufficiale della spedizione René Primevère Lesson e il primo ufficiale e botanico Jules Dumont d'Urville e in marzo li accompagnò a erborizzare nelle contee di Camden e Argyle; visitarono i laghi George e Bathurst, le sorgenti del Murrumbidge, Brisbane Downs, la Marley Plain e Shoalhaven. Era una zona facile da percorrere e almeno in parte già battuta, che non offriva grandi novità botaniche, tranne intorno alle cave calcaree di Shoalhaven, ma fu senz'altro un splendido biglietto d'ingresso per i due naturalisti francesi, Rientrato con loro a Parramatta all'inizio di maggio, Cunningham trascorse i mesi di luglio e agosto a erborizzare a Illawarra, uno dei suoi luoghi preferiti, riportandone piante vive che piantò in piccole scatole o vasi, perché recuperassero prima di essere spedite in Inghilterra. Tra l'altro scoprì la terribile Dendrocnide excelsa (lui la chiamò Urtica gigas), un albero dalle foglie urticanti che provocano un dolore che può durare mesi, tanto inteso da resistere alla morfina. Si affrettò poi a rientrare a Parramatta, in modo da imbarcarsi sulla Amish diretta a Moreton Bay; questa spedizione, di nuovo guidata da Oxley, aveva lo scopo di esplorare il fiume Brisbane. Insieme a Oxley, Cunnigham risalì in battello il fiume finché fu navigabile; lungo le sue rive poté scoprire molte piante interessanti, tra cui Araucaria cunninghamii, e anche diverse specie di orchidee. A ottobre era di nuovo a Parramatta; per concludere l'anno, tornò nuovamente a Bathurst a fare incetta di semi. Ne riportò novità come Banksia cunninghamii, Grevillea anethifolia, Eucalyptus mannifera. Dal Nuovo Galles al Queensland Nell'inverno del 1825 (da aprile a giugno) fu la volta di una nuova spedizione verso nord, che nel prima tratto ripercorse la strada che egli stesso aveva aperto due anni prima. Passando da Richmond, Cunningham raggiunse la valle dell'Hunter, quindi superò il Pandora's Pass procedendo verso nord attraverso le Liverpool Plains, dove trovò un notevole ostacolo nella pioggia continua e nel terreno piatto e paludoso; proseguì alla ricerca di una strada più elevata, finché fu costretto a tornare indietro, trovando la piana completamente allagata. Rientrò a Parramatta il 17 giugno, avendo percorso un circuito di 700 miglia. Gli ultimi mesi dell'anno furono trascorsi ad esplorare le aree della Wellington valley e di Mudgee, alla ricerca di semi ed esemplari da inviare a Kew; il bottino più interessante furono diverse orchidee terrestri. Ma la sua salute cominciava a risentire di tante fatiche e tanti viaggi, e dovette fermarsi fino a febbraio, per poi accontentarsi di escursioni botaniche relativamente brevi lungo il Cox's River e ancora a Illawarra. Nell'agosto 1826 poté realizzare un sogno che accarezzava da molto tempo: imbarcatosi su una baleniera, raggiunse la Nuova Zelanda dove fu accolto calorosamente dai missionari della Baia delle isole. Si trattenne nell'isola del Nord per quattro mesi, visitando l'area compresa tra la Baia delle isole e Hokianga, la zona di Wangoroa e la baia di Plenty. Infine, il 29 dicembre si imbarcò sul piccolo vascello dei missionari diretto a Sydney, dove sbarcò il 20 gennaio 1827 dopo un viaggio reso lungo e penoso dai venti avversi. Risultato della breve visita fu Florae Insularum Novae Zelandiae Precursor (1837-39), considerato la prima sinossi della flora neozelandese. Lo attendeva la più impegnativa delle sue spedizioni. Essendogli giunta notizia che il governatore sir Ralph Darling desiderava si esplorassero le potenzialità economiche dell'area compresa tra la Grande Catena divisoria e Moreton Bay (l'odierna Brisbane), si offrì come capo della spedizione, per la quale propose un dettagliato itinerario. Ad accompagnarlo sarebbero stati sei uomini, parecchi cani e undici cavalli da soma con le provviste per quattordici settimane; i cavalli vennero inviati via terra fino all'alto corso del fiume Hunter, mentre Cunnigham raggiungeva in nave Newcastle; da qui risalì il fiume con le provviste fino a Dulwich, dove il gruppo si riunì. Proseguirono quindi insieme fino a Segenhoe, all'epoca la fattoria più estrema e punto di partenza della spedizione vera e propria. Gli esploratori ne partirono il 30 aprile e si diressero a nord, varcando la Liverpool Range all'altezza di Dartbrook Creek; spesso la strada era così ripida che bisognava alleggerire i cavalli, trasportando i bagagli a braccia. Quindi si diressero verso nord in direzione del fiume Peel, passando attraverso una boscaglia aperta di Eucalyptus sideroxylon. Il 21 maggio raggiunsero un vasto fiume che Cunningham chiamò Gwydir; proseguirono attraverso aride boscaglie interrotte da crinali e gole, fino a fiume Macintyre che era quasi asciutto per la siccità. Preoccupato dalla mancanza di pascolo per i cavalli e per le provviste, già consumate a metà, Cunningham decise di non proseguire verso nord come aveva progettato, ma di spostarsi più a est. Fu così che il gruppo si imbatté in un fiume largo e profondo che il botanico battezzò Dumaresq, in onore del segretario del governatore Henry Dumaresq. Dopo averlo attraversato, proseguirono per altri sei giorni; il 6 giugno Cunnigham salì sul monte Damaresq: di fronte a lui una vasta pianura feritile di ricchi pascoli. Era le terra promessa che era venuto a cercare: non a caso la battezzò Darling Downs in onore del governatore che aveva voluto quella spedizione. A una distanza di forse dieci km, vide anche un valico che prometteva di offrire un comodo passaggio verso Moreton Bay. Debilitato dall'epatite di cui soffriva periodicamente fin dai tempi dei viaggi della Mermaid, non lo esplorò personalmente, ma vi inviò due uomini che confermarono la sua supposizione. Cunningham lo chiamò Spicers Gap in onore di Peter B. Spicer, sovrintendente dei forzati. Attraverso un altro passo, che poi sarebbe stato chiamato Cunningham's Gap, il gruppo scese nei Darling Downs, seguendo per qualche giorno il corso del fiume che lo irrigava (Cunningham lo battezzò Condamine River, in onore di Thomas de la Condamine, ex aiuto di campo del governatore); quindi si accamparono in una valle ad est del fiume (Logan Valley, in onore del comandante dell'insediamento di Moreton Bay) per far recuperare uomini e cavalli. Era infatti ora di tornare indietro, cosa che fecero seguendo una via più occidentale rispetto a quella dell'andata, rientrando a Segenhoe dopo un viaggio di tredici settimane. Cunningham poté presto verificare di persona la praticabilità della via di collegamento che aveva intravvisto. Nel 1828 andò ad erborizzare a Moreton Bay con il botanico della colonia Charles Fraser; a luglio partivano in spedizione con il comandante Logan, un soldato, cinque forzati e molte provviste. Dirigendosi verso sud, raggiunsero il Logan River, scoperto dal capitano due anni prima, e il monte Barney, che Logan già aveva tentato inutilmente di scalare. Questa volta ci riuscì. Dopo aver esplorato per qualche giorno l'area intorno all'attuale Boonah, Fraser e Logan tornarono a Brisbane; Cunningham invece si addentò nelle montagne e varcò il passo che aveva scoperto nel 1827. La strada che egli percorse è oggi diventata un'autostrada, e ovviamente porta il suo nome: Cunningham Highway. Cunningham tornò a Moreton Bay ancora nel 1829, per esplorare l'alto corso del Brisbane River. Anche nel 1828 e nel 1829 non mancarono i consueti viaggi botanici a Bathurst e Illawarra. Tra maggio e settembre egli visitò anche l'isola Norfolk. Trattenuto nell'isola oltre il previsto dal cattivo tempo, poté fare un inventario molto ampio della sua flora (nel suo diario elenca 104 specie che ritiene native e 38 che considera introdotte). Visitò anche la vicina isola Phillip, dove fu derubato di gran parte dell'equipaggiamento e delle provviste da alcuni forzati. Fin nel 1828 aveva chiesto di poter tornare in Inghilterra (ricordo che l'aveva lasciata nell'ormai lontano 1814); il permesso gli fu finalmente accordato nel novembre 1830. Dopo un'ultima visita a Illawarra e alla Cox Walley e i saluti agli amici (erano tanti che richiesero non meno di una settimana), partì da Sydney il 25 febbraio e arrivò in Inghilterra a luglio. Qui si stabilì non lontano da Kew, dedicandosi alla sistemazione del suo erbario e alla stesura di vari articoli. Nel 1832 fu ammesso alla Linnean Society. Lo stesso anno morì Charles Fraser, e gli fu offerto di succedergli come botanico della colonia, ma egli rifiutò a favore del fratello minore Richard. Anche quest'ultimo era un ottimo botanico, entrato appena quindicenne a Kew. In Australia non mancò di partecipare a diverse spedizioni e visitò anche la Nuova Zelanda (dove tra l'altro scoprì l'orchidea che porta il suo nome Dendrobium cunninghamii), ma infine fu vittima di un tragico incidente. Nell'aprile 1835 si unì alla spedizione Mitchell, inviata ad esplorare il corso del fiume Darling. Nei pressi del Bogan River, si allontanò dal gruppo per erborizzare e non fece mai più ritorno. Più tardi si scoprì che, perdutosi e probabilmente in preda al delirio, si era unito ad alcuni indigeni che più tardi, terrorizzati dal suo strano comportamento notturno, lo avevano ucciso. Quando la notizia della morte di Richard giunse in Inghilterra, il posto di botanico della colonia fu nuovamente offerto a Allan Cunningham, che questa volta accettò e ritornò a Sidney nel febbraio 1837. Tra i suoi compiti, c'era anche la direzione del Giardino del governatore; Fraser aveva cominciato a trasformarlo in orto botanico (il futuro Sydney Royal Botanic Garden), ma era ancora soprattutto un parco pubblico e un orto per la coltivazione di verdure per la mensa del governatore; dopo qualche mese, Cunningham diede le dimissioni, proclamando che non "avrebbe più tollerato di essere un mero coltivatore di cavoli e rape". Nell'aprile 1838 si imbarcò sulla corvetta francese L'Héroine alla volta della Nuova Zelanda; trovò tempo pessimo e ritornò Sidney in ottobre gravemente malato. Nonostante la sua salute continuasse a peggiorare, progettava di accompagnare il capitano John Wickam della Beagle in una nuova ricognizione della costa nord-occidentale. Ormai stava così male che la nave partì senza di lui; il suo successore e amico James Anderson lo fece trasportare in un piccolo cottage situato nell'Orto botanico, dove Cunningham si spense il 27 giugno 1839. Nel 1844 in sua memoria venne eretto un obelisco commemorativo, alla cui base nel 1901 vennero traslate le sue ceneri. Si trova al centro di un piccolo stagno affiancato da boschetto di una delle tante piante da lui scoperte, la palma Archontophoenix cumminghamiana. Gli è intitolata anche la rivista scientifica dell'Orto botanico di Sydney "Cunninghamia".  Una piccola pianta per un grande raccoglitore Insieme a Robert Brown, Allan Cunningham è considerato il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento; ne esplorò le coste settentrionali, gran parte del Nuovo Galles del Sud, il Queensland meridionale, la Tasmania, nonché le isole Norfolk e Phillips e alcune aree della nuova Zelanda. Secondo il suo amico e primo biografo Robert Heward, le specie da lui raccolte ammontano a 3000. I suoi invii di semi, bulbi, piante vive a Kew furono così importanti che una serra, prima destinata alle piante africane, venne invece riservata alle sue australiane. Moltissime delle specie da lui raccolte erano ignote alla scienza, e non poche gli sono state dedicate. Ricordiamo almeno Casuarina cunninghamiana, Archotophoenix cunninghamiana, Araucaria cunninghamii, Crotalaria cunninghamii, Actinodium cunninghamii, Adenanthos cunninghamii, Alsophila cunninghamii, Angianthus cunninghamii, Banksia cunninghamii, Cassinia cunninghamii, Clematis cunninghamii, Eucalyptus cunninghamii, Nothofagus cunninghamii, Solanum cunninghamii. A una scelta di queste magnifiche piante è dedicata la gallery a fine post. Anche se i continui viaggi e la brevità del soggiorno in Inghilterra gli permisero di pubblicare solo una minima parte delle sue raccolte, gli si devono 139 denominazioni valide: 6 generi (Ackama, Alseuosmia, Corokia, Fieldia, Rabdothamnus, Hoheria), 133 specie (la più nota delle quali è probabilmente Grevillea rosmarinifolia) e una varietà. Si basano invece su raccolte di Cunningham più di 300 denominazioni di altri autori, tra cui 6 generi. A Cunningham sono stati dedicati due generi: Cunninghamia R.Br., che condivide con il quasi omonimo James Cuninghame (ne ho parlato in questo post) e Alania Endl., un genere monospecifico della famiglia Boryaceae, la cui unica rappresentante ha la ventura di ricordare il nostro protagonista sia nel nome generico sia nell'epiteto: è infatti Alania cunninghamii, un'erbacea rizomatosa del Nuovo Galles del Sud. Come ci ricorda Endlicher, Cunnigham la raccolse all'inizio del suo soggiorno australiano, nel 1818, "in campi aridi nei pressi delle Blue Mountains". E' una perenne cespitosa con foglie lineari, infiorescenze ascellari di piccoli fiori bianchi a stella con perianzio formato da sei tepali liberi, sei stami inseriti alla base con filamenti lunghi quanto i tepali. E' endemica delle Blue Mountains settentrionali; eliofila, tende a formare tappeti espandendosi con i rizomi. Qualche informazione in più nella scheda.
0 Comments
Napoleone è appena stato sconfitto e relegato all'Elba, quando sir Joseph Banks e il suo capo giardiniere William Townsend Aiton approfittano della pace ritrovata per inviare a caccia di piante i primi due "raccoglitori dei re" James Bowie e Allan Cunningham. Dopo una breve puntata in Brasile, il primo dovrà andare a raccogliere in Sud Africa, il secondo in Australia. La ripresa della guerra prolunga il soggiorno brasiliano e solo nel 1816 i due si dividono per raggiungere le destinazioni finali. In questo primo post seguiamo le avventure sudafricane di James Bowie, ricchissime di scoperte, finché il malcapitato botanico scopre sulla propria pelle che cosa succede quando, morto un re, se ne fa un altro. Da botanico del re cerca allora di rimettersi sul mercato come cacciatore di piante indipendente, ma l'impresa gli riuscirà solo per breve tempo. A ricordarlo la curiosissima Bowiea volubilis, oggi assai ricercata da appassionati e collezionisti. 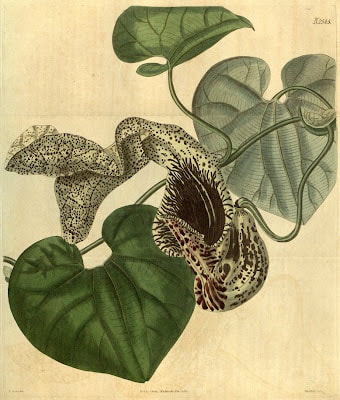 Australia, Sudafrica via Brasile Il 3 maggio 1814 lo sconfitto Napoleone sbarca all'Elba da una nave da guerra britannica. Per l'Europa è arrivato il momento della pace? Ne è convinto il capo giardiniere di Kew William Townsend Aiton che il 29 maggio ricorda a sir Joseph Banks che prima di ammalarsi re Giorgio III aveva espresso la volontà di inviare dei raccoglitori per incrementare le collezioni dei giardini reali e gli suggerisce di discuterne con il principe reggente. Il 7 giugno Banks risponde che la pace con la Francia ha riaperto la possibilità, e aggiunge che l'imperatore d'Austria ne sta già approfittando per spedire in giro i raccoglitori di Schönbrunn, l'unico vero rivale di Kew. Se il Reggente acconsentirà, ha già individuato tre possibili mete: il Capo, Buenos Aires e il Nuovo Galles del sud. Da parte sua, Aiton ha già in mente le persone adatte: due giovani giardinieri molto preparati che ha istruito lui stesso: James Bowie e Allan Cunningham. Alla fine le mete scelte sono due: il Sudafrica e l'Australia, con tappa intermedia in Brasile. Ci vuole ancora qualche mese per ottenere l'autorizzazione sia del Reggente, sia del governo portoghese. Terminati i preparativi, il 29 ottobre 1814 i "raccoglitori del re per Kew" Bowie e Cunningham si imbarcano sulla HMS Duncan alla volta di Rio de Janeiro, dove sbarcano il 29 dicembre. Dovrebbero fermarsi pochi mesi, ma la ripresa della guerra in Europa in seguito alla fuga di Napoleone dalla Elba cambia tutto: le comunicazioni intercontinentali sono di nuovo difficili e Banks usa tutto il suo prestigio per convincere i portoghesi a concedere ai suoi raccoglitori il permesso di addentrarsi nell' interno del paese, fino ad allora chiuso agli stranieri. Nei dintorni di Rio Bowie e Cunningham hanno trovato una ricca messe di piante e hanno già cominciato a inviare in patria esemplari d'erbario, semi e occasionalmente piante vive, che i francesi lasciano passare benevoli sempre grazie al prestigio internazionale di Banks. Nel aprile 1815 partono per Sao Paulo, che raggiungono dopo un mese di difficile viaggio a dorso di mulo. Si trattengono in questa regione che sono i primi europei ad esplorare per circa quattro mesi, per poi rientrare a Rio ad agosto. Dedicano l'autunno e l'anno successivo di nuovo ai dintorni di Rio, con escursioni a breve raggio nelle località più promettenti, in particolare alla Serra dos Orgãos, famosa per la sua ricchezza di biodiversità vegetale e animale. Se nelle zone più aride hanno raccolto soprattutto cactacee (sono loro a "scoprire" Rhipsalis grandiflora, Hatiora salicornioides e lo splendido Rhodocactus grandifolius), ora è la volta di bromeliacee e orchidee. Quelle che inviano a Kew sono soprattutto "piante da stufa", ovvero da serra calda. I loro apporti più noti sono la glossinia Sinningia speciosa e Jacaranda mimosifolia. Nel giugno 1816 arriva l'ordine di Banks di lasciare il Brasile e di imbarcarsi per le mete finali con la "primissima opportunità", ma, soprattutto per insistenza di Bowie che vuole completare l'esplorazione della Serra dos Orgãos, si trattengono ancora qualche mese. Infine, il 28 settembre 1816 entrambi si imbarcano per le rispettive destinazioni: Cunningham sulla Surry alla volta di Port Jackson (ovvero l'attuale Sideney) - dove lo raggiungeremo in un prossimo post -, Bowie sulla Mulgrave Castle per il Capo, dove sbarca il 1 novembre. 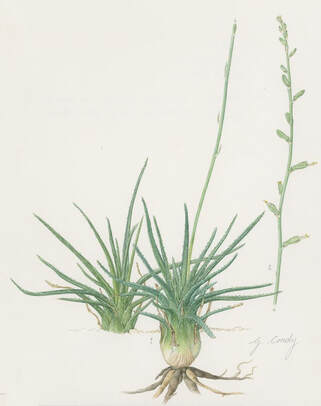 Quattro grandi spedizioni e un triste declino James Bowie (ca. 1789–1869), londinese, era figlio di un mercante di seta di Oxford Street. Intorno al 1810, a circa vent'anni, era stato assunto come giardiniere ai Kew Gardens, dove dunque prima di imbarcarsi per il Brasile aveva lavorato per quattro anni, venendo formato dalla stesso Aiton non solo in orticoltura, ma nelle migliori tecniche di raccolta e conservazione gli esemplari. Era un naturalista entusiasta e scrupoloso, ma, forse agli occhi di Banks, fino troppo intraprendente (e indipendente). Anche se aveva lasciato il Brasile con qualche rimpianto, il Sud Africa appariva ai suoi occhi ancora più promettente: "Nessun luogo è così produttivo del Capo di Buona Speranza [...]. Le piante di questo paese sono belle all'estremo e adatte alla conservazione". Banks la pensava nello stesso modo e non a caso aveva spedito qui il suo primissimo raccoglitore, Francis Masson, nell'orami lontano 1772; senza contare che le sudafricane, a differenza delle brasiliane, non erano "piante da stufa", ma specie rustiche o semirustiche, quindi più adatte alla coltivazione in giardino. Erano passati vent'anni da quanto Masson aveva lasciato definitivamente il Sudafrica, ed era ora di riallacciare quel filo interrotto dalla guerra, in una situazione politica per altro molto più favorevole, visto che nel 1797 gli inglesi avevano occupato la colonia del Capo e nel 1806 l'avevano annessa formalmente. Per circa un anno, Bowie erborizzò nei dintorni di città del Capo, finché nel marzo 1818 intraprese la prima spedizione nell'interno. Muovendosi a poca distanza della costa lungo quella che oggi è nota come Garden Route, esplorò la provincia del Capo occidentale, caratterizzata da clima mediterraneo con estati calde e asciutte e inverni miti e umidi, toccando successivamente Caledon, Gourits River, Great Brak River, George, Kaaimans River, Swart River, Goukamma e raggiungendo la costa a Knysna. Qui fece la conoscenza con George Rex, un ex funzionario britannico interessato alle scienze naturali che possedeva una fattoria detta Melkhoutkraal, che sarebbe diventata la sua base operativa nelle spedizioni successive. Quindi rientrò a Cape Town il 14 gennaio 1819. Si stabilì così una specie di routine: Bowie trascorreva i mesi estivi (ricordiamo che ci troviamo nell'emisfero sud, con stagioni invertite) caldi e asciutti, il periodo di stasi delle fioriture, a Città del Capo per preparare e spedire a Londra le raccolte di esemplari, semi, bulbi; all'inizio dell'autunno, ripartiva rientrando all'inizio dell'estate successiva. E' la falsariga della seconda spedizione (9 aprile 1819-22 gennaio 1820), durante la quale, dopo una sosta a Melkhoutkraal, si spinse fino a Plettenberg Bay, rientrando poi a Cape Town insieme a George Rex. Per la spedizione del 1820, ritornò a Knysna, dove fu ospite di Rex da marzo a settembre, quindi si mosse verso est fino ad Avontour, quindi a Uniondake nella Lang Kloof che separa la provincia del Capo occidentale da quella del Capo orientale; cambia anche il clima e ovviamente la vegetazione: dalla regione con piogge invernali, si passa a quella con piogge estive e inverni secchi e soleggiati, ma anche freddi di notte. Il viaggio proseguì per Uitenhage, Algoa Bay (l'attuale Port Elizabeth), Kowie, Grahamstown, quindi di nuovo Algoa Bay dalla quale Bowie rientrò a Cape Town il 29 gennaio 1821. La quarta e ultima spedizione fu la più lunga, occupando circa un anno e mezzo. Il suo punto di partenza fu quello di arrivo della spedizione precedente, Algoa Bay. Partitone nel giugno 1821, Bowie si diresse verso nord, toccando Graaff-Reinet e Eerste Poort, le località più settentrionali dei suoi viaggi. Rientrato a Algoa Bay, ne ripartì all'inizio del 1822. A febbraio a Uitenhage incontrò il botanico tedesco G.L.E. Krebs che aiutò a impacchettare bulbi e succulente. Una puntata ad est lo portò fino al Kowie River, l'estremo punto orientale delle sue spedizioni. Nel viaggio di ritorno toccò Avontuur, Van Stadens e Knysna, dove trascorse di nuovo tre mesi a casa di Rex, prima di rientrare a Cape Town il 4 dicembre 1822. Lo attendeva un'amara sorpresa. Nel 1820 erano morti sia Banks sia Giorgio III; per il nuovo sovrano Giorgio IV (il principe reggente che abbiamo incontrato all'inizio di questa storia), pochissimo interessato a piante e giardini, Kew cessava di essere una priorità; i fondi destinati ai Kew Gardens vennero dimezzati e fu deciso di richiamare uno dei due "raccoglitori del re", ovvero il nostro Bowie. Il motivo? "La mancanza di applicazione". Eppure egli era un raccoglitore formidabile, e le sue raccolte erano eccellenti per qualità e imponenti per quantità. I motivi veri erano altri: in primo luogo aveva dimostrato di essere troppo indipendente, di voler fare di testa sua, scegliendo in autonomia mete ed itinerari; in secondo luogo aveva preso due abitudini deprecabili agli occhi dei burocrati britannici: per arrotondare il magro salario vendeva sottobanco ai ricchi borghesi di Cape Town vistosi esemplari di piante molto richieste, come le Cycadaceae, le Strelitziae e i Crinum; per mantenere segreti i luoghi di raccolta, nelle note inviate a Kew li indicava in modo approssimativo o anche errato. Bowie dovette rassegnarsi a lasciare il Sudafrica. Non fu licenziato, ma assegnato all'erbario di Kew. Dopo otto anni di viaggi avventurosi e appassionanti, si sentiva stretto nei panni di botanico da scrivania. Sfogava la sua frustrazione nei bar e nei pub, raccontando ai compagni di bevute le sue mirabolanti avventure in Brasile e Sudafrica, magari stupendoli con un enorme serpente impagliato o altre bestie. Il suo unico sogno era tornare in Sudafrica, ma come raccoglitore indipendente. Ce ne informa nei particolari un breve articolo pubblicato all'inizio del 1827 sull'Edinburgh Journal of Science. L'autore (si tratta di William Jackson Hooker) esprime il suo rammarico per un provvedimento che ha rattristato "chiunque abbia a cuore la botanica", attesta l'eccellente qualità delle raccolte di Bowie, che ha potuto esaminare di persona a Kew; quindi scrive: "È ora suo [di Bowie] proposito tornare al Capo, ed esplorare di nuovo l'interno a proprio rischio, in cambio di un compenso per le sue grandi spese, nell'intento di mettere ciò che potrà raccogliere a disposizione dei naturalisti di questo paese". Segue un dettagliato prezzario: esemplari d'erbario, 2 sterline e 10 scellini il centinaio; semi, 5 sterline per cento dozzine; bulbi, come Ixia e simili, 10 scellini il centinaio; per quelli grandi, da 1 a 2 scellini e 6 centesimi l'uno; piante vive, 2 scellini e 6 centesimi l'una (per le piccole succulente, vale l'offerta tre per uno); Strelitziae, Zamiae e piante di dimensioni simili, 5 scellini l'una. Per le specie nuove si applica una maggiorazione. Grazie a questa inserzione e all'interessamento di amici come lo stesso Hooker, nell'aprile 1827 Bowie riuscì a ripartire per il Sudafrica e per qualche anno riprese le sue raccolte come cacciatore di piante free lance, inizialmente con qualche successo. Era anche un membro attivo della comunità scientifica della Colonia: fu tra i soci fondatori della South African Institution, la primissima società scientifica del Sudafrica, di fronte alla quale nella seduta del 31 agosto 1829 sostenne la necessità di creare un orto botanico a Cape Town dove le piante, in attesa di essere spedite in Europa, potessero essere acclimatate e studiate. Nel corso di tre sedute successive, presentò anche tre interventi intitolati "Sketches of the botany of South Africa", uno dei quali fu pubblicato da W. Bridekirk e rappresenta la prima guida della flora del Capo mai pubblicata. Considerato una specie di autorità, la cui conoscenza della flora del Capo era ritenuta senza pari, veniva anche consultato da ricchi proprietari di giardini, come il barone C.F.H. von Ludwig, che, quando la sua impresa fallì verso la metà degli anni '30, lo assunse come sovrintendente del proprio giardino. Sempre inquieto, lavorò alle sue dipendenze fino al 1841, quando riprese a viaggiare nell'interno a caccia di nuove piante; non ne aveva più né l'età né la fibra, anche perché "le sue abitudini erano tali da interferire con i suoi progetti" (dietro questa reticente formula vittoriana del Journal of botany si cela l'alcolismo). Si ridusse in estrema miseria, finché per carità Ralph H. Alderne lo assunse come giardiniere del suo giardino di Clarment. Bowie morì a Wynberg all'età di circa 80 anni. 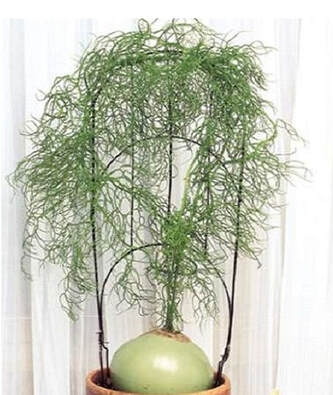 Una pianta più curiosa che bella? Hooker non era il solo ad apprezzare il lavoro di Bowie. Tra coloro che più si erano giovati dei suoi invii di succulente, c'era Adrian Haworth che nel 1824 denominò in suo onore Bowiea africana una delle piante da lui raccolte nell'ultima spedizione. La denominazione non è valida e oggi si chiama Aloe bowiea, conservando l'omaggio nell'epiteto. Un altro estimatore di Bowie era W. H. Harvey che, essendo stato ridotto Bowiea Haw. a sinonimo di Aloe, decise di recuperare il nome con una motivazione assai elogiativa che è anche un omaggio postumo a un uomo tanto bistrattato dalla sorte: "in molti anni di paziente lavoro nell'interno del Sudafrica ha arricchito i giardini europei con una varietà di succulente molto più ampia di qualsiasi altro viaggiatore in precedenza". Sono inoltre circa una ventina le specie, tanto brasiliane quanto sudafricane, che si fregiano degli epiteti bowiei e bowieanus; tra di esse Oxalis bowiei, Eriospermum bowieanum, Aspalathus bowieana. Bowiea Harv. ex Hook.f. (famiglia Asparagaceae) è un genere monotipico, rappresentato unicamente dalla sudafricana B. volubilis. Hooker figlio, che la pubblicò dopo la morte di Harvey, non la apprezzava più di tanto, ma ne era incuriosito; infatti scrive: "Per quanto possegga poca bellezza, è certamente una delle piante più curiose mai introdotte in Europa". E' proprio questa stranezza a farla oggi apprezzare dai collezionisti di bulbose e succulente. Affine a Drimia o Albuca, possiede un grande bulbo di colore verde chiaro che generalmente affiora dal terreno, rimanendo in gran parte scoperto, da cui nella stagione vegetativa emerge un fusto volubile molto ramificato che può raggiungere anche i tre metri. Le foglie che sono prodotte soprattutto vicino al bulbo in genere cadono poco dopo la nascita, mentre la funzione clorofilliana è svolta dal fusto e dai rami. Oltre che in Sudafrica, è presente in altri paesi adiacenti dell'Africa sud-orientale, dove cresce soprattutto in aree semiaride con piogge estive; in dormienza in inverno, con le prime piogge produce un fusto che cresce molto rapidamente. In primavera sbocciano anche i fiori, poco appariscenti e verdastri, seguiti a fine estate da capsule brunastre. Nel tardo autunno la pianta secca totalmente e entra in riposo. Di crescita lentissima (il bulbo può raggiungere il 15 cm di diametro, ma per farlo gli occorrono 25 anni) richiede coltivatori pazienti. In Sudafrica è diventata rara per l'eccessiva raccolta come pianta medicinale utilizzata per curare varie affezioni; le sono attribuite anche proprietà magiche come rendere i guerrieri coraggiosi, proteggere i viandanti, assicurare l'amore. Eppure è una pianta velenosissima tanto per gli uomini quanto per gli animali. Altre informazioni nella scheda. Negli anni decisivi in cui il Chelsea Physic Garden, grazie alla generosità di Hans Sloane e alla sapienza orticola dell'inarrestabile capo giardiniere Philip Miller, si trasforma da hortus medicus, ancora per lo più riservato alle piante medicinali, in un grande orto botanico di acclimatazione delle esotiche, a guidarlo come dimostratore e praefectus è il farmacista Isaac Rand, cui si devono una gestione accorta, i primi cataloghi, l'apertura agli artisti che vengono a ritrarre dal vivo le piante delle sue aiuole. Lo ricorda il genere Randia (Rubiaceae), omaggio di Houstoun validato da Linneo. 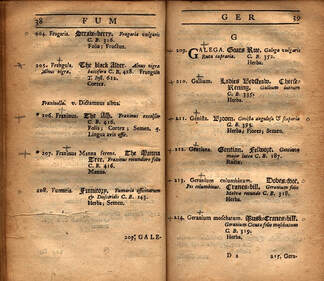 Una gestione accorta ed efficente Nel 1718, alla morte di James Petiver, prese il suo posto come dimostratore del giardino dei farmacisti di Chelsea il suo collega Isaac Rand (1674–1743) che già da qualche anno lo affiancava nelle attività didattiche. Rand era figlio d'arte e godeva di ottima reputazione come botanico. Il padre James Rand faceva parte della commissione che nel 1674 aveva deciso di proteggere il giardino con un muro di cinta; il figlio ne rilevò l'attività e intorno al 1700 gestiva una farmacia sull'Haymarket. Doveva essersi appassionato di botanica durante l'apprendistato, ed è citato da diversi botanici della generazione precedente per il suo occhio di lince, capace di scovare piante fino ad allora mai notate anche in zone molto battute. In Almagesti botanici mantissa (1700) Plukenet lo ricorda per aver scoperto nei Tothill Fields a Westminster la pianta che oggi si chiama Rumex palustris e lo definisce "farmacista londinese diligentissimo indagatore delle piante e botanico di belle speranze". A Doody invece segnalò un'altra specie di Rumex, R. maritimus, che cresceva nei luoghi umidi vicino a Burlington House. Adam Buddle gli attribuisce la scoperta di Mentha dumetorum (sin. M. pubescens) lungo le rive di certi stagni presso Marybone e Petiver quella di Oxybasis glauca (sin. Chenopodium glaucum) che battezzò in suo onore "blito quercino di Rand". Di Buddle e dei colleghi Doody e Petiver doveva essere compagno di scorribande botaniche, che evidentemente avevano per teatro la stessa Londra e le immediate vicinanze, quelle dove insieme allo stesso Petiver guidava gli herborizing degli apprendisti farmacisti. Nella società dei farmacisti divenne presto un elemento di primo piano; nel 1707 lo troviamo tra i membri della commissione incaricata di valutare il mantenimento del giardino, per fare sopravvivere il quale fece una donazione e affittò persino una parte del terreno. Assistente e successore di Petiver, si trovò poi alla guida del giardino in un momento decisivo della sua storia. Come ho raccontato in questo post, nel 1722 sir Hans Sloane prese il Physic Garden sotto le sue ali protettrici, cedendo in perpetuo alla Worshipful Society il terreno del giardino in cambio di un affitto simbolico e della fornitura di 50 esemplari d'erbario alla Royal Society. Lo stesso anno, su suggerimento dello stesso Sloane, fu assunto anche Philip Miller. Fu Rand a gestire il delicato cambio di gestione, e di vocazione, del giardino, che, da orto dei semplici dove si coltivava anche qualche esotica, in seguito all'obbligo di fornire ogni anno cinquanta esemplari di specie esotiche preferibilmente inedite veniva trasformato in giardino botanico di acclimatazione che guardava sempre più ai modelli di Leida e Parigi. Nel 1725 Rand divenne il primo direttore ufficiale del Chelsea Physic Garden e dal 1733 portò il pomposo titolo Horti Praefectus et Praelector Botanicus Chelseiani, in cui si uniscono le funzioni amministrativa e didattica: come già Petiver prima di lui, suo compito era infatti, oltre a guidare gli herborizing, tenere almeno due lezioni in horto al mese nella stagione estiva. Fu incaricato di stendere un progetto di miglioramento del giardino; approvato dalla Società dei farmacisti, ottenne il sostegno finanziario di Sloane, che convinse sia il Collegio dei medici sia la Royal Society a versare un contributo; ne seguirono grandi trasformazioni, con la costruzione di un’aranciera, che ospitava anche una biblioteca e una sala per le riunioni, di alloggi per il prefetto e il capo giardiniere, di una serra fredda e di due serre riscaldate con un sistema di riscaldamento dal basso. La prima pietra di questi nuovi edifici fu posta ovviamente da Sloane nel 1732. Tra i compiti di Rand c'era anche aumentare e documentare le collezioni. Teneva i contatti con altri orti botanici, in particolare con quello di Leida, con il quale intensificò il programma di scambi. Era lui a occuparsi della preparazione degli esemplari da consegnare alla Royal Society, il primo gruppo di cinquanta dei quali, debitamente etichettato, fu presentato nel marzo del 1723. Gli si deve il primo catalogo, 57 anni dopo la fondazione del giardino; pensato per la formazione degli apprendisti, elenca 518 specie officinali, specificando quali parti vanno utilizzate. Meno legato alla originaria vocazione di hortus medicus è il secondo catalogo, pubblicato nel 1739, in cui vengono elencate circa mille piante raggruppate in 749 generi Rand capì anche quanto potesse essere utile documentare le piante affiancando all'ormai tradizionale erbario immagini di buona qualità. Quando il medico Alexander Blackwell finì in carcere per debiti, incoraggiò la moglie Elizabeth a stabilirsi vicino al giardino e a frequentarlo liberamente, per ritrarre le piante esotiche dal vivo (il risultato fu A Curious Herbal che permise alla coppia di uscire dalla loro situazione disperata). Un altro artista protetto da Rand fu il tedesco Dyonisius Ehret che si legò anche più a Chelsea quando sposò la cognata di Philip Miller. Non ultimo merito di Rand fu riuscire a tenere a bada l'irrefrenabile capo giardiniere. Dopo la sua morte (1743) e quella dell'immediato successore Joseph Miller (prefetto dal 1743 al 1746), la Società dei farmacisti rinunciò a nominare un prefetto, affidando la gestione a un comitato che ben poco poteva di fronte all'esuberanza del testardo Miller. Rand si ricordò dell'amato giardino anche nel testamento, lasciandogli in eredità la sua biblioteca botanica, 22 volumi di erbario e un lascito di 50 sterline annue destinato al rinnovamento dell'erbario del dimostratore con esemplari freschi.  Gardenie spinose Rand era amico di Mark Catesby e fu tra i sottoscrittori di Natural History of Carolina; doveva godere almeno della stima di William Houstoun visto che - sebbene ancora vivo - risulta tra i dedicatari di uno dei 14 nuovi generi creati dal chirurgo scozzese in Plantae Houstonianae. Randia (Rubiacaeae) fu poi validato da Linneo; in precedenza un vasto genere pantropicale, è stato ristretto fondamentalmente all'America tropicale e subtropicale, dagli Stati Uniti meridionali all'Argentina, con un centinaio di specie di arbusti, liane e piccoli alberi. Continuano a farne parte anche tre specie australiane (le altre sono state state trasferite al genere Atractocarpus) che però appaiono abbastanza diverse da quelle americane. Per lo più dioiche, con fiori dei due sessi su piante diverse, sono arbusti o piccoli alberi sempreverdi o caducifogli, spesso armati di spine, con foglie opposte o raggruppate in verticilli agli apici dei rami. I fiori, uniti in cime o grappoli all'ascella delle foglie o solitari all'apice di brevi rametti, hanno calice troncato, dentato o lobato, tubo corollino cilindrico con cinque lobi, che in boccio si presenta ritorto. I frutti sono bacche succulente che contengono molti semi. Il centro di diversità è probabilmente il Messico, con una quarantina di specie. Ma qualcuna si spinge anche negli Stati Uniti meridionali, come R. aculeata, una delle più diffuse, con un areale che dalla Florida raggiunge la Colombia, passando per il Messico e le Antille. E' un piccolo albero, sempreverde o deciduo in base alla piovosità, con rami quasi orizzontali, molto spinosi, foglie verde brillante quasi ovali, bei fiori bianchi a stella con cinque lobi seguiti da bacche tondeggianti biancastre a maturazione (da cui il nome white indigoberry), molto apprezzate dagli uccelli, la cui polpa in passato veniva usata per produrre un colorante blu. Tra le australiane, merita una segnalazione R. moorei, un arbusto o alberello originario dell'estremità nordorientale del Nuovo Galles del Sud e delle aree adiacenti del Queensland. Anch'essa è spinosa, a volte anche lungo il tronco, ha foglie largamente ovoidali con apice acuto. Porta fiori bianchi molto profumati, raggruppati in gruppi di tre all'apice dei rami o lungo i rami stessi che le hanno guadagnato il nome di spiny gardenia, "gardenia spinosa". Le bacche, dapprima giallo aranciato, diventano nere a maturazione. Rara, è minacciata dalla progressiva distruzione del suo ambiente naturale, il sottobosco della foresta pluviale su suolo basaltico. La sua appartenenza al genere Randia è per altro discussa e ne è stato proposto lo spostamento in Xeromphis. Altre informazioni nella scheda. Si ritiene generalmente che il primo occidentale a creare una raccolta sistematica di piante cinesi sia stato il chirurgo e mercante James Cuninghame, che negli anni a cavallo tra Seicento e Settecento operò dapprima ad Amoy quindi a Chusan, raccogliendo circa 600 specie, diverse delle quali furono prontamente pubblicate da James Petiver e Leonard Plukenet. La penetrazione del commercio inglese in estremo oriente era ancora agli inizi, e presto gli inglesi abbandonarono questi avamposti dove gli scarsi guadagni non erano tali da compensare la rapacità dei funzionari cinesi. Dopo la relativamente fortunata parentesi cinese, per Cuninghame iniziarono i guai: inviato a Pulo Condore in Cocincina, fu tra i pochi sopravvissuti a un massacro e dovette subire due anni di penosa prigionia; né più solida era la situazione dell'emporio della compagnia a Banjarmasin nel Borneo, diretto per poche settimane da Cuninghame prima che fosse distrutto e gli inglesi espulsi del paese. Allo sfortunato chirurgo-mercante non rimase che ritornare in patria; ma non vi arrivò mai, probabilmente perendo in mare. Robert Brown volle ricordarlo dedicandogli una delle sue scoperte cinesi: lo splendido "abete cinese", ovvero Cunninghamia lanceolata. Che deve però dividere con un quasi omonimo, il "raccoglitore del re" Allan Cunningham. 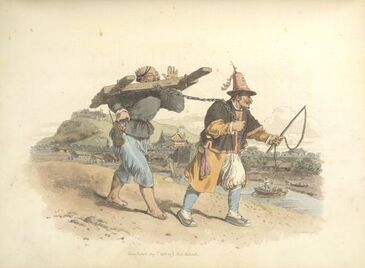 Una sequela di disastri Richard S. Morel l'ha soprannominato "il botanico più sfortunato dell'Asia"; in effetti, anche se sventure di ogni genere erano il corollario abituale delle vite dei cacciatori di piante dei tempi eroici, è difficile trovare una sequela di catastrofi che eguagli quelle che costellarono i viaggi di James Cuninghame (o Cunningham, ca. 1665–1709). Molto poco sappiamo della sua giovinezza. Cuninghame era scozzese e doveva essere nato intorno al 1665, visto che nel 1686, quando si immatricolò alla facoltà di medicina di Leida, risulta ventunenne. Presumibilmente non si laureò: infatti era chirurgo e non medico, ma non sappiamo né dove né come completò gli studi. Nella seconda metà del 1696 era di ritorno da un viaggio nelle Indie orientali, nel corso del quale doveva aver già raccolto qualche curiosità naturale. Fu così che entrò in contatto con Hans Sloane, all'epoca segretario della Royal Society, e strinse amicizia con James Petiver. Avendo saputo che si preparava a ripartire per la Cina, quest'ultimo gli consegnò una lista di piante desiderabili e gli raccomandò di cercare di procurarsi disegni o pitture di piante cinesi, nonché di raccogliere per lui ogni tipo di curiosità. Cuninghame lasciò l'Inghilterra alla fine del 1697, presumibilmente a bordo della Tuscan, che non apparteneva né alla Compagnia delle Indie né alla rivale New Company, ma a qualche mercante indipendente, i cosiddetti interlopers "intrusi" (si è fatto il nome di Henry Gough). Insieme a un'altra nave di cui non conosciamo il nome, nel gennaio 1698 la Tuscan fece scalo nell'isola di La Palma nelle Canarie, dove Cuninghame fece le sue prime raccolte (circa 150 esemplari, un decimo della flora dell'isola) e si produsse un grave incidente. Una parte dei marinai si ammutinò e disertò; per cercare di catturarli, il capitano inglese usò le maniere forti, finendo per scontrarsi con le autorità spagnole, con il risultato che la nave fu posta sotto sequestro e la ciurma messa agli arresti. Solo dopo qualche giorno, vennero rilasciati e la Tuscan poté riprendere il mare. A metà febbraio passarono l'equatore, quindi doppiarono il Capo di Buona Speranza, proseguendo senza fare scali fino a Batavia, dove gettarono l'ancora a giugno. Cuninghame ne approfittò per raccogliere altre 121 piante. A luglio erano ad Amoy (oggi Xiamen), uno dei pochi porti cinesi aperti agli occidentali. Il soggiorno nell'isola di Amoy si protrasse per sei mesi. Cuninghame (che era qui in veste di mercante, non di chirurgo) trovò il tempo per osservare e descrivere nel suo diario le tecniche di fabbricazione della carta, dell'ottone, del colorante rosso estratto dai semi di Gardenia jasminoides, l'estrazione del salnitro, i nidi commestibili di uccelli e l'ambra grigia. Ovviamente continuò le raccolte, mettendo insieme esemplari d'erbario di 176 specie e semi di 84. Inoltre raccolse una quarantina di "Miscellanea", incluso un esemplare del leggendario "agnello di Tartaria" o barometz segnalando che si trattava della radice di una felce (oggi identificata come Cibotium barometz). Infine commissionò a un artista locale circa 800 acquarelli della flora di Amoy. Di ritorno in Inghilterra verso la metà del 1699, egli poté presentare questo bottino ai suoi amici e ne fu premiato con l'ammissione alla Royal Society. Dopo meno di sei mesi, era di nuovo in partenza, questa volta come chirurgo di bordo della Eaton, una nave della Compagnia delle Indie inviata nell'isola di Chusan (oggi Zhoushan) nella speranza di crearvi una stazione commerciale. Durante il viaggio, la nave dovette fare scalo sia all'isola dell'Ascension, sia al Capo, visto che nell'erbario di Cuninghame si trovano esemplari provenienti da entrambe le località. Anche a Chusan egli continuò alacremente la sua attività di raccolta, estesa anche alle vicine Crocodile Islands; inviò inoltre alla Royal Society alcune lettere poi pubblicate sulle Philosophical Transactions, su argomenti come la coltivazione del tè o certi coralli e altre curiosità sottomarine. Nel 1702 la Compagnia delle Indie decise di abbandonare l'emporio di Chusan, che si era mostrato poco redditizio a causa dei forti dazi; Cuninghame, che doveva essersi ben comportato, fu promosso capo in seconda e inviato nell'isola di Pulo Condore (oggi Côn Sơn) nel Vietnam meridionale per aprirvi un insediamento. Venne costruito un forte e per proteggerlo furono ingaggiati mercenari Makassar. Nel marzo 1705 questi ultimi si ammutinarono, incendiarono la stazione e uccisero sedici uomini che cercavano di spegnere le fiamme. Gli inglesi chiesero l'aiuto delle autorità locali, ma queste, dopo aver catturato e giustiziato i Makassar, si rivolsero contro i britannici, completando il massacro. Solo Cuninghame e pochi altri sopravvissero. Allo sfortunato naturalista, ferito, fu imposta la gogna (kang) e fu trascinato di fronte alle autorità per una sorta di processo. Tre i capi d'accusa: aver stabilito l'insediamento di Pulo Condore contro la volontà del re di Cocincina; non aver presentato a quest'ultimo un tributo adeguato; essere in comunicazione segreta con la Cambogia, con cui la Cocincina era in guerra. Ogni difesa fu inutile; per due anni egli venne tenuto prigioniero con appena il necessario per sopravvivere. Rilasciato nell'aprile 1707, poté raggiungere Batavia. Forse per ricompensarlo di tante sofferenze, la Compagnia lo inviò a Banjarmasin in Borneo come capo di quella stazione commerciale. Tre settimane dopo il suo arrivo, anche quest'ultima venne attaccata e distrutta, sebbene con perdite umane minori rispetto a Pulo Condore, e la Compagnia delle Indie venne espulsa dal Borneo. A Cuninghame non restava che rientrare in Inghilterra. Nel gennaio 1709 scrisse l'ultima lettera a Petiver e Sloane, annunciando il suo rientro. Tuttavia non giunse mai a casa: probabilmente morì durante il viaggio di ritorno. Invece i manoscritti e le raccolte arrivarono sani e salvi a Londra. 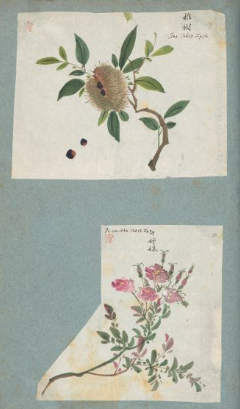 Una collezione di grande importanza storica A parte qualche esemplare occasionale, era la prima volta che un naturalista di valore faceva raccolte sistematiche in Cina. Nel complesso, gli esemplari inviati da Cuninghame ai suoi corrispondenti londinesi (in primo luogo Petiver e Sloane, ma anche il rivale Plukenet) ammontano a circa 600; vista la loro novità, Petiver e Plukenet fecero a gara per pubblicarli quanto prima. Tra le circa 1000 specie descritte da James Petiver nelle centurie dei Musei Petiveriani (1696-1703) figurano una cinquantina di esemplari raccolti da Cunninghame; accanto alle piante troviamo serpenti, conchiglie, farfalle e altri insetti. Nel 1703, nelle Philosophical Transactions lo stesso Petiver pubblicò un resoconto su una settantina di piante raccolte di Cunninghame a Chusan; infine in Gazophylacii naturae (1702–09), ne descrisse un'altra ventina, insieme a conchiglie raccolte all'Ascension e Pulo Condore, falene, coleotteri e un millepiedi delle Indie Orientali. Ancora più ampio è l'utilizzo dei materiali di Cunninghame da parte di Plukenet. In Amaltheum botanicum vengono descritte circa 400 piante risalenti alle sue raccolte di Chusan, circa metà delle quali sono anche raffigurate nel terzo volume di Phytographia. Infine, nel terzo volume di Historia Plantarum, John Ray descrisse 22 specie raccolte da Cunninghame ad Amoy. Tra le specie più notevoli, tra gli alberi troviamo in primo luogo quella destinata ad immortalare il nome di Cunninghame, Cunninghamia lanceolata, e Cryptomeria japonica; tra gli arbusti, Camellia japonica, Loropetalum chinense, Chimomanthus praecox, Hibiscus tiliaceus e Abelmoschus manihot, nonché il nespolo giapponese Eriobotrya japonica (recentemente riclassificata come Rhaphiolepis bibas). Grazie ai semi inviati a Petiver, ma anche a Uvedale, qualche specie dovette essere introdotta in coltivazione; potrebbe essere il caso di due specie di crisantemi osservati a Chusan. Gli erbari e la collezione di acquarelli, che Petiver definiva "herbarium nostrum sinicum pictum", dovettero passare a Petiver, e dopo la morte di questi, essere inglobati nelle collezioni prima di Sloane, poi del British Museum. Sotto il titolo Drawings of Chinese Flowers, Plants, and Fruits, in colours, by a native artist, at Emuy, i dipinti sono oggi custoditi alla British Library; recentemente digitalizzati, sono consultabili a questo indirizzo.  Un genere per due Nel 1791 si ricordò di questo sfortunato pioniere dello studio della flora cinese J. C. D. von Schreber, dedicandogli Cunninghamia (Rubiaceae). Trattandosi di un nome illegittimo e superfluo, non viene preso in considerazione, al contrario del secondo genere Cunninghiamia (Cupressaceae) creato nel 1826 da Robert Brown. In una pubblicazione più tarda, quest'ultimo ne spiega chiaramente la motivazione: "Il genere deve essere denominato Cunninghamia, per commemorare i meriti del sig. James Cunningham, un eccellente osservatore ai suoi tempi, da cui questa pianta fu scoperta"; ma aggiunge: "e in onore del sig. Allan Cunningham, l'assai meritevole botanico che accompagnò il sig. Oxley nella sua prima spedizione nell'interno del Nuovo Galles del Sud, e il capitano King in tutti i suoi viaggi di ricognizione della costa della Nuova Olanda". Insomma, Brown prese due piccioni con una fava e dedicò Cunninghamia a due differenti botanici quasi omonimi. Sul secondo, assai importante per la storia dell'esplorazione della flora australiana, sarà necessario tornare in altri post. Per ora, soffermiamoci sull'interessantissimo genere Cunninghamia. Con due specie, C. lanceolata, originaria della Cina meridionale, e C. konishii, forse endemica di Taiwan, ma presente anche in Indocina - ma per molti si tratta di una varietà della precedente, C. lanceolata var. konishii-, è considerato il genere più primitivo tra le Cupressaceae, tanto che alcuni botanici l'hanno assegnato a una famiglia propria (Cunninghamiaceae). Sono alberi di notevoli dimensioni (anche più di 50 metri), di portamento conico e piramidale, con rami tendenzialmente orizzontali ma pendenti alle estremità. Gli aghi, piatti, coriacei, verde scuro o glauco, si dispongono a spirale lungo i rami; la pagina inferiore (e talvolta anche quella superiore) è caratterizzata da due bande di stomi bianche o verde chiaro. Monoiche, hanno fiori maschili cilindrici raccolti in amenti all'estremità dei rami; quelli femminili sono strobili giallo-verdastro lunghi circa un cm. I frutti sono coni verdastri, da ovali a globosi, ricoperti da scaglie disposte a spirale. In Cina C. lanceolata è molto apprezzata per il legname, leggero, durevole, profumato e non attaccato dai parassiti. La sua coltivazione è anzi in costante crescita, andando a costituire circa un terzo delle piantagioni di alberi da legname e un quarto della produzione di legname della Cina. Introdotto in occidente a inizio Ottocento da William Kerr, in Europa rimane una pianta per intenditori, presente in pochi parchi e arboreti. Altre informazioni nella scheda. In anni decisivi per la storia della botanica inglese, tra fine Seicento e inizio Settecento, il farmacista James Petiver riesce a conquistare prestigio nella società colta grazie alla sua formidabile collezione di esemplari d'erbario, conchiglie, insetti, fossili e così via, seconda solo a quella del ben più ricco Hans Sloane. Raggiunge l'intento tessendo una straordinaria rete di contatti, con almeno un centinaio di corrispondenti tra Europa, Americhe, Asia meridionale e orientale, Africa occidentale e Sudafrica: studiosi e appassionati come lui, ma soprattutto persone comuni, giardinieri, capitani di marina, medici, chirurghi e sacerdoti che vivono nelle colonie e contribuiscono chi con un esemplare, chi con molti, pur di essere citati nelle sue Centurie e di partecipare al progresso delle scienze. Un modello di cui farà tesoro lo stesso Linneo, che lo ricordò con il monotipico genere Petiveria. 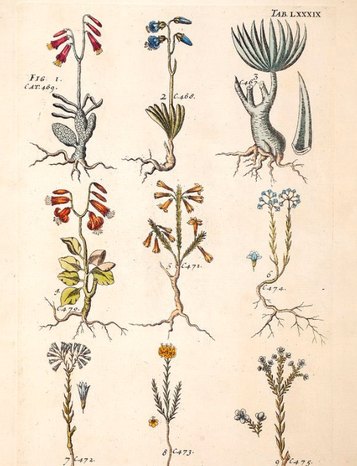 Come nacque una grande collezione Nel 1706, con la morte del curatore Samuel Doody, tra i farmacisti londinesi riprese l'eterno dibattito: aveva senso continuare a mantenere il costoso Physic Garden di Chelsea, o era meglio liberarsi di quell'impianto mangia-soldi? Per valutare la situazione finanziaria, venne formato un comitato che fu anche incaricato di prendere contatto con il proprietario del terreno, sir Charles Cheyne, per verificarne l'eventuale acquisto. Cheyne chiese una cifra irraggiungibile: 400 sterline. Nonostante ciò, il comitato si pronunciò a favore del mantenimento del giardino e per far fronte ai debiti indisse una sottoscrizione straordinaria, alla quale, per dare l'esempio, i suoi membri aderirono per primi. Il seguito tra gli altrui soci fu modesto, ma il giardino sopravvisse. Gran parte del merito va ascritto al membro più autorevole del comitato stesso, il farmacista James Petiver (1663-1718), che succedette a Doody come curatore del giardino, ma anche come "dimostratore di botanica". I suoi compiti principali erano due: da una parte, impartire lezioni di botanica pratica ("dimostrazioni") ai giovani apprendisti, da tenersi almeno due volte al mese nel Physic Garden nei mesi estivi; dall'altra, organizzare la Grande erborizzazione annuale, con la partecipazione di maestri ed apprendisti. Abbiamo già incontrato Petiver come amico di Doody e attivo membro del Temple Coffee House Botanical Club; è ora di conoscerlo meglio. Figlio di un merciaio di Rugby, poco dopo la morte di quest'ultimo dovette interrompere gli studi e sempre ne ebbe rammarico, soprattutto per non aver potuto acquisire una sufficiente padronanza del latino, all'epoca la lingua ufficiale delle scienza. Nel giugno 1677, quattordicenne, iniziò il suo apprendistato sotto Charles Feltham, il farmacista del St Bartholomew's Hospital di Londra. Intorno al 1680 conobbe Whatts e cominciò a frequentare il giardino di Chelsea, stringendo amicizia con Doody; a quanto risulta dal suo erbario, almeno dal 1683 prese regolarmente parte agli herborizing organizzati dalla Società dei farmacisti. Nel 1685, terminati i previsti otto anni di apprendistato, ottenne la licenza e tra il 1686 e il 1687 aprì una propria farmacia all'insegna della Croce bianca in Aldersgate Street (nei pressi dell'attuale Barbican Centre), che avrebbe gestito fino alla fine dei suoi giorni. A questo punto doveva già essersi fatto un nome come esperto botanico, visto che nel 1688, insieme all'amico Doody, viene ringraziato da John Ray per l'aiuto prestato per il secondo volume di Historia Plantarum. Probabilmente attraverso Doody, conobbe Sloane, rientrato dalla Giamaica nel 1689 con un'enorme collezione di naturalia, e incominciò a frequentare il Temple Coffee House Botanical Club, di cui diventò la personalità più nota dopo lo stesso Sloane. Forse incoraggiato dall'esempio di questi, decise di creare una propria collezione, che sarebbe stato anche il migliore biglietto da visita per garantire a lui, semplice farmacista "illetterato", l'accesso alla società colta londinese. Non aveva le enormi disponibilità finanziare di Sloane, ma poteva trarre profitto da un altro vantaggio: come farmacista e fornitore di farmaci di alcuni ospedali londinesi, nella sua bottega già affluivano spezie e piante medicinali da molte parti del mondo; era dunque in contatto con membri della Compagnia delle Indie e mercanti che praticavano il commercio internazionale. Come risulta dalle sue lettere, almeno dal 1690 Petiver incominciò a tessere quella formidabile rete di contatti che gli avrebbe permesso di essere il più importante collezionista del suo tempo dopo il ricchissimo Sloane. Uno dei suoi primi corrispondenti documentati è il chirurgo Samuel Browne, che lavorava per la Compagnia delle Indie orientali a Fort St George in Bengala (oggi Chennai). Non solo Browne raccolse per lui molte piante, che gli inviò in Inghilterra accompagnate da note con i nomi locali, ma a sua volta lo mise in contatto con altre persone: il reverendo George Lewis, collezionista di conchiglie, e soprattutto il missionario gesuita Georg Joseph Kamel, pioniere dello studio della flora delle Filippine. A sua volta Petiver fece da tramite tra Kamel e Ray, che pubblicò l’opera del missionario moravo in appendice al terzo volume di Historia Plantarum. Si tratta solo del nucleo iniziale di una vastissima rete di corrispondenti e contributori, che giunse a comprendere oltre cento persone: alcuni erano noti scienziati, come Boerhaave o Tournefort, oppure collezionisti e proprietari di grandi giardini come i fratelli Sherard, la duchessa di Beaufort o il vescovo Compton, ma la stragrande maggioranza era costituita da persone comuni: chirurghi, medici, capitani di nave, mercanti, sacerdoti, giardinieri che contribuirono chi con un esemplare, chi con dozzine e dozzine di piante, insetti e altri animali, conchiglie, fossili, spediti da vari paesi europei, dalla Cina, dall’India, dal Sud Africa, dal Sud e dal Nord America. È stato sottolineato che almeno un terzo di queste persone era legato in un modo o nell’altro al commercio triangolare, o in altri termini alla tratta degli schiavi. Oltre a Browne, i contributori più importanti furono Hendrik Oldenland, il curatore dell’orto botanico della VOC a Table Bay, e James Cunninghame, un chirurgo scozzese che lavorava per la Compagnia delle Indie nelle basi di Zhoushan e Amoy (oggi Xiamen) in Cina e fu il primo europeo a raccogliere un significativo erbario di piante cinesi. Per i suoi contributori, Petiver giunse a stilare prima liste di "desiderata", poi vere e proprie istruzioni stampate sulle modalità di raccolta, conservazione e spedizione, che costituiscono un modello e un'anticipazione delle indicazioni di Linneo ai suoi apostoli. Col tempo, la sua bottega di Aldersgate Street si trasformò in una specie di centro di interscambio, dove da tutto il mondo giungevano pacchi di esemplari, libri, lettere con richieste di consulenza ma anche di materiali. Per Petiver, infatti, il collezionismo di naturalia era anche un'attività lucrativa: se tratteneva per sé gli esemplari che considerava più prestigiosi o interessanti, altri li vendeva a caro prezzo ad altri collezionisti. 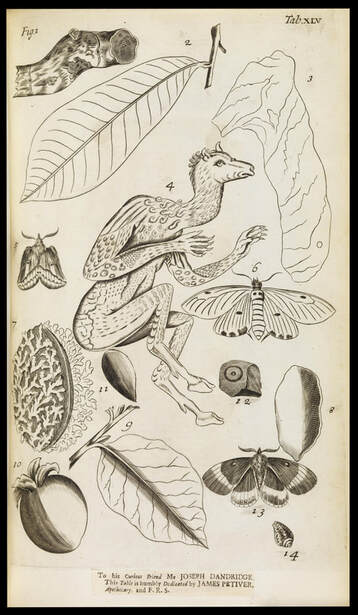 Collezionista e dimostratore Con la sola eccezione di un viaggio nei Paesi Bassi di cui parleremo più avanti, Petiver limitò le sue attività di raccolta diretta a qualche escursione in Inghilterra; oltre che nei dintorni di Londra, sono documentati viaggi nelle Midlands, in Essex, a Bath, a Bristol, nell'Essex e nel Suffolk. Il grosso delle sue collezioni arrivava però dai suoi corrispondenti che lo misero in contatto, letteralmente, con tutti i continenti (eccetto l'ancora inesplorata Oceania), permettendogli di accumulare una collezione che, oltre a centinaia e centinaia di altri esemplari, comprendeva almeno 5000 piante essiccate. A partire dal 1695, cominciò a pubblicare gli esemplari più curiosi, rari o significativi in una serie di cataloghi, dapprima senza immagini, poi illustrati, organizzati come "centurie", ovvero in serie di cento esemplari. Il primo è Musei Petiveriani centuria prima (1695), che descrive cento tra insetti, conchiglie, fossili e piante provenienti da Europa, America settentrionale, Africa occidentale, Asia meridionale e orientale; tra il 1698 e il 1703 seguirono altre cinque centurie, per un totale di seicento naturalia. Petiver pubblicò inoltre dozzine di brevi articoli nella rivista The Monthly Miscellany e molti contributi nelle Transactions della Royal Society, di cui divenne membro nel 1695 (nella stessa seduta dell'amico Samuel Doody). I suoi lavori più rilevanti sono la relazione sulle piante indiane ricevute da Browne An account of some Indian plants (1698) e due scritti di entomologia: Gazophylacium naturae et artis (1702–6), un catalogo illustrato degli insetti britannici, e Papilionum Brittaniae Icones, la prima rassegna completa dei lepidotteri inglesi che lo ha fatto salutare come «padre delle farfalle britanniche», che non di rado ha battezzato con il nome comune che portano ancora oggi. Petiver era anche un abile uomo d’affari e mise la sua competenza manageriale al servizio sia della Royal society, sia del Chelsea Physic Garden, anche se, di fronte ai suoi mille impegni professionali (oltre che del St Bartholomew, divenne anche farmacista della Charterhouse school and hospital), il suo incarico di dimostratore passava un po’ in secondo piano, tanto che presto dovette essere affiancato da Isaac Rand; il suo maggior merito fu sistematizzare e estendere le escursioni botaniche. Mentre in precedenza se ne teneva solo una all’anno, con Petiver e Rand il loro numero crebbe fino a sei, una al mese per tutta la bella stagione, a partire da aprile. Accompagnati dal dimostratore, gli apprendisti raggiungevano località come Hampstead Head, Putney e Greenwich per escursioni di una ventina di miglia; durante il pranzo, che di solito si teneva in qualche osteria, le piante venivano esaminate e identificate e ne venivano descritte le particolarità e le virtù medicinali. L’ultima escursione, detta General Herborizing, poteva durare due giorni, coprire una sessantina di miglia, era riservata ai maestri e ai loro ospiti, spesso membri eminenti dei Collegi dei medici e dei chirurghi, ed era anche un’importante occasione sociale. Anche il Chelsea Physic Garden poté beneficiare della rete di Petiver per un sensibile arricchimento delle collezioni. In particolare, nel 1711, per incarico di Hans Sloane, Petiver si recò in Olanda per trattare l’acquisto delle collezioni di Paul Hermann, messe all’asta dalla vedova; fu l’occasione per conoscere di persona Boerhaave e per rinnovare la collaborazione e gli scambi tra i due orti botanici. Tra il 1711 e il 1714, Petiver pubblicò sulle Philosophical Transactions una serie di articoli molto interessanti per chi studia la storia delle introduzioni delle piante esotiche, perché vi recensì le piante rare recentemente introdotte dal Nord America, dalla Cina e dalla Provincia del Capo e coltivate con successo nei giardini del vescovo di Londra a Fulham, in quello della duchessa di Beaufort e soprattutto a Chelsea. A partire dal 1716, la sua salute cominciò a declinare. Alla sua morte, nel 1718, le sue collezioni furono acquistate da Sloane, che ebbe a lamentare il grande disordine in cui erano tenute; ora sono in parte conservate nel Natural History Museum di Londra.  Un'erbacea... odorosa Anche Petiver fa parte del nutrito gruppo di naturalisti omaggiati da Plumier e Linneo con la dedica di un genere botanico. Il francese fece in tempo a vedere il primo catalogo della sua collezione, e lo loda per la ricchezza dei materiali e il buon ordine in cui sono disposti (il che contrasta con le lamentele di Sloane, ma anche con ciò che riferiscono alcuni viaggiatori che ebbero l'occasione di vederle di persona). Linneo attinse ampiamente alle pubblicazioni di Petiver sia per le piante esotiche, da lui documentate per la prima volta, sia per gli insetti, e apprezzava il fatto che in alcuni dei suoi contributi sulle Transactions il farmacista avesse abbozzato una classificazione naturale. Il genere Petiveria L. (appartenente a una famiglia propria, Petiveriaceae) comprende una sola specie, P. alliacea: caratterizzata come dice il nome da un forte odore di aglio, è una grande erbacea perenne cespugliosa, con foglie intere obovate e infiorescenze a spiga di piccoli fiori biancastri, cui nei paesi d’origine (gran parte dell’America subtropicale e tropicale, dalle Florida al Perù) sono attribuite innumerevoli proprietà terapeutiche; per l’odore, è però utilizzato anche come repellente. Qualche informazione in più nella scheda. Il secondo orto botanico inglese nasce un po' per caso nel 1673 per volontà della Corporazione dei farmacisti londinesi. Siamo ancora lontani dalle future glorie: gli inizi sono confusi e contrastati, con la Corporazione sempre indecisa se continuare o meno quell'impresa rivelatasi troppo dispendiosa. Per qualche anno, a dirigere il giardino è il farmacista Samuel Doody, amico e compagno di scorribande botaniche di Buddle e Petiver, specialista di crittogame, stimato anche da John Ray. La dedica del genere di felci Doodia appare dunque quanto mai appropriata.  Un inizio travagliato Il secondo orto botanico inglese nacque un po' per caso, oltre mezzo secolo dopo il primo, quello di Oxford. A prendere l'iniziativa fu la Corporazione londinese dei farmacisti (Worshipful Society of Apothecaries), nell'ambito di un lungo braccio di ferro legale con il Collegio dei medici. Gli statuti reali concedevano alla Worshipful society ampia autonomia e la facoltà di addestrare ed esaminare i propri membri, che erano ammessi alla professione dopo un tirocinio in bottega di otto anni, durante il quale imparavano a riconoscere i semplici, a preparare i medicamenti e a somministrarli correttamente. Non erano però autorizzati a prescriverli, compito riservato ai soli medici autorizzati. Tuttavia, la rapida crescita della popolazione londinese e le ricorrenti epidemie resero insufficiente il numero di questi ultimi, e la società dei farmacisti ricorse alla legge per veder riconosciuto ai propri membri il diritto legale di praticare la medicina di base: dopo anni, la battaglia fu infine vinta nel 1704, quando la Camera dei Lord si pronunciò a favore dei farmacisti contro l’ordine dei medici; il diritto della Corporazione londinese dei farmacisti di impartire un'istruzione medica primaria e di concedere licenze professionali a chirurghi, ostetriche e ginecologi sarebbe perdurato fino al 1999. Per accreditarsi agli occhi dei tribunali e dei Lord, la Corporazione doveva dimostrare la competenza professionale dei propri membri, in particolare la perfetta conoscenza delle erbe officinali, da cui si traeva la maggior parte dei medicamenti. Essa possedeva un hortus medicus a Westminster, di cui sappiamo ben poco, ma il principale strumento didattico sembra fossero le herborizing, escursioni nelle campagne dei dintorni in cui gli apprendisti erano guidati dai maestri a raccogliere e riconoscere le erbe. Da resoconti dell'epoca, sappiamo che si collocavano a metà tra l'occasione didattica e l'allegra scampagnata, e si concludevano immancabilmente in un'osteria. Poiché le strade erano scomode o poco sicure, apprendisti e maestri raggiungevano le località prescelte con una barca affittata allo scopo; tuttavia nel 1673 la società decise l’acquisto di un’imbarcazione, da usare anche per le feste solenni, come la parata annuale organizzata dal sindaco di Londra; in tali occasioni, veniva pavesata a festa, con nastri, pennoni, bandiere, lo stemma dei farmacisti e sculture di unicorni e rinoceronti. Si poneva il problema di trovare un posto per ricoverare la "barca sociale", che, diversamente dall’hortus di Westminster, avesse accesso diretto dal fiume. A tal fine, la Società dei farmacisti affittò da Charles Cheyne, proprietario del Chelsea Manor, un terreno di quattro acri situato nel villaggio di Chelsea, poco distante dal Tamigi, e vi fece costruire tre rimesse, una per la propria barca, le altre due da affittare ad altre corporazioni. Non era lontano neppure dall’affollato mercato di Chelsea, per cui l’anno successivo fu deciso di proteggerlo con un muro di cinta. Solo a questo punto, la Società decise di approfittare del suolo fertile e della posizione riparata per spostare qui le piante fino ad allora coltivate a Westminster e creare un Physic garden (ovvero hortus medicus), destinato sia alla produzione di erbe medicinali da vendere o da elaborare nel proprio laboratorio, sia all’addestramento degli apprendisti. Per gestire il trasferimento e creare il nuovo giardino, fu assunto il giardiniere Spencer Piggott, che però si rivelò disonesto, tanto che dopo un anno o due il contratto non gli venne rinnovato. Il 1678 gli succedette il più affidabile Richard Pratt che procedette ai trapianti, piantò diverse piante da frutto e preparò le aiuole didattiche, divise in pulvilli sul modello di Leida. Dal 1680 la gestione generale fu affidata al farmacista John Watts, un abile uomo d'affari e un intenditore di piante esotiche, che coltivava in uno splendido giardino privato a Enfield. Con l'assistenza di due giardinieri, il suo compito principale era arricchire il giardino di piante autoctone ed esotiche; per ospitare queste ultime, egli fece subito allestire una serra riscaldata, presumibilmente la prima del paese. Nel 1682 le collezioni erano già abbastanza ricche da meritare una visita di Paul Hermann, che invitò Watts a Leida. Nacque così il primo programma di scambi a noi noto tra orti botanici. Nel 1683 Watts andò a Leida in compagnia di George London, il giardiniere del vescovo Compton, e ne ritornò con moltissime piante, tra cui i famosi quattro cedri del Libano che divennero il simbolo del giardino. Inoltre Watts, che era un mercante specializzato nel commercio internazionale, con interessi anche in Cina, organizzò almeno una spedizione botanica, inviando in Virginia il cacciatore di piante James Harlow. Tuttavia, sul piano finanziario, anche la sua gestione si rivelò un disastro: i giardinieri divennero ben sei, la serra consumava impressionanti quantità di legname e di soldi, Watts si fece anche raddoppiare lo stipendio da 50 a 100 sterline annue e usò liberamente il terreno per coltivazioni in proprio, con eterne questioni su quali piante fossero sue e quali della società. Per di più, spremuto lo spremibile, prese ad assentarsi sempre di più, finché nel 1692 il contratto non gli fu rinnovato.  Il secondo curatore del Physic garden Pur tra tante difficoltà, il giardino aveva cominciato ad assolvere il suo compito di formare una generazione di giovani farmacisti, alcuni dei quali divennero anche appassionati botanici. Tra di loro troviamo due amici e quasi coetanei, Samuel Doody (1656-1706) e James Petiver (1663 – 1718), entrambi venuti a Londra dalla provincia per diventare apprendisti farmacisti. Le gite fuori porta stimolarono la loro passione per le erborizzazioni in compagnia, che condividevano con altri amici, come Hans Sloane, che, prima di andare a studiare medicina e botanica in Francia, aveva frequentato insieme a loro le aiuole di Chelsea e le allegre herborizing. Intorno al 1685, quasi contemporaneamente, i due si abilitarono alla professione e aprirono le loro farmacie, Doody nello Strand e Petiver a Islington. A quel punto dovevano già essere membri attivi di quel circolo londinese di studiosi di botanica e scienze naturali che a partire dal 1689 prese a riunirsi nel cosiddetto Temple Coffee House Botanical Club. Oltre a Sloane, che ne era l'animatore, un punto di riferimento era John Ray, anche se quest'ultimo era tornato a vivere nel villaggio natale di Black Notley e veniva solo occasionalmente a Londra. Insieme al curatore dell'orto botanico di Oxford Jacob Bobart il giovane, a Sloane e al suo amico Tancred Robinson, i due farmacisti collaborarono con le loro raccolte e le loro note a Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum di John Ray, la cui prima edizione uscì nel 1690. È stato anzi supposto che tra di loro si fosse stabilita una certa divisione dei compiti, nell'intento comune di riconoscere e recensire il maggior numero possibile di piante della flora britannica. Doody si specializzò in un campo ancora poco battuto, quello delle crittogame, in particolare muschi e licheni. Su questo argomento corrispondeva con il reverendo Adam Buddle, che talvolta veniva a Londra per erborizzare con lui e Petiver, o per confrontare le raccolte, discutendone davanti a un bicchiere di vino o un boccale di birra al Greyhound Tavern di Fleet Street o in altre taverne londinesi. Un altro corrispondente di Doody era Edward Lhwyd, il custode dell'Ashmolean Museum, che invece si era concentrato nello studio dei fossili. Grazie a questi contatti e alla collaborazione con Ray, il farmacista aveva ormai una solida reputazione di botanico che sicuramente pesò quando, nel 1692, fu chiamato a sostituire Watts come curatore del Chelsea Physic Garden. Era in qualche modo un tentativo di salvare il giardino, che molti membri della società avrebbero preferito dismettere. Doody, come il predecessore, ricevette un salario di 100 sterline, al quale tuttavia rinunciò a partire dal 1696 quando prese in affitto una parte dell'appezzamento. Il suo primo compito fu catalogare le piante per sbrogliare la matassa di quali spettassero alla Society e quali a Watts. Quindi anch'egli si diede da fare per incrementare le collezioni, organizzando una spedizione alle Canarie nel 1694. Si impegnò molto nelle herborizing, durante le quali faceva sfoggio del suo sapere botanico. Sia lui sia Petiver entrarono a far parte del comitato che seguiva la disputa legale con il Collegio dei medici e nel 1695 furono ammessi nella medesima seduta alla Royal Society, di cui da poco l'amico Sloane era diventato uno dei segretari. L'unico contributo di Doody alle Transactions della Società fu una comunicazione su un caso di idropisia (1697). Anche sulla sua gestione del Physic Garden non sappiamo molto altro; in ogni caso fu breve, perché egli morì nel 1706. A presiedere la cerimonia funebre fu Adam Buddle. I suoi libri, l'erbario e qualche manoscritto confluirono nelle collezioni di Sloane. Il pezzo di maggior interesse è una copia della seconda edizione della Synopsis methodica di Ray, interfogliata con note di pugno di Doody che riguardano soprattutto funghi, muschi e licheni e furono utilizzate da Dillenius per la terza edizione.  Felci ruvide Fu il ruolo pionieristico di Doody in questo campo a suscitare l'interesse di Robert Brown che nel 1810 gli dedicò il genere Doodia con questa breve motivazione: "L'ho dedicato alla memoria del farmacista londinese Samuel Doody, quasi il primo in Inghilterra ad esplorare le crittogame". Doodia è un piccolo genere di felci della famiglia Blechnaceae, con 15-20 specie distribuite tra l'Asia sud-orientale, l'Australia e la Nuova Zelanda, di status tassonomico discusso. Secondo il gruppo di lavoro diretto da M. J. M. Christenhusz (2011) è annidato in Blechnum, nel quale va fatto confluire. Secondo il Pteridophyte Phylogeny Group (PPG, 2016) va mantenuto come genere autonomo, uno dei diversi un cui va smembrato il polifiletico Blechnum. Sono piante terrestri, in genere sempreverdi, con fronde unipinnate, foglie lanceolate e ruvide al tatto (da cui il nome comune inglese rasp fern, "felce rasposa"); i sori sono disposti in file ai lati della nervatura centrale delle pinnae e le loro tracce sono ben visibili sulla superficie superiore. In genere al momento dell'apertura le fronde sono da rosate a rossastre, per poi diventare verde scuro. E' questa la maggiore attrattiva di queste felci, di cui in giardino si coltivano soprattutto due specie australiane, tendenzialmente tappezzanti e di facile coltivazione, ma purtroppo non del tutto rustiche, D. aspera e D. media. Alcune specie di ridotte dimensioni, come l'australiana e neozelandese D. caudata, sono anche adatte alla coltivazione in un giardino alpino. Qualche approfondimento nella scheda. Non stupisce che la duchessa di Beaufort, grande appassionata senza problemi di mezzi, appena vide le serre riscaldate di Hampton Court, si affrettasse a farsi costruire un'analoga "serra tropicale" per i suoi giardini di Badminton. Più curioso è che anche prima di lei se ne fosse dotato un semplice maestro di scuola: il dr. Robert Uvedale. Come per la ben più ricca nobildonna, anche per lui le piante erano una ragione di vita ed era così abile nel coltivarle che la sua reputazione di esperto orticoltore travalicava le frontiere britanniche. Gli è attribuita l'introduzione in Inghilterra di due piante: quella dubbia del cedro del Libano e quella documentata del pisello odoroso. A ricordarlo, tramite l'amico Petiver, l'epiteto linneano di Smallanthus uvedalia, e il genere australiano Uvedalia (Phrymaceae).  Piselli siciliani e cedri libanesi I britannici hanno una vera passione per i piselli odorosi Lathyrus odoratus. Non solo li coltivano ampiamente nei loro giardini, magari facendoli arrampicare su apposite piramidi sullo sfondo dei mixed border, ma ne fanno i protagonisti di premi e concorsi e ne arricchiscono continuamente la gamma con nuove selezioni e varietà. I nomi di due di esse, 'Cupani' e 'Robert Uvedale', ci portano all'origine di questa passione. Lathyrus odoratus è un endemismo della Sicilia e di alcune aree dell'Italia meridionale. Il primo a darne una descrizione fu Francesco Cupani in Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum (1694) e poi nuovamente in Hortus catholicus (1696). Nel 1699 ne inviò i semi a Caspar Commelin dell'orto botanico di Amsterdam, che li coltivò con successo e fece ritrarre la pianta nel quarto volume del Moninckx Atlas (1699) come Lathyrus siculus. La bella specie, deliziosamente profumata, che ogni tanto produceva fiori bianchi, ottenne successo; nel 1737 Burman attesta che era ormai coltivatissimo nei giardini dei Paesi bassi, compreso quello del patrono di Linneo George Clifford, dove il botanico svedese lo vide, ripubblicandolo in Hortus cliffortianus come Lathyrus odoratus. Cupani inviò semi anche ad altri corrispondenti, uno dei quali era l'inglese Robert Uvedale (1642-1722). Laureato in teologia a Cambridge, Uvedale era un semplice maestro di scuola: dirigeva la Grammar School di Enfield, a nord di Londra, ma soprattutto era famoso in tutta l'Inghilterra come grande esperto di orticultura e floricoltura; la sua specialità erano le piante esotiche, per coltivare le quali si era dotato di arancere e di una delle primissime serre riscaldate del paese. I semi di Cupani capitarono dunque in ottime mani, non solo perché Uvedale li coltivò nel migliore dei modi, ma anche perché li diffuse tra i suoi amici. Anche se egli stesso non ne faceva parte, alcuni di essi erano i colti gentiluomini che si riunivano nel Temple Coffee House Botany Club: Leonard Plukenet, che forse era stato suo compagno di scuola, il farmacista James Petiver e il dr. Sloane, almeno un nipote del quale fu suo allievo; tra i corrispondenti più assidui il medico, antiquario e collezionista Richard Richardson. Nel 1700 Plukenet pubblicò la nuova specie in Almagesti Botanici Mantissa e diversi esemplari coltivati a Enfield sono tuttora conservati nel suo erbario. Come in Olanda, anche in Inghilterra quel fiore profumatissimo piacque molto; nel 1724 cominciò ad essere disponibile nei cataloghi dei vivai. Era l'inizio di un grande amore che perdura tuttora. Oggi le varietà si contano a centinaia. Tra di esse 'Cupani', la più simile al pisello odoroso originario: ha solo due fiori per stelo, piccoli e bicolori, ma profumatissimi. C'è anche 'Robert Uvedale', con grandissimi fiori rosa intenso. Il pisello odoroso non è l'unica specie la cui introduzione è attribuita a Uvedale. Ma dal campo dei fatti, passiamo in quello della leggenda. Fino al 1920, presso l'Enfield Palace si poteva ammirare un esemplare secolare di cedro del Libano Cedrus libani, che sarebbe stato piantato da Uvedale tra il 1662 e il 1670, da semi portati da Gerusalemme da un allievo. Si tratterebbe del primo esemplare piantato in Inghilterra, se non in Europa. E' una pretesa largamente infondata. Le prime pigne di cedro furono portate in Inghilterra nel 1639 da Edward Peckock, Cappellano della compagnia turca ad Aleppo, che le passò al fratello, cappellano del conte di Pembroke a Wilton (Devon); intorno al 1640 due esemplari nati dai loro semi furono messi a dimora nel parco di Wilton e vissero fino al 1874. Più tardi Peckock divenne rettore di Childrey, Oxfordshire, e piantò nel giardino del rettorato un esemplare che sopravvive tuttora. Quando Uvedale piantò il suo a Enfield, dunque, se la data tradizionale è fondata, il cedro di Childrey era già un bell'albero di 40 o 30 anni, Ma anche quella data è stata contestata. In nessuna delle lettere di Uvedale ai suoi numerosi corrispondenti egli cita l'albero né viene menzionato nella descrizione del giardino di Enfield contenuta in Short Account of several Gardens near London di J. Gibson (1691). John Ray, un altro dei corrispondenti di Uvedale, parlando dei quattro esemplari di cedro piantati al Chelsea Physic Gardens nel 1683, si dice convinto che siano i primi ad essere piantati in Inghilterra (come abbiamo visto, non lo sono; ma furono i primi a fruttificare, e da loro discendono i virgulti portati al Jardin des Plantes da Bernard de Jussieu), Dal libro di Gibson ricaviamo interessanti informazioni sul giardino di Enfield: "Il dr. Uvedale di Enfield è un grande amante delle piante e, avendo un'arte straordinaria nel coltivarle, è riuscito a creare una delle più grandi e rare collezioni di esotiche che si siano viste in questo paese. Il giardino comprende cinque o sei edifici o ambienti. Il più vasto è occupato da aranci e da grandissimi mirti, un altro è riempito da mirti più piccoli; le piante più graziose e curiose, che richiedono maggior cura, si trovano in stanze più calde, alcune delle quali possono essere riscaldate all'occorrenza. I fiori sono scelti, l'assortimento ricco, la coltivazione metodica e curiosa; non vale però la pena di parlare dell'aspetto generale del giardino, perché la sua delizia e la sua cura più che nel piacere dell'occhio risiedono nella coltivazione di piante rare". Insomma, ancora lontano dal giardino paesaggistico all'inglese, il giardino di Uvedale è ancora essenzialmente una camera delle meraviglie barocca, in cui il sommo piacere è dato dall'ostentazione di piante rare, la cui coltivazione è resa possibile da una serie di stanze con temperature variabili; che una o più siano riscaldabili è una novità nell'Inghilterra del 1691, se pensiamo che sono precedute solo dalla "stufa" del giardino dei farmacisti a Chelsea (forse 1681) e dalle tre serre della regina a Hampton Court (1690). Persino la "serra delle esotiche" della ben più ricca duchessa di Beaufort arriva dopo. Né ricco né nobile, questo modesto insegnante di provincia, non di rado in conflitto con i suoi superiori, traeva dalla rarità delle collezioni, dalla suprema abilità di coltivatore e dalla frequentazione di dotti e stimati botanici un prestigio capace di elevarne lo status e di farne una figura riconosciuta, come abbiamo visto, persino in Sicilia. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1722, la collezioni di piante vive fu acquistata da Robert Walpole per Houghton Hall; l'erbario fu invece acquisito da Sloane. Anch'esso documenta la rete di corrispondenti di Uvedale, con esemplari ottenuti non solo da corrispondenti inglesi come Sherard, Richardson, Petiver, Plukenet, Bobart, Doody, Sloane, Du Bois, ma anche da corrispondenti continentali come Tournefort, Magnol, Vaillant e altri.  Dediche intricate Il dr. Uvedale doveva anche possedere il talento dei rapporti umani, tanto che riuscì a conservarsi l'amicizia sia di Plukenet sia di Petiver, nonostante l'ostilità tra i due. Al primo forniva piante per i suoi libri e per i giardini di Hampton Court, il secondo lo onorò battezzando Wedalia (il cognome poteva essere scritto in vari modi, incluso Wedal) una bella asteracea nordamericana con foglie palmate e capolini giallo oro. Linneo, prima in Hortus cliffortianus poi in Species plantarum, riprese la denominazione di Petiver, ma ne normalizzò la grafia e la trasformò in epiteto, ribattezzando la specie Polymnia uvedalia. Oggi si chiama Smallanthus uvedalia. Del nome generico così rimasto disponibile si ricordò a inizio Ottocento Robert Brown che in Prodromus Florae Novae Hollandiae (1810) istituì il genere Uvedalia per una piccola pianta da lui scoperta in Australia, U. linearis. Nella breve motivazione sono citati esplicitamente Plukenet, Petiver e il giardino di Enfield: "Questo genere, forse troppo affine a Mimulus, l'ho battezzato Uvedalia in memoria del dottore in teologia e legge Uvedale, lodato da Plukenet e Petiver, che nei pressi di Enfield creò un giardino soprattutto ricco di esotiche". Che fosse troppo affine a Mimulus lo pensavano sicuramente de Candolle che nel 1813 soppresse il genere e lo fece confluire in Mimulus, nonché Bentham che nel 1835 ribattezzò la specie di Brown dapprima Mimulus linearis, quindi M. uvedaliae, con un assurdo genitivo. Questa è stata la situazione per circa 200 anni, fino al 2012, quando Barker e Beardsley hanno fatto risorgere Uvedalia nell'ambito di una revisione generale di Mimulus, che ha comportato il distacco delle specie australiane, assegnate a sei piccoli generi, tra cui appunto Uvedalia con due specie, U. linearis e U. clementii. Ovviamente una soluzione che non piace a tutti: altri preferirebbero un genere Mimulus onnicomprensivo, sulla scia della linea adottata di recente per Salvia. Al momento, però, Uvedalia resiste. U. linearis è una piccola erbacea che vive nei suoli sabbiosi dei territori del nord dell'Australia, con foglie lineari e fiori con corolla bilabiata blu-violaceo con gola gialla, oppure gialla a volte puntinata di rosso nella varietà lutea. La poco nota e rara U. clementii è invece nativa dell'Australia nord occidentale. Nel 1691, poco dopo essere stato nominato dalla regina Mary giardiniere reale e curatore del giardino di Hampton Court, Leonard Plukenet dà alle stampe a proprie spese il primo volume di Phytographia; è l'atto di nascita di uno straordinario corpus di immagini di rarità botaniche provenienti da tutto il mondo, che arriverà a comprendere oltre 2700 figure. Con centinaia di specie inedite o almeno mai raffigurate in precedenza, è un'opera di riferimento imprescindibile per i botanici successivi, in particolare Linneo che volle dedicare a questo botanico "unico tra tutti" una pianta dai fiori altrettanto singolari, Plukenetia (Euphorbiaceae).  Collezionista ed esperto di piante esotiche In Historical and Biographical Sketches of the Progress of Botany (1790) Richard Pulteney inizia il suo profilo di Leonard Plukenet (1642-1706) lamentando come gli sia toccato il destino comune a molti grandi uomini di cadere nell'oblio poco dopo la morte. Duecento anni dopo, la situazione non sembra cambiata di molto; al contrario degli amici-rivali Hans Sloane e James Petiver, la cui opera è ben nota e oggetto di ampi studi, Plukenet continua a ricevere un'attenzione marginale, né è disponibile uno studio complessivo del suo stesso capolavoro Phytographia. Eppure si tratta di un'opera notevolissima, tale da guadagnare al suo autore l'immensa stima di Linneo che lo definì "un botanico diverso da tutti gli altri". Poco conosciamo della sua vita fino ai quarant'anni. Nativo di Westminster, Plukenet dovette frequentare la Westminster School e poi forse l'università di Cambridge dove avrebbe stretto amicizia con William Courten e Robert Uvedale; la sua immatricolazione non risulta, così come non compare tra i laureati. Poiché esercitava la medicina e si firmava MD Medical Doctor, si suppone che si sia laureato all'estero. In ogni caso negli anni '80 viveva a Londra ed era di condizione agiata, anche se non sappiamo se cioè fosse dovuto al successo professionale o a qualche eredità. Il suo nome incomincia a emergere intorno alla metà di quel decennio; è citato in una lettera di John Ray a Hans Sloane (1684) e nel 1688, insieme a William Courten, Samuel Doody e James Petiver, è calorosamente ringraziato da Ray per l'assistenza prestata per il secondo volume di Historia Plantarum. Gli uomini citati sono alcuni degli animatori del Temple Coffee House Botanical Club, che a quanto pare cominciò a riunirsi nel 1689, sia in un caffè sia nella vicina casa di Courten a Middle Temple. Era un gruppo eterogeneo di appassionati e professionisti: Courten era un mercante che aveva ereditato dalla famiglia una intricata situazione patrimoniale e legami con le Barbados e altre colonie, che seppe sfruttare per creare un ammirato gabinetto di curiosità; Doody e Petiver erano membri della gilda dei farmacisti, botanici ben più che dilettanti e uno dopo l'altro curatori del Chelsea Physic Garden; Plukenet come sappiamo era medico. Tutti erano appassionati collezionisti. Anche se non conosciamo la cronologia e la stratificazione delle sue collezioni, all'epoca Plukenet doveva già essersi fatta una solida fama di esperto di piante esotiche, che si procurava attraverso una rete internazionale di corrispondenti, coltivava nel giardino di St Margaret’s Lane e pressava in un erbario sempre più voluminoso. Come si deduce dalla profonda conoscenza della letteratura botanica che emerge dalle sue opere, doveva anche possedere una fornita biblioteca. Furono certo queste due competenze, quella di botanico autodidatta ma di grande preparazione e quello di esperto di esotiche, a convincere William e Mary (ovvero Guglielmo III d'Orange e Maria II Stuart) a nominarlo sovrintendente dei giardini reali di Hampton Court. I due sposi, divenuti sovrani d'Inghilterra e Scozia in seguito alla Gloriosa Rivoluzione, condividevano la passione per i giardini e le piante esotiche (quelle stesse che attraverso le compagnie mercantili olandesi affluivano nei Paesi Bassi dall'Asia, dal Sudafrica, dai Caraibi e dal Suriname) e nei palazzi olandesi di Honselaarsdijk e Het Loo possedevano grandi limonaie e serre riscaldate dove d'inverno venivano ricoverate le loro grandi collezioni di agrumi e esotiche non rustiche. Poco dopo l'ascesa al trono, William incaricò Christopher Wren di ristrutturare palazzo e giardino di Hampton Court; per il godimento della Regina fu creato un giardino privato in stile barocco olandese con intricati parterre a ramages e sentieri in brecciolino colorato, una fontana e un pergolato; il vecchio stagno Tudor venne prosciugato per ospitare tre nuovi giardini murati: il quadrato dei fiori, quello delle Primula auricula (una delle piante preferite della sovrana) e quello degli agrumi (piante "dinastiche" degli Orange). In ciascuno di essi il carpentiere olandese Hendrick Floris costruì una serra riscaldata lunga circa 16 metri, tra le prime e le più perfette che si fossero viste in Inghilterra. D'inverno ospitavano la splendida collezione di esotiche, che invece nella bella stagione erano esposte all'aperto. Era la più ricca e raffinata del paese, con limoni, aranci e altri agrumi, cacti e succulente, palme, piante di caffè, dracene, agave, aloe, yucche, molte bulbose. Parecchie, soprattutto le sudafricane, erano delle novità assolute. A presiedere questa meraviglia furono chiamati come capo giardiniere George London (che abbiamo già incontrato alle dipendenze del vescovo Compton a Fulham) e come sovrintendente appunto Leonard Plukenet, nominato Queen's Botanist o anche Royal Professor of Botany (presumibilmente un titolo onorifico che non comportava insegnamento). I due, ovviamente, si conoscevano già, essendo entrambi assidui membri del Temple Coffee House Botanical Club, come lo stesso vescovo Compton. L'incarico permise sicuramente a Plukenet di incrementare le sue collezioni, accedendo alle piante coltivate sia a Hampton Court sia nei giardini di altri nobili e appassionati, come il braccio destro di Gugliemo III Hans William Bentnick, il primo conte di Portland, oppure la contessa di Beaufort. Gli diede anche il prestigio internazionale per corrispondere alla pari con colleghi di altri paesi, come Paul Hermann prefetto dell'orto di Leida (dove spedì London a fare incetta di piante) o Giovanni Macchion, giardiniere dell'orto di Padova. 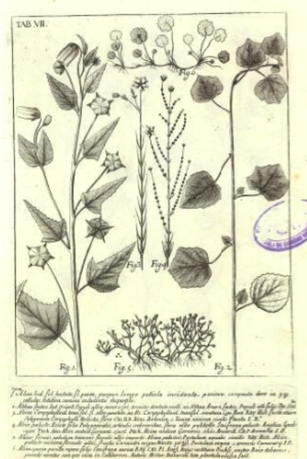 Un immenso corpus di immagini Certamente sulla base di un lavoro iniziato da tempo, già nel 1691 Plukenet fu in grado di dare alle stampe - a proprie spese - il primo volume di Phytographia, sive stirpium illustriorum et minus cognitorum icones, che, se non si presentava come un catalogo del giardino reale, ne condivideva lo spirito. Composto unicamente di figure (dette tavole fitografiche) e dedicato sia al "venerabile sommo mecenate di tutti i botanofili", ovvero il vescovo Compton, sia al re Guglielmo III, era essenzialmente una vetrina cartacea delle piante più nuove ed esotiche, anche se non mancava qualche specie locale. John Ray lo recensì con favore per le Philosophical Transactions della Royal Society, sottolineando che tra le centinaia di piante di cui "il colto e ingegnoso autore" dava la figura e la didascalia, moltissime in precedenza non erano state né descritte né raffigurate, altre descritte ma mai raffigurate o viceversa. Certo, il testo era limitato ai "titoli", ovvero ai nomi polinomiali, ma questi ultimi contenevano note caratteristiche sufficienti per distinguere una specie dall'altra. A soddisfare i desideri dei lettori, curiosità come l'Artemisia usata dai cinesi per la moxibustione, l'altrettanto celebre radice di Ginseng, o la miracolosa "erba dei serpenti" della Virginia (oggi Aristolochia virginiana), efficace antidoto contro il morso dei serpenti. Per comprendere il significato culturale e in un certo senso pedagogico di un'opera senza precedenti in Inghilterra, va sottolineato che non si trattava di un maestoso in folio pensato per fare bella figura nelle biblioteche dei ricchi, ma di un più maneggevole ed economico in quarto destinato allo studio e alla consultazione. Per ottimizzare lo spazio e abbattere i costi, ciascuna delle 72 tavole calcografiche non raffigura una singola pianta a piena pagina, ma da un minimo di tre a un massimo di sei piante, disegnate in modo essenziale ma ben riconoscibile; dato che spesso i disegni furono tratti non da piante vive ma da esemplari d'erbario, non sempre sono dotate di fiori e frutti. Dopo il primo volume, ne seguirono a ritmo serrato altri tre: la seconda parte nello stesso 1691 (tav. 73-120), la terza parte nel 1692 (tav, 121-250) e l'immensa quarta parte (tav. 122-328) nel 1696; insieme a quest'ultima uscì Almagestum botanicum, sive, Phytographiae Plukenetianae Onomasticon, Methodo Synthetico digestum, un volume di 400 pagine con le descrizioni, i nomi e i sinonimi di ben 6000 piante; per quelle raffigurate in Phytographia, Plukenet aggiunse anche le referenze bibliografiche e molte note critiche, che dimostrano una conoscenza approfondita della precedente letteratura botanica e un esame molto serio per giungere a identificazioni corrette. Impressionante per le dimensioni e l'erudizione, il lavoro di Plukenet si segnala anche per la notevole accuratezza delle descrizioni. Gli sono estranee invece preoccupazioni tassonomiche che vadano al di là di genere e specie: tanto nella Phytographia quanto nel Almagestum le specie, designate con un nome descrizione polinomio che ha come primo termine il nome generico, sono disposte infatti in ordine alfabetico. D'altra parte, le immagini di specie diverse dello stesso genere, pubblicate una di fianco all'altra nella medesima pagina, sono di per se stesse uno strumento di identificazione di straordinaria efficacia, che oggi ci è familiare, ma era all'epoca una novità assoluta. Nel 1700 seguì ancora un'appendice, Almagesti botanici mantissa, con ulteriori 25 tavole, altri sinonimi e note e gli indici completi delle due opere. Nel 1705, un anno prima della morte, Plukenet pubblicò infine Amaltheum botanicum (ovvero "Cornucopia botanica") con le tavole e le descrizioni di un centinaio di specie di origine per lo più cinese o indiana; per quest'ultimo volume, avendo evidentemente esaurito i fondi, si rassegnò ad indire una pubblica sottoscrizione. Tutti insieme, questi libri di Plukenet vanno a costituire un enorme corpus di 2740 figure, di fondamentale importanza per documentare la prima introduzione di nuove specie dalle Americhe, dal Sudafrica e dall'Asia orientale. Benché di piccole dimensioni e di qualità diseguale (furono affidate ad artisti diversi, tra cui spicca l'incisore fiammingo Michael Vandergucht), testi e illustrazioni divennero un riferimento imprescindibile per i botanici successivi. Morto nel 1706, Plukenet lasciò un immenso erbario di oltre 8000 esemplari che fu venduto dalla famiglia al vescovo di Norwich, uno dei sottoscrittori dell'Amaltheum. Qualche anno dopo, confluì anch'esso nell'erbario di Sloane, così come una collezione di circa 1500 insetti pressati e incollati su carta. Come altri collezionisti inglesi del suo tempo, Plukenet si servì di una vasta rete di corrispondenti e fornitori, che in parte coincide con quella di Petiver, di cui facevano parte botanici, giardinieri, collezionisti e appassionati, mercanti dediti al commercio internazionale, residenti nelle colonie nordamericane e un buon numero di medici e chirurghi al servizio della compagnia delle Indie. Tra i nomi più significativi, per le colonie americane spicca John Banister, di cui, con il permesso del vescovo Compton, Plukenet pubblicò diverse tavole, ma importanti invii si devono anche al medico tedesco David Krieg che visitò il Maryland; le numerose piante del Capo, punto di passaggio obbligato per le navi dirette nelle Indie orientali, si devono per lo più a chirurghi navali come Alexander Brown, che fece raccolte anche a Sant'Elena, o Patrick Adair che raccolse anche nelle Comore. Ci portano invece rispettivamente in India e in Cina le raccolte di Samuel Browne e James Cunnighame, soggetto principale di Amaltheum botanicum. Il primo, chirurgo del Fort St George (oggi Madras), raccolse nel Malabar e corrispose con Petiver e Ray, che mise in contatto con Kamel; il secondo, medico al servizio della Compagnia delle Indie nella factory di Chusan, fu il primo europeo a fare significative raccolte in Cina.  Un botanico e una pianta senza uguali Prima di concludere, vale la pena di approfondire le relazioni con Petiver, Sloane e Ray che forse spiegano perché, nonostante l'enorme influenza sui botanici successivi, il nome di Plukenet abbia finito per essere dimenticato. I quattro facevano parte degli stessi ambienti, erano assidui del Temple Coffee House Botanical Club, si scambiavano fornitori ed esemplari. All'inizio erano indubbiamente amici. In Almagestum botanicum, Plukenet ringrazia ripetutamente Petiver e Sloane per avergli procurato esemplari rari; come abbiamo visto, la recensione di Ray alla prima parte di Phytographia è elogiativa. Eppure, qualcosa si guastò. Come collezionisti, Plukenet, Petiver e Sloane era naturalmente rivali, dal momento che ciascuno avrebbe voluto gloriarsi della collezione più vasta e ricca di rarità. In questa specie di gara, facendo capo alla medesima rete di raccoglitori, non devono essere mancati gli sgarbi. Per Petiver lo fu senza dubbio la pubblicazione stessa delle piante dei suoi corrispondenti Browne e Cunningham in Amaltheum botanicum, che privò della primogenitura i suoi articoli per la Royal Society. Ad aprire le ostilità fu per altro Plukenet, che nella Mantissa non risparmiò le critiche né a Petiver né alla Storia naturale della Giamaica di Sloane, definita "un caos". Ray, che all'epoca si proclamava ancora amico di Plukenet, cercò di fare da paciere, ma dovette arrendersi di fronte al suo pessimo carattere che così definisce in una lettera a Sloane: "E' un uomo pieno di puntiglio, piuttosto presuntuoso e supponente, incapace di accettare consigli". Se Ray e Sloane, signorilmente, si limitarono ad esprimere le loro riserve anche scientifiche nella corrispondenza privata, Petiver lo fece in pubblico. Nel suo articolo sulle piante indiane di Browne, pubblicato sulle Philosophical Transactions, lo colpisce nell'orgoglio: "Quel celebratissimo botanico, il dr. Plukenet, può ben vantarsi delle sue innumerevoli specie di piante, visto che le moltiplica, come ha fatto con questa, rendendola tre erbe diverse". Ora ci è chiaro perché il "Botanico della Regina" non abbia mai fatto parte della Royal Society e perché la sua opera sia stata apprezzata più nel continente che in patria. Tra i suoi più fervidi ammiratori vi fu certamente Linneo, che fece larghissimo uso del corpus di Plukenet (che egli conosceva in un'edizione complessiva, pubblicata nel 1720) citandolo in quasi pagina di Species plantarum. In Critica botanica, dedicandogli il genere Plukenetia, ne tesse un vero encomio: "La Plukenetia ha una struttura dei fiori unica tra le piante, come lo è Plukenet tra i botanici. Egli preferì le piante a ogni ricchezza; non risparmiò nulla per illustrare quelle rare per le quali ardeva più di ogni altro". Plukenetia L. (famiglia Euphorbiaceae) comprende una ventina di specie di liane e rampicanti volubili diffuse nelle aree tropicali di tutto il mondo. I fiori che avevano stupito Linneo sono curiosi sia per la struttura (privi di petali hanno un calice globoso che si apre in quattro lobi valvati), sia per la disposizione, con uno o due fiori femminili alla base e molti fiori maschili disposti lungo l'asse del racemo. Curiosi anche i frutti, con quattro lobi angolati o alati, che si aprono in quattro cocci bivalvi che contengono un seme. Sono proprio i semi a costituire il maggiore punto di interesse di diverse specie, compresa la più nota, P. volubilis, conosciuta come sacha ichi o arachide degli Inca. Originaria del Sud America tropicale, ma coltivata anche altrove, è una liana con foglie cuoriformi e piccoli fiori raccolti in cime seguiti da curiosi frutti verdi, capsule con 4-7 punte che a maturazione si aprono mostrando una polpa biancastra che avvolge grandi semi. Non commestibili da crudi, lo diventano previa tostatura. Ricchissimi di proteine e di oli, se ne ricava un olio considerato salutare per l'alta presenza di acidi grassi polinsaturi. Qualche approfondimento nella scheda. Linneo soprannominò eristici, ovvero seguaci di Eris, la dea della discordia, i botanici delle generazioni immediatamente precedenti, impegnati in polemiche tanto feroci quanto sterili a difesa dei rispettivi sistemi di classificazione delle piante. Il più litigioso era indubbiamente lo scozzese Robert Morison, che non si peritava ad attaccare a testa bassa i botanici del passato e del presente, definendo i loro errori "allucinazioni". Da loro pretendeva di non aver appreso nulla e di aver tratto il suo nuovo metodo dalla natura stessa; molto probabilmente a ispirarglielo era stato invece Cesalpino, che però non cita mai. Pagò cara questa arroganza: i botanici successivi lo ripagarono della stessa moneta, attingendo alla sua opera pionieristica sotto traccia e censurando con altrettanta asprezza le sue pretese. Tra i critici più recisi lo stesso Linneo, che tuttavia gli dedicò il genere Morisonia (Capparaceae), che, manco a farlo apposta, suscita polemiche altrettanto roventi. 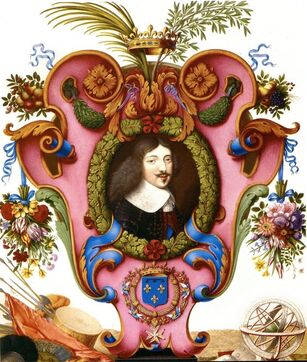 Formazione: Francia, Parigi e Blois Nel 1637, contro la pretesa del re d'Inghilterra Carlo I di imporre vescovi di propria scelta e un nuovo libro di preghiere sul modello anglicano, i presbiteriani scozzesi, con un patto giurato (Covenant) proclamarono che avrebbero difeso la loro fede fino alla morte. Ben presto si arrivò alla guerra aperta (prima e seconda guerra dei vescovi, 1639-1640), preludio alla rivoluzione inglese che avrebbe portato alla decapitazione del re e all'instaurazione del Commonwealth. Il solo fatto militare di una certa importanza della Prima guerra dei vescovi fu la battaglia del Bridge of Dee (18-19 giugno 1639) con la quale i Covenanter riuscirono a strappare alle truppe fedeli al re il controllo del ponte che dava accesso alla città di Aberdeen; tra coloro che militavano nell'esercito realista c'era anche il diciannovenne Robert Morison (1620-1683) che rimase gravemente ferito alla testa. Dopo la guarigione, come altri oppositori dei Covenanter che ormai controllavano la Scozia, decise di lasciare il paese e di rifugiarsi in Francia. Ci sarebbe rimasto vent'anni, cambiando del tutto il proprio destino. Anziché uomo di Chiesa, come avrebbe voluto la famiglia, divenne medico, naturalista e botanico. A Parigi, il suo primo rifugio, oltre a mantenersi come precettore del figlio di un certo consigliere Bizet, poté seguire lezioni di anatomia, zoologia, mineralogia, chimica e botanica, presumibilmente nel neonato Jardin des Plantes, dove fu allievo di Vespasien Robin. Nel 1648 si laureò in medicina a Angers, quindi nel 1649 o 1650, su raccomandazione di Robin, entrò al servizio dello zio del re, il principe Gastone d'Orlèans. Vale la pena di dedicare qualche riga a questo personaggio, che Morison proclamerà "patrono di tutti i botanici e mecenate veramente regale, versatissimo nell'arte botanica", tanto più che gli sono stati dedicati ben due generi di piante (entrambi oggi ridotti a sinonimi): Borbonia da parte di Plumier e Gastonia da parte di Commerson. Come politico, il duca d'Orlèans gode pessima stampa: intrigante e inconcludente, coinvolto in mille congiure tutte finite male, pronto a salvare la pelle abbandonando i suoi seguaci; brilla invece come mecenate delle arti e delle scienze, creatore della più vasta collezione di medaglie e antichità d'Europa, di una prestigiosa biblioteca, di un gabinetto scientifico e di collezioni d'arte. Della botanica era cultore più che dilettante grazie agli insegnamenti del medico che lo seguiva fin dalla nascita, il protestante Abel Brunier (o Brunyer, 1572-1665). Testimonianze del tempo riferiscono che conoscesse a memoria il nome di "tutte le erbe" (i comodi nomi binomiali di Linneo erano al di là da venire: siamo ancora all'epoca dei nomi-descrizione) e che amasse erborizzare, tanto che scoprì una nuova specie di trifoglio. A partire dal 1635, quando si stabilì a Blois al ritorno di un periodo di esilio, egli affidò a Brunyer, assistito dal secondo medico Jean Laugier e dal farmacista Nicolas Marchand (o Marchant), la creazione di un orto botanico, per il quale non lesinò attenzioni e spese. Dal 1644, ne fece anche immortalare le rarità su pergamena dall'abilissimo pittore Nicolas Robert: è l'inizio della spettacolare collezione nota come "Vélins du Roi". Tuttavia, dopo la morte di Richelieu nel 1642, egli si gettò nuovamente nell'agone politico e tornò a vivere a corte, portando con sé Brunyer, che per altro era ormai sulla settantina. Affidato ad altre mani, il giardino fu forzatamente trascurato. Dunque l'ingaggio di Morison, come terzo medico e botanico, era più che opportuno. E tanto più lo diverrà nel 1652, quando Mazzarino confinò il duca a Blois. Collezioni e piante divenivano ora la sola ragione di vita del principe sconfitto. Mentre l'anziano Brunyer rimaneva al suo fianco e allestiva il catalogo del giardino (Hortus Regius Blesensis, 1° ed. 1653, 2° ed. 1655), Laugier, Marchand e Morison venivano sguinzagliati per tutta la Francia alla ricerca di piante rare: come riferisce egli stesso, lo scozzese fu in Borgogna, Poitou, Bretagna (di cui esplorò le coste e le isole), Linguadoca e Provenza. Nel 1657, insieme a Laugier, esplorò l'area di La Rochelle, dove recensì 84 specie. Nel febbraio 1660 Gastone morì all'improvviso, lasciando erede delle sue collezioni il nipote Luigi XIV. Il giardino venne smantellato e Marchand, nominato direttore della coltivazione delle piante del Jardin du roi, fu incaricato di trasferire le piante nell'orto botanico parigino; anche Robert passò al servizio del re Sole, come "pittore ordinario del re per la miniatura". Una sistemazione fu offerta anche a Morison, ma eli preferì seguire in Inghilterra Carlo II, che proprio quell'anno aveva recuperato il trono. Il botanico lo aveva conosciuto proprio a Blois, durante una delle visite del re in esilio allo zio Gastone (Carlo II era figlio di Carlo I e di sua moglie Enrichetta, sorella di Luigi XIII e del duca d'Orlèans). Questa frequentazione altolocata non era l'unico lascito del decennale soggiorno a Blois. Fu quell'ambiente aperto e stimolante a fare nascere l'interesse di Morison per la classificazione delle piante. Tanto Brunyer quanto Laugier erano uomini di Montpellier: il secondo fu il maestro di Magnol, il primo sembra fosse alla ricerca di un metodo di classificazione razionale (non se ne trova però traccia nelle due edizioni del suo catalogo, semplici elenchi alfabetici). Nella fornitissima biblioteca del suo patrono, Morison poté leggere le principali opere dei botanici precedenti: De plantis di Cesalpino, l'Ekphrasis di Colonna, le opere dei fratelli Bauhin; sicuramente gli era nota anche l'opera di Boccone, che poi avrebbe contribuito a far conoscere in Inghilterra. Possiamo ipotizzare che il suo metodo sia nato dalla congiunzione tra queste letture, la ricerca sul campo e il confronto con il suo secondo maestro Abel Brunyer. Più tardi, egli lo negherà recisamente, proclamandolo un "nuovo metodo dato dalla natura, solo da me (senza arroganza) osservata, trovato da nessuno se non da me stesso". 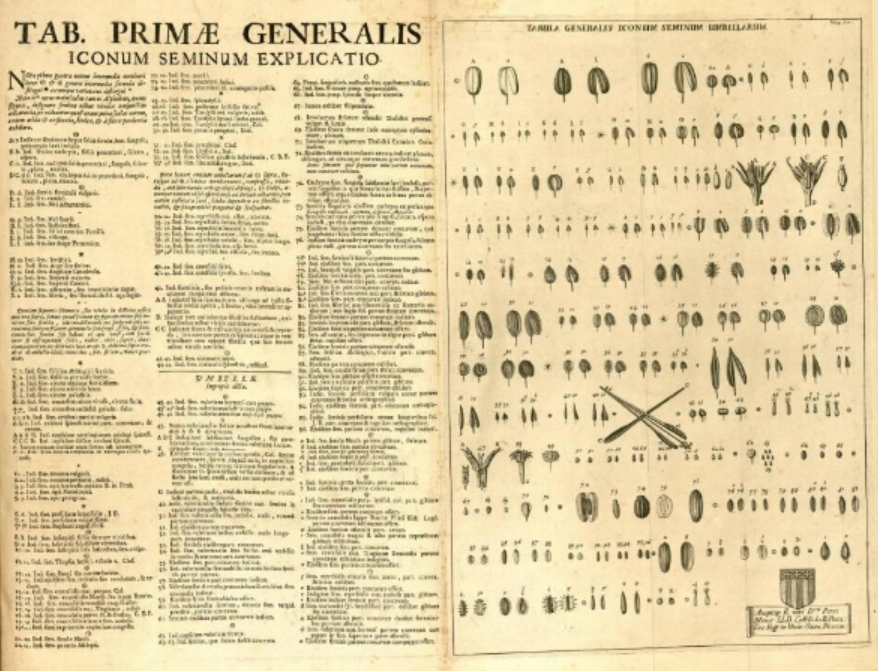 Maturità: Inghilterra, Londra e Oxford Carlo II, che a sua volta era vissuto in esilio quasi dieci anni, non di rado trattato alla stregua di un parente povero, provava ammirazione e riconoscenza per il botanico scozzese che aveva subito un lungo esilio per la causa della sua famiglia; lo nominò proprio medico personale e responsabile dei giardini reali, assegnandogli una casa a Londra e uno stipendio di 200 sterline. All'inizio del 1669, Morison pubblicò la sua prima opera, Praeludia botanica, un volume miscellaneo che riunisce tre lavori probabilmente scritti in momenti diversi. Di un certo interesse la dedica a Carlo II, in cui egli riferisce che, quando era al servizio del duca di Orlèans, aveva delineato un nuovo sistema di classificazione delle piante e che il duca gli aveva promesso di finanziare la pubblicazione di un libro per illustrarlo; ma la morte improvvisa del suo protettore aveva infranto le sue speranze. Ora si rivolgeva al re d'Inghilterra, degno nipote di tanto zio, per realizzare quel progetto che avrebbe d'un colpo reso la botanica inglese più illustre di quella italiana, francese o tedesca. La prima parte (e più cospicua del volume) è la terza edizione del catalogo dell'orto botanico di Blois, un elenco di circa 2600 piante, 260 delle quale sono indicate come nuove e sono descritte dettagliatamente in appendice. La seconda parte, Hallucinationes Caspari Bauhini in Pinace, item Animadversiones in tres Tomos Universalis Historiae Johannis Bauhini, è un feroce attacco contro gli errori di nomenclatura e classificazione dei fratelli Bauhin, puntigliosamente (e spesso non a torto) corretti e qualificati di "allucinazioni". La terza parte, Dialogus inter Socium Collegii Regii Gresham dicti et Botanographum Regium, è un dialogo sulla classificazione della piante tra se stesso e un membro della Royal Society. Morison magnifica la superiorità del proprio metodo, ma non lo descrive, limitandosi ad asserire, sulla scorta di Boccone, che la "nota generica" non deve essere tratta né dalle proprietà medicinali né dalla forma delle foglie, ma dalla fruttificazione, cioè dai fiori e dai frutti; non manca poi di stigmatizzare come "caos e confusione", pur senza citare in modo esplicito né l'opera né l'autore, il sistema elaborato da John Ray per le Tavole botaniche incluse nel saggio del vescovo Wilkin An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (1668). E' l'inizio di una frattura insanabile tra i due padri fondatori della sistematica britannica. Poco dopo l'uscita del libro, l'Università di Oxford gli offrì la cattedra di botanica: voluta da lord Danby all'atto di fondazione dell'Orto botanico di Oxford nel 1621, diventava effettiva solo ora, dopo un'attesa di quasi mezzo secolo. Era la prima in tutto il territorio britannico. Morison accettò e prese il nuovo incarico molto seriamente. I corsi si svolgevano nell'orto botanico per cinque settimane, nella bella stagione; una testimonianza del tempo ricorda che tre volte alla settimana il professore prendeva posto dietro un tavolo, posto al centro del guardino e colmo di piante, e le illustrava a studenti e uditori, che riusciva ad affascinare nonostante il duro accento scozzese. Per il resto dell'anno, tutto il suo impegno andava alla stesura dell'opera sognata per tutta la vita: se erano mancati i finanziamenti di due patroni regali, Gastone e Carlo II, ora Morison aveva trovato nell'Università di Oxford un sponsor disposto a pubblicare la sua opera, grazie soprattutto al sostegno dei fondatori dell'Oxford University Press John Fell del Christ Church e Obadiah Walker dell'University College. La grande opera, intitolata significativamente Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis seu Herbarum distributio Nova per Tabulas Cognationis & Affinitatis ex Libro Naturae Observatae & Detectae, sarebbe stata il fiore all'occhiello della nova casa editrice e sarebbe stata riccamente illustrata. Morison ne diede un primo saggio in Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova, pubblicato dalla casa editrice universitaria nel 1672. E' un fascicolo pilota il cui scopo fondamentare è sollecitare sottoscrizioni e donazioni per Historia universalis, di cui le Umbelliferae costituiranno la sezione IX; ecco perché nella Prefazione vengono finalmente presentati i principi del "nuovo metodo": "Il metodo è l'anima di ogni conoscenza: dunque in questa trattazione delle umbellifere, come pure in quella universale di tutte le piante, che promettiamo, mostreremo le note generiche ed essenziali tratte dai semi e dalla loro somiglianza, disponendo le specie in tavole sulla base di parentele e affinità. Aggiungeremo differenze specifiche tratte dalle parti meno nobili, ovvero radice, foglie, fusti, odore, sapore, colore, raccogliendo le singole specie sotto i singoli generi: in tal modo, specie riconoscibili per il diverso aspetto si schiereranno sotto generi intermedi, generi intermedi sotto generi supremi [ovvero tribù o famiglie], ciascuno distinto dalle proprietà essenziali e sempre nello stesso modo. Questo è l'ordine che la natura stessa ha dato alle piante, da me osservato per primo". Segue la trattazione delle piante con infiorescenza ad umbella, classificate sulla base delle caratteristiche dei semi, integrate con quelle di altri organi come le foglie. Morison distingue le Umbelliferae vere e proprie dalle Umbellae improprie dicto, dove troviamo generi come Valeriana, Filipendula e Thalictrum, e determina con chiarezza generi e gruppi di generi, le cui parentele e affinità sono illustrare da otto diagrammi (tabulas cognationis & affinatatis). La prima delle venti tavole calcografiche (le altre sono dedicate a specie nuove o meno note) raffigura le principali categorie di semi, sintetizzate nelle didascalie esplicative della pagina a fronte. Fin qui, la pars contruens; per non smentirsi, c'è anche la pars destruens, ovvero una quindicina di pagine dedicate alle Hallucinationes Caspari Bauhini, aliorum auctorum. La monografia, la prima dedicata a una famiglia e illustrata da tavole calcografiche, è una brillante riuscita. Del resto, il soggetto del fascicolo di lancio non è stato scelto a caso: da una parte, questa famiglia è stata una delle prime ad essere identificata (da Dodoens nel 1583); dall'altra, anche oggi pnel suo ambito i frutti e i semi sono determinanti per una corretta identificazione. Applicare il metodo all'universo modo delle piante è un'altra faccenda. Più difficile ancora trovare i soldi per continuare l'opera, costosissima proprio per il ruolo essenziale delle immagini. Il progetto prevede tre libri, il primo dedicato agli alberi e agli arbusti, gli altri due alle piante erbacee. Conscio della difficoltà dell'impresa, Morison parte da queste ultime, le più numerose e difficili da classificare, e nel 1680 esce finalmente la Pars secunda dell'Historia universalis, che contiene cinque delle quindici sezioni previste per le erbacee (De bacciferis, De leguminis, De siliquosis tetrapetalis bivalvis, De hexapetalis tricapsularis, De tricapsularis lactescentibus). Il risultato è inferiore alle attese: Morison per primo non si attiene al proprio metodo e le incongruenze abbondano. Non parliamo poi dell'aspetto finanziario: nonostante le sottoscrizioni di alcuni membri della Royal Society e del Collegio reale dei medici, egli è costretto a indebitarsi pesantemente con l'University Press. Comunque continua a lavorare alacremente al terzo volume; ma nel 1683, muore in seguito a un incidente stradale in cui incorre attraversando Charing Cross.  Morisonia: le allucinazioni dei botanici continuano? Come abbiamo visto in questo post, sarà il diligente Jacob Bobart il Giovane a portare a termine il secondo volume. Il primo invece non uscirà mai. La casa editrice universitaria sarà per anni schiacciata dal debito di questa opera innovativa e audace, che non mancherà di influenzare i botanici successivi, mentre l'Università di Oxford si troverà per anni impelagata in una causa legale con la vedova per la proprietà dell'erbario. Il metodo di Morison fa scuola soprattutto in Germania: i suoi seguaci più entusiasti sono i fruttisti (secondo la terminologia di Linneo) Paul Amman, Christoph Knaut e Paul Hermann. In patria, gli nuocciono il carattere terribile e le offese a Ray, il cui metodo ben presto surclasserà il suo. A Morison è invece riservata una vera e propria damnatio memoriae. Più sotterraneo, ma determinante, l'influsso su Joseph Pitton de Tournefort, che dal botanico scozzese trarrà senza dubbio insegnamento per la precisa determinazione dei generi e la distinzione tra genere e specie. Ma la sua arroganza gli spiacerà sommamente, e non gli perdonerà di aver saccheggiato i botanici precedenti senza neppure citarli. Così si esprime in Elemens de botanique: "E' impossibile lodare a sufficienza questo autore. Ma mi sembra che si lodi già troppo da sé; perché invece di accontentarsi della gloria di aver partecipato al più bel progetto che si sia mai fatto in botanica, osa paragonare le proprie scoperte a quelle di Cristoforo Colombo, e senza parlare di Gessner, Cesalpino e Colonna, in molti luoghi delle sue opere afferma di non avere appreso nulla se non dalla natura. Gli si sarebbe potuto credere sulla parola, se non si fosse preso la pena di trascrivere pagine di questi due ultimi autori; dal che si vede che gli erano molto familiari. Il sig. Ray senza fare tanto chiasso è riuscito molto più di lui". I sospetti di Tournefort erano più che fondati; gli studiosi successivi hanno rilevato interi passi presi di peso da Cesalpino, che Morison conosceva benissimo ma non nomina mai: nella biblioteca di Oxford si trova una copia di De plantis fittamente annotata di sua mano. Quanto a Linneo (che guardava con un po' di sufficienza a questi predecessori in eterna lite tra di loro, tanto che li soprannominò Eristici, seguaci di Eris, la dea della discordia), in una lettera a Albrecht von Haller ne riconosce i meriti, ma conclude con una condanna senza appello: "Morison era vanitoso, ma gli va dato il merito di aver rinnovato un sistema mezzo morto. Se si osservano i generi di Tournefort, si deve ammettere quanto debba a Morison, tanto quanto questi doveva a Cesalpino, sebbene Tournefort stesso sia un ricercatore coscienzioso. Tutto ciò che c'è di buono in Morison è preso da Cesalpino, senza la cui guida egli si perde alla ricerca più di affinità naturali che di caratteristiche distintive". In ogni caso, riprendendo un suggerimento di Plumier, riserverà anche a lui la gloria di un genere botanico, Morisonia L., famiglia Capparaceae. E qui finiamo in una polemica non indegna dell'astioso dedicatario. La delimitazione in generi di questa famiglia nelle Americhe ha dato più di un grattacapo ai tassonomisti; tradizionalmente, la maggior parte delle specie erano assegnate a Capparis, affiancato da una serie di generi minori, tra cui appunto Morisonia, con circa otto specie. Questo amplissimo Capparis risultava però artificiale (polifiletico) e da qualche anno la linea prevalente è limitarlo alle specie del Vecchio Mondo. Quanto a quelle americane, alcuni ricercatori hanno iniziato a staccarne una serie di piccoli generi, finché nel 2018 nel quarto volume di The Global Flora è comparsa una nuova trattazione che ha incluso in Morisonia gran parte delle Capparaceae in precedenza assegnate a Capparis, allargandone i confini a oltre ottanta specie. La risposta di Xavier Cornejo (specialista di Capparaceae e principale fautore della divisione di Capparis in molti piccoli generi) non si è fatta attendere: in un articolo comparso lo stesso anno ha criticato aspramente questa soluzione, rilevando che, così inteso, Morisonia presenta una tale varietà di forme e comportamenti da diventare "un genere innaturale e difficile da comprendere". Dopo una pagina di critiche serrate, egli conclude che "la nomenclatura proposta [...] non ha supporto né morfologico né molecolare. Dunque nessuna di queste combinazioni ha valore nomenclatorio e va ridotta a sinonimi". Allucinazioni, avrebbe detto Morison. Ma noi viviamo in un'epoca più cortese (o forse più ipocrita). In attesa di futuri sviluppi che certo non mancheranno, conviene attenersi alle poche certezze: comunque venga inteso (con le ottanta e più specie di Morisonia sensu lato o le otto di Morisonia sensu stricto), si tratta di arbusti o alberelli del sottobosco delle boscaglie e delle foreste stagionalmente aride di Messico, Antille, Centro e Sud America. Sicuramente continuerà a farne parte la specie tipo di Linneo, M. americana; chiamata in inglese Ratapple, "mela dei ratti", nei paesi latino americani è conosciuta con tanti nomi che variano da un luogo all'altro: chocolatillo, zapote blanco, arbol del Diablo. E' un piccolo arbusto del sottobosco delle foreste aride caducifoglie, distribuito dal Messico all'Argentina settentrionale, attraverso le Antille; la caratteristica più notevole sono i piccoli frutti sferici con spessa corteccia marroncina e polpa biancastra edule usata come emolliente, con proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie. Qualche approfondimento nella scheda. Nella primavera del 1679 arriva in Virginia come pastore il reverendo John Banister; formatosi a Oxford, dove ha seguito i corsi di Robert Morison, è il primo naturalista con una formazione scientifica universitaria a stabilirsi nelle colonie inglesi del Nord America; all'impegno pastorale affianca infatti l'esplorazione della flora (e della fauna), incoraggiato da committenti inglesi, tra cui il suo diretto superiore, il vescovo Compton, cui invia molte primizie americane per il giardino di Fulham. Progetta di scrivere una storia naturale della Virginia, ma perde la vita in un incidente assurdo. A ricordarlo il genere Banisteriopsis (famiglia Malpighiaceae). 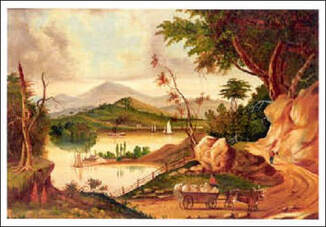 Un pastore naturalista A fine Seicento, la Virginia, la prima delle tredici colonie del Nord America, incominciava ad assestarsi dopo un avvio tutt'altro che facile. I coloni, che l'avevano fondata nel 1609, avevano dovuto affrontare la fame, ripetute guerre contro le popolazioni native, due massacri (nel 1622 e nel 1644). Durante la guerra civile erano rimasti sostanzialmente fedeli alla monarchia (tanto che Carlo II, recuperando il trono, la soprannominò The Old Dominion, l'antica colonia). Malattie, uragani, alluvioni, l'ostilità dei nativi, le tensioni con il governo centrale non mancavano, ma la Virginia aveva ormai trovato la risorsa che ne avrebbe fatto la più ricca delle colonie: la coltivazione del tabacco. Non era però una situazione né tranquilla né pacificata. Nel 1676 il piantatore Nathaniel Bacon guidò una rivolta armata (la prima nelle tredici colonie) contro il governatore William Berkeley, biasimato da una parte per i suoi metodi autocratici, dall'altro per la sua politica di pacificazione con i nativi, che impediva ai coloni poveri di installarsi oltre i confini della colonia. Alla ribellione, che assunse carattere molto violento, con il genocidio degli indiani Susquehanock e l'incendio della capitale Jamestown, aderirono i medi e piccoli proprietari e molti degli immigrati più poveri arrivati in Virginia come "servi a contratto", mentre i grandi proprietari rimanevano fedeli al governatore. Repressa con ferocia da Berkeley, la ribellione si esaurì con la morte di Bacon, ma lasciò un'eredità pesante: da quel momento, a lavorare nelle piantagioni furono sempre meno europei semi-liberi e sempre più schiavi neri. La Virginia si avviava a trasformarsi in una società razzista, basata sul sistema di piantagione e lo schiavismo. Il protagonista della nostra storia vi arrivò a ridosso di questi eventi. John Banister (1650-1692), nato in una famiglia modesta, a diciassette anni fu ammesso come corista al Madgdalen College di Oxford; benché destinato al sacerdozio, incominciò a frequentare l'Orto botanico, facendo amicizia con Jacob Bobart il Giovane e seguendo le lezioni di Robert Morison, a quel tempo impegnato nella mastodontica Plantarum historia universalis oxoniensis. Allestì un erbario e un catalogo di piante; ad affascinarlo erano soprattutto quelle americane. A sua volta Morison fu colpito dal suo talento e lo segnalò al vescovo di Londra Henry Compton, che stava cercando missionari interessati alle scienze naturali da inviare nelle colonie. Fu così che Banister, dopo essersi laureato nel 1674 e aver servito per un biennio come cappellano, nel 1678 si imbarcò alla volta dell'America, ufficialmente come ministro anglicano, ufficiosamente come naturalista e cacciatore di piante per i suoi patroni Morison e Compton. Dopo due scali alle Barbados e a Grenada, raggiunse la Virginia nella primavera del 1679. Il 7 aprile 1679 (data della prima lettera a Morison a noi pervenuta) era ospite del piantatore e commerciante William Byrd I. Di poco più vecchio di lui, Byrd era emigrato in Virginia per prendere possesso di una proprietà di alcuni acri lasciatagli da uno zio e aveva cominciato ad arricchirsi trafficando con gli indiani rum, fucili, ferramenta e lana in cambio di pellicce; era stato uno dei primi seguaci di Bacon, prendendo anche parte ad alcune azioni armate, ma poi era passato dalla parte del governatore. Col tempo sarebbe diventato un ricchissimo piantatore, proprietario della Westover Plantation che si estendeva per 1200 acri (equivalenti a quasi 5 km quadrati). Byrd era interessato alle piante da un punto di vista pratico: fece venire semi di nuove varietà di tabacco e importò piante orticole e agricole dall'Inghilterra. Incoraggiò Banister nelle sue ricerche, coinvolgendolo nelle sue spedizioni lungo la frontiera, e più tardi mantenne per lui i rapporti con l'Inghilterra, curando i suoi invii di piante, semi e animali e procurandogli materiali da disegno, carta e libri. Nella lettera a Morison, dopo aver descritto in termini coloriti i conflitti con gli indiani "nemici barbari", Banister descrive la Virginia come una terra fertile e ricca di acque che può offrire ogni bene necessario per la vita e per il piacere. Riferisce con meraviglia della grande ricchezza di alberi, che potrebbero ripopolare gli impoveriti boschi inglesi: ogni tipo di quercia, castagno, salice. Biasima la ristrettezza di vedute dei piantatori, unicamente interessati al tabacco e ai soldi che ne possono ricavare, mentre è affascinato dalla grande varietà di piante coltivate dai barbari indiani: mais con chicchi di tutti i colori, patate in innumerevoli varietà, fagioli, angurie e meloni. A lui il tabacco interessava soprattutto dal punto di vista scientifico e più tardi raccolse i semi delle diverse varietà coltivate dagli Indiani, creando una specie di banca del seme ante litteram. In una data ignota, Banister divenne ministro della Parrocchia di Bristol, la cui chiesa parrocchiale si trovava nei pressi dell'attuale città di Hopewell, lungo il fiume Appomattox. Cercava di conciliare i doveri pastorali con le ricerche naturalistiche, ma dovette constatare che era impossibile vivere con i magri proventi della parrocchia e dei pochi acri di terra che gli erano stati concessi, tanto più che nel 1687 mise su famiglia, sposando una giovane vedova. Qualche aiuto gli sarà venuto dai suoi amici londinesi, ma alla fine si rassegnò a trasformarsi anche lui in piantatore; nel 1689 acquistò 1735 acri nella Charles City County. A quel punto doveva ormai essere uno dei maggiorenti locali: l'anno successivo lo ritroviamo tra i membri del comitato fondatore del College of William and Mary che, tuttavia, a causa di difficoltà finanziarie, nascerà ufficialmente solo dopo la sua morte. Banister cominciò ad esplorare la natura della Virginia fin dal suo arrivo nella colonia. Dato che muoversi da solo in quel territorio ancora di frontiera era estremamente pericoloso, approfittava il più possibile delle spedizioni di Byrd, anche se difficilmente si sarà allontanato da casa più un centinaio di km. Le spedizioni, che comprendevano cacciatori, boscaioli per aprirsi la strada, guide e interpreti, si muovevano lungo le piste commerciali, per lo più ai piedi delle colline, e più raramente si spingevano sulle montagne (contro l'immagine eroica che Linneo darà delle esplorazioni di Banister). Il primo invio del missionario-naturalista raggiunge l'Inghilterra nel 1680: ci sono insetti, aracnidi e molluschi per il medico Martin Lister e circa 150 tra disegni, esemplari di piante e semi per Morison e il vescovo Compton. A destare la maggior sensazione è il disegno di una pianta "dalla forma così strana e mostruosa che ne provo paura": è Sarracenia purpurea. Il vescovo e i suoi amici del Temple Coffee House Club ne sono elettrizzati e chiedono a Banister (si spera in cambio di qualche sussidio economico) di inviare disegni di piante, esemplari di erbario, piante vive, semi, tutto quello che potrà raccogliere. L'invio del 1682 comprende una lista di piante per John Ray, una serie di disegni per Leonard Plukenet (che li pubblicherà nella sua Pytographia), altre piante per il giardino di Fulham: la più notevole è Magnolia virginiana, la prima magnolia a toccare il suolo europeo. Seguiranno Lindera benzoin, Liquidamber styraciflua, Cornus amomum, Gleditsia triacanthos, Chionanthus virginicus, Acer negundo, Rhus copallina, Aralia spinosa, Merispermum canadense, Quercus rubra, Ostrya virginiana, Abies balsamea, Nyssa aquatica. Tra tanti alberi e arbusti c'è anche qualche erbacea, come il Dracunculus Virginianus latifolius di cui il vecchio amico Bobart pubblica un'immagine nel 1699: è la prima riproduzione di Echinacea purpurea. Banister si interessa anche di altri campi della storia naturale. In una lettera al vescovo Compton del 1689, descrive e riconosce la funzione dei bilancieri delle mosche, che erano stati descritti qualche anno prima da Robert Hooke, senza però individuarne la funzione; in un contributo poi inviato alla Royal Society studia la conchiglia e i disegni dorsali e ventrali del curioso granchio Limulus polyphemus; è il primo a descrivere l'anatomia interna di una lumaca. La lettera in cui descrive Mutinus elegans è considerata il primo articolo dedicato a un fungo del Nord America. Rimane però principalmente un botanico e il suo sogno è scrivere una storia naturale della Virginia; a tale scopo, raccoglie esemplari d'erbario, redige liste, prende note. Ma a soli 42 anni la sua vita viene spezzata da un incidente assurdo e crudele. All'inizio di maggio 1692, ancora una volta accompagna Byrd e i suoi uomini in una spedizione che seguendo la pista commerciale nota come Occaneechee Trading Path si dirige verso il Roanoke River; forse proprio per cercare qualche pianta, si addentra nella boscaglia. Uno dei dipendenti di Byrd, Jacob Colson, lo scambia per un animale e gli spara. Almeno, questa è la versione ufficiale, registrata nel Henrico County Court order book in data 16 maggio 1692. L'incidente, avvenuto lontano da occhi indiscreti, resta avvolto dal mistero: la famiglia venne informata che il pastore era stato ucciso dalla caduta di un albero, mentre Ray credeva fosse morto cadendo da una roccia. Lasciava una vedova, un bimbo di due anni e un'opera mai scritta. Il suo nome è ricordato da Banisteria, la rivista della Virginia Natural History Society, dedicata alla storia naturale della Virginia, con articoli che coprono la botanica, la zoologia, l'ecologia e la geologia.  Botanici allucinati, piante allucinogene Dopo la sua morte, le collezioni di Banister furono riunite da Byrd e inviate a Londra insieme a una copia dei cataloghi. Le osservazioni sugli insetti della Virginia furono pubblicate nel 1701 nelle Transactions della Royal Society, mentre le raccolte botaniche, i disegni, le lettere e i cataloghi di piante influenzarono in vario modo la conoscenza della flora nordamericana e le opere di molti altri autori. In primo luogo, attraverso il giardino del vescovo Compton a Fulham, e in misura minore l'orto botanico di Oxford, furono dozzine le specie da lui introdotte in Inghilterra, in particolare quegli alberi e arbusti che sono alla base del passaggio dal giardino formale alla francese al giardino paesaggistico all'inglese. In secondo luogo, molti autori recuperarono le sue osservazioni sulla flora, la fauna e gli abitanti della Virginia, a volte senza citarlo. Così fece Robert Beverly, che in History and Present State of Virginia (1705) trascrisse verbatim intere pagine delle note di Banister. Molto ampia è la presenza delle sue raccolte nelle opere dei botanici britannici a cavallo tra Seicento e Settecento, a cominciare da John Ray che nel secondo volume di Historia Plantarum (1693) pubblicò un catalogo di piante americane, basato su una lista ricevuta nel 1682 da Banister, da lui salutato come "uomo eruditissimo e completissimo botanico". James Petiver in Museum Petiverianum cita 65 denominazioni di Banister per piante americane coltivate nel giardino di Fulham dal vescovo Compton e utilizza le sue note sui funghi nelle edizioni della sua Gazophylacii Naturae & Artis (1702–1709). Lister pubblica gli insetti, molluschi, aracnidi e animali primitivi da lui raccolti in Historia Sive Symposis Methodica Conchyliorum (1685–1692). Plukenet utilizza alcuni dei suoi disegni in Phytographia (1691–1705). Dillenius include i suoi muschi in Historia Muscorum (1741). Sono tutte opere ben note a Linneo, che durante la sua visita a Londra e a Oxford poté anche ammirare esemplari di erbario raccolti da Banister. E' dunque naturale che accogliesse la proposta di Houstoun di dedicargli un genere di piante. Houstoun aveva unito sotto il nome Banisteria un'intera famiglia di piante rampicanti tropicali, una delle quale era stata raccolta da Banister nelle Barbados. Forse attraverso racconti orali raccolti durante il soggiorno inglese, Linneo si era anche formata un'immagine romantica della figura di Banister, che ritroviamo nella dedica strappalacrime del genere Bannisteria (con due enne) in Hortus Cliffortuanus: "Houstoun ha destinato questa santa famiglia di piante alla memoria dell'inglese John Bannister [sic!] che prima di lui diede persino la carissima vita per le piante. Egli infatti penetrando i recessi della Virginia, scalando monti e rupi, affinché nulla rimanesse nascosto al suo zelo, per un caso sventurato inciampò, cade, si sfracellò e perì miseramente. Gli fu dunque dedicata una pianta americana rampicante con frutto spaccato color del sangue". Come si vede, egli segue la versione divulgata da Ray; la pianta in questione, qui Bannisteria foliis ovatis, ramis dichotomis [ecc.], ribattezzata in Species plantarum Banisteria (con una enne) fulgens, oggi si chiama Stigmaphyllon emarginatum. In effetti è un rampicante che ha per frutto uno schizocarpo che a maturità si divide in tre samare con ali rosso vivo. Linneo ufficializza il genere in Species Plantarum (1753), questa volta con la grafia corretta Banisteria. E' l'inizio di un nodo gordiano tassonomico. Egli distribuisce le specie che più tardi saranno assegnate alla famiglia Malpighiaceae in tre generi, distinti sulla base dei frutti: Malpighia, con frutto carnoso; Banisteria, con frutto che si divide in tre samare ciascuna con una grande ala dorsale trilobata; Thryallis con il frutto che si divide in tre cocci. Oggi, l'unico accettato rimane Malpighia. Il suo genere Banisteria, con il senno di poi, risulta un gruppo eterogeneo, che riunisce sette specie che oggi appartengono a quattro generi diversi (uno dei quali di un'altra famiglia). Dal resto, questo gruppo di Malpighiaceae è particolarmente difficile da classificare, e non possiamo prendercela con il vecchio Linneo, tanto più che i botanici che verranno dopo faranno di peggio. Nel corso dell'Ottocento, infatti, mentre cresceva il numero delle specie note e venivano creati nuovi generi, il nome linneano fu mantenuto e allargato a molte nuove specie. Particolarmente influente fu la trattazione di Banisteria di Adrien de Jussieu, seguita da molti autorevoli colleghi; ma il suo genere non aveva nulla a che fare con quello di Linneo, di cui non includeva neppure una specie. Infatti le specie linneane erano state tutte via via assegnate a nuovi generi; il gruppo più consistente era costituito da tre specie che ora facevano parte di Heteropterys, creato da Kunth nel 1821. Il primo ad accorgersi di questa incongruenza fu il botanico americano Charles Budd Robinson che nel 1910 propose di ripristinare il nome linneano per sostituire Heteropterys e ribattezzare Banisteriopsis "simile a Banisteria" il genere Banisteria nel senso di Jussieu. La proposta fu accettata solo in parte, generando ulteriore confusione; come capita in questi casi, a tagliare il nodo gordiano provò il Congresso Botanico Internazionale di Cambridge (1930) che decise di considerare legittimi Heteropterys e Banisteriopsis e di cassare Banisteria (nome reijcendum). La saga non finì lì, ci fu ancora qualche botanico che difese Banisteria, per non parlare di vivaisti e appassionati, finché negli anni '60 del Novecento il nome linneano fu definitivamente mandato in pensione e Banisteriopsis universalmente accettato. Banisteriopsis C.B.Rob. è un vasto genere della famiglia Malpighiaceae che riunisce una sessantina di specie di arbusti, piccoli alberi e liane rampicanti diffusi dal Messico al Sud America tropicale, con centro di diversità in Brasile, in due diversi ambienti: le savane tropicali, dove sono soprattutto arbusti, e la foresta pluviale, dove sono liane, a volte di dimensioni enormi. Dopo aver letto l'intricata storia della loro denominazione, forse non vi stupirete di scoprire che la specie più nota B. caapi è un potente allucinogeno. Tanto è vero che lo stato della Louisiana ha proibito la detenzione e la coltivazione di tutte le specie di questo genere, salvo per usi ornamentali. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
March 2024
Categorie
All
|





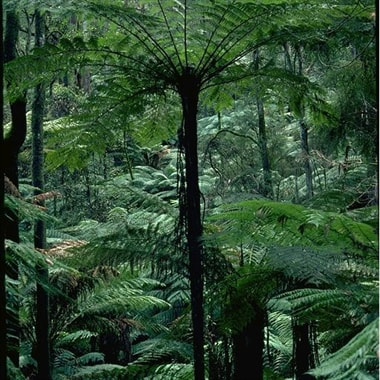



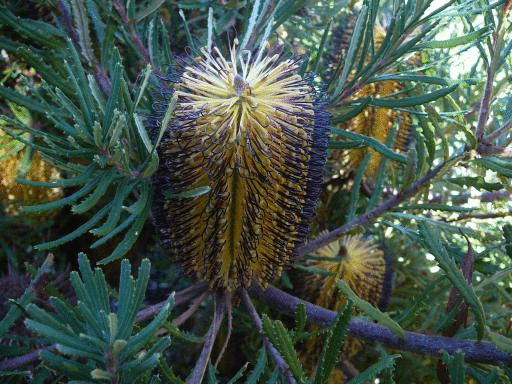



 RSS Feed
RSS Feed