|
Esponente di spicco della scienza, della teologia e della politica svedese e finlandese della prima metà del Settecento, Johannes Browallius è poco noto al di fuori della Svezia e della Finlandia, tranne forse per l'abile difesa del sistema linneano contro gli attacchi di Siegesbeck. Più che per i suoi contributi originali (che scopriamo tutt'altro che secondari) all'estero è soprattutto un amico di Linneo o, magari, un ex-amico. Se sia vero o falso, scopriamolo insieme, anche seguendo le vicende delle denominazioni linneane delle specie del genere Browallia (Solanaceae) che si vuole riflettano gli alti e bassi di quella amicizia.  Linneo innamorato Nel dicembre del 1733, Linneo (all'epoca ventiseienne) fu invitato da uno dei suoi allievi ed amici, Claes Sohlberg, a trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia, a Falun, in Dalarna, dove il padre era ispettore minerario. Era una buona occasione per visitare la miniera di rame, per approfondire gli studi di mineralogia cui si era già accostato durante il viaggio in Lapponia, e magari per fare qualche conoscenza utile alla sua carriera scientifica. Non si sbagliava: strinse amicizia con il giovane teologo Johannes Browallius (1707-1755) con il quale aveva molto in comune: erano coetanei, avevano studiato ad Uppsala e soprattutto erano entrambi assetati di conoscenza. Il nuovo amico lo introdusse presso il governatore del Dalarna Niels Reuterholm, per il quale lavorava come cappellano, informatore scientifico e precettore dei figli. Entusiasta del racconto del viaggio in Lapponia, il governatore commissionò a Linneo una spedizione analoga nella regione, che in effetti avrebbe avuto luogo nell'estate successiva (3 luglio-17 agosto 1734). Fu un’ancora di salvezza per Linneo, che nel frattempo era stato allontanato dall’università di Uppsala in seguito al brutto affare con Niels Rosén. Al rientro dal viaggio, al quale avevano partecipato tra l’altro Sohlberg e i due figli di Reuterholm, si stabilì a Falun, dove il governatore gli concesse di utilizzare il laboratorio della miniera e di aprire una piccola accademia privata, dove insegnava mineralogia; era una soluzione di ripiego e senza grandi prospettive. Secondo Browallius, la vera soluzione era un’altra: doveva andare all’estero, laurearsi in medicina (le università svedesi non erano abilitate a farlo) e, una volta laureato, tornare in Svezia ad esercitare la professione. Non aveva i soldi per il viaggio? Allora era il caso di trovare una fidanzata ricca. Sembra che gli abbia anche proposto vari partiti, ma senza successo. La freccia di Cupido, infatti, aveva già trafitto il cuore di Linneo. Tra coloro che seguivano le sue conferenze, che in quella piccola località di montagna di meno di 7000 abitanti destarono una certa sensazione, c’era anche il medico cittadino Johan Moraeus; Linneo cominciò a frequentarne la casa e si innamorò di una delle sue figlie, la diciassettenne Sara Elizabeth detta Sara Lisa. Squattrinato com’era, è strano che pensasse a sposarsi (anche se il dottor Moraeus era agiato, aveva sette figli, e Sara Lisa non era certo l’ereditiera favoleggiata da Browallius), ma sembra che a deciderlo a quel passo sia stata la morte della madre, deceduta ad appena 44 anni. In ogni caso, intraprese un serrato corteggiamento che conosciamo a grandi linee grazie al suo diario privato (laconico ma esplicito). Il giorno di Natale 1734 Linneo fu invitato a pranzo a casa Moreus. Il 2 gennaio 1735, per fare colpo, vi andò in visita vestito con il famoso costume lappone. Il giorno dopo, ripeté la visita approfittando dell'assenza dei genitori. Seguirono altre visite e incontri in casa di amici comuni, finché il 16 gennaio ("un giorno di immortale commemorazione", scrisse nel suo diario) Linneo fece la sua proposta a Sara Lisa e fu accettato. Il 20 gennaio chiese la mano al padre, che era molto perplesso: lui stesso medico, sperava per la figlia un matrimonio finanziariamente più promettente; ancora più contraria era la madre. Alla fine il dottore cedette, ma pose due condizioni: il matrimonio sarebbe avvenuto entro tre anni e nel frattempo Linneo doveva andare all'estero a laurearsi in medicina, in modo da poter mantenere la futura famiglia (i pareri di Perpetua… ovvero di Browallius). Il 22 gennaio i fidanzati si scambiarono gli anelli e i voti di fedeltà. Fu deciso che Linneo sarebbe andato a laurearsi a Hardwijk, la più economica delle università olandesi; insieme a lui sarebbe partito Claes Sohlberg, il cui padre avrebbe pagato il viaggio del figlio e di Linneo; Sara Lisa gli passò sotto banco i suoi risparmi, un centinaio di corone, e, dopo baci e abbracci il 20 febbraio il neofidanzato lasciò Falun per la Svezia meridionale dove avrebbe salutato la famiglia, per poi partire per l’Olanda.  Una leggenda botanica L'amicizia con Linneo fu determinante anche per Browallius, che da quel momento intensificò i suoi interessi scientifici. Ispirato dalla spedizione lappone dell'amico, nel 1735 e nel 1736 intraprese due viaggi scientifici che dalla Dalarna lo portarono in Norvegia. Si mantenne in corrispondenza con Linneo (che, ad esempio, informò anche lui che si sarebbe trattenuto in Olanda essendo stato assunto come medico personale e curatore del giardino di Clifford) e nel 1737 gli spedì uno suo testo in svedese sulla necessità di introdurre l'insegnamento scientifico nelle scuole superiori, che Linneo tradusse in latino e pubblicò in appendice a Critica botanica, l'opera in cui dettò le regole per la formulazione dei nomi delle piante. Ma a un certo punto, secondo la vulgata, sarebbe successo un fattaccio che avrebbe messo fine alla loro amicizia. La versione più nota è quella del Curtis's Botanical Magazine (1838) che riprende e amplia una notizia del Codex botanicus linnaeanus di Hermann Richter (1837). Ecco dunque i fatti: mentre si trovava all’estero, qualcuno informò Linneo che Browaliius aveva approfittato della sua assenza per corteggiare Sara Lisa ed era quasi riuscito a convincerla a lasciare il fidanzato che, a quando le diceva, non aveva alcuna intenzione di tornare in Svezia. Fu una delusione cocente per Linneo che troverebbe riflesso nelle denominazioni delle tre specie del genere Browallia che egli aveva incautamente dedicato all’ex-amico: B. elata ("alto, elevato, nobile") rappresenterebbe il momento più alto della loro amicizia; B. demissa ("basso, debole, pendente" ma in questo caso "scoraggiato") la rottura, mentre B. alienata, oltre all'incerta natura di questa specie, la successiva separazione tra i due. Un’altra versione meno popolare (la troviamo ad esempio nella Revue scientifique, 1865) sostiene che Linneo chiamò la prima specie di Browalllia a lui nota B. demissa; aveva bei fiori, ma il suo portamento ricadente ben rifletteva l’atteggiamento umile, dimesso, di Browallius nei suoi confronti; egli si mantenne umile e rispettoso anche quando divenne vescovo, così Linneo chiamò B. elata una seconda specie più alta; con il tempo, però, il vecchio amico insuperbì e incominciò a trattare Linneo in modo ingiusto; così, quando venne scoperta una terza specie piena di spine fu la volta di B. alienata, a suggellare la fine di un’amicizia. Quanto c’è di vero in queste storie? Nulla, secondo la biografia di Linneo di Theodor Magnus Fries e Banjamin Daydin Jackson, che ritengono che alla base di questa vera e propria leggenda metropolitana ci sia un equivoco. Effettivamente tra Browallius e Linneo ci fu se non uno scontro, una differenza di vedute, ma non riguardava la mano di Sara Lisa, bensì il livello del mare. In un importante articolo supplicato dall’Accademia svedese delle scienze nel 1743, l’amico di Linneo Anders Celsius (colui che inventò la scala centimetrica delle temperature) spiegò l'innalzamento delle terre emerse con la lenta diminuzione del volume delle acque oceaniche; Linneo appoggiò questa tesi; vi si opposero invece altri studiosi, tra cui appunto Browallius in saggio pubblicato postumo nel 1756 in cui vi contrappose una grande massa di misurazioni che dimostravano il contrario. Ma torniamo a Browallia e proviamo a verificare se il piccolo affaire de coeur regge alla prova dei fatti. Nel 1735 Philip Miller ricevette da Panama i semi di una pianta che coltivò a Chelsea e chiamò Dalea; presumibilmente in occasione del suo viaggio in Inghilterra dell’estate del 1736, ne fece parte a Linneo che decise di dedicare la pianta, appartenente a un nuovo genere, all’amico Browallius; il genere Browallia compare per la prima volta proprio in Critica botanica (maggio 1737) tra le denominazioni dedicate a “celebri botanici” senza altre indicazioni che “a Browallius svedese, 1737”; nessuna indicazione neppure nella prima edizione di Genera plantarum, uscita a Leida lo stesso anno. Contemporaneamente Linneo stava scrivendo Hortus cliffortianus (sul frontespizio compare la data di stampa 1737, ma in realtà uscì nel 1738) dove invece troviamo una lunga e sperticata dedica in cui il “chiarissimo teologo e maestro Johannes Browallius” viene dipinto come un erudito universale, versato in ogni ramo delle scienze naturali dalla litografia alla botanica alla zoologia. Al genere è attribuita una sola specie, di cui viene dato il nome descrizione; il binomiale compare per la prima volta quasi vent’anni dopo, nella prima edizione di Species plantarum (1753) e non è nessuno di quelli citati, ma banalmente Browallia americana. I famosi nomi Browallia demissa, B. elata, B. alienata compaiono in quest’ordine (dunque demissa precede elata) solo nella decima edizione di Systema naturae (1758-59); Linneo si è convinto che ci siano almeno due specie di Browallia, una che reca un solo fiore per peduncolo, che chiama B. demissa; un’altra con fiori riuniti in mazzi, che chiama B. elata; ce n’è poi una terza alquanto differente, B. alienata, che in precedenza aveva classificato come Ruellia paniculata. Non c’è bisogno di evocare né love story né la superbia di Browallius per spiegare questi nomi: B. americana (è tornata a chiamarsi così per la regola della priorità) è una specie molto variabile che può avere portamento ricadente (demissus) o eretto (elatus); quanto a B. alienata, aveva ragione il Linneo del 1753: il nome corretto è Ruellia paniculata (ed appartiene a tutt'altra famiglia). Aggiungiamo ancora un dato: il 12 febbraio 1737 Browallius sposò Elisabet Ehrenholm. Come abbiamo visto, dopo la partenza di Linneo, anche lui si mise in viaggio e ritornò a Falum solo nell'autunno o nella tarda estate del 1736. Quando sarebbe avvento il fattaccio? Possiamo ipotizzare che nell’arco di pochi mesi Browallius abbia corteggiato Sara Lisa, sia stato respinto, per poi fidanzarsi e sposarsi con un’altra, e Linneo sia venuto a saperlo solo nella seconda metà del 1737 o addirittura nel 1738? La biografia di Browallius pubblicata dall'archivio di stato svedese ammette una breve rottura, subito ricomposta, ma le lodi sperticate di Linneo all'amico rendono poco credibile anche questa ipotesi. Tanto meno è credibile che abbia covato il suo astio per vent’anni, dandogli libero sfogo quando ormai Browallius era morto e sepolto. Tanto più che, come vedremo tra poco, aveva un debito di riconoscenza non da poco nei suoi confronti; testimonianze dirette e corrispondenza stanno lì a dimostrare che l'amicizia, magari affievolita dalla distanza e dagli impegni di entrambi, non venne mai meno. 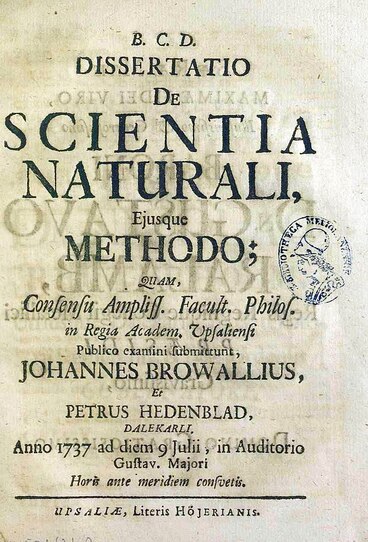 Uno scienziato, insegnante, pastore e politico molto impegnato Dissipata la nebbia delle leggende, veniamo al vero Browallius, una personalità di primo piano dell’Illuminismo svedese. Il 1737 per lui fu un anno di svolta; oltre a sposarsi, scrisse due importanti testi teorici che gli aprirono le porte dell'insegnamento universitario: il trattato De scientia naturali eiusque metodo, dedicato allo statuto e ai metodi delle scienze naturali, e un saggio in svedese di politica educativa in cui sosteneva l’utilità dell’introduzione dell’insegnamento della scienza nelle scuole, in particolare nei ginnasi (quello tradotto in latino da Linneo). Grazie ad essi, il cancelliere dell'Università di Abo/ Turku Ernst Johan Creutz ne caldeggiò la nomina a professore di fisica (un’etichetta che copriva un po’ tutte le scienze naturali): Browallius, versato in molte scienze, con un solido impianto teorico e aperto alla ricerca sperimentale, gli pareva la persona giusta per modernizzare l’insegnamento universitario aprendolo alle scienze esatte e naturali. La nomina di Browallius segnò per la Finlandia l'inizio di quella che è stata chiamata "età dell'utile", ovvero di un illuminismo che vedeva nella scienza lo strumento centrale per rinnovare l'economia e la società. Nominato professore nel novembre 1739, egli inaugurò il suo corso nel 1738 e mantenne la cattedra fino al 1746; le sue lezioni toccarono tutti i rami delle scienze naturali, nonché il loro intreccio con la teologia; seguì (o meglio scrisse, secondo l'uso del tempo) 49 tesi che toccano argomenti che spaziano dalla fisica sperimentale alla mineralogia, dalla chimica alla zoologia e alla botanica. Nelle sue lezioni insistette sull'utilità delle scienze applicate alla tecnica e all'economia; rifacendosi a Bacone, Newton e Linneo, il suo insegnamento aveva un carattere spiccatamente sperimentale. Lo sperimentalismo è particolarmente evidente nel campo della chimica, in cui il suo maggiore contributo furono le ricerche sull'arsenico, il suo ossido e il solfuro, che ne fanno il precursore del nipote Johann Gadolin (figlio di sua figlia Elisabet), considerato il fondatore della chimica finlandese. Riservò molta attenzione anche alla botanica. Come Linneo, accompagnava gli studenti in escursioni botaniche e lasciò manoscritta una flora finlandese; scrisse non meno di dodici trattati di argomento botanico, molti dei quali dedicati alla botanica economica. Ottenne che l'Università finanziasse ogni anno una borsa di studio per esperimenti botanici e coltivazioni sperimentali. Tra i suoi allievi il più noto è Pehr Kalm, che fu in un certo senso anche l'erede di questa impostazione scientifica fortemente ancorata all'economia. Sostenitore della prima ora del sistema linneano, di cui si può dire abbia visto la nascita discutendone con il creatore negli anni di Falun, Browallius esordì come scrittore scientifico nel 1739 con un trattato in sua difesa che gli diede anche una certa rinomanza all'estero, oltre a rendere all'amico un servizio incommensurabile. Linneo era tornato in Svezia alla fine del giugno 1738; andò subito a Falun, ma anziché rimanervi come assistente del suocero, come questi aveva progettato, decise di esercitare la professione a Stoccolma, dove avrebbe avuto più possibilità di lanciare la sua carriera scientifica, forte dei tanti scritti epocali pubblicati in Olanda e della crescente fama europea. Scoprì amaramente che i due pamphlet di Siegesbeck che presentavano il suo sistema come "pornografia botanica" gli avevano fatto intorno terra bruciata; come scrisse a Albrecht von Haller, forse con un po' di esagerazione, era diventato la favola della città, tanto che gli era difficile persino trovare un servitore disposto a lavorare per lui e nessuno gli avrebbe fatto curare neppure un cane. A suo tempo aveva promesso a Boerhaave di non farsi trascinare in una nessun disputa scientifica e non intendeva rispondere di persona; a farlo per lui fu dunque Browallius. In Examen epicriseos in Systema plantarum sexuale Cl. Linnaei, Anno 1737 Petropoli evulgatae, auctore Jo. Georgio Siegesbeck, pubblicato nel 1739, egli smontò punto per punto le critiche di Siegesbeck, dimostrandone l'infondatezza tanto scientifica quanto morale e teologica; un solo rilievo poteva essere mosso al sistema linneano: una medesima classe poteva riunire piante molto diverse; era però un difetto comune a tutti i sistemi artificiali, che sarebbe stato superato solo quando fosse stato possibile stabilire un sistema naturale, verso il quale il sistema di Linneo era un passo avanti, visto che conteneva più gruppi naturali di ogni sistema precedente. La serrata e lucida argomentazione (che certo fu discussa e preparata con lo stesso Linneo) ristabilì l'onore scientifico e personale del "principe dei botanici", tanto più che l'aveva scritta un teologo e un rispettato ecclesiastico. Browallius, infatti, affiancava all'attività scientifica e didattica un forte impegno pastorale: fin dal 1738 fu nominato vicario della parrocchia di Pikis, che forniva le prebende da cui dipendeva la sopravvivenza dell'Università; come predicatore, dovette imparare il finlandese e lo fece così bene e in fretta che presto fu coinvolto nella revisione della nuova Bibbia della chiesa finlandese. Nel 1740 presentò la tesi De coercitione hereticorum e fu dichiarato dottore in teologia; lo stesso anno fu promosso diacono e vicario della parrocchia di Turku. Nel 1746 lascò la facoltà di filosofia per assumere la cattedra di teologia; nel 1749 divenne vescovo della diocesi di Abo/ Turku. L'ascesa nella gerarchia ecclesiastica promosse la sua carriera politica. Benché il suo primo sponsor fosse stato Ernst Johan Creutz, noto esponente del partito dei berretti, Browallius si schierò con i "cappelli", la cui politica culturale includeva la promozione delle scienze ritenute utili e l'estensione dell'uso dello svedese a discapito del latino. Scelto come esponente del clero nel parlamento del 1746-47, sostenne vigorosamente le posizioni del partito dei cappelli, entrando a far parte di varie commissioni. Ancora più rilevante fu il suo ruolo nel parlamento del 1751-52 come membro del comitato segreto; nell'ambito della discussione sui principi dello stato nel memoriale Sui concetti fondamentali della forma del governo sostenne la sovranità popolare espressa in forma repubblicana, rifacendosi ai costituzionalisti inglesi e al pensiero di Locke. Nello stesso spirito, chiese che l'educazione del principe ereditario includesse fin dall'inizio l'avversione per l'autocrazia, "contraria alla legge di natura e all'economicità". Ovviamente, anche se ottenere qualche ascolto, queste posizioni non furono divulgate all'esterno del Consiglio segreto. In ogni caso, Browallius era probabilmente sulla strada di diventare arcivescovo, quando morì improvvisamente nel 1755, a soli 48 anni.  Fiori di zaffiro Browallia L. è un piccolo genere di erbacee annuali o perenni della famiglia Solanaceae, diffuse dall'Arizona alle Ande tropicali, passando per il Messico, l'America centrale e le Antille. Assai discusso il numero di specie attribuite, che a seconda degli autori varia da 6-7 a 19; è affine al genere monotipico Streptosolen, la cui unica specie S. jamesonii era un tempo classificata come B. jamesonii. Il diverso numero delle specie riconosciute è legato alla variabilità morfologica delle specie stesse (che, come abbiamo visto, trasse in inganno già Linneo) ma soprattutto a scoperte recenti in particolare nell'area peruviana, dove a partire dal 1995 alla lista della specie note è venuta ad aggiungersi una dozzina di specie scoperte dal team coordinato da S. Leiva Gonzales, il quale è il primo a riconoscere che "il genere richiede maggiori osservazioni sul campo, studi cito-genetici e molecolari per poter delimitare le specie". Le nuove arrivate non sono solo peruviane, tanto più che qualche specie sembra fatta apposta per eludere le ricerche dei botanici, come è il caso di B. eludens: fu descritta per la prima volta nel 1993 ed oggi ne sono conosciute popolazioni disgiunte in una singola località dell'Arizona sud-orientale e in poche località negli stati messicani di Chihahua e Sonora, dove sembra confinata ad habitat con estati temperate e umide lungo i confini delle boscaglie sempreverdi della Sierra madre occidentale. E' un'annuale strettamente legata al regime delle piogge, con un breve ciclo vitale; il che significa che negli anni di scarsa pioggia può scomparire ed essere più abbondante dove trova l'habitat giusto. Si distingue dalle altre specie per i fusti non ramificati e per i fiori bianchi. Per variabilità la campionessa sembra essere la specie tipo B. americana, che infatti ha collezionato una ventina di sinonimi: variano il portamento, eretto oppure decombente, le dimensioni, la presenza o l'assenza di peli ghiandolari, la forma e la dimensione delle foglie, il colore dei fiori (bianchi, azzurri, azzurri con una macchia bianca, malva, viola) solitari o riuniti in piccoli gruppi. Anche se non sono molto grandi, sono molto numerosi, rendendo questa specie decisamente decorativa; è dunque una pianta da giardino molto apprezzata, soprattutto in una delle sue varietà con fiori più grandi, spesso commercializzata sotto il sinonimo B. grandiflora. Come annuale da giardino, è coltivata anche B. viscosa, caratterizzata da fiori blu con centro bianco La specie più diffusa in case e giardini è però B. speciosa, originaria di Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Perù; è perenne, ma da noi è spesso trattata come annuale. Di portamento piuttosto cespuglioso e ramificato, adatta anche alla coltivazione in vaso e in cestini appesi, sta conoscendo una crescente popolarità per il colore insolito dei fiori blu-viola, cui deve il nome comune fior di zaffiro, l'abbondanza dei fiori, che può essere favorita da opportune cimature, e il lungo periodo di fioritura, che si protrae da giugno a settembre. Tra le varietà più note 'Blue Troll', di portamento compatto con fiori blu e centro bianco, e 'White Troll' con fiori bianchi. Viene anche commercializzata come pianta d'appartamento, spesso trattata con nanizzanti per mantenere il portamento compatto. L'ultima novità sono gli ibridi, caratterizzati da fioriture prolungate e da fiori particolarmente grandi e numerosi, come 'Illumination' (blu scuro) e 'Flirtation' (bianca) della serie Endless, indicati anche per aree in mezz'ombra.
0 Comments
Quando ero bambina, ho sentito vecchie signore chiamare le dalie "giorgine". Oggi forse non si sente più, tranne che in tedesco dove queste bellissime piante si chiamano indifferentemente Georgina o Dahlie. E' quanto rimane di una vecchia diatriba che nei primi decenni dell'Ottocento divise i botanici, mentre quei fiori stupendi, passati inosservati per qualche secolo, andavano rapidamente alla conquista delle aiuole e le varietà si moltiplicavano vertiginosamente. Partiamo dunque per un viaggio nel mondo del genere Dahlia, dove a farci compagnia saranno coltivatori messicani affamati, conquistadores distratti, lo sfortunato botanico svedese Anders Dahl e il tedesco russizzato Johann Gottlieb Georgi, l'abate Cavanilles e il professor Willdenow l'un contro l'altro armati, con un cameo di Alexander von Humboldt.  Prima tappa: Messico-Madrid A differenza delle loro cugine zinnie, che dovettero avere un ruolo marginale nelle culture indigene e passarono inosservate agli occhi degli spagnoli, le dalie hanno alle spalle una storia secolare. La loro coltivazione è documentata almeno dal XIV secolo presso diversi popoli precolombiani; gli aztechi le chiamavano acocotle e cocoxochitl, che dovrebbero significare "cannuccia " e "fiore della cannuccia", in riferimento ai fusti cavi. Anche se la loro bellezza era apprezzata, l'uso fondamentale era quello alimentare (si consumavano i tuberi). Non sfuggirono all'attenzione del primo importante studioso della flora messicana, Francisco Hernández, che ne descrisse due specie, poi riprese e raffigurate nel Tesoro messicano dell'Accademia dei Lincei, senza tuttavia suscitare entusiasmo; mentre già dopo pochi anni i giardini e gli orti di Siviglia si riempiavano di tageti e peperoncini, le dalie erano ignorate tanto come alimento quanto come pianta ornamentale. A sottrarle all'oblio fu ancora una volta la Spedizione botanica di Sessé e Mociño, nel corso della quale furono raccolti esemplari poi coltivati nell'Orto botanico di Città del Messico da Vicente Cervantes. Quest'ultimo nel 1789 inviò dei semi - etichettati erroneamente come Coreopsis - all'abate Antonio José Cavanilles, membro anziano dello staff del Real Jardin Botanico di Madrid (di cui più tardi divenne direttore). A quanto sembra, una pianta fiorì già l'anno successivo e nel 1791 Cavanilles la pubblicò nel primo volume di Icones et Descriptiones Plantarum come Dahlia pinnata; il nome specifico fa riferimento alle foglie pennate, quello generico è un omaggio commemorativo al botanico svedese Anders Dahl (1751-1789). Dahl, allievo di Linneo, era un botanico eccezionalmente dotato e echi della sua fama dovettero giungere in Spagna, forse attraverso Thunberg. Ripercorriamone velocemente la carriera scientifica: figlio, come tanti altri linneani, di un pastore di provincia, fin da bambino aveva sviluppato un forte interesse per le scienze naturali che lo aveva portato, adolescente, a fondare con alcuni amici la Società topografica svedese di Skara, che si proponeva di descrivere l'ambiente naturale e umano del Västergötland; Dahl vi contribuì con diversi saggi, tra cui una flora locale. Nel 1770 approdò all'Università di Uppsala, dove fu allievo di Linneo; la morte del padre, l'anno successivo, rovinò finanziariamente la famiglia e lo costrinse a interrompere gli studi. Grazie alla raccomandazione di Linneo fu assunto da Alströmer, con l'incarico di organizzare il suo giardino botanico a Kristinedal, nei pressi di Göteborg; quando il suo protettore fece fallimento, Dahl lo seguì nella nuova residenza di Gåsevadsholm, dove si occupò della catalogazione del "piccolo erbario" ceduto a Alströmer da Linneo figlio. Dahl fu tra i pionieri degli studi sull'inquinamento ambientale: nel 1784 su un giornale di Stoccolma pubblicò uno studio sugli effetti inquinanti degli scarti di produzione dell'olio di aringa; grazie alla sua denuncia, furono introdotte alcune restrizioni sugli scarichi industriali (forse la prima legge di questo tipo al mondo). Alla morte del figlio di Linneo, con altri si impegnò per creare una cordata che acquistasse le collezioni linneane, ma senza successo (ad aggiudicarsele su l'inglese James Edward Smith). Nel 1786 si recò brevemente in Danimarca, dove l'università di Kiel gli assegnò la laurea honoris causa in medicina; l'anno successivo divenne professore associato di medicina e dimostratore di botanica all'Università di Turku; tuttavia poco dopo morì precocemente di polmonite. Poco prima, aveva pubblicato la sua opera più importante, Observationes botanicae circa systema vegetabilium divi a Linne Gottingae 1784 editum. Molte delle sue carte e delle sue collezioni andarono perdute nell'incendio che distrusse il centro della città nel 1827. Qualche notizia in più sulla sua vita nella sezione biografie. Non esiste alcun rapporto diretto tra Cavanilles e Dahl, ma probabilmente lo spagnolo ne conosceva l'operato attraverso Thunberg (che di Dahl fu amico), suo corrispondente; inoltre poté essere impressionato dalla sua morte precoce, preceduta di pochissimo dalla pubblicazione di un'opera di qualche valore. In ogni caso, accompagnò la dedica con la laconica indicazione "In honorem D. Andreae Dahl, sueci botanici”. Che Dahl fosse l'assistente di Cavanilles e che insieme avessero seminato le prime dalie è una delle tante leggende metropolitane che fioriscono anche nel mondo della botanica.  Seconda tappa: alla conquista dell'Europa Intanto le dalie continuavano la loro marcia di conquista. Altre due specie nate dai semi messicani erano giunte a fioritura e Cavanilles, in base al colore dei fiori, le battezzò rispettivamente D. rosea e D. coccinea. Dall'orto botanico di Madrid, i semi arrivarono a Kew (la prima a portarveli fu la marchesa di Bute, la stessa che introdusse la zinnia in Inghilterra), Parma, Berlino, Dresda, Torino, Thiene. Tuberi di tutte e tre le specie raggiunsero il Jardin des Plantes di Parigi, dove per impulso di André Thouin - sotto gli auspici dell'imperatrice Giuseppina - iniziarono anche i primi esperimenti di ibridazione. Anche Redouté non mancò di immortalare la nuova favorita dei giardini. A complicare le cose si inserì Alexander von Humboldt che dal Messico, ultima tappa del suo memorabile viaggio sudamericano, nel 1803 spedì semi a Willdenow a Berlino, a Thouin a Parigi, a Aiton a Kew. Incominciarono ad essere disponibili altri colori e gli sforzi degli ibridatori vennero premiati dalle prime forme semidoppie. Carl Ludwig Willdenow, direttore dell'orto botanico di Berlino, decise che era ora di fare ordine, e come spesso capita ottenne l'effetto opposto. In quella che è la prima revisione del genere, sostituì il nome Dahlia con Georgina, in onore di un altro botanico tedesco, Johann Gottlieb Georgi, anch'egli morto di recente (nel 1802). In effetti, Willdenow considerò invalido il nome Dahlia sulla base del fatto che Thunberg nel 1792 aveva chiamato Dahlia crinita un'Amamelidacea sudafricana (a quanto pare, lo specifico era uno spiritoso riferimento all'aspetto lanoso dei fiori di questa specie, che gli ricordavano i capelli crespi di Dahl). All'epoca la regola della priorità (nella tassonomia botanica, in caso di conflitto, il nome valido è il più antico) non era ancora stata stabilita definitivamente; Willdenow ritenne che la denominazione di Thunberg, in quanto più diffusa, fosse quella da mantenere. Grazie alla sua autorità, il nome si impose nelle pubblicazioni scientifiche e negli orti botanici. Inoltre, nel 1809, riesaminando vari esemplari, giunse alla conclusione che due delle tre specie di Cavanilles fossero sostanzialmente simili, e le ribattezzò Georgina variabilis; mantenne separata solo G. coccinea, cui aggiunse le nuove introduzioni di Humboldt, G. lilacina e G. pallida. Anche de Candolle ci mise del suo: nel 1810 nella sua Note sur les Georginas sostenne la validità delle conclusioni di Willdenow, mentre i curatori (l'articolo fu pubblicato negli Annali del Museo di Storia naturale di Parigi) prendevano le distanze pubblicando contestualmente una nota in cui si affermava la validità di Dahlia; d'altra parte, nel 1836, nella sua revisione del genere, de Candolle ritornò sui suoi passi, riaffermando Dahlia. Insomma, un affaire internazionale: mentre in Spagna e in Francia prevaleva Dahlia, per quasi un secolo nell'Europa centrale e orientale continuò ad essere usato Georgina. Che arrivò anche in Italia: Georgina è il nome adottato tanto dalle Istituzioni botaniche di Torgioni Tozzetti (1813) quando dal Dizionario delle scienze naturali (1842), che lo italianizza anche in giorgina, nome che fino a qualche decennio fa capitava ancora di sentire e forse sopravvive ancora come denominazione locale. In tedesco è rimasto come nome volgare, e viene usato soprattutto per designare i vecchi ibridi. A chi poi fosse interessato a saperne di più su Georgi, ricordo che è una vecchia conoscenza di questo blog: lo abbiamo già incontrato come membro della spedizione dei Pallas e testimone delle tragiche vicende di Peter Falck. Rimasto in Russia, divenne un eminente studioso, autore di importanti opere etnografiche nonché di una flora della regione di San Pietroburgo. Mentre infuriava questa battaglia nominalistico-diplomatica, le nostre dalie-giorgine diventavano un fiore di culto e invadevano le aiuole in centinaia e centinaia di varietà. Dopo le prime forme semidoppie del primo decennio dell'Ottocento, nel 1829 fu la volta di quelle a fiore d'anemone, nel 1850 delle pompon, nel 1872 delle cactus, nel 1880 di quelle a collaretto. E la storia continua.  Dahlia la multiforme Dahlia è un genere della famiglia Asteraceae originario degli altopiani e delle montagne del Messico (tra 1500 e 3700 metri), con qualche presenza sporadica nelle aree adiacenti, come il Guatemala e altri paesi del Cento America e Sud America settentrionale. Sono piante di montagna, con radici perenni (tuberose) e una densa vegetazione in genere decidua, una strategia per superare la stagione fredda. La loro caratteristica più evidente è la grande varietà, che ha anche dato parecchi grattacapi ai tassonomisti; delle più di cento denominazioni specifiche che le sono state attribuite, oggi si riconosce la validità di circa 42 specie. Quanto alle varietà coltivate, superano le 20.000, differenti tra loro per colori, forma dei fiori, dimensioni. Eppure la maggior parte di esse derivano da due sole specie, D. x pinnata e D. coccinea (le due specie di Cavanilles, dato che i posteri almeno su questo hanno dato ragione a Willdenow, considerando D. rosea sinonimo di D. pinnata). Come si spiega tanta prodigiosa varietà? La ragione sta nel fatto che le dalie sono ottoploidi, ovvero hanno otto serie di cromosomi (la maggior parte delle piante è diploide, con due serie di cromosomi); ciò significa che le possibili combinazioni si moltiplicano esponenzialmente, rendendo possibile una diversità forse senza pari nel mondo vegetale. Una varietà che emerse evidente fin dalle piante nate dai semi coltivati a Madrid da Cavanilles e dai loro discendenti, che aveva così generosamente distribuito agli orti botanici europei, tanto da spingere un disorientato Willdenow a proporre per le sue giorgine lo specifico variabilis. Studiandone accuratamente la storia e le caratteristiche, nel 1996 Hansen e Hierting dimostrarono che D. pinnata, coltivata già da secoli quando Cervantes ne spedì i semi a Madrid, è a sua volta un ibrido, e sarebbe meglio correggerne il nome in D. x pinnata. Essi ipotizzano che si trattasse di un variante di D. soerensenii che già aveva acquisito caratteri di ibrido prima di essere introdotta in Europa, probabilmente incrociandosi con D. coccinea. Oggi è solo una pianta orticola e non esiste più in natura. Qualche informazioni in più sulla classificazione delle dalie, e soprattutto link selezionati a risorse on-line nella scheda. Nella povera Svezia di metà Settecento, in assenza di finanziamenti statali o di fondi a disposizione dell'Università e dell'Accademia delle scienze, per Linneo fu importantissimo il sostegno del direttore della Compagnia svedese delle Indie Orientali, Magnus Lagerstroem. Grazie a questo collezionista e curioso di cose naturali, tanti dei suoi "apostoli" poterono viaggiare gratuitamente sulle navi della Compagnia e lo stesso Linneo poté giovarsi di una notevole collezione di reperti etnografici e naturalistici di provenienza asiatica. Riconoscente, dedicò all'amico e mecenate il brillante genere Lagerstroemia. 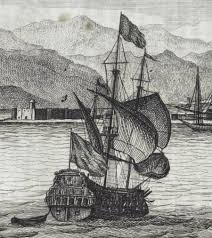 Linneo trova un mecenate La Svezia di metà Settecento sembra travolta dalla sinomania: nel 1753 nel parco del castello reale di Drottningholm viene inaugurato il padiglione cinese, al presenza dell'erede al trono (il futuro Gustavo III) vestito in abiti da mandarino; nobili e ricchi borghesi fanno a gara per ornare le loro case con porcellane e mobili cinesi; diventa di moda indossare abiti di seta di fattura cineseggiante. Porcellane, suppellettili e soprattutto il desideratissimo tè arrivano in Svezia grazie alle navi della Compagnia svedese delle Indie Orientali (SOIC), fondata nel 1731, ma che proprio tra il 1746 e il 1766 tocca l'apice del successo. E' una via di contatto con l'Oriente di cui Linneo capisce subito le potenzialità scientifiche. Attraverso il conte Tessin, cancelliere del re e presidente dell'Accademia svedese delle scienze, incomincia a premere sui vertici della Compagnia perché i viaggi commerciali assumano, in qualche modo, anche il carattere di spedizioni scientifiche. Trova immediatamente un interlocutore più che interessato in Magnus Lagerstroem, uno dei direttori della SOIC. Lagerstroem, uno svedese di origine baltica, con una notevole cultura letteraria e studioso dilettante di cose naturali, era allora all'apice della sua carriera. Con un'ottima formazione universitaria, acquisita in diversi atenei tedeschi, era un poliglotta che nella sua gioventù si era mantenuto come letterato e traduttore (fu il primo a tradurre in svedese il Tartufo di Molière e a pubblicare un manuale di lingua inglese); proprio grazie alla conoscenza delle lingue (ne scriveva e parlava almeno sei, e se la cavava con altre tre), nel 1731 era stato assunto dalla neonata SOIC come segretario. Il matrimonio con la figlia di un ricco mercante gli aveva permesso di scalare i vertici della Compagnia, fino a divenirne uno dei quattro direttori nel 1746. Proprio quell'anno si giunse a un accordo (di cui non conosciamo tutti i particolari) tra Linneo, l'Accademia delle Scienze e la SOIC: ai capitani e ai commissari di bordo delle navi che annualmente facevano la spola tra Göteborg e Canton si raccomandava di fare ogni sforzo per procurarsi oggetti di interesse etnografico e esemplari di piante e animali; nel 1747 Lagestroem emanò una circolare che stabiliva che i chirurghi e i cappellani di bordo dovevano avere una formazione scientifica, acquisita preferibilmente a Uppsala, alla scuola di Linneo. Di fatto, secondo un modello che qualche anno più tardi Joseph Banks riuscì ad imporre alla Royal Navy, queste figure assumevano un duplice volto: accanto ai loro compiti istituzionali, erano anche naturalisti a tutti gli effetti, formati secondo le istruzioni di Linneo a raccogliere e conservare reperti scientifici e a documentare le loro ricerche in accurati diari di viaggio. Fu così che iniziò l'avventura cinese degli apostoli di Linneo che abbiamo già incontrato in questo blog: Christopher Tärnström, imbarcato come pastore di bordo nel viaggio del 1746 e sfortunatamente morto prima di raggiungere la meta; Olof Torén che, sempre come pastore, tra il 1748 e il 1752 partecipò a due viaggi, prima a Giava, quindi in India e in Cina; Pehr Osbeck, cappellano della seconda nave del viaggio del 1750-1752; Carl Fredrik Adler, che tra il 1748 e il 1761 partecipò a quattro viaggi come medico di bordo; Anders Sparrman, aiuto chirurgo diciassettenne in Cina nel 1765. Grazie a questi giovani scienziati, che pagarono quasi tutti con la vita il loro amore per la scienza, giunsero in Svezia semi, piante essiccate e vive, animali, osservazioni scientifiche di ogni genere; i capitani contribuirono con rilievi cartografici e osservazioni meteorologiche. I materiali raccolti da cappellani, medici, capitani, commissari di bordo ma anche semplici marinai, andarono ad arricchire le collezioni del re, dell'Accademia delle Scienze, dell'Università di Uppsala, ma anche di facoltosi privati. Il più attivo di tutti fu proprio il nostro Magnus Lagerstroem che, approfittando della sua posizione di direttore della SOIC e investendo un notevole patrimonio, mise insieme una rilevante collezione di "cose cinesi" (ma molti reperti arrivavano da altre tappe del viaggio, dal Madagascar piuttosto che da Giava o dall'India). Quello che Lagerstroem chiamava "il mio raccolto delle Indie Orientali" comprendeva piante e animali cinesi, animali e altri reperti marini, oggetti di interesse etnografico (disegni e modellini di case e macchinari, manufatti, abiti, mappe, libri, curiosità come un corno di rinoceronte intagliato), un'intera collezione di 1000 medicinali cinesi acquistati nelle farmacie di Canton, una copia del Bencao Gangmu (o Pen-tsao Kang-mu), un grande compendio di farmacopea cinese, in 36 volumi, due dei quali di figure. Qualche anno prima della morte (avvenuta nel 1759), Lagerstroem donò le sue collezioni alla famiglia reale e a Linneo, al quale aveva anche procurato diverse piante vive per l'orto botanico dell'Università di Uppsala: tra gli altri, Arum chinense (oggi Colocasia esculenta), Artemisia chinensis (probabilmente una varietà cinese di Artemisia vulgaris, importante nella medicina cinese con il nome di moxa), Artemisia minima (oggi Centipeda minima), e, presumibilmente, quella che da lì a poco Linneo avrebbe battezzato in suo onore Lagerstroemia indica. Grazie a lui, arrivò anche una sospiratissima pianta di tè che, tuttavia, con grande delusione di Linneo, alla fioritura si rivelò una semplice camelia ornamentale. Ci è pervenuta una descrizione dei reperti naturalistici donati a Uppsala (qualche alga, qualche mammifero, ma soprattutto una cinquantina tra animali marini e uccelli) grazie alla tesi intitolata Chinensia Lagerstroemiana, scritta da Linneo nel 1754 e discussa, secondo l'abitudine del tempo, dal suo allievo Johan Lorens Odhelius. Molti di essi (tra gli altri, il famoso corno di rinoceronte) pervennero a Londra dopo l'acquisto delle collezioni linneane da parte di James Edward Smith, entrando a far parte del patrimonio della Linnean Society. Una sintesi della vita di Lagerstroem nella sezione biografie.  Lagerstroemia, dalle foreste asiatiche ai viali cittadini Poco dopo la morte del generoso mecenate, che era anche un amico personale (ci rimangono diverse sue lettere nell'epistolario linneano) Linneo volle celebrarne la memoria creando il genere Lagerstroemia. Manifestò la sua riconoscenza scegliendo una specie particolarmente bella e pregevole per le vistose fioriture, giunta a quanto pare in Svezia nel 1746 proprio attraverso Lagerstroem e i suoi fornitori di naturalia, Lagestroemia indica. Una specie indiana (oggi L. speciosa) era già stata descritta dai botanici olandesi in Hortus Malabaricus con il nome indiano di Adambea; fu forse questo a trarre in inganno Linneo - che in ogni caso dimostrò spesso una certa disinvoltura nelle sue denominazioni geografiche - inducendolo a battezzare con lo specifico indica una specie di origine cinese. Il genere Lagerstroemia appartiene alla famiglia Lythraceae, di cui costituisce il genere più cospicuo e anche il solo a comprendere veri e propri alberi. Di distribuzione essenzialmente asiatica - dall'India alla Cina e al Giappone, all'Indocina, spingendosi fino all'Australia attraverso la Malaysia - comprende una cinquantina di specie di alberi e arbusti a foglie persistenti o decidue. La più nota da noi è proprio la quasi onnipresente L. indica, che soprattutto potata a alberetto e per lo più nella varietà a fiori rosa carico, imperversa in parchi e viali cittadini, spesso usata con scarsa fantasia. Eppure ne esistono innumerevoli varietà (intorno al 2000 ne sono state recensite ben 250) e anche il mercato italiano è ben rifornito, con la presenza di vivai specializzati e di cultivar tutte italiane, come quelle selezionate dal pistoiese Antonio Grassi. Ampissima la selezione disponibile sul mercato americano, anche grazie agli ibridi tra L. indica e L. fauriei, notevoli per la rusticità e per la resistenza al mal bianco. E la scelta non si limita al solito, un po' stucchevole, rosa shocking: la gamma dei colori, oltre a tutte le sfumature del rosa e del viola, comprende anche il bianco e il rosso. Almeno un cenno al gigante del genere, l'indiana L. speciosa, un grande albero tropicale dalle vistose fioriture dal bianco al porpora che può raggiungere i 20 metri, importante per le sue implicazioni culturali; in alcune correnti del Buddismo, è considerato l'albero sotto il quale era seduto Buddah quando raggiunse l'illuminazione. Le sue foglie vengono seccate e utilizzate per un infuso simile al tè. Altri particolari su questo genere tanto diffuso quanto superficialmente noto nella scheda. Negli anni '70 del Settecento, a stare ai resoconti dei naturalisti, si ha l'impressione che la colonia del Capo, in Sud Africa, pullulasse di svedesi. Linneo non aveva colto l'opportunità di andarci di persona, ma era riuscito a farci arrivare ben tre allievi. E al loro fianco, spunta un personaggio misterioso, un altro svedese ovviamente: Franz Pehr Oldenburg.  Uno svedese in Sud Africa Nelle storie dei botanici e cacciatori di piante che esplorarono la natura sudafricana negli anni '70 del Settecento, prima o poi capita, con un ruolo più o meno di comparsa, un misterioso svedese, Franz Pehr (o Frans Petter) Oldenburg. Di lui non sappiamo molto, e forse proprio questo mistero eccita la curiosità. Soprattutto non sappiamo come uno svedese di Stoccolma fosse arrivato nella colonia olandese del Capo di Buona Speranza e si fosse arruolato come mercenario della VOC, la potente Compagnia Olandese delle Indie orientali. Dato che più tardi lo ritroveremo chirurgo di bordo, potrebbe essere arrivato in Sud Africa con lo stesso ruolo; di solito le navi della Compagnia svedese delle Indie orientali non facevano scalo a Cape Town, perché la VOC non ne vedeva di buon occhio la concorrenza, ma in effetti nel maggio 1770 la Finland, comandata dal capitano Carl Gustaf Ekeberg attraccò al Capo e vi sostò relativamente a lungo. Anche se Oldenburg non risulta tra i chirurghi della nave, è possibile che prestasse servizio come aiuto chirurgo (solo gli ufficiali erano registrati nei documenti della compagnia). Appare invece davvero remota l'ipotesi - che pure è stata avanzata - che anche lui fosse un allievo di Linneo (i chirurghi a quel tempo non erano medici e non avevano una formazione universitaria). In ogni caso, nel marzo del 1771 era sicuramente a Cape Town e prestava servizio come mercenario agli ordini della VOC. Lo testimoniano Joseph Banks e Daniel Solander che lo incontrarono quando sbarcarono al Capo durante il viaggio di ritorno della Endeavour. I due svedesi, Oldenburg e Solander, rimasero in contatto epistolare anche dopo il ritorno di quest'ultimo in Gran Bretagna. Nel 1772 ritroviamo Oldenburg in compagnia di un altro conterraneo e apostolo di Linneo, Carl Peter Thunberg, che accompagnò in brevi spedizioni di raccolta nella penisola del Capo. A settembre, era invece insieme a Anders Sparrman in un'escursione di una settimana nei dintorni di Paarl, nel Capo Occidentale. Sono indizi a favore della sua appartenenza alla piccola rete sudafricana di studenti e amici di Linneo (di cui faceva parte anche Ekeberg, che aveva propiziato l'arrivo in Sud Africa di Sparrman); inoltre fu anche corrispondente di un altro linneano, P. B. Bergius. All'epoca Oldenburg aveva già acquisito una buona conoscenza del territorio e delle sue insidie, conosceva tutti i segreti per muoversi con un carro trainato da buoi lungo strade che erano niente di più che piste; parlava bene l'olandese e alcune lingue indigene. Così, tra dicembre 1772 e gennaio 1773, lo ritroviamo come compagno di viaggio e interprete dell'ancora inesperto Francis Masson cui insegnò le basilari tecniche di sopravvivenza. Se non lo era già prima, sicuramente a questo punto era diventato anche lui un appassionato di scienze naturali e un esperto raccoglitore. Inoltre era un bravo disegnatore; un migliaio tra suoi disegni e esemplari da lui raccolti furono acquistati dopo la sua morte da Banks e si trovano ora al Natural History Museum di Londra. Tra il 1773 e il 1774 presumibilmente accompagnò con una certa frequenza Thunberg e Masson nelle brevi escursioni "invernali" nei dintorni del Capo. Lo testimonia lo stesso Thunberg nella sua lettera di raccomandazione al governatore van Plattenberg: "Ha praticato la botanica per due anni e mi ha accompagnato nelle mie escursioni". Infatti, nel 1774 il governatore chiese a Thunberg di imbarcarsi come chirurgo di bordo sulla Hoeker, una nave negriera che andava a rifornirsi di schiavi in Madagascar. Thunberg - che stava preparando la sua terza e ultima spedizione - declinò, ma raccomandò il connazionale, il quale, purtroppo per lui, accettò. Poco dopo il suo arrivo in Madagascar infatti morì di febbri. Una sintesi di questa breve vita nella sezione biografie.  Il singolare genere Oldenburgia Il ricordo di questa figura minore dell'esplorazione naturalistica del Sud Africa, oltre che alle relazioni di viaggio dei suoi compagni Masson e Thunberg, è affidato a un genere endemico del Sud Africa, Oldenburgia, della famiglia Asteraceae, creato nel 1830 dal botanico tedesco Lessing, grande esperto di questa famiglia. Con sole quattro specie, tutte originarie della provincia del Capo, questo genere è così singolare che recenti studi lo hanno assegnato a una tribù specifica (Oldenburgieae). Comprende sia arbustini a cuscino sia piccoli alberi, caratteristici del fynbos, la vegetazione arbustiva dell'area costiera del Capo, simile per caratteristiche ecologiche alla macchia mediterranea. La più singolare di tutte è Oldenburgia grandis, che è si presenta come un piccolo albero (uno dei pochi casi di questa famiglia), con grandi foglie coriacee, che quando spuntano sono completamente coperte da morbidi peli bianchi, che le fanno assomigliare alle orecchie di qualche animale (da qui i nomi popolari inglesi rabbit's ears, lamb's ears, donkey's ears) e enormi capolini che ricordano un cardo gigante, anch'essi fittamente ricoperti di corti peli bianchi vellutati. Questa densa peluria protegge le giovani foglie e i capolini dal calore del sole e soprattutto dal vento che spazza la chioma di questa specie che si erge al di sopra di arbusti solitamente molto più bassi. Di portamento totalmente diverso è l'altra specie più nota, O. paradoxa, che cresce nelle aree rocciose delle montagne del Capo, dove si abbarbica sulle parete rocciose formando densi, bassi cuscini che possono raggiungere anche un metro di diametro, con foglie strette, densamente lanose nella pagina inferiore, da cui emergono numerosi piccoli capolini con brattee lanose e minuscoli flosculi bianchi. Entrambe le specie sono impollinate da vari tipi di colibrì. Qualche informazione in più nella scheda. C'è stata una botanica svedese prima di Linneo; e tra quei precursori, destinato a una fama postuma inaspettata, Olaus Bromelius, che ha donato il suo nome a un genere centro e sud americano di cui non ha mai visto neppure una spina, ma soprattutto all'intera, vasta, famiglia delle Bromeliaceae. 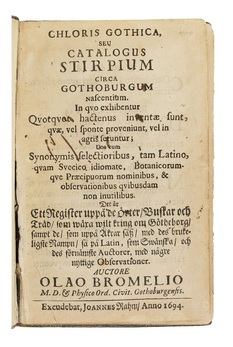 Dedicato a Clori Tra le poche opere di autori svedesi che accesero la passione per la botanica del giovane Linneo, accanto al monumentale Campi Elysii dei due Rudbeck, si colloca Chloris gothica, seu catalogum stirpium circa Gothoburgum, che vanta il primato di essere la prima descrizione scientifica della flora di una provincia svedese. L'autore è il medico Olaf Bromel (più comunemente noto nella grafia latinizzata Olaus Bromelius), vissuto nella seconda metà del Seicento. Di pochi anni più giovane del primo Rudbeck, anche Bromelius studia medicina a Uppsala quindi in Olanda, dove, come altri medici-botanici svedesi tra Seicento e Settecento - Linneo compreso - consegue la laurea. Membro del collegio medico, insegnante di materia medica, sovrintendente delle farmacie di Stoccolma, nel 1676 è un professionista autorevole, tanto che è chiamato a far parte di una commissione di laici e religiosi incaricata dal re di esaminare alcuni casi di stregoneria. Anche se i lavori della commissione si conclusero con alcune condanne al rogo, si ritiene che proprio i suoi lavori e le sue indagini abbiano messo fine in Svezia alla stagione della caccia alle streghe. Gli scritti botanici di Bromelius risalgono però a un periodo successivo, quando viene nominato medico cittadino di Gotheborg e capo medico delle province di Elsborg e Bohuslan nella Svezia sud-occidentale. La sua prima opera sulle piante (1687) è un breve manuale destinato agli agricoltori, dal curioso titolo Lupulogia (contiene infatti anche parti dedicate alla coltivazione del luppolo). Dall'attenta esplorazione del distretto di Gothland nasce la sua opera più importante, appunto Chloris gotica (1694), che è un catalogo della flora della città e dei suoi dintorni. Un'opera di buon livello, tanto da essere conosciuta e apprezzata anche al di fuori della Svezia. Il titolo contiene una piccola civetteria: non Flora, la dea mediterranea delle fioriture, è chiamata a presiedere ai vegetali delle terre dei Goti, ma la sua compagna, la ninfa Clori, la verde. E' anche la prima opera in cui, accanto ai nomi latini, vengono usati i nomi svedesi delle piante. Come altri scienziati del tempo, Bromelius fu anche un collezionista che, nella sua personale Wunderkammer, raccolse monete, animali impagliati, piante e semi, minerali e fossili. Dopo di lui, la raccolta fu incrementata dal figlio Magnus (1679-1731, nobilitato con il nome di von Bromel), importante scienziato e padre della paleontologia svedese. Qualche notizia in più, tra le non molte che ci sono giunte su Olaus Bromelius, nella biografia. 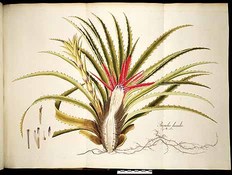 Bromeliae e Bromeliaceae L'opera di Bromelius era ben nota a Plumier che in Nova plantarum americanarum genera, lo celebra come "famosissimo dottore dell'arte medica, botanico peritissimo" e soprattutto come colui che "studiando e raccogliendo i fiori nei boschi e nei prati gotici, a prezzo di grandi fatiche, con la sua Chloris gothica ha coronato Flora stessa". Questi sperticati elogi accompagnano e giustificano la dedica di una delle piante da lui scoperte nelle Antille, con la creazione del nuovo genere Bromelia, che nel 1753 sarà confermato da Linneo. Una dedica importante, grazie alla quale lo studioso della flora della terra dei Goti diventa il padre eponimo di un'intera, importante famiglia di piante del nuovo mondo, di cui non vide né conobbe neppure un esemplare: le Bromeliaceae (Bromeliad in inglese, ma semplicemente bromelia in molte lingue, tanto per complicare la vita a chi fa ricerche in rete). E' la famiglia dell'ananas, della Tillandsia e di molte altre amatissime piante d'appartamento, dalla Guzmania alla Billbergia. Quanto al genere tipo, Bromelia, comprende una sessantina di specie, caratteristiche soprattutto delle aree aride, in un aerale che va dal Messico all'Argentina, passando per il Brasile, dove nella vasta savana del Cerrado trova la sua massima biodiversità con circa metà delle specie. Sebbene anche in Italia si stia diffondendo l'abitudine di chiamare sbrigativamente bromelia qualsiasi Bromeliacea, è improbabile che nelle vostre case ci sia una specie del genere Bromelia. Infatti non sono molto usate come piante ornamentali per le dimensioni in genere ragguardevoli e l'estrema spinosità delle foglie. Nel loro habitat naturale sono erbacee terrestri imponenti, con foglie spinose e infiorescenze con lunghe brattee colorate; alcune di esse (come la gigantesca B. sylvicola, una specie endemica del Mato Grosso che può raggiungere anche i tre metri) vengono utilizzate per racchiudere tra siepi vive impenetrabili i recinti di bestiame. Dalle foglie di diverse specie vengono ricavate fibre tessili, note con il nome di chaguar; anche i frutti eduli trovano impiego sia nella farmacopea tradizionale sia nella preparazione di bevande. Qualche approfondimento nella scheda. Linneo è morto da quasi quindici anni e in Francia c'è la rivoluzione quando Adam Afzelius parte per l'ultimo viaggio degli apostoli. A un mondo che traballa, dove le sicurezze illuministe lasciano il posto alle rivoluzioni e al misticismo, come i discepoli di Linneo che lo hanno preceduto in giro per il mondo, oppone tenacia e dedizione alla scienza. E lascia il suo nome a un genere di splendidi alberi tropicali.  Una patria per gli schiavi liberati Sono passati quasi vent'anni dallo sfortunato viaggio di Berlin in Africa, quando Adam Afzelius parte a sua volta per la medesima meta, la Sierra Leone. Proprio su suggerimento di Henry Smeathman, il compagno di viaggio di Berlin, il paese è stato scelto dagli abolizionisti britannici per creare una colonia dove trovino una patria e un rifugio gli schiavi liberati; nel 1792, il progetto si concretizza nell'emigrazione di un migliaio di neri e nella fondazione della capitale, Freetown. Per rendere economicamente produttiva la colonia, affrancandola dal commercio degli schiavi, è necessario inventariare le risorse naturali del paese e individuarne le potenzialità economiche. E' un compito delicato, da affidare a esperti naturalisti, in primo luogo a un botanico; William Wilberforce, uno dei membri più influenti della Sierra Leone Company, che finanzia l'impresa, chiede consiglio a Joseph Banks, che propone appunto la candidatura di Afzelius, l'ennesimo allievo di Linneo approdato a Londra, in quegli anni di fine secolo ormai definitivamente la capitale della botanica mondiale. In quel momento Afzelius non è certo un giovanotto di belle speranze. Quando ha lasciato la Svezia l'anno prima, aveva già più di quarant'anni e aveva percorso lo gavetta di una modesta carriera accademica; è giunto a Londra proprio a cercare l'occasione di una spedizione scientifica che gli dia fama e rilanci la sua carriera stagnante (a Uppsala è ormai l'era di Thunberg: difficile competere con un personaggio di quel calibro). Quasi contemporaneamente, gli viene offerto di partecipare all'ambasciata in Cina di Macartney, ma Afzelius opta per la Sierra Leone: forse perché è rimasto un territorio quasi ignoto alla botanica europeo, forse perché diversi svedesi - seguaci di Swedenborg -sono membri attivi del movimento abolizionista; uno di loro è August Nordenskiöld, l'alchimista finno-svedese assunto dalla Compagnia come geologo. Lui e Afzelius faranno il viaggio d'andata insieme; ma per il compatriota non ci sarà viaggio di ritorno: morirà dopo pochi mesi. Un altro dei suoi influenti amici britannici, quel James Edward Smith che aveva acquistato le collezioni di Linneo ed era diventato presidente della Linnean Society, gli procura anche un assistente: un giovane italiano, Francesco Borone, suo servitore, che ha rivelato un sorprendente acume per la botanica. 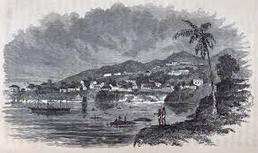 L'importante è non arrendersi Dopo i canonici due mesi di navigazione, nel maggio 1792 Afzelius e Borone sono a Freetown; trovano molte tensioni politiche, una crisi degli alloggi e molte difficoltà a preparare e soprattutto a preservare le collezioni in mancanza di carta, alcool, scatole a tenuta stagna (come dirà spiritosamente Smith, la Sierra Leone è un paese umido e "molto insettifero"); all'inizio non hanno neanche la casa promessa loro dalla compagnia. Ma soprattutto tutti e due si ammalano, presumibilmente di malaria; tanto che dopo appena un anno tornano a Londra per curarsi. A marzo dell'anno successivo Afzelius, questa volta da solo, parte di nuovo per la Sierra Leone, con attrezzature più adatte, in buona parte fornite da Banks; oltre al suo lavoro per la compagnia, in pochi mesi riesce a raccogliere, classificare, preparare, impacchettare e spedire a Banks e Smith a Londra e a Thunberg a Uppsala due importanti collezioni di piante, semi, bulbi, insetti, conchiglie, ecc. Anche se si muove poco da Freetown (compie escursioni relativamente brevi nella penisola in cui sorge la città, del resto un'area di ricca biodiversità), si avvale di una notevole rete di raccoglitori indigeni da cui acquista gli esemplari e che interroga puntigliosamente sui possibili usi. In riva al mare, nella Susan's Bay, ha una piccola casa e un giardino sperimentale dove coltiva piante utili e ornamentali e alleva i piccoli animali vivi che gli procurano i suoi raccoglitori. Ha appena messo insieme una terza collezione, ancora più imponente, quando, nel settembre 1794, una flotta francese (siamo ai tempi della prima coalizione contro la Francia rivoluzionaria) attacca Freetown. La città viene saccheggiata, devastata, incendiata; Afzelius perde la casa, tutte le sue collezioni, i libri, gli strumenti scientifici, il giardino e, quel che è peggio, il suo diario di lavoro. Non ha più nulla, tranne il vestito che ha addosso. Senza una casa, senza materiali, senza strumenti, per qualche mese vive in condizioni drammatiche. Ma non appena dall'Inghilterra gli arriva qualche aiuto, si rimette al lavoro. Mentre aspetta che una nave lo riporti in Inghilterra (non è facile, dato lo stato di guerra), nel corso del 1795 esplora non solo la costa, ma anche l'interno e ricostruisce una nuova collezione naturalistica e etnografica (particolarmente notevole la collezione di frutti); infine, nel maggio 1796 si imbarca sulla Eliza diretta a Portsmouth. In seguito a una burrasca, le piante vive che porta con sé periscono, ma si salvano i diari e tutti gli altri materiali. Altre informazioni sulla sua lunghissima vita (morirà a 86 anni, salutato come il "Nestore della botanica" e curerà anche la pubblicazione dell'autobiografia di Linneo) nella biografia.  Afzelia, legname pregiato e semi alla moda Poco dopo il suo rientro in Gran Bretagna, l'amico James Edward Smith gli dedicherà il genere Afzelia, scegliendo giustamente una delle piante raccolte dal botanico svedese in Sierra Leone, Afzelia africana. Afzelia (Fabaceae) comprende una dozzina di specie di notevoli alberi da legname, nativi delle foreste tropicali dell'Africa e dell'Asia; in Africa coprono un aerale molto vasto, che occupa la fascia forestale e le adiacenti savane, dalla Sierra Leone e dal Cameron fino alla Tanzania e al Sud Africa. Le specie asiatiche sono concentrate in Indocina, in Filippina e in Indonesia. Il legname delle specie africane è commercializzato con il nome doussié o doussie. Il più pregiato (doussie rosso) è fornito da A. africana e A. bipindensis; da A. pachyloba e A. quanzensis si ricava invece il doussie giallo o falso doussie. Per la bellezza, la durata e la stabilità, il doussie può essere annoverato tra i più pregiati legnami tropicali, paragonabile al mogano o al palissandro. Le afzelie sono alberi molto attraenti, con fiori papilionacei bianchi o rosati, spesso profumati, con un grande petalo dorsale eretto striato che può ricordare una farfalla (destinato ad attrarre le falene, i suoi insetti impollinatori). I semi bicolori di alcune specie, come A. quanzensis, vengono utilizzati come vaghi per bracciali e collane. Altre informazioni nella scheda. Andreas Berlin, uno degli ultimi apostoli di Linneo, con una borsa di studio va a Londra e entra nell'entourage di Banks. Ma anche lui sogna di partecipare a una spedizione scientifica; così non esita a partire per l'Africa per esplorare la quasi sconosciuta Sierra Leone. Ma ben presto scopre a sue spese che l'Africa può essere ben peggio della selvaggia e famigerata Lapponia di Lule.  Un coleottero, una disputa e una spedizione scientifica Nel 1766, Mr. Ogilvie, il medico di bordo del vascello britannico Renown, alla fonda alla foce del Gabon, entra in possesso di un enorme insetto, trovato a fluttuare morto nelle acque del fiume. Quelli che oggi conosciamo come "scarabei golia" sono gli insetti più grandi della Terra, possono essere lunghi fino a 15 cm e pesare un etto; subito battezzato Goliathus goliatus da Linneo (1771), il mostruoso coleottero è al centro di una curiosa disputa tra collezionisti di curiosità naturali. Il medico lo vende a William Hunter, celebre anatomista e proprietario di un notevole gabinetto di curiosità; membro della Aurelian Society, un influente circolo di entomologi, egli presta l'esemplare a un altro socio, Emanuel Mendez da Costa, che sta curando una pubblicazione. A sua volta da Costa, dopo aver fatto ritrarre l'esemplare dal celebre disegnatore naturalista Moses Harris, trovandosi in difficoltà finanziare, senza alcuna autorizzazione, vende il disegno a Dru Drury, importante entomologo e a sua volta grande collezionista, che lo pubblica come fosse proprio, senza indicare il vero proprietario, Vedendo la sua generosità così mal ripagata, Hunter va su tutte le furie. L'episodio, oltre a dimostrare quanto grande fosse nell'Inghilterra del Settecento la rivalità tra collezionisti, è all'origine di una spedizione scientifica che coinvolge uno degli ultimi apostoli di Linneo, Andreas Berlin. Nel 1771 Drury, Harris, il medico John Fothergill, l'ornitologo Marmaduke Tunstall, desiderosi di assicurare alle loro collezioni prestigiose rarità, si associano per finanziare una spedizione naturalistica in Africa occidentale, una regione poco conosciuta dagli europei e quindi particolarmente adatta "ad offrire esemplari nuovi e rari dei tre regni della natura". Coinvolgono nel progetto anche il giovane Banks, appena rientrato dal viaggio dell'Endeavour, grazie al quale ottengono il sostegno della Royal Society. La spedizione è affidata al giovane naturalista Henry Smeathman, con l'assistenza appunto di Berlin. Quest'ultimo nel 1770 si era trasferito a Londra con una borsa di studio, nella speranza di unirsi a qualche spedizione botanica. Era quindi stato assunto come segretario da Banks, che lo aveva impegnato in compiti di scarso peso scientifico, come copiare in bella copia le descrizioni delle piante; come scrive in una lettera a Linneo, tuttavia, Berlin è incerto sul suo futuro: Banks e Solander al momento sono intenzionati a partecipare al secondo viaggio di Cook e inizialmente Berlin pensa di partire con loro. Quando il progetto salta, decide di accettare la proposta di Fothergill di accompagnare Smeathman in Africa; anche se l'obiettivo principale è la raccolta di insetti, la presenza di un botanico (materia poco nota a Smeathman) è un valore aggiunto. La meta prescelta è la Guinea. Abituato al terribile clima lappone, Berlin è convinto che se la caverà benissimo in Africa: "L'Africa non può essere peggio della Lapponia di Lule". Si sbaglia di grosso. Dopo due mesi di navigazione, Berlin arriva in Africa all'inizio di aprile 1773 e raggiunge Smeathman nelle Isole delle banane, un piccolo arcipelago a sud della Sierra Leone, che sarà la base iniziale della spedizione. E' stupefatto dalla ricchezza e dalla bellezza della natura africana, tanto da paragonarsi a un cieco che ha appena ricevuto la vista. Nell'unica lettera inviata a Linneo dall'Africa, gli racconta con entusiasmo che dopo un quarto d'ora d'escursione ha già trovato tre specie sconosciute; inoltre si è accordato con Smeathman di inviare al maestro un esemplare per ogni insetto che troveranno. Ma questi progetti non si realizzeranno mai: prima ancora di lasciare le isole per la terraferma Berlin si ammala gravemente di una febbre tropicale, presumibilmente di malaria, e a giugno muore. Qualche notizia in più nella biografia.  La Berlinia e le sue sorelle La tragica vicenda di Berlin (che ha condiviso il destino di tanti altri discepoli di Linneo e in particolare del primo, quel Tärnström morto prima di raggiungere la meta) gli ha impedito di offrire particolari contributi alla scienza. Il condiscepolo Solander volle tuttavia ricordarlo dedicandogli il genere Berlinia, una leguminosa (Fabacea) africana di grande bellezza, tra i pochi esemplari vegetali che lo sfortunato naturalista era riuscito a raccogliere. Questo genere comprende una ventina di specie arboree o meno frequentemente arbustive esclusive delle foreste e delle boscaglie dell'Africa occidentale. Non è ancora ben conosciuto, tanto che recentemente - nel corso di uno studio finanziato dai Kew Gardens - ne sono state riconosciute tre nuove specie, tra cui la gigantesca B. korupensis, endemica del Parco Nazionale Korupe del Cameron, che può raggiungere i 40 metri; porta enormi baccelli che, quando sono maturi, esplodono, lanciando i semi a grande distanza. Nonostante diverse specie siano minacciate, questo alberi sono anche sfruttati per il legname, che viene commercializzato con il nome "ebiara" o (nei paesi anglofoni) Zebrawood per le evidenti venature scure. Dal genere Berlinia sono stati distaccati due generi affini: Microberlinia, che comprende due specie di alberi nativi del Cameron e del Gabon, anch'essi noti con il nome di Zebrawood; Isoberlinia, che comprende cinque specie originarie delle boscaglie aride dell'Africa tropicale, caratteristiche della formazione vegetale denominata miombo (boscaglia delle regioni aride, formata prevalentemente da alcune specie di leguminose). Le tre specie Berlinia, Isoberlinia, Microberlinia sono molto affini tra loro (le differenze sono così piccole da non essere riconoscibili quando le piante non sono in fiore e spesso sono confuse anche dalla popolazione del luogo); qualche informazione in più nelle rispettive schede. Per tutto il Settecento, nessun botanico europeo aveva potuto mettere piede in Giappone, chiuso agli stranieri dalla politica isolazionista del sakoku. L'impresa di infrangere quella cortina di ferro riuscì a uno dei formidabili apostoli di Linneo, Carl Peter Thunberg. Per riuscirci dovette farsi olandese. E mentre cambiava pelle e lingua, diede un ineguagliabile contributo alla conoscenza della flora e della fauna del Sud Africa.  Come si diventa olandesi? Nel 1636, nella baia di Nagasaki venne costruita l'isola artificiale di Dejima (o Deshima). A forma di ventaglio, lunga 120 m e profonda 75, con una circonferenza di poco più di 500 m, questo luogo minuscolo per circa 200 anni sarebbe stata l'unica finestra del Giappone sul mondo; vi aveva infatti sede l'agenzia della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC), l'unica ad essere autorizzata a commerciare con il Giappone durante il lungo periodo dell'isolazionismo, o sakoku. Qui nel 1775 giunse Carl Peter Thunberg, il più grande dei discepoli di Linneo. Per arrivarci, aveva già percorso una lunga strada e si era creato una nuova identità. Studente a Uppsala alla fine degli anni '60, nel 1770 aveva lasciato la Svezia per perfezionarsi in medicina e scienze naturali a Parigi, Leida e Amsterdam. In Olanda il suo talento fu notato da Johannes Burman (che oltre trent'anni prima aveva ospitato Linneo) e dal figlio Nicolaas, i quali progettavano di inviare in Giappone un medico-naturalista che arricchisse di nuove piante gli orti botanici olandesi; in effetti, nell'ultimo quarto del Settecento l'isolazionismo del Giappone si era fatto meno severo e, grazie all'importazione di numerosi libri scientifici in lingua olandese, vi era vivo l'interesse per le scienze occidentali, soprattutto l'erboristeria e la medicina. Un medico con una buona preparazione botanica sarebbe stato il benvenuto e avrebbe potuto ottenere piante in cambio di informazioni scientifiche. Ottimo medico e dotto naturalista della scuola linneana, Thunberg era il candidato ideale; tranne per un particolare: non era olandese. Non un ostacolo tale da impressionare né i Burman né l'avventuroso Thunberg: se non era olandese, avrebbe potuto diventarlo almeno abbastanza da apparire credibile a occhi e orecchie giapponesi. Sostenuti gli esami per essere assunto dalla VOC come chirurgo, avrebbe dovuto trasferirsi in Sud Africa, in modo da imparare la lingua e le abitudini olandesi soggiornando nella colonia del Capo. E ovviamente, mentre era sul posto, esplorare la flora e la fauna di quella ricca regione naturalistica. Linneo, sempre puntigliosamente informato dalle lettere dell'affezionato allievo, diede il suo assenso. Dunque nell'autunno del 1771 Thunberg partì per il Capo di Buona Speranza come medico di bordo della nave Schoonzigt. Il viaggio gli costò quasi la vita, per colpa di un cuoco maldestro che per errore mescolò biacca di piombo alla farina dei pancake della mensa ufficiali; ma fu anche un'occasione per dimostrare il suo acume scientifico, salvando se stesso e le altre vittime e descrivendo il decorso della malattia in una puntigliosa relazione. 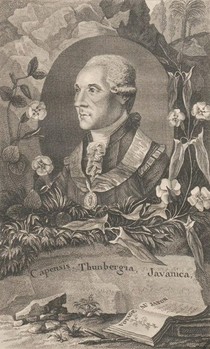 Il "padre della botanica sudafricana" Dopo la pericolosa avventura, Thunberg arrivò al Capo il 16 aprile 1772, appena una settimana dopo il condiscepolo Sparrman (come si è visto in questo post). In Sud Africa sarebbe rimasto tre anni durante i quali avrebbe esplorato sistematicamente le ricchezze naturali della regione. Il primo contatto con la flora sudafricana avvenne proprio in compagnia di Sparrman con il quale esplorò la baia del Capo, ma ben presto le strade dei due si divisero. Nonostante il nuovo governatore della Compagnia, Joachim van Plettenberg (a differenza del predecessore, Rijh Tulbagh, corrispondente di Linneo) fosse scarsamente interessato alle esplorazioni scientifiche e Thunberg fosse sempre a corto di denaro (si manteneva con il lavoro di medico della VOC e ottenne aiuto e prestiti da alcuni sponsor), egli riuscì a sfruttare al meglio la sua permanenza: ogni anno, dedicò il periodo settembre-dicembre (corrispondente alla primavera australe, la stagione delle piogge e il momento di massimo rigoglio della vegetazione) a una lunga spedizione naturalistica nell'interno; i mesi restanti erano utilizzati per raggranellare quattrini, riordinare le raccolte, scrivere le pubblicazioni scientifiche relative, compiere frequenti escursioni a breve raggio nei dintorni di Città del Capo (ad esempio, scalò la Table Mountain per almeno quindici volte). Nella prima spedizione (7 settembre 1972-2 gennaio 1773) Thunberg fu accompagnato da Johann Andreas Auge, il soprintendente dei giardini della Compagnia al Capo; dal sedicenne Daniel Ferdinand Immelmann, figlio di un ufficiale olandese; dal sergente dell'esercito Christian Hector Leonhard e da due "ottentotti" (ovvero Khoi). Dapprima si mossero verso occidente, fino alla base di Saldanha; quindi, dopo aver raggiunto le montagne, un grande giro verso est lungo l'altopiano li portò a toccare la costa a Mossel Bay. Qui si inoltrarono ancora verso est, toccando il punto più orientale al fiume Gamtoos. La spedizione si muoveva lentamente, pernottando nelle fattorie della compagnia con carri trainati dai buoi, più adatti dei cavalli ad affrontare la scarsità d'acqua. Al suo rientro a Città del Capo, Thunberg accompagnò in una breve escursione il naturalista francese Pierre Sonnerat, di passaggio in Sud Africa; ma soprattutto incontrò Francis Masson, il raccoglitore di piante inviato al Capo da Banks per conto dei Kew Gardens. I due, pur diversissimi per cultura e carattere, divennero amici e decisero di proseguire insieme l'esplorazione; in effetti, la collaborazione conveniva da entrambi: Masson aveva dalla sua una maggiore disponibilità di mezzi, Thunberg l'eccezionale competenza scientifica, oltre a una migliore conoscenza del territorio. Dopo un breve viaggio di prova, in cui insieme al capitano Gordon esplorarono le montagne intorno al Capo (13-16 maggio 1773), nel settembre 1773 i due, accompagnati da quattro khoi, partirono, per una lunga spedizione che si mosse grosso modo sulle tracce di quella precedente; tuttavia, spesso, mentre i khoi proseguivano con i carri per strade più battute e percorribili, i due naturalisti, a cavallo, affrontarono impervie scalate e passi disagevoli per esplorare la flora e la fauna delle montagne dell'altopiano. Impetuoso e talvolta imprudente, mentre guadava un torrente Thunberg rischiò di annegare nella profonda buca scavata da un ippopotamo, ma superò l'avventura con imperturbabile sangue freddo. Il punto estremo della spedizione fu questa volta il Sundays River. L'anno successivo i due amici si unirono per un'ultima spedizione (settembre-dicembre 1774) che si spinse all'interno, in direzione nord-ovest, per esplorare l'altipiano del Roggeveld, fino ad allora mai toccato dai naturalisti. Tra gli obiettivi anche la raccolta di campioni minerari. Anche se una parte delle collezioni andò perduta in seguito al ribaltamento di uno dei carri, anche in questo caso il bottino dei due amici fu ricchissimo. Durante la sua permanenza al Capo, Thunberg, raccoglitore estremamente accurato e coscienzioso, raccolse un'impressionante massa di esemplari botanici (ma anche animali, rocce, minerali, fossili): circa 3000 piante (ovvero il 30% delle specie dell'area), di cui almeno un migliaio ignote alla scienza. Insieme a numerosissime pubblicazioni più brevi dedicate a generi endemici della flora sudafricana, i suoi Prodromus plantarum capensium (1794-1800) e Flora capensis (1807-1823) furono per decenni i testi di riferimento per la conoscenza della flora sudafricana e gli guadagnarono il soprannome di "Padre della botanica sudafricana".  Il "Linneo giapponese" Ma era tempo per Thunberg di lasciare il Sud Africa per la sua vera meta. Ora parlava fluentemente l'olandese (se ne servì anche per alcuni scritti scientifici) e degli olandesi aveva assunto anche le abitudini (ma non quella del fumo, che detestava). Nel marzo del 1775 si imbarcò come medico di bordo sulla Loo, diretta a Batavia, dove riuscì a farsi assegnare il posto di medico residente dello stabilimento commerciale di Dejima. Vi arrivò ad agosto a bordo della nave Stavenisse e vi rimase per circa quindici mesi (fino al novembre 1776). Agli europei era vietato lasciare l'isola (collegata alla terraferma da un ponticello strettamente sorvegliato e chiuso da una grata); così, all'inizio l'avventura giapponese di Thunberg fu estremamente frustrante. Le uniche piante che riuscì ad osservare erano quelle utilizzate come foraggio per il bestiame che gli olandesi tenevano sull'isola. Tuttavia, grazie al suo carattere aperto e allegro, riuscì a stringere amicizia con alcuni degli interpreti giapponesi - alcuni dei quali erano medici o naturalisti - che gli procurarono esemplari in cambio di informazioni mediche e scientifiche. Grazie ai suoi contatti giapponesi nel febbraio 1776 ottenne finalmente dal governatore di Nagasaki l'autorizzazione ad esplorare i dintorni, anche se sempre accompagnato da uno stuolo di interpreti, guardie e domestici, a cui era obbligato ad offrire il tè a proprie spese in ogni punto di sosta. Ogni anno, in occasione del Capodanno giapponese, il capo dell'agenzia olandese si recava ad Edo (l'odierna Tokio) per rendere omaggio allo Shogun. Nel 1776 della delegazione fa parte anche Thunberg; durante il lungo e lento viaggio di circa 1000 km - gli ospiti europei sono trasportati in lussuose portantine - può così osservare gli usi e i costumi del paese e raccogliere numerosi esemplari botanici; unico rammarico: i contadini giapponesi sono coltivatori così solerti che difficilmente nei campi si trovano erbacce. Dopo aver toccato Osaka e Miyako (oggi Kyoto), ad aprile la delegazione arriva a Edo. Qui Thunberg è stato preceduto dalla sua fama di sapiente medico e incontra, tra gli altri, il medico personale dello Shogun, Katsuragawa Hoshu, che, insieme all'amico Nakagawa Jun-an, sta traducendo in giapponese un importante testo di anatomia; sono tre settimane di intensissimo colloqui scientifici su diversi argomenti, nel corso dei quali, tra l'altro, Thunberg avrà modo di introdurre in Giappone il mercurio per curare la sifilide. I due medici giapponesi - con i quali Thunberg rimarrà in contatto anche quando sarà rientrato in Svezia - gli procurano piante e lo informano sui loro nomi giapponesi; a sua volta, lo svedese riferisce i nomi olandesi e latini. Dopo essere stato ricevuto dallo Shogun il 18 maggio, il gruppo riparte per Nagasaki; a Osaka Thunberg trova un piccolo giardino botanico dove acquista diverse piante che poi spedirà a Amsterdam in tinozze piene di terra. Il 29 giugno è di nuovo a Deshima; durante l'estate, Thunberg, oltre a riordinare le collezioni raccolte durante il viaggio, ha modo di compiere diverse escursioni nell'area di Nagasaki. Il risultato del suo soggiorno giapponese sarà Flora japonica (1784), la prima descrizione sistematica della flora e della fauna del Giappone, un testo innovativo e influente, che gli guadagnerà il soprannome di "Linneo giapponese". Curiosamente, molte delle piante battezzate da Thunberg con il nome specifico japonica, non sono autoctone giapponesi, ma piuttosto piante orticole di origine cinese importate da secoli nel paese del Sol Levante. Altri approfondimenti su questa grande figura di naturalista nella biografia.  Thunbergia, esuberanza tropicale Onorato in vita con numerosi riconoscimenti, Thunberg ha lasciato una profonda impronta nella nomenclatura botanica. Scopritore di dozzine di nuovi generi, ha tenuto a battesimo piante oggi comuni nei giardini come Deutzia, Weigela, Aucuba, Nandina, Skimmia. Sono almeno 250 le specie vegetali (e alcune animali) che lo onorano con l'epiteto thunbergii, thunbergianus. Si deve a un altro botanico svedese, Anders Johan Retzius, la dedica del genere Thunbergia (1780), la cui specie tipo è T. capensis, una delle numerose piante raccolte da Thunberg nella regione del Capo. Questo genere della famiglia Acanthaceae comprende un centinaio di specie di erbacee, arbusti, ma soprattutto rampicanti, originarie dell'Africa meridionale, del Madagascar e dell'Asia tropicale. Vigorose, di rapida crescita e molto decorative per l'esuberante fioritura, molte sono popolari piante da giardino, soprattutto dove il clima mite ne consente la coltivazione all'aperto. La più diffusa è probabilmente T. alata, nota con il curioso nome "Susanna dagli occhi neri" per i fiori dalle corolle aranciate o gialle con un caratteristico centro dal colore scuro. Di rapida crescita, è spesso coltivata come annuale anche in climi più rigidi. Di frequente coltivazione è anche T. grandiflora, nativa dell'India tropicale, una vigorosa rampicante sempreverde con grandi fiori blu-violetto. Per approfondimenti su altre specie si rimanda alla scheda. Viaggiatore di lungo corso, Anders Sparrman a diciassette anni va in Cina, a ventiquattro in Sud Africa da dove parte per il giro del mondo con James Cook. Sopravvissuto ai ghiacci antartici e alle frecce avvelenate polinesiane, torna in Africa, diventa un'autorità nel campo dei mammiferi africani e dà un contributo determinante all'abolizione della tratta degli schiavi. A ricordarlo la bella e "sensibile" Sparrmannia. 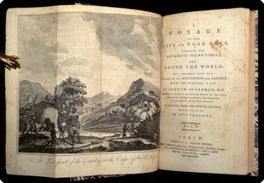 In Cina e in Sud Africa con la SOIC Di tutti gli apostoli di Linneo, Anders Sparrman è stato quello che ha viaggiato di più: ben cinque viaggi, toccando tutti e cinque i continenti (anzi tutti e sei, se contiamo anche l'Antartide). Approdato a Uppsala addirittura a otto anni, nel 1765, ad appena 17 anni, si imbarca come assistente medico su una delle navi della Compagnia svedese delle Indie Orientali (SOIC) dirette a Canton, quinto apostolo a percorrere quella rotta. Il viaggio cinese è poco più di un apprendistato sul campo per il giovane Anders, che al suo rientro ad Uppsala riprende con decisione gli studi medici e sostiene gli esami teorici nel 1770. Tuttavia non arriva alla laurea, perché all'inizio del 1772 riparte, questa volta per il Sud Africa. Il suo comandante nel viaggio in Cina, il capitano Carl Gustav Ekeberg, è riuscito a convincere le autorità olandesi a permettere a un naturalista svedese di visitare la colonia del Capo, uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del pianeta. La SOIC tuttavia si limita ad offrirgli un passaggio gratuito; al Capo per mantenersi dovrà lavorare come precettore dei numerosi figli del residente olandese Johann Friederick Kirsten, dedicando alle ricerche naturalistiche l'eventuale tempo libero. Arrivato a Cape Town nell'aprile 1772, Sparrman ha la gradita sorpresa di incontrare un altro allievo di Linneo, Carl Peter Thunberg. Ma dopo pochi giorni entusiasmanti passati a esplorare insieme quell'angolo di Paradiso, deve raggiungere il suo datore di lavoro. Mentre Thunberg, ufficialmente medico al servizio della Compagnia olandese delle Indie, esplora liberamente il paese, lui deve accontentarsi di brevi scappate rubate ai momenti di riposo. A tanto entusiasmo, subentra la delusione. In un'accorata lettera al maestro, si paragonerà a qualcuno che assiste da lontano a un ricco banchetto: gli arriva lo stuzzicante odorino delle vivande, ma a lui toccano solo le ossa. Per altro sembra proprio che la colonia del Capo si stia trasformando nel terreno di gioco preferito dei botanici, continua con amara ironia: è pieno di cercatori di piante e, ad avere i soldi per pagare, puoi procurarti tutte quelle rarità che lui non è destinato neppure a vedere. E' persino arrivato un inglese (lo conosciamo bene: è Francis Masson, il cacciatore di piante spedito da Banks)! Insomma, una situazione davvero frustrante.  Il secondo viaggio di Cook Ma prima di continuare con le avventure di Sparrman, facciamo un passo indietro e un salto in Inghilterra, dove Cook stava preparando il suo secondo viaggio. Il dubbio sull'esistenza di un continente australe, l'ipotetica Terra australis incognita, non era stato risolto dal primo pur fortunato viaggio; ecco dunque che l'ammiragliato varò immediatamente una seconda spedizione, cui avrebbero partecipato due navi: la Resolution e l'Adventure. L'équipe scientifica, dopo la defezione di Banks, fu capeggiata da un botanico tedesco, Johann Reinhold Forster, accompagnato dal figlio Georg; c'era inoltre un astronomo, William Wales, e un pittore, William Hodges. Su richiesta di Banks, fu imbarcato anche il giardiniere di Kew Francis Masson, che sarebbe sbarcato al Capo per esplorare la flora del Sud Africa. Invece di circumnavigare il globo da est a ovest, come nel primo viaggio, questa volta la rotta si sarebbe mossa in senso contrario, esplorando l'Atlantico e il Pacifico meridionale alla ricerca sistematica dello sfuggente mitico continente australe. Partito da Plymouth nel maggio 1772, Cook si diresse verso sud, toccando Madeira e le isole di Capo Verde. Il 30 ottobre giunse a Cape Town, dove venne sbarcato Masson. Durante la sosta sudafricana, Johann Reinhold Forster conobbe il nostro Anders Sparrman e gli propose di unirsi alla spedizione. Dopo una notte insonne, passata a soppesare i pro e i contro, Sparrman accettò. La Resolution e l'Adventure salpano il 22 novembre 1772 dirigendosi verso sud, nell'area dove il navigatore francese Bouvet pretendeva di aver avvistato terre emerse. Senza toccare terra per 124 giorni, le due navi esplorano l'Atlantico e il Pacifico meridionali, tra venti gelidi, nebbie antartiche e iceberg, passano per due volte il circolo polare antartico e dimostrano definitivamente che non esiste alcun continente australe sconosciuto. Balene, foche, pinguini... ma nessuna pianta per fare felici i nostri botanici. Dopo essere state separate dalla nebbia, nel maggio 1773 l'Adventure e la Resolution si ricongiungono in Nuova Zelanda. A ottobre, dopo aver esplorato Tonga, una tempesta separa di nuovo le due navi; Fourneaux, il comandante dell'Adventure, decide di rientrare in Inghilterra. Invece Cook, approfittando dell'estate australe, punta ancora una volta a sud, passa per la terza volta il circolo polare antartico, finché non viene bloccato dalla banchisa; ha comunque toccato il punto più a sud mai raggiunto (71° 10'). Anzi, secondo un aneddoto, proprio a Sparmann spetterebbe il record di essere l'uomo giunto più a sud, perché in quel momento si trovava sulla poppa della nave. Non potendo proseguire oltre, Cook ritorna a nord, esplorando palmo a palmo il Pacifico, in un grande giro che tocca Tonga, l'isola di Pasqua, l'isola Norfolk, la Nuova Caledonia, Vanuatu, quindi ancora la Nuova Zelanda. Nel novembre 1774 inizia il viaggio di ritorno; toccata la Terra del Fuoco e doppiato Capo Horn, dopo un'ulteriore puntata a sud che frutta la scoperta delle desolate Georgia del Sud e Sandwich del Sud, finalmente il 21 marzo si approda a Table Bay, la baia del Capo. Per Sparrman è ora di sbarcare. Dopo una sosta di qualche settimana, gli altri riprendono il viaggio e saranno a casa il 30 luglio. Appena sbarcato, Sparrman si affretta a scrivere a Linneo (a differenza di Solander, era un corrispondente attivo e considerava un "parricidio" trascurare le lettere al maestro). Il tono non è entusiastico, anzi... Dopo aver affrontato un viaggio durissimo (in due anni e mezzo, i periodi trascorsi a terra sommano a meno di sei mesi), il freddo polare, i rapporti ostili con gli abitanti di molte isole (sia lui sia Georg Forster hanno rischiato lo pelle), la fame e le privazioni (al loro sbarco a Cape Town sembravano un equipaggio di fantasmi), il bottino che può vantare non si può certo paragonare a quello di Solander e Banks. Quei due hanno avito la fortuna di mettere le mani sulla cassa del tesoro, hanno scoperto piante a migliaia, mentre lui ha dovuto accontentarsi di scoprirne a centinaia, in tutte quelle isole, e a ben caro prezzo: si erborizzava mentre intorno volavano pietre, lance, randelli e frecce avvelenate. Le lamentele continuano: tutti gli altri si sono laureati, grazie al nome del loro maestro stanno facendo delle belle carriere, solo lui a causa dei tanti viaggi è rimasto senza laurea e senza prospettive. Spera di rifarsi al suo ritorno, tra un anno, quando lascerà definitivamente l'Africa. 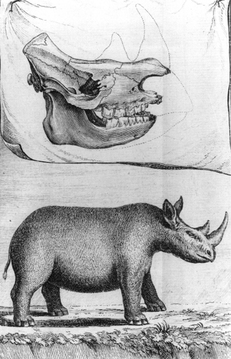 Alla scoperta della fauna africana In effetti i risultati scientifici più importanti devono ancora arrivare. D'altra parte, benché importante, il suo ruolo nella seconda spedizione di Cook era stato quello di un collaboratore - ancora oggi, è difficile distinguere i suoi contributi da quelli dei due Forster. Lavorando per quattro mesi come medico a Città del Capo e arrotondando i proventi con qualche non meglio specificata speculazione commerciale, Sparrman riesce a mettere insieme quanto basta per finanziarsi una spedizione nell'interno della colonia del Capo. Per quasi un anno (dal luglio 1775 all'aprile 1776), accompagnato da Daniel Ferdinand Immelmann (che già aveva fatto da guida a Thunberg) e da portatori khoi-khoi, esplorò l'area orientale della colonia del Capo, spingendosi fino al Great Fish River e ai confini della colonia. Importanti furono soprattutto le scoperte zoologiche: tra le molte segnalazioni, che fecero di lui un'autorità nel campo dei mammiferi africani, fu il primo a descrivere il rinoceronte africano e il bufalo del Capo. Il viaggio confermò anche il giudizio negativo di Sparrman sull'atteggiamento degli europei verso i neri e il netto rifiuto dello schiavismo, che indagò con occhio critico e spirito umanitario. Rientrò a Città del Capo appena in tempo per imbarcarsi sulla nave Stockholms Slott. Giunto a Stoccolma a luglio 1776, scoprì che la fama lo aveva preceduto, grazie ai suoi compagni di viaggio rientrati a Londra già da un anno, L'Università di Uppsala gli aveva anche attribuito, honoris causa, la tanto sospirata laurea. Per un breve periodo, in Svezia fu l'uomo del giorno. Fu ammesso all'Accademia delle Scienze, delle cui collezioni naturalistiche fu nominato curatore (incarico che mantenne per vent'anni, dal 1777 al 1798) e qualche anno più tardi ottenne una cattedra universitaria. Nel 1787 lo attendeva un ultimo viaggio: fu nominato membro della commissione che doveva esplorare il Senegal alla ricerca di un luogo adatto a una colonia svedese. La spedizione fu un fallimento, ma durante il viaggio di ritorno Sparrman e il suo compagno Wadström, di passaggio a Londra, resero un'importante testimonianza contro la tratta degli schiavi che ebbe grande influenza nell'orientare in senso antischiavista l'opinione pubblica britannica. Personalità inquieta, divisa tra l'entusiasmo illuminista per le scienze e tensioni preromantiche, nell'ultima parte della vita Sparrman, pur mantenendo un certo prestigio nell'ambiente scientifico svedese, si vide messo in secondo piano da personalità più forti, in particolare da Thunberg. Altre notizie nella biografia. Autore solerte e prolifico, egli raccontò i suoi viaggi nell'opera in tre volumi Resa till Goda Hopps-Udden, södra Polkretsen och omkring Jordklotet, samt Till Hottentott- och Caffer-Landen Åren 1772-1776 ("Viaggio dal Capo di Buona Speranza, attraverso il circolo polare Antartico e attorno al mondo, ma soprattutto nel paese degli Ottentotti e dei Caffri, dall'anno 1772 al 1776") che fu tradotto in diverse lingue europee e (nonostante qualche lungaggine) divenne un piccolo bestseller. Recentemente, lo scrittore svedese Per Wästberg gli ha dedicato un romanzo, di cui è disponibile la traduzione inglese (The Journey of Anders Sparrman, GRANTA 2010).  La sensibile Sparrmannia Benché con gli anni gli interessi di Sparrman si spostassero sempre più dalla botanica alla zoologia e dalla zoologia agli esseri umani (terminerà la sua carriera come medico dei poveri), nei suoi viaggi raccolse e classificò un importante erbario, inviò a Linneo molti esemplari e concorse alla conoscenza della flora del Capo, anche se il suo contributo è molto meno noto di quello di Thunberg. Tra le piante che contribuì a far conoscere e ad introdurre in Europa c'è anche quella che porta il suo nome, Sparrmannia africana. Sparrmannia è un piccolo genere di arbusti o piccoli alberi nativi dell'Africa tropicale, del Sud Africa e del Madagascar (famiglia Tiliaceae, ora inclusa in Malvaceae), creato dal figlio di Linneo nel 1792. La specie più nota è proprio Sparrmannia africana, un grande arbusto che cresce ai margini delle foreste, nei burroni e lungo i fiumi dal Capo occidentale a Port Elisabeth ed è comune nei distretti di George, Knysna, Uniondale e Humansdsorp (gli ultimi due comprendono alcune delle aree esplorate da Sparrman). I vistosi stami dei fiori dai petali bianchi, raccolti in ampie ombrelle, hanno una particolarità: sono sensibili al contatto. Quando un insetto tocca il fiore la massa degli stami si distende, allontanandosi dallo stigma, presumibilmente per favorire l'impollinazione. La bellezza dei fiori e delle foglie a forma di cuore, nonché la relativa facilità di coltivazione, fin dalla fine del Settecento ne hanno favorito l'introduzione prima nelle serre poi nei giardini delle zone miti. Grazie ai giardinieri inglesi nell'Ottocento la pianta ha trovato una certa diffusione nei giardini mediterranei e in altre aree non soggette al gelo, ad esempio a Madeira, ma anche in Costa Azzurra e in Riviera. Qualche notizia in più nella scheda. All'appuntamento con Venere del giugno 1769, oltre a Falk si presenta un altro apostolo di Linneo, il più famoso di tutti: Daniel Solander. L'osservazione del transito nell'esotica Tahiti è solo la prima tappa di uno dei viaggi naturalistici più famosi di tutti i tempi, il primo viaggio di Cook, con la scoperta dell'Australia e della sua natura stupefacente. Ma questa è anche la storia di un grande sodalizio intellettuale e di un'amicizia profonda, quella tra Daniel Solander e Joseph Banks.  Signori a bordo! Si parte per Tahiti Alla fine dell'agosto 1768, mentre Falk lasciava Pietroburgo per affrontare il freddo della Siberia e il sole nero della depressione, il transito di Venere metteva in movimento un altro allievo di Linneo, che per osservarlo sarebbe andato letteralmente in capo al mondo. Era Daniel Solander, il più famoso di tutti, uno dei naturalisti che a bordo dell'Endeavour fu tra i protagonisti di una delle pagine più epiche della storia della scienza: il primo viaggio di Cook e la scoperta dell'Australia. Solander era il delfino di Linneo, che contava di farne il proprio successore all'Università di Uppsala (preferendolo al figlio, il mediocre Carl il giovane) e suo genero (era fidanzato con sua figlia maggiore, Lisa Stina). Nel 1760 il maestro lo aveva spedito a Londra con il delicato incarico di diffondere il sistema sessuale linneano negli ambienti scientifici britannici che rimanevano fedeli ai sistemi di Ray e Tournefort. Il giovane Daniel assolse fin troppo bene il compito, entrando nelle grazie delle persone che contavano nella scienza londinese; ma soprattutto scoprì un ambiente molto più fertile e libero della grigia, luterana e assolutistica Svezia. Mentre Linneo preparava per lui un carriera di professore universitario, cercandogli un ingaggio (guarda caso!) all'Accademia di Pietroburgo, Solander faceva orecchie da mercante e con l'aiuto degli amici inglesi cercò un incarico che gli permettesse di rimanere a Londra. Lo trovò al British Museum che gli chiese di catalogare le farraginose collezioni di storia naturale. In questo compito Solander si dimostrò brillantissimo, divenendo un pioniere della museologia; inventò persino un particolare tipo di scatola da archivio, che in inglese porta ancora il suo nome, Solander box. Fu proprio al British Museum che incontrò un giovane ricchissimo, appassionato di storia naturale, destinato a diventare il suo migliore amico, il suo compagno di avventura e il suo protettore: Joseph Banks. Nel febbraio del 1768, la Royal Society (la più importante istituzione scientifica europea) chiede al re Giorgio III di finanziare una spedizione scientifica nell'Oceano Pacifico allo scopo di osservare nelle migliori condizioni il transito di Venere; il re accetta e la Royal Navy ne approfitta per unire allo scopo scientifico un secondo obiettivo, tenuto segreto: esplorare il Pacifico meridionale alla caccia della Terra australis incognita, l'ipotetico continente che avrebbe dovuto riequilibrare la distribuzione delle masse terrestri. Gli scopi dell'Ammiragliato britannico, com'è ovvio, sono più strategici e militari che scientifici; quindi, esattamente come nella contemporanea spedizione dell'Accademia russa, ricerca scientifica, prestigio internazionale e interessi imperialistici vanno di pari passo. Ma il fatto che a prendere l'iniziativa questa volta siano gli scienziati (e non un monarca più o meno illuminato) la dice lunga sulla distanza che separa la monarchia parlamentare inglese e la stratificata società britannica dagli altri stati europei, ancora immersi nell'ancien régime. Eccoli dunque, sul ponte della HMS Endevour, i protagonisti della grande avventura: il comandante James Cook, appena promosso tenente di vascello; settantatré marinai; dodici fanti di marina; l'astronomo Charles Green; lo scienziato dilettante Joseph Banks, nominato botanico ufficiale senza stipendio (a lui interessa la gloria, personale e della nazione), assistito da una piccola équipe di sette persone pagata di tasca propria composta da Daniel Solander, dal segretario finlandese Herman Spöring, dai disegnatori Sydney Parkinson e Alexander Buchan e da quattro servitori. Non mancano due levrieri, caso mai nelle pause ci fosse l'occasione di praticare lo sport della caccia! Quando salpano da Plymouth, è il 26 agosto 1768; quando getteranno nuovamente l'ancora in acque inglesi, dopo aver circumnavigato il globo e aver scoperto un nuovo continente, saranno trascorsi quasi esattamente tre anni (12 luglio 1771).  Alla scoperta della flora del quinto continente La prima tappa del viaggio è Madeira: Banks, Solander e la loro squadra ne approfittano per esplorare l'isola; in sei giorni di permanenza raccolgono circa 700 esemplari. Il viaggio prosegue alla volta del Brasile; a Rio, mentre la nave viene caricata di acqua e provviste, il viceré rifiuta lo sbarco ai botanici, sospettandoli di spionaggio. Ma gli scienziati non si arrendono: oltre a corrompere i fornitori perché insinuino qualche bella pianta tra gli ortaggi, di notte lasciano più volte la nave alla chetichella per andare ad erborizzare. Da Rio si prosegue lungo la costa americana, raggiungendo il Pacifico dopo aver doppiato il tempestoso Capo Horn. Nonostante qualche perplessità, Cook si fa convincere dai "gentiluomini passeggeri" a sbarcare nella Terra del fuoco per un'escursione botanica; quella che all'inizio si presenta come una piacevole gita, a causa del mutevole clima patagonico si trasforma in una tragedia: Solander rischia di morire di ipotermia e due servitori di Banks perdono la vita. Ma è ora fare vela per Tahiti (scoperta giusto un anno prima da un altro navigatore inglese, Samuel Wallis), il luogo scelto per le osservazioni astronomiche del transito di Venere. Dopo una lunga navigazione senza mai avvistare terra, la meta è raggiunta a metà aprile 1769. Nell'attesa dell'evento, i naturalisti esplorano estensivamente la natura dell'isola e, nelle pause, si rilassano con le amichevoli ragazze tahitiane. Venere si presenta all'appuntamento il 3 giugno, in una giornata serena che permette a Green, Cook, Solander di fare osservazioni e misurazioni indipendenti. L'unico neo del felice soggiorno tahitiano è la morte di Buchan, in seguito ad un attacco epilettico. Terminato il compito ufficiale, Cook apre finalmente il plico sigillato che contiene le indicazioni segrete dell'Ammiragliato: cercare l'ipotetico continente australe. Con a bordo un tahitiano di nome Tapua che funge da guida, l'Endeavour tocca le isole della Società (Cook le chiamò così non tanto in onore della Royal Society quanto perché sono molto vicine le une alle altre), quindi la Nuova Zelanda. Dopo aver circumnavigato l'isola (il bottino botanico è modesto perché poche sono le occasioni di sbarcare), Cook intende dirigersi a sud per cercare di ritrovare la Tasmania (toccata più di un secolo prima dall'olandese Tasman), ma a causa delle correnti è costretto a tenere una rotta più settentrionale. E' così che il 20 aprile 1770 viene avvistata per la prima volta la costa occidentale dell'Australia. L'Endeavour prosegue verso nord lungo la costa, finché trova un'insenatura adatta all'ormeggio. Banks, Solander, Spöring e i disegnatori possono sbarcare e iniziare l'esplorazione. L'episodio è notissimo: una flora e una fauna ricchissime e sconosciute si offrono agli stupefatti botanici, favoriti anche dalla stagione (è l'autunno australe, dopo la stagione delle piogge). I risultati sono così straordinari che Cook decide di ribattezzare il luogo dell'approdo (che inizialmente aveva battezzato Singray Harbour, baia delle razze) Botany Bay, baia della botanica. Per otto giorni Solander e Banks esplorano liberamente la zona, dalla riva paludosa alla foresta di eucalipti dell'interno, mettendo insieme un bottino così ricco che lo stesso Banks dispera di riuscire mai a classificare tutti quegli esemplari mai visti. Con la nave stipata di collezioni, i fortunati esploratori riprendono il viaggio, sempre facendo rotta verso nord, mantenendosi in vista della costa. Senza saperlo, si infilano nel labirinto (l'espressione è di Cook, che lo definisce "Insane labyrinth") della Grande Barriera Corallina e il'11 giugno sfiorano il disastro: la nave rimane gravemente danneggiata dall'impatto con le rocce coralline. Dopo una giornata di passione, riescono a raggiungere terra; i danni sono così gravi che sarà necessaria una sosta di due mesi per effettuare le riparazioni. Ma non tutto il male viene per nuocere: per i naturalisti è un'altra grande occasione per incrementare le raccolte. Riparata la nave, con una lenta navigazione tra gli isolotti e gli scogli della Grande Barriera, raggiungono il punto estremo, Capo York, dal quale fanno vela per l'isola di Giava. Dopo una sosta nell'isola di Savu (dove Cook sequestra libri, giornali e diari di bordo e fa giurare a tutti di mantenere segreta l'impresa), il 10 ottobre raggiungono Batavia, la capitale delle Indie Olandesi, dove la nave potrà essere messa in condizioni di affrontare il viaggio di ritorno. Cook è orgoglioso di non aver perso neppure un uomo a causa dello scorbuto che nei lunghi viaggi per mare spesso dimezzava l'equipaggio: anche se la causa del morbo, ovvero la carenza di vitamina C, non era ancora nota, è riuscito a prevenirlo imponendo ai suoi uomini e ai passeggeri una dieta variata con agrumi, crauti e verdure crude. Tuttavia proprio la sosta a Batavia è fatale: le condizioni igieniche sono pessime e molti uomini si ammalano di dissenteria e malaria. Muore un terzo dell'equipaggio, tra gli altri - alcuni a Batavia, altri durante il viaggio verso il Capo di Buona Speranza -Spöring, l'astronomo Green, il disegnatore Parkinson, il secondo ufficiale Hicks. Anche Solander e Banks sono in punto di morte, tanto che quando raggiungono il Capo non potranno approfittare più di tanto dei tesori naturali di quel secondo paradiso dei botanici. Ma il viaggio volge al termine: toccata sant'Elena, il 10 luglio 1771 avvistano le sospirate coste inglesi. Cook e Banks, ma anche il nostro Solander, sono gli eroi del giorno; per limitarci alla botanica le loro collezioni comprendono 30.300 esemplari di 3.607 specie, di cui 1.400 sconosciute, 110 nuovi generi. Si aggiungano uccelli, mammiferi, molluschi, pesci e altri animali marini.  All'ombra di Banks Solander non tornerà mai più in Svezia. Dopo la fortunata impresa e la ventilata partecipazione al secondo viaggio di Cook (vedremo nel prossimo post, dedicato a Banks, le ragioni per le quali i due rimasero a terra), rimane legato all'amico e protettore. Nell'estate del 1772 va con lui nelle Ebridi e in Islanda (quasi una gita, per chi aveva appena circumnavigato il mondo). In seguito, pur mantenendo l'incarico al British Museum, in qualità di bibliotecario di Banks si occupa essenzialmente di ordinare e catalogare l'immensa collezione raccolta durante il grande viaggio. In particolare sono di sua mano i testi che, accompagnando 743 incisioni tratte dai disegni di Parkinson, dovrebbero formare il grande Banks Florilegium. Purtroppo, l'opera non vedrà mai la luce: nel 1782, a 49 anni, Solander è improvvisamente stroncato da un'emorragia celebrale. Banks, preso da mille incarichi, nonostante il rimpianto per l'amico, non provvederà alla pubblicazione. Ciò nuocerà alla fama postuma di Solander che, soprattutto in Inghilterra, è stato a volte descritto come uno scienziato brillante, ma pigro, che si era fatto affascinare dalla dolce vita londinese fino a trascurare i suoi doveri scientifici. Hooker si spinse a definirlo un parassita che viveva alle spalle di Banks. Il lavoro di catalogazione per il British Museum e molti privati, la mole dei manoscritti, la stessa influenza scientifica sull'amico (che, forse, se non lo avesse mai incontrato, non sarebbe diventato il grande patron della botanica britannica) smentiscono questa interpretazione. Qualche approfondimento nella biografia. A celebrare Solander non mancano comunque i riconoscimenti postumi: il capo Solander (la punta più meridionale di Botany Bay), l'arcipelago delle Solander a sud della Nuova Zelanda, il parco Solander nella città natale Piteå (che ospita istituti scientifici e aziende a energia pulita); molte piante e animali con nome specifico solandri, solandranus, e ovviamente un genere Solandra. Anche qui c'è una piccola storia da raccontare. Il nome è stato assegnato ben tre volte. Non sono validi i nomi attribuiti da Linneo (Solandra capensis, attualmente Centella capensis) e Murray (Solandra lobata, oggi Hibiscus lobatus): in entrambi i casi, si tratta di specie di generi già noti, non di nuovi generi; ecco perché ad essere accettata è l'attribuzione di Swartz, che nel 1787 descrisse Solandra grandiflora. Anche Olaf Schwartz era svedese; nel 1787, al ritorno da una spedizione in Nord America e nelle Antille, soggiornò a Londra, dove conobbe Banks ed ebbe modo di consultare le collezioni di Banks e i manoscritti di Solander. La dedica di una delle piante da lui raccolte in America a Solander fu sia un atto d'omaggio alla sapienza botanica del suo conterraneo scomparso, sia un ringraziamento per la gentilezza e la generosità di Banks.  Le pericolose trombe d'oro del dio del vento Il mio primo incontro con la spettacolare Solandra maxima è avvenuto nelle Canarie, dove è stata introdotta nei parchi e nei giardini con tanto successo da naturalizzarsi in alcuni siti favorevoli. Mi piace pensare che le sgargianti trombe gialle di questa esuberante sarmentosa siano un omaggio fatto su misura per Solander; uomo amato da tutti, modesto e cordiale, vivace e pieno di spirito, definito dai contemporanei conversatore filosofo per la capacità di parlare in modo brillante di ogni argomento, dal più profondo al più frivolo, aveva una piccola debolezza: la passione per i panciotti un po' vistosi. Questa pianta, che probabilmente non ha mai visto, sicuramente gli sarebbe piaciuta. Il genere Solandra, appartenente alla famiglia Solanaceae, comprende una decina di specie di arbustive e sarmentose rampicanti originarie delle zone tropicali dell'America. Solandra maxima, nativa del Messico, era ben nota ai popoli precolombiani che con il nome di kieri o kieli la veneravano come pianta magica, utilizzata come potente droga per indurre viaggi sciamanici, grazie ai suoi effetti allucinogeni. Secondo gli indios huicholes era l'incarnazione del dio del vento; chi dorme accanto ai suoi fiori, sarà trasportato dalla sua fragranza in un regno di illuminazione mistica. In effetti, stretta parente di Brugmansia e Datura, contiene diversi alcaloidi, che la rendono un allucinogeno potente ma alquanto pericoloso. Meno rischioso dunque, là dove il clima lo permette, coltivare questa pianta per i suoi fiori spettacolari, grandi trombe dorate con strisce porpora che possono raggiungere il diametro di venti centimetri; con le lucide foglie lussureggianti, trasformerà qualsiasi pergola in un angolo dei Tropici. Altri approfondimenti nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed