|
Svoltasi tra il 1803 e il 1806, la prima circumnavigazione russa mancò totalmente i troppo ambiziosi obiettivi politici e raggiunse solo parzialmente quelli economici, ma segnò una pietra miliare nella conoscenza del Pacifico settentrionale. Fu una scuola di navigazione alla quale si formò un'intera generazione di navigatori russi, tra i quali Otto von Kotzebue, a sua volta protagonista di due giri del mondo, e Fabian von Bellingshausen, lo scopritore del continente antartico. Oltre ai progressi nell'idrografia e nella cartografia, notevoli furono gli apporti della sua équipe scientifica a campi che vanno dall'astronomia, all'etnografia, alla biologia marina. Mentre l'astronomo e geografo svizzero Johann Kaspar Horner collaborava con gli ufficiali in rilevazioni e misurazioni, i medici e naturalisti tedeschi Wilhelm Gottilieb Tilesius e Georg Heinrich Langsdorff approfittarono di ogni occasione per raccogliere e studiare gli animali e le piante marine, e più limitatamente, terrestri. A Tilesius, che per una serie di circostanze divenne anche l'illustratore ufficiale della spedizione, questa avventura guadagnò un titolo nobiliare e l'ingresso nella nomenclatura botanica, con la dedica del genere Tilesia. 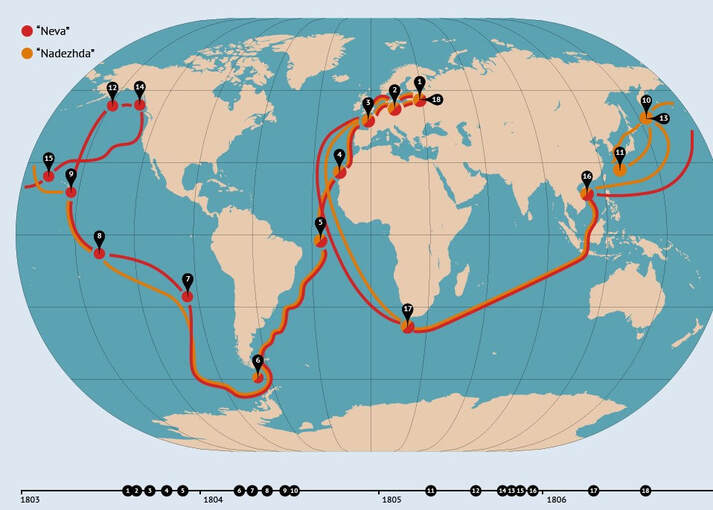 Nei mari del Sud: 1803-1804 La prima circumnavigazione russa coinvolse due navi, Nadežda e Neva, 129 persone tra ufficiali, marinai, diplomatici, agenti della Compagnia russo-americana e scienziati, e durò quasi esattamente 3 anni (agosto 1803 - agosto/settembre 1806). Per gli standard dell’epoca, fu caratterizzata da una navigazione senza troppi intoppi, nonostante qualche incidente (incluso un incagliamento nella barriera corallina). Al di là del valore simbolico (per la prima volta navi russe si spingevano nell’Oceano aperto, superavano la linea dell’equatore e tornavano a casa dopo aver fatto il giro del mondo) portò a una migliore conoscenza delle Marchesi e delle Hawaii e alla mappatura di diversi settori del Pacifico settentrionale; fu un’esperienza straordinaria per gli ufficiali che vi presero parte, alcuni dei quali sarebbero stati protagonisti di altre spedizioni, come Otto von Kotzebue (che comandò due circumnavigazioni tra il 1823 e il 1826) e Fabian von Bellingshausen, lo scopritore dell’Antartide. A condizionare negativamente la spedizione fu piuttosto il sovrapporsi di obiettivi scientifici, economici e politici e soprattutto la decisione di inviare in Giappone una missione diplomatica, capeggiata in veste di ambasciatore dal conte Rezanov, che era anche uno dei dirigenti della Compagnia russo-americana. Ne risultarono conflitti continui tra Adam von Krusenstern, il comandante della spedizione, e lo stesso Rezanov, che sulla base di istruzioni ambigue credette di aver autorità non solo sul corpo diplomatico, ma sull’intera spedizione. Nella rivalità tra i due uomini si riflettevano intenti e personalità opposte: Krusenstern era un tedesco del Baltico, un luterano con un forte senso del dovere, un ufficiale educato nella Royal Navy, ammiratore di Cook, per il quale prima di tutto venivano i suoi uomini e il successo della missione di esplorazione; Rezanov era un nobile russo, un cortigiano e un imprenditore dalla morale elastica, per il quale contavano soprattutto il potere e la ricchezza. La Nadežda e la Neva, comandate rispettivamente da Krusenstern e dal suo secondo Lisjanskij, salparono da Kronstadt il 7 agosto 1803, facendo rotta per Copenhagen dove si imbarcò la piccola équipe scientifica, formata dall'astronomo e geografo svizzero Johann Kaspar Horner e dai medici e naturalisti tedeschi Wilhelm Gottilieb Tilesius e Georg Heinrich Langsdorff. A bordo c’erano anche un botanico russo, Brinkin o Brinken, che però fu emarginato dagli studiosi teutonici, e il disegnatore Stepan Kurljancev. Dopo una seconda sosta a Falmouth e un breve scalo a Tenerife, le due navi si diressero alla volta del Brasile; il 26 novembre venne superata la linea dell'equatore, la prima volta nella storia della marina russa. Si festeggiò con salve di cannone, fuochi d'artificio e bevute di vodka, offerta dal quartiermastro nei panni di Nettuno. Il 21 dicembre le navi ancorarono di fronte all'isola di Santa Catarina in Brasile, dove si trattennero circa un mese e mezzo, per sostituire alcuni alberi e carenare la Neva. Horner fin dal giorno del suo arrivo si trasferì nell'isolotto di Atomiris per allestire un osservatorio portatile. Langsdorff, che ancora non sapeva di aver incontrato il suo destino (come scopriremo in un prossimo post, sarà un grande esploratore della natura brasiliana), osservò: "la ricchezza e la varietà di animali e piante potrebbe tenere occupati centinaia di naturalisti per anni". Scoppiò anche il primo grave conflitto di autorità tra Krusenstern e Rezanov, provocato da un curioso personaggio, il conte Fedor Tolstoj, che passava il tempo a giocare d’azzardo, fare scherzi di dubbio gusto e seminare zizzania. Ebbe anche un diverbio con l’artista Kurljancev, che insultò il comandante e di conseguenza fu escluso dalla mensa degli ufficiali e degli scienziati. Le navi russe lasciarono Santa Catarina il 2 febbraio 1804. Le attendeva il difficile passaggio di Capo Horn, che venne doppiato il 21 marzo. Poco dopo, a causa della forte nebbia, i due vascelli persero il contatto visivo. La Neva fece rotta per l'Isola di Pasqua, raggiunta il 16 aprile, mentre Krusenstern preferì puntare direttamente sull'isola di Nuku Hiva nell’arcipelago delle Marchesi; vi approdò il 10 maggio e il giorno successivo fu raggiunto da Lisjanskij. Gli indigeni avevano fama di cannibali, e ai naturalisti fu concesso di lasciare le navi solo sotto scorta; poterono però studiarne i costumi, rimanendo particolarmente affascinati dall’arte dei tatuaggi. Lo stesso capitano si fece tatuare su un braccio il nome dell’adorata moglie. Ma la sosta nell’isola fu tutt’altro che una vacanza tropicale; il suo scopo era rinnovare le scorte, procurandosi tra l’altro un certo numero di maiali. Sapendo che l’unico bene che interessava agli indigeni erano gli oggetti di ferro, Krusenstern proibì di scambiarli con ogni altra cosa; Rezanov disobbedì e, facendo incetta di oggetti etnografici per la Kunstkammer imperiale, provocò il crollo del valore degli oggetti di ferro, rendendo impossibili gli approvvigionamenti. Nel chiarimento pubblico che seguì, non solo Rezanov contestò l’autorità del comandante, ma cercò di scavalcarlo, provocando un ammutinamento. Nessuno degli ufficiali lo seguì. Intanto Tilesius, ingaggiato come medico e naturalista esperto di biologia marina, cambiava mestiere. Il pittore Kurljancev infatti diede di matto e distrusse a colpi d’ascia la sua cabina, non risparmiando neppure le icone. Fu così che il medico tedesco, che era anche un eccellente disegnatore, divenne l’illustratore ufficiale della spedizione. Per completare le scorte le due navi si diressero quindi alla maggiore delle isole Hawaii. Qui si separarono, dandosi appuntamento l’autunno dell’anno successivo a Macao: il 10 giugno la Nadežda salpava alla volta della Kamčatka, mentre qualche giornp dopo la Neva partiva per l’Alaska. 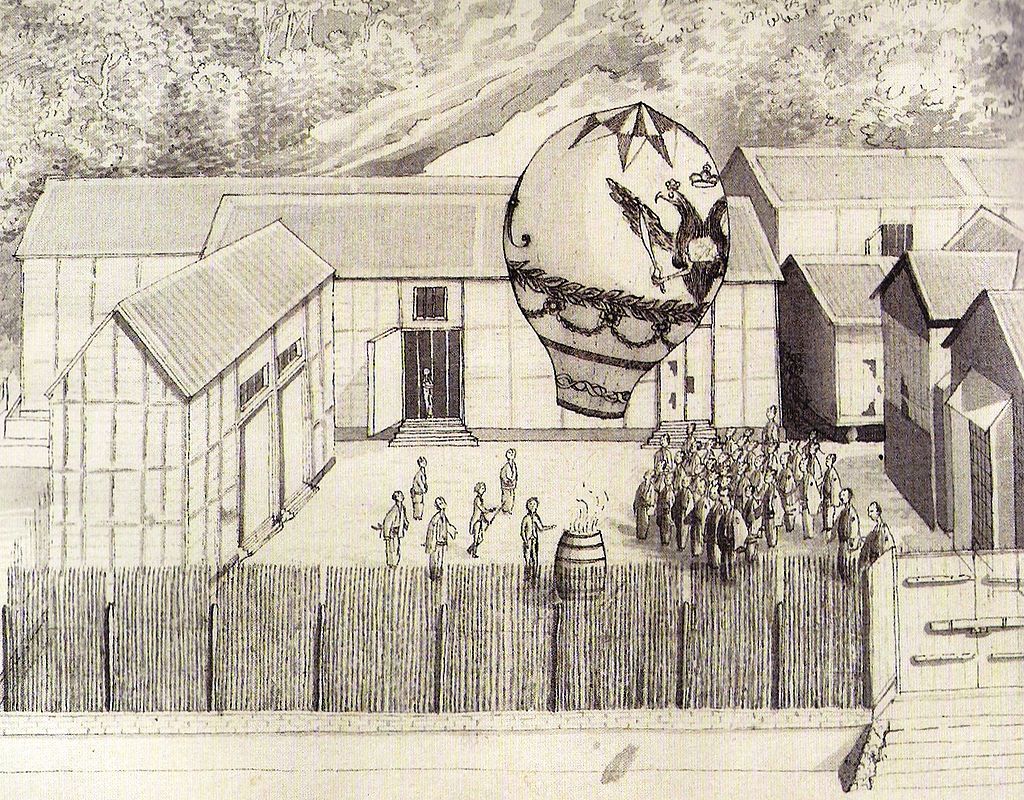 La Nadežda in Kamčakta e Giappone: 1804-1805 Dopo un viaggio senza incidenti di 35 giorni, il 15 luglio la Nadežda attraccò a Peterpavlovsk; immediatamente Rezanov fece appello al governatore Košelev perché mettesse sotto accusa Krusenstern e i suoi ufficiali per insubordinazione. Dopo aver sentito entrambe le campane, il generale capì perfettamente di trovarsi in un ginepraio e rifiutò di pronunciarsi, dichiarando che in quella faccenda era testimone e non giudice. Alla fine si giunse a una riconciliazione e il 6 settembre la Nadežda ripartiva alla volta di Nagasaki. Rimanevano a terra lo scapestrato Tolstoj e i due paria di bordo, il pittore Kurljancev e il botanico Brinkin. La missione giapponese fu un totale fallimento; le trattative si trascinarono per sei mesi, mentre la Nadežda era posta in disarmo, i cannoni e la polvere da sparo sequestrati, gli uomini confinati in un piccolissimo spazio. Gli unici a trarne profitto furono Tilesius e Langendorff che riuscirono a convincere i pescatori che rifornivano la squadra di pesce a procurare specie sempre nuove; fu così che poterono studiare 400 specie di pesci di 180 generi diversi. Insieme a Horner, allestirono anche un piccolo spettacolo per i loro ospiti nipponici, costruendo e facendo volare una mongolfiera in seta e carta di riso. La risposta ufficiale giunse il 7 aprile 1805: il governo giapponese respingeva i doni, rifiutava ogni rapporto diplomatico o anche solo commerciale con i russi, cui era ingiunto di lasciare il paese al più presto. Lasciata Nagasaki il 18 aprile, Krusenstern, nonostante la contrarietà delle autorità giapponesi, anziché seguire la rotta diretta, costeggiò Honshu e Hokkaido, fino a raggiungere lo stretto che separa quest'ultima da Sakhalin, di cui vennero mappate le coste. Dopo aver scoperto alcune isole del gruppo delle Curili, rientrò infine a Petropavlovsk il 5 giugno. Ad attenderlo trovarò un rescritto dello zar che gli conferiva la croce dell'ordine di Sant'Anna di Prima Classe; per Rezanov c'erano una tabacchiera e l'ordine di andare a ispezionare l'Alaska russa. Langsdorff decise di approfittare dell'occasione per visitare anche quelle contrade. Krusenstern dedicò il resto dell'estate a esplorare le coste di Sakhalin e le Curili, ma dovette rinunciare a cercare la foce dell'Amur per non mancare l'appuntamento con Lisjanskij a Macao. Partita da Peterpavlovsk il 5 ottobre, la Nadežda rischiò subito di arenarsi, quindi affrontò una navigazione molto difficile per le temperature rigide e le continue tempeste, raggiungendo infine Macao il 20 novembre. La Neva non c'era ancora. 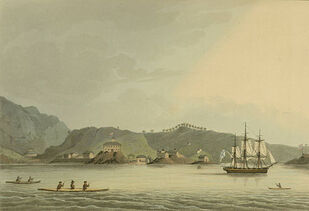 La Neva in Alaska e il viaggio di ritorno Scopriamo insieme perché. Il 10 luglio 1804 la Neva giunse nell'isola di Kodiak, in Alaska. Poco dopo, il governatore della colonia Baranov chiese a Lisjanskij di aiutarlo a liberare Sitka dai Tlingit, che, dopo aver cacciato i russi, vi avevano costruito un fortino. L'intervento della Neva, con i suoi 14 cannoni, fu determinante per il successo russo nella cosiddetta "battaglia di Sitka" (1-4 ottobre 1804). Lo scontro fu comunque molto duro, tra i marinai ci furono tre morti e diversi feriti. L'inverno era ormai alle porte e la Neva lo trascorse a Kodiak. Soltanto ad aprile il disgelo rese possibile mappare il golfo di Chiuniat e l'arcipelago Kodiak. Intanto le stive della nave si riempivano delle provviste per il viaggio e di 440.000 tra pellicce e pelli di tricheco da rivendere in Cina. Lasciato il porto di Pavlovsk sull'isola Kodiak il 13 giugno, arrivarono il 22 a Novo-Arckangelsk, come i russi avevano ribattezzato Sitka, dove nel frattempo il governatore Baranov aveva fatto costruire otto grandi edifici in legno che a Lisjanski apparvero "abbastanza decenti anche per l'Europa". Prima di lasciare l'Alaska, insieme a un compagno, egli volle scalare e esplorare il Monte Edgecumbe, il magnifico vulcano che domina Sitka. Il 1 settembre la Neva lasciò l'Alaska. Lungo la rotta per la Cina, secondo le istruzioni, avrebbero anche dovuto cercare terre sconosciute a est del Giappone; non ne incontrarono nessuna fino al 15 ottobre quando, proseguendo verso sudovest, si arenarono sulla barriera corallina. Gettando fuori bordo tutto il possibile, riuscirono a liberare la nave, che però rimase fortemente danneggiata. Fu così scoperta l'isola Lisianski (una scoperta di cui il dedicatario avrebbe fatto volentieri a meno). Mentre le provviste cominciavano a scarseggiare, la navigazione proseguì in condizioni difficili, peggiorate il 22 novembre da una tempesta al largo delle Marianne che mise in forse la sopravvivenza della nave. L'acqua penetrata nella stiva causò il deterioramento di molte pellicce, che dovettero essere gettate fuori bordo. Ecco i motivi del ritardo della Neva. Ricongiunte, la Nadežda e la Neva si trasferirono sull'isola di Wampoa, dove attraccavano le navi europee autorizzate a commerciare negli empori di Canton. I russi non erano tra questi (tanto che, dopo la loro partenza, i funzionari che avevano autorizzato le transazioni furono severamente puniti); inoltre stava per iniziare la stagione dei tifoni e, per non rischiare di rimanere bloccati per un altro anno, i funzionari della Compagnia accettarono la mediazione di una ditta inglese, cui dovettero versare una generosa commissione, vendendo infine le pellicce a un prezzo assai inferiore al previsto. Mentre le laboriose trattative commerciali proseguivano, la Neva venne riparata e messa in condizione di riprendere il viaggio. Il 31 gennaio 1806 le due navi lasciarono la Cina, fissando come eventuale punto d'incontro l'isola di Sant'Elena; viaggiarono insieme fino al 15 aprile, quando furono separate dalla nebbia e dall'oscurità. In una tacita gara con l'amico-rivale Krusenstern, Lisjanski decise di fare tutto il possibile per arrivare per primo. Procedendo a vele spiegate, doppiò il Capo di Buona Speranza il 20 aprile e, valutando di avere provviste sufficienti, proseguì direttamente per l'Inghilterra. Con una velocità senza riscontri per l'epoca, in soli 180 giorni raggiunse il porto di Portsmouth (28 giugno), da dove, dopo una sosta di due settimane, fece vela per Kronstadt, dove attraccò la mattina del 6 agosto, a tre anni esatti dalla partenza. Al contrario del suo secondo, Kruzenstern tenne fede ai patti. Doppiato il Capo di Buona Speranza, si diresse a Sant'Elena, dove giunse il 3 maggio. Quindi, facendo rotta verso l'Europa, toccò alcune isole scozzesi e Copenhagen, rientrando a Kronstadt il 19 agosto. 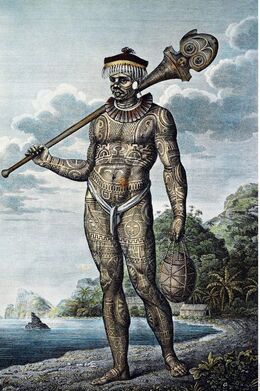 Un versatile zoologo si trasforma in illustratore Sul piano scientifico la spedizione fu un indubbio successo. Le rilevazioni delle squadre della Nadežda e della Neva permisero di correggere le carte di Cook e La Pérouse, mappando varie aree del Pacifico settentrionale; vennero scoperte alcune isole, in Alaska, nelle Curili e nell'arcipelago hawaiiano. Inoltre Krusenstern fu il primo a dimostrare che Sakhalin non è collegata alla terra ferma. Con il rilevante contributo dell'astronomo Horner (1774-1833), vennero effettuate osservazioni e misurazioni oceanografiche, tra cui l'analisi della correlazione tra profondità, temperatura e peso specifico dell'acqua. Le soste sempre troppo brevi e la difficoltà di procurarsi e conservare gli esemplari senza alcun aiuto furono sicuramente una fonte di frustrazione per Tilesius e Langsdorff; forzatamente, i loro studi dovettero concentrarsi sulla biologia marina, che, per altro, era anche il settore di specializzazione di Tilesius. Mentre la Nadežda attraversava l'Atlantico in direzione del Brasile, studiarono e scoprirono la causa della luminescenza marina; in Giappone, come abbiamo già visto, scoprirono numerose specie di pesci. Come ho già anticipato, tornerò su Langsdorff in un prossimo post. Per concludere, quindi, qualche parola su Wilhelm Gottlieb Tilesius (1769-1857). Studente di medicina a Lipsia, seguì anche i corsi del pittore e scultore Adam Frederick Oeser, divenendo un eccellente disegnatore e incisore. Nel 1795-96, ancora studente, accompagnò Hoffmannsegg in Portogallo, dove si occupò soprattutto di animali marini. L'eccellente lavoro che ne ricavò, accompagnato da ottime illustrazioni di sua mano, attirò l'attenzione dell'Accademia delle Scienze russe, che lo propose come medico di bordo e naturalista della spedizione Krusentern. Il più vecchio e il più autorevole dei tre naturalisti, tendeva a comportarsi come il capo dell'équipe scientifica (creando una certa tensione con Langsdorff). Era soprattutto uno zoologo; tra le sue scoperte più rilevanti il granchio reale, Paralithodes camtschaticus. Soprattutto durante l'esplorazione di Sakhalin ebbe però occasione anche di studiarne la flora; tra le sue scoperte Artemisia sachaliensis, Artemisia tilesii e Serratula tilesii. Come abbiamo già visto, a partire dalla sosta nelle Marianne, divenne anche l'illustratore ufficiale della Nadežda . L'Atlante della Circumnavigazione pubblicato da Krusenstern nel 1813 è illustrato da 109 sue tavole, precise nei tratti ma non prive di efficacia evocativa. Le più celebri sono senza dubbio quelle dedicati ai guerrieri tatuati di Nuku Hiva. Dopo il rientro in Russia, fu nobilitato dallo zar (divenne così Tilesius von Tilenau) e ammesso all'Accademia delle scienze, che lo incaricò di ricostruire lo scheletro del mammut riportato dalla Siberia da Adams, il più completo conosciuto all'epoca. Tuttavia la sua carriera accademica non decollò e nel 1814 decise di tornare in Germania, dove, benché fosse membro di moltissime società scientifiche e continuasse a pubblicare molti articoli, soprattutto sugli animali marini, non riuscì mai ad ottenere una cattedra universitaria. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Gli strani frutti di Tilesia Il suo nome tuttavia era abbastanza noto. Nel 1818 G.F.W. Meyer gli dedicò il genere Tilesia, appartenente alla famiglia Asteraceae. Solo a inizio '900 il suo rilevante contributo allo studio degli animali marini fu premiato con la dedica di un genere di pesci, Tilesina. Tilesia Mey. comprende tre specie di erbacee o arbusti rampicanti diffusi nelle Antille, in Centro America e nel Sud America tropicale, caratterizzati da frutti carnosi simili a drupe, una particolarità quasi unica in questa famiglia. Infatti, a differenza delle altre Asteraceae sudamericane, che vivono in habitat aperti e hanno frutti secchi dispersi dal vento, le Tilesiae sono piante delle foreste semidecidue i cui semi sono dispersi da vari uccelli che si cibano delle bacche. La specie più nota, T. baccata, è una liana che vive lungo i corsi d'acqua o al margine delle foreste, con capolini terminali all'ascella delle fronde superiori, con flosculi del disco bisessuali arancioni e flosculi ligulati sterili, giallo vivo, spesso con apice trilobato. E' l'unica specie a fiori gialli, mentre le altre due (diffuse in aree ristrette) li hanno rossi. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
La spedizione di Bering apre la strada all'espansione russa nelle Aleutine e in Alaska, alla ricerca delle preziose e richiestissime pellicce di lontra. E' un'impresa condotta con brutalità e sempre sull'orlo del fallimento, a causa del difficile e costoso approvvigionamento di quella lontana colonia. Per risolvere il problema, la Compagnia russo-americana, che ha ottenuto il monopolio del commercio delle pellicce, caldeggia il progetto dell'ammiraglio Krusenstern: creare una via commerciale diretta tra Russia e Cina circumnavigando il globo. Il progetto, per quanto audace, lusinga l'orgoglio russo e la nuova consapevolezza di sé alimentata dal ruolo di primo piano che l'Impero russo sta giocando nelle guerre contro la Francia prima rivoluzionaria poi napoleonica. Si dilata così in un ambizioso sogno coloniale: la creazione di una sfera d'influenza politica ed economica nel Pacifico settentrionale a cavallo tra tre continenti, sostituendosi all'impero spagnolo ormai declinante. Con l'entusiastica adesione dello zar, nel 1803 inizierà così la prima circumnavigazione russa del globo, comandata dallo stesso Krusenstern. Tra i suoi sostenitori più calorosi, l'allora ministro del commercio, il conte Nikolaj Rumjancev. Quindici anni dopo, quando la sua stella politica (che lo aveva portato a diventare ministro degli esteri) sarà ormai tramontata, lo stesso Rumjancev finanzierà la seconda circumnavigazione, guadagnandosi la dedica del nome specifico di alcuni animali e piante e del genere Romanzoffia.  L'America russa: pellicce, genocidi e un progetto audace Sebbene la seconda spedizione di Bering si fosse risolta in un disastro, aveva raggiunto i suoi obiettivi, dimostrando definitivamente che Asia e America non erano collegate e aprendo la rotta tra i due continenti. Ad eccitare gli animi (e la cupidigia) furono poi le pellicce di lontra portate con sé dai naufraghi della Sv. Petr. Dopo decenni di caccia indiscriminata, in Siberia gli animali da pelliccia incominciavano a scarseggiare; le isole Aleutine e l'America settentrionale (ovvero l'Alaska) promettevano nuovi, ricchissimi territori di caccia. Nei decenni successivi, cominciò così la penetrazione russa in quei territori, sotto forma prima di avamposti dei commercianti di pellicce, poi di insediamenti stabili. Il prodotto di punta erano proprio le pellicce di lontra di mare, tra l'altro una delle pochissime merci di importazione ben accette sul mercato cinese. Accompagnata da spaventose brutalità ai danni degli indigeni (con il genocidio di larga parte degli aleutini) e segnata da un atteggiamento predatorio verso la natura, l'espansione russa avvenne dapprima in modo disordinato, grazie all'iniziativa di singoli mercanti; vennero poi fondate compagnie più strutturate, la più importante delle quali fu la Compagnia russo-americana, creata nel 1799, che riuscì a farsi concedere dallo zar il monopolio del commercio delle pellicce per vent'anni. Lo stesso anno quella che veniva ormai chiamata "America russa" fu annessa all'Impero. Malgrado gli sforzi della Compagnia, che cercò anche di stimolare l'arrivo di coloni dalla Russia e dalla Siberia, sul piano commerciale la situazione era tutt'altro che florida. Il problema principale era l'approvvigionamento degli insediamenti, il cui unico cordone ombelicale con la madrepatria erano le navi che affrontavano la difficile navigazione con la Siberia e la Kamčatka, impraticabile dall'autunno alla primavera inoltrata (senza contare l'interminabile viaggio dalla Russia alla Siberia, che poteva richiedere da due a tre anni). Anche le pellicce di lontra per raggiungere la Cina, il loro principale mercato, dovevano percorrere la stessa via: sbarcate nel porto di Okhotsk, in Siberia, venivano trasportate via terra al punto di confine di Kyakhta, da cui, secondo le clausole dell'omonimo trattato, dovevano passare tutte le merci scambiate tra Russia e Cina; di qui, ogni tre anni, una carovana di mercanti muoveva poi per Pechino. Insomma, lungaggini e spese che erodevano i guadagni e mettevano in forse la stessa sopravvivenza dell'America russa. A proporre una soluzione alternativa fu l'ammiraglio von Krusenstern. Suddito russo di origine baltica e lingua tedesca, durante le guerre contro la Francia aveva servito nella Royal Navy e aveva visitato gli Stati Uniti, le Antille, Calcutta e Canton. Nel 1799, mentre si trovava a Calcutta, inviò a San Pietroburgo una relazione in cui illustrava i vantaggi di aprire una via di comunicazione diretta tra Russia e Cina che circumnavigasse il globo passando da Capo Horn all'andata e dal Capo di Buona Speranza al ritorno. Il progetto suscitò l'interesse della Compagnia russo-americana, nella persona del suo più autorevole esponente, Nikolaj Petrovič Rezanov, che riuscì a convincere politici influenti e lo stesso imperatore. Erano gli anni in cui l'impero russo, guidato dal giovane e romantico Alessandro I, salito al trono nel 1801, giocava un ruolo di primo piano nelle coalizioni antifrancesi e incominciava ad imporsi come una delle principali potenze continentali; negli ambienti di corte, la proposta di Krusenstern, che lusingava l'orgoglio nazionale, incominciò a dilatarsi fino a trasformarsi in un progetto politico di ampio respiro: oltre ad assicurare il collegamento stabile con l'Alaska e una via commerciale diretta tra l'America russa e la Cina, si puntava ad aprire relazioni diplomatiche ufficiali con il Giappone, ad inserirsi nel commercio con il Sud America e a sondare la possibilità di colonizzare la California, approfittando della debolezza della Spagna. Era l'inizio di un grandioso sogno di espansione, che il governo russo perseguì per una quarantennio: la trasformazione del Pacifico settentrionale in un "mare russo", grazie al controllo delle sue isole e delle sue coste orientali e occidentali.  Un discusso uomo politico e un grande mecenate Fu così che nell'agosto del 1803 salparono da Kronstadt alla volta delle Canarie, prima tappa della prima circumnavigazione russa del globo, le navi Nadežda (ovvero "Speranza") e Neva, comandate rispettivamente dallo stesso Krusenstern e dal capitano-luogotenente Lysianskij. Un quindicennio dopo, archiviate le guerre napoleone, l'avrebbe seguita una seconda circumnavigazione (1815-18), quella della Rjurik, comandata dal luogotenente Kotzebue. Fino alla cessione dell'Alaska agli Stati Uniti (1867), le circumnavigazioni russe sarebbero poi diventate quasi viaggi di routine (tra 1803 e 1835 se ne totalizzarono venticinque). Sulle prime due, che ebbero rilevanti risvolti scientifici, tornerò in altri post. Qui vorrei concentrami su uno degli uomini politici che le vollero e le resero possibili, il conte Nikolaj Petrovič Rumjancev (1754-1826), uno delle maggiori personalità della Russia a cavallo tra Settecento e Ottocento. Negli anni in cui si discuteva la proposta di Krusenstern, egli era direttore delle comunicazioni fluviali e marittime e ministro del commercio; uomo dalla mentalità molto aperta e intraprendente, si batté contro l'arretratezza economica del paese, snellendo in senso liberale la legislazione commerciale, migliorando le vie d'acqua e promuovendo la costruzione di canali navigabili e di nuovi ponti; egli vide subito le potenzialità del progetto e si spese a favore della sua approvazione, usando tutta la sua notevole influenza sul giovane zar e su sua madre, la zarina vedova Marija Fedorovna. Rumjancev era un uomo molto colto, con interessi sia umanistici sia scientifici; in gioventù aveva servito a lungo all'estero come diplomatico e aveva cominciato ad ammassare una prodigiosa collezione di libri, incunaboli, manoscritti, stampe, monete, opere d'arte e oggetti etnografici; spinse dunque anche sugli obiettivi scientifici della missione, cui volle prendesse parte un gruppo di scienziati. Intanto, mentre la Nadežda e la Neva solcavano gli oceani e poi rientravano trionfanti in patria, la posizione politica della Russia andava evolvendo: dopo la cocente sconfitta di Austerlitz (1805) e la disfatta di Friedland (1807), Alessandro I, fino ad allora uno dei più determinati avversari di Napoleone, incominciò a dare ascolto a quanti gli consigliavano di trattare con l'imperatore dei francesi. Il più convinto assertore di questa svolta politica era proprio Rumjancev, un ammiratore dell'illuminismo decisamente francofilo, che per un breve periodo divenne il più ascoltato e influente dei suoi ministri. Fu lui a convincere il riluttante Alessandro a incontrare Napoleone sul Njemen e a siglare la pace di Tilsit (1807) e l'effimera alleanza tra Russia e Francia. La carriera politica di Rumjamcev toccò il suo apice: nel 1808 fu nominato ministro degli esteri e nel 1810 presidente del consiglio di Stato. Ma, mano a mano che i rapporti tra Francia e Russia si gustavano, la sua posizione filofrancese lo rendeva sempre più isolato e inviso allo zar (come capo dei circoli francofili, figura ambigua se non odiosa, compare anche in Guerra e Pace di Tolstoj). L'invasione francese del 1812 lo colse tanto di sorpresa da provocargli un colpo apoplettico che lo privò parzialmente dell'udito; nonostante ciò, continuò a consigliare lo zar di esautorare Kutuzov e di trattare con Napoleone. Di conseguenza, prese la confidenza di Alessandro, che lo allontanò dalla vita politica. Ritiratosi a vita privata nel 1814, Rumjancev dedicò gli ultimi anni alle sue collezioni e alla promozione degli studi storici, letterari e scientifici. Fin da giovane, aveva una collezione di minerali, che ora incrementò con l'acquisto di altre raccolte, tra cui i materiali riportati da Lisyanski dalla prima circumnavigazione. Grandissimo bibliofilo, possedeva una biblioteca di 30.000 volumi (12.000 dei quali di argomento storico), oltre 1000 manoscritti, 5000 incisioni, 600 mappe, che dopo la sua morte andò a costituire il primo nucleo della Biblioteca di Stato russa. Come appassionato di studi storici, riunì intorno a sé un circolo di giovani studiosi delle antichità russe e slave e finanziò la pubblicazione di una quarantina di antichi testi (tra cui i primi capolavori della letteratura russa, come il Canto di Igor). Le sue collezioni d'arte dopo la sua morte andarono invece a formare il primo museo russo aperto al pubblico (nel 1831). Chiuso e smembrato nel 1924, confluì in parte nella Galleria Tret'jakov, in parte nel Museo Puškin delle Belle Arti. Una sintesi della vita di questo discusso politico e grande promotore degli studi e delle arti nella sezione biografie. Egli fu anche un mecenate delle scienze, finanziando la seconda circumnavigazione russa del globo; mentre la prima, come abbiamo visto, fu una spedizione in grande stile, promossa e finanziata dal governo russo nell'ambito di un ambizioso progetto politico, la seconda, anche se fu approvata dalla zar, fu frutto di un'iniziativa dello stesso Rumjancev ed ebbe un carattere più nettamente scientifico. Infatti, la mutata situazione politica, che vedeva ora la Spagna alleata della Russia, rendeva poco prudente perseguire apertamente una penetrazione russa nelle aree rivendicate dalla monarchia iberica.  Romanzoffia, minuta bellezza E' proprio come mecenate della spedizione di Kotzebue che il conte Rumjancev entra a buon diritto nella nostra galleria di dedicatari di un genere botanico. Adalbert von Chamisso, il botanico della spedizione, volle infatti rendergli omaggio dedicandogli alcune delle piante raccolte durante il viaggio. Lo ricordano nel nome specifico Spiranthes romanzoffiana, un'orchidea dell'America settentrionale, e Syagrus romanzoffiana, la spettacolare "palma regina", raccolta in Brasile durante il viaggio d'andata, probabilmente la più conosciuta delle piante dedicate al nostro conte. Lo zoologo della spedizione Eschscholtz gli dedicò invece la bellissima farfalla Papilio rumanzovia, scoperta nelle Filippine. Fu invece raccolta nell'isola di Unalaska, nelle Aleutine occidentali, la specie tipo del genere Romanzoffia, creato da Chamisso nel 1820. Appartenente alla famiglia Boraginaceae (precedentemente Hydrophyllaceae) comprende cinque specie erbacee annuali o perenni native dell'America nordoccidentale, dall'Alaska alla California, ovvero proprio la zona esplorata da Chamisso e dai suoi compagni. Le Romanzoffiae hanno foglie lobate e graziosi fiori campanulati, solitamente bianchi, portati su lunghi steli, a fioritura primaverile. Adattate a ambienti rocciosi umidi e ombreggiati, hanno robuste radici rizomatose che permettono di crescere anche tra le fessure; le specie perenni dopo la fioritura avvizziscono e entrano in dormienza. Il ciclo ricomincerà con le prime piogge d'autunno, quando rispunteranno le foglie. Queste caratteristiche hanno permesso al genere, tipicamente artico e boreale, di scendere più a sud, colonizzando anche la California settentrionale, dove le estati sono calde e aride. Qui vive la specie più meridionale e più nota, R. californica, che negli Stati Uniti è talvolta coltivata nei giardini rocciosi. Ci riportano invece in Alaska R. unalaschensis, la specie raccolta da Chamisso a Unalaska e R. sitchensis, che prende il nome da Sitka; all'epoca del dominio russo si chiamava Novo-Archangelsk ed era la sede principale della Compagna russo-americana. E' le specie con l'areale più ampio, diffusa dall'Alaska alla California, passando per gli stati canadesi del British Columbia e della Alberta e l'Oregon. Un cenno alle altre specie nella scheda. Linneo trascorse l'estate del 1736 in Inghilterra. Lo scopo ufficiale del viaggio, finanziato dal suo datore di lavoro George Clifford, era procurarsi piante rare per arricchire le collezioni del suo mecenate; ma per il giovane studioso svedese era soprattutto l'occasione per conoscere i "colleghi" britannici e propagandare il suo nuovo sistema. Contrariamente alle aspettative, fu tutt'altro che una tournée trionfale. A Londra, i big della botanica inglese, da Sloane a Miller, lo accolsero con freddezza; né meglio andò ad Oxford, dove Dillenius, il primo titolare della cattedra di botanica sherardiana, lo apostrofò come "l'uomo che ha messo l'intera botanica in confusione". A sentire Linneo e i suoi biografi, quello che era iniziato come un increscioso incidente diplomatico si risolse tuttavia in una vittoria dello svedese e in una dimostrazione luminosa dell'efficacia del suo metodo, tanto che alla fine l'arcigno tedesco l'avrebbe pregato in lacrime di diventare il suo assistente. Probabilmente non andò davvero così, ma è certo che da quel momento tra i due ci fu reciproca stima; l'anno successo, Linneo dedicò a Dillenius la sua Critica botanica e creò in suo onore il genere Dillenia. Del resto, il botanico tedesco era uno studioso di grande valore, la cui Historia muscorum segnò una tappa decisiva nello studio delle cosiddette "piante inferiori". 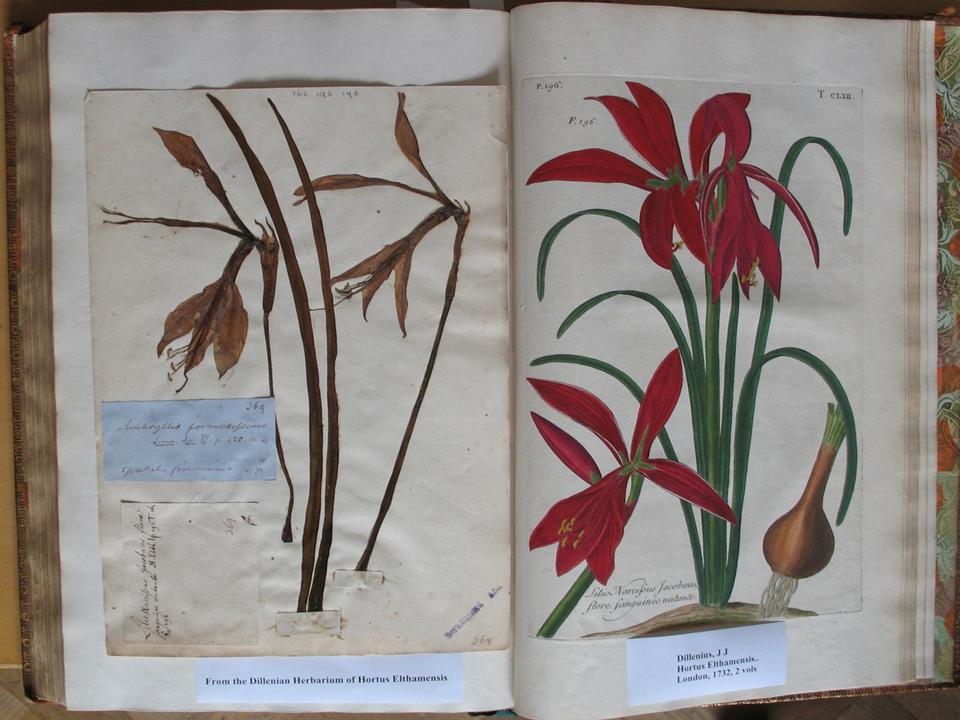 Linneo a Londra: una fredda accoglienza Come ho raccontato in questo post (a proposito, era il centesimo e questo è il numero duecento!), tra il 1735 e il 1737 Linneo lavorò per il ricchissimo George Clifford, borgomastro di Amsterdam e direttore della Compagnia olandese delle Indie orientali, riorganizzando e catalogando il suo orto botanico privato di Hartekamp. Clifford desiderava ardentemente arricchire le sue collezioni con qualcuna delle rarità esotiche di provenienza americana coltivate nelle serre di Londra e Oxford; per questo accettò di privarsi per qualche settimana del "suo" botanico, inviandolo in Inghilterra a far incetta di piante. Per Linneo, che nel 1735 aveva pubblicato proprio in Olanda la prima edizione di Systema naturae, era l'occasione per conoscere di persona i big della botanica britannica, di cui sperava di ottenere il riconoscimento, proprio come aveva ottenuto quello di studiosi olandesi del calibro di Gronovius e Boerhaave. Gli esiti, tuttavia, furono molto lontani dalle speranze. Freddissima fu l'accoglienza di Hans Sloane, il presidente della Royal Society, cui Linneo si era presentato munito di una lettera proprio di Boerhaave, in cui quest'ultimo invitava l'illustre collezionista ad accogliere quel giovane degno di lui, aggiungendo che "chi vi vedesse insieme, vedrà una coppia di cui il mondo difficilmente potrà vedere l'uguale". Sloane, che aveva 77 anni ed era abituato ad essere universalmente riconosciuto e riverito, non gradì per nulla l'accostamento a quell'ignoto neolaureato svedese trentenne, e si degnò appena di mostrargli le sue collezioni e il suo erbario. Le cose non andarono meglio con Philip Miller, il capo giardiniere del Chelsea Physic Garden, da cui Linneo sperava di ottenere piante rare per il suo mecenate. Dopo la brutta esperienza con Sloane, egli, che aveva sentito dire che Miller era uno scozzese piuttosto scorbutico, pensò che fosse meglio comportarsi con prudenza. Quando quest'ultimo lo accompagnò a visitare il giardino e incominciò a illustrare le piante usando i prolissi nome-descrizione e le classificazioni di Ray e Tournefort, per non irritarlo rimase in silenzio. Il giorno dopo, venne a sapere che Miller si era fatto beffe di lui con i suoi amici dicendo che "quel botanico del borgomastro di piante non sa un'acca". Era troppo per Linneo che, quanto a brutto carattere, non era da meno di Miller. Alla sua seconda visita a Chelsea, quando il giardiniere gli mostrò l'erbario, contestò le sue denominazioni, sostenendo che "se ne possono usare di migliori e più sintetiche" e cercò in ogni modo di fare sfoggio delle sue competenze. Il risultato fu di far imbufalire Miller, che non amava essere contraddetto e giudicava Linneo un arrogante presuntuoso, il cui sistema non aveva nulla a che fare con la realtà delle piante, serviva solo a mettersi in mostra e non avrebbe avuto futuro; egli avrebbe cambiato idea solo molti anni dopo, nel 1768, quando nell'ottava edizione del suo Gardeners Dictionary si convinse finalmente ad adottare il sistema linneano. 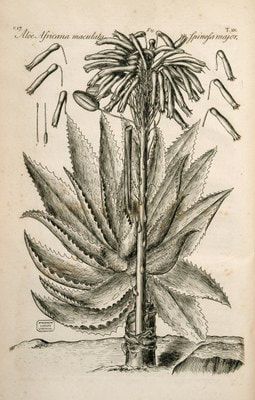 Gli errori di Linneo... e quelli di Dillenius Linneo non fu accolto a braccia aperte neppure ad Oxford, dove era andato appositamente per incontrare Johann Jacob Dillenius, lo scienziato di origine tedesca che da qualche anno era il titolare della prima cattedra di botanica presso quell'università, nonché curatore dell'orto botanico. Durante il primo incontro Linneo mantenne una condotta cortese e deferente. Esordì scusandosi di dover parlare in latino, visto che non conosceva l'inglese. Dillenius bruscamente si rivolse a un altro gentiluomo che assisteva al colloquio (secondo i biografi di Linneo, si tratterebbe di James Sherard) che gli aveva chiesto chi fosse quel giovanotto, dicendo: "E' l'uomo che ha messo l'intera botanica in confusione". Poiché aveva parlato in inglese, pensava che Linneo non avrebbe capito; lo svedese, invece, non solo capì che si parlava di lui, ma anche la sostanza delle parole di Dillenius (l'inglese confusion è simile al latino confusio), ma al momento decise di abbozzare. I tre quindi si spostarono in giardino; Linneo notò una pianta che non aveva mai visto: "Che pianta è?" "Dovreste dirlo voi a me!" "Certamente, se mi permettete di esaminare un fiore." "Avanti, lo faccia." Linneo eseguì e, contando gli stami e il pistillo, ne diede il nome corretto, ma non per questo Dillenius si sciolse. Linneo era ormai convinto che il suo viaggio fosse stato inutile e, visto che incominciavano anche a scarseggiare i soldi, il giorno dopo tornò da Dillenius per congedarsi. Questa volta il cattedratico era solo. Linneo lo pregò di inviare un servitore a fissare per lui la carrozza di posta che l'avrebbe riportato a Londra, quindi, con la massima cortesia di cui era capace, gli domandò: "Perché ieri avete detto all'uomo che era con voi che sono quello che porta confusione nell'intera botanica?" Dillenius, molto imbarazzato, cercò di cambiare argomento, ma Linneo insisteva. "Venite con me", disse allora il tedesco e lo portò nella sua biblioteca. Da uno scaffale estrasse una copia di Systema naturae che aveva ricevuto da Gronovius e mostrò quelle pagine costellate della sigla NB. "Che significa?" domandò Linneo. "Sono gli errori del vostro libro" "Non sono errori, ma se lo fossero, insegnatemi meglio. Riceverò con gratitudine le vostre correzioni". "Benissimo, proviamo. Ecco, ad esempio, il genere Blitum. Lei pretende che abbia un solo stame, ma ne ha tre". Linneo e Dillenius si spostarono in giardino, Linneo esaminò un fiore di Blitum e mostrò che lo stame era effettivamente uno. "Bah, è un esemplare anomalo". Li osservarono tutti e risultò che aveva ragione Linneo. L'esame continuò con altri generi, sempre dimostrando che le descrizioni di Linneo erano corrette. A questo punto, Dillenius cambiò totalmente atteggiamento, e, stando alla versione diffusa da Linneo, l'avrebbe addirittura supplicato in lacrime di non partire ma di fermarsi ad aiutarlo a classificare l'erbario di Sherard, in cambio di metà del suo salario. E' probabile che le cose non siano davvero andate così se poco dopo Dillenius scrisse a un collega "Linneo ha certamente una conoscenza approfondita della botanica, ma il suo metodo non funziona"; e qualche anno dopo avrebbe scritto allo stesso Linneo: "Non ha dubbi che voi stesso, un giorno, rigetterete il vostro sistema". In ogni caso tra i due si era stabilita una stima reciproca; iniziarono a scriversi e a scambiarsi esemplari e le rispettive pubblicazioni. Nel 1738 Linneo dedicò a Dillenius Critica botanica e tenne poi sempre in grande considerazione le opere del collega tedesco, da cui riprese diversi generi in Species plantarum. 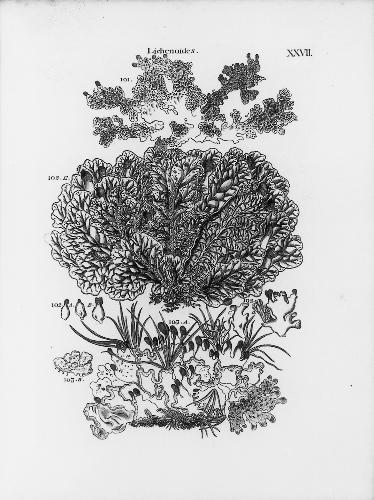 Un grande tassonomista e l'inizio dello studio scientifico delle crittogame Per quanto ritoccato da Linneo e dai suoi biografi, l'aneddoto assume quasi il valore di un metaforico passaggio di testimone tra la vecchia scuola tassonomica di Ray e Tournefort, di cui Dillenius fu un esponente di primo piano, e il nuovo sistema linneano. Del resto, tra i due protagonisti di questa storiella, curiosamente, c'è più di una affinità. Come Linneo si era trasferito in Olanda e aveva iniziato la sua carriera classificando le collezioni di un mecenate, lo stesso aveva fatto Dillenius, spostandosi dalla nativa Germania in Inghilterra al servizio del botanico e collezionista William Sherard. Nato nel 1684 a Darmstadt, si formò e insegnò medicina e botanica all'università di Giessen; nel 1719 pubblicò una flora dei dintorni di questa città, Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium, che illustrò di propria mano, essendo anche un eccellente disegnatore e incisore. E' un'opera notevole perché, accanto alle fanerogame, tratta anche le crittogame e presenta uno dei primi tentativi di classificazione dei funghi; delle 160 specie di funghi descritte, 90 erano inedite; delle 200 specie di muschi, erano sconosciute ben 140. Questo lavoro diede fama europea a Dillenius e attrasse l'attenzione di William Sherard che nel 1721 lo invitò a trasferirsi in Inghilterra per aiutarlo a catalogare il suo immenso erbario e ad allestire il catalogo del giardino di Eltham nel Kent, dove suo fratello James (anche lui appassionato botanico) coltivava piante rare. Lavorando fianco a fianco con William Sherard, che aveva studiato a Parigi con Tournefort, Dillenius divenne uno dei migliori tassonomisti della sua generazione, con un'approfondita conoscenza anche del sistema di Ray, di cui nel 1724 curò la terza edizione di Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum, incorporandovi tra l'altra l'opera sui muschi del reverendo Adam Buddle. Stabilitosi a Eltham, Dillenius divenne il curatore di quel magnifico orto botanico privato, di cui documentò le collezioni in Hortus elthamensis, uscito infine dopo una lunga rielaborazione nel 1732; in due spettacolari volumi in folio, con 324 tavole disegnate e incise dallo stesso Dillenius, è uno dei capolavori della botanica prelinneana, per la precisione delle descrizioni (la parte tassonomica è per lo più dovuta allo stesso Sherard) e la bellezza delle immagini, in cui vengono trattate e illustrate 417 piante rare e esotiche; di grande importanza storica la trattazione delle succulente sudafricane, che fu ampiamente riutilizzata da Linneo. Catalogare l'immenso erbario del maggiore dei fratelli Sherard richiedeva un impegno anche più gravoso: rendendosi conto che non gli restava molto da vivere, nel suo testamento William lasciò all'università di Oxford la sua biblioteca, il suo erbario e un lascito di 3000 sterline, a condizione che venisse istituita una cattedra di botanica da affidare al professor Dillenius, che avrebbe dovuto completarne lo studio e la catalogazione. Sherard morì nel 1728, ma Dillenius, ancora impegnato a Eltham, poté assumere il nuovo incarico solo nel 1734. Possiamo credere che non gli sarebbe davvero spiaciuto essere affiancato da Linneo, come lui aveva affiancato il vecchio Sherard; nelle sue lettere, spesso lamenta di aver perso tempo e denaro (sembra che i fratelli Sherard lo pagassero molto poco) in quel compito immane, di cui non venne mai a capo, anche perché, probabilmente, preferiva ricerche più originali, in particolare lo studio delle sue amate crittogame. Frutto di un lavoro ventennale, il suo capolavoro è infatti Historia muscorum (1741), in cui vengono trattati, oltre ai muschi, altri gruppi di "piante inferiori": funghi, alghe, licheni, epatiche, antocerote e licopodi, per un totale di 661 taxa. Anche in questo caso, le 85 tavole che illustrano il grosso volume di 576 pagine sono di sua mano. I funghi sono classificati sulla base delle caratteristiche del corpo fruttifero (criterio poi fatto proprio da Linneo) e vengono creati numerosi generi, che poi furono mantenuti dallo svedese. Ogni voce comprende una dettagliata descrizione, la lista dei sinonimi e l'indicazione degli eventuali usi. Era un'opera costosa, di cui furono stampate solo 250 copie, vendute al prezzo di una ghinea l'una, che si rivelò un insuccesso finanziario; per recuperare almeno in parte le spese, Dillenius ne preparò una versione abbreviata, priva di illustrazioni, che conteneva solo i nomi, l'habitat e una breve descrizione, rimasta però allo stadio di manoscritto. Per raccogliere il materiale necessario, nel 1726, egli aveva fatto una lunga escursione in Galles, ma soprattutto ricorse al contributo di numerosissimi corrispondenti in Inghilterra e all'estero. Morì nel 1747 in seguito a un colpo apoplettico. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Dillenia ovvero una chicca per elefanti Nel 1736 Clifford ottenne alcuni semi di una pianta indiana detta syalita; seminati a Hartekamp, germinarono, ma le pianticelle sopravvissero solo due settimane. Quanto bastava perché Linneo potesse includere anche questa specie nel catalogo del giardino, Hortus Cliffortianus (1737), traendo la descrizione da Hortus Malabaricus e da Herbarium Amboinense di Rumphius; stando a queste fonti, si trattava di un albero di notevole bellezza; Linneo ritenne capitasse proprio al momento giusto per ingraziarsi il bisbetico professore tedesco e la denominò Dillenia indica, con queste parole: "Ho nominato questo albero dai bellissimi fiori e dai frutti enormi in onore di Dillenius, dottore in medicina, botanico incomparabile dei tempi nostri, professore sherardiano a Oxford e membro dell'Accademia Leopoldina". Confermò poi il genere in Species Plantarum, 1753. Dillenia L, che dà il nome alla famiglia Dilleniaceae, comprende un centinaio di specie di alberi, arbusti e liane tropicali, diffusi tra il Madagascar, l'India, il sud-est asiatico e l'Oceania occidentale. La specie più nota è proprio D. indica; è un grande arbusto o un piccolo albero con chioma tendenzialmente tondeggiante e spettacolari fiori candidi che possono ricordare quelli di Magnolia grandiflora, seguiti da enormi frutti tondeggianti giallo-verdastro. Di sapore tra l'acido e l'amarognolo, in India sono aggiunti ai curry o usati per preparare marmellate e gelatine. A esserne ghiotti sono soprattutto gli elefanti (i frutti crescono molto in alto, dove non sono raggiungibili da animali più piccoli), tanto da essere noti come "mela degli elefanti". Di grande valore ornamentale e talvolta usata in giardini e alberate in aree a clima tropicale è D. philippinensis, endemica delle Filippine; simile alla precedente, ha fiori con cinque sepali candidi che circondano una doppia corona di stami rossi e porpora, seguiti da frutti globosi. Di quest'albero, detto catmon, viene utilizzato tutto: il legname; la corteccia da cui si ricava un colorante rosso; i sepali carnosi eduli; i frutti, il cui sapore dovrebbe ricordare quello di una mela acida, usati per preparare salse e confetture e aromatizzare il pesce; corteccia e foglie hanno proprietà astringenti, antinfiammatorie, antimicrobiche e analgesiche. Può essere coltivata come pianta da interni o da serra in grandi contenitori. Qualche notizia in più nella scheda. Nella storia della Francia del XVIII secolo, il magistrato Antoine René Gaillard de Charentonneau non si è guadagnato neppure una nota a piè di pagina. Invece, in quella della botanica, complice un amico, il botanico Antoine Denis Fougeroux de Bondaroi, ha legato per sempre il suo nome a una delle beniamine delle aiuole estive, la coloratissima Gaillardia. E se su questo illustre sconosciuto c'è ben poco da dire, qualche parola in più lo meritano loro, oggi forse un po' demodé, ma facili, allegre e generose di fioriture.  Un magistrato con l'hobby della botanica Nel maggio 1786, il botanico, illustratore e divulgatore delle scienze applicate Antoine Denis Fougeroux de Bondaroi presenta all'Accademia delle Scienze parigina un'Asteracea di belle forme e fioritura generosa, capace di fiorire ininterrottamente da metà estate ai primi freddi. I semi sono stati importati dalla Louisiana dal Conte di Essales; Fougeroux, che ne ha ottenuto alcuni da piante coltivate in Francia, l'ha moltiplicata e coltivata per due anni. E' ora di pubblicarla e di darle un nome, visto che, a quanto pare, appartiene a un genere finora ignoto alla scienza. Ecco le sue parole: "La chiameremo Gaillardia (pulchella) [...] dal nome del sig. Gaillard de Charentonneau, che, ai doveri della Magistratura, ha saputo unire come svago la coltivazione delle piante e lo studio della botanica". E' quasi tutto quello che sappiamo su questo personaggio (nella sezione biografie, una sintesi di queste poche notizie). E' probabile che fosse un amico di Fougeroux, nel cui carteggio si trova una sua lettera; presumibilmente faceva parte di quei circoli di studiosi, appassionati e mecenati che ruotavano attorno all'Accademia delle Scienze di Parigi (di cui non risulta membro, nonostante ciò venga affermato da alcune fonti di seconda o terza mano). Nato forse intorno al 1720, si chiamava Antoine René e apparteneva a una famiglia della nobiltà di toga, con estese proprietà in città e nei dintorni di Parigi. Come il padre, che portava il suo stesso nome, era consigliere della Cour des aides, il tribunale d'appello che aveva giurisdizione sulle questioni finanziarie e fiscali; lo troviamo infatti citato in diversi documenti che riguardano l'operato di questo organismo. Nel 1779 dovette ritirarsi a vita privata, visto che un atto attesta la nomina del suo successore, ma era sicuramente ancora vivo nel 1788, anno in cui risulta proprietario del castello di Charentonneau e, in quanto feudatario, vi esercitava il potere giurisdizionale. Sulle sue attività come botanico e coltivatore ci rimane solo la laconica nota di Fougeroux. Molto probabilmente si sarà dedicato a questo "svago" nella sua proprietà di Charentonneau, sulle rive della Marna, dove la sua famiglia possedeva un grazioso castello, ai piedi del quale c'era un giardino e un parco con boschetti. Nel 1793, la proprietà fu confiscata e messa in vendita come bene appartenente a un emigrato (forse il nostro Antoine René, forse un figlio): il castello, passato di mano in mano, sopravvisse fino al 1950, quando fu abbattuto per costruire un gruppo di casermoni da 700 appartamenti. Del parco, che esisteva sicuramente ancora nel 1870, rimangono solo i resti dell'Orangerie, che forse fu fatta costruire dal nostro magistrato per le sue piante rare.  I solari capolini della Gaillardia A questo Carneade, a questo signor nessuno, il caso ha voluto legare un genere ben noto e frequente nei nostri giardini. Gaillardia, della famiglia Asteraceae, comprende 25-30 di specie erbacee annuali, biennali e perenni distribuite tra Nord America, Centro America e Sud America. I capolini, simili a margherite, ma con petali ligulati spesso trilobati, hanno colori caldi e brillanti (giallo, arancione, rosso), talvolta bicolori. Native principalmente di aree desertiche, hanno grande resistenza all'aridità; si adattano a molti tipi di suoli, anche poveri, in posizione soleggiata. Soprattutto, sono generosissime di fioriture, visto che sono in grado di fiorire l'intera estate. Nei nostri giardini se ne coltivano essenzialmente tre specie e le loro cultivar. G. pulchella, come abbiamo già visto, fu la prima ad arrivare in Europa. Originaria degli Stati Uniti centrali e meridionali e del Messico, è una annuale o perenne di breve vita con fiori del disco porpora e fiori ligulati gialli con punte rosse, oppure interamente gialli o rossi. Se ne coltivano alcune serie migliorate, con fiori doppi. La specie più diffusa in coltivazione è però G. aristata; fu raccolta per la prima volta nel 1806 in Montana durante la spedizione di Lewis e Clark; di dimensioni molto maggiori della precedente, è una perenne caratterizzata da fiori sfrangiati con fiori del disco arancione-rossastro e fiori ligulati gialli oppure bicolori, rossi con apici gialli. Nel 1857 in un giardino belga le due specie furono incrociate, producendo G. x grandiflora, che fu poi pubblicata da van Houtte. E' una perenne a breve vita cespugliosa con capolini che possono superare i 10 cm di diametro, con fiori del disco giallo-bruni e fiori del raggio gialli, soffusi di rosso alla base. Ne sono però state selezionate molte cultivar con altre combinazioni di colori. Qualche approfondimento nella scheda. Nel Cinquecento il mercato editoriale tedesco è uno dei più vivaci centri della produzione di testi di botanica e "materia medica". Da una parte ci sono le opere in latino, spesso innovative e scritte da studiosi con una preparazione filologica o medica come Brunfels e Fuchs, che si rivolgono soprattutto a medici e studenti di medicina; dall'altra c'è una vasta produzione di Krauterbucher, "libri di erbe", che a parte qualche eccezione (come il New Kreütter Büch di Bock), sono per lo più rifacimenti di erbari manoscritti medievali, dal contenuto ben poco originale; di carattere eminentemente pratico, ma anche ricchi di curiosità, soddisfano un pubblico molto più ampio e poco esigente, che comprende farmacisti, padri di famiglia, semplici curiosi. Requisito essenziale del loro successo sono le illustrazioni xilografiche che, proprio come i testi, passano disinvoltamente da un'edizione all'altra. Tra i protagonisti di questo mondo editoriale di riedizioni, rifacimenti, riscritture, maestro del copia-incolla, è il medico e botanico Adam Lonitzer; nella maturità, divenuto egli stesso editore dopo aver sposato la figlia di uno dei maggiori stampatori e editori tedeschi, seppe fare del suo Kräuterbuch un long seller che gli sopravvisse per due secoli: uscito per la prima volta nel 1557, raggiunse infatti 27 edizioni, l'ultima delle quali è del 1783. Come gli altri autori di questo tipo di prodotto, fu anch'egli poco più di un abile compilatore; il genere Lonicera, dedicatogli da Linneo raccogliendo un suggerimento di Plumier, non premia dunque né l'originalità né la profondità di pensiero, ma il successo di un libro che ancora nel Settecento non mancava nella biblioteca di ogni studioso di botanica. 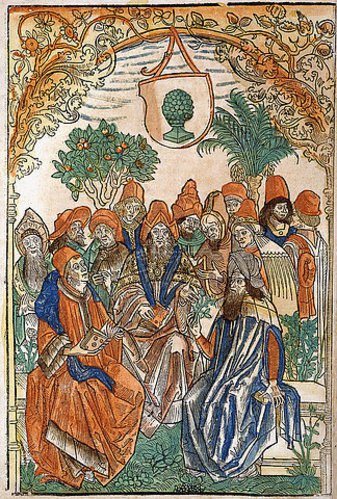 Successi commerciali e una causa per plagio Con l'invenzione della stampa, i libri si fanno più accessibili e incominciano a raggiungere un pubblico più ampio. Accanto alla Bibbia e ai classici, tra i primi testi a suscitare l'interesse di stampatori e lettori ci sono anche i manuali di medicina pratica e i libri di erbe. Particolarmente vivace è il mercato tedesco, dove il primo erbario (noto come Herbarius latinus o Herbarius moguntinus, "erbario di Magonza") venne stampato nel 1484 da Peter Schöffer, il principale collaboratore di Gutenberg; entro il 1499 giunse a toccare undici edizioni. L'anno successivo lo stesso Schöffer dava alle stampe il primo Krauterbuch ("libro d'erbe") in lingua tedesca, Gart der Gesundheit (corrispettivo del latino Hortus sanitatis), attribuito al medico della città di Francoforte Johann Wonnecke von Kaub, anche noto con il nome latinizzato Johannes de Cuba. Anche quest'opera nell'arco di pochi anni ebbe molteplici edizioni nonché adattamenti e traduzioni. Mentre l'erbario latino si rivolgeva al pubblico più tradizionale dei medici e dei farmacisti, quello in lingua locale rispondeva alle esigenze e alle curiosità di una sempre più vasta fascia di lettori che non conoscevano il latino. Né l'uno né l'altro erano opere dal contenuto originale, ma compilazioni basate sugli erbari manoscritti medievali, risalenti a loro volta ai rifacimenti medievali di Dioscoride, magari attraverso la mediazione araba. A costituire un valore aggiunto erano soprattutto le illustrazioni xilografiche, apprezzate anche dagli illetterati. A capirlo perfettamente fu il tipografo-editore Christian Egenolff (1502-1555), che operava sulla importante piazza di Francoforte sul Meno. Dotato di grande fiuto commerciale, era un editore eclettico che pubblicava di tutto, incluse partiture musicali. Nel 1533 entrò nel mercato degli erbari illustrati pubblicando Kreutterbuch von allem Erdtgewächs, un rifacimento del libro di Johannes de Cuba curato dal medico cittadino Eucharius Rösslin. Per illustrarlo, fece eseguire solo poche nuove xilografie, prendendo le altre (rimpicciolite e ruotate di 180 gradi) da Vivae icones herbarium di Brunfels, pubblicata l'anno prima a Strasburgo dell'editore Schott. Quest'ultimo, che aveva ottenuto un privilegio imperiale che gli concedeva l'esclusiva dell'opera per sei anni, lo citò in giudizio presso la Suprema corte di giustizia dell'Impero. In quella che può essere considerata la prima causa per plagio della storia dell'editoria, Egenolff si difese sostenendo in primo luogo che copiare da un libro vecchio di trenta o quarant'anni è lecito, anzi in questo caso benemerito, considerando i benefici che ne derivano per la salute pubblica; in secondo luogo, la sua non poteva considerarsi una copia del volume di Brunfels, visto che, oltre ad avere un testo completamente diverso, conteneva anche immagini originali; in terzo luogo, il privilegio editoriale riguardava la trattazione delle piante, non le loro forme: queste le impone la natura, e qualsiasi illustrazione delle piante non potrà che assomigliarsi. Un argomento specioso, ma che ben testimonia il nuovo modo rinascimentale di concepire la natura e la sua rappresentazione. Non sappiamo come finì la causa, ma è certo che Egenolff continuò imperterrito a illustrare i suoi numerosi libri di medicina e botanica con xilografie altrui. Erano pubblicazioni pensate per grandi tirature, né innovative né originali nei contenuti, ma perfette per il gusto del largo pubblico. Insomma, una specie di Reader's Digest del Rinascimento. Inoltre, per conquistare un'ulteriore fetta di mercato, Egenolff, seguendo l'esempio di Isengrin, l'editore di Fuchs, nel 1546 pubblicò un album costituito unicamente da immagini, prevalentemente di piante ma anche di animali, minerali e manufatti utilizzati in farmacia con il titolo Herbarum, arborum, fruticum, frumentorum ac leguminum... iconae. Non c'è bisogno di dire che anche in questo caso si trattava di xilografie pirata (copiate tra l'altro anche da opere di Fuchs). Sebbene non sia indicato il nome del curatore del testo, limitato all'indice e ai nomi latini e tedeschi dei semplici, gli studiosi lo identificano in Adam Lonitzer, all'epoca insegnante di matematica e promettente studente di medicina. 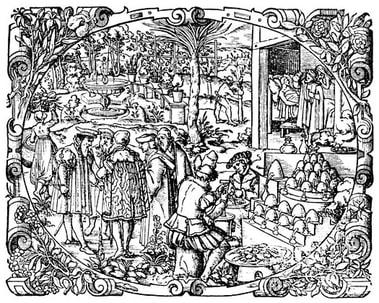 Un insuccesso editoriale e un long seller Figlio di un filologo e docente universitario di lingue classiche, Adam Lonitzer (Lonicerus nella forma latinizzata) aveva probabilmente familiarità con il mondo editoriale fin dall'infanzia. Dopo aver studiato filosofia e medicina nella sua città natale, Marburg, per completare gli studi nel 1545 si trasferì a Francoforte, dove probabilmente poco dopo entrò in contatto con Egenolff, con cui collaborò come correttore di bozze e curatore di volumi di medicina. Egenolff, che continuava a sfruttare il successo commerciale del vecchio testo di Johannes de Cuba (dopo il rifacimento di Rösslin, nel 1540 ne aveva pubblicato un'ulteriore edizione, con il titolo Botanicon, firmata da Theodor Dorstein), pensò di affidargli un'opera decisamente più ambiziosa. In effetti quel filone d'oro stava ormai esaurendosi, reso obsoleto dalle opere dei grandi botanici del Rinascimento come Mattioli, Gessner, Bock e Fuchs. Lonitzer, pur basandosi ancora una volta su quel vecchissimo testo, avrebbe dovuto attualizzarlo, dandogli una patina di novità grazie alle informazioni attinte dai più affermati moderni. Egenolff puntò su un'edizione di lusso: in lingua latina, con il titolo pliniano Naturalis historia, erano due grossi volumi in folio di 744 pagine con oltre 700 xilografie; inoltre, a quanto pare, fu messa in commercio solo la versione con le tavole acquarellate a mano (che mediamente costava il doppio di quella in bianco e nero). Per una volta, il fiuto commerciale di Egenolff sembrò venuto meno. Fu un clamoroso flop, se ancora quattordici anno dopo, nel 1565, i suoi eredi cercarono di liberarsi delle copie invendute cambiando il frontespizio per spacciarle per un'opera nuova intitolata Botanicon. In effetti, il vecchio Egenolff aveva sbagliato il target: un'opera così costosa, scritta in latino, avrebbe dovuto trovare il suo pubblico tra i dotti, agli occhi dei quali, per abile che fosse stato Lonitzer nel suo copia-incolla, si palesava immediatamente per quello che era: un centone, un patchwork con ben poca originalità. Nessuna originalità neppure nelle tavole, riciclate da opere precedenti della casa editrice e in buona parte piratate. Intanto Lonitzer faceva carriera. Nel 1553 ottenne una cattedra di matematica a Marburg e nel 1554 conseguì il dottorato in medicina; lo stesso anno fu nominato medico della città di Francoforte (incarico che avrebbe mantenuto fino alla morte, nel 1586) e sposò Magdalena, una delle figlie di Egenolff, legando per sempre le sue sorti alla casa editrice di cui, dopo la morte del suocero, nel 1555, divenne una specie di direttore editoriale. E in tale veste riuscì ad ottenere il più grande e più duraturo successo della ditta: il suo Kräuterbuch, prima edizione 1557, cui avrebbero fatte seguito altre tre durante la sua vita (1564, 1573, 1578); con rifacimenti e riadattamenti, questo long seller avrebbe totalizzato ventisette edizioni, l'ultima delle quali nel 1783. E che cos'era questo prodotto editoriale di successo? Nient'altro che la catastrofica Historia naturalis che, tradotta in tedesco, aveva finalmente trovato il suo pubblico: non più i facoltosi, dotti e smaliziati ma riluttanti acquirenti della versione latina, ma lettori di media cultura, più interessati a informazioni pratiche esposte in modo chiaro che a disquisizioni filologiche sull'identificazione delle piante di Dioscoride e Teofrasto. Del resto, sebbene sia fondamentalmente il frutto di un abile lavoro di copia-incolla, l'opera di Lonitzer ha il pregio della chiarezza e, soprattutto nella parte botanica, contiene anche qualche informazione tratta dall'esperienza diretta di medico e osservatore della natura. Ad esempio, egli fu il primo a segnalare e descrivere l'agente dell'ergotismo, il fungo parassita della segale Claviceps purpurea. Tra le parti più apprezzate del suo erbario, il primo ampio capitolo, dedicato alla distillazione. L'arte della distillazione, sconosciuta agli antichi, era un'invenzione araba che si era diffusa in Occidente nel corso del Medioevo; era dunque ancora relativamente recente e quanto mai necessaria a medici e farmacisti, perché permetteva di ricavare gli estratti alcoolici poi utilizzati per la preparazione dei farmaci. Intendiamoci, neppure qui non c'è nulla di nuovo o originale: Lonitzer riprese le sue informazioni da fonti precedenti, in particolare dal Liber de arte distillandi de simplicibus di Hyeronimus Braunswig. Tuttavia la sua esposizione e le immagini che accompagnano il testo sono tanto chiare e dettagliate che un'équipe internazionale di ricercatori le ha utilizzate per ricostruire sperimentalmente il processo di distillazione del XVI secolo. Sicuramente proprio questa parte contribuì non poco al successo del libro, tanto più che Lonitzer seppe valorizzarla fin dal frontespizio dove, sulla sinistra, in primo piano è rappresentato un farmacista che, assistito da un aiutante, sta distillando i semplici. Inoltre, c'erano anche informazioni sulla coltivazione dei giardini, anch'essa raffigurata nel frontespizio, in secondo piano sulla destra, dietro a un gruppo di dottori a consulto. Una sintesi della vita di Lonitzer come sempre nella sezione biografie.  Lonicera: bellezza e profumo Campione di vendite, il nome di Lonitzer era dunque ben noto ai cultori di botanica; grazie a questa fama Plumier gli dedicò uno dei suoi nuovi generi americani, battezzato Lonicera sulla base del cognome latinizzato Lonicerus. D'altra parte, è probabile che egli conoscesse solo i titoli dei suoi libri, visto che nella nota che accompagna la dedica cita come tre opere distinte Historia naturalis, Botanicon e un "herbarium vernacula lingua", ovvero il Krauterbuch. Il genere Lonicera di Plumier non è per altro quello a noi oggi familiare: appartenente alla famiglia Loranthaceae, corrisponde all'attuale genere Psittacanthus, che riunisce alcune piante parassite delle Antille e del Centro America affini al vischio. Se non fosse in contrasto con la candida personalità del buon padre Plumier, si potrebbe sospettare uno di quei ritratti vegetali al vetriolo che tanto deliziavano Linneo. Invece quest'ultimo, che aveva una copia del Krauterbuch nella sua biblioteca, volle dedicare al nostro protagonista un genere diverso e ben più importante, forse riconoscendo l'apporto di Lonitzer alla divulgazione del sapere botanico tra il vasto pubblico. Lo scrittore tedesco ci guadagnò immensamente nel cambio, aggiudicandosi Lonicera L., famiglia Caprifoliaceae, un vastissimo genere di oltre 180 specie, molte delle quali sono tra i rampicanti e gli arbusti più coltivati nei nostri giardini. Finalmente possiamo parlare di un genere anche europeo, anzi di uno di più ricchi di specie del nostro continente (ma presente anche in America settentrionale e in Asia; la sola Cina, centro di diversità del genere, ne vanta un centinaio). E quindi abbiamo a disposizione anche un nome comune, caprifoglio (dalla credenza che le capre si nutrissero delle sue foglie). In Italia ne abbiamo una dozzina di specie spontanee, legate ad ambienti diversi, le più note delle quali sono probabilmente la mediterranea L. caprifolium, la madreselva o caprifoglio comune (che dà anche il nome alla famiglia), diffusa in tutta la penisola, ma non nelle isole; l'atlantica L. periclymenum, presente solo nelle regioni settentrionali, il caprifoglio europeo più coltivato, con diverse pregevoli varietà da giardino; la montana L. xylostemum, il caprifoglio peloso, che non è un rampicante, ma un arbusto. Se infatti nell'immaginario collettivo tendiamo ad associare al nome caprifoglio a rampicanti dalle copiose e profumate fioriture, in realtà la maggior parte delle specie sono arbustive. I nostri caprifogli sono coltivati da secoli immemorabili e hanno lasciato la loro impronta anche in letteratura, ad esempio nel Lai du chievrefoil di Marie de France o nella poesia di Shakespeare. Hanno anche ispirato l'arte pittorica, dalle miniature medievali stile mille fleurs alle carte da parati di Morris. A partire dal Settecento, alle europee si è anche aggiunta la popolosa legione straniera delle asiatiche, come la profumatissima L. fragrantissima dalle fioriture precoci; la bella ma iperinfestante L. japonica; le arbustive L. nitida e L. pileata, la prima ottima pianta da siepe, la seconda eccellente tappezzante; L. tatarica, un grande arbusto dalla fioritura abbondante e prolungata. Già da un secolo era arrivata L. sempervirens, il caprifoglio della Virginia, con brillanti fiori tubolari che nel paese d'origine sono la delizia dei colibrì. Ma l'elenco potrebbe continuare, tanto più che alle già numerose specie si sono aggiunti molti ibridi orticoli. Su almeno qualcuno troverete qualche informazione nella scheda. Anche se per volontà dell'imperatrice, dell'ammiragliato e dell'Accademia delle Scienze, si era trasformata in una impresa monstre con molti obiettivi collaterali, lo scopo principale della Grande spedizione del Nord era pur sempre riprendere e completare quanto era stato fatto da Bering con la prima spedizione in Kamčatka: confermare che non c'era continuità territoriale tra Asia e America e raggiungere il continente americano, in vista di un possibile insediamento russo. Affidata a Bering in persona, l'impresa, dopo una preparazione decennale, per una serie di coincidenze, errori e fatalità si volse tuttavia in catastrofe, con la morte di ben 30 dei 74 membri dell'equipaggio della nave ammiraglia. Tra i sommersi, lo stesso Bering, morto nell'isola che oggi porta il suo nome insieme a un terzo dei suoi uomini. Tra i salvati, il naturalista tedesco Georg Wilhelm Steller, il primo scienziato ad esplorare la fauna e la flora dell'Alaska (sia pure per sole dieci ore); come medico di bordo, se non riuscì a salvare il capitano, strappò alla morte molti compagni, senza mai smettere, in condizioni difficilissime, di studiare e catalogare la natura dell'isola dove erano stati gettati dalla malasorte. Sono celebri soprattutto le sue scoperte zoologiche, con la prima segnalazione della lontra marina e di vari animali che oggi portano il suo nome. Fu tuttavia anche un grande botanico, con notevoli contributi anche alla conoscenza delle flore della Siberia e della Kamčatka. A ricordarlo nella tassonomia botanica fu Linneo, che volle dedicargli il genere Stellera, che oggi comprende una sola specie, l'asiatica S. chamaejasme. Ma, dato che anche i botanici giocano con gli anagrammi, va aggiunto l'indiretto omaggio di Restella. 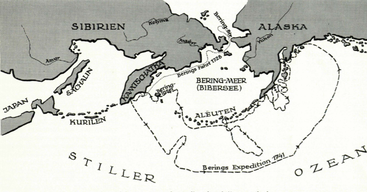 Dieci anni di preparazione... Nel 1728, appena rientrato dalla prima spedizione in Kamčatka, Vitus Bering propose di organizzarne una seconda, con l'obiettivo di raggiungere le coste americane. Dopo alcuni anni di dilazioni, in cui la lista degli scopi da perseguire non fece che crescere, infine nel 1732 fu posto a capo della gigantesca Grande spedizione del Nord, di cui coordinò tutti i distaccamenti. A lui in persona fu affidato il comando di quello più importante, il cui compito, facile a dirsi e difficile da conseguire, era appunto navigare verso est partendo dalla Kamčatka fino ad incontrare le coste americane. Rinunciando all'idea (che comunque venne messa in campo) di raggiungere la penisola circumnavigando il globo per la via di Capo Horn, si decise di inviare uomini e mezzi via terra, attraversando la Siberia. Le navi necessarie alla spedizione sarebbero state costruite sul posto, ovvero a Okhotsk, l'unico porto russo sul Pacifico. Guidati da Bering e dai suoi secondi Spanberg e Čirikov, i distaccamenti che avrebbero esplorato il Pacifico si misero in marcia tra febbraio e aprile 1733; a percorrere l'enorme distanza ci vollero oltre due anni. Dopo un primo inverno trascorso a Tobolsk, Bering stabilì infine il suo quartier generale a Yakutsk. Dovendo fare i conti, oltre che con la mancanza di strutture, con l'inerzia quando non con l'ostilità delle autorità locali, dovette trattenersi qui circa tre anni per predisporre le attrezzature e le provviste e sorvegliare la costruzione delle imbarcazioni che avrebbero risalito il fiume Lena e l'allestimento dei collegamenti con Okhotsk, dove già era stato spedito Spanberg. Solo nell'estate del 1737, dopo essere stato raggiunto anche dal distaccamento dell'Accademia, Bering partì per Okhotsk. Ma il naturalista che lo avrebbe accompagnato nell'ultimo viaggio non fu uno dei professori dell'Accademia, bensì il medico tedesco Georg Wilhelm Steller, aggregatosi alla spedizione come membro aggiunto solo in un secondo tempo. E' ora dunque di fare entrare in scena il nostro protagonista, e che protagonista! Figlio di un organista e cantore luterano, nato nel 1709 a Windsheim in Franconia con il nome di Georg Wilhelm Stöller, fu destinato dalla famiglia a divenire pastore; dapprima seguì i corsi di teologia a Wittenberg, ma ben presto li abbandonò per la sua vera vocazione, le scienze naturali. Si spostò così a Berlino dove si laureò in medicina presso l'Obercollegium. Fresco di laurea, nel 1734, inseguendo il suo "desiderio insaziabile di visitare paesi stranieri", si imbarcò come medico di bordo su una nave militare russa; si racconta che, giunto a san Pietroburgo senza un soldo e senza appoggi, fosse caduto in tale miseria da essere costretto a dormire nei portoni. Un giorno, mentre visitava l'orto botanico, si sarebbe imbattuto per caso nell'arcivescovo Feofan Prokopovič, stretto collaboratore di Pietro il Grande e uno dei fondatori dell'Accademia delle scienze, che, colpito dal suo fluente latino, lo assunse come medico personale. Ma la storia vera è probabilmente meno romantica: forse quell'incontro casuale ci fu davvero, ma a conquistare la fiducia dell'ecclesiastico contribuirono le lettere di raccomandazione del professore di Berlino di Stöller, Friedrich Hoffmann, membro corrispondente dell'Accademia russa delle Scienze. Il giovane medico tedesco, che nel frattempo aveva cambiato il cognome da Stöller a Steller (più facile da trascrivere in cirillico), lavorò per due anni per l'ecclesiastico che lo introdusse negli ambienti accademici; un altro tedesco, Johann Amman, che insegnava botanica all'Accademia, lo prese come proprio assistente. Con il titolo di membro aggiunto, Steller poté così presentare la sua candidatura per partecipare come volontario alla spedizione in Kamčatka, che venne accettata nel gennaio 1737. Prima di partire per l'Oriente, egli si sposò con la giovane vedova di un altro studioso tedesco, Daniel Gottlieb Messerschmidt, che aveva esplorato la Siberia per sette anni, non sappiamo se più attratto dalle grazie di lei o da quelle dei quaderni di campo che il primo marito le aveva lasciato in eredità. Poté partire solo un anno dopo, nel gennaio 1738; aveva sperato di avere la compagnia della sposa Brigitta, ma, giunta a Mosca, la giovane donna rifiutò di proseguire. Steller si rassegnò così a continuare il viaggio da solo. Al contrario dei professori dell'Accademia, che viaggiavano in comode e calde carrozze o slitte, riveriti e serviti da decine di servitori, si muoveva con un piccolo calesse, con un equipaggiamento spartano, provvedendo a tutto da sé. Ma in questo modo era anche molto più veloce e dopo un anno e mezzo li raggiunse a Enisejsk. Steller era un ottimo naturalista, che si era preparato al suo compito leggendo tutto il leggibile sulla natura siberiana, ma era anche uno spirito libero e un caratteraccio, dipinto da qualche biografo come un attaccabrighe per non dire un asociale; Gmelin fu ammirato dalla sua preparazione e dal suo ardore scientifico, ma anche scioccato dalle sue abitudini e dal suo aspetto poco presentabile: "Non si preoccupava certo dei suoi vestiti. Dato che in Siberia è necessario portare con sé il proprio equipaggiamento, lo aveva ridotto a una bussola. Aveva rinunciato al vino e beveva tanto la birra quanto l'acquavite nella medesima tazza. Aveva un solo piatto dal quale mangiava qualsiasi cibo. Per questo non aveva bisogno di un cuoco e cucinava tutto da sé, accontentandosi di pochissimo e magari cucinando insieme zuppa, verdure e carne. Non usava né parrucca né cipria e qualsiasi tipo di calzatura gli andava ugualmente bene. Le più povere condizioni di vita non sembravano dargli fastidio, anzi più c'erano contrattempi, più sembrava contento. D'altra parte, nonostante il completo disordine del suo modo di vivere, si è sempre dimostrato estremamente meticoloso nelle sue osservazioni e instancabile in tutte le sue imprese". Gmelin fu dunque felicissimo di spedirlo immediatamente in Kamčatka, dove non aveva alcuna intenzione di andare di persona e già aveva inviato il suo allievo Krašeninnikov. Dopo solo sette settimane trascorse con Gmelin e Müller a Eniseisk, nel marzo 1739 dunque Steller ripartì: dedicò la primavera e l'estate all'esplorazione della regione del Baikal e, dopo aver trascorso l'inverno a Irkutsk, si unì al gruppo accademico che doveva esplorare la Kamčatka; oltre a lui ne facevano parte l'astronomo Louis de l'Isle de la Croyère, l'artista Johann Christian Berkan (1709-1751) e lo studente A. P. Gorlanov. Nell'agosto 1740, il gruppo arrivò infine a Okhotsk dove Steller incontrò per la prima volta Bering e gli comunicò il suo vivo desiderio di esplorare terre sconosciute.  Dieci ore di esplorazione e un tragico epilogo Torniamo dunque a Bering e ai suoi lunghissimi preparativi. Quando egli giunse a Okhotsk, nel corso del 1737, dovette subito far fronte ai soliti problemi logistici; il più grave era la mancanza di legname, visto che negli anni precedenti erano già state costruite, oltre alla nave appoggio Fortuna, che assicurava il collegamenti con la Kamčatka, i vascelli Gavril, Nadezda e Arkangel Mikhail, che sotto il comando di Spanberg sarebbero stati inviati ad esplorare le Curili. Non mancavano anche fibrillazioni nell'ammiragliato, visto che i costi e gli anni (inizialmente ne erano stati preventivati quattro) erano lievitati a dismisura. Soltanto nel 1740 furono infine pronte le due navi destinate al viaggio americano: la San Pietro (Sv. Petr) comandata dallo stesso Bering e la San Paolo (Sv. Pavel), affidata a Čirikov. Nel frattempo, Steller era arrivato in Kamčatka, dove un po' bruscamente aveva imposto la sua autorità a Krašeninnikov. Giunto qui nel settembre 1740, trascorse l'inverno nel forte di Bolšeretsk, dove, oltre a dedicarsi a studi naturalistici e etnografici, aprì la prima scuola destinata alla popolazione locale, verso la quale, al contrario dell'"imperialista" Krašeninnikov, aveva un atteggiamento aperto e solidale. Insieme a lui, nel febbraio 1741 fece una spedizione in slitta fino al Capo Lopatka, nel corso della quale ebbe a scoprire il primo degli animali marini che porta il suo nome, il leone marino di Steller, Eumetopias jubatus. Intanto Bering con la San Pietro e la San Paolo si era spostato nella baia dell'Avača sulla costa pacifica della Kamčatka, dove su suo ordine era stata creata una base con infrastrutture portuali, abitazioni e magazzini (dal nome delle due navi sarebbe stata chiamata Petropavlovsk; oggi è la capitale e la principale città della penisola). A febbraio scrisse a Steller, invitandolo a unirsi alla sua spedizione come medico di bordo e mineralista; non c'è bisogno di dire che Steller accettò con entusiasmo e all'inizio della primavera raggiunse la baia dell'Avača in slitta. Dopo dieci anni di preparativi, la seconda spedizione in Kamčatka stava finalmente per cominciare, segnata fin da subito da contrattempi e errori che si rivelarono fatali. In primo luogo, la partenza fu ritardata dall'attesa della nave d'appoggio Nadezda, prima trattenuta in porto da una tempesta poi incagliata in un banco di sabbia (privando in tal modo la spedizione dei biscotti che avrebbero permesso di svernare in America). Questo primo incidente ne causò un secondo: le provviste rimanenti dovettero essere trasportate via terra da Bolšeretsk; mancando di uomini, slitte e cani, Bering obbligò al servizio forzato alcuni Coriachi che, allontanati da casa e costretti a una semi schiavitù, si ribellarono, uccidendo sette russi. Seguì una spaventosa spedizione punitiva, che comportò la deportazione dei maschi adulti, l'uccisione di donne e bambini, la fuga o il suicidio di chi non voleva cadere in schiavitù. Uno choc per Steller, un luterano educato al pietismo, che perse ogni stima e rispetto per il comandante. Aggiungiamo un'ultima circostanza. Come vedremo, molti giorni preziosi furono sprecati su una rotta sbagliata, alla ricerca della mitica Terra di Joao da Gama (o Gamaland), un inesistente territorio che avrebbe dovuto trovarsi a nord tra l'Asia e l'America; inesistente ma indicato nella mappa predisposta dal geografo ufficiale della spedizione, Louis de l'Isle de la Croyère, e dai suoi fratelli Guillaume e Joseph-Nicolas. Finalmente le due navi partirono da Petropavlovsk il 4 giugno 1741. Dopo aver seguito per nove giorni una rotta in direzione sudest, dove si supponeva trovarsi Gamaland, virarono verso nordest. Il 20 giugno si imbatterono in una fitta nebbia in cui si persero di vista. Čirikov, mantenendo la rotta a nordest, dopo circa un mese avvistò terra (presumibilmente una piccola isola di fronte all'isola Principe di Galles, nell'Alaska sudorientale); inviati a terra successivamente due uomini, che non fecero ritorno, rinunciò a sbarcare, e, dopo aver avvistato la penisola di Kenai e l'isola di Afognak, dal momento che a bordo incominciava a imperversare lo scorbuto, attraverso le isole Aleutine fece rotta per la Kamčatka, dove era di ritorno in ottobre. Pochi giorni dopo, proprio di scorbuto morì de l'Isle de la Croyère, che era imbarcato sulla San Paolo. Al contrario del suo secondo, dopo la separazione delle due navi, Bering si ostinò a ricercare la Terra di Joao da Gama, indotto in errore anche da Steller che, osservando le alghe portate dalla corrente e la presenza di uccelli terrestri, credette prossima una terra in direzione sudest. Dopo altri quattro giorni perduti, cambiata finalmente rotta, la San Pietro il 16 luglio avvistò in lontananza un'alta montagna coronata di neve, che il capitano chiamò Monte Sant'Elia in onore del santo la cui festa cadeva il 20 luglio, giorno in cui finalmente toccarono terra in una piccola isola, che è stata identificata con Kayak Island, nel golfo d'Alaska. Bering intendeva fermarsi solo il tempo necessario per rinnovare le provviste di acqua dolce; Steller, incredulo, lo pregò prima con le buone poi con le cattive di permettergli di esplorare l'isola. Dopo un violento diverbio, in cui il naturalista minacciò Bering di deferirlo al senato di San Pietroburgo, il comandante si piegò e gli concesse... dieci ore! Dieci ore di esplorazione scientifica costate dieci anni di preparazione, come ebbe più tardi a scrivere l'amareggiato Steller. Come non capirlo! Ma proviamo a metterci nei panni di Bering: sapeva che il tempo per completare il viaggio senza mettere a repentaglio la nave e i suoi uomini era ormai agli sgoccioli. Bisognava rientrare alla base entro ottobre, per evitare di incappare nelle tempeste che a partire da quel mese rendevano impossibile la navigazione nel Pacifico settentrionale; inoltre ogni viaggio per mare che si prolungasse per più di due mesi metteva gli uomini a rischio di ammalarsi di scorbuto (una malattia devastante causata dalla carenza di vitamina C, le cui cause all'epoca erano ancora ignote o mal comprese). Dunque la sua fretta è più che comprensibile. In ogni caso, il nostro naturalista mise a frutto il poco tempo a disposizione e in quella mezza giornata si diede alla raccolta frenetica di piante, minerali e animali. L'incontro con quella che sarebbe stata chiamata ghiandaia di Steller (Cyanocitta stelleri) gli confermò che avevano toccato il continente americano, per la sua somiglianza con la ghiandaia americana (Cyanocitta cristata), che gli era nota grazie alle sue letture. Fu anche il primo scienziato europeo a vedere le lontre marine (che, come scopriremo nei prossimi post, occuperanno un ruolo importante nella storia dell'esplorazione russa del Pacifico settentrionale). Durante la sua escursione, Steller vide anche in lontananza i fumi di un insediamento indigeno e chiese al capitano di inviare una barca ad esplorarla; la risposta di Bering fu assai poco diplomatica: "Porta subito il tuo culo a bordo, se non vuoi che ti lasci a terra". Steller dovette ubbidire. Una volta salito sulla nave con le sue preziose raccolte, dovette subire un ultimo oltraggio: senza fare una piega, Bering fece voltare fuori bordo un esemplare di Rubus spectabilis (salmonberry), che gli sembrava perfettamente identico ai lamponi di casa. Il viaggio di ritorno cominciò così con il comandante e il suo naturalista ai ferri corti, potremmo dire separati in cabina, visto che Steller condivideva la cabina di Bering. Dopo aver costeggiato l'Alaska meridionale, la rotta seguì la cresta delle isole Aleutine, dove in brevissime soste Steller ebbe modo di raccogliere altri esemplari naturalistici e oggetti etnografici. Poté anche osservare molti animali marini. Intanto, uno dopo l'altro, gli uomini cominciarono ad ammalarsi di scorbuto. Il primo a morire fu il marinaio Nikita Šumagin, che venne sepolto in una di quelle che Bering in suo ricordo battezzò isole Šumagin. Mentre l'autunno incombeva e i venti battevano la nave, le condizioni a bordo erano sempre più drammatiche. Quando raggiunsero quella che credevano la costa della Kamčatka, su 78 uomini, 12 erano già morti e 49 ammalati; solo una decina di uomini aveva forze sufficienti per manovrare la nave, che il 10 novembre fece naufragio sulle scogliere in un'isola sconosciuta (oggi porta il nome di Bering). Lotta per la sopravvivenza e scoperte scientifiche Il primo a scoprire che non si trattava della Kamčatka fu proprio Steller, vedendo piante e animali che non aveva incontrato nel continente. Grazie a ciò che aveva appreso sia dalle letture sia dai contatti con le popolazioni native, incominciò subito a cercare piante capaci di combattere lo scorbuto; con un miscuglio di erbe, foglie e bacche, riuscì a mantenere in buona salute se stesso e il proprio servitore, mentre gli ufficiali rifiutavano di cibarsi di quell'intruglio. E così, si continuava a morire. Allo scorbuto e alla scarsità di cibo, si aggiungeva l'inclemenza del clima invernale, con temperature sempre più basse e tempeste devastanti (una delle quali finì di distruggere la San Pietro) e le incursioni degli animali selvatici, come le volpi artiche che non esitavano a penetrare nell'accampamento di quegli sventurati e ad azzannare quelli che lottavano tra la vita e la morte, come Bering (che morì l'8 dicembre; altri 17 uomini subirono la stessa sorte). Vedendo che si manteneva in buona salute, i suoi compagni incominciarono a prendere sul serio Steller e ad accompagnarlo a caccia o alla ricerca di erbe. Insieme a tre di loro, egli scavò nella sabbia dei rifugi dove dormire al riparo delle volpi; riuscì a cacciare queste ultime dal campo e a salvare i superstiti nutrendoli con biscotti intinti in grasso di foca e carne di lontra (efficace contro lo scorbuto perché relativamente ricca di vitamina C). Durante l'inverno, diresse la costruzione di un accampamento scavato nella neve. Nonostante tutte queste incombenze, non tralasciò le osservazioni naturalistiche; ad esempio, costruì un capanno proprio nel mezzo di una colonia di foche, dove poté osservarle non visto per sei giorni. La scoperta più sensazionale fu certamente la ritina di Steller (Hydrodamalis gigas), un gigantesco sirenide lungo fino a 8 metri, un esemplare del quale fornì abbondante cibo e calorie ai naufraghi. Purtroppo, per la caccia eccessiva, questa specie si estinse pochi anni dopo. Quando riconobbe in alcuni uccelli una specie che aveva già notato in Kamčatka (un altro degli animali che porta il suo nome, l'edredone di Steller, Polysticta stelleri) capì che la terra ferma non doveva essere lontana e stimolò i compagni a raddoppiare gli sforzi per mettersi in salvo. A primavera l'abilissimo carpentiere della San Pietro, utilizzando quanto rimaneva della nave, riuscì a costruire un battello più piccolo, battezzato con lo stesso nome. Lasciata l'isola Bering il 14 agosto 1742, dodici giorno dopo i 46 superstiti toccavano in salvo la baia dell'Avača. Le avventure di Steller non erano finite: mentre lavora ai suoi manoscritti (la relazione di viaggio, il trattato sugli animali marini De bestiis marinis, la descrizione delle numerose specie di animali e piante raccolte durante il viaggio e nell'isola Bering), continuò ad esplorare la Kamčatka e alcune delle isole Curili; in urto con l'amministrazione locale per le sue simpatie verso i nativi, fu posto sotto accusa e richiamato a San Pietroburgo; mentre era già sugli Urali, fu arrestato e ricondotto a Irkutsk. Scagionato, riprese il viaggio verso occidente ma morì a Tyumen a soli 37 anni. Una sintesi della sua vita avventurosa e travagliata nella sezione biografie.  Stellera, una bellezza pericolosa Steller è noto soprattutto per le importanti scoperte zoologiche, ma quelle botaniche non sono ttrascurabili. Nelle poche ore trascorse in Alaska (durante la sosta a Kayak il 20 luglio e anche più brevemente tra il 30 e 31 agosto a Nagai Island) raccolse e descrisse 143 piante. Non meno significative sono le sue ricerche botaniche nell'isola Bering, in Kamčatka e in Siberia. Tra le piante che lo ricordano nel nome specifico Arabis stelleri, Cassiope stelleriana, Lagotis stelleri, Veronica stelleri, Limnas stelleri, Cryptogramma stelleri. Anche se Steller non poté pubblicare né le sue ricerche né il racconto del proprio viaggio, dopo la sua morte i suoi diari furono pubblicati da Pallas (Reise von Kamtschatka nach Amerika mit dem Commandeur-Capitän Bering) e gli diedero fama europea. Tra i suoi ammiratori, lo stesso Linneo che in Species plantarum (1753) gli dedicò il genere Stellera. Molto più tardivo l'omaggio del botanico russo Nikolaj Turčaninov che nel 1840 lo omaggiò con un secondo genere Stellera; poiché non valido per la regola della priorità, nel 1849 lo sostituì con l'anagrammatico Rellesta (oggi considerato un sinonimo di Swertia). Stellera L. (famiglia Thymelaeaceae) è un genere monospecifico, rappresentato unicamente da S. chamaejasme. Originaria delle regioni montane dell'Asia centrale e meridionale (inclusa la Siberia) è una perenne semilegnosa o un arbustino che, almeno nelle fioriture, ricorda l'affine Edgeworthia con infiorescenze globose assai decorative in diverse sfumature di colori (solitamente rosa, ma anche bianche o gialle). Molto attraente, è adatta ai giardini rocciosi, sebbene la sua coltivazione sia tutt'altro che facile. L'intera pianta è tossica, tanto che anche i suoi fiori sono evitati dagli insetti e nei pascoli di alta montagna del Tibet cinese la sua diffusione è considerata un problema per gli animali. Nonostante ciò, la medicina tradizionale cinese la utilizza da secoli come antinfiammatorio e oggi se ne studiano le proprietà antitumorali. Inoltre in Tibet dalle sue radici si ricava una carta di alta qualità, sottile e allo stesso tempo robusta, oltre che inattaccabile da muffe e insetti. Qualche approfondimento nella scheda.  Restella: un anagramma vegetale La storia tassonomica del genere Stellera è assai travagliata; Linneo gli aveva assegnato due specie (S. chamaejasme e S. passerina, oggi Thymelaea passerina) cui se ne aggiunsero via via altre, fino a raggiungere una dozzina di specie. Più recentemente, con l'eccezione appunto di S. chamaejasme, sono state tutte riassegnate ad altri generi. Uno di essi, indirettamente, si ricollega ancora una volta al nostro eroe. Nel 1886 Eduard August von Regel aveva denominato Stellera alberti un arbusto raccolto da suo figlio Johann Albert durante una spedizione in Asia centrale; nel 1941, la botanica russa Evgenija Pobedimova la separò da Stellera e la attribuì al nuovo genere Restella (anagramma di Stellera). Anche Restella Pobed. appartiene ovviamente alla famiglia Thymelaeaceae, e anch'esso comprende una sola specie, appunto R. alberti. E' un bellissimo arbusto dagli sfolgoranti fiori giallo zolfo, endemico di poche località della catena del Tien Shan in Uzbekistan; benché raro, non è a rischio perché le aree in cui vive sono protette. Anche in questo caso, qualche informazione in più nella scheda. Per completezza d'informazione, segnalo che a Steller sono state dedicati indirettamente altri due generi: nel 1893 da van Thiegem Dendrostellera e nel 1950, nuovamente da Pobedimova, Stelleropsis; entrambi oggi sono confluiti in Diathron. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
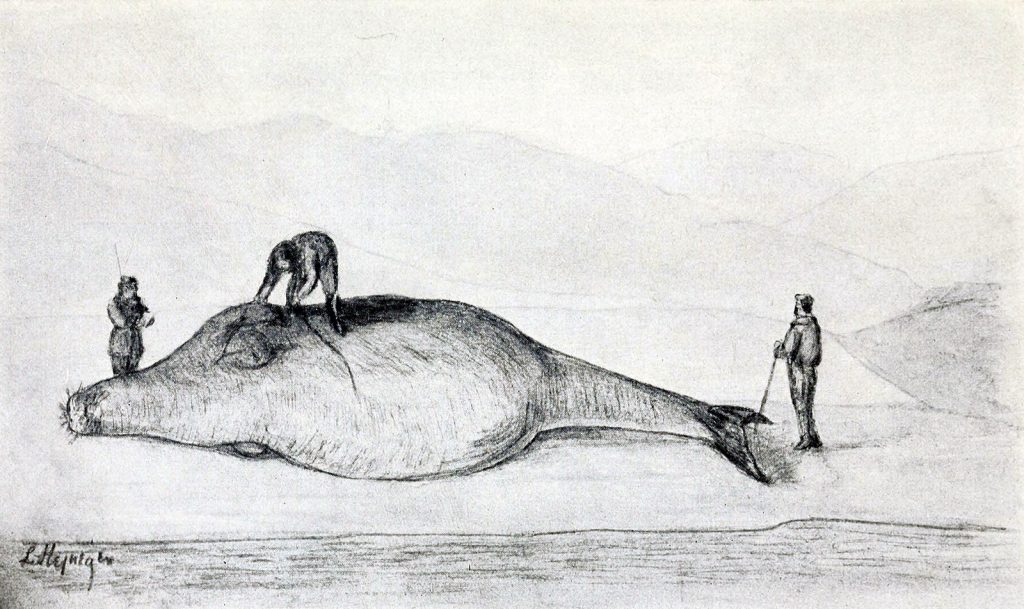

 RSS Feed
RSS Feed