|
Il mercante e alto funzionario della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher si rese benemerito come fondatore e animatore di una delle prime società erudite dell'Asia orientale, la Reale società delle Arti e delle Scienze di Batavia, alla quale donò la prima sede, la propria biblioteca e la propria collezione di curiosità naturali, oggetti etnografici, strumenti musicali, opere d'arte. Anche se non sono giunti fino a noi, c'erano sicuramente anche fogli d'erbario, dato che sappiamo che ricevette campioni dal Giappone da Thunberg ed egli stesso fece raccolte a Giava e inviò exssiccata a Houttuyn. Tra i suoi vasti e variegati interessi c'era infatti anche la botanica, come testimonia una delle sue opere, una lista delle piante dell'isola. A ricordarlo il genere Radermachera, che fu inizialmente descritto proprio sulla base di una specie presente anche in Indonesia. Un dilettante curioso e la nascita di una società scientifica Quando lasciò per la prima volta l'Olanda alla volta dell'Indonesia (le Indie orientali olandesi, come le chiamavano allora), Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783) aveva appena sedici anni. Se non fosse rimasto orfano di padre a sette anni forse non avrebbe avuto bisogno di cercare fortuna in Oriente. La sua era una infatti famiglia influente. Il bisnonno Johan Radermacher era stato balivo di Middelburg e direttore della WIC (la Compagnia olandese delle Indie Occidentali), il padre Johan Cornelis tesoriere generale del principe e primo grande maestro della loggia massonica L'Union. La decisione di mandarlo a Batavia ad imparare il mestiere di mercante nonostante la giovanissima età probabilmente fu presa dallo zio Samuel Radermacher che era uno dei direttori della VOC, come lo sarebbe stato dopo di lui il figlio Daniel. Così il 30 dicembre Jacobus (d'ora in avanti lo chiameremo con il primo nome, come del resto era d'uso) si imbarcò con il grado di sottomercante sulla nave "Middelburg" diretta a Batavia. Qui fece rapidamente carriera, certamente anche grazie alla protezione dello zio e del cugino: un anno dopo era secondo amministratore del Groote Winkel ("grande negozio") e pochi mesi dopo secondo amministratore del Graanmagazijn (il magazzino principale). Il 10 gennaio 1761 gli fu conferito il grado di mercante e il 6 aprile 1762, quando aveva appena 21 anni, fu nominato capo commerciante e contemporaneamente capitano di porto per la popolazione nativa non cristiana. Lo stesso anno, seguendo la tradizione familiare, fondò la loggia massonica La Choisie, la più antica dell'Asia orientale. Nel frattempo si era sposato con Margaretha Verijssel, figlia di un consigliere delle Indie Orientali, e di Sophia Francisca Westpalm, che, rimasta vedova, si era risposata con Reinier de Klerk, all'epoca consigliere straordinario del Consiglio delle Indie. Nonostante la rapida e brillante carriera, Jacobus doveva essere insoddisfatto e chiese di rientrare in patria. Ottenuta l'autorizzazione, nell'ottobre 1763 si imbarcò alla volta dell'Olanda con la moglie. Si stabilì all'Aja e incominciò a studiare legge privatamente; per conseguire la laurea, si iscrisse all'Università di Harderwijk, un diplomificio noto per per conferire diplomi lampo (lo stesso dove una trentina di anni prima si era laureato Linneo): nel suo caso, dall'iscrizione alla laurea passò appena un giorno! Quindi prestò giuramento all'avvocatura di Arnheim, ma qualcosa dovette andare storto e dopo appena sei mesi incominciò a fare pressione sulla direzione della VOC per essere richiamato a Batavia. Incontrò ripetuti rifiuti, forse dovuti all'ostilità che gli aveva procurato il suo scritto "Riflessioni sullo stato attuale dei Paesi Bassi", in cui prendeva atto della crisi della Compagnia, ne criticava le scelte nei confronti dei dipendenti e dei nativi e proponeva una serie di riforme. Aveva idee progressiste anche in altri campi: era contrario alla pena di morte, con l'argomentazione "economicista" che uccidere un reo non portava vantaggio a nessuno, mentre un reo rieducato avrebbe potuto essere utile alla società anche per mezzo secolo. Infine gli fu accordato il permesso di partire, ma a proprie spese e senza alcun incarico ufficiale. Il 20 dicembre la famiglia Radermacher (nel frattempo erano nati due bimbi) si imbarcò sulla nave "Tulpenburg"; il giorno di Natale, mentre erano ancora nella rada di Texel in attesa di un tempo più propizio, il più piccolo dei bimbi morì. Era il mesto inizio di un viaggio difficile, che si protrasse per più di otto mesi e fu segnato dalla morte di un quinto dei passeggeri. Al suo arrivo a Batavia il 21 agosto 1767, Radermarcher, che aveva annotato scrupolosamente gli eventi nel proprio diario di viaggio e aveva incominciato ad interessarsi di cartografia come reazione alle ripetute perdite di rotta, scoprì che nel frattempo era stato nuovamente assunto dalla VOC. La seconda parte della sua carriera non fu più quella di un mercante, ma di un amministratore e alto funzionario. Nel 1768 fu nominato balivo di Batavia, ufficiale giudiziario e curatore della chiesa; nel 1775 consigliere straordinario delle Indie orientali; nel 1777 presidente degli assessori, colonnello della borghesia, presidente del consiglio di amministrazione delle scuole cittadine e commissario delle Terre Alte. Contemporaneamente era diventato uno degli animatori della vita culturale di Batavia; si interessava di tutto (amministrazione, cartografia, geografia, letteratura e linguistica, religione, navigazione, scienze naturali), collezionava curiosità naturali e possedeva una biblioteca aggiornata con libri in varie lingue, un Dictionaire Encyclopedique in 17 volumi e 68 volumi delle opere di Voltaire, di cui evidentemente era ammiratore. Fin dagli anni '60 con alcuni amici, ispirandosi al modello della Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Reale società olandese delle scienze e delle arti) di Haarlem, la più antica e prestigiosa società scientifica olandese, propose di creare a Batavia una società erudita, ma il progetto fu messo da parte per il totale disinteresse dei vertici della società e dei governatori van der Parra e van Riemsdijk. Una svolta si ebbe nel 1777, anno in cui si celebrava il 25esimo anniversario della società di Haarlem; probabilmente grazie al cugino Daniel, che presiedeva diverse società, sia Radermacher sia Reinier de Klerk, il patrigno della moglie Margharete, ne furono nominati amministratori. Poco dopo il governatore van Riemsdijk morì e fu sostituito proprio da de Klerk, che condivideva gli interessi culturali del genero. La strada per la fondazione della Reale società delle scienze e delle arti Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) era spianata. Essa nacque ufficialmente il 24 aprile 1778, con il motto "A beneficio della comunità"; non era un ramo della società di Haarlem, ma una società scientifica indipendente, interessata "alla storia naturale, alle antichità, alla morale e ai costumi del popolo". Ne facevano parte di diritto il governatore generale e alti ufficiali della VOC, tra i quali venne scelto un comitato che si riuniva il primo lunedì di ogni mese al casa di Radermacher. Un anno dopo nel palazzo del governatore si tenne la prima riunione generale in cui Radermacher annunziò tra l'altro la sua intenzione di donare alla società un edificio, i propri libri e le proprie collezioni per allestire una biblioteca e un museo. Suggerì anche di acquistare un giardino dove coltivare le piante native: è considerato il precursore dell'orto botanico di Buitenzorg. La società si diede anche un organo, la rivista Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, che iniziò le pubblicazioni nel 1779. Lo stesso anno il museo venne aperto al pubblico, anche se solo per due ore la settimana, la mattina del mercoledì. Radermacher era il vero animatore sia della società sia della rivista, sulla quale pubblicò una serie di articoli sugli argomenti più diversi; per fare un solo esempio, nel numero del 1780, oltre alla relazione sulle attività annuali, leggiamo suoi saggi sul Borneo, sulla cura della gotta, sulle carte nautiche. Intanto egli aveva raggiunto il culmine della carriera: nel marzo del 1781 in occasione dello scoppio della guerra con l'Inghilterra fu nominato commissario delle opere difensive (ovvero responsabile della difesa di Batavia in caso di attacco inglese) e poco dopo commissario della flotta e dell'esercito, Lo stesso anno subì il grave lutto della perdita della moglie; tuttavia già nel 1783 si risposò con l'adolescente Anna Bosch (lui aveva 42 anni, lei 15). Poco dopo gli giunse la notizia che era stato nominato consigliere ordinario del Consiglio delle Indie orientali. Ma Jacobus aveva altri piani: sempre più sofferente per la gotta che lo tormentava da anni, aveva chiesto di tornare in patria, dove contava di vivere di rendita grazie alla dote della ricca moglie. Il permesso gli venne accordato, anzi venne nominato ammiraglio della flotta di ritorno. Così lui e Anna si imbarcarono sulla nave "Java"; il 24 dicembre, mentre si trovavano al largo, una ventina di marinai cinesi assalì gli ufficiali. Jacobus venne accoltellato a morte, Anna fu ferita ma si salvò. La rivolta fu quasi immediatamente soffocata, gli ammutinati furono rinchiusi nella stiva e il giorno di Natale eliminati uno dopo l'altro con un atto di giustizia sommaria. Per sua fortuna, Frans Reinier, l'unico figlio superstite di Radermacher, era rimasto a Batavia.  Una lista di piante di Giava e una pianta cinese Tra i molteplici interessi di Radermacher c'era anche la botanica. Come commissario delle Terre alte visitò diverse aree dell'isola; conosciamo l'itinerario di due di queste ispezioni: nell'agosto 1776 da Batavia mosse per Krawang, Klapanungal, Buitenzorg, Pondokgede, Tjipanas; nel novembre dell'anno successivo ripercorse la medesima via, per poi proseguire per Megamendung, Telaga Warna, Tjiandjoer e rientrare via Tangerang; nel maggio 1777 fu la volta delle regioni occidentali. Sicuramente approfittò di questi viaggi nell'interno per fare raccolte botaniche e raccogliere informazioni sui nomi e sugli usi tradizionali delle piante di Giava. Anche se non ci è giunto, certamente creò un erbario che entrò a far parte delle collezioni del museo della Società batava delle scienze e delle arti; non a caso, nel primo volume della rivista volle includere istruzioni su come essiccare e conservare i vegetali. Oltre alle raccolte fatte da Radermacher a Giava (e forse a Sumatra), l'erbario presumibilmente comprendeva campioni inviati da Thunberg dal Giappone. Radermacher e Thunberg si erano conosciuti nell'estate del 1775, quando lo svedese era arrivato a Batavia dal Sudafrica; aveva poi proseguito quasi immediatamente per il Giappone, non senza aver preso accordi con Radermacher perché facesse da intermediario con uno dei suoi sponsor, il naturalista Martinus Houttuyn. Il primo di questi invii, spedito da Thunberg a Radermacher a Batavia e da questi inoltrato a Houttuyn ad Amsterdam, dovette raggiungere i Paesi Bassi nel maggio-giugno 1777, come dimostra la nota editoriale dell'ottavo volume della seconda parte di Natuurlijke historie (31 Dicembre 1777) di Houttuyn dove compaiono le prime specie giapponesi. Altre raccolte Thunberg le consegnò di persona quando tornò a Giava da Dejima, nel dicembre 1776. Tra l'altro gli affidò una collezione di pesci, che Radermacher si affrettò a inoltrare ad Houttuyn il quale nel 1782 avrebbe pubblicato 36 specie di pesci giapponesi (21 dei quali nuovi per la scienza) nell'articolo Beschrijving van eenige japansche visschen en andere zee-schepselen (Descrizione di alcuni pesci giapponesi e di alcune altre creature marine). Al secondo passaggio, Thunberg si trattenne a Giava per circa sei mesi e fece estese esplorazioni dell'interno; Radermacher cercò inutilmente di convincerlo a rimanere nell'isola. Anche se non accettò, lo svedese fu profondamente colpito dalla sua personalità e generosità, tanto da dedicargli il genere Radermachia (oggi sinonimo di Artocarpus) con parole di sincera riconoscenza: "Il nome è in onore del sommo mecenate, patrono e massimo fautore delle scienze naturali Jacobus Cornelis Matteus Radermacher, consigliere del Consiglio delle Indie e illustre presidente dell'Accademia delle Scienze di Batavia". Non sappiamo se Radermacher e Houttuyn si conoscessero già in precedenza (è possibile, visto che entrambi erano membri delle società scientifiche di Haarlem e di Vlessingen), ma, oltre a fare "da postino" per gli invii di Thunberg, Radermacher ne aggiunse anche di propri, permettendo al suo corrispondente di pubblicare per primo piante indonesiane come l'albero della canfora di Sumatra Dryobalanops aromaticus. Il suo interesse per la botanica per altro andava oltre i ruoli di mecenate e raccoglitore-collezionista; gli si deve infatti almeno un'opera di botanica, Naamlijst der planten die gevonden worden op het eiland Java (Elenco delle piante trovate sull'isola di Giava) in tre volumi. Il primo, dopo un'introduzione di carattere generale che è anche un omaggio a Linneo di cui viene illustrato sinteticamente il sistema, è costituito dalla descrizione di 99 piante giavanesi, in ordine alfabetico secondo il nome locale. Le descrizioni sono sempre molto sintetiche, ma abbastanza precise. Ad esempio, alla voce Sampar o Tinguli (una delle poche per le quali è fornito anche il nome botanico Cassia fistula), si legge: "Un grande albero con foglie ovali lunghe quattro pollici; fiore con calice a cinque sepali, cinque petali gialli, dieci stami; frutto retto da un gambo rotondo marrone lungo 30 cm che contiene una polpa bianca usata in medicina. Appartiene alla 1a classe Decandria. Il Tingulong descritto da Rumphius è un'altra pianta". Segue un indice in cui, salvo eccezioni, ad ogni specie si fa corrispondere il genere botanico. Da indici sono costituiti anche il secondo e il terzo volume che elencano le piante in olandese, latino, malay (trascritto in caratteri latini). C'è anche una lista dei nomi di Rumphius con i supposti equivalenti latini. Stampata a Batavia nella tipografia della VOC tra il 1780 e il 1782, l'opera ebbe scarsa circolazione ed è stata quasi totalmente ignorata dai botanici successivi. Era tuttavia nota a H. Zollinger e A. Moritzi che proprio in ragione di quest'opera gli dedicarono il genere Radermachera scrivendo: "In onore del sig. J. C. M. Radermacher, che scrisse Naamlyst der planten op het eiland Java e altre opere simili, Batavia 1780-4, amico e protettore di Thunberg, membro del Consiglio delle Indie". La specie sulla base della quale i due botanici svizzeri crearono il genere è R. stricta, oggi R. glandulosa, in precedenza descritta da Blume come Spathoidea glandulosa. È una delle poche specie presenti anche in Indonesia. Infatti il centro di diversità di questo genere dell'Asia tropicale di circa 17 specie delle famiglia Bignoniaceae è la Cina, con sette specie. E alla Cina (anche se il suo areale è molto più vasto) fa riferimento l'eponimo della specie più nota, R. sinica, che da qualche anno ha incominciato ad acquisire in certa popolarità come pianta da appartamento magari in forma di bonsai. Le Radermachera in effetti sono alberi, anche di grandi dimensioni (alcune specie possono raggiungere in 40 metri) con foglie composte sempreverdi e grandi fiori a tromba bianchi, viola o gialli, raccolti in infiorescenze a pannocchia. R. sinica però si adatta anche alla coltivazione in vaso; in queste condizioni mantiene dimensioni contenute (al massimo mezzo metro) e si fa apprezzare per il bellissimo fogliame lucido verde smeraldo, mentre raramente fiorisce. Invece in natura è un albero che può raggiungere i 30 metri con grandi fiori bianchi che si aprono al tramonto e al mattino già sfioriscono. È a questi fiori candidi che deve uno dei suoi numerosi nomignoli "bambola di porcellana"; si riferisce invece ai frutti, lunghe e strette capsule che possono ricordare serpentelli, il soprannome "albero serpente" e al colore delle foglie "albero smeraldo".
0 Comments
La prima metà del Cinquecento, prima che le divisioni religiose e la guerra insanguinassero il paese, fu per le Fiandre un'età d'oro, con un'eccezionale fioritura economica ed artistica. In questo contesto si svilippò anche il gusto per i giardini e le piante rare ed esotiche. Nella progettazione di alcuni di essi fu coinvolto il botanico Carolus Clusius. Dopo aver lavorato come "consulente botanico" per Charles de Saint Omer nel castello di Moerkerke, intorno al 1567 si trasferì a Malines, dove creò e curò il giardino del ricco collezionista Jean de Brancion; forse proprio qui incontrò per la prima volta la giovane nobildonna Marie de Brimeu. Poi la vita (e la guerra) li divisero. Si ritrovarono vent'anni dopo, quando il botanico, lasciata la corte imperiale, viveva a Francoforte, aveva pubblicato molti libri ed era il massimo esperto riconosciuto di piante esotiche, e Marie era diventata la principessa di Chimay e per non rinunciare alla sua fede protestate aveva scelto una vita d'esilio e avea lasciato il marito traditore di quegli ideali. Ora viveva a Leida, dove c'erano molti appassionati di giardini; riprese a scrivere a Clusius, usò tutta la sua influenza per farlo venire a Leida come prefetto dell'orto botanico e non cessò di scambiare con lui lettere e piante anche quando dovette lasciare prima Leida poi i Paesi Bassi. Le sue 27 lettere a Clusius costituiscono una testimonianza storica ed umana eccezionale. A ricordarla (nonostante un piccolo errore) il genere Brimeura, rappresentato anche nella flora sarda. 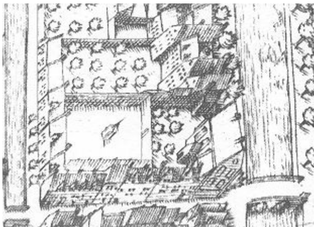 Una donna coraggiosa e un amico ritrovato Con le sue circa 1600 lettere superstiti, l'epistolario di Carolus Clusius costituisce una testimonianza unica della rete che nel secondo Cinquecento univa botanici e amatori di tutta Europa, al di là di ogni frattura politica e religiosa. 377 sono state scritte da Clusius stesso, le rimanenti 1200 gli sono state inviate da circa 335 corrispondenti sparsi in undici paesi; tra di loro, adetti ai lavori come botanici, medici, farmacisti, ma anche un gran numero di appassionati. E appassionate: 110 lettere sono state scritte da 25 donne che, nella maggior parte dei casi, lo interpellavano come esperto di piante rare, chiedevano consigli su come procurarsele e scambiavano con lui semi, talee, bulbi e frutti. Appartenevano tutte all'alta società; le loro lettere sono scritte in francese, tedesco, olandese, mai in latino, la lingua della scienza da cui le donne erano escluse, così come dalle università. Tra queste corrispondenti, per il numero di lettere spiccano l'aristocratica viennese Anna Maria von Heusenstain, con 25 lettere scambiate tra il 1588 e il 1606, e la nobildonna fiamminga Marie de Brimeu principessa di Chimay (ca. 1550-1605) con 27 lettere inviate (nessuna delle risposte di Clusius è conservata). Per l'eccezionalità della sua figura, questa donna, che giocò anche un ruolo politico non irrilevante nelle tormentate vicende dai cui nacque la Repubblica delle Province unite, è sicuramente la più nota e studiata tra le correspondenti di Clusius. Marie apparteneva a una delle principali famiglie dell'aristocrazia francofona delle Fiandre meridionali. La sua prima lettera a Clusius, accompagnata da un dono di melograni e radici di rose muschiate e agrumi, risale al 23 febbraio 1571, quando aveva circa vent'anni e non era ancora sposata; tra le altre cose, la giovane donna ringrazia per l'invio di alcuni semi e ricorda a Clusius la sua promessa di aiutarla a restaurare il suo giardino danneggiato dal maltempo. All'epoca è dunque già appassionata di piante e giardini, e si rivolge al già celebre Clusius - che ha più del doppio dei suoi anni - in tono allo stesso tempo rispettoso ed affettuoso. Probabilmente i due si erano conosciuti a Malines, dove la famiglia di Marie possedeva una casa (e forse il giardino di cui si parla nella lettera), tramite il collezionista Jean de Brancion, presso cui Clusius abitava curandone il giardino. Poi, per vent'anni, la corrispondenza si interrompe. Le lettere intermedie potrebbero essere andate perdute, ma è più probabile che i due si fossero persi di vista. Nel 1573 Clusius fu nominato medico imperiale e lasciò definitivamente le Fiandre; per quasi quindici anni visse tra Vienna e l'Ungheria, per poi spostarsi a Francoforte. Quanto a Marie, nel 1572 ereditò da uno zio la contea di Megen nel Brabante settentrionale; lo stesso anno, o forse alla fine di quello precedente, sposò un esponente dell'aristocrazia militare, Lancelot de Barlaymont; forse visse con lui nel castello di Beauraing nelle Ardenne e ne ebbe due figli, morti nell'infanzia. Intanto era scoppiata la rivolta contro la Spagna; il marito combattè contro i ribelli, si distinse all'assedio di Zichem, ma durante l'assedio di Philippeville si ammalò e morì in giovane età nel 1578. La vedova stava maturando convinzioni politiche e religiose opposte. Fosse l'indignazione per la brutalità delle azioni militari del duca d'Alba (soprannominato il "macellaio delle Fiandre"), oppure lo sgomento per la distruzione delle sue stesse terre - dal 1572 la contea di Megen fu teatro di pesanti combattimenti; il castello, dove probabilmente era nata, fu arso e demolito, e se c'era un giardino, certo non sopravvisse; fatto sta che Marie abbracciò pienamente la causa dei ribelli e si convertì alla fede protestante. Le terre di cui era signora e ciò che aveva ereditato dal marito la rendevano ricchissima; nel 1580 si risposò con Charles III de Croÿ principe di Chimay; il giovane aristocratico aveva dieci anni meno di lei e ne subì a tal punto il fascino da adottarne le scelte politiche e religiose; condivideva anche il suo interesse per le piante e la natura. Per qualche tempo la coppia visse nel castello dei principi di Croy nell'Hainaut, ma anche questo fu danneggiato dalla guerra e, se c'era un giardino, andò certamente distrutto. Intanto la situazione politica andava evolvendo; il nuovo governatore Alessandro Farnese riuscì a riprendere il controllo delle province meridionali che scesero a patti con la Spagna e firmarono l'Unione di Arras che ribadiva la lealtà a Filippo II e al cattolicesimo. Marie e il marito decisero di lasciare segretamente il paese e nel giugno 1582, sfuggendo di misura a un gruppo di cavalieri spagnoli, riuscirono a raggiungere prima Sedan poi l'Olanda. Nel 1583 Charles de Croÿ venne nominato stadtholder delle Fiandre, ma la sua politica moderata lo portò in conflitto con Guglielmo d'Orange; nel maggio 1584 consegnò la città di Bruges ad Alessandro Farnese e ritornò alla fede cattolica. Marie visse queste vicende come un tradimento e decise di separarsi dal marito. Rimase nelle Province unite e visse successivamente in varie città (Middelburg, Delft, Utrecht) finché nel 1590 si stabilì a Leida. Nel 1584, contro le consuetudini, gli Stati Generali stabilirono che la nobildonna - e non suo marito - conservava il pieno controllo dei propri beni. Anche se questa decisione fu all'origine di una controversia legale senza fine con il principe, grazie ad essa Marie poté vivere come donna ricca ed indipendente. Nelle varie case in cui visse successivamente, aveva con sè parenti, amici, dame di compagnia, molti servitori, e per amministrare i suoi beni si avvaleva di segretari, tra cui l'ex predicatore Lieven Calvaert; il fatto che vivesse con lei diede adito a pettegolezzi, scientemente raccolti dal marito che nel 1586 giunse ad organizzare un tentativo di avvelenamento per liberarsene. Non sappiamo se Marie avesse un giardino nelle varie citt olandesi dove visse prima di Leida; probabilmente no, visto che si trattò sempre di sistemazioni precarie e di breve durata. A Leida invece si stabilì in una spaziosa casa sul Rapenburg dotata di un doppio giardino posteriore; solo un muro lo separava dal terreno incolto dove di lì a poco sarebbe sorto l'orto botanico. Qui Marie poté coltivare le piante che tanto amava e strinse amicizia con un gruppo di colte dame che condividevano la stessa passione, tra cui Louise de Coligny, vedova di Guglielmo il Taciturno. Questo circolo prescindeva da differenze religiose: tra le sue più intime amiche c'era anche Stephana van Rossem, che era stata l'ultima badessa del monastero di Rijnsburg smantellato dai protestanti. Marie aveva altri amici con l'hobby del giardinaggio: frequentava le case del mercante Daniel van der Meulen, che come lei aveva un giardino sul Rapenburg, e del patrizio della Zelanda Johannes van Hoghelande, intimo amico e corrispondente di Clusius. Fu probabilmente grazie a queste frequentazioni che nel 1591 riprese a scrivere a quest'ultimo, che le inviò bulbi e semi da Francoforte. La principessa di Chimay giocò indubbiamente un ruolo importante nella venuta di Clusius a Leida. Dovette usare tutta la sua influenza alla corte dell'Aja e negli ambienti universitari per far accettare le condizioni da lui poste - nessun incarico di insegnamento, la disponibilità di un servitore, l'assistenza di un giardiniere -, ma soprattutto fu determinante nel convincere il riluttante botanico ad accettare, nonostante l'età avanzata e i numerosi acciacchi. La nobildonna promise persino di ospitarlo e di mettergli a disposizione metà del suo giardino; e sarà stato forse qui che, in attesa che l'orto botanico fosse pronto ad accoglierli, vennero temporaneamente scaricati i bulbi di tulipano e le piante che Clusius aveva portato con sè da Francoforte. Ammettendo che sia andata così, si trattò di una sistemazione temporanea; poco dopo il suo arrivo, Clusius si stabilì presso una vedova nel Pieterskerkgracht, une via perpendicolare del Rapenburg, dove avrebbe abitato fino alla morte. Egli teneva molto alla propria indipendenza; in una lettera a Camerarius di pochi anni prima scrisse infatti: "A essere sincero, non mi auguro di entrare al servizio di un principe finché sono in grado di mantenermi con le mie entrate, per modeste che siano; perché una persona abituata alla libertà fin dalla prima giovinezza farebbe fatica a dipendere da qualcuno da vecchio". La relazione tra Clusius e la principessa di Chimay non è quella classica protetto-protettore, ma piuttosto un'amicizia tra due persone che condividono la stessa passione. Inoltre, poco dopo l'arrivo del botanico a Leida, Marie dovette trasferirsi a Loo presso all'Aja per essere più vicina alla corte; l'Aja e Leida non sono troppo lontane e non mancarono le visite reciproche, ma soprattutto si intensificò la corrispondenza. Marie scriveva regolarmente a Carolus; le sue lettere seguono per lo più un modello ricorrente: la principessa ringrazia per le piante ricevute, ne chiede altre, riferisce di quelle che non hanno resistito al freddo dell'inverno, racconta dei visitatori che hanno ammirato il suo giardino, si lamenta dei furti (sia lei sia Clusius furono spesso vittime di ladri di piante). Spesso parla della sua salute, sempre più malferma, e si preoccupa di quella dell'amico. Il giardino, di cui è estremamente fiera, è una gioia, anzi "l'unico piacere che oggi ho al mondo". Poi, nel 1600, il distacco più doloroso. Dopo lunghe trattative, Marie si lasciò infine convincere a riconciliarsi con il marito, a patto di mantenere la propria fede e la propria indipendenza. Lasciò dunque i Paesi Bassi per trasferirsi a Liegi, dove però non visse con il marito. Continuò a corrispondere con Clusius, a ricevere piante da lui, a creare giardini. Ma la sua salute, da tempo fragile, continuò a peggiorare, costringendola a trascorrere sempre più tempo in località termali, finché si spense nel 1605, a circa cinquantacinque anni. Clusius, che di anni ormai ne aveva ottanta, le sopravvisse di quasi cinque anni, Com'erano i giardini di Marie de Brimeu? Poiché non li fece mai ritrarre, possiamo ricostruirli soltanto attarverso i cenni contenuti nelle sue lettere a Clusius e le pochissime menzioni che ne fa quest'ultimo nelle sue opere. Secondo Anne Mieke Backer, che ha tentato questa difficile impresa, riflettevano una nuova concezione della natura in cui, all'interesse quasi esclusivo per le piante officinali e a una lora visione dominata dal simbolismo religioso, incominciava a sostituirsi l'interesse per le piante in sè e il godimento per la loro bellezza. Backer fa l'esempio del giglio (Lilium candidum): Clusius gli assegnava un posto centrale nella composizione dei giardini, ma solo per la sua "distinta grandezza e i suoi bei fiori" e non perché fosse una pianta consacrata alla Vergine Maria. Marie, più che una collezionista che si compiaceva di possedere una pianta per la sua rarità - era esattemente l'atteggiamentro del marito principe, che era anche collezionista d'arte e a Beaumont costruì un prestigioso giardino -, era un'amante delle piante, che ricercava per la loro bellezza e per la gioia di disporle nel modo più armonico, in base all'altezza, alla dimensione, al colore e tenendo conto del succedersi delle fioriture. Non si pensi però a un moderno mixed border: il modello cui guardava la principessa era piuttosto quelle delle tapezzerie mille fleurs, nelle quali ciascun fiore spicca sul fondo scuro (quello della terra nuda) e ogni fiore può essere ammirato sia in sè sia come parte di un insieme. Backer propone anche un elenco: ovviamente tulipani e altre bulbose (narcisi, giacinti, Frittilaria meleagris e Fritillaria imperialis, anemoni, ranuncoli,Erythronium dens canis), peonie, diversi tipi di rose, tra cui le rose muschiate, diversi tipi di gigli, Delphinium, cui si aggiungevano piante più comuni e da tempo coltivate, come iris, primule, mughetti, violette, garofani, nontiscordardimé, fiori di trifoglio, pervinche e margherite. C'erano anche piccoli alberi in vaso (melograni e agrumi) che d'inverno venivano portati all'interno. Non c'erano invece fontane, statue, padiglioni, siepi, viali alberati. Quelli di Marie, esule sempre in viaggio, erano giardini temporanei, in cui i fiori e la loro disposizione mutavano da un anno all'altro.  Una piccola bulbosa per le fioriture di primavera Questa donna indubbiamente eccezionale è entrata nel numero purtroppo modesto delle dedicatarie di generi di piante grazie a Salisbury, che però incappò in una curiosa confusione. Nel protologo scrive di aver dedicato il genere Brimeura "a Marie de Brimeur, celebre all'epoca di Clusius per l'amore e la coltivazione dei fiori". Ebbene, tra le corrispondenti di Clusius c'erano due donne dal nome quasi uguale: la nobildonna Marie di Brimeu, che già conosciamo, e Marie de Brimeur, moglie del mercante di Anversa Coenraad Schets, che aveva un bel giardino in questa città negli anni '80 ed è citata due volte da Clusius in Rariorum plantarum historia. Per quanto posedesse un giardino con qualche pianta esotica, non era certo "celebre per l'amore e la coltivazione dei fiori"; dunque è indubbio che Salisbury pensasse alla nostra Marie, ma la confuse con la quasi omonima e aggiunse una r di troppo. Brimeura (Asparagaceae) è un piccolo genere di bulbose endemiche della penisola iberica, della Francia meridionale, delle isole del Mediterraneo occidentale, che comprende tre specie: B. amethystina, B. duvigneaudii, B. fastigiata. Hanno strette foglie lineari e fiori a campana con sei lobi, solitamente azzurri. La più coltivata è B. amethystina (talvolta commercializzata con il sinonimo Hyacinthus amethystinus); ricorda abbastanza da vicino Hyacinthoides hispanica e in primavera produce racemi laschi di fiori campanulati in varie sfumature di azzurro e violetto; la forma 'Alba' è bianca. B. duvigneaudii è un endemismo dell'isola di Maiorca. B. fastigiata, la sola specie della nostra flora, è endemica di Sardegna, Corsica e Baleari. Ogni bulbo produce da due a quattro foglie lineari e canicolate più lunghe degli scapi fiorali; i fiori sono raccolti da due a sei in infioresceze subcorimbose con steli cilindrici di colore rossiccio; dal diametro di circa 6 mm, hanno forma campanulata con tepali divisi fino a poco più della metà in sei lacinie con apici acuti. Il colore varia dal bianco al lilacino più o meno intenso con striature longitudinali più scure. Fiorisce da marzo a maggio. In Sardegna è piuttosto comune, ma spesso passa inosservata sia per le piccole dimensioni sia per l'habitat tipico: vive infatti tra gli arbusti al limitare della boscaglia o della macchia mediterranea. Tra le migliaia di persone che, attratte dalla febbre dell'oro, attorno al 1850 si riversarono in California, c'era anche Hiram Green Bloomer. Della sua vita personale sappiamo poco, ma gli atti dell'Accademia delle scienze della California attestano che fu uno dei sette fondatori e poi me fu un membro molto attivo, rivestendo a lungo il ruolo di curatore del dipartimento di botanica. Fece raccolte sia in California sia in Nevada e, oltre a donare molti esemplari all'accademia, altri ne inviò per la determinazione ai botanici dell'East Cost. Diversi gli furono dedicati da Asa Gray e uno da Sereno Watson. Non amava scrivere, ma era un bibliofilo e collezionista di libri di botanica (non per sé, ma per la biblioteca dell'Accademia); amava invece coltivare le bulbose native, come quella bellissima dai fiori d'oro che l'amico Albert Kellogg vide per la prima volta fiorire nel suo giardino. Gliela dedicò e così nacque il genere Bloomeria (Asparagaceae). 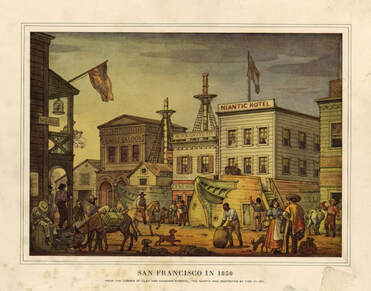 Dalla corsa dell'oro all'Accademia delle scienze Fino al 1846, là dove sarebbe sorta San Francisco, c'era un villaggio di meno di 300 abitanti chiamato Yerba buena (dal nome spagnolo di Clinopodium douglasii, abbondante in quest'area). Poi gli Stati Uniti strapparono al Messico la California (nel 1850 sarebbe diventata il 31 stato), Yerba buena divenne San Francisco, nel 1848 a Sutter's Mill venne scoperto l'oro; nell'arco di pochi anni 300.000 persone arrivarono qui da tutti gli Stati uniti e dall'estero in cerca di oro e fortuna. Tra di loro c'erano anche Hiram Green Bloomer (1821–1874) e la sua famiglia. Era nato a Marlborough nello stato di New York; non conosciamo molto della sua vita personale, ma sappiamo che aveva studiato al Newburgh College; era sposato e aveva già diversi figli. Nel 1849, all'età di 28 anni, tentò di raggiungere una prima volta la California ma a Panama, dove doveva imbarcarsi, si ammalò e fu costretto a tornare a casa. Arrivò a San Francisco probabilmente l'anno dopo e si inserì in fretta in quella città in tumultuosa crescita, divenendo un "cittadino a scartamento largo", come lo definisce Jepson, impegnato in molte attività civiche. Ad attrarlo in California non dovette essere solo l'oro, ma anche le piante, visto che già a Panama aveva fatto qualche raccolta. Entrò così in contatto con altri appassionati, tra cui il medico e farmacista Albert Kellogg. Nella serata del 4 aprile 1853, Kellogg e Bloomer si incontrarono con altre cinque persone in un ufficio di Montgmery Street: è l'atto di fondazione dell'Accademia delle Scienze della California, i cui scopi erano "una sistematica e accurata ricognizione di ogni porzione dello Stato e la raccolta di un gabinetto delle sue rare e ricche produzioni". Fino ad allora, ad interessarsi della ricca flora californiana erano stati da una parte i botanici delle spedizioni che vi fecero scalo tra il Settecento e la prima metà dell'Ottocento, come Menzies, il botanico della spedizione Vancouver che la visitò nel 1793, o raccoglitori venuti da lontano, come David Douglas che nel 1831 esplorò la California meridionale per incarico della Royal Horticultural Society. Kellogg e Bloomer furono tra i primi botanici residenti. Oltre alla passione per le piante, avevano in comune il talento artistico (del primo ci sono rimasti eccellenti disegni di piante, il secondo trasmise i primi rudimenti dell'arte al figlio Hiram Reynolds Bloomer, in seguito un noto pittore paesaggista) e la dedizione all'accademia, nella quale occuparono ruoli importanti. Kellogg fu il fondatore dell'erbario e il primo curatore del dipartimento di botanica, Bloomer, dopo essere stato segretario e redattore dei verbali dal 1854, fu curatore del dipartimento di botanica dal 1856 al 1866, infine direttore del museo, dal 1868 fino alla morte nel 1874. Kellogg e Bloomer erano amici e collaboratori, ma in una cosa si differenziavano totalmente: il primo era uno scrittore prolifico con all'attivo decine di articoli nei Proceedings dell'Accademia e in altre riviste, del secondo ci è noto sola un breve testo in cui difese la priorità degli studi di Kellogg sulla sequoia gigante di fronte alla pretese di Lindley di denominare quella gloria americana Wellingtonia gigantea. Jepson nel breve schizzo biografico che gli dedicò lo ha spiritosamente definito membro della "molto stimabile confraternita dei non-scrittori". Non scriveva, ma prendeva frequentemente la parola alle riunioni dell'accademia, spesso per presentare qualche libro o recenti pubblicazioni di botanica. Il non scrittore Bloomer era infatti un lettore e un bibliofilo: all'accademia donò in più occasioni non solo esemplari botanici da lui raccolti, ma anche libri; ci è rimasta una sua unica lettera a Torrey, in cui chiede informazioni sul prezzo e la reperibilità della sua Flora of New York e un aiuto per trovare testi botanici rari; quello che desiderava di più era Les Liliaceés di Redouté, anche di seconda mano. Le liliacee (ovvero le bulbose: ai suoi tempi ne facevano parte moltissime specie poi transitate in altre famiglie) erano la sua più grande passione e, come vedremo meglio tra poco, amava coltivare quelle native nel suo giardino. All'amore per le piante si deve anche la sua morte, a poco più di cinquant'anni: nel settembre 1874, con altri appassionati, partecipò a un viaggio di esplorazione nel Marin County; il gruppo si perdette e fu costretto a trascorrere la notte all'addiaccio. Per la fatica e l'esposizione agli elementi, Bloomer si ammalò e poco dopo morì.  Bloomeria, ovvero stelle d'oro Bloomer erborizzò in California e in Nevada; secondo la testimonianza del figlio Hiram Reynolds, creò un erbario di diverse migliaia di esemplari, accuratamente classificati ed etichettati, e circa un anno prima della morte lo donò all'Accademia; purtroppo è andato perduto, ma alcuni duplicati sono conservati in altre collezioni. La sua attività di raccoglitore è testimoniata da diverse dediche di botanici dell'East cost, che pure guardavano dall'alto in basso i "dilettanti" della California: da Sereno Watson, Ranunculus bloomeri (oggi Ranunculus orthorhynchus var. bloomeri), raccolto dal "Dr. J. (sic!) G. Bloomer in un fondo umido presso San Francisco", e da Asa Gray varie specie da lui raccolte a Virginia City e sul Monte Davidson in Nevada: Aster bloomeri (oggi Symphyotrichum campestre), Erigeron bloomeri, Haplopappus bloomeri (oggi Ericameria bloomeri), e Galium bloomeri (oggi Galium multiflorum), a proposito del quale Gray scrive:"[raccolto] nel territorio di Nevada presso Virginia City da Mr. H. G. Bloomer, al quale, come suo scopritore, ho il piacere di dedicare questa specie così ben caratterizzata". Fu invece un altro botanico attivo in California, Henry N. Bolander, a dedicargli Stipa bloomeri (oggi Eriocoma × bloomeri) per "commemorare i suoi servigi alla botanica di questa costa occidentale". Alla passione per le liliacee si deve una dedica in un certo senso "mancata" da parte dell'amico Kellogg. Prima del 1860 egli vide nel giardino di Bloomer "il giglio più magnifico della costa pacifica". Ne fu così impressionato che ne presentò un disegno (forse realizzato dallo stesso Bloomer) all'Accademia; tuttavia non lo pubblicò. Lo fece solo una dozzina di anni dopo, denominandolo Lilium bloomerianum. Troppo tardi: due anni prima la magnifica specie, raccolta in California da Benedikt Roezl e inviata in Europa, era stata validamente pubblicata come Lilium humboldtii, in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande esploratore-naturalista. Kellogg aveva comunque provveduto a immortalare l'amico con la dedica di una genere. Nella seduta del 18 luglio 1859 dell'Accademia delle scienze, egli presentò esemplari e disegni di due liliacee (sempre nel senso ampio impiegato all'epoca) raccolte a New Idria da John Allean Veatch e coltivate nel giardino di Bloomer. Non sappiamo se le avesse disegnate lo stesso Kellogg oppure Bloomer, entrambi eccellenti artisti. Ritenendole nuove per la scienza e non appartenenti ad alcun genere noto, Kellogg stabilì per lo loro due nuovi generi, battezzandole rispettivamente Veatchia crystallina e Bloomeria aurea. In realtà, la prima non era inedita: era stata pubblicata quasi trent'anni prima da Lindley come Hesperoscordum hyacinthinum; in seguito, fu riclassificata e oggi si chiama Triteleia hyacinthina; Veatchia è dunque sinonimo di Triteleia e la fama del perito, agrimensore e mineralogista Veatch rimane affidata alla scoperta di un vasto deposito di borace nel Lake County. Kellogg aveva invece visto giusto con Bloomeria: questo piccolo genere, di cui fu il primo a descrivere una specie, rimane valido e continua ad essere il più bell'omaggio al non-scrittore Hiram Green Bloomer. Come Brodiaea, Behria e Triteleia, fa parte della sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Le sue tre specie (Bloomeria clevelandii, B. crocea e B. humilis) sono native delle colline pedemontane aride della California e della Baja California, dove crescono in praterie, nei boschi aperti o nel chaparral. Come le loro sorelle, hanno cormi, foglie lineari e sottili steli culminanti con una infiorescenza a ombrella relativamente grande. Invece degli azzurri di Triteleia e Brodiaea e del rosso di Behria, i fiori di Bloomeria ostentano il più luminoso dei gialli. I singoli fiori sono piccoli, a stella (in inglese si chiamano Golden Stars), con lobi molti aperti, per lo più liberi (una caratteristica distintiva rispetto ai generi affini). Solitamente si coltiva la specie più diffusa, B. crocea. Si riproduce con facilità, è molto fiorifera e regala una lunga fioritura se coltivata al sole in terreno ben drenato. Dopo la fioritura, le foglie seccano e, poiché non è rustica e detesta l'umidità invernale, dove gli inverni sono freddi e umidi il modo migliore per coltivarla è ritirare i cormi d'autunno e conservarli in un luogo asciutto, ripiantandoli in primavera; si piantano invece in autunno dove gli inverni sono miti, a condizione da proteggerli tassativamente dalle piogge invernali. Secondo il folklore locale, è nella brulla brughiera di Brodie che Banco e Macbeth incontrarono il loro destino sotto forma di tre streghe. Poco lontano sorge il castello di Brodie, oggi gestito dal National Trust e famoso per la collezione di narcisi del suo giardino. Fino a qualche anno fa, era la sede ufficiale dei capi del clan Brodie; tra la seconda metà del Settecento e il primo Ottocento, il ruolo fu ricoperto da James Brodie, uomo politico non indimenticabile e botanico dilettante appassionato di crittogame nonché corrispondente di James Edward Smith e William Jackson Hooker. Tutto sommato, non indimenticabile neppure come botanico. Eppure l'amico Smith gli dedicò il grazioso genere Brodiaea: per meriti reali? per amicizia? per un intrigo di cui non sappiamo quanto il gentiluomo scozzese fosse consapevole? In ogni caso caso, a torto o a ragione, è questo il nome che la comunità scientifica riconosce. Prevalentemente californiano, e spesso confuso con l'affine Triteleia, offre fiori bellissimi che prolungano la stagione delle bulbose.  Un gentiluomo scozzese, tra politica e passione botanica In una seduta della Linnean Society dell'aprile 1808, il presidente James Edward Smith lesse la descrizione di un nuovo genere, denominato Brodiaea in onore di James Brodie, un gentiluomo i cui meriti, secondo lui, non richiedevano una particolare spiegazione. Per lui e per i membri della Society (di cui anche Brodie faceva parte) sarà stato così; ma non per noi, visto che il personaggio in questione non pubblicò nulla e della sua attività come botanico rimangono solo tracce sparse nella corrispondenza di botanici più illustri e qualche esemplare da lui raccolto nell'erbario dell'orto botanico di Edimburgo. James Brodie, o meglio James Brodie of Brodie (1744-1824), era il 21° capo del clan Brodie. Apparteneva a un ramo cadetto e a 15 anni ereditò inaspettatamente il titolo e la tenuta in seguito alla morte in giovane età del 20° capo, il secondo cugino Alexander; questi era figlio del membro forse più illustre della famiglia, il 19° capo Alexander Brodie of Brodie, che sedette alla Camera dei Comuni per 34 anni come sostenitore del governo e per 27 anni fu Lord Lyon King of Arms, il grado più basso dei grandi ufficiali di stato della Scozia, con il compito di regolamentarne l'araldica. Questo grande personaggio viveva al di sopra dei suoi mezzi, sicché James Brodie con il titolo ereditò una tenuta fortemente gravata da debiti e per tutta la vita dovette fare i conti con una situazione finanziaria difficile. Né lo aiutò il matrimonio con Lady Margareth Duff, sorella del conte di Fife, una delle figure dominanti della Scozia nord orientale, contrario al matrimonio. Anzi, Brodie si schierò con gli oppositori di Fife, tra i quali troviamo anche il fratello minore Alexander che, entrato al servizio della Compagnia delle India, al contrario di lui fece fortuna in India. Grazie a lui, James Brodie entrò in contatto con Henry Dundas, il braccio destro di William Pitt, con il sostegno del quale a partire dal 1794 fu eletto alla Camera dei comuni come rappresentate dell'Elginshire. Vi sedette per tre successivi mandati fino al 1807; sembra che non fosse molto assiduo e non prese la parola nemmeno una volta. Era per lo più schierato con il governo, ma non senza ambiguità. Insomma, una carriera politica tutt'altro che brillante, dovuta al fratello ricco (a sua volta deputato) e ad amici influenti. A Londra preferiva la Scozia, dove ebbe anche incarichi militari come tenente colonnello della milizia di Ross, e soprattutto alla politica preferiva le scienze naturali, cui probabilmente sia era accostato negli anni degli studi, prima alla Elgin academy, poi all'università di Saint Andrews. Si specializzò nelle crittogame (alghe, felci, muschi) e scoprì un certo numero di nuove specie sia nei dintorni di Edimburgo sia nella sua tenuta di Brodie. Qui aveva una discreta biblioteca, un gabinetto di curiosità e un erbario; su una delle torrette del castello fece installare un telescopio. Condivideva volentieri le sue scoperte ed corrispondeva con diversi eminenti botanici del tempo, tra cui appunto James Edward Smith e William Jackson Hooker. In English Botany Smith lo cita per Pyrola uniflora (oggi Moneses uniflora), di cui fu il primo a raccogliere un esemplare nelle isole britanniche, e per Ulva defracta, un'alga "trovata sulla costa orientale della Scozia dal nostro liberale corrispondente James Brodie"; in Flora scotica Hooker lo cita per una decina di alghe raccolte nel Firth of Forth e in altre località scozzesi. Nel 1795 Brodie fu ammesso alla Linnean Society e nel 1797 alla Royal Society. La sua vita personale fu funestata da due tragedie: nel 1786 la moglie morì in un incendio a Brodie House; nel 1801 il figlio maggiore James, che si trovava in India al servizio della Compagnia delle Indie, morì annegato in seguito al ribaltamento di un battello nei pressi di Madras. James Brodie morì nel 1824 all'età di 79 anni. Una parte del suo erbario è conservata all'Orto botanico di Edimburgo; si tratta di un'ottantina di esemplari, per lo più di piante palustri, in gran parte carici. 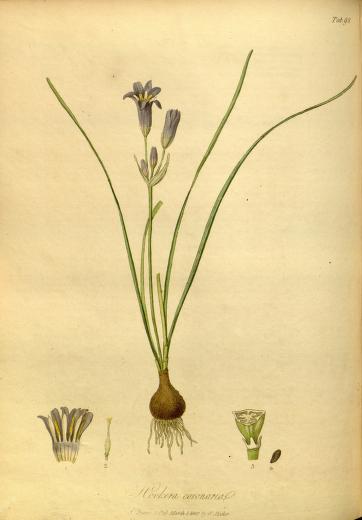 Una denominazione intricata Come ho anticipato, questo botanico dilettante è entrato nel gotha dei dedicatari di un genere botanico grazie all'amico e corrispondente James Edward Smith, che istituì il genere Brodiaea con queste parole: "Poiché queste piante formano indubbiamente un nuovo genere delle Liliaceae, o ordine patrizio, l'ho chiamato Brodiaea, per James Brodie della Britannia settentrionale, un gentiluomo i cui meriti scientifici, le cui varie scoperte, le cui generose comunicazioni in ogni occasione utile a illuminare la botanica soprattutto del suo paese, non richiedono una elaborata spiegazione per i membri della Linnean Society". Non si trattava però di una specie scozzese. Esemplari della futura Brodiaea furono raccolti per la prima volta nel 1792 nei pressi dello Strait of Georgia da Archibald Menzies, il botanico della Spedizione Vancouver. Nel 1807, nella sua An introduction to physiological and systematical botany, Smith fece riferimento a quello che già riteneva un nuovo genere per sostenere che i tepali delle liliacee sono sepali piuttosto che petali; però non gli diede un nome. La prima descrizione formale di una specie del genere fu pubblicata all'inizio dell'anno successivo da Richard Salisbury in Paradisus Londinensis come Hookera coronaria (in onore dell'illustratore William Hooker e non del botanico William Jackson Hooker). Immediatamente dopo Smith chiamò Hookeria un genere di muschi e appunto nell'aprile 1808 lesse la descrizione del genere Brodiaea alla Linnean Society; per la pubblicazione a stampa nelle Transactions si dovette aspettare il 1810. Stando alle regole della priorità, Hookera Salisb. dovrebbe essere il nome accettato, mentre Brodiaea e Hookeria (troppo simile a Hookera) dovrebbero essere respinti, Sarebbe così, se Salisbury non fosse stato il paria della botanica in seguito al fattaccio con Robert Brown; l'establishment botanico accettò i nomi di Smith e respinse quello di Salisbury. Secondo George Boulger, le mosse di Smith furono deliberatamente intese a privare il rivale - che detestava ferocemente - della paternità del nuovo genere, e riuscì pienamente nel suo intento. Da allora Hookera Salisbury è nomen rejiciendum, Brodiaea Sm. nomen coservandum. Unica parziale vittoria di Salisbury il successivo ripristino dell'epiteto in base alla legge della priorità: Brodiaea grandiflora Sm. oggi si chiama ufficialmente Brodiaea coronaria (Salisb.) Jeps. Chissà se James Brodie era al corrente dell'intrigo; è possibile, visto che proprio in una lettera rivolta a lui Smith definì Salisbury "quel rettile", e precisò "più calpesti uno str...o più puzza". Da parte mia, temo che la dedica a Brodie sia più giustificata dall'amicizia e forse dalla complicità (dopo tutto lo scozzese era un politico di lungo corso non alieno da manovre e camarille) più che da meriti che "non richiedono una elaborata spiegazione".  Fiori azzurri dalla California Lasciamo da parte questa vicenda decisamente squallida per passare al bellissimo genere Brodiaea, anche se, oltre al suo nome, ha fatto discutere anche la sua collocazione tassonomica. Smith lo collocò "indubitabilmente" nelle Liliaceae, e i botanici successivi ora nelle Liliaceae, ora nelle Alliaceae, ora nelle Amaryllidaceae. Unico bastian contrario, ancora Salisbury che pensava che appartenesse a una famiglia propria, che egli stesso istituì e denominò Themidaceae (dal genere monotipicoThemis rappresentato unicamente da T. ixioides). Solo verso la fine del Novecento con gli studi filogenetici molecolari è emerso con chiarezza che a vederci giusto era stato proprio Salisbury (magari rettile, ma di certo grande botanico). Di conseguenza, nel 1996 la famiglia Themidaceae venne ripristinata; più di recente, è passata al rango di sottofamiglia delle Asparagaceae con il nome Brodiaeoideae. La sottofamiglia, di cui Brodiaea è ora il genere tipo, comprende 12 generi di erbacee perenni diffusi unicamente lungo la costa pacifica dell'America settentrionale, dal British Columbia al Guatemala; i due più grandi sono Triteleia (16 specie) e Brodiaea (18 specie) che sono anche quelli più comunemente coltivati nei giardini. Tratti comuni a tutta la sottofamiglia sono il cormo amidaceo che si rinnova ogni anno a partire da quello vecchio; le foglie lineari, talvolta carnose; i fiori bisessuali, con 6 tepali in due giri di tre, raccolti in infiorescenze ad ombrella; 6 stami fertili o 3 stami alternati a 3 staminoidi; ovario supero triloculare; frutto a capsula che si apre lungo le suture dei carpelli; semi ricoperti da uno strato duro di colore nero. Poiché i confini tra i diversi generi della sottofamiglia non sono netti e Brodiaea fu il primo ad essere stabilito, in passato ne hanno fatto parte molte specie via via trasferite in altri generi; è il caso anche diTriteleia laxa, la specie più coltivata dell'intero gruppo, che è spesso ancora commercializzata sotto il sinonimo Brodiaea laxa, tanto che per molti è la Brodiaea per antonomasia anche se da tempo non appartiene più a questo genere. Non di rado sono commercializzate come Brodiaea anche le specie e gli ibridi di Dichelostemma. Themis non esiste più e T. ixioides, dopo essersi chiamata tra l'altro Brodiaea ixioides, è ora Triteleia ixioides. Brodiaea è presente lungo la costa pacifica dell'America settentrionale dal British Columbia alla Baja California, con centro di diversità nella California settentrionale. Alcune specie endemiche della California si sono adattate a suoli con particolare composizione chimica, hanno limitata diffusione e sono a rischio di estinzione. Diverse sono coltivate come piante da giardino, apprezzate sia per il raro colore azzurro delle corolle sia perché prolungano la stagione di fioritura delle bulbose primaverili; infatti, più che in primavera tendono a fiorire all'inizio dell'estate. In primavera dal cormo emergono da una a sei foglie lineari. Solitamente ogni cormo produce un singolo scapo fiorale privo di foglie che porta alla sommità un'infiorescenza a ombrella, composta di fiori a stella con sei tepali azzurri o viola, congiunti alla base a formare un tubo con sei lobi liberi alla gola, i tre esterni più stretti dei tre interni. La maggior parte delle specie presenta tre stami fertili e tre staminoidi simili a piccoli petali, ciascuno opposto a uno dei tepali esterni. E' questa la caratteristica più distintiva del genere, che lo distingue tra l'altro da Triteleia che invece possiede sei stami fertili. Da Dichelostemma invece si distingue per lo scapo diritto anziché ricurvo e per l'ombrella aperta anziché densa e compatta. Le specie più frequentemente coltivate sono Brodiaea californica, la più grande, con corolle a calice stellato in colori che variano dal bianco al lavanda e occasionalmente al rosa; B. coronaria (sin. B. grandiflora), con corolle a campana dai petali ricurvi, da blu a viola a rosa porpora; B. elegans, con tepali blu-violetto che contrastano con gli staminoidi bianchi. Altre informazioni nella scheda. Dopo la tulipomania, che nel Seicento bruciò tanti capitali, nel Settecento infuriò la giacintomania. Tra le sue vittime, sir James Justice, un legale scozzese che dilapidò tutta la sua fortuna per coltivare piante rare, tra cui appunto i preziosi giacinti doppi che acquistava a caro prezzo in Olanda. Grande sperimentatore di tecniche di coltivazione, fu probabilmente il primo a far fruttificare gli ananas in Scozia, creando per loro una serra riscaldata all'avanguardia. Un successo che gli guadagnò la quasi immediata ammissione alla Royal Society. Nell'arco di pochi anni, alle prese con debiti sempre più enormi, fu costretto a vendere la tenuta di Crichton dove aveva creato il più raffinato giardino di Scozia. Seguirono processi, un divorzio, l'ignominia del carcere per debiti, l'espulsione dalla Royal Society per morosità. Alla sua morte, alla vedova e al figlio bambino rimase un capitale di 60 sterline, ovvero il prezzo a cui veniva venduto al momento della sua apparizione il giacinto 'Gloria florum suprema'. A ricordare Justice rimangono il notevole The Scots Gardiners Director, ma soprattutto il genere Justicia, oggi il più vasto della famiglia Acanthaceae.  Giacinti e giacintomania Il 22 ottobre 1730 la Royal Society ammise un nuovo membro, presentato dal presidente in persona sir Hans Sloane, dal capo giardiniere di Chelsea Philip Miller e da John Martyn, che due anni dopo sarebbe stato nominato professore di botanica a Cambridge. Il nuovo socio era un legale scozzese, sir James Justice (1698-1763), alto funzionario della corte di Edimburgo (Principal Clerk to the Court of Sessions), ma soprattutto appassionato giardiniere. Ad attirare l'attenzione di sponsor tanto prestigiosi erano stati i suoi esperimenti orticoli. Sfidando il rigido clima scozzese, nella sua tenuta di Crichton, a circa 20 km a sud di Edimburgo, egli si era fatto costruire una serra riscaldata all'avanguardia (tra l'altro, una delle poche all'epoca ad avere anche il tetto vetrato) dove era riuscito a fare fruttificare gli ananas. Vi coltivava anche banani, guaiave, piante del cacao e del caffè; era riuscito a far fruttificare anche queste ultime, che avevano dato semi fertili da cui erano nate pianticelle. Fu il momento di massima gloria di Justice, che per tutta la vita (anche quando, come vedremo, non ne aveva più diritto) fece sempre orgogliosamente seguire al suo nome la sigla FRS, Fellow of Royal Society. All'epoca aveva poco più di trent'anni e aveva cominciato i suoi esperimenti orticoli forse intorno al 1727. Apparteneva a una facoltosa famiglia di mercanti e legali scozzesi, la cui parabola - tanto per rimanere nei cliché - ricorda quella dei Buddenbrook. All'inizio, ovviamente, c'è un fondatore, in questo caso il mercante James Justice (morto nel 1711) che fu bailie (magistrato municipale) e prevosto di Edimburgo e acquistò la proprietà di Crichton. Il rappresentante della seconda generazione, anche lui James, entrò a fare parte della nobiltà di toga, aggiungendo un titolo baronale alla tenuta e divenendo Principal Clerk to the Court of Sessions, incarico che mantenne fino al 1727, quando vendette la carica e la riacquistò per il figlio; la terza generazione è appunto quella di James il botanico. Infine la dinastia si chiude con il quarto James, l'unico figlio sopravvissuto, militare noto come "Captain Justice", eccentrico quanto il padre (anche se la sua passione andava più alle fanciulle che ai fiori). La passione del padre James III per l'orticultura era nata in Olanda, dove era stato inviato a laurearsi in giurisprudenza, secondo una consuetudine abituale nella Scozia del tempo. Mentre non provava alcun interesse per la carriera legale, si innamorò dell'orticoltura e del vivaismo olandesi. Per impadronirsi delle tecniche di coltivazione più aggiornate, oltre a frequentare assiduamente i vivai di Haarlem, in un lungo grand tour orticolo dovette visitare anche la Francia ( dove si interessò soprattutto della coltivazione a spalliera di peschi e altri alberi da frutto) e l'Italia. Non conosciamo le date di questo viaggio, che probabilmente si protrasse per diversi anni. Al suo rientro in Scozia, Justice era un raffinato gentiluomo per padroneggiava l'inglese senza "scotismi", il latino, l'olandese e il francese, conosceva bene la letteratura botanica del tempo e le nuove tecniche orticole messe a punto nel continente. Era ansioso di sperimentarle per "migliorare" la tenuta di Crichton. Come il padre era infatti membro della Honourable Society of Improvers in the Knowledge of Agriculture in Scotland, che si proponeva di migliorare l'orticoltura scozzese introducendo tecniche che aumentassero le rese. Certamente piantò alberi e introdusse migliorie nella gestione della tenuta, ma soprattutto si concentrò sulla coltivazione delle esotiche, facendo costruire per loro una serra all'epoca quasi avveniristica. Il suo interesse principale dovette però transitare ben presto alle piante da fiore, in particolare le bulbose. Nel 1730 infatti lo troviamo a Bruxelles, per studiare le tecniche di coltivazione di François Beaulinx, specialista nella produzione di tulipani Bizard da seme. Altri contatti nelle Fiandre e in Olanda erano Jan van Leuwen di Rotterdam, famoso per i suoi Iris persica azzurri, e soprattutto i vivai van Zompel e Voorhelm di Haarlem. Questi ultimi furono all'origine della giacintomania che infuriò in Olanda nella prima metà del Settecento. I giacinti Hyacinthus orientalis all'epoca erano abbastanza diversi da quelli che coltiviamo oggi. Quelli a fiore singolo avevano pannocchie piuttosto rade, con fiori piccoli, ancora simili alle forme selvatiche; occasionalmente nascevano piante a fiore doppio, che inizialmente non suscitarono alcun interesse, anzi i vivaisti si affrettavano a scartarle perché sterili. Nel 1684 il vivaista di Haarlem Peter Voorhelm cadde ammalato, lasciando il vivaio per qualche tempo abbandonato a se stesso; quando poté occuparsi della cernita dei giacinti, ne trovò uno doppio particolarmente bello; scoprì anche che ai suoi clienti piaceva ed erano disposti a pagarlo di più degli altri. Continuò a coltivarlo e a sviluppare nuove varietà. La prima ad aver successo e a scatenare la giacintomania fu 'Koning for Groot Brittanien' (così chiamata in onore di Guglielmo d'Orange, re d'Inghilterra come Guglielmo III), con fiori bianchi e cuore rosa intenso, una robusta varietà ancora segnalata da Loudon all'inizio dell'Ottocento. Al suo apparire, nel 1702, un singolo bulbo costava l'equivalente di 100 sterline. I prezzi erano così alti perché i giacinti doppi erano rari, ci volevano cinque anni per portarli a fioritura, e con il loro insieme di colori eccitavano il gusto del bizzarro, proprio come i tulipani variegati all'origine della tulipomania. La giacintomania raggiunse il suo apice negli anni '20-'30 del 1700, ovvero esattamente nel periodo in cui Justice frequentò l'Olanda prima come studente poi come acquirente di bulbi. I Voorhelm continuavano ad essere il vivaio leader di questa produzione, ma ora erano affiancati da molti altri produttori che ogni anno immettevano sul mercato centinaia di varietà. Tuttavia, avevano imparato la lezione dal crollo della bolla dei tulipani, e nei loro cataloghi offrivano un'ampia gamma di giacinti dai prezzi diversificati, riuscendo a mantenere alti quelli delle novità più pregiate. Così due produzioni dei Voorhelm (molto ammirate da Justice) 'Gloria Mundi', azzurro chiaro con cuore blu scuro, e 'Gloria Florum suprema', bianco neve con cuore scarlatto, al loro apparire furono venduti rispettivamente a 500 e 600 fiorini a bulbo, cioè 50 e 60 sterline. I prezzi raggiunsero il picco tra il 1733 e il 1736, per poi crollare quasi all'improvviso: il mercato ormai era saturo, le varietà veramente di valore erano introvabili, e per vendere i vivaisti furono costretti a tagliare i prezzi. Nei cataloghi del 1738 vediamo 'Staaten General' passare da 210 a 20 fiorini e 'Gekroont Salomon’s Jewel' da 80 a 3. 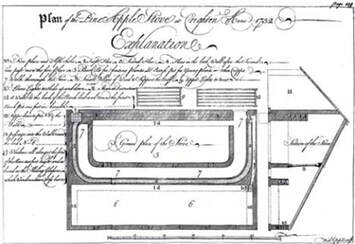 Rovinarsi per le piante In Olanda Justice si era innamorato dei giacinti e non se li fece mancare nel giardino di Crichton, in stile francese, considerato il più bello e raffinato della Scozia. Quanto avesse pagato i suoi giacinti e le innumerevoli altre bulbose che li affiancavano non sappiamo. Ma certo fu vittima, se non della sola giacintomania, della sua irresistibile passione per il giardinaggio. Non badava a spese per far venire bulbi dall'Olanda e per acquistare piante e semi tanto a Londra quanto in Scozia. I guai arrivarono presto; i debiti erano tanti che, per salvare il salvabile, il padre James II predispose un atto di successione a favore del nipote anziché del figlio e si risolse a vendere la tenuta. Nel 1738, poco più di un anno dopo la sua morte, la vendita fu infine conclusa dal nostro James III, con un ricavo di 7000 sterline. Egli tentò anche di impugnare l'atto paterno, ma vi rinunciò, vedendo che era insufficiente a tacitare i creditori. Pagati almeno una parte dei debiti, investì quanto gli rimaneva in una tenuta di minore estensione chiamata Ugston nella parrocchia di Channelkirk (Berwikshire) che da quel momento fu ribattezzata Justicehall. Anche qui piantò alberi e coltivò bulbose, tanto che uno studioso di storia locale ha raccolto la voce che facesse addirittura arrivare la terra dall'Olanda per offrire agli amati bulbi la terra natìa; la notizia è improbabile (come vedremo, tra i più importanti esperimenti di Justice vi era la produzione di terricci su misura per le varie coltivazioni), ma ci dice molto sulla fama di eccentricità del personaggio. A rovinare del tutto la sua reputazione, ai debiti si aggiunse lo scandalo: iniziò una relazione con una giovane domestica e la moglie chiese il divorzio. Ne seguì un'intricata vicenda processuale in cui Justice arrivò ad accusare un ex amico di aver tentato di assassinarlo. Erano condotte che la puritana società scozzese non era disposta a tollerare; così, nell'ottobre 1744 Justice se ne andò in volontario esilio nell'Inghilterra settentrionale, con il risultato di contrarre altri debiti. Tornato in Scozia nel novembre 1746, prese in affitto una casa con giardino ad Edimburgo; era sempre più perseguitato dai creditori (in una lettera li chiama "diavoli") e nel 1748 subì anche una breve incarcerazione per debiti, da cui fu liberato grazie alla malleveria di lord Milton, alto magistrato e suo lontano cugino; con il suo aiuto, cercò inutilmente di liberarsi dell'odiato lavoro in tribunale. Nel 1750 si sposò con la ragazza dello scandalo, che però presto si ammalò e dopo appena due anni lo lasciò vedovo. Seguì un terzo matrimonio, e nel 1755, ormai quasi sessantenne, gli nacque l'unico figlio superstite (il maggiore era morto nel 1750). Nel 1757, non avendo pagato da anni la quota associativa, subì lo smacco di essere espulso dalla Royal Society. Nel 1758 si trasferì nella sua ultima casa, nel distretto di Leigh, dove sarebbe morto nel 1763. Anche qui c'era un giardino, che riempì di fiori, tra cui una spettacolare collezione di auricola; erano piante di grande valore, su cui contava per garantire un gruzzoletto alla moglie e al figlioletto dopo la sua morte. Invece quando la vedova le mise in vendita, ne ricavò solo 20 sterline, un terzo dell'eredità che le rimaneva.  Una guida per i giardinieri scozzesi Nel 1754, a suo dire cedendo alle pressioni di amici ed estimatori, Justice si risolse a mettere per iscritto quanto aveva appreso dalle sue esperienze trentennali in ogni campo dell'orticoltura, trasfondendole in una guida all'orto famigliare e al giardino, The Scots Gardiners Director. Anche se l'identità dell'autore era un segreto di Pulcinella, inizialmente la pubblicò anonima (era pur sempre un rispettabile funzionario); il nome compare nell'edizione del 1759, intitolata The British Gardener's New Director; nell'edizione riveduta del 1764 (uscita postuma) tutte le remore sono cadute: sir James arriva a reclamizzare e porre in vendita alcune delle sue produzioni. Il libro è interessante da diversi punti di vista. Era una delle prime pubblicazioni del genere in Scozia (grazie ad essa, Justice è stato definito il padre dell'orticultura scozzese) ed ebbe un notevole successo, venendo ristampato anche in Irlanda. Era anzi la prima ad essere concepito appositamente per il clima e i terreni della Scozia, tanto diversi da quelli della più temperata e fertile Inghilterra. Soprattutto, non aveva nulla di libresco e si basava su esperienze di prima mano, esposte dall'autore in modo dettagliato e potremmo dire generoso. Così, le pagine di The Scots Gardiners Director sono per noi una specie di macchina del tempo per conoscere le pratiche orticole del Settecento, i successi e i fallimenti di sir James e il mondo del vivaismo olandese (egli vi riportò interi cataloghi delle loro produzioni, in particolare quelle dell'amico Joris Voorhelm, autore a sua volta di uno dei primi trattati sui giacinti). Il volume è diviso i due parti. La prima è dedicata all'orto famigliare; è un orto-frutteto, un walled garden recintato da muri che lo proteggono dal rigido clima settentrionale. Justice fornisce dettagliate istruzioni sull'esposizione ideale, sulla scelta dei fruttiferi più adatti, sulla coltivazione a spalliera e la potatura; spiega come allestire lettorini caldi (incluso uno per i funghi) e muri riscaldati dotati di intercapedini dove far passare aria calda per far maturare l'uva e altri frutti che non riuscirebbero a farlo nel clima scozzese. Non dimentico del suo primo successo, non trascura la coltivazione degli ananas e offre ai lettori due progetti di serre calde. La prima parte si conclude con la rassegna delle orticole e delle erbe aromatiche. La seconda parte (è una novità non trascurabile) è interamente dedicata alla coltivazione dei fiori; si intitola etimologicamente Anthologia, selezione di fiori, e occupa un po' di più della metà del volume. Mentre le piante da aiuola, ad eccezione di poche specie, sono trattate spesso sommariamente, a fare la parte del leone sono le bulbose, che Justice espone seguendo il ritmo delle stagioni, iniziando con l'aconito d'inverno, ovvero Eranthis hyemalis, e i bucaneve, per terminare con i colchici autunnali. E così, con dovizia di indicazioni sulle varietà, la coltivazione, la semina, la preparazione dei terreni, ecco sfilare le epatiche, a proposito delle quali Justice confessa un insuccesso: ripetendo le semine per molti anni, è riuscito a ottenere diversi colori e forme semidoppie, ma mai le varietà doppie disponibili in Olanda; gli economici crochi che l'amico Voorhelm (ne propone 12 varietà) vende a 1 fiorino per 100 bulbi; gli aristocratici iris persiani, che si acquistano a Rotterdam ed è impossibile riprodurre da seme, ma possono essere forzati in vaso per ornarne la casa all'inizio della primavera; i narcisi, di cui ci sono innumerevoli varietà e tipi, da piantare in massa 100 alla volta; i ciclamini rustici; il colchico di Spagna, ovvero Bulbocodium vernum; il dente di cane Erythronium dens-canis. Su Fritillaria meleagris si dilunga per illustrare le tecniche di semina che gli hanno permesso di ottenere sette varietà del tutto nuove entrate a far parte del catalogo Voorhelm; segue la corona imperiale F. imperialis, gloria dei vivai olandesi che la chiamano William Rex e ne offrono almeno quindici varietà. Tra le rarità dei loro cataloghi c'è anche quello che chiamano Lilium persicum, in cui riconosciamo F. persica. A questo punto entrano in scena i giacinti "una delle principali bellezze della primavera". Justice - dichiara subito che sono la sua pianta preferita - dedica loro moltissime pagine, con dettagliate istruzioni su come trattare i bulbi giunti dall'Olanda, su come allestire una root-room per conservarli e moltiplicare i bulbi, sulle semine e sul terriccio ideale, che egli prepara secondo una ricetta di sua elaborazione che comprende sabbia, letame maturo e compost di foglie. Ne aveva già parlato nel suo primo scritto noto, Directions for propagating Hyacinths, pubblicato nel 1743 nelle Transactions della Hourable Society of Improvers. Per i giacinti Justice ha speso capitali, ma anche ottenuto grandi successi; mentre i suoi conterranei, sono costretti a sostituire continuamente i bulbi, lui grazie al suo terriccio e alle perfette tecniche di coltivazione riesce a mantenere i fiori grandi come il primo anno; non parliamo poi delle semine, che gli hanno permesso di ottenere novità di pregio. Nel 1764 Voorhelm gliene dedicherà una commemorativa, 'Mijnherr Justice', un bianco singolo con tocchi di rosa. Justice spiega anche come forzare i bulbi in caraffe di vetro, una tecnica messa a punto pochi anni prima in Svezia e introdotta nel Regno unito dal corrispondente Philip Miller. Per pagine e pagine, egli si profonde quindi nella descrizione di dozzine di varietà; quelle a fiore singolo (10 bianchi, 10 rosa, 16 blu scuro e 20 azzurro chiaro) ammette di averle coltivate tutte; ovviamente va pazzo (e sappiamo fino a che punto) per quelle a fiore doppio, ma forse neppure lui avrà sperimentato tutte le 86 varietà offerte nel 1752 da Voorhlem e van Zompel, che però descrive puntigliosamente, certo in più di un caso per conoscenza diretta. Tra di esse le costosissime 'Gloria mundi' e 'Gloria florum suprema. Ma a suo parere "i più belli dei doppi per il loro colore ammirevole" sono i rossi, di cui menziona 9 varietà. Dopo i giacinti, tocca ai tulipani. Forse sono stati una passione giovanile, e non li trascura, ma è chiaro che il suo cuore va ai giacinti, tanto che non hai mai provato a riprodurli per seme. A paragone, dedica più spazio ai ranuncoli, di cui invece ha praticato la semina su larga scala, ottenendo parecchie pregevoli varietà. Lasciate le bulbose, come si è detto la trattazione si fa più scarna, con qualche eccezione, come le primule orecchie d'orso (Primula auricola); negli ultimi anni della sua vita, quando non disponeva più dei larghi spazi delle tenute di campagna, ma solo di un piccolo giardino urbano, hanno sostituito nel suo cuore i giacinti e per ospitarle degnamente ha persino inventato un apposito scaffale con ripiani doppi. Un'altra eccezione è l'astro della Cina Callistephus chinensis; si trattava in effetti di una new entry nei giardini europei. I primi semi erano approdati dalla Cina al Jardin des plantes di Parigi intorno al 1730 (se ne attribuisce erroneamente l'invio a padre Incarville, che però all'epoca viveva in Canada); qui se li era procurati Philip Miller che aveva incominciato subito a seminarli e a sperimentare la creazione di diverse varietà, ottenendo dopo molti anni le prime doppie. Probabilmente Justice ottenne i semi da lui e ne sperimentò la semina ripetuta, separando i semi delle piante più promettenti, fino a riuscire a produrre addirittura una forma doppia bicolore, che secondo la sua biografa Priscilla Minay rivaleggia con le migliori varietà moderne.  Un grande genere pantropicale Anche se ci è rimasta solo una delle lettere di Justice a Miller, scritta poco dopo l'amissione alla Royal Society, è probabile che i due abbiano corrisposto per molti anni; erano uniti dalle origini scozzesi e da un approccio molto simile all'orticoltura, fatto di prove ed esperimenti ripetuti con tenacia e caparbietà. Forse un conoscente comune era un terzo scozzese, il chirurgo William Houstoun; in un passo di The Scots Gardiners Director Justice mostra di conoscere le sue ricerche su Mirabilis jalapa, mentre Houstoun lo stimava abbastanza da dedicargli uno dei suoi generi di piante americane. Fatto proprio e validato da Linneo, Justicia è oggi il più vasto genere della famiglia Acanthaceae. Distribuito nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo, comprende al momento attuale oltre 900 specie di erbacee perenni, arbusti e suffrutici di morfologia piuttosto variabile; tra i tratti comuni, foglie con nervature molto evidenti e fiori tubolari caratterizzati da una corolla bilabiata con labbro superiore bilobato e labbro inferiore trilobato. Nella sua storia tassonomica, i confini di questo genere si sono più volte modificati. Nella prima metà del Novecento, prevaleva la linea di riconoscere come separati una serie di generi più piccoli, i più noti dei quali per giardinieri e appassionati sono Jacobinia e Beloperone. Nel 1988, uno studio di W. A. Graham ha inaugurato la linea opposta, con un vastissimo genere Justicia diviso in 16 sezioni e 7 sottosezioni, in cui sono confluiti molti generi minori. La soluzione continua a prevalere ed è stata confermata da studi recenti, ma è anche contestata sulla base di evidenze molecolari che dimostrano che Justicia nel senso di Graham è largamente parafiletico, ovvero artificiale. In attesa di cambiamenti che non mancheranno, godiamoci la bellezza di queste piante, apprezzate in natura da farfalle, api e colibrì e da tutti noi nei giardini o nelle serre (purtroppo, con l'eccezione parziale di J. americana, non sono rustiche). E' probabile che molti giardinieri e appassionati conoscano le due specie più note e coltivate sotto i vecchi nomi. La prima è Justicia carnea, in precedenza Jacobinia carnea, un arbusto di origine brasiliana (uno dei centri di diversità del genere) apprezzato per le spettacolari spighe di fiori tubolari rosa. La seconda è Justicia brandegeeana, in passato Beloperone guttata, nota nei paesi anglofoni con il curioso nomignolo shrimp plant, ovvero pianta gamberetto. A suggerirlo sono la forma e il colore delle brattee che sottendono i fiori sovrapposti come i segmenti della corazza di questo crostaceo. Comunque la si voglia chiamare, è un arbusto piacevole e dalle fioriture singolari, che dove il clima lo consente si protraggono per mesi. Tra le altre specie di questo numerosissimo genere, vale la pena di ricordare J. aurea, simile a J. carnea, ma con infiorescenze gialle; J. floribunda, un piccolo arbusto con fiori tubolari penduli bicolori gialli e scarlatti che qualcuno chiama molto impropriamente "fuchsia brasiliana"; la messicana J. spicigera, propria delle foreste aride, con brillanti infiorescenze aranciate, nota anche per le sue proprietà medicinali come depurativo e stimolante. Approfondimenti su queste e altre specie nella scheda. Intorno al 1817 in un giardino piemontese che presto sarebbe scomparso fiorisce e fruttifica, a quanto pare per la prima volta in Europa, un arbusto che si crede originario dell'Australia. E' così che il conte Freylino, grande appassionato di piante esotiche, ha avuto la ventura di dare il suo nome al piccolo genere Freylinia che, però, non viene dall'Australia, bensì dal Sud Africa, dove i suoi fiori dal profumo di miele fanno la delizia di farfalle e altri impollinatori.  Un conte giacobino e botanofilo Il 31 gennaio 1799 la piazza della cittadina piemontese di Buttigliera d'Asti ospitò un'animata cerimonia: l'innalzamento dell'albero della libertà, ornato di nastri tricolori. La "festa repubblicana" durò tre giorni: per tutti ci fu pane, riso e ottimi agnolotti, innaffiati dal vino spillato da due fontane: dall'una, "esquisito vino bianco di malvasia", dall'altra "ottimo vino di nebiolo", Il fatto più curioso è che ad offrire albero e intrattenimento fu il signore feudale del paese, Pietro Lorenzo Freylino, conte di Pino e Buttigliera. Ma forse in paese nessuno si stupì: non solo il conte, benché discendesse da una famiglia di finanzieri e consiglieri di Stato, era di idee giacobine. ma era anche abbastanza eccentrico da occuparsi più di botanica che di politica. Nel 1771 suo padre Pietro Giuseppe Freylino, già conte di Pino e proprietario di metà del feudo di Buttigliera, acquistò anche la seconda metà e con essa il palazzo che si affacciava sulla piazza del paese e il giardino attiguo. Il giovane Pietro Lorenzo (all'epoca un adolescente) ne fece il suo regno; sappiamo che già nel 1773 aveva incominciato a trasformarlo in un giardino di gusto ecclettico: c'erano statue, fontane e giochi d'acqua, per qualche tempo anche una stazione meteorologica e una serra. La località doveva godere di un'ottima esposizione (sappiamo da documenti d'epoca che vi si coltivavano gli olivi) e il conte ne approfittò per far crescere in piena terra le tipiche piante d'agrumi dei giardini all'italiana, che solitamente in Piemonte erano tenute in vaso e passavano l'inverno in una citroniera (così localmente si preferiva chiamare l'aranciera). Fin dall'inizio ci furono moltissime esotiche, per le quali Freylino sperimentava l'acclimatazione tanto in piena terra quanto in serra, con l'aiuto del "giardiniere ordinario" Andrea Pasta e del "giardiniere botanico" Giovanni Battista Rossi, così quotato che in seguito divenne capo giardiniere dei Borromeo all'Isola Madre e infine direttore dei Regi Giardini di Monza. Dal 1782 giunse anche nelle vesti di segretario, collaboratore, allievo e amico Maurizio Pangella che forse lo assistette nella stesura del primo catalogo del giardino: uscito nel 1785 (lo stesso anno della Flora pedemontana di Allioni) elencava 953 specie, utilizzando la terminologia linneana. Fu sicuramente Pangella ad occuparsi dell'aggiornamento, con due edizioni in francese uscite rispettivamente nel 1812 e nel 1818. Negli anni dell'effimera Repubblica piemontese, poi della Repubblica cisalpina, infine dell'annessione alla Francia, Freylino fu molto attivo, con una piccola carriera politica locale, culminata nella nomina a maire, ovvero sindaco di Buttigliera. Era piuttosto conosciuto negli ambienti botanici piemontesi; lo stesso Allioni ebbe a definirlo "indefessus botanophylus"; sappiamo che era in relazione, forse con scambi di semi e piante, con un altro nobile appassionato, il marchese de Spin, nonché con Balbis e Colla, giacobini come lui. Secondo la testimonianza dell'erudito astigiano Gian Secondo de Canis, nel 1814 il giardino conteneva "seimila piante tutte rare" e "alberi da ogni parte del mondo" e poteva senz'altro essere definito "il migliore che vi sia in Piemonte". Una gloria destinata a finire presto: nel luglio di quello stesso anno Vittorio Emanuele I rientrò a Torino ed ebbe inizio la restaurazione. A differenza di Balbis, forse il nobile conte Freylino non subì particolari ritorsioni; si ritirò nei suoi possedimenti astigiani e si occupò di piante, come prima più di prima. Tuttavia già nel 1820 morì e con la sua morte si aprì una vicenda giudiziaria degna di Casa desolata di Dickens; egli infatti nominò erede universale Maurizio Pangella, ma alcuni nobili parenti alla lontana del conte (che non aveva eredi diretti) impugnarono il testamento. Alla fine a Pangella venne riconosciuta la proprietà del palazzo e del giardino, mentre i beni feudali furono assegnati ai ricorrenti. Vittima della lunga causa fu soprattutto il giardino che, trascurato, finì per scomparire.  Dolce profumo di miele Prima del triste epilogo, un piccolo evento aveva fatto entrare il nostro conte botanofilo nella schiera dei dedicatari di un genere di piante. Nel maggio 1817 i lettori della Gazzetta piemontese potevano leggere la seguente notizia: "Nel ragguardevole numero di piante esotiche che il signor Conte Freylino coltiva nel suo giardino a Buttigliera, se ne trova una, creduta unica in Italia, la quale due anni sono fiorì ma non produsse alcun frutto. In quest'anno diede e fiore e frutto. Il direttore del giardino, signor Pangella, promette di darne fra breve un'esatta descrizione. Credesi questa pianta originaria della Nuova Olanda, e le verrà dato il nome di Freylinia oppositifolia. Molti rinomati botanici italiani ed oltramontani l'hanno riconosciuta per pianta nuova". Su quella "esatta descrizione" si basò l'amico Luigi Colla, che coltivava egli stesso quella pianta nel suo giardino di Rivoli e la pubblicò nel catalogo dello stesso (Hortus ripulensis, 1824). Non veniva però dalla Nuova Olanda (ovvero dall'Australia), ma dal Sudafrica. Oggi non si chiama più F. oppositifolia, ma F. lanceolata, perché era stata già descritta in precedenza dal figlio di Linneo come Capraria lanceolata. Oggi a Freylinia Pangella ex Colla (famiglia Scrophulariaceae) sono attribuite nove specie. Otto sono endemiche del Sudafrica, anzi della Provincia del Capo; l'eccezione è F. tropica, che è presente anche in Zimbabwe e Tanzania. Sono fitti arbusti sempreverdi di medie dimensioni, talvolta piccoli alberi, che al momento della fioritura si coprono di fiori tubolari con cinque lobi, in genere dolcemente profumati di miele, che attirano nugoli di farfalle e altri insetti. Ecco perché sono conosciute con il nome comune è honey bells. La specie più coltivata è F. lanceolata, con fiori giallo-aranciati o più raramente bianchi; quelli di F. crispa e F. visseri sono viola-porpora, mentre quelli di F. tropica possono essere bianchi, malva o azzurri; questa specie differisce dalle altre perché ha fiori raccolti in infiorescenze ascellari anziché in grandi infiorescenze terminali. Tutte fioriscono a profusione e sono estremamente eleganti anche nel portamento. Qualche informazione in più nella scheda. Non stupisce che la duchessa di Beaufort, grande appassionata senza problemi di mezzi, appena vide le serre riscaldate di Hampton Court, si affrettasse a farsi costruire un'analoga "serra tropicale" per i suoi giardini di Badminton. Più curioso è che anche prima di lei se ne fosse dotato un semplice maestro di scuola: il dr. Robert Uvedale. Come per la ben più ricca nobildonna, anche per lui le piante erano una ragione di vita ed era così abile nel coltivarle che la sua reputazione di esperto orticoltore travalicava le frontiere britanniche. Gli è attribuita l'introduzione in Inghilterra di due piante: quella dubbia del cedro del Libano e quella documentata del pisello odoroso. A ricordarlo, tramite l'amico Petiver, l'epiteto linneano di Smallanthus uvedalia, e il genere australiano Uvedalia (Phrymaceae).  Piselli siciliani e cedri libanesi I britannici hanno una vera passione per i piselli odorosi Lathyrus odoratus. Non solo li coltivano ampiamente nei loro giardini, magari facendoli arrampicare su apposite piramidi sullo sfondo dei mixed border, ma ne fanno i protagonisti di premi e concorsi e ne arricchiscono continuamente la gamma con nuove selezioni e varietà. I nomi di due di esse, 'Cupani' e 'Robert Uvedale', ci portano all'origine di questa passione. Lathyrus odoratus è un endemismo della Sicilia e di alcune aree dell'Italia meridionale. Il primo a darne una descrizione fu Francesco Cupani in Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum (1694) e poi nuovamente in Hortus catholicus (1696). Nel 1699 ne inviò i semi a Caspar Commelin dell'orto botanico di Amsterdam, che li coltivò con successo e fece ritrarre la pianta nel quarto volume del Moninckx Atlas (1699) come Lathyrus siculus. La bella specie, deliziosamente profumata, che ogni tanto produceva fiori bianchi, ottenne successo; nel 1737 Burman attesta che era ormai coltivatissimo nei giardini dei Paesi bassi, compreso quello del patrono di Linneo George Clifford, dove il botanico svedese lo vide, ripubblicandolo in Hortus cliffortianus come Lathyrus odoratus. Cupani inviò semi anche ad altri corrispondenti, uno dei quali era l'inglese Robert Uvedale (1642-1722). Laureato in teologia a Cambridge, Uvedale era un semplice maestro di scuola: dirigeva la Grammar School di Enfield, a nord di Londra, ma soprattutto era famoso in tutta l'Inghilterra come grande esperto di orticultura e floricoltura; la sua specialità erano le piante esotiche, per coltivare le quali si era dotato di arancere e di una delle primissime serre riscaldate del paese. I semi di Cupani capitarono dunque in ottime mani, non solo perché Uvedale li coltivò nel migliore dei modi, ma anche perché li diffuse tra i suoi amici. Anche se egli stesso non ne faceva parte, alcuni di essi erano i colti gentiluomini che si riunivano nel Temple Coffee House Botany Club: Leonard Plukenet, che forse era stato suo compagno di scuola, il farmacista James Petiver e il dr. Sloane, almeno un nipote del quale fu suo allievo; tra i corrispondenti più assidui il medico, antiquario e collezionista Richard Richardson. Nel 1700 Plukenet pubblicò la nuova specie in Almagesti Botanici Mantissa e diversi esemplari coltivati a Enfield sono tuttora conservati nel suo erbario. Come in Olanda, anche in Inghilterra quel fiore profumatissimo piacque molto; nel 1724 cominciò ad essere disponibile nei cataloghi dei vivai. Era l'inizio di un grande amore che perdura tuttora. Oggi le varietà si contano a centinaia. Tra di esse 'Cupani', la più simile al pisello odoroso originario: ha solo due fiori per stelo, piccoli e bicolori, ma profumatissimi. C'è anche 'Robert Uvedale', con grandissimi fiori rosa intenso. Il pisello odoroso non è l'unica specie la cui introduzione è attribuita a Uvedale. Ma dal campo dei fatti, passiamo in quello della leggenda. Fino al 1920, presso l'Enfield Palace si poteva ammirare un esemplare secolare di cedro del Libano Cedrus libani, che sarebbe stato piantato da Uvedale tra il 1662 e il 1670, da semi portati da Gerusalemme da un allievo. Si tratterebbe del primo esemplare piantato in Inghilterra, se non in Europa. E' una pretesa largamente infondata. Le prime pigne di cedro furono portate in Inghilterra nel 1639 da Edward Peckock, Cappellano della compagnia turca ad Aleppo, che le passò al fratello, cappellano del conte di Pembroke a Wilton (Devon); intorno al 1640 due esemplari nati dai loro semi furono messi a dimora nel parco di Wilton e vissero fino al 1874. Più tardi Peckock divenne rettore di Childrey, Oxfordshire, e piantò nel giardino del rettorato un esemplare che sopravvive tuttora. Quando Uvedale piantò il suo a Enfield, dunque, se la data tradizionale è fondata, il cedro di Childrey era già un bell'albero di 40 o 30 anni, Ma anche quella data è stata contestata. In nessuna delle lettere di Uvedale ai suoi numerosi corrispondenti egli cita l'albero né viene menzionato nella descrizione del giardino di Enfield contenuta in Short Account of several Gardens near London di J. Gibson (1691). John Ray, un altro dei corrispondenti di Uvedale, parlando dei quattro esemplari di cedro piantati al Chelsea Physic Gardens nel 1683, si dice convinto che siano i primi ad essere piantati in Inghilterra (come abbiamo visto, non lo sono; ma furono i primi a fruttificare, e da loro discendono i virgulti portati al Jardin des Plantes da Bernard de Jussieu), Dal libro di Gibson ricaviamo interessanti informazioni sul giardino di Enfield: "Il dr. Uvedale di Enfield è un grande amante delle piante e, avendo un'arte straordinaria nel coltivarle, è riuscito a creare una delle più grandi e rare collezioni di esotiche che si siano viste in questo paese. Il giardino comprende cinque o sei edifici o ambienti. Il più vasto è occupato da aranci e da grandissimi mirti, un altro è riempito da mirti più piccoli; le piante più graziose e curiose, che richiedono maggior cura, si trovano in stanze più calde, alcune delle quali possono essere riscaldate all'occorrenza. I fiori sono scelti, l'assortimento ricco, la coltivazione metodica e curiosa; non vale però la pena di parlare dell'aspetto generale del giardino, perché la sua delizia e la sua cura più che nel piacere dell'occhio risiedono nella coltivazione di piante rare". Insomma, ancora lontano dal giardino paesaggistico all'inglese, il giardino di Uvedale è ancora essenzialmente una camera delle meraviglie barocca, in cui il sommo piacere è dato dall'ostentazione di piante rare, la cui coltivazione è resa possibile da una serie di stanze con temperature variabili; che una o più siano riscaldabili è una novità nell'Inghilterra del 1691, se pensiamo che sono precedute solo dalla "stufa" del giardino dei farmacisti a Chelsea (forse 1681) e dalle tre serre della regina a Hampton Court (1690). Persino la "serra delle esotiche" della ben più ricca duchessa di Beaufort arriva dopo. Né ricco né nobile, questo modesto insegnante di provincia, non di rado in conflitto con i suoi superiori, traeva dalla rarità delle collezioni, dalla suprema abilità di coltivatore e dalla frequentazione di dotti e stimati botanici un prestigio capace di elevarne lo status e di farne una figura riconosciuta, come abbiamo visto, persino in Sicilia. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1722, la collezioni di piante vive fu acquistata da Robert Walpole per Houghton Hall; l'erbario fu invece acquisito da Sloane. Anch'esso documenta la rete di corrispondenti di Uvedale, con esemplari ottenuti non solo da corrispondenti inglesi come Sherard, Richardson, Petiver, Plukenet, Bobart, Doody, Sloane, Du Bois, ma anche da corrispondenti continentali come Tournefort, Magnol, Vaillant e altri.  Dediche intricate Il dr. Uvedale doveva anche possedere il talento dei rapporti umani, tanto che riuscì a conservarsi l'amicizia sia di Plukenet sia di Petiver, nonostante l'ostilità tra i due. Al primo forniva piante per i suoi libri e per i giardini di Hampton Court, il secondo lo onorò battezzando Wedalia (il cognome poteva essere scritto in vari modi, incluso Wedal) una bella asteracea nordamericana con foglie palmate e capolini giallo oro. Linneo, prima in Hortus cliffortianus poi in Species plantarum, riprese la denominazione di Petiver, ma ne normalizzò la grafia e la trasformò in epiteto, ribattezzando la specie Polymnia uvedalia. Oggi si chiama Smallanthus uvedalia. Del nome generico così rimasto disponibile si ricordò a inizio Ottocento Robert Brown che in Prodromus Florae Novae Hollandiae (1810) istituì il genere Uvedalia per una piccola pianta da lui scoperta in Australia, U. linearis. Nella breve motivazione sono citati esplicitamente Plukenet, Petiver e il giardino di Enfield: "Questo genere, forse troppo affine a Mimulus, l'ho battezzato Uvedalia in memoria del dottore in teologia e legge Uvedale, lodato da Plukenet e Petiver, che nei pressi di Enfield creò un giardino soprattutto ricco di esotiche". Che fosse troppo affine a Mimulus lo pensavano sicuramente de Candolle che nel 1813 soppresse il genere e lo fece confluire in Mimulus, nonché Bentham che nel 1835 ribattezzò la specie di Brown dapprima Mimulus linearis, quindi M. uvedaliae, con un assurdo genitivo. Questa è stata la situazione per circa 200 anni, fino al 2012, quando Barker e Beardsley hanno fatto risorgere Uvedalia nell'ambito di una revisione generale di Mimulus, che ha comportato il distacco delle specie australiane, assegnate a sei piccoli generi, tra cui appunto Uvedalia con due specie, U. linearis e U. clementii. Ovviamente una soluzione che non piace a tutti: altri preferirebbero un genere Mimulus onnicomprensivo, sulla scia della linea adottata di recente per Salvia. Al momento, però, Uvedalia resiste. U. linearis è una piccola erbacea che vive nei suoli sabbiosi dei territori del nord dell'Australia, con foglie lineari e fiori con corolla bilabiata blu-violaceo con gola gialla, oppure gialla a volte puntinata di rosso nella varietà lutea. La poco nota e rara U. clementii è invece nativa dell'Australia nord occidentale. Moglie di un alto funzionario civile e militare, la contessa scozzese Christian Dalhousie seguì il marito prima in Canada poi in India. Forse per lei, come per molte dame del suo ceto, all'inizio la botanica fu solo un piacevole passatempo, ma presto divenne una missione, il suo modo di contribuire al progresso scientifico e alla diffusione della cultura. Corrispondente di William Jackson Hooker, fece parte di un singolare gruppo di signore che collaborarono attivamente alla raccolta di piante canadesi per la sua Flora boreali-americana; al contrario delle sue amiche, per lei però non fu un episodio. Le sue raccolte indiane furono così importanti da guadagnarle l'ingresso nella Società botanica di Edimburgo, unica donna del tempo a farne parte. La ricordano varie piante indiane e malesi e il genere Dalhousiea.  Quattro signore a caccia di piante Tra il 1829 e il 1840 William Jackson Hooker, all'epoca direttore dell'orto botanico di Glasgow, pubblicò la monumentale Flora boreali-americana, un'opera capitale per la conoscenza delle piante dell'America settentrionale. Si basò soprattutto sulle piante raccolte durante la seconda spedizione Franklin (1825-26), ma si servì anche degli esemplari e delle informazioni forniti da circa 120 raccoglitori e collaboratori: naturalisti e cacciatori di piante, ma anche militari, funzionari coloniali, persone comuni. Per preparare al compito quelli tra loro che non avevano una formazione come naturalisti (ed erano la maggior parte), predispose addirittura delle istruzioni su come raccogliere ed essiccare correttamente gli esemplari (Directions for Collecting and Preserving Plants in Foreign Countries: On Preserving Plants for a Hortus Siccus, 1828). Tra i più entusiasti raccoglitori canadesi di Hooker spiccano i nomi di quattro signore: Christian Broun Ramsay (più nota come Lady Dalhousie), Anne Mary Perceval, Harriet Sheppard e Mary Brenton. Tre di loro erano amiche intime e vivevano a Quebec City, all'epoca il centro amministrativo delle province orientali del Nord America britannico: Christian Ramsay (1786-1839) era la moglie di lord Dalhousie, prima vice governatore della Nuova Scozia, poi governatore generale del Nord America britannico; Anne Mary Flowers Perceval (1790-1876) era la moglie del direttore delle dogane del porto di Quebec; Harriet Sheppard (1786-1858) era la moglie di un facoltoso mercante di legname appassionato di scienze naturali. La quarta, Mary Brenton (1792-1884), viveva a Terranova, dove il padre era giudice della Corte Suprema; era l'unica a non far parte del gruppo di amiche, ma apparteneva alla stessa classe sociale, l'élite costituita dagli alti funzionari e dai facoltosi mercanti britannici. Come vedremo meglio tra poco, Hooker corrispondeva già con lady Dalhousie, ma la prima ad essere reclutata formalmente fu Anne Mary Flower Perceval. Non solo è citata in Flora boreali-americana non meno di 150 volte, ma fu lei a coinvolgere nell'avventura le due amiche e altri conoscenti. I coniugi Perceval erano bel noti nella vita mondana e culturale della colonia; il marito Michael Henry era figlio dell'ex primo ministro britannico Spencer Perceval, mentre la moglie era nata in una ricca famiglia di mercanti londinesi; molto apprezzati erano i pranzi e le serate danzanti che si tenevano nella loro bella casa, Spencer Wood, al centro di una grande tenuta. Anne Mary era una "castellana elegante", una dama dalle maniere squisite, ma anche una madre di famiglia con dieci figli che cercava di educare secondo i metodi più all'avanguardia. Fu probabilmente pensando alla loro educazione che incominciò ad interessarsi di botanica, approfittando della ricchezza di piante che poteva raccogliere nella sua stessa tenuta. Avviò un erbario, appassionandosi soprattutto di crittogame, e incominciò a corrispondere con vari botanici americani, tra cui John Torrey. Fu proprio quest'ultimo nel 1824 a raccomandarla a Hooker: la signora Perceval - scrisse - era un'eccellente botanica, che avrebbe potuto essergli utile spedendogli piante essiccate; ma era anche una dama dell'alta società con vasti contatti che poteva aiutarlo coinvolgendo altre persone. Tra Hooker e Perceval iniziò un scambio epistolare; la donna accettò con entusiasmo di contribuire al progresso dell'amabile scienza delle piante, coinvolgendo anche i suoi bambini di varie età. Per venire incontro alle sue esigenze pedagogiche Hooker le inviò una copia delle sue Botanical Illustrations (1822), un manuale che aveva scritto per la classe iniziale dei suoi studenti di botanica all'università di Glasgow. Perceval, che già utilizzava come punto di riferimento Flora Americae septentrionalis di Pursh, di cui apprezzava la chiarezza didattica, ne fu deliziata. Già nel giugno 1825 fu in grado di spedire a Hooker un primo invio, assicurandogli che presto ne sarebbe seguito un altro, grazie al coinvolgimento di diversi amici. A ottobre dello stesso anni gli scriveva: "Ho sguinzagliato i miei amici in tutte le direzioni. I signori Sheppard si occuperanno del Quebec, lady Dalhousie di Sorel e Montreal, e io di quello che resta". Tra il 1825 e il 1826 la signora Perceval, insieme ai figli, trascorse l'inverno a Filadelfia, dove incontrò il botanico Lewis von Schweinitz, cui diede vari esemplari tra cui Pterospora andromedea, un'ericacea rara che cresceva nel sottobosco di pini di Spencer Wood, e il medico e botanico William Darlington cui donò un album di piante canadesi. Avrebbe continuato a collaborare attivamente con Hooker fino al 1828, quando rimase improvvisamente vedova e lasciò il Canada. Non risultano sue raccolte dopo questa data. Delle amiche reclutate da Anne Mary Perceval, l'acquisto più produttivo fu indubbiamente Harriet Campbell Sheppard, anche perché, al contrario di Perceval e Ramsay, rimase in Canada fino alla fine dei suoi giorni. Le sue raccolte si estendono per tutti gli anni '20 e '30 e in Flora boreali-americana è citata 144 volte; molte delle piante da lei raccolte appartengono a generi "difficili", ovvero di classificazione problematica. Anche suo marito era interessato alla botanica e la coppia inviò esemplari non solo a Hooker, ma anche a Torrey e Asa Grey. Anche i loro bambini furono coinvolti nelle raccolte, con gli stessi intenti pedagogici di Anne Mary Perceval, che del resto era un'amica intima della coppia e loro vicina di casa. Sappiamo che non di rado erborizzavano insieme. Negli anni '20, William e Harriet Sheppard furono in prima fila nelle istituzioni che promuovevano la diffusione della cultura e della conoscenza scientifica in Canada, come la Literary and Historical Society of Quebec; sorta nel 1824 sotto il patronato di lord Dalhousie, divenne anche una tribuna dove comunicare le loro ricerche. Tuttavia, contrari all'esclusivismo della LHSQ, che accettava solo membri della ricca élite anglofona, nel 1827 furono tra i fondatori della più democratica Society for the Encouragement of Sciences and the Arts, che era aperta a anglofoni e francofoni e incoraggiava la partecipazione femminile. Harriet Sheppard pubblicò anche diversi contributi, tra cui una memoria sulle conchiglie. Già anziana, nel 1864 fu invitata a parlare alla conferenza annuale della Montreal Natural History Society come "una dei pionieri della storia naturale in questo paese". Ne approfittò per fare l'elogio della sua vecchia amica lady Dalhousie. Prima di occuparci di lei (la vera protagonista di questo post), ancora due parole sulla quarta raccoglitrice di Hooker, Mary Brenton. Alla fine del 1829, il botanico scrisse a lady Dalhousie lamentando che rimaneva scoperta la flora dell'estremità orientale dall'America britannica. Lady Dalhousie chiese al marito di coinvolgere ufficialmente i governatori del New Brunswick e di Terranova. Fu così che fu individuata Mary Brenton, le cui raccolte si estendono dal 1830 al 1838 circa. In Flora Boreali-Americana è citata 102 volte per piante sia native sia introdotte. Accompagnando il padre nei suoi doveri d'ufficio, poté viaggiare parecchio. Un'alta percentuale delle sue raccolte è costituita da piante boreali, molte delle quali provengono da stagni e paludi. Alcune sono rare, come Halenia brentoniana (oggi H. deflexa subsp. brentoniana), così denominata da Hooker in suo onore. Alla ricerca di piante "nuove e rare" in Canada e in India Ma è ora di parlare di lady Dalhousie. Nata Christian Broun, discendeva da una nobile famiglia scozzese tradizionalmente impegnata in campo legale. Diciannovenne si sposò con George Ramsay, ottavo conte di Dalhousie, un militare che aveva combattuto sotto Wellington nelle guerre napoleoniche. Tornata la pace, anche per far fronte alle ingenti spese della ristrutturazione dell'amato Dalhousie Castle, egli accettò di entrare nell'amministrazione civile e nel 1816 fu nominato vicegovernatore della Nuova Scozia. La moglie e i tre figli lo accompagnarono in Canada, stabilendosi ad Halifax. Entrambi i coniugi coltivavano interessi culturali e promossero il progresso della cultura scientifica. Lord Dalhousie fondò il Dalhousie College di Halifax, ora Dalhousie University; inoltre acquistò una vasta proprietà dove introdusse miglioramenti agricoli. Lady Dalhousie faceva da padrona di casa, presiedeva alle occasioni mondane e accompagnava il marito nei frequenti viaggi imposti dai suoi doveri. Era una grande lettrice, di vasta cultura, molto spiritosa (come si evince sia dalle sue lettere, piene di humor, sia dalle divertenti caricature della buona società di Halifax che disegnò in quegli anni), ma anche seria e determinata. Una serietà e una metodicità ben riconoscibili nell'erbario che iniziò in questi anni, in cui luogo e data di raccolta sono indicati con precisione, le piante sono accompagnate da indicazioni sull'habitat e spesso da schizzi ad acquarello e le specie sono identificate con notevole precisione sulla scorta di Flora Americae septentrionalis di Pursh. Ben presto le sue preferite divennero le felci. Iniziò anche a spedire in Scozia semi e piante vive per il giardino di Dalhousie Castle. Nel 1820 lord Dalhousie fu promosso Governatore generale dell'America britannica e la famiglia si trasferì a Quebec City. La sede ufficiale era Chateau St. Louis, nella città alta, ma la residenza preferita divenne la tenuta di Sorel, una cittadina situata a sud-est di Montreal. Era una zona ricca di piante che permise a lady Dalhousie di raffinare le sue conoscenze botaniche. L'erbario crebbe rapidamente. Nel 1823, tra Sorel e Montreal, raccolse 328 piante, alcune delle quali rare. Nell'estate del 1826, tra Sorel, Quebec City, l'Ottawa River e il Gaspé, ne raccolse circa 300. Lady Dalhousie entrò in contatto con Hooker ancora prima che questi lanciasse il suo appello per Flora boreali-americana. Nel 1823 gli inviò alcune scatole con varie rarità raccolte nelle vicinanze di Montreal, soprattutto orchidee. Lo stesso anno egli la raccomandò all'esploratore artico John Richardson come "una botanica molto zelante" e nel suo saggio On the Botany of America del 1825 la collocò in prima fila tra coloro che maggiormente stavano contribuendo alla conoscenza della flora canadese. Dunque accolse volentieri l'invito dell'amica Anne Mary Perceval. Tuttavia, rispetto a lei e alle altre due raccoglitrici di Hooker, il suo contributo quantitativo a Flora boreali-americana si riduce a una cinquantina di specie, soprattutto orchidee e felci: infatti era sua ambizione contribuire con piante nuove o rare. Insieme al marito, progettava anche di creare un orto botanico in un'isola del San Lorenzo, ma ostacoli politici ne impedirono la realizzazione. Nel 1824 la famiglia tornò momentaneamente in patria e lady Dalhouisie diede mano alla ristrutturazione del giardino di Dalhousie Castle; lord Dalhousie era intenzionato a dare le dimissioni e ad occuparsi della sua proprietà in Scozia, ma le finanze familiari furono rovinate dal fallimento del suo agente. I Dalhousie dunque tornarono in Canada, rimanendovi fino al 1828. Nel 1827 lady Dalhousie presentò alla Literary and Historical Society of Quebec (di cui era cofondatrice con il marito) circa 400 piante canadesi; il catalogo fu pubblicato nel 1829 nel primo volume delle Transactions della società. Nel frattempo, lord Dalhousie era stato nominato comandante in capo dell'esercito britannico in India. Nel luglio 1829 marito e moglie partirono per la nuova destinazione; durante il viaggio, lady Dalhousie approfittò degli scali a Madeira, Sant'Elena e al capo di Buona Speranza per incrementare le sue raccolte. Lo stesso fece durante il soggiorno indiano, che si protrasse fino al 1834. Anche se si definiva a tyro "una tirocinante, una principiante", e all'inizio fu sconcertata da una flora che appariva tanto diversa da quella scozzese o canadese, era ormai una botanica ben più che dilettante. Le raccolte del periodo indiano ammontano a non meno di 1200 esemplari; quelle più significative le fece a Simla e a Penang. In una spiritosa lettera del febbraio 1833 a Hooker riassume i suoi viaggi, scusandosi della scarsa qualità e quantità delle piante raccolte in Malesia: il loro soggiorno è durato solo sei settimane ed è coinciso con la stagione delle piogge, rendendo impossibile seccare le piante a regola d'arte. Racconta poi del viaggio a Simla: dopo aver risalito il Gange per 700 miglia, hanno percorso le pianure indiane per 800 miglia a dorso d'elefante: viaggiare a tanti piedi d'altezza non è molto pratico per botanizzare! A Simla si sono fermati sette mesi, e lì davvero ha trovato un paradiso botanico, ma - aggiunge modestamente - non c'era nessuno ad aiutarla e potrebbe aver identificato scorrettamente molte piante. In realtà, era un'abile raccoglitrice con occhi esercitati per individuare piante nuove e rare. Grazie a lei molte andarono ad arricchire l'orto botanico di Calcutta. Del suo vasto ed eccellente erbario poté giovarsi ancora il figlio di Hooker Joseph Dalton per la sua Flora Indica. Hooker padre volle manifestare la sua gratitudine dedicandole il volume del 1833 del Curtis Botanical Magazine "per gli essenziali servizi che, nonostante i suoi vari doveri in Canada e in Bengala, ha reso alla botanica con le sue estese collezioni e l'introduzione di molte specie interessanti nei giardini di questo paese". Tornata definitivamente in Scozia nel 1834, donò le sue collezioni all'orto botanico di Edimburgo e divenne membro onorario della Società botanica della città, la sola donna ad esservi ammessa. Fu presto una figura riconosciuta della società cittadina e dedicò i suoi ultimi anni soprattutto al giardino di Dalhousie Castle, dove aveva creato un felceto con le piante raccolte durante i suoi viaggi. Era sua intenzione descriverle in un volume, come annuncia in una lettera a Hooker; la morte improvvisa nel 1839 le impedì di realizzare il progetto. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Omaggi floreali Diverse piante ricordano la nostra raccoglitrice "ai quattro angoli del mondo" (l'espressione è sua). La maggior parte delle piante che portano o hanno portato il suo nome nell'eponimo furono raccolte durante il "piovoso" soggiorno a Penang: le felci Asplenium dalhousiae e Pteris dalhousiae, la licopodiacea Huperzia dalhousieana, la spettacolare orchidea Dendrobium dalhousieanum (oggi D. pulchellum). Fu raccolta invece a Simla la bella Acantacea Strobilanthes dalhousiana. Le è stato dedicato anche il coloratissimo beccolargo codalunga, un passeriforme dell'Himalaya, Psarisomus dalhousiae; ne vediamo un esemplare impagliato nell'unico ritratto ufficiale della contessa: austeramente vestita di nero, ostenta un cipiglio severo che non ci aspetteremmo leggendo le sue lettere piene di ironia. Lo splendido Rhododendron dalhousiae non è invece dedicato a lei, ma a sua nuora Susan, moglie dell'unico figlio sopravvissuto, James Broun-Ramsay, marchese di Dalhousie. Quest'ultimo alla fine del 1847 fu nominato governatore generale dell'India e, insieme alla moglie, raggiunse la sua sede viaggiando sulla stessa nave che portò in India Joseph Dalton Hooker. Il botanico divenne buon amico della coppia e, grato dei molti aiuti ricevuti dal governatore durante la sua spedizione indiana, dedicò la bella pianta a lady Susan. Lady Christien è infine ricordata dal genere Dalhousiea (famiglia Fabaceae). Roxburgh nelle foreste del Bengala aveva raccolto un rampicante che denominò Podalyria bracteata, ma Robert Brown osservò che non poteva appartenere a quel genere. Robert Graham, professore di botanica di Edimburgo e membro eminente della Edinbourgh Botanical Society, la attribuì a un genere proprio che denominò appunto Dalhousiea. Si tratta di un piccolo genere con areale disgiunto, che comprende due sole specie: D. africana, che vive nell'Africa occidentale tropicale, e D. bracteata, diffusa nell'Himalaya orientale, in Bengala, in Assam e in Myanmar. Entrambe vivono nelle foreste tropicali umide. D. africana è una liana, mentre D. bracteata è un arbusto sarmentoso o una rampicante, con infiorescenze terminali di fiori bianco neve. Le foglie fresche sono usate in impiastri, mentre nella comunità Tagin dell'Arunachal Pradesh pezzi di corteccia trovano uso in rituali divinatori. Scoperto nel giardino abbandonato di un monastero buddista birmano, quello che fu presto soprannominato "l'albero più bello del mondo" venne battezzato dal botanico Nathaniel Wallich Amherstia nobilis in onore di Sarah e Sarah Elizabeth Amherst, rispettivamente moglie e figlia del governatore dell'India. Sembrerebbe il solito, banale, omaggio cortigiano se non fosse che le due ladies si erano rese benemerite della botanica come pioniere dell'esplorazione della flora indiana, scoprendo e introducendo in Europa, tra l'altro, una beniamina dei nostri giardini, Clematis montana.  Una nobile pianta... Nel marzo del 1826, il trattato di Yandaboo metteva fine alla prima guerra anglo-birmana (1824-1826) con la cessione all'Inghilterra di Assam, Manipur, Arakan e Tenasserim. Lord Amherst, il governatore generale dell'India, inviò immediatamente nella Birmania meridionale una missione esplorativa capeggiata dal medico e esperto diplomatico John Crawfurd; ne faceva parte anche il botanico Nathaniel Wallich, direttore dell'orto botanico di Calcutta, il cui compito principale era valutare le potenzialità forestali della regione. Alla fine del mese, mentre Wallich rimaneva a Rangoon, Crawford con alcuni accompagnatori esplorò la zona tra Rangoon e la foce del fiume Thanlwin. Il 4 aprile, il gruppo visitò la grotta naturale di Kogún, decorata con centinaia di tavolette votive di terracotta; tra le offerte dei fedeli, manciate di splendidi fiori rossi. Erano stati raccolti poco lontano, nel giardino incolto di un monastero buddista semiabbandonato, dove cresceva "un albero alto circa venti piedi, abbondante di lunghi grappoli penduli di fiori di un ricco color geranio, con lunghe eleganti foglie lanceolate" (An Account of Martaban in March and April 1826). Crawfurd capì subito di trovarsi di fronte a una pianta ancora ignota alla scienza, impressione confermata al ritorno a Rangoon da Wallich, cui mostrò i campioni raccolti. Nei mesi successivi, il botanico danese la cercò inutilmente nelle foreste birmane, finché la ritrovò nel sito già segnalato da Crawfurd. Ne prelevò anche diversi germogli che poi trapiantò nell'orto botanico di Calcutta. Al suo ritorno in Inghilterra, pubblicò lo splendido albero in Plantae asiatiacae rariores (1830) come Amheristia nobilis, in onore della moglie e della figlia del governatore. Sembrerebbe il più scontato degli omaggi cortigiani, se non fosse che quel riconoscimento la madre, la contessa Sarah Amherst, e la figlia, Sarah Elizabeth Amerherst, se l'erano guadagnato davvero non solo come protettrici della scienza, ma come instancabili raccoglitrici di piante. Lo ricorda nella dedica lo stesso Wallich: "Dedicato alla nobile contessa Amherst e a sua figlia lady Sarah Amherst, in segno di riconoscimento della somma cura, della debita assiduità e degli indefessi e felici successi con i quali, finché dimorarono in India, coltivarono e promossero la scienza botanica". Tanto più che, quando Wallich scrisse queste parole, la burrascosa carriera pubblica di lord Amherst era ormai giunta al termine. William Pitt Amherst (1773-1857) è passato agli annali della diplomazia come responsabile del fallimento della sfortunata ambasceria in Cina (1816) a causa del suo rifiuto di prostrarsi di fronte all'imperatore. Anche il suo mandato in India, di cui fu governatore generale tra il 1823 e il 1828, fu sfortunato e discusso. Poco dopo il suo arrivo nel subcontinente, egli si lasciò incautamente convincere a dichiarare guerra alla Birmania, convinto che il conflitto si sarebbe risolto in poche settimane. Invece durò due anni, costò 13 milioni di sterline, scatenò un'epidemia di colera, provocò l'ammutinamento dei sepoys, rovinò l'economia indiana e le finanze della Compagnia delle Indie. Se non avesse avuto potenti protettori a Londra, primo fra tutti il duca di Wellington, egli sarebbe stato destituito. La conclusione positiva della guerra, insieme a una sua condotta più prudente, fece cambiare idea ai vertici della compagnia. Tuttavia, nel 1826, con una tipica operazione promoveatur ut amoveratur, il re lo nominò visconte, ma contemporaneamente fu richiamato in patria e per i quasi trent'anni che gli rimasero dal vivere non gli fu più affidato alcun incarico pubblico. Molto più gloriosi dunque gli allori botanici (e ornitologici) di sua moglie e sua figlia.  E due nobili raccoglitrici La contessa Amherst (1762-1838), nata Sarah Archer, apparteneva all'alta nobiltà britannica. Sedicenne, si sposò con un cugino, il conte di Plymouth, da cui ebbe diversi figli. Rimasta vedova, nel 1800 si risposò con lord Amerhest, da cui ebbe una figlia, appunto Sarah Elizabeth, e tre figli. Non sappiamo come fosse nata la sua passione per le piante né se precedesse il soggiorno indiano. Come molte dame del suo ceto, coltivava le arti del disegno e della musica, che aveva trasmesso anche alla figlia. Nel 1823, quando partì alla volta dell'India con il marito, la figlia Sarah Elizabeth e il figlio maggiore Jeffrey, la contessa aveva già compiuto sessant'anni. Sui circa cinque anni trascorsi in India siamo ben informati grazie alle lettere di Sarah Elizabeth ai fratelli e soprattutto grazie al diario della stessa lady Amherst, di notevole freschezza e ammirevole semplicità. Il 18 marzo 1823 la famiglia sbarcò a Madras, dove fu ricevuta in pompa magna; proseguì poi via terra per Calcutta, dove giunse il 1 agosto. La residenza del governatore, Gouvernment House, era, anzi è, un lussuoso palazzo posto al centro di un vastissimo complesso, di cui conosciamo l'aspetto all'epoca grazie a uno schizzo di Sarah Elizabeth. Lady Amherst, che considerava assurdi i tentativi delle sue compatriote di ricreare in India cloni dei giardini inglesi, con piante portate dalla madrepatria condannate a morte certa, era decisa a crearvi un giardino popolato di piante locali. Fu forse con questo intento che visitò ripetutamente l'orto botanico della Compagnia delle Indie, a Shibpur, a una decina di km dall'area governativa di Calcutta. Fondato nel 1787, sotto la direzione prima di William Roxburgh e ora di Nathaniel Wallich, era divenuto un centro di studio e di acclimatazione di prim'ordine e un'oasi verde con migliaia di specie provenienti da tutte le regioni del subcontinente, ma anche da altri paesi tropicali. Diligente, lady Sarah ne percorreva i sentieri disegnando schizzi, prendendo note, chiedendo lumi al direttore, che divenne subito un amico. Fu forse su suo incoraggiamento che la nobildonna, con l'aiuto dell'inseparabile figlia, iniziò a creare il suo erbario indiano, con le piante raccolte e preparate "in modo abile e industrioso" (sono parole di Wallich). I numerosi viaggi ufficiali cui partecipò a fianco del marito le diedero occasione di visitare diverse aree del paese e di mettere insieme una collezione di non meno di cinquecento specie. Non è però il caso di immaginare le due ladies nei dimessi panni di cacciatrici di piante in gonnella. Coinvolgendo la prima dama del paese, anche una breve escursione diventava un affare di stato. Ad esempio, come leggiamo nel diario della contessa, nel gennaio 1825 madre e figlia, scortate da aiutanti di campo, risalgono il fiume in battello per visitare le rovine del forte di Gaukachi; fanno un picnic nella foresta, accettano graziosamente gli omaggi di banane, arance, latte offerte dai contadini; poi, mentre i battitori le aprono la strada a colpi di machete, lady Amherst issata su un elefante può penetrare nella giungla, che le si mostra come uno scrigno prezioso e selvaggio di alberi coperti di fiori e frutti. Alla sera, le due dame tornano trionfanti a casa con i loro trofei: piante, schizzi, fiori. Tra battellieri, cuochi, servitori, portatori, battitori la gitarella ha coinvolto qualche centinaio di persone. Lo stesso anno, un viaggio fluviale di una decina di giorni con la famiglia Amherst al completo impegnerà, tra servitori, battellieri e soldati di scorta, circa cinquecento persone. Tra i viaggi ufficiali, il più lungo e impegnativo fu quello che tra il giugno 1826 e il luglio 1827 portò il governatore (accompagnato dalla consorte e dalla figlia) a visitare gran parte dell'India settentrionale. Nella primavera del 1827, dopo una lunga visita di stato al moghul a Dehli, Amherst raggiunse Simla, dove doveva incontrare il maharaja del Punjab e l'ex re di Kabul. Fu così che scoprì quella che qualche anno dopo sarebbe diventata anche ufficialmente la "capitale estiva del Raj Britannico". Situata a un'altitudine di oltre 2000 metri e circondata dalle maestose cime dell'Himalaya, incantò tutti; le più felici erano la contessa e sua figlia che nei due mesi e mezzo trascorsi a Simla poterono sfogare la loro passione per la natura arrampicandosi instancabili sulle pendici di colline e montagne alla ricerca di piante rare o sconosciute alla scienza. In quel paradiso botanico che erano tra le prime ad esplorare scoprirono numerose nuove specie, tra cui Spiraea argentea Benth. (forse da identificarsi con S. media), Astragalus amherstianus, Allium leptophyllum (oggi A. rubellum), Bosea amherstiana, Wulfeniopsis amherstiana, Anemone vitifolia (oggi Eriocapitella vitifolia). Nel sottobosco di una foresta di cedri deodora, la scoperta più bella: Clematis montana, nella forma alba. Al loro ritorno a Calcutta, Sarah Elizabeth si ammalò gravemente. Il governatore e la sua famiglia dovettero così attendere l'inizio del 1828 per lasciare l'India. All'appello mancava Jeffrey che nel 1826 era morto di febbri a soli 24 anni. Nei loro bagagli, molti souvenir indiani, un erbario di cinquecento specie, semi e piante vive da introdurre in Inghilterra e una coppia di splendidi fagiani birmani, dono del re di Birmania alla contessa. Oggi sono noti come "fagiani di lady Amherst", Chrysolophus amherstiae. Ormai escluso dalla vita pubblica, lord Amherst si ritirò a vivere a Montreal, la sua casa di campagna nel Kent. Nel giardino e nelle serre, la contessa coltivava le piante portate dall'India, ma anche altre esotiche, come le brasiliane Justicia amherstiae (oggi J. brasiliana) e Grobya amherstiae. Il magnifico giardino che aveva creato attorno alla Gouvernment House non sopravvisse alla sua partenza: la moglie del nuovo governatore, lady Bentinck, dichiarò che quei fiori erano "veramente malsani" e tempo una settimana fece spiantare tutto. Una sintesi della vita delle due ladies Amherst nella sezione biografie.  Una gara tra giardinieri La pubblicazione di Amherstia nobilis da parte di Wallich destò sensazione; la pianta venne immediatamente proclamata "l'albero più bello del mondo" e destò la cupidigia dei collezionisti. Tuttavia, al momento si conosceva solo l'esemplare di Kogún e i virgulti trapiantati da Wallich a Calcuitta che ci misero qualche anno a fiorire. Nel 1836 il duca di Devonshire spedì in India a caccia di piante l'aiuto giardiniere John Gibson: le sue istruzioni recitavano "procurarsi tutte le orchidee possibili e ritrovare Amherstia nobilis". Gibson ebbe la fortuna di arrivare a Calcutta proprio al momento della fioritura delle Amherstiae trapiantate da Wallich; si dice che ne fu così emozionato da mettersi a battere le mani come un bambino piccolo. Poi andò in Martaban a raccogliere semi e talee che però non sopravvissero. Un anno dopo tornò in Inghilterra con 300 nuove specie, tra cui 80 orchidee, e una pianticella di Amherstia nobilis. Per accoglierla degnamente, il duca fece costruire nel suo giardino di Chatsworth una serra apposita, la Amherstia house. Ma nonostante tutte le cure, la pianta morì qualche anno dopo, senza mai essere arrivata a fiorire. Negli anni successivi, la stessa sorte toccò ad altri esemplari coltivati a Syon House e a Kew. Il successo sarebbe arriso a un'altra signora, Louisa Lawrence. Moglie di William Lawrence, presidente del reale ordine dei chirurghi di Londra, a partire dal 1838 creò a Ealing un giardino famoso per la bellezza, la grande varietà di piante rare, la perfezione con cui erano coltivate. Orgogliosa della sua abilità e molto competitiva, Louisa accumulava premi su premi alle principali mostre orticole; il suo più grande rivale era Joseph Paxton, il capo giardiniere del duca di Devonshire. Nel 1849 gli inflisse la suprema umiliazione di riuscire a far fiorire per la prima volta Amherstia nobilis; ottenne quel risultato semplicemente lasciando aperta la porta della serra. Da allora, finché Louisa visse, il miracolo si ripeté ogni anno. Alla sua morte, nel 1855, la pianta venne trasferita a Kew, dove fiorì ancora per tre anni, poi morì. Ma nel frattempo i suoi fiori erano stati offerti alla regina Vittoria e aveva fatto in tempo a vederla e disegnarla anche Marianne North. Come scrive nelle sue memorie, furono anzi quei meravigliosi fiori ad accendere il suo desiderio di viaggiare per dipingere piante esotiche: "Una volta Sir William Hooker mi diede un mazzo di Amherstia nobilis, uno dei più grandi fiori esistenti. Era la prima volta che fioriva in Inghilterra, e quel dono mi fece desiderare ancora di più di vedere i tropici". Amherstia nobilis è l'unica specie del suo genere (famiglia Fabaceae). E' originaria delle foreste umide della Birmania e della Tailandia, ma in natura è molto rara. Considerata sacra, nel sudest asiatico viene spesso piantata nei giardini dei templi, in modo da poterne offrire i fiori freschi alle immagini del Budda. Inoltre è stata introdotta in altri paesi tropicali, anche se, come si è potuto notare, la sua coltivazione non è semplice, quindi a coltivarla sono soprattutto gli orti botanici. E' un albero sempreverde, alto fino a 15 metri, con chioma arrotondata, eleganti rami penduli e lunghe foglie composte. Fiorisce due volte l'anno, in ottobre e in aprile, e ciascuna volta per appena due o tre giorni. Le infiorescenze, lunghe anche 80 cm, portano venti fiori o più; retti da piccioli con la parte terminale cremisi, hanno cinque petali diseguali, quelli superiori più piccoli anch'essi cremisi, quelli medi cremisi con apici gialli, quello centrale di dimensioni maggiori, a forma di ventaglio con un triangolo giallo che si estende dal labbro alla gola; molto decorativi anche gli stami arcuati, rosso chiaro con antere gialle. Anche i frutti, a forma di scimitarra e dapprima rossi, sono di piacevole aspetto. La spettacolare pianta è nota anche con il nome "orgoglio di Birmania". Altre informazioni nella scheda. Situata nel villaggio di Emame nelle Fiandre, Huis Beaucarne è una dimora storica che si inorgoglisce di una spettacolare "serra dell'uva", con viti di circa 250 anni; ma anche di aver dato il nome al genere Beaucarnea che qui fiorì per la prima volta in coltivazione. Merito del notaio Beaucarne, al suo tempo celebre collezionista di orchidee, un grande appassionato che nelle sue serre sapeva offrire alle piante le condizioni ideali e le migliori tecniche di coltivazione.  Una visita a casa Beaucarne Oggi Emame fa parte della municipalità di Oudenarde. Un tempo vi sorgeva una delle abbazie più importanti del Belgio, quella di San Salvatore che tuttavia nel 1795, in seguito all'occupazione francese, fu smantellata. Il sindaco della cittadina, Jean François Beaucarne, mise in salvo (o, si impadronì, dipende dai punti di vista) diversi arredi che andarono ad arricchire la sua casa, Huis Beaucarne, una dimora storica che si affaccia sulla piazza del paese e appartiene alla famiglia dal 1748. Con i suoi interni d'epoca e collezioni d'arte e curiosità, oggi è un monumento nazionale protetto; è anche una meta turistica, che offre visite guidate, tè del pomeriggio e location per matrimoni e altri eventi. Tra le attrazioni più notevoli, la maestosa vigna piantata due secoli e mezzo fa che occupa il secondo piano dell'arancera settecentesca, sopraelevata nell'Ottocento proprio per ospitarla. Il giardino, passato attraverso molti rifacimenti, appare un po' trascurato e incoerente, ma nell'Ottocento era uno dei più celebri del Belgio, soprattutto per le sue serre. Merito di uno dei membri della famiglia, il notaio Jean Baptiste Beaucarne (1802-1889); al contrario di almeno due dei suoi fratelli, impegnati in politica e protagonisti della rivoluzione del 1830, egli si divideva tra la professione e la passione per le piante, alle quali dedicava ogni momento libero. La sua era una famiglia di notabili, e non gli mancava la disponibilità finanziaria; aveva al suo servizio diversi giardinieri (nei registri comunali ne risultano almeno sette) ma sicuramente sapeva dirigerli con competenza. La sua lunga vita gli permise di diventare il decano dei collezionisti-amatori belgi. Il suo nome compare con una certa frequenza nelle riviste di giardinaggio dell'epoca. Era famoso soprattutto come orchidofilo, citato con elogio anche da Linden; le sue piante, esposte in patria e all'estero, gli guadagnarono menzioni e premi, come la medaglia d'oro alle Floralies di Gand del 1883. Un articolo comparso sulla Revue d'horticulture belge et étrangere nel 1886 ci consente di farci un'idea delle sue serre ai tempi d'oro. Mentre oggi sopravvivono solo la serra dell'uva e quella delle orchidee, trasformata prima in orangerie poi in cafeteria, allora ce n'erano almeno cinque. Proprio come la casa, tutto era lindo e pinto, con i muri tinteggiati di fresco e i pavimenti ben piastrellati. Due grandi serre erano riservate alla collezione di camelie e azalee, all'epoca considerate demodé, ma coltivate benissimo e con molte varietà recenti. La terza serra, di tipo "olandese", ovvero con le finestre a 90 gradi per ricevere il massimo della luce solare nei mesi invernali, era il regno di Agave, Dasilyrion e Yucca, di cui il notaio possedeva la più completa collezione del paese, con molte rarità: piante di dimensioni contenute, poco esigenti, coltivate in modo ottimale a giudicare dal loro rigoglio. Accanto a loro, altre piante ornamentali, una collezione di Araliaceae, qualche palma e una spettacolare Medinilla magnifica. Al piano terra della serra dell'uva venivano ricoverate le piante poco rustiche che trascorrevano la bella stagione all'esterno. Infine, eccoci giunti al clou, la serra delle orchidee. Diversamente dalle altre, non era pavimentata e vi era mantenuta un'atmosfera caldo-umida. Al momento della visita, ad attirare gli sguardi era un'impressionante Vanda lowii (oggi Dimophorchis lowii) in fiore, con due scapi lunghi 1,65 cm e 22 fiori ciascuno; nel 1876 Beaucarne era stato il primo a far fiorire questa una rarità. Ma c'erano molte altre orchidee fiorite, e tutte colpivano per il vigore eccezionale; nell'articolo si citano Vanda, Aerides, Saccolabium e Phalaenopsis; tra le altre spiccavano una notevole Laelia x brysiana (oggi Cattleya elegans) e una Vanda parishii (oggi Phalaenopsis hygrochila). Al momento della visita il notaio, che accolse i suoi ospiti con affabilità, era già ultraottantenne e morì pochi anni dopo, nel 1889. Almeno una parte delle piante fu messa in vendita dagli eredi. Il catalogo d'asta registra 694 tra specie e varietà. L'asta richiamò acquirenti anche dall'estero e durò due giorni, il primo riservato alle azalee e alle camelie, il secondo a tutto il resto. Oltre a numerosissime orchidee, furono offerte palme, Bromeliaceae e Amaryllis (presumibilmente Hippeastrum). 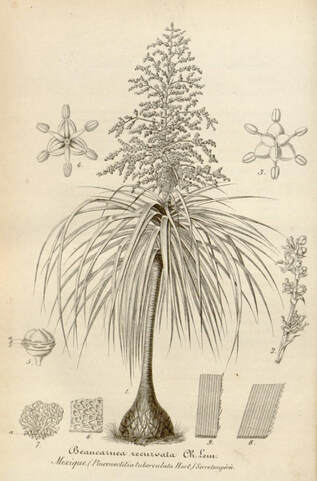 Fiorirà la Beaucarnea... Non fu però un'orchidea a guadagnare al notaio Beaucarne un posticino nella storia della botanica, ma una delle piante senza troppe pretese che coltivava nella serra "olandese". A spiegarci perché è Charles Antoine Lemaire, curatore della celebre rivista L'Illustration agricole. Il primo settembre 1861 egli si trovò a far parte della giuria dell'esposizione floricola di Oudenarde, a due passi da casa Beaucairne. Il notaio presentò un esemplare di Pincecnitia, Pincinectia o Pincenectia (un nome barbaro scritto in vari modi), una pianta che da qualche tempo era abbastanza coltivata nelle serre temperate belghe; non rara, e neppure di dimensioni eccezionali: Lemaire ne aveva viste alte e grosse il doppio o il triplo, ma... quella del notaio era in piena fioritura! Fino ad allora, nessuno era riuscito a farla fiorire e i fiori erano ignoti. Già da un primo sommario esame, Lemaire capì che doveva trattarsi di un'Asparagacea; ne ebbe la conferma studiando a suo agio l'infiorescenza "per la graziosa cortesia del possessore". Giunse così alla conclusione che la specie andava assegnata a un genere nuovo che battezzò Beaucarnea, in onore appunto del nostro Jean-Baptiste Beaucarne. Denominò la specie Beaucarnea recurvata, un nome che conserva anche oggi; nota anche con il nome comune di "pianta mangiafumo", è una delle più diffuse piante d'appartamento. La si può acquistare ovunque, incluso il negozietto di Huis Beaucarne, di cui ovviamente è il genius loci. E' la specie più conosciuta del genere Beaucarnea, che comprende una dozzina di specie di succulente pachicauli delle foreste xerofile di Messico, Belize e Guatemala; è molto affine a Nolina, ma recenti ricerche ne hanno confermato l'indipendenza, inserendovi anche le due specie precedentemente assegnate a Calibanus. Chi desiderasse saperne di più, non deve mancare di visitare il Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero a Xalapa, nello stato messicano di Veracruz; qui si trova la "Colección Nacional de Beaucarneas" con oltre 400 esemplari di sette specie. Di lenta crescita, hanno fusto ingrossato alla base e foglie lineari, in alcune specie lunghissime, raccolte in ciuffi apicali; i fiori, riuniti in una grande pannocchia, sono numerosissimi ma molto piccoli. A produrli solitamente sono solo gli esemplari piuttosto vecchi: cosa che rende ancora più eccezionale l'impresa del notaio Beaucarne e dei suoi giardinieri. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|



 RSS Feed
RSS Feed