|
Nell'epoca vittoriana, la passione per le piante esotiche ha ormai contagiato l'intera società britannica; e all'introduzione di nuove specie da studiare, moltiplicare e coltivare non contribuiscono solo botanici e cacciatori di piante al servizio di orti botanici e vivai, ma anche singoli viaggiatori, commercianti, soldati, funzionari. E diplomatici, come il protagonista di questa storia, John Henry Mandeville. Furono numerose le piante interessanti che inviò a Londra dalla sua sede di Buenos Aires, secondo la testimonianza di John Lindley, che gli dedicò la più bella, la profumatissima Mandevilla suaveolens. A lungo piante di nicchia coltivate solo da chi poteva permettersi una serra, le Mandevillae sono oggi protagoniste di una vera rivoluzione, che le ha trasformate nelle rampicanti da fiore più apprezzate e vendute (persino nei supermercati), anche se, per una serie di complesse vicende, spesso sono commercializzate con il sinonimo Dipladenia. 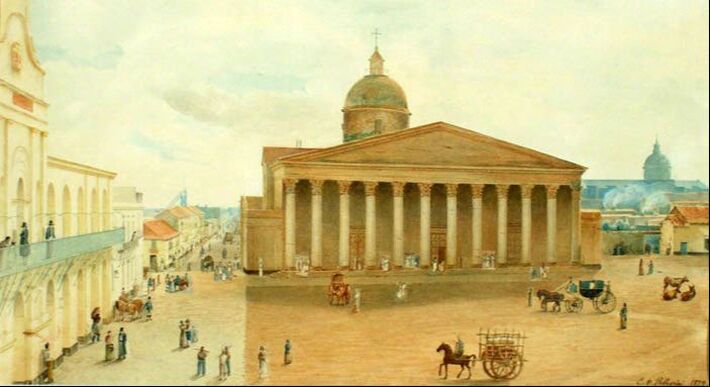 Successi e umiliazioni di un diplomatico Dopo un trentennio di gavetta, la carriera diplomatica di John Henry Mandeville (1773-1861) raggiunse il suo culmine con la nomina a ministro plenipotenziario britannico a Buenos Aires. Secondo Raymond Jones, studioso della diplomazia del Regno Unito, era un ottimo diplomatico, un "cavallo da tiro", stimato dai superiori per la capacità di iniziativa, l'intelligenza, l'affidabilità. Tuttavia gli mancavano gli amici potenti che gli avrebbero garantito incarichi più prestigiosi; dovette così accontentarsi di questa sede diplomatica che il Foreign office considerava secondaria. Diplomatico di lunga esperienza, uomo di mondo e conversatore facondo e affabile, Mandeville sembrava la persona giusta per barcamenarsi in una situazione tutt'altro che facile. Gli interessi britannici nel paese sudamericano, che aveva raggiunto l'indipendenza nel 1823 e si era affrettato a sottoscrivere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione con il Regno Unito, erano importanti: la Gran Bretagna era il maggior partner commerciale e il primo investitore, e il trattato garantiva molti privilegi ai suoi sudditi. Tuttavia l'ascesa al potere del generale Rosas sembrava mettere in forse la stretta alleanza tra i due paesi, come faceva temere l'allontanamento del predecessore di Mandeville, Hamilton Charles Hamilton. La scelta del Foreign Office si rivelò lungimirante: giunto nella sua nuova sede nel 1835, Mandeville riuscì a conquistare la fiducia di Rosas e a convincerlo a sottoscrivere un accordo che metteva al bando la compravendita di schiavi. Il suo rapporto con il tirannico, sospettoso e grossolano generale non fu però esente da ombre: se da una parte quest'ultimo ne apprezzava la conversazione e lo invitava volentieri alla casa Rosada, incoraggiandolo addirittura a corteggiare sua figlia Manuela, dall'altra diffuse pettegolezzi su di lui e arrivò a farlo pedinare dalla polizia e a intercettarne la corrispondenza. D'altra parte, anche l'atteggiamento di Mandeville verso il dittatore argentino era ambivalente, come la politica del suo paese. Se mai si permise una critica aperta, non mancò di informare puntualmente il suo governo delle nefandezze del regime rosista ai danni degli oppositori; in ogni caso, sia lui, sia lord Palmerston erano convinti che in un paese selvaggio come l'Argentina un personaggio come Rosas fosse un male necessario (non diverso sarà il giudizio di Churchill su Mussolini). A partire dal 1838, Mandeville si trovò a gestire la difficile crisi internazionale provocata dalla Francia che impose il blocco navale del Rio della Plata per vedersi riconosciuto lo status di "potenza più favorita" di cui già godeva la Gran Bretagna; la Francia puntava direttamente alla caduta di Rosas, allenandosi con i suoi oppositori interni e con l'Uruguay. Dietro a tutto questo c'era evidentemente la rivalità politica ed economica tra la stessa Francia e la Gran Bretagna; tuttavia quest'ultima andò sempre più allontanandosi da Rosas, perché la situazione politica globale (si pensi in particolare alla Guerra dell'oppio) spingeva a un'intesa con Parigi. La guerra tra Argentina e Uruguay, il feroce nazionalismo di Rosas, il deciso interventismo francese spinsero così Palmerston a capovolgere la propria politica, alleandosi con la Francia contro Rosas (con la partecipazione al blocco anglo-francese del Rio de la Plata, 1845-1850). Il logoramento della relazioni anglo-argentine mise Mandeville in una posizione molto difficile, che raggiunse l'apice nel 1844, alla vigilia del suo congedo: il quotidiano "El Nacional" di Montevideo pubblicò undici sue lettere che contenevano giudizi molto duri sulla politica di Rosas, suscitando l'indignazione generale dell'opinione pubblica argentina; Rosas pensò che il diplomatico inglese non avrebbe più osato presentarsi al suo cospetto. Invece, con sangue freddo, Mandeville si recò alla sua residenza a Palermo. Rosas lo ricevette, ma dopo mezz'ora di conversazioni apparentemente senza importanza, diede libero sfogo in sua presenza a una necessità corporale. Alle proteste indignate dell'inglese, obiettò che era ben nota a tutti l'abitudine di Mandeville di grattarsi ovunque le natiche; lui non lo aveva mai ripreso per questo, perché riteneva che non potesse farne a meno, se gli prudeva. Dopo un simile affronto pubblico, al malcapitato ministro plenipotenziario britannico non restava che lasciare il paese; tornato in Gran Bretagna nel 1845, andò in pensione (aveva già superato i settant'anni), e visse ancora a lungo, forse coltivando la passione per il giardinaggio che l'aveva spinto, durante il mandato decennale, ad inviare in patria numerose piante rare. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Mandevilla o Dipladenia? Riconoscente per i numerosi interessanti invii, nel 1840 John Lindley volle dedicargli la specie più bella tra quelle da lui introdotte, una rampicante dai profumatissimi fiori bianchi, che in Argentina era nota come "gelsomino del Cile"; la battezzò Mandevilla suaveolens, ma poiché era già stata pubblicata nel 1799 da Ruiz e Pavon come Echites laxus, oggi il suo nome accettato è Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson. Nel corso dell'Ottocento altre specie di questo genere della famiglia Apocynaceae arrivarono occasionalmente nelle serre europee, ma nessuna divenne veramente popolare; diverso fu invece la sorte di una altro gruppo di specie affini. Nel 1844 Alphonse de Candolle pubblicò in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis una revisione delle Apocynaceae in cui, tra l'altro, creò il nuovo genere Dipladenia (il nome significa "con due ghiandole", in riferimento alla coppia di ghiandole del nettario), in cui riunì una ventina di specie staccate da Echites. Al contrario delle sorelle Mandevillae, queste rampicanti dai fiori spettacolari incontrarono il favore degli intenditori e nel corso del secolo diverse specie vennero introdotte nelle serre europee. Una delle prime fu D. rosacampestris (oggi Mandevilla illustris), raccolta in Brasile nel 1839 dai francesi Guillemin e Hullet; la stessa specie nel 1847 fu portata a Gand da de Vos, raccoglitore per i vivai Verschaffelt, con il nome D. nobilis. Nel 1841 William Lobb, cacciatore di piante dei vivai Veitch, raccolse nella Serra dos Órgãos in Brasile D. splendens e D. urophylla. A suscitare grande sensazione, quando venne presentata in una mostra floricola a Londra, fu soprattutto la prima, lodata da Hooker per l'esotica bellezza. Più o meno nello stesso periodo a nord di Rio de Janeiro fu scoperta D. sanderi, che però venne importata in Inghilterra solo nel 1896, appunto dal vivaio F. Sander and Co. Si deve a un altro cacciatore dei Veitch, Richard Pierce, l'introduzione di D. boliviensis; raccolta nel suo viaggio in Sud America tra il 1859 e il 1861, fiorì per la prima volta nelle serre dei Veitch nel 1868. Lo stesso anno venne presentato su The Gardener's cronicle un ibrido destinato a segnare la storia del genere, D. x amabilis (anche noto come D. amoena): l'aveva ottenuto nel 1862 Henry Tuke, giardiniere di un certo R. Nicolls a Bramley presso Leeds, incrociando D. splendens con D. crassinoda. Erano piante magnifiche e imponenti, che troviamo spesso illustrate nelle riviste di giardinaggio dell'epoca; ma non erano per tutte le tasche; costose ed esigenti, necessitavano di cure professionali e dell'atmosfera protetta di una serra tropicale. Fu così che nel Novecento furono un po' dimenticate, anche se nel 1930 in Francia si ebbe un apporto particolarmente apprezzabile, D. x amabilis "Alice du Pont", una statuaria bellezza dai fiori rosa chiaro. Vi state chiedendo come mai questa lunga storia di Dipladenia in un post dedicato a Mandevilla? Semplice: nel 1933 R.E. Woodson propose una ridefinizione di Mandevilla, che venne allargato a 107 specie, con la confluenza di otto generi incluso Dipladenia. Nel 1949 Pichon propose una nuova riclassificazione, che includeva in Mandevilla anche il piccolo genere Macrosiphonia, mantenuto indipendente da Woodson. I recenti studi tassonomici basati sul DNA hanno confermato queste conclusioni. Oggi, Mandevilla è il più numeroso genere neotropicale delle Apocynaceae, con oltre 150 specie, mentre per i botanici il genere Dipladenia non esiste più (o meglio è un sinonimo "storico" di Mandevilla). Ma le cose stanno diversamente in campo orticolo. Qui, evidentemente, il nome Dipladenia aveva fatto in tempo a entrare nella memoria e nel cuore di coltivatori e appassionati, cui era ben più familiare di Mandevilla. Ed è dunque con il duplice nome Mandevilla / Dipladenia che le nostre spettacolari rampicanti tropicali nell'ultimo ventennio sono diventate protagoniste di una delle più eclatanti rivoluzioni del mercato floricolo. Si è detto che il primo Novecento le trascurò; a riscoprirle furono nella seconda metà degli anni '50 gli orticultori danesi, che reintrodussero nel mercato "Alice du Pont" e diverse cultivar di Mandevilla sanderi (da questo momento, uso i nomi attuali!). Ma la vera rivoluzione inizia nel 1991: nei vivai della giapponese Suntory vengono seminati i semi di un incrocio tra M. x amabilis 'Rose Giant' (madre) e M. boliviensis (padre). Dei 35 semenzali solo uno sarà selezionato: è nata Sunmandeho, ovvero la capostipite della fortunata serie Sundaville, commercializzata a partire dal 2000 in Europa come 'Sundaville Cosmos White' e in America come 'Sun Parasol Giant White'. Nel 2005 seguirà la più famosa di tutte, la rossa Sunmadecrim, ibrido tra M. atroviolacea e M. sundaville 'Cosmos White'. Sarà commercializzata come Dipladenia sundaville 'Red'. La Suntory decide infatti di usare i due nomi per differenziare la sua produzione: Mandevilla per le rampicanti vigorose con grandi foglie dalla venatura evidente, Dipladenia per le forme più compatte, cespugliose e foglie piccole. Una distinzione inconsistente dal punto di vista botanico, ma che ha fatto scuola, tanto che oggi (almeno da noi) il nome commerciale prevalente sembra proprio essere Dipladenia (del resto, le forme compatte, nei nostri terrazzi e nei nostri piccoli giardini, hanno la preferenza su quelle a grande sviluppo). Sotto l'uno o l'altro nome, oggi sono le rampicanti da fiore più vendute sul mercato, tanto che è facile trovarle in vendita persino sugli scaffali dei supermercati, a prezzi così competitivi che molti le coltivano come annuali, proprio come si fa con le petunie. Le grandi ditte che dominano questo mercato miliardario si sfidano a colpi di novità: accanto al bianco, al rosa e al rosso, arrivano il giallo e l'albicocca; Suntory moltiplica le serie, introducendo le Mini e le Up con fiore stellato; la francese Lannes risponde con le piccole deliziose Diamantina; Syngenta punta sulle fioriture precoci, il portamento ordinato e compatto, la versatilità, la resistenza e la facilità di coltivazione della sua serie Rio (è probabile che se acquistate una "Dipladenia" rossa senza nome in un supermercato, sia una 'Rio Red', la più venduta di tutte). Dopo aver sopportato l'ignobile oltraggio di Rosas, il buon Mandeville saprà farsi una ragione se la "sua" pianta imperversa in ogni dove sotto le mentite spoglie di Dipladenia. Qualche notizia sulle specie più importanti per la creazione degli ibridi nella scheda.
0 Comments
Nella storia della Francia del XVIII secolo, il magistrato Antoine René Gaillard de Charentonneau non si è guadagnato neppure una nota a piè di pagina. Invece, in quella della botanica, complice un amico, il botanico Antoine Denis Fougeroux de Bondaroi, ha legato per sempre il suo nome a una delle beniamine delle aiuole estive, la coloratissima Gaillardia. E se su questo illustre sconosciuto c'è ben poco da dire, qualche parola in più lo meritano loro, oggi forse un po' demodé, ma facili, allegre e generose di fioriture.  Un magistrato con l'hobby della botanica Nel maggio 1786, il botanico, illustratore e divulgatore delle scienze applicate Antoine Denis Fougeroux de Bondaroi presenta all'Accademia delle Scienze parigina un'Asteracea di belle forme e fioritura generosa, capace di fiorire ininterrottamente da metà estate ai primi freddi. I semi sono stati importati dalla Louisiana dal Conte di Essales; Fougeroux, che ne ha ottenuto alcuni da piante coltivate in Francia, l'ha moltiplicata e coltivata per due anni. E' ora di pubblicarla e di darle un nome, visto che, a quanto pare, appartiene a un genere finora ignoto alla scienza. Ecco le sue parole: "La chiameremo Gaillardia (pulchella) [...] dal nome del sig. Gaillard de Charentonneau, che, ai doveri della Magistratura, ha saputo unire come svago la coltivazione delle piante e lo studio della botanica". E' quasi tutto quello che sappiamo su questo personaggio (nella sezione biografie, una sintesi di queste poche notizie). E' probabile che fosse un amico di Fougeroux, nel cui carteggio si trova una sua lettera; presumibilmente faceva parte di quei circoli di studiosi, appassionati e mecenati che ruotavano attorno all'Accademia delle Scienze di Parigi (di cui non risulta membro, nonostante ciò venga affermato da alcune fonti di seconda o terza mano). Nato forse intorno al 1720, si chiamava Antoine René e apparteneva a una famiglia della nobiltà di toga, con estese proprietà in città e nei dintorni di Parigi. Come il padre, che portava il suo stesso nome, era consigliere della Cour des aides, il tribunale d'appello che aveva giurisdizione sulle questioni finanziarie e fiscali; lo troviamo infatti citato in diversi documenti che riguardano l'operato di questo organismo. Nel 1779 dovette ritirarsi a vita privata, visto che un atto attesta la nomina del suo successore, ma era sicuramente ancora vivo nel 1788, anno in cui risulta proprietario del castello di Charentonneau e, in quanto feudatario, vi esercitava il potere giurisdizionale. Sulle sue attività come botanico e coltivatore ci rimane solo la laconica nota di Fougeroux. Molto probabilmente si sarà dedicato a questo "svago" nella sua proprietà di Charentonneau, sulle rive della Marna, dove la sua famiglia possedeva un grazioso castello, ai piedi del quale c'era un giardino e un parco con boschetti. Nel 1793, la proprietà fu confiscata e messa in vendita come bene appartenente a un emigrato (forse il nostro Antoine René, forse un figlio): il castello, passato di mano in mano, sopravvisse fino al 1950, quando fu abbattuto per costruire un gruppo di casermoni da 700 appartamenti. Del parco, che esisteva sicuramente ancora nel 1870, rimangono solo i resti dell'Orangerie, che forse fu fatta costruire dal nostro magistrato per le sue piante rare.  I solari capolini della Gaillardia A questo Carneade, a questo signor nessuno, il caso ha voluto legare un genere ben noto e frequente nei nostri giardini. Gaillardia, della famiglia Asteraceae, comprende 25-30 di specie erbacee annuali, biennali e perenni distribuite tra Nord America, Centro America e Sud America. I capolini, simili a margherite, ma con petali ligulati spesso trilobati, hanno colori caldi e brillanti (giallo, arancione, rosso), talvolta bicolori. Native principalmente di aree desertiche, hanno grande resistenza all'aridità; si adattano a molti tipi di suoli, anche poveri, in posizione soleggiata. Soprattutto, sono generosissime di fioriture, visto che sono in grado di fiorire l'intera estate. Nei nostri giardini se ne coltivano essenzialmente tre specie e le loro cultivar. G. pulchella, come abbiamo già visto, fu la prima ad arrivare in Europa. Originaria degli Stati Uniti centrali e meridionali e del Messico, è una annuale o perenne di breve vita con fiori del disco porpora e fiori ligulati gialli con punte rosse, oppure interamente gialli o rossi. Se ne coltivano alcune serie migliorate, con fiori doppi. La specie più diffusa in coltivazione è però G. aristata; fu raccolta per la prima volta nel 1806 in Montana durante la spedizione di Lewis e Clark; di dimensioni molto maggiori della precedente, è una perenne caratterizzata da fiori sfrangiati con fiori del disco arancione-rossastro e fiori ligulati gialli oppure bicolori, rossi con apici gialli. Nel 1857 in un giardino belga le due specie furono incrociate, producendo G. x grandiflora, che fu poi pubblicata da van Houtte. E' una perenne a breve vita cespugliosa con capolini che possono superare i 10 cm di diametro, con fiori del disco giallo-bruni e fiori del raggio gialli, soffusi di rosso alla base. Ne sono però state selezionate molte cultivar con altre combinazioni di colori. Qualche approfondimento nella scheda. Da qualche anno incontra un crescente successo anche nei nostri giardini Muhlenbergia capillaris, una graminacea a fioritura tardiva, abbastanza insignificante fino a fine stagione, quando esplode in una sorprendente nuvola di aerei fiori rosa. Potrebbe essere un involontario ritratto vegetale del reverendo Henry Muhlenberg, placido pastore luterano e pioniere della botanica americana, che scelse la via del modesto raccoglitore della flora locale (mettendo insieme un catalogo di oltre mille specie, tutte rigorosamente raccolte nel raggio di tre miglia da casa) e propugnò il progetto di una flora nazionale, nata dalla collaborazione e dal confronto tra i botanici. Solo in tarda età, quando vide che a prevalere erano invece l'ambizione e le rivalità personali, si decise a pubblicare un lavoro che considerava poco più di un indice di quella flora cooperativa. Addirittura postuma uscì la sua opera più importante, dedicata alle sue piante preferite: carici e graminacee. E' dunque giusto che a celebrarlo siano le graminacee del genere Muhlenbergia, i cui numerosi rappresentanti negli Stati Uniti sono chiamati affettuosamente muhly. 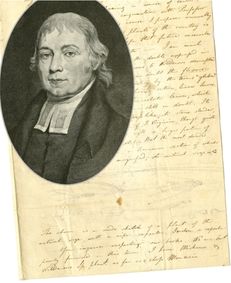 Conflitti tra vocazioni Dopo le turbolente vicende di Frederick Pursh, parlare di Henry Muhlenberg è come contemplare un placido lago dopo aver affrontato le rapide di un torrente. Anche lui vantava un doppio nome ed era di origine tedesca, ma le analogie finiscono qui. Il suo nome ufficiale era Gotthilf Heinrich Ernst, ma preferiva il più colloquiale Henry. Apparteneva a una delle famiglie più influenti della importante comunità tedesca e olandese della Pennsylvania; il padre Henry Melchior (nato Heinrich Melchior Mühlenberg, 1711-87) era il fondatore e il patriarca della Chiesa luterana negli Stati Uniti; i due fratelli maggiori, John Peter Gabriel e Frederick August, furono importanti uomini politici; il primo, generale dell'Armata continentale, era un eroe nazionale, la cui popolarità presso gli "olandesi" di Pennsylvania era seconda solo a quella di Washington. Anche nelle generazioni successive, fino ai nostri giorni, questa famiglia ha continuato ad essere illustrata da uomini di Chiesa e politici, scienziati, architetti e filantropi (se vi incuriosisce, qui trovate l'albero genealogico). Quando aveva solo nove anni, Henry fu mandata a studiare in Germania, a Halle, insieme ai fratelli maggiori, per ricevere un'adeguata istruzione che li avrebbe preparati alla carriera ecclesiastica cui li destinava il padre. Qui rimase dieci anni e studiò lingue antiche, filosofia, teologia; anche se la città vantava un prestigioso orto botanico e una secolare tradizione medica, non sembra che al momento il ragazzo se ne interessasse. Rientrò in patria nel 1770 e fu immediatamente ordinato sacerdote (aveva solo 17 anni), divenendo prima assistente del padre poi pastore a Filadelfia. Nel settembre del 1777 la città fu occupata dalle truppe britanniche; temendo rappresaglie per l'impegno patriottico dei fratelli maggiori, Henry preferì rifugiarsi nella casa paterna a Trappe, dove trascorse un anno di esilio forzato durante il quale incominciò a interessarsi delle piante locali. Uomo prudente e metodico, prese ad annotare le sue osservazioni in un diario di campo (scritto in grafia minutissima in un misto di tedesco colloquiale, inglese e latino, ha messo a dura prova gli studiosi) e a confrontarle con quanto poteva leggere nella letteratura sulla flora americana. Questo studio da autodidatta continuò quando venne nominato pastore a Lancaster, una località a circa 100 km da Filadelfia, dove servì fino alla morte per ben trentacinque anni. Inizialmente il suo interesse andava soprattutto alle piante medicinali, di cui sperimentava le virtù su se stesso, la sua numerosa famiglia (ebbe otto figli) e la comunità. Esplorava le campagne dei dintorni, raccogliendo semi che poi seminava nel giardino di casa, sempre annotando scrupolosamente le sue osservazioni. Si attirò così anche i rimproveri del padre, che avrebbe preferito si occupasse meno delle piante e più dei parrocchiani. La botanica era vista come un hobby, una passione un po' frivola, che non doveva distoglierlo dai compiti pastorali e didattici (nel 1789 divenne il primo presidente del Franklin College). Per almeno un decennio, Muhlenberg continuò ad osservare e analizzare la flora locale, sempre più consapevole del rischio di errori di identificazione vista la carenza di testi di riferimento. Infatti a quel tempo erano disponibili ben poche opere sulla flora delle colonie americane, nessuna delle quali si occupava specificamente della Pennsylvania: Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands di Mark Catesby (1729-31), Flora virginica (1739-1743) di Gronovius, cui nel 1788 aveva fatto seguito Flora Caroliniana (1788) di Thomas Walter. Il pastore-botanico giunse così a compilare un Calendario delle fioriture delle piante locali e una lista di circa 1100 piante spontanee e coltivate che crescevano nel raggio di 3 miglia da Lancaster, presentata nel 1791 alla American Philosophical Society. Molte potevano essere specie nuove, ma per saperlo con certezza era necessario entrare in contatto con gli studiosi europei che, avendo accesso ai grandi erbari, avrebbero potuto aiutarlo a identificare e denominare correttamente i suoi esemplari. Determinante in questa decisione fu l'incontro con Johann David Schoeppf; questi, medico militare delle truppe dell'Assia stanziate presso New York durante la guerra d'indipendenza, dopo la fine del conflitto aveva ottenuto il permesso di rimanere nel paese e nel corso di vari viaggi esplorò la flora da New York alla Florida. Incontrò anche Muhlenberg, che lo accompagnò in alcune escursioni e condivise con lui le sue osservazioni sulle piante medicinali. Tornato in patria, Schoeppf pubblicò Materia medica americana (1787), senza neppure ringraziarlo. Tuttavia lo mise in contatto con il celebre naturalista Johan Christian Schreber, più tardi presidente dell'Accademia Leopoldina (cui anche Muhlenberg fu ammesso poco dopo), il quale a sua volta lo inserì nella rete dei grandi naturalisti europei, con i quali Muhlenberg scambiava piante, semi, esemplari e osservazioni naturalistiche. 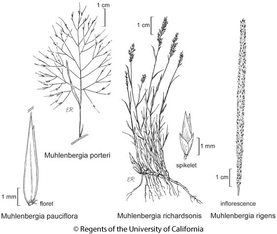 Un progetto di flora cooperativa A suscitare l'interesse dei corrispondenti europei erano soprattutto le nuove specie di briofite, caricacee e graminacee scoperte dal nostro pastore. I suoi invii furono determinanti ad esempio per gli studi sulle felci di Olaf Schwartz. A capire pienamente il valore delle sue ricerche fu però soprattutto Willdenow, il direttore dell'Orto botanico di Berlino, che nel 1801 pubblicò negli annali della Società di scienze naturali una serie di osservazioni di Muhlenberg sui generi Juglans, Fraxinus e Quercus, accompagnati dalle proprie descrizioni e note in latino: in tal modo, queste denominazioni di Muhlenberg, a differenza di quelle della lista del 1791, prive di descrizioni, risultano pienamente valide e sono entrate nella tassonomia botanica. Nel 1803 seguì un altro saggio sui salici. Numerose sono poi le specie segnalate da Muhlenberg pubblicate da Willdenow nella sesta edizione di Species plantarum (1798-1826) , tra cui numerosi carici. La fama e il prestigio di Muhlenberg in Europa è testimoniata anche dalla visita che gli fecero Humboldt e Bompland nel 1804, al ritorno dal loro viaggio in Sud America. Se nella prima parte della sua vita, la rete di corrispondenti di Muhlenberg includeva soprattutto studiosi europei, dopo l'indipendenza divennero sempre più numerosi gli americani, nell'ambito di un grande progetto che egli riuscì solo in parte a realizzare. In un discorso letto nel febbraio 1791 alla American Philosophical Society propugnò una Flora della nuova nazione che avrebbe dovuto nascere non dal lavoro di un singolo, geniale, studioso, ma dalla collaborazione di molti raccoglitori e uomini di scienza: "Ripeto il desidero che ho già espresso: alcuni connazionali istruiti dovrebbero unirsi nelle ricerche botaniche, e spedire alla nostra Società le loro Flore per essere esaminate e eventualmente pubblicate; in tal modo, dall'unione delle Flore di ciascun stato, potremmo avere una Flora degli Stati Uniti, basata su osservazioni valide e certe". Raccolse qualche adesione: tra le più entusiastiche, quelle di un altro pastore, Manasseh Cutler, che contribuì con le sue ricerche in varie aree del New England; William Baldwin, con raccolte in Georgia e Florida; Stephen Elliott, che contribuì per la Virginia occidentale. Ma, in generale, l'intuizione precorritrice di Muhlenberg cadde nel vuoto, mentre si moltiplicavano le flore scritte da botanici stranieri come Michaux, Pursh e Nuttall, in uno spirito di accesa competizione e di ricerca di gloria personale totalmente opposto al sogno "cooperativo" di Muhlenberg. Fu questa situazione, infine, a deciderlo a uscire dal riserbo e a pubblicare egli stesso Catalogus Plantarum Americae Septentrionalis or A catalogue of hitherto known native and naturalizes plants of North America, che include 3780 specie, raccolte grazie al contributo di 28 corrispondenti (scrupolosamente elencati nella prefazione). Nella speranza che mani più forti e abili delle sue, come ebbe a scrivere a Baldwin, completassero il lavoro, si tratta ancora una volta di una lista molto succinta, in cui utilizzò solo in parte il tesoro delle sue annotazioni botaniche, rimaste manoscritte. Unica eccezione, la parte dedicata alle amate graminacee e caricacee, pubblicata postuma dal figlio Frederick August in Descriptio Uberior Graminum et Plantarum Calamariarum Americae Septentrionalis Indiginarum et Cicurum (1817), un'opera di grande importanza storica perché numerose piante native vi vengono descritte per la prima volta. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Le nuvole rosa di Muhlenbergia Dipinto dai suoi contemporanei come un uomo amabile, ospitale, generoso, pieno di humor e calda simpatia (tratti evidenti anche ai nostri occhi grazie alle sue numerosissime lettere), benché abbia pubblicato così poco Muhlenberg fu riconosciuto già dai contemporanei come il vero padre della botanica americana, salutata da Baldwin come "il Linneo del nostro paese". Non mancarono dunque i riconoscimenti: numerosi botanici, tra cui Elliott, Gray, Torrey, Grisebach e Schwarz, gli dedicarono almeno una specie e Schreber, il suo primo corrispondente tedesco, battezzò in suo onore Muhlenbergia un genere di Poaceae (1789), omaggio adattissimo a questo grande esperto di erbe. Questo grande genere di graminacee comprende circa 150 specie di erbe diffuse in Asia e nel continente americano, soprattutto nel Stati Uniti sudoccidentali e in Messico. Molte delle numerose specie nordamericane hanno grande importanza ecologica come specie dominanti di praterie e pascoli montani. Native per lo più di ambienti desertici e semidesertici, sono piante poco esigenti che si adattano a suoli poveri e alla siccità, caratteristiche che, unite al notevole impatto estetico durante la fioritura, le stanno rendendo sempre più popolari nei giardini. Da noi la specie più nota è sicuramente la vistosa M. capillaris, caratterizzata da aeree infiorescenze che a fine estate e a inizio d'autunno la trasformano in una nuvola rosa, purtroppo non del tutto rustica; altre acquisizioni più recenti che stanno raggiungendo anche i nostri giardini sono M. reverchonii, più piccola e meno vistosa della precedente, ma anche più rustica; M. lindheimeri con fogliame verde azzurro e una fontana di spighe verde-argento, decorativa anche in inverno per i semi persistenti; M. dumosa con fusti eretti e finemente ramificati che la fanno assomigliare a un bambù, tanto che in America è detta Bamboo muhly. Muhly è infatti l'affettuoso nomignolo con cui le specie di questo genere sono note negli Stati Uniti. Altre specie sono presentate nella scheda. Comandante dell'Esercito continentale, primo presidente degli Stati Uniti, padre fondatore della nazione. Ma oltre a tutto questo, George Washington fu anche un imprenditore agricolo di successo e il creatore di uno splendido giardino in cui si armonizzano utilità e piacere, rigore e libertà, giardino formale e parco paesaggistico. Mount Vernon, con i suoi sentieri sinuosi fiancheggiati da centinaia di alberi nativi fu anche un giardino programmaticamente "americano" che influenzò il gusto delle generazioni successive. A tanto personaggio, non potevano che essere dedicate piante speciali: le altissime palme americane del genere Washingtonia.  Un imprenditore di successo Tra il 1758, quando lasciò l'esercito dopo aver combattuto nella guerra franco-indiana, e il 1775, quando fu nominato comandante in capo dell'Esercito Continentale, George Washington fu un piantatore di successo, impegnato a estendere le sue proprietà e a renderle sempre più produttive. Mentre la maggior parte dei suoi vicini coltivava soprattutto tabacco, egli capì che, da una parte, questo impoveriva il suolo; dall'altra, come prodotto destinato essenzialmente all'esportazione in Europa, lo rendeva economicamente dipendente dal mercato inglese. Decise così di differenziare le colture, puntando su prodotti destinati al mercato interno: grano, mais, altri cereali, fibre tessili come canapa, lino, cotone. Oltre ad almeno una sessantina di colture, sperimentò fertilizzanti, sementi, tecniche di rotazione, attrezzature innovative, affiancando alla produzione agricola altre attività come l'allevamento di pecore, una piccola flotta di pescherecci, un mulino e una distilleria di whisky. Da cadetto di una famiglia di piantatori di modeste fortune, si trasformò così in un facoltoso proprietario terriero. Per un uomo della sua classe sociale, una bella casa, dove ricevere signorilmente, circondata da un parco ameno era anche uno status symbol, e Washington adeguò alla sua nuova posizione sociale la tenuta di Mount Vernon, ereditata dal fratello maggiore. La casa, posta in un punto panoramico con un'eccezionale vista sul fiume Potomac, fu totalmente ricostruita in stile palladiano. Quanto al giardino, probabilmente all'inizio l'interesse del proprietario andava soprattutto alla sua dimensione utilitaria. Fin dagli anni '60 venne creato un vasto orto, circondato da un muro per proteggerlo dai cervi e da altri animali selvatici; Washington fece anche piantare centinaia di alberi da frutto, in particolare peri, meli, ciliegi e peschi. La frutta era molto richiesta, oltre che per il consumo immediato, per la preparazione di conserve e la fabbricazione del sidro. L'idea di ridisegnare il parco secondo i canoni del giardino paesaggistico nacque probabilmente più tardi, a ridosso degli eventi della Guerra d'indipendenza che avrebbero tenuto Washington lontano dalla sua casa per otto anni, dal 1775 al 1783. Tuttavia l'amato Mount Vernon continuava ad essere al centro dei suoi pensieri, tanto che in una lettera del 1776 istruisce il cugino Lund Washington sulle specie da piantare nelle bordure di arbusti lungo i sentieri che portano alla casa: rododendri, meli selvatici, Kalmia latifolia. Secondo Andrea Wulf, che ha dedicato a Washington e ai giardini di Mount Vernon uno dei capitoli del suo Founding Gardeners, questa lettera - sorprendente per il momento in cui fu scritta, la vigilia della battaglia di Long Island, in cui i britannici sconfissero le truppe indipendentiste, prendendo il controllo di New York - va intesa come un manifesto della volontà del generale di fare del suo giardino un manifesto patriottico, dove crescessero solo piante native, mettendo al bando le specie europee, ancora tanto ricercate dai ricchi proprietari di giardini. Ritornato a Mount Vernon alla fine del 1783, al termine della guerra, nei sei anni che intercorsero fino alla sua elezione a presidente degli Stati Uniti, Washington si dedicò a realizzare questo programma e ridisegnò completamente il parco, dove volle che fossero in certo senso rappresentati gli interi Stati Uniti, affiancando alle specie locali, tra gli altri, alberi e arbusti da fiore portati dalla Carolina o conifere giunte dagli Stati del Nord. Il progetto, completato poi durante i due mandati presidenziali (1789-1797) e negli ultimi anni, quando Washington tornò a vivere stabilmente a Mont Vernon (proprio qui morì nel 1799), diede al parco la fisionomia che ancora oggi possiamo apprezzare, grazie alla paziente opera di ricerca, conservazione e restauro promossa dalla benemerita Mount Vernon Ladies' Association, anche se quanto vediamo è solo il nucleo centrale (circa 500 acri degli 8000 su cui si estendeva la tenuta alla morte di Washington). Un sintetico profilo della sua vita nella sezione biografie.  Mount Vernon: un parco paesaggistico e quattro ordinati giardini L'originalità del progetto di Mount Vernon, che non fu creato da un architetto alla moda ma dallo stesso Washington, nasce dalla capacità di integrare in un disegno unitario elementi a prima vista eterogenei: il piacere e la bellezza con l'utile, il rigore con la libertà, il giardino formale con il parco paesaggistico, caratterizzato da vasti prati dalle linee ondulate, viali e quinte di alberi, boschetti di alberi e arbusti , sentieri a serpentina. Il generale seppe inoltre sfruttare al meglio la posizione eccezionale della casa, posta sulla sommità di un dolce pendio che domina il fiume Potomac. La casa stessa, con le sue ali a mezza luna che abbracciano il cortile d'onore, il Mansion Circle, a forma di ellisse, costituisce il punto focale e unificante del disegno. Ma non vi si giunge attraverso il classico viale rettilineo; per raggiungerlo il visitatore deve percorrere uno dei due viali a serpentina immersi tra gli alberi. Washington fece infatti livellare l'area a ovest, di fronte alla casa, creando un vasto prato (detto Bowling green) dalle forme ondulate che ricordano la cassa armonica di una chitarra. Sui bordi fece disegnare due viali che ne seguono tutte le sinuosità, fiancheggiati a loro volta da centinaia di alberi, trapiantati dalle foreste circostanti. Molti di essi, oltre ad essere squisitamente "americani", uniscono alle belle fioriture primaverili spettacolari colori autunnali: meli selvatici, sassofrassi (Sassafras albidum), aceri, tupelo (Nyssa sylvatica). Gli alberi, fin dagli anni giovanili in cui aveva fatto l'agrimensore, erano la vera passione di Washington che ne piantò a profusione anche in altri spazi. A nord della casa venne creato un bosco di Robinia pseudoacacia; la radura verso sud venne riempita con sempreverdi, Cornus florida e alberi di Giuda (Cercis canadensis). A est, a creare una cornice alla veduta sul Potomac, la collina venne piantumata con una grande varietà di piante locali. Ma veniamo ai quattro giardini, partendo dal basso. Sul fianco destro del pendio che culmina con il Bowling Green, troviamo un vasto frutteto (Fruit Garden, lettera d nella mappa); questo terreno originariamente era una vigna sperimentale, piantata con ceppi di origine europea, che vennero distrutti dalla filossera. Nel 1785 Washington vi fece trapiantare gli alberi da frutto rimossi dall'Upper Garden e circa 200 meli ricevuti da un certo Major Jennifer. Protetta da un'alberata (soprattutto robinie), l'area è costituita da sei grandi rettangoli regolari, quattro coltivati a frutteto e due a orto, con verdure, piccoli frutti, erbe aromatiche, e include anche un vivaio. Immediatamente sopra il frutteto, da cui è separato da un viale e da un prato, si trova il giardino inferiore (Lower garden, lettera b), racchiuso da un muro di mattoni; è un vasto orto formale suddiviso in ordinatissime parcelle dove veniva coltivata una grande varietà di verdure e erbe aromatiche. Lungo i muri ci sono peri e meli coltivati a spalliera. Al livello più alto, al di là del prato, troviamo il giardino superiore (Upper Garden, lettera a). Simmetrico al Lower Garden, di cui riprende la forma e le dimensioni, inizialmente era un frutteto; nel 1785 Washington lo fece liberare dagli alberi per trasformarlo in un giardino di piacere. Anch'esso circondato da un muro su cui si appoggiano alberi da frutto a spalliera sui lati al sole e alberi ornamentali sui lati in ombra, ha un disegno formale che ricorda quello della finestra di una cattedrale, con sei aiuole, quattro rettangolari e due curvilinee, circondate da bordure di bosso nano. Le tre aiuole sulla sinistra (due rettangolari e una curvilinea) sono di dimensioni maggiori e combinano la funzione utilitaria dell'orto con quella estetica del giardino; il centro è occupato da file ordinate di verdure e erbe, lungo i bordi fiori e arbusti ornamentali formano una colorata cornice; anche in questo caso si tratta per lo più di specie native. Le due aiuole rettangolari sulla destra, più piccole, e separate tra loro dal piccolo cortile antistante la serra, ospitano un parterre di bosso che riproduce il "fleur de lys", ovvero il simbolo della Francia, preziosa alleata durante la guerra d'Indipendenza. L'ultima aiuola curvilinea sulla destra ospita invece piante da frutto. Bordure fiorite si trovano anche lungo i muri esposti al sole, ai piedi degli alberi a spalliera. Il punto focale di questo giardino è una serra molto innovativa per l'epoca dove venivano riparati aranci, limoni, limette e piante tropicali. Tra di esse una Cycas revoluta giunta in dono dalle Antille, ancora oggi viva e in ottima forma. Infine, l'orto botanico (Botanical garden, lettera c), una piccola area rettangolare incuneata tra il viale superiore e l'Upper garden, seminascosta da diversi edifici utilitari. Washington, che lo amava molto, lo chiamava "my Little garden" o "my Botanick garden". Era lo spazio destinato alla sperimentazione di nuovi semi, bulbi e talee che giungevano sempre più numerosi da amici, ammiratori, ma anche governi stranieri. Tra di essi quello francese, che, tramite André Michaux, fornì un cipresso a piramide e altri sempreverdi. Qui Washington "giardinava" di persona annotando scrupolosamente nei suoi diari successi e fallimenti. Liberalmente aperto ai visitatori già quando il presidente vi viveva (nel 1794 scrisse: "Non obbietto al fatto che ogni persona sobria o in ordine gratifichi la sua curiosità vedendo le strutture, i giardini, ecc. di Mount Vernon.") il giardino "americano" di Washington divenne anche un prestigioso modello che non mancò di influenzare la progettazione dei giardini della nuova nazione. A chi desidera saperne di più, consiglio vivamente una visita all'ottimo sito George Washington's Mount Vernon, una vera miniera di informazioni e curiosità.  Una palma americana per il generale Washington Ovviamente, non fu per i suoi meriti di appassionato e di creatore di giardini che Washington fu onorato con un nome botanico, ma in quanto padre della patria. Anche se la prima denominazione che lo celebra non è valida, ha una storia così curiosa che vale la pena raccontarla. Nel 1853 il botanico inglese John Lindley dedicò uno studio alla sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum) che proprio in quegli anni incominciava ad essere conosciuta in Europa; colpito dalla maestosità di questi alberi, i più alti del pianeta, nell'attribuirli a un nuovo genere li battezzò Wellingtonia gigantea, perché secondo lui il generale Wellington (il vincitore di Waterloo) superava ogni uomo proprio come la sequoia supera tutti gli altri alberi. Questa denominazione (illegittima secondo le leggi della botanica, perché il nome Wellingtonia era già stato usato per un'altra pianta) non mancò di suscitare indignazione dall'altra parte dell'oceano: come poteva un generale britannico dare il suo nome alla più maestosa pianta d'America? Infatti, l'anno dopo un certo Andreas Peter Winslow in articolo pubblicato su un settimanale locale, California Farmer, in cui raccontava il suo viaggio a Calaveras Grove, protestò contro questa denominazione poco patriottica, sostenendo che l'unico degno di dare il suo nome al gigante tra le piante americane fosse Washington. Aggiunse che, se la pianta fosse risultata appartenente al genere Taxodium doveva chiamarsi Taxodium washingtonium, se appartenente a un genere nuovoWashingtonia californica. Winslow non era un botanico e la sua denominazione, irregolare per diversi motivi, non è valida, ma rimane comunque molto interessante sul piano storico. La denominazione valida giunse nel 1873 da parte non di un patriota statunitense ma di un botanico tedesco, H. Wendland, che separò dal genere Pritchardia P. filifera, rinominandola Washingtonia filifera "in onore di un grande americano". Una terza Washingtonia era stata creata da Rafinesque, ma, pubblicata da Coulter e Rose solo nel 1900, non può essere presa in considerazione per la regola della priorità. La dedica di Wendland è invece un omaggio indubbiamente adeguato; il genere Washingtonia, della famiglia Arecaceae, comprende due specie di palme native degli Stati Uniti sud-occidentali e del Messico settentrionale, note per la loro altezza, maestosità e bellezza: W. filifera, nota anche come palma della California, e W. robusta, nota come palma del Messico. Sono molto simili tra loro, ma W. robusta ha tronco più sottile, cresce più alta e più rapidamente; a distinguerle poi è il colore della base del picciolo, rosso-porpora in W. robusta e verde in W. filifera. Alte fino a 30 metri, con grandi foglie a ventaglio che formano una densa chioma tondeggiante, sono tra le palme più note e apprezzate, molto coltivate anche da noi in parchi e alberate; la specie californiana è anche relativamente rustica. Qualche informazione in più nella scheda. La rarissima, strabiliante, Rafflesia arnoldii vanta il fiore più grande al mondo (oltre un metro di diametro). Non meno curiosa e interessante è la sua scoperta da parte della scienza occidentale (ovviamente, era nota da secoli alla popolazione locale, e usata nella medicina tradizionale) che coinvolse i due personaggi per sempre uniti nel suo nome: il botanico Joseph Arnold e il suo mecenate, Thomas Stamford Raffles, futuro fondatore di Singapore.  Antefatti: un botanico sfortunato e un funzionario ambizioso Ufficialmente, la scoperta di quella che sarà battezzata Raffelsia arnoldii avvenne il 19 maggio 1818 a Sumatra. Tuttavia per trovare il primo botanico occidentale che vide una Rafflesia dobbiamo tornare indietro di oltre vent'anni e spostarci nell'isola di Giava, dove il botanico francese Louis Auguste Deschamps, superstite della spedizione Entrecasteaux, su richiesta del governatore olandese aveva condotto estese ricerche scientifiche nell'interno dell'isola. Probabilmente nell'agosto 1797, nell'isola di Nusa Kambangan, di fronte alla costa meridionale di Giava, si imbatté in una pianta ignota alla scienza occidentale, nota agli indigeni come Bunga patma (quasi certamente una Rafflesia, anche se è in discussione di quale specie). La descrisse e la disegnò. Nel 1802, quando Napoleone concesse l'amnistia agli emigrati che non avessero impugnato le armi contro la Repubblica, Deschamps rientrò in patria; ma nel corso del viaggio di ritorno la nave su cui viaggiava fu fermata dagli inglesi, che sequestrarono esemplari, appunti e disegni. Nonostante la scoperta non sia mai stata pubblicata (le carte dello sfortunato botanico, tuttora inedite, si trovano al British Museum), era nota ai botanici che operavano in quell'area e sembra circolassero persino copie del suo disegno. Negli anni successivi, le guerre napoleoniche coinvolsero anche le colonie del sudest asiatico. Per sottrarla al controllo francese, nel 1811 i britannici occuparono Giava e la amministrarono fino alla pace del 1814, quando fu restituita all'Olanda. A governarla fu chiamato un giovane e brillante funzionario della Compagnia delle Indie orientali, Thomas Stamford Raffles. Durante il suo breve mandato, oltre che per le riforme amministrative, egli si segnalò per l'interesse per la storia, la cultura (iniziò il restauro del tempio di Borobudur) e la natura giavanese. Per procurarsi animali e esemplari botanici, organizzò una squadra di raccoglitori indigeni, sotto la guida di un medico e naturalista americano, Thomas Horsfield; creò una specie di zoo, un rudimento di orto botanico e una collezione di oggetti naturali e etnografici. Fu il vero e proprio inizio delle ricerche naturalistiche a Giava, che avrebbe ispirato iniziative come la creazione dell'orto botanico di Bogor, fondato dagli olandesi nel 1817. A far conoscere la natura di Giava contribuì anche l'importante History of Java (pubblicato da Raffles nel 1817), che comprende capitoli sulla flora e la fauna. Quest'opera introdusse Raffles nell'establishment scientifico britannico, guadagnandogli l'ammissione alla Royal Society e l'amicizia di personalità come Joseph Banks. Il re lo nominò baronetto. Apprezzato a Londra, ma molto meno dai vertici della Compagnia, con una vera e propria retrocessione nel 1817 Raffles tornò in Asia come governatore generale di Bencoolen, una base commerciale di scarsa importanza sulla costa occidentale di Sumatra. Anche qui, come a Giava, si segnalò per l'energia delle sue riforme, le capacità diplomatiche e l'interesse per il mondo naturale. Adesso al suo servizio c'era un altro giovane naturalista, il medico inglese Joseph Arnold. 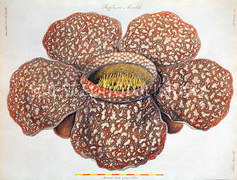 Una scoperta sensazionale Ed eccoci ritornati a quel maggio 1818 in cui fu scoperta Rafflesia arnoldii, nel corso di una breve spedizione a metà tra missione diplomatica e esplorazione scientifica. Temendo le incursioni delle popolazioni locali nei territori della Compagnia situati lungo la costa meridionale di Sumatra, Raffles decise di muovere verso sud per cercare un accordo. La spedizione, oltre a Raffles e al dottor Arnold, comprendeva la moglie di Raffles, l'intrepida lady Sophia, alcuni soldati e una sessantina di portatori. Partito da Bencoolen intorno al 15 maggio, viaggiando a cavallo dopo due giorni il gruppo raggiunse Manna, dove gli si unirono ufficiali locali, il Pangeran (un alto nobile locale) e il residente della compagnia, Edward Presgrave. Il 19 maggio, nei pressi del villaggio di Pulau Lebar, uno dei servitori malesi richiamò l'attenzione del dottor Arnold, che si era separato dal gruppo per esplorare la foresta: "Signore, venga, venga con me. Un fiore molto grande, bellissimo, meraviglioso!". Arnold non se lo fece dire due volte: ed eccolo di fronte a un oggetto mai visto: una corolla enorme, con un diametro di più di un metro e spessi petali carnosi rossastri, macchiettati di bianco. Il peso era di quasi sette chili e la coppa interna conteneva non meno di sei litri d'acqua. Il tutto emanava esattamente l'odore della carcassa di un bufalo in avanzato stato di decomposizione. Poco dopo allo stupefatto botanico si unirono Raffles, Sophia e Presgrave. Arnold disegnò e raccolse l'esemplare (un fiore maschile che si decompose rapidamente; fu possibile conservare solo una piccola parte dell'apparato riproduttivo) e alcuni boccioli ancora chiusi. Pochi mesi dopo, Arnold morì di una febbre contratta in questa o in una successiva spedizione nell'interno, senza aver potuto completare né la descrizione né il disegno (a completarlo fu Sophia Raffles). Le note di Arnold, il disegno, i boccioli e ciò che si era potuto preservare del fiore furono spediti a Banks, a Londra, che li affidò per il riconoscimento e la descrizione a Robert Brown. A Sumatra, il successore di Arnold come botanico della Compagnia delle Indie, William Jack, continuò le ricerche, raccogliendo anche un esemplare femminile (anche i boccioli raccolti da Arnold risultarono maschili). Nel 1820, scrisse un articolo in cui descrisse diverse specie tropicali ignote alla scienza, tra cui quella che denominò Rafflesia titan. Lo inviò alla madre, con la richiesta di farlo pubblicare se in Inghilterra Rafflesia era ancora inedita; altrimenti di sopprimerlo. Questa strana richiesta si spiega con il desiderio di assicurare la priorità alla scienza britannica: temeva infatti che Deschamps (la cui scoperta era ben nota ai botanici che operavano tra Sumatra e Giava), nonostante la perdita dei materiali, potesse pubblicarla per primo. Pubblicato solo nel 1822 in Malayan Miscellanies, il nome è oggi considerato illegittimo perché preceduto dalla denominazione di Brown. Basandosi sul disegno e i materiali di Arnold, quest'ultimo aveva infatti comunicato la scoperta del gigantesco fiore di Sumatra nella riunione della Linnean Society del 30 giugno 1820; nella seduta del 21 novembre, aggiunse altre informazioni ricevute da Raffles e Jack. La pubblicazione ufficiale avvenne l'anno successivo in Transaction of Linnean Society. Inizialmente Brown aveva pensato di denominare il fiore gigante Arnoldia grandiflora, ma poi, seguendo le abitudini dell'epoca (era usuale privilegiare lo sponsor più che il botanico) decise di riunire il nome di due scopritori in Rafflesia arnoldii, scrivendo che lo stesso dottor Arnold avrebbe voluto così (è probabile, come dimostra l'analoga scelta di Jack). Illustrata da un magnifico disegno di Bauer, la pubblicazione destò scalpore: quel fiore mostruoso corrispondeva perfettamente a ciò che l'immaginario collettivo dell'epoca associava all'Oriente: il mistero, l'eccesso, l'esuberanza di una natura che affascinava e allo stesso tempo respingeva. Come scrive T.P. Barnard in The East India Company and the Natural World, da una parte divenne il simbolo dell'alterità delle regioni tropicali, dall'altra una giustificazione delle spedizioni per conoscerle e prenderne possesso. Quasi immediatamente (1825) ne vennero ordinati tre modelli in cera a grandezza naturale, uno per lo stesso Raffles, uno per la Linnean Society, l'altro per la Royal Horticultural Society. Quest'ultimo è l'unico sopravvissuto e può essere tuttora ammirato ai Kew Gradens.  Epilogo: distruzione e creazione di un eroe Come nei romanzi ottocenteschi, prima di salutare i tanti personaggi comparsi in questa storia, due parole sulle vicende successive. Lasciamo da parte Deschamps, Horsfield e Jack che, come dedicatari rispettivamente di Deschampsia, Horsfieldia e Jackiopsis, saranno protagonisti di post tutti per loro. Arnold, l'ho già anticipato, morì pochi mesi dopo la sensazionale scoperta. Dopo la sua morte, gli vennero dedicati ben due generi, ma nessuno dei due è tuttora valido: nel 1824 il botanico francese Henri Cassini gli dedicò Arnoldia (famiglia Asteraceae), oggi sinonimo di Dimorphoteca; nel 1826 una seconda Arnoldia (famiglia Cunoniaceae) gli fu dedicata dal tedesco Blume, denominazione non valida per la priorità di quella di Cassini. Quanto a Raffles, doveva ancora conquistare il suo maggior titolo di gloria: la fondazione di Singapore, di cui comprese l'enorme valenza strategica, suggerendone la creazione alla Compagnia nel 1818 e gettandone le basi l'anno successivo. Lasciando da parte le vicende politiche (qualche cenno si troverà nella biografia), negli anni che avrebbe ancora trascorso nel Sudest asiatico continuò a promuovere l'esplorazione naturalistica di Sumatra avvalendosi della collaborazione di Jack (anch'egli morto di febbri nel 1822) per mettere insieme una collezione di oltre 2000 pezzi, che comprendeva anche disegni commissionati a pittori locali. Nei brevi periodi trascorsi a Singapore (funestati dall'ostilità crescente dei vertici della Compagnia e dalla rivalità con il Residente William Farquahr) promosse istituzioni scientifiche, fondando tra l'altro una scuola dove si potesse studiare sia l'inglese sia le lingue locali, nell'obiettivo di formare i figli tanto degli impiegati della Compagnia quanto dei leader malesi e cinesi. Ospitò Nathaniel Wallich, venuto qui in convalescenza, e insieme crearono un orto botanico e un giardino sperimentale, dedicato soprattutto alle piante di interesse commerciale. Probabilmente Raffles progettava di scrivere un'opera su Sumatra analoga a quella su Giava. Tuttavia tutte le sue carte, le collezioni naturalistiche, i disegni di piante e animali, andarono perduti nell'incendio della nave "Fame" su cui si era imbarcato con la famiglia nel gennaio del 1823 per tornare in patria. Nelle otto settimane seguenti, in attesa di un nuovo imbarco, commissionò ad artisti locali una serie di disegni (44 uccelli, 7 mammiferi e 27 piante), oggi conservati nella British Library. Rientrato in patria in pessime condizioni di salute, in totale rottura con la Compagnia delle Indie, si concentrò sugli interessi naturalistici. Nel 1825 fu tra i fondatori della Società zoologica di Londra (di cui fu il primo presidente) e promosse la creazione dello Zoo di Londra. Morì nel 1826, il giorno prima del suo quarantacinquesimo compleanno. In odio alle sue posizioni antischiaviste, il vicario della sua parrocchia (la cui famiglia si era arricchita con il commercio di schivi) gli rifiutò la sepoltura; la compagnia negò ogni pensione alla vedova e requisì le sue proprietà in risarcimento delle perdite subite durante la sua amministrazione. A riabilitarne la memoria si dedicarono prima la moglie, che gli sopravvisse per un trentennio, poi gli esegeti del colonialismo vittoriano, che ne fecero un eroe.  Piante rare a rischio d'estinzione Il genere Rafflesia comprende circa 28 specie di piante parassite endemiche delle foreste pluviali del Sudest asiatico (Thailandia, Indonesia, Malaysia, Filippine). Sono endoparassiti, che vivono totalmente all'interno dei tessuti della pianta ospite (diverse specie di Tetrastigma, una liana della famiglia Vitaceae); il corpo della pianta è costituito da filamenti presenti nelle radici dell'ospite; è priva di foglie, fusti, radici; l'unica manifestazione esterna sono i fiori. I boccioli tondeggianti, simili a un cavolo, emergono dalla corteccia dell'ospite e dopo circa 9 mesi si apre un fiore massiccio, con cinque petali e una profonda coppa centrale, che contiene numerosi organi appuntiti, la cui funzione è sconosciuta, e molti litri di nettare. In quasi tutte le specie, i fiori maschili (dotati di stami) e quelli femminili (dotati di pistillo) sono portati da piante diverse, spesso molto distanti tra loro; inoltre, quelli femminili sono particolarmente rari. L'impollinazione viene effettuata da insetti sarcofagi, attratti dall'intenso odore di carne putrefatta. Il fiore appassisce dopo pochissimi giorni (da 5 a 7); questo, insieme alla distanza tra gli esemplari femminili e maschili e ai lunghi tempi di sviluppo del bocciolo, che rendono rara la fioritura contemporanea in aree sufficientemente prossime di esemplari dei due sessi, rende piuttosto difficile l'impollinazione. Se invece le cose vanno lisce, alla fioritura seguirà un frutto tondeggiante, di circa 15 cm di diametro, che contiene migliaia di piccoli semi. La dispersione di questi ultimi avviene grazie a piccoli roditori che si cibano dei frutti. Tutte queste caratteristiche hanno due conseguenze: le Rafflesiae sono poco conosciute e rischiano di estinguersi. Per studiarne i tessuti, bisogna necessariamente uccidere sia la pianta sia l'ospite. Inoltre, mancando (fiore a parte) tutti gli altri organi tipici delle piante superiori, la classificazione di questo genere (e dei generi affini Rhizanthes e Sapria, che insieme formano la famiglia delle Rafflesiaceae) è un vero rebus, che è stato risolto solo di recente grazie allo studio del DNA, dimostrando con prove convincenti che la famiglia più vicina è costituita dalle Euphorbiaceae (il che desta stupore, pensando che a questa famiglia appartengono piante con fiori molto piccoli). Le particolarissime esigenze e le specificità della riproduzione delle Rafflesiae, unite alla costante diminuzione del loro habitat, ne mettono inoltre a rischio la sopravvivenza; nessun orto botanico, compreso quello di Singapore, è finora riuscito a coltivare con successo R. arnoldii; R. patma è invece coltivata nell'orto botanico di Bangor, a Giava, dove sono stati sperimentati con successo metodi di riproduzione agamica (mentre è fallita la riproduzione per semi). L'unica strada per conservare questa meraviglia della natura è dunque preservarne l'ambiente naturale, una sfida senza dubbio difficile. A Sabah, nel Borneo settentrionale, sono stati creati giardini di conservazione (la specie presente qui è R. keiti) e si incoraggiano i proprietari dei terreni dove ne è stata segnalata la presenza a mantenerli intatti, a proteggere i boccioli nei lunghi mesi che precederanno la fioritura, a segnalare l'apertura dei fiori e ad accogliere i turisti, in cambio di un contributo statale; in altri paesi sono in atto iniziative analoghe di turismo ecosostenibile. Con la sua rarità e il suo fascino esotico, Rafflesia è infatti anche un'attrazione turistica, che alimenta un'industria i cui proventi si spera possano contribuire a salvarla. Qualche approfondimento nella scheda. E' brevissima la vita di Robert James Petre, ottavo barone Petre. Ma lascia un'impronta indelebile nella storia dei giardini inglesi, anche se del mirabile giardino che creò a Thorndon non rimane neanche un'immagine; a evocare l'armonia che egli seppe creare disegnando il paesaggio con "matite vive" restano alcune lettere dell'amico Peter Collinson. A ricordare Petre, complice Linneo, provvede inoltre il genere Petrea, che comprende alcuni dei più spettacolari rampicanti tropicali.  Un prototipo di giardino paesaggistico Nel 1742, quando lord Petre morì all'improvviso, vittima di un'epidemia di vaiolo (che portò alla tomba con lui una trentina tra famigliari e servitori), non aveva ancora compiuto 29 anni. Da pochi mesi gli era nato l'erede maschio e le attività nel parco di Thornton Hall erano al culmine. Nei due anni precedenti, vi aveva fatto piantare più di 60.000 piante (tra cui 10.000 tra arbusti e alberi americani) di 50 specie e altre decine di migliaia erano in attesa negli enormi vivai. Erano ormai dieci anni, da quando era diventato maggiorenne, che Petre aveva preso a rimodellare la tenuta di Thorndon Hall; per il palazzo, ridisegnato secondo lo stile palladiano allora in voga, aveva assunto l'architetto italiano Leoni; per il parco, si era rivolto all'artista francese H.F. Bourguignon (più tardi sarebbe diventato celebre con lo pseudonimo Gravelot). Il vero creatore del parco, in realtà, fu lo stesso Petre, che univa a un gusto sicuro una perfetta conoscenza delle esigenze delle piante. Era appassionato di botanica fin da ragazzo: si racconta che quando aveva 14 anni come regalo di Natale avesse ricevuto, graditissimo, uno speciale coltello da innesto. Poco più che adolescente, era stato ammesso alla Royal Society. Suo mentore fu Peter Collinson, più anziano di una ventina di anni, che lo coinvolse nell'introduzione in Inghilterra delle piante americane. Dapprima divise con lui i semi che gli giungevano dai suoi corrispondenti, poi, quando iniziò a finanziare le spedizioni di Bartram e creò il sistema delle sottoscrizioni, fece di Petre il primo e il più munifico dei suoi clienti. Al giardino di Collinson a Mill-Hill Petre guardò per ridisegnare Thornton, ma disponendo di spazi ben maggiori (il parco era di 1000 acri, circa 400 ettari) e di ingenti capitali, poteva fare le cose in grande. Come altri gentiluomini appassionati del suo tempo, era in primo luogo un collezionista di piante esotiche e rare. Per accoglierle, fece edificare alcune serre, dette stufe, considerate le più moderne d'Europa. La Grande stufa, la più grande dell'epoca, era alta 9 m e conteneva alberi e arbusti alti fino a 7 m. Le pareti erano colme di rampicanti, tra cui passiflore, molte Clematis e Cereus ricadenti. Una serra lunga 18 metri era riservata alla coltivazione delle banane e degli ananas, allora così rari che non venivano mangiati ma mostrati agli ospiti durante le feste. C'era poi una serra temperata. In una di quelle serre fiorirono per la prima volta in Inghilterra le camelie (ma Petre non morì per il dolore della perdita di quelle rare piante, come vuole una persistente leggenda metropolitana). I semi procurati da Collinson e da altri fornitori venivano seminati nei vastissimi vivai, i più grandi non commerciali, presieduti dal capo giardiniere James Gordon. Mano a mano che le piante crescevano, venivano trapiantate nel parco, secondo un progetto nuovo e originale, che fece di Thorndon il prototipo del giardino naturale. La mescolanza di piante europee, asiatiche e americane consentì infatti a Petre di ridisegnare il paesaggio, secondo le parole di Collinson, usando "matite vive". L'effetto era ottenuto accostando sapientemente le piante per la forma e le sfumature di colore delle chiome, la tessitura delle foglie, il colore e la struttura delle cortecce. L'arrivo di alberi e arbusti americani consentì di trasformare l'autunno in una stagione dai colori squillanti, grazie al rosso delle querce e dei frassini americani, allo scarlatto dei tupelo (Nyssa sylvatica), all'arancio degli aceri e al melanzana dei liquidambar. Molto apprezzati erano anche i sempreverdi: come fa notare A. Wulf in La confraternita dei giardinieri, la flora inglese comprende solo quattro sempreverdi autoctoni (il pino silvestre, l'agrifoglio, il bosso, il tasso); grazie alle introduzioni americane, a Thorndon se ne coltivavano almeno trenta, tra cui una decina di pini (il più amato da Petre era lo strobo, per i suoi lunghi aghi piumosi) e Juniperus virginiana, apprezzato per la forma colonnare e il colore glauco della chioma. Ricercatissimi erano poi gli alberi da fiore (così rari nella flora europea); il più desiderato e costoso era senza dubbio Liriodendron tulipifera di cui Petre fece impiantare ben novecento esemplari. Il parco, a differenza dei giardini formali barocchi, non era più pensato per essere visto dall'alto, dalle finestre del palazzo, ma per essere goduto percorrendone i sentieri sinuosi. Le piante, che dovevano "apparire distribuite a caso come in un bosco naturale" erano in realtà piantate con cura, non solo tenendo conto delle forme e dei colori, ma anche in ranghi disposti per altezza: davanti i fiori, poi gli arbusti (scelti per le fioriture, ma anche la struttura delle foglie e le bacche autunnali), quindi gli alberi sempre più maestosi. Questi criteri furono applicati da Petre anche al cosiddetto Amphiteatre di Worksop Manor, che creò nel 1738 per un altro nobile appassionato, il duca di Norfolk; era un emiciclo, racchiuso da una bassa siepe di tasso, piantato con cinque ranghi di sempreverdi, posti in ordine d'altezza, con colori e strutture contrastanti: bosso, viburno tino, corbezzolo formavano il primo rango, seguiti da agrifogli, quindi da conifere, il tutto coronato da un Cedrus. Petre non era solo un "pratico". Aveva una profonda conoscenza della botanica e la sua biblioteca era notevolissima (desideroso di tenersi al corrente di tutte le novità, acquistò anche diverse copie di Systema Naturae). Era in corrispondenza e in contatto con i più importanti botanici del tempo. Creò un notevolissimo erbario (avvalendosi della consulenza di Gronovius). La sua morte precoce sembrò disperdere quegli esperimenti e quel patrimonio di competenze. La giovane vedova non intendeva sobbarcarsi la continuazione dei lavori; per recuperare almeno in parte i capitali investiti, decise di mettere in vendita gli esemplari coltivati nei vivai (secondo varie testimonianze dell'epoca, si trattava di quasi 220.000 esemplari di circa 700 specie). I nobili amici di Petre fecero a gara per portarseli via a prezzi di liquidazione, le "americane" invasero i parchi della nobiltà inglese, e, grazie alla moda lanciata dallo sfortunato barone, l'impresa di Collinson (disperato per la perdita del giovane amico) sopravvisse e trovò nuovi clienti. Non sopravvisse invece Thorndon: pochi anni dopo la morte del suo creatore le serre erano ormai vuote, il parco trascurato. Divenuto maggiorenne, il figlio, il nono barone Petre, a sua volta appassionato di giardini, ma evidentemente insensibile all'eredità paterna, fece ridisegnare il parco da Capability Brown, cancellando quanto ne rimaneva. Il caso ha voluto che non ne rimangano neppure immagini, ad eccezione della pianta disegnata da Bourguignon. Una sintesi della vita di Petre, come sempre, nella sezione biografie.  Un rampicante spettacolare Fu a Hartekamp, il meraviglioso giardino di George Clifford, che Linneo conobbe lo spettacolare rampicante che avrebbe battezzato Petrea volubilis. Arrivato da poco dal Messico grazie al medico e cacciatore di piante William Houstoun, che l'aveva raccolta nei pressi di Veracruz nel 1731, era ancora una primizia, degna di onorare un intenditore come Petre, che amava tappezzare le pareti della sua serra maggiore con lussureggianti rampicanti. In Hortus Cliffortianus (1737) Linneo descrisse la splendida pianta, facendo propria la denominazione proposta da Houstoun, con la seguente motivazione: "Questa pianta fu consacrata da Houstoun al nobilissimo Robert James Petre, barone di Writtle, estimatore e sommo coltivatore delle piante più rare e esotiche in Inghilterra". Lo stesso Linneo confermò poi la denominazione in Species Plantarum (1753). Il genere Petrea, della famiglia Verbenaceae, comprende una quindicina di specie origianarie dell'America tropicale (distribuite dal Messico al Perù e alla Bolivia, passando per le Antille); si tratta soprattutto di liane, ricadenti o rampicanti, che si distinguono dalle altre Verbenaceae per le foglie scabre e per il calice persistente che ha la funzione di aiutare la dispersione dei semi. La specie più nota, e anche quella più diffusa in natura, è appunto P. volubilis, una rampicante che può raggiungere i 12 metri, avvolgendosi ai supporti grazie ai fusti volubili. Ha una fioritura spettacolare grazie ai lunghi racemi penduli di fiori profumati, blu o viola pallido, in cui la piccola corolla lilla scuro, caduca, è circondata dai lunghissimi lobi del calice petaloideo, persistente, di colore più chiaro. Poco resistente al freddo, da noi può essere coltivata all'aperto solo nelle zone più miti, mentre altrove può essere allevata in vaso, anche come ricadente. E' stata introdotta in molte aree tropicali, dove assume la funzione del glicine in climi più freddi. Qualche informazione in più nella scheda. Il giurista amburghese Johann Heinrich von Speckelsen, proprietario di un giardino molto ammirato, in questa storia deve condividere la scena non solo con Linneo, ma con un'idra a sette teste. E il modo con cui è riuscito a dare il suo nome alla sfolgorante Sprekelia è quanto meno tortuoso.  Le vacanze intelligenti del giovane Linneo Nella primavera del 1735, il ventottenne Linneo parte per l'Olanda (dove, condizione imposta dal futuro suocero per concedergli la mano della figlia, dovrà conseguire un dottorato in medicina). Nei bagagli, una collezione di quasi mille insetti raccolti in Lapponia e Dalecarlia, e il famoso costume lappone con tanto di tamburo, con i quali conta di far colpo su eventuali protettori. Lungo la strada, si ferma due settimane ad Amburgo, dove viene accolto a braccia aperte da molti esponenti del vivace ambiente intellettuale della grande città anseatica. Il suo punto di riferimento è Johann Peter Kohl, slavista e redattore di un noto periodico di divulgazione scientifica, Hamburgischen Berichte von neuen Gelehrten Sachen, in cui aveva dato conto del viaggio di Linneo in Lapponia. Grazie alla raccomandazione di Kohl, al giovane svedese si aprono tutte le porte: si esibisce persino in un'imitazione di cerimonia sciamanica lappone, suscita interesse e ammirazione per il suo acume, la sua profonda cultura scientifica, l'atteggiamento modesto. Il celebre bibliografo J. A. Fabricius lo accoglie nelle sue stanze tappezzate di libri; il mercante di spezie Natorp gli mostra la sua collezione di lucertole, serpenti e altre rarità; il medico G. J. Jaenisch diventa un amico e un futuro corrispondente. Ma sicuramente l'incontro più fruttuoso per Linneo è quello con il collezionista e botanico dilettante Johann Heinrich von Spreckelsen; laureato in diritto, avvocato, membro di una famiglia di ricchi mercanti ben inserita nell'establishment amburghese, di lì a qualche anno diverrà segretario del Consiglio della città. Ma soprattutto è il proprietario di una fornitissima biblioteca ricca di testi di botanica (che presta liberalmente al nuovo amico) e di un ammirevole orto botanico privato, dove coltiva aranci e molte piante esotiche (a sentire Linneo, ci sono almeno 45 tipi di Aloe e 56 di Mesembryanthemum), soprattutto americane (grazie ai legami commerciali dei mercanti di Amburgo con le Americhe); possiede anche una collezione di cose naturali, tra cui una raccolta di fossili che lo svedese giudica la più grande che abbia mai visto. Oggi è difficile trovare informazioni su di lui, ma al tempo dovette essere ben inserito negli ambienti botanici europei: nel 1729 pubblicò un foglio con la figura della Yucca draconis (oggi Yucca aloifolia var. draconis), che nel 1732 fu ripreso da Dillenius in Hortus Elthamensis; più tardi sarà tra i corrispondenti di Collinson. Linneo stesso lo definirà botanicus doctissimus.  L'idra smascherata Sicuramente lo svedese avrebbe prolungato il piacevole soggiorno, se non fosse stato per uno sgradevole incidente. Tra le curiosità della città, c'era anche una celebre idra a sette teste, che proprio l'anno prima l'olandese Albertus Seba, collezionista e cultore di cose naturali, aveva descritto e fatto ritrarre nella sua Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, assicurandone l'autenticità. Linneo non poteva farsi scappare l'occasione di darle un'occhiata; vi riuscì grazie ai buoni uffici di Kohl. Ma gli bastò ben poco per capire che quella vantata meraviglia era una frode: si trattava di un grossolano artefatto, creato rivestendo ossa di donnola con pelli di serpente. Piuttosto sicuro del fatto suo, non tenne per sé la scoperta, anzi la annunciò sulle Hamburgischen Berichte. Gli sarebbe piaciuto anzi smascherare quel falso in un pubblico dibattito, ma un amico gli fece capire che era meglio tagliasse la corda: rischiava addirittura di essere messo ai ferri. E Linneo lasciò la città in fretta e furia. Ma da dove arrivava l'idra, e soprattutto di chi era? L'orgoglio della città d'Amburgo aveva già tutta una storia alle sue spalle: nel 1648, in seguito alla battaglia di Praga, l'ultima della guerra dei Trent'anni, sottratta a quanto si dice da una chiesa della città, era finita come bottino di guerra nella mani del comandante svedese, il conte di Königsmarck; poi, attraverso eredità e vendite, era passata di mano in mano fino ad approdare ad Amburgo. E qui le nostre fonti si dividono: secondo Seba, apparteneva ai mercanti Dreyern e Handel; secondo la maggior parte degli autori, faceva parte della collezione di curiosità del borgomastro Johann Anderson; secondo il biografo di Linneo D. C. Carr, che scriveva nella prima metà dell'Ottocento, apparteneva invece proprio al nostro von Spreckelsen. L'oggetto in ogni caso era considerato di grande valore: un tempo il re di Danimarca aveva cercato di aggiudicarselo per 30.000 ducati; ora il suo valore di mercato era molto inferiore, ma certamente l'incursione di Linneo si risolse in un danno non solo d'immagine per il proprietario. D'un tratto quel mirabile oggetto senza uguali non valeva più nulla; e capiamo perché secondo le fonti che identificano in Anderson il proprietario, questi fosse furioso e volesse far arrestare Linneo. Secondo Carr, invece, von Spreckelsen aveva contratto un prestito di 10.000 talleri dando come garanzia l'idra, e si trovò del tutto rovinato. Sono convinta che questa versione sia infondata: a smentirla sono gli ottimi rapporti che rimasero tra Linneo e von Spreckelsen dopo la partenza precipitosa dello svedese da Amburgo. Non solo egli elogia più volte il collezionista amburghese in diverse opere e non manca di ringraziarlo per avergli messo a disposizione i suoi libri, ma soprattutto ci sono rimaste due lettere di von Spreckelsen a Linneo (una del 1737, l'altra del 1755), in cui egli si esprime in termini di amicizia e di ammirazione nei suoi confronti. Un breve sunto della sua vita nella sezione biografie.  E finalmente... chiamiamola Sprekelia! Ma è ora che faccia il suo ingresso la protagonista verde di questa storia. Tra le rarità che von Spreckelsen coltivava nel suo giardino di Amburgo c'era anche quello che al tempo era noto come Lilio-narcissus o Narcissus jacobeus. Egli ne cedette qualche esemplare al medico e botanico Lorenz Heister, che a Helmstedt dirigeva uno degli orti botanici più celebrati della Germania. Come ringraziamento, questi ribattezzò la pianta Sprekelia (1753). Una denominazione che, come vedremo, dovette aspettare quasi settant'anni per entrare nell'uso. Se era una pianta rara, non era certo una novità nei giardini europei. Coltivata già dagli aztechi con il nome di atzcalxóchitl o “fiore di splendore rosso”, è citata da Hernández in Historia natural de Nueva España, scritta durante il suo viaggio in Messico tra il 1571 e il 1576. Secondo Linneo, arrivò in Europa nel 1593. Non sappiamo da dove egli derivasse questa notizia; sappiamo invece dalla corrispondenza del medico Simon de Tovar che quest'ultimo la coltivava nel suo giardino di Siviglia; nel 1595 ne inviò tre bulbi nelle Fiandre al conte di Arenberg; l'anno dopo ne inviò una dettagliata descrizione a Clusius, in cui per la prima volta ne associò il fiore alla spada dei cavalieri di San Giacomo, in base alla forma (ancora oggi, in inglese è detto Jacobean lily e in spagnolo è flor de Santiago). Si devono proprio a Clusius (in Rariorum plantarum Historia, 1601) la prima descrizione scientifica e la prima immagine. Nel corso del Seicento, viene riprodotta molte volte, ad esempio nelle opere di Vallet, Parkinson, Ferrari, de Bry, Morison, e così nel Settecento, per lo più come Narcissus indicus, Narcissus jacobaeus o Lilio-narcissus. Qualcuna di queste immagini in questa pagina. Linneo lo descrisse in Species plantarum, assegnandolo al genere Amaryllis come A. formosissima. Il nome Sprekelia rimase dunque inutilizzato, finché nel 1821 William Herbert in An Appendix. Preliminary Treatise, un lavoro propedeutico alla sua fondamentale opere sulle Amaryllidaceae, separò A. formosissima da Amaryllis e lo assegnò a un genere proprio; inizialmente aveva pensato di battezzarlo Jacobaea, rifacendosi al nome volgare, ma poi ragionò così: "Era stato chiamato Sprekelia da Heister, sebbene io creda che il nome non sia mai stato adottato, e io ho sempre pensato che è giusto aderire a un nome che è già stato dato". Noto anche con il nome di giglio azteco, Sprekelia è considerato uno dei fiori più belli; come si è anticipato, appartiene alla famiglia Amaryllidaceae, è originario del Messico e del Guatemala. Fino a pochi anni fa, era considerato un genere monotipico, con l'unica specie S. formosissima, caratterizzata da singolari fiori rosso brillante con tepali posti a croce a simmetria assiale. Oggi si riconosce una seconda specie, S. howardii, scoperta nel Messico meridionale e descritta nel 2000 da D. Lehmiller, più piccola della precedente e con tepali strettissimi. Qualche informazione in più nella scheda. La sera del 7 marzo 1804 in una libreria del quartiere londinese di Piccadilly si incontrano sette uomini, diversi per età e condizione sociale. A unirli, la passione per il giardinaggio e l'orticoltura. Da quell'incontro nascerà la Horticultural Society, oggi Royal Horticultural Society, la più prestigiosa associazione di orticultura del mondo, con oltre 350.000 iscritti. Più di uno di quei sette uomini verdi è ricordato da un genere di piante. Per cominciare, facciamo conoscenza con il più altolocato, l'onorevole Charles Francis Greville, dedicatario della Grevillea. 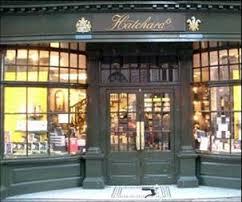 Una fruttifera riunione in libreria Nell'Inghilterra di inizio Ottocento, in cui il possesso di un parco con essenze esotiche è uno status symbol e l'hobby del giardinaggio unisce titolati e ricchi borghesi, mentre le conseguenze della interminabile guerra con la Francia rendono sempre più urgente incrementare le rese agricole e valorizzare gli alberi di frutto e da legname, l'idea di creare un'associazione che si proponga di promuovere lo sviluppo dell'orticultura in tutte le sue forme è nell'aria. Il primo a lanciarla è John Wedgwood, figlio di Josiah, fondatore della celeberrima fabbrica di ceramiche, che nel giugno 1801 scrive una lettera a William Forsyth, soprintendente dei giardini reali di Kensington e Saint James, chiedendogli di contattare sir Joseph Banks, presidente della Royal Society e grande patron degli studi botanici, per proporgli di creare una Società dedicata alla promozione dell'orticoltura. La risposta di Banks, prontamente coinvolto da Forsyth, è entusiastica, ma ci vogliono quasi tre anni per giungere alla fatidica sera del 7 marzo 1804 quando finalmente, presso la libreria Hatchards di Piccadilly, avviene l'incontro tra i sette soci fondatori da cui nasce ufficialmente la Horticultural Society (qualche anno dopo divenuta Horticultural Society of London e dal 1864, ottenuto il patrocinio reale, Royal Horticultural Society). I sette personaggi sono un piccolo spaccato della dinamica e aperta società inglese, in cui troviamo fianco a fianco nobiluomini, ricchi dilettanti, uomini di scienza e orticultori con le mani sporche di terra. Il primo è ovviamente John Wedgwood, che in quanto promotore presiede l'incontro. E' un ricco borghese appassionato di giardinaggio, ma è anche l'esponente di una famiglia in ascesa che unisce la ricchezza (derivata da una grande azienda di successo) agli interessi scientifici. Il padre Josiah, protagonista della prima rivoluzione industriale, si interessò di scienza applicata, inventò il pirometro - uno strumento per misurare le alte temperature necessarie per la cottura delle ceramiche - e fu accolto nella Royal Society. Il fratello Richard proseguì gli studi del padre sulla temperatura, ma soprattutto fu tra gli antesignani della fotografia. La sorella Susannah sposò Robert Darwin, figlio del filosofo Erasmus, divulgatore del sistema linneano con un poema all'epoca famoso, Gli amori delle piante. Dalla coppia nascerà il grande naturalista Charles Darwin. A rappresentare la nobiltà è l'honourable Charles Francis Greville, figlio cadetto di un lord, collezionista d'arte e appassionato dilettante di giardinaggio. La scienza è invece rappresentata da tre botanici: sir Joseph Banks, amico personale del re Giorgio III, sovrintendente ufficioso e artefice dei Royal Kew Gardens, presidente della Royal Society, e onnipotente patrono della botanica britannica, che già tante volte abbiamo incontrato in questo blog; Richard Anthony Salisbury, un personaggio dal passato (e dal futuro) alquanto chiacchierato; James Dickson, autore di un'importante opera sulle alghe e i funghi britannici, ma anche vivaista e come tale esponente anche dell'ultimo gruppo, quello dei "pratici". A formarlo insieme a lui sono i sovrintendenti dei giardini reali: William Forsyth, che dirige i parchi di Kensington e St. James dopo una lunga gavetta iniziata come aiuto giardiniere; William Townsend Aiton, capo giardiniere di Kew, carica ereditata dal padre, il grande William Aiton.  Nomi botanici, imbrogli e scandali Per quella che non è affatto una coincidenza, ben quattro di questi sette personaggi sono onorati da generi celebrativi tuttora validi, e un quinto da un sinonimo che gli assicura comunque un posto nella storia della nomeclatura botanica. A essere rimasti a bocca asciutta sono soltanto Josiah Wedgwood e W. T. Aiton, che tuttavia vive di gloria riflessa, dal momento che il suo nome di famiglia è ricordato dal genere Aitonia, dedicato al padre (oggi però ridotto a sinonimo). A sfiorare il podio è stato Richard Anthony Salisbury, nato Richard Markham; quando partecipò alla fatidica riunione, aveva alle spalle un passato burrascoso che lo aveva portato in carcere per debiti, ma godeva di una solida reputazione scientifica; nel 1797 James Edward Smith gli aveva dedicato il genere Salisburia (non valido: Salisburia adiantifolia Smith è un sinonimo di Ginkgo biloba L., pubblicato da Linneo nel 1771); nel 1809 fu nominato segretario ad honorem propria della neonata Horticultural Society. Ma quello stesso anno fu protagonista di uno scandalo che gli costò l'ostracismo dall'establishment scientifico britannico; dopo aver assistito presso la Linnean Society ad una conferenza di Robert Brown in cui lo botanico scozzese presentava la sua revisione tassonomica delle Proteaceae, ne memorizzò i nomi e li pubblicò come propri, sotto il nome di un amico, Joseph Knight, anticipando di qualche mese la pubblicazione di Brown. Da quel momento, nonostante la sua innegabile competenza, le sue opere furono boicottate e rimasero manoscritte; inoltre il suo successore alla carica di tesoriere della Horticultural Society, Joseph Sabine, ne rilevò e denunciò le irregolarità finanziarie. I quattro generi tuttora validi sono toccati rispettivamente a sir Joseph Banks con Banksia L.f. 1782 (se ne è già parlato in questo post); William Forsyth con Forsythia Vahl 1804; James Dickson con Dicksonia L'Héritier 1789; Charles Francis Greville con Grevillea R. Brown ex Knight 1809. Riservando a Forsyth e Dickson i prossimi post, approfondiamo ora la conoscenza con Greville.  Fiorirà la vaniglia Charles Francis Greville era il secondo figlio del primo conte di Warwick, proprietario tra l'altro di un grande parco progettato da Capability Brown. Come molti cadetti del suo ceto, godeva di un patrimonio personale molto limitato. Nonostante questo, investendolo con proverbiale oculatezza - i detrattori la definivano avarizia - riuscì a creare una notevole collezione di antichità e di pittura italiana, anche grazie ai contatti dello zio materno, sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli. Nelle cronache rosa, è noto per la sua lunga relazione con Emily Hart detta Emma. Ormai stanco di lei e desiderando sposarsi con una ricca ereditiera - l'unico modo per rimpinguare le sue magre finanze - senza tenere conto della volontà di lei, la spedì a Napoli dallo zio, da cui contava di ereditare, perché ne facesse la sua amante, nel duplice intento di liberarsi di una relazione scomoda e di evitare un secondo matrimonio del facoltoso parente. I suoi progetti però fallirono completamente: il ricco matrimonio andò in fumo, sir William si innamorò di Emma e la sposò; con il nome di lady Hamilton, la bellissima donna entrò nella storia come confidente della regina Carolina di Napoli e come amante di Horace Nelson. Alla morte del padre, Greville ereditò dal fratello maggiore un seggio alla Camera dei comuni e percorse una carriera politica che lo portò a rivestire diverse cariche di una certa rilevanza (fu Tesoriere della Real casa e membro del Consiglio privato della corona). Gli furono spesso affidati incarichi finanziari, dove poté esplicare il suo notevole spirito imprenditoriale. I suoi interessi scientifici furono variegati; come collezionista, incominciò a interessarsi di pietre preziose e minerali, divenendo amico di James Smithson, dedicatario dello Smithsonian di Washington; le sue collezioni furono poi acquisite dal British Museum. Membro di diverse società scientifiche (incluse la Royal Society, la Linnean Society e la Society of Antiquarians of London), come membro della Società dei dilettanti divenne intimo amico di Joseph Banks, che lo avvicinò alla passione per i giardini. Per molti anni visse in una casa affacciata sul Paddington Green, alla periferia di Londra, dove creò un giardino estremamente raffinato, dotato di serre in cui coltivava le piante tropicali che gli giungevano grazie ai contatti di Banks. Nell'inverno 1806-1807 ottenne il suo maggior successo, riuscendo a far fiorire per la prima volta in serra l'orchidea da cui si ricava la vaniglia, Vanilla planiflora. Pubblicata nel 1807 da Salisbury nel suo Paradisus londinensis (un catalogo delle piante più significative dei giardini di Londra), proprio perché se ne conoscevano i fiori solo da illustrazioni, fu ritenuta erroneamente una nuova specie e battezzata Vanilla fragrans. Greville fornì anche diversi esemplari di piante rare a James Edward Smith per il suo erbario, oggi conservato presso la Linnean Society. Qualche informazione in più sulla sua vita nella sezione biografie.  Il fascino esotico della Grevillea A questo appassionato di giardini e protettore della botanica, Robert Brown volle dedicare uno dei nuovi generi di Proteaceae australiane, Grevillea, stabilito nel 1810 in Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen. Come si accennato, però, i suoi risultati furono plagiati da Salisbury, che nel 1809 ne anticipò la pubblicazione in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae, sotto il nome di Knight. Ecco perché, per la regola della precedenza, la denominazione completa del genere è Grevillea Brown ex Knight. Con le sue circa 300 specie, Grevillea è uno dei più vasti generi della famiglia Proteaceae. Multiforme per portamento (si va dagli arbusti sempreverdi prostrati alti non più di mezzo metro ai grandi alberi che superano i trenta), si è adattato agli habitat più vari: dagli ambienti montani innevati alle foreste pluviali, dalle aree aride semidesertiche dell'interno australiano alle zone costiere sabbiose. La maggior parte delle specie è endemica dell'Australia, ma il suo areale si estende a nord all'Indonesia e alla Nuova Guinea e a est alla Nuova Caledonia. Molto caratteristiche sono le infiorescenze dai colori brillanti, talvolta unilaterali, talvolta cilindriche, che possono ricordare uno spazzolino, formato da numerosissimi fiori privi di petali con un calice tubolare che si divide in quattro brevi lobi da cui si protende un lunghissimo stilo. Ricchi di nettare, attirano insetti e uccelli, che ne sono i principali impollinatori; alcune specie sono però impollinate da farfalle, falene, coleotteri, imenotteri, formiche e persino da piccoli marsupiali. Le foglie alternate variano invece molto da una specie all'altra (aghiformi, pennatosette, pennate, profondamente dentate). Per i loro fiori inconsueti e vistosi, dal fascino decisamente esotico, alcune sono apprezzate piante da giardino; in Australia sono tra le più frequentemente coltivate nei parchi e nei giardini pubblici e privati; introdotte nei paesi tropicali e subtropicali, alcune specie sono abbastanza diffuse anche da noi in aree non soggette a gelate. Tra le più note G. banksii, un piccolo albero o arbusto espanso originario del Queensland, con vistosi racemi cilindrici rosso brillante; relativamente frequente da noi anche l'arbustiva e rustica G. rosmarinifolia, orginaria dell'Australia Sud orientale, con lunghe foglie lineari e fiori da rosa vivo e rosso riuniti in racemi allargati, da alcuni paragonati a ragni. G. robusta, nativa del Queensland e del South New Wales, è invece un vero e proprio albero, di crescita veloce, con fiori da arancione a giallo oro, riuniti in racemi orizzontali unilaterali. Moltissimi sono poi le cultivar e gli ibridi orticoli, selezionati soprattutto in Australia. Qualche approfondimento nella scheda. Nessun mistero, nessun rovello per scoprire il legame tra l'amatissima Saintpaulia e il suo dedicatario, il barone Walter von Saint Paul: fu lui a "scoprirla", a inviarne i semi in Europa, a ricevere la dedica del nome da un botanico riconoscente. Ma, come in tutte le storie, qualche piccola sorpresa c'è. Soprattutto c'è il paradosso delle amatissime violette africane, presenti in ogni casa e quasi estinte in natura. Con un post scriptum e un'ulteriore sorpresa dell'ultima ora.  Il figlio "buon colonialista"... L'avventura coloniale della Germania in Africa comincia quando Francia e Gran Bretagna si sono già spartite quasi tutto il continente. Il cancelliere Bismarck, infatti, desideroso di non turbare gli equilibri europei, ha preferito lasciare che rimanesse un terreno di caccia, ma anche di scontro, tra le due potenze. Le cose cambiano intorno al 1884 per iniziativa di un sinistro personaggio, Carl Peters. Vissuto a lungo a Londra, dove si è imbevuto dei principi della colonizzazione e dell'imperialismo, al suo rientro in Germania fonda la Società per la colonizzazione tedesca (Gesellschaft für Deutsche Kolonisation), quindi si reca in Africa orientale, dove conclude alcuni trattati con capi locali a nome della Società, che all'inizio del 1885 si trasforma nella Compagnia dell'Africa orientale tedesca. Ottenuto il riluttante appoggio del cancelliere, all'inizio la Compagnia gestirà direttamente la colonia, ma con metodi così brutali da provocare una rivolta, sedata nel sangue dalle truppe inviate dal governo tedesco che nel 1890 trasforma il possedimento della Compagnia in una colonia. Quanto a Peters, tornato in Africa come Alto Commissario imperiale, agì con tanta ferocia e scelleratezza da essere licenziato con disonore e da dover fuggire in esilio a Londra (niente da stupirsi che la sua memoria sia stata riabilitata da Hitler). E' proprio a questa ignobile figura che dobbiamo il coinvolgimento nell'avventura africana del nostro primo protagonista, il barone Walter von Saint Paul-Illaire (anzi, per una volta scriviamo il suo nome tutto intero: Adalbert Emil Walter Le Tanneux von Saint Paul-Illaire). Fu infatti Peters, che del barone era stato compagno di scuola, a proporgli di entrare a far parte della Compagnia dell'Africa orientale tedesca, cui avrebbe portato il prestigio di un nome altisonante. Saint Paul accettò, partecipando nel 1885 a una spedizione in Kenya e divenendo direttore della Compagnia. Nel 1891 lo troviamo nelle vesti di Commissario Distrettuale a Tanga, importante porto sull'Oceano Indiano (incarico che mantenne fino al 1910). Per nostra fortuna, benché fosse un convinto colonialista, era un uomo di tutt'altra pasta rispetto a Peters: nell'Introduzione al suo importante manuale di lingua swahili - a cui cominciò a lavorare non appena giunto in Africa - ebbe a scrivere: "In primo luogo, non è il nero a volere qualcosa da noi, ma siamo noi che siamo venuti a casa sua contro i suoi desideri e vogliamo qualcosa da lui. Per lo meno, abbiamo il dovere di dire quello che vogliamo nella sua lingua". I viaggiatori europei che lo incontrarono lo descrivono come un perfetto gentiluomo; viveva nella più bella casa di Tanga (Usumbara Court House, oggi restaurata e trasformata nel museo cittadino, Tanga Heritage Centre) e, oltre ai suoi doveri professionali e allo studio della lingua e delle tradizioni locali, si interessava anche alla natura. Fu così che un giorno imprecisato del 1892 nei pressi di Tanga notò graziose piantine dai fiori azzurri che crescevano in luoghi umidi e riparati tra le rocce; altre ne trovò nella foresta nei Monti Usumbara. Ne raccolse i semi e li inviò (presumibilmente nell'estate di quell'anno) a suo padre, il barone Ulrich.  Un padre con il pollice verde Entra così il scena il nostro co-protagonista, Ulrich Maximilian von Saint Paul-Illaire, barone di Fishbach. Nobiluomo, alto ufficiale di marina, aiutante di campo del comandante della flotta tedesca, membro del parlamento, ma soprattutto, dal nostro punto di vista, presidente dell'Associazione per la promozione dell'orticultura e primo presidente della Società tedesca degli amici delle Rose. Insomma, un appassionato di piante, orticultura e giardinaggio. Intorno al 1878 si era fatto costruire una villa nel suo possedimento di Fishbach in Slesia (oggi Karpniki, in Polonia) con un parco di cui, a quanto pare, curò personalmente la realizzazione. Vi coltivava, tra gli altri, magnolie e rododendri e le prime Catalpa bignonioides introdotte in Germania. Tra i primi in Europa riuscì a far germinare Picea breweriana. Fu in corrispondenza con diversi botanici, in particolare con George Engelmann, botanico tedesco naturalizzato statunitense, uno dei suoi fornitori di semi e piante rare. Insomma, i semi inviati da Walter al padre non potevano capitare in mani migliori. E il nostro barone dal pollice verde infatti riuscì a farli germinare e a ottenere le prime "violette di Usumbara", come le aveva battezzate il figlio. Tra i suoi contatti, c'era anche Hermann Wendland, conservatore dell'Orto botanico di Herrenhuasen e autorevole tassonomista; il barone Ulrich attirò la sua attenzione su quelle piante, che Wendland poté esaminare e descrivere scientificamente; stabilì che si trattava di una specie e di un genere nuovi per la scienza; in onore di padre e figlio, la battezzò Saintpaulia ionantha "con fiori simili alle viole" (1893). Tutto semplice e lineare, ma una piccola complicazione c'è. In realtà, qualche anno prima che Walter von Saint Paul scoprisse la pianta che gli avrebbe regalato la sua porzione di immortalità, due esploratori britannici, lo scozzese John Kirk nel 1884 e il reverendo W.E. Taylor nel 1887, ne avevano già raccolto alcuni esemplari che avevano inviato a Kew, ma la loro cattiva qualità non ne aveva permesso né la descrizione né la classificazione. Invece i semi di Walter, come abbiamo visto, non solo erano germogliati nelle serre di Ulrich, ma da loro discendono almeno in parte le violette africane che ornano oggi le nostre case. Inoltre, poco dopo la pubblicazione dell'articolo di Wendland, un giardiniere notò che non si trattava di una, ma di due specie: le capsule di alcune erano tonde, quelle di altre allungate. Oggi sappiamo che i semi raccolti vicino alla costa erano di S. ionantha, quelli che arrivavano dalle montagne appartenevano a quella che un po' ironicamente venne battezzata S. confusa (oggi riclassificata come S. ionantha subsp. grotei). Immediatamente presentate alla Mostra internazionale di floricoltura di Gand, le Saintpauliae incominciarono il loro cammino trionfale alla conquista degli appartamenti d'Europa e più tardi d'America. Rimaste infatti per un ventennio ambite piante per collezionisti, fu proprio in America che negli anni '20, a partire da semi europei discendenti dalle piante seminate dal nostro barone, incominciarono ad essere selezionate, incrociate, riprodotte in serie e a invadere i mercati. Qualche approfondimento sulle vite di padre e figlio nella sezione biografie.  Saintpaulia, un panda vegetale? Il destino delle violette africane, le belle, notissime e diffusissime Saintpauliae è davvero paradossale. Immancabili in ogni casa, vendute in ogni garden center, portate in dono all'amica ammalata o alla mamma per il suo compleanno, al centro di giri d'affari da capogiro, nel loro ambiente naturale sono ormai così rare che qualcuno le ha definite il "panda del regno vegetale". Saintapaulia è (o meglio era, come scopriremo più avavnti) un piccolo genere della famiglia Gesneriaceae; gli si assegnano solitamente una ventina di specie, ma studi recenti lo restringono a sei, riclassificando buona parte delle specie come sottospecie di S. ionantha. In natura vivono in una zona molto limitata dell'Africa sud-orientale, in Tanzania e in aree confinanti del Kenia sudorientale. Sono legate a un habitat molto specifico: originarie della foresta pluviale, vivono in piccole tasche di terra acida tra le rocce o lungo i corsi d'acqua, dove possono godere dell'ombra costante delle piante della foresta. Alcune sono epifite. Sono proprio queste esigenze così particolari a metterle in pericolo: l'espansione dei terreni agricoli sta sempre più riducendo le foresta, eliminando gli alberi che forniscono alle Saintpauliae rifugio ed ombra. Tutte le specie e le sottospecie sono incluse nella lista rossa delle specie minacciate; particolarmente a rischio S. teitensis (endemica di un'area limitata a 1 km quadrato nei Taita Hills del Kenia meridionale), ridotta a una popolazione di meno di 2500 esemplari; S. ulugurensis, presente in un solo sito, un un'area di cinque metri quadri, nei monti Uluguru (forse meno di 50 individui). Negli zoo delle nostre case, prosperano invece le Saintpauliae colitivate; dopo 120 anni di selezioni e ibridazioni, sono oggi disponibili circa 2000 cultivar con fiori bianchi, rosa, blu, viola, rossi, persino gialli e bicolori; semplici, semidoppi e doppi; con margini dei petali arrotondati, arricciati, increspati, frangiati. Non mancano le varietà con foglie variegate; le mini e le micro, le standard e le grandi. Una scelta infinita che alimenta la passione dei collezionisti. Qualche approfondimento nella scheda. PS Questo post è stato scritto nell'estate del 2017 e al momento la comunità scientifica accettava ancora Saintpaulia come genere indipendente. Nel frattempo le cose sono cambiate. Poco più di un anno prima, alla fine del 2015, Kanae Nishii e altri avevano pubblicato un articolo in cui ridefinivano i confini di Streptocarpus includendo tutte le Geseneriacee afro-malgasce. Tra l'altro, si dimostrava senza ombra di dubbio che Saintpaulia è annidato in Streptocarpus. La proposta è stata via via accettata dalle autorità internazionali botaniche, incluse Gesneriad Society e African Violet Society of America (cui spetta la registrazione delle varietà di Saintpaulia). Dunque oggi il genere Saintpaulia non esiste più; tuttavia rimane un nome botanico legittimo, non come genere, ma come sezione del sottogenere Streptocarpella. Inoltre Saintpaulia (tondo e non corsivo), per evitare confusioni e conflitti con ibridi di Streptocarpus, continua ad essere usato per designare gli ibridi moderni, almeno finché la transizione sia stata completata e tutti i nomi siano stati ridefiniti. In ogni caso, Saintpaulia ionantha Wendl. è ufficialmente diventata Streptocarpus ionantus (Wendl.) Christenh. Per mia fortuna, ho fatto in tempo a raccontare questa bella storia in zona Cesarini! Questa storia sembra uscita dalle pagine di un romanziere tardo vittoriano. Gli ingredienti sono quelli giusti: un gruppo di amici con quel pizzico di eccentricità very British; un'escursione abbastanza avventurosa e audace da meritare il nome di spedizione ma con gli agi e i tempi rilassati di una gita in campagna; ardimentosi esploratori appassionati di caccia grossa; ladies coraggiose cacciatrici di piante. Uniamoci anche noi alla spedizione; la nostra metà è la Somalia britannica del 1895 sulle tracce della favolosa Edithcolea.  Tre uomini e due donne a zonzo Quando si svolge la nostra storia, la penetrazione inglese in Somalia datava da appena dieci anni. L'occupazione militare era stata preceduta dalla spedizione di un gruppetto di esploratori che era penetrato nell'interno proprio per verificare le possibilità di aprire quell'area al commercio e al colonialismo britannico. Due di loro li ritroveremo tra gli allegri escursionisti del 1895: Ethelbert Lort-Phillips, un facoltoso architetto gallese, naturalista dilettante, vicepresidente della Zoological society, appassionato di caccia grossa e altri sport; l'amico Percy Aylmer, esploratore, cacciatore, più tardi militare sempre in scenari africani. Insieme i due avevano già condiviso altre avventure, soprattutto partite di caccia. La spedizione del 1884-85 non era stata una passeggiata: i somali, che giustamente temevano le mire europee sul loro territorio, aizzavano l'uno contro l'altra le potenze coloniali (in quell'area, Francia, Gran Bretagna, Italia) e non pochi europei furono vittime dei loro attacchi. Comunque, Lort-Phillips e i suoi amici ne erano usciti indenni (anche se erano stati costretti a rientrare anticipatamente dal Foreing Office, in seguito all'Assedio di Khartum); Lort-Phillips e il medico della spedizione, J. G. Trupp, erano anche riusciti a raccogliere una discreta collezione di reperti naturalistici, in particolare uccelli (Lort-Phillips era un appassionato ornitologo). Nei dieci anni intercorsi, il nostro architetto cacciatore si era sposato e era riuscito a contagiare del mal d'Africa la giovane moglie, Louisa Jane Gunnis, alla quale in occasione del matrimonio aveva donato bei gioielli d'argento portati con sé dalla Somalia. Sarà stato così che, quando la situazione si era ormai tranquillizzata con l'occupazione inglese dell'area nord-occidentale del paese (Somaliland, o Somalia Britannica), la coppia decise di ripercorrere le tappe di quel viaggio avventuroso, ormai trasformato in una gita di piacere dalla Pax britannica. A partire da Londra il 4 gennaio 1895 furono in cinque: Ethelbert e Louisa, l'amico Aylmer, Frank Gunnis (fratello di Louisa) e Edith Cole, un'amica di Louisa che era stata una delle sue damigelle di nozze. L'obiettivo, come dichiara Ethelbert in On birds observed in the Goolis Mountains in the Northern Somali-land, era "trascorrere tre piacevoli mesi lontano dall'umidità e dal freddo dell'inverno inglese"; altri sarebbero andati in Costa Azzura o magari a Madera, ma evidentemente i Lort-Phillips e i loro amici cercavano emozioni più forti e qualcosa di più inconsueto da raccontare ai loro ospiti nelle serate mondane (i loro nomi ricorrono nelle cronache del jet set). La prima tappa fu Aden, raggiunta con un comodo piroscafo, dove si trattennero un paio di giorni, per imbarcarsi sul "guscio d'uovo" che li avrebbe portati a Berbera, giusto di fronte, sulla costa somala. Imbarcatisi la sera, speravano di essere a destinazione già la mattina dopo, ma la traversata si protrasse invece fino al tardo pomeriggio, funestata dal mare grosso e dal mal di mare (sopportato stoicamente anche dalle giovani ladies). A Berbera le donne furono ospitate dal residente inglese, mentre i maschi si accampavano spartanamente nel maidan. Il progetto era fermarsi in città giusto il tempo per ingaggiare le guide e i portatori e affittare cammelli e cavalli, per poi partire immediatamente per le colline; ma si dovette cambiare programma, a causa di un'intossicazione alimentare che colpì tutti i membri maschili del gruppo. L'impavido Lort-Phillips se la cavò in una giornata ricorrendo a una dose da cavallo di olio di ricino, mentre gli amici, che avevano rifiutato quel drastico rimedio, rimasero ko per più giorni. Nell'attesa che si rimettessero, Ethelebert e le signore si spostarono nell'oasi di Dobar, a otto miglia da Berbera, dove si trovavano cisterne e orti, particolarmente ricchi di farfalle e coleotteri. Edith e Louisa incominciarono la loro raccolta entomologica, suscitando la sorpresa dei locali ("Che se ne fanno le signore? Non si possono neanche mangiare"). Dopo due giorni trascorsi piacevolmente a leggere, prendere il fresco all'ombra dei tamarindi e a cacciare farfalle, furono raggiunti da Percy e Frank, finalmente rimessi. Per raggiungere la loro meta, le montagne Golis, gli amici si mossero verso sud ovest, toccando l'oasi di Bihen, Gelloker (una località particolarmente piacevole, con una ricca vegetazione dominata dalle acacie a ombrello e una notevole fauna avicola), Hammar, ai piedi del passo Sheik. Qui Lort-Phillips fu protagonista di un'avventura a lieto fine, tra l'incosciente e il fanfarone. Mentre, munito di retino, cercava di catturare le farfalle nelle pozze formate da una cascatella, scorse un serpente ed ebbe la bizzarra idea di catturarlo con il retino; quando avvicinò quest'ultimo al volto per osservare meglio la sua preda, questa gli sputò in un occhio. Nonostante il dolore fortissimo il nostro barone di Munchausen gallese si lavò il volto nell'acqua, ricatturò il serpente che se l'era svignata e solo a questo punto tornò di corsa all'accampamento. Fu molto fortunato; nel giro di poche ore il dolore si attenuò, senza lasciare conseguenze. Solo più tardi avrebbe scoperto che il rettile era un cobra e che sarebbe bastata una piccola ferita per morire o per perdere l'occhio.  Tordi, corvi e nuove piante Il giorno successivo, attraverso il passo Sheik, varcato senza difficoltà grazie alla nuovissima carrozzabile costruita dall'amministrazione inglese, il gruppo raggiunse finalmente le montagne Gulis. Senza affrettarsi troppo, esplorarono l'altopiano muovendosi verso occidente, alternando le piacevoli escursioni, la caccia, la raccolta di esemplari naturalistici (senza dimenticare le immancabili pause per il tè). Si erano divisi i compiti secondo un criterio di genere: gli uomini cacciavano, catturavano mammiferi e uccelli; le donne raccoglievano insetti e piante, all'occasione si occupavano dei piccoli animali catturati (come un cucciolo di babbuino, che fu poi donato alla Zoological Society). Per l'ornitologo Lort-Phillips, la spedizione fu un grande successo; la zona era ricca di uccelli, e riuscì a individuare due specie nuove che, galantemente, dedicò una alla moglie (il tordo della Somalia, Merula ludoviciae, oggi Turdus ludoviciae), l'altro a Edith (il corvo somalo, Corvus edithae; Lort Phillips si vanta di averlo riconosciuto come nuova specie solo sentendolo gracidare dalla sua tenda). Per il cacciatore Lort-Phillips, fu invece molto deludente: non c'erano grossi animali da cacciare, e anche se i leopardi attaccarono il loro accampamento cinque volte, non riuscirono a prenderne neanche uno. Il successo più grande tuttavia fu per le nostre cacciatrici di piante (e entomologhe). Gli altopiani somali sono aridi, ma nella stagione delle piogge la vegetazione si fa all'improvviso rigogliosa. Durante le ultime settimane del viaggio, iniziarono le piogge primaverili e quando il gruppo raggiunse la valle di Wadaba tutto era verdeggiante. Fu qui che Edith e Louisa raccolsero il loro più ricco bottino; alla fine, le piante da loro raccolte (anche Ethelbert e Percy concorsero, sebbene in minor misura) furono circa 350; quando furono esaminate a Kew (da Baker e Brown) si scoprì che quasi 70 erano nuove per la scienza. La più notevole è Edithcolea grandis, destinata a eternare il nome di Miss Cole, insieme a Caralluma edithae e Crassula coleae, mentre Louisa è ricordata da Euphorbia phillipsiae e Sansievieria phillipsiae. Prima di rientrare a Berbera al gruppo toccò ancora un'avventura che Lort-Phillips definisce "un'esperienza più eccitante". Lasciate ormai le colline, spostandosi da Wadaba a Bihen dovettero affrontare un lungo tratto di pianura assolata e priva di luoghi di sosta dove trascorrere le ore più calde della giornata; quando ormai disperavano di trovare un luogo adatto, scorsero in lontananza una macchia di verde: erano due acacie completamente coperte di liane e rampicanti che formavano un fresco baldacchino, al centro di un isolotto nel greto di un torrente quasi asciutto. Felici, si accamparono, estraendo dai loro panieri da caccia sedie, tavolini, provviste per un picnic in piena regola. Ma mentre si godevano felici la frescura facendo la pennichella, incominciò a piovere e a tuonare; rapidamente gli incoscienti viaggiatori trasformarono sedie tavole e coperta da picnic in una tenda improvvisata che, insieme agli alberi, li riparava egregiamente dalla pioggia che cadeva a catinelle; ma quegli alberi altissimi, in mezzo a una pianura spoglia - si resero conto troppo tardi - erano perfetti per attirare i fulmini, così come le loro armi e le suppellettili di metallo. Dopo una decina di minuti di panico, il temporale si allontanò; ma i pericoli non erano finiti: il corso d'acqua, gonfiatosi all'improvviso, travolse l'accampamento, trascinando via ogni cosa mentre i nostri audaci (e imprudenti) esploratori si salvavano a stento. Arrivati a Bihen, scoprirono che il resto della carovana, che aveva percorso un'altra strada, non aveva incontrato nemmeno una goccia di pioggia. Pochi giorni dopo, rientrarono a Berbera, dove terminò la loro comune avventura africana. I coniugi Lort-Phillips tornarono altre volte in Africa, poi si lanciarono in un'impresa di altro genere: si spostarono in Norvegia, dove Ethelbert fu un pioniere dell'industria turistica, costruendo cinque alberghi destinati agli inglesi appassionati di pesca al salmone. Di Edith, che vivrà ancora per più di quarant'anni, quasi si perdono le tracce: abbiamo qualche sua lettera ai direttori di Kew, la segnalazione della partecipazione a qualche occasione mondana, sempre in compagnia dei Lort-Phillips, che sicuramente visitò anche in Norvegia. Le poche notizie che sono riuscita trovare su di lei sono sintetizzate nella sezione biografie.  Edithcolea, fiori come tappeti persiani Davvero bella e singolare è Edithcolea grandis, l'unica specie del genere monotipico Edithcolea, della famiglia Apocynaceae (un tempo Asclepiadaceae): per i fiori particolarmente grandi con corolle che possono superare i 10 cm di diametro e la sorprendente combinazione di colori, che in inglese le hanno guadagnato il nome di Persian carpet flower, "fiore tappeto-persiano", è uno dei rappresentanti più belli e ricercati della tribù Stapelieae. La corolla a cinque lobi, a stella appiattita, ha il disco esterno con colore di base giallo macchiettato di un ricco rosso porpora, con macchie puntiformi che si fanno via via più piccole e fitte al centro, formando righe concentriche attorno alla corona centrale. Quel bersaglio colorato non è fatto per la gioia dei nostri occhi, ma per trarre in inganno gli insetti impollinatori, soprattutto mosche, così come quell'odorino di carogna che ha in comune con le sue consorelle. Che non scoraggia certo i collezionisti, come non li ferma la fama di difficile di questa pianta che, figlia delle zone aride della regione dei Grandi laghi, del Corno d'Africa e dello Yemen, si trova un po' spaesata nelle nostre case. A dedicarla ad Edith l'anno stesso della scoperta (1895) fu Nicholas Edward Brown, tassonomista di Kew, uno dei due botanici che esaminò e pubblicò la collezione raccolta da Edith Cole e Louisa Lort- Phillipps durante quel "piacevole viaggio" in Somalia. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
March 2024
Categorie
All
|
 RSS Feed
RSS Feed