|
Il mercante e alto funzionario della VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali) Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher si rese benemerito come fondatore e animatore di una delle prime società erudite dell'Asia orientale, la Reale società delle Arti e delle Scienze di Batavia, alla quale donò la prima sede, la propria biblioteca e la propria collezione di curiosità naturali, oggetti etnografici, strumenti musicali, opere d'arte. Anche se non sono giunti fino a noi, c'erano sicuramente anche fogli d'erbario, dato che sappiamo che ricevette campioni dal Giappone da Thunberg ed egli stesso fece raccolte a Giava e inviò exssiccata a Houttuyn. Tra i suoi vasti e variegati interessi c'era infatti anche la botanica, come testimonia una delle sue opere, una lista delle piante dell'isola. A ricordarlo il genere Radermachera, che fu inizialmente descritto proprio sulla base di una specie presente anche in Indonesia. Un dilettante curioso e la nascita di una società scientifica Quando lasciò per la prima volta l'Olanda alla volta dell'Indonesia (le Indie orientali olandesi, come le chiamavano allora), Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher (1741-1783) aveva appena sedici anni. Se non fosse rimasto orfano di padre a sette anni forse non avrebbe avuto bisogno di cercare fortuna in Oriente. La sua era una infatti famiglia influente. Il bisnonno Johan Radermacher era stato balivo di Middelburg e direttore della WIC (la Compagnia olandese delle Indie Occidentali), il padre Johan Cornelis tesoriere generale del principe e primo grande maestro della loggia massonica L'Union. La decisione di mandarlo a Batavia ad imparare il mestiere di mercante nonostante la giovanissima età probabilmente fu presa dallo zio Samuel Radermacher che era uno dei direttori della VOC, come lo sarebbe stato dopo di lui il figlio Daniel. Così il 30 dicembre Jacobus (d'ora in avanti lo chiameremo con il primo nome, come del resto era d'uso) si imbarcò con il grado di sottomercante sulla nave "Middelburg" diretta a Batavia. Qui fece rapidamente carriera, certamente anche grazie alla protezione dello zio e del cugino: un anno dopo era secondo amministratore del Groote Winkel ("grande negozio") e pochi mesi dopo secondo amministratore del Graanmagazijn (il magazzino principale). Il 10 gennaio 1761 gli fu conferito il grado di mercante e il 6 aprile 1762, quando aveva appena 21 anni, fu nominato capo commerciante e contemporaneamente capitano di porto per la popolazione nativa non cristiana. Lo stesso anno, seguendo la tradizione familiare, fondò la loggia massonica La Choisie, la più antica dell'Asia orientale. Nel frattempo si era sposato con Margaretha Verijssel, figlia di un consigliere delle Indie Orientali, e di Sophia Francisca Westpalm, che, rimasta vedova, si era risposata con Reinier de Klerk, all'epoca consigliere straordinario del Consiglio delle Indie. Nonostante la rapida e brillante carriera, Jacobus doveva essere insoddisfatto e chiese di rientrare in patria. Ottenuta l'autorizzazione, nell'ottobre 1763 si imbarcò alla volta dell'Olanda con la moglie. Si stabilì all'Aja e incominciò a studiare legge privatamente; per conseguire la laurea, si iscrisse all'Università di Harderwijk, un diplomificio noto per per conferire diplomi lampo (lo stesso dove una trentina di anni prima si era laureato Linneo): nel suo caso, dall'iscrizione alla laurea passò appena un giorno! Quindi prestò giuramento all'avvocatura di Arnheim, ma qualcosa dovette andare storto e dopo appena sei mesi incominciò a fare pressione sulla direzione della VOC per essere richiamato a Batavia. Incontrò ripetuti rifiuti, forse dovuti all'ostilità che gli aveva procurato il suo scritto "Riflessioni sullo stato attuale dei Paesi Bassi", in cui prendeva atto della crisi della Compagnia, ne criticava le scelte nei confronti dei dipendenti e dei nativi e proponeva una serie di riforme. Aveva idee progressiste anche in altri campi: era contrario alla pena di morte, con l'argomentazione "economicista" che uccidere un reo non portava vantaggio a nessuno, mentre un reo rieducato avrebbe potuto essere utile alla società anche per mezzo secolo. Infine gli fu accordato il permesso di partire, ma a proprie spese e senza alcun incarico ufficiale. Il 20 dicembre la famiglia Radermacher (nel frattempo erano nati due bimbi) si imbarcò sulla nave "Tulpenburg"; il giorno di Natale, mentre erano ancora nella rada di Texel in attesa di un tempo più propizio, il più piccolo dei bimbi morì. Era il mesto inizio di un viaggio difficile, che si protrasse per più di otto mesi e fu segnato dalla morte di un quinto dei passeggeri. Al suo arrivo a Batavia il 21 agosto 1767, Radermarcher, che aveva annotato scrupolosamente gli eventi nel proprio diario di viaggio e aveva incominciato ad interessarsi di cartografia come reazione alle ripetute perdite di rotta, scoprì che nel frattempo era stato nuovamente assunto dalla VOC. La seconda parte della sua carriera non fu più quella di un mercante, ma di un amministratore e alto funzionario. Nel 1768 fu nominato balivo di Batavia, ufficiale giudiziario e curatore della chiesa; nel 1775 consigliere straordinario delle Indie orientali; nel 1777 presidente degli assessori, colonnello della borghesia, presidente del consiglio di amministrazione delle scuole cittadine e commissario delle Terre Alte. Contemporaneamente era diventato uno degli animatori della vita culturale di Batavia; si interessava di tutto (amministrazione, cartografia, geografia, letteratura e linguistica, religione, navigazione, scienze naturali), collezionava curiosità naturali e possedeva una biblioteca aggiornata con libri in varie lingue, un Dictionaire Encyclopedique in 17 volumi e 68 volumi delle opere di Voltaire, di cui evidentemente era ammiratore. Fin dagli anni '60 con alcuni amici, ispirandosi al modello della Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (Reale società olandese delle scienze e delle arti) di Haarlem, la più antica e prestigiosa società scientifica olandese, propose di creare a Batavia una società erudita, ma il progetto fu messo da parte per il totale disinteresse dei vertici della società e dei governatori van der Parra e van Riemsdijk. Una svolta si ebbe nel 1777, anno in cui si celebrava il 25esimo anniversario della società di Haarlem; probabilmente grazie al cugino Daniel, che presiedeva diverse società, sia Radermacher sia Reinier de Klerk, il patrigno della moglie Margharete, ne furono nominati amministratori. Poco dopo il governatore van Riemsdijk morì e fu sostituito proprio da de Klerk, che condivideva gli interessi culturali del genero. La strada per la fondazione della Reale società delle scienze e delle arti Batavia (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) era spianata. Essa nacque ufficialmente il 24 aprile 1778, con il motto "A beneficio della comunità"; non era un ramo della società di Haarlem, ma una società scientifica indipendente, interessata "alla storia naturale, alle antichità, alla morale e ai costumi del popolo". Ne facevano parte di diritto il governatore generale e alti ufficiali della VOC, tra i quali venne scelto un comitato che si riuniva il primo lunedì di ogni mese al casa di Radermacher. Un anno dopo nel palazzo del governatore si tenne la prima riunione generale in cui Radermacher annunziò tra l'altro la sua intenzione di donare alla società un edificio, i propri libri e le proprie collezioni per allestire una biblioteca e un museo. Suggerì anche di acquistare un giardino dove coltivare le piante native: è considerato il precursore dell'orto botanico di Buitenzorg. La società si diede anche un organo, la rivista Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, che iniziò le pubblicazioni nel 1779. Lo stesso anno il museo venne aperto al pubblico, anche se solo per due ore la settimana, la mattina del mercoledì. Radermacher era il vero animatore sia della società sia della rivista, sulla quale pubblicò una serie di articoli sugli argomenti più diversi; per fare un solo esempio, nel numero del 1780, oltre alla relazione sulle attività annuali, leggiamo suoi saggi sul Borneo, sulla cura della gotta, sulle carte nautiche. Intanto egli aveva raggiunto il culmine della carriera: nel marzo del 1781 in occasione dello scoppio della guerra con l'Inghilterra fu nominato commissario delle opere difensive (ovvero responsabile della difesa di Batavia in caso di attacco inglese) e poco dopo commissario della flotta e dell'esercito, Lo stesso anno subì il grave lutto della perdita della moglie; tuttavia già nel 1783 si risposò con l'adolescente Anna Bosch (lui aveva 42 anni, lei 15). Poco dopo gli giunse la notizia che era stato nominato consigliere ordinario del Consiglio delle Indie orientali. Ma Jacobus aveva altri piani: sempre più sofferente per la gotta che lo tormentava da anni, aveva chiesto di tornare in patria, dove contava di vivere di rendita grazie alla dote della ricca moglie. Il permesso gli venne accordato, anzi venne nominato ammiraglio della flotta di ritorno. Così lui e Anna si imbarcarono sulla nave "Java"; il 24 dicembre, mentre si trovavano al largo, una ventina di marinai cinesi assalì gli ufficiali. Jacobus venne accoltellato a morte, Anna fu ferita ma si salvò. La rivolta fu quasi immediatamente soffocata, gli ammutinati furono rinchiusi nella stiva e il giorno di Natale eliminati uno dopo l'altro con un atto di giustizia sommaria. Per sua fortuna, Frans Reinier, l'unico figlio superstite di Radermacher, era rimasto a Batavia.  Una lista di piante di Giava e una pianta cinese Tra i molteplici interessi di Radermacher c'era anche la botanica. Come commissario delle Terre alte visitò diverse aree dell'isola; conosciamo l'itinerario di due di queste ispezioni: nell'agosto 1776 da Batavia mosse per Krawang, Klapanungal, Buitenzorg, Pondokgede, Tjipanas; nel novembre dell'anno successivo ripercorse la medesima via, per poi proseguire per Megamendung, Telaga Warna, Tjiandjoer e rientrare via Tangerang; nel maggio 1777 fu la volta delle regioni occidentali. Sicuramente approfittò di questi viaggi nell'interno per fare raccolte botaniche e raccogliere informazioni sui nomi e sugli usi tradizionali delle piante di Giava. Anche se non ci è giunto, certamente creò un erbario che entrò a far parte delle collezioni del museo della Società batava delle scienze e delle arti; non a caso, nel primo volume della rivista volle includere istruzioni su come essiccare e conservare i vegetali. Oltre alle raccolte fatte da Radermacher a Giava (e forse a Sumatra), l'erbario presumibilmente comprendeva campioni inviati da Thunberg dal Giappone. Radermacher e Thunberg si erano conosciuti nell'estate del 1775, quando lo svedese era arrivato a Batavia dal Sudafrica; aveva poi proseguito quasi immediatamente per il Giappone, non senza aver preso accordi con Radermacher perché facesse da intermediario con uno dei suoi sponsor, il naturalista Martinus Houttuyn. Il primo di questi invii, spedito da Thunberg a Radermacher a Batavia e da questi inoltrato a Houttuyn ad Amsterdam, dovette raggiungere i Paesi Bassi nel maggio-giugno 1777, come dimostra la nota editoriale dell'ottavo volume della seconda parte di Natuurlijke historie (31 Dicembre 1777) di Houttuyn dove compaiono le prime specie giapponesi. Altre raccolte Thunberg le consegnò di persona quando tornò a Giava da Dejima, nel dicembre 1776. Tra l'altro gli affidò una collezione di pesci, che Radermacher si affrettò a inoltrare ad Houttuyn il quale nel 1782 avrebbe pubblicato 36 specie di pesci giapponesi (21 dei quali nuovi per la scienza) nell'articolo Beschrijving van eenige japansche visschen en andere zee-schepselen (Descrizione di alcuni pesci giapponesi e di alcune altre creature marine). Al secondo passaggio, Thunberg si trattenne a Giava per circa sei mesi e fece estese esplorazioni dell'interno; Radermacher cercò inutilmente di convincerlo a rimanere nell'isola. Anche se non accettò, lo svedese fu profondamente colpito dalla sua personalità e generosità, tanto da dedicargli il genere Radermachia (oggi sinonimo di Artocarpus) con parole di sincera riconoscenza: "Il nome è in onore del sommo mecenate, patrono e massimo fautore delle scienze naturali Jacobus Cornelis Matteus Radermacher, consigliere del Consiglio delle Indie e illustre presidente dell'Accademia delle Scienze di Batavia". Non sappiamo se Radermacher e Houttuyn si conoscessero già in precedenza (è possibile, visto che entrambi erano membri delle società scientifiche di Haarlem e di Vlessingen), ma, oltre a fare "da postino" per gli invii di Thunberg, Radermacher ne aggiunse anche di propri, permettendo al suo corrispondente di pubblicare per primo piante indonesiane come l'albero della canfora di Sumatra Dryobalanops aromaticus. Il suo interesse per la botanica per altro andava oltre i ruoli di mecenate e raccoglitore-collezionista; gli si deve infatti almeno un'opera di botanica, Naamlijst der planten die gevonden worden op het eiland Java (Elenco delle piante trovate sull'isola di Giava) in tre volumi. Il primo, dopo un'introduzione di carattere generale che è anche un omaggio a Linneo di cui viene illustrato sinteticamente il sistema, è costituito dalla descrizione di 99 piante giavanesi, in ordine alfabetico secondo il nome locale. Le descrizioni sono sempre molto sintetiche, ma abbastanza precise. Ad esempio, alla voce Sampar o Tinguli (una delle poche per le quali è fornito anche il nome botanico Cassia fistula), si legge: "Un grande albero con foglie ovali lunghe quattro pollici; fiore con calice a cinque sepali, cinque petali gialli, dieci stami; frutto retto da un gambo rotondo marrone lungo 30 cm che contiene una polpa bianca usata in medicina. Appartiene alla 1a classe Decandria. Il Tingulong descritto da Rumphius è un'altra pianta". Segue un indice in cui, salvo eccezioni, ad ogni specie si fa corrispondere il genere botanico. Da indici sono costituiti anche il secondo e il terzo volume che elencano le piante in olandese, latino, malay (trascritto in caratteri latini). C'è anche una lista dei nomi di Rumphius con i supposti equivalenti latini. Stampata a Batavia nella tipografia della VOC tra il 1780 e il 1782, l'opera ebbe scarsa circolazione ed è stata quasi totalmente ignorata dai botanici successivi. Era tuttavia nota a H. Zollinger e A. Moritzi che proprio in ragione di quest'opera gli dedicarono il genere Radermachera scrivendo: "In onore del sig. J. C. M. Radermacher, che scrisse Naamlyst der planten op het eiland Java e altre opere simili, Batavia 1780-4, amico e protettore di Thunberg, membro del Consiglio delle Indie". La specie sulla base della quale i due botanici svizzeri crearono il genere è R. stricta, oggi R. glandulosa, in precedenza descritta da Blume come Spathoidea glandulosa. È una delle poche specie presenti anche in Indonesia. Infatti il centro di diversità di questo genere dell'Asia tropicale di circa 17 specie delle famiglia Bignoniaceae è la Cina, con sette specie. E alla Cina (anche se il suo areale è molto più vasto) fa riferimento l'eponimo della specie più nota, R. sinica, che da qualche anno ha incominciato ad acquisire in certa popolarità come pianta da appartamento magari in forma di bonsai. Le Radermachera in effetti sono alberi, anche di grandi dimensioni (alcune specie possono raggiungere in 40 metri) con foglie composte sempreverdi e grandi fiori a tromba bianchi, viola o gialli, raccolti in infiorescenze a pannocchia. R. sinica però si adatta anche alla coltivazione in vaso; in queste condizioni mantiene dimensioni contenute (al massimo mezzo metro) e si fa apprezzare per il bellissimo fogliame lucido verde smeraldo, mentre raramente fiorisce. Invece in natura è un albero che può raggiungere i 30 metri con grandi fiori bianchi che si aprono al tramonto e al mattino già sfioriscono. È a questi fiori candidi che deve uno dei suoi numerosi nomignoli "bambola di porcellana"; si riferisce invece ai frutti, lunghe e strette capsule che possono ricordare serpentelli, il soprannome "albero serpente" e al colore delle foglie "albero smeraldo".
0 Comments
Per la vastità e la diversità degli argomenti toccati, la Storia naturale (Natuurlyke Historie) dell'olandese Martinus Houttuyn, con i suoi 37 volumi, può essere paragonata solo all'Histoire naturelle di Bouffon, che ne comprende 36. Certamente è meno originale e brillante, ma è stato osservato che, per quanto riguarda gli animali, il francese non andò oltre gli uccelli e i quadrupedi e omise le piante, mentre l'olandese trattò in modo completo il regno animale, inclusi gli insetti e altri invertebrati, e non trascurò quello vegetale. Inoltre, mentre Buffon poté avvalersi dell'assistenza di Daubenton e Gueneau de Montbeillard, Houttuyn lavorò completamente da solo, realizzando uno straordinario one's man work, che lo impegnò per un trentennio. Senza dimenticare che, per le sue ricerche, il conte di Buffon poteva disporre delle raccolte del Jardin du Roi, delle collezioni, delle biblioteche e dei laboratori della capitale culturale d'Europa, nonché di un notevole patrimonio personale, mentre Martinus Houttuyn viveva in una Amsterdam orami relativamente provinciale e poteva contare solo sui gabinetti di curiosità di alcuni amici, e soprattutto sul suo, messo insieme barcamenandosi tra un lavoro editoriale e l'altro. Membro di due società scientifiche e corrispondente di diversi naturalisti di primo piano, tra cui Carl Peter Thunberg, in vita Houttuyn godette di una certa fama, ma poi fu quasi totalmente dimenticato. Il motivo principale è che aveva scritto in olandese, limitando fortemente la diffusione di quell'opera gigantesca, già di per sé costosa e adatta a poche tasche. Al di fuori degli specialisti, a mantenere vivo il suo ricordo è dunque soprattutto il genere Houttuynia che gli fu dedicato appunto da Thunberg.  L'one man's work di un naturalista olandese Dopo trent'anni di lavoro, dovette essere certamente con sollievo che Martinus Houttuyn (1720-1798) scrisse l'ultima parola della sua Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus (Storia naturale o descrizione dettagliata di animali, piante e minerali, secondo la classificazione del signor Linneo). Un sollievo che traspare nei versi commossi (e commoventi) che chiudono il 37esimo e ultimo volume; l'opera di una vita è terminata e il sessantacinquenne Houttuyn può pensare all'eternità: "O Creatore della natura la cui meravigliosa mano ha portato il mondo a una condizione così bella, ha ornato il Regno terrestre di persone, animali e piante e il suo interno di metalli e diamanti preziosi, tu che tutto mantieni, tu, o buon Signore, che hai avuto la compiacenza di assistermi per più di trent'anni dedicati ad osservare le tue creature per rafforzare il sapere dei miei connazionali, ora che - sei volte dieci più cinque - il ciclo dei miei anni si chiude, concedi che, dopo questo, il mio nobile spirito nell'eternità si avvicini meglio alla tua sapienza, si diverta con le creature celesti nel coro degli angeli, mentre il Paradiso mi offre i suoi frutti". Traspare anche una profonda religiosità, che Martinus (Maarten nella forma olandese, che però il naturalista non usò mai nei suoi scritti) dovette assorbire fin dalla nascita nella piccola congregazione mennonita di Hoorn, di cui il padre Willem era allo stesso tempo medico e predicatore laico. Fu il padre ad impartirgli una accurata educazione, che, oltre alla medicina, comprendeva matematica, geometria, fisica, astronomia, botanica sistematica (secondo il sistema di Tournefort) e "l'enorme diversità della natura". Nel 1647, a 27 anni, si iscrisse alla facoltà di medicina di Leida e conseguì la laurea due anni dopo; era un'età avanzata per l'epoca, probabilmente spiegata dalla scarsa disponibilità economica della famiglia, e quindi dal desiderio di abbreviare il più possibile il soggiorno nella costosa città universitaria. Dopo la laurea Martinus Houttuyn tornò per breve tempo ad Hoorn, per poi trasferirsi con la famiglia (nel frattempo si era sposato e aveva un figlio) a Amsterdam dove dal 1753 risulta registrato come cittadino e medico; secondo alcune fonti, prestò servizio come medico della comunità mennonita di Amsterdam, ma presto il suo lavoro principale divenne quello editoriale. Incominciò infatti a lavorare per il secondo cugino Frans Houttuyn, un editore stampatore che, probabilmente proprio approfittando del talento linguistico e delle vaste competenze di Martinus, a partire dal 1755 cominciò pubblicare "Uitgezogte Verhandelingen" (Articoli selezionati), una rivista trimestrale che presentava al pubblico olandese traduzioni o recensioni delle migliori e più importanti pubblicazioni delle principali società scientifiche straniere. Come capo redattore Martinus Houttuyn, oltre a coordinare il lavoro degli altri collaboratori (non tutti sono stati identificati, visto che firmavano solo con l'iniziale; uno di loro però era lo zoologo Cornelius Nozeman), forniva la maggior parte delle traduzioni e anche qualche articolo originale; all'inizio si concentrò sui testi medici, ma poi allargò sempre più il suo interesse alle scienze naturali. La rivista proseguì le pubblicazioni per dieci anni, fino al 1765, quando lo stesso Houttuyn decise di mettervi fine, sia in seguito alla morte del cugino (gli ultimi numeri furono pubblicati dagli eredi - De erven van F. Houttuyn - o meglio dai tutori o dagli esecutori testamentari dei figli bambini di Frans) sia per l'ingentissimo impegno della pubblicazione di Natuurlyke Historie, di cui nel frattempo erano usciti i primi volumi. Fu certamente l'esperienza della rivista a convincere Martinus Houttuyn dell'urgenza di un'ampia trattazione enciclopedica che presentasse in lingua olandese l'intero campo delle scienze naturali a un pubblico di media cultura che non leggeva il latino. Si imbarcò così nell'impresa di descrivere animali, piante, minerali, usando come punto di riferimento la dodicesima e ultima edizione di Systema naturae di Linneo. Il primo volume di Natuurlyke Historie "Sull'uomo e alcuni mammiferi" uscì per i tipi di Frans Houttuyn nel 1761; i volumi successivi uscirono con cadenza regolare nell'arco di quasi 25 anni (il volume 37 uscì infatti nel 1785). Dopo la morte di Frans Houttuyn, avvenuta come abbiamo già detto nel 1765, la pubblicazione fu continuata dai suoi eredi, per poi essere completata dall'editore J. van der Burgh che stampò gli ultimi quattro volumi (1784-85). Come vedremo meglio più avanti, quell'opera monumentale non fu certo un successo commerciale. Per mantenere sé stesso e la famiglia, Houttuyn dovette continuare a lavorare come traduttore (tradusse tra l'altro dal francese Description des expériences de la machine aérostatique de MM. Montgolfier et celles auxquelles cette découverte a donné lieu di Barthélemy Faujas de Saint-Fond, facendolo precedere da un'ampia introduzione e arricchendolo con numerose note); continuava anche a collaborare a diverse riviste e a scrivere contributi di varia estensione e argomento. La pubblicazione di Natuurlyke Historie e il possesso di un ricco gabinetto di curiosità, che aveva creato essenzialmente come strumento di studio per la compilazione della sua enciclopedia, gli diedero una certa fama in patria e all'estero. Nel 1775 fu ammesso alla Società scientifica della Zelanda di Vlissingen e nel 1780 alla Società scientifica olandese di Haarlem. Corrispondeva regolarmente con la prima, frequentava attivamente le riunioni della seconda e collaborava alle riviste di entrambe con articoli di zoologia, botanica e mineralogia e traduzioni di articoli di scienziati stranieri (tra cui Carl Peter Thunberg, che aveva conosciuto quando questi viveva in Olanda, divenendo probabilmente uno degli sponsor del suo viaggio in Sudafrica e Giappone). Dopo la conclusione di Natuurlyke Historie, Houttuyn fu coinvolto in un'altra importante impresa editoriale: nel 1786 gli fu richiesto di continuare Nederlandsche Vogelen (Gli uccelli olandesi), rimasto incompleto per la morte dell'autore Cornelius Nozeman; sfortunatamente neppure lui poté ultimarlo; morì infatti nel 1798 senza aver concluso il compito. Il suo ricco gabinetto di curiosità era già stato venduto qualche anno prima, in due aste tenutesi rispettivamente nel 1787 e nel 1789.  Non solo "divulgatore" di Linneo Riccamente illustrata (le tavole calcografiche, di eccellente qualità, si devono a Jan Caspar e Caspar Philips) e graficamente curata, Natuurlyke Historie era un'opera di proporzioni monumentali estremamente costosa. Da questo punto di vista mancò l'obiettivo di Houttuyn di divulgare la storia naturale presso il largo pubblico, che non poteva permettersi di acquistarla e incominciava a trovare anche in lingua olandese opere molto più maneggevoli ed economiche. Incontrò invece una discreta accoglienza e giudizi positivi da parte degli addetti ai lavori. Tuttavia il fatto che fosse scritta in olandese ne limitò la diffusione al di fuori dei Paesi Bassi. Unica eccezione, la Germania, dove a partire dal 1777 ne venne pubblicata una traduzione riveduta e corretta a cura di Statius Müller per la parte zoologica e di Christmann & Panzer per quella botanica. Gli editori tedeschi, per ragioni puramente commerciali, la presentarono non come un'opera originale ma come una riedizione di Systema naturae: nel frontespizio Linneo figura come autore, mentre Houttuyn come semplice curatore: "Del cavaliere Carl von Linné Sistema naturale completo preparato secondo la dodicesima edizione e secondo le istruzioni dell'opera olandese di Houttuyn". D'altra parte, anche nel frontespizio dell'edizione olandese figurava solo il nome di Linneo e bisognava andare a cercare il nome del modestissimo Houttuyn nelle pagine interne, in calce alle prefazioni ai singoli volumi. Ciò ha fatto sì che anche oggi il naturalista olandese sia conosciuto più come divulgatore di Linneo che come studioso indipendente, contro ogni evidenza: Natuurlyke Historie comprende 21.500 pagine di testo e 296 tavole calcografiche, contro 2370 pagine e 3 tavole della dodicesima edizione di Systema naturae. Del resto, l'intento era totalmente diverso: non classificare l'intero mondo naturale in ordine gerarchico, ma illustrare approfonditamente un numero ridotto di specie significative, raccogliendo tutte le informazioni disponibili nella letteratura scientifica, se possibile integrandole con l'osservazione diretta. Così, per limitarci al regno vegetale, contro le 6000 specie elencate da Linneo e descritte con una succinta diagnosi che raramente supera le dieci parole, ecco le 275 specie esaminate da Houttuyn in capitoli che quasi sempre si dilungano per più pagine, con puntuali riferimenti e spesso citazioni della letteratura botanica contemporanea, che ci riportano al taglio enciclopedico e al sapere erudito dei naturalisti rinascimentali. Houttuyn divise il suo magnum opus in tre parti: zoologia (prima parte, 18 volumi), botanica (seconda parte, 14 volumi), mineralogia (terza parte, 5 volumi). La parte (Deel) di botanica uscì tra il 1773 e il 1783. Estesa per 8600 pagine e illustrata da 105 tavole calcografiche, presenta 275 specie, un centinaio delle quali nuove o poco note. Il primo volume inizia con una estesa trattazione dei principi generali della botanica, seguita da un profilo storico che dà ampio spazio ai sistemi di classificazione, da quello classico di Tournefort a quello recente di Michel Adanson. Si passa poi al primo gruppo di piante, le palme (anche in Linneo sono una categoria tassonomica a sé) con 12 specie. Nei volumi successivi le piante sono sì classificate nelle 24 classi linneane, ma anche raggruppate in più vaste e tradizionali categorie: ecco dunque gli alberi (vol. 2-3), gli arbusti (vol. 4-6), le erbacee (vol. 7-11), le bulbose (vol. 12), le graminacee (vol. 13) e, a concludere il tutto, le crittogame (felci, alghe, muschi e funghi). Come sappiamo dai cataloghi che Houttuyn redasse per le aste del 1787 e del 1789, lo studioso olandese possedeva un vasto erbario di piante esotiche (oggi in parte conservato pressoml'erbariomdi Ginevra); anche se egli stesso non si era mai allontanato dai Paesi Bassi, poté arricchirlo grazie a campioni raccolti da altri e in particolare da Carl Peter Thunberg, di cui, nonostante le scarse disponibilità economiche, dovette essere uno dei finanziatori se lo svedese si premurò di fargli arrivare esemplari di piante inedite dal Sudafrica, da Ceylon, dal Giappone e da Giava, spesso accompagnati da qualche nota e talvolta da un nome. Un altro dei fornitori di Houttuyn fu l'alto funzionario della VOC e botanico dilettante Jacobus Cornelius Matheus Radermacher che, oltre a fare da tramite tra Houttuyn e Thunberg (gli inviò piante giapponesi che lo svedese aveva mandato a Batavia), contribuì egli stesso con almeno due invii di piante raccolte a Giava. In Natuurlyke Historie Houttuyn propose 11 nuovi generi e circa 140 nuove specie o combinazioni. Anche se la loro pubblicazione precede le descrizioni dello stesso Thunberg o del figlio di Linneo, vista la scarsa circolazione dell'opera, poche delle sue denominazioni furono accolte dai botanici successivi. Tra i generi l'unico accettato è Reynoutria; venti invece sono le specie, e tra di esse piante notevoli come le sudafricane Massonia depressa, Ornithogalum dubium, Ixia campanulata, le giapponesi Leonuros japonicus e Reynoutria japonica, e soprattutto Myristica fragrans, l'albero che produce le noci moscate.  La pianta camaleonte La morte di Houttuyn (avvenuta, come si è detto, nel 1798), coincise con il tramonto della potenza mercantile dei Paesi Bassi e con la perdita della stessa indipendenza politica, con la trasformazione in uno dei paesi satelliti della Francia rivoluzionaria prima, napoleonica poi. Anche queste circostanze contribuirono ad offuscare la memoria del naturalista olandese, che nell'Ottocento era al massimo ricordato - come abbiamo visto, a torto - come divulgatore di Linneo. A ricordarlo è dunque rimasto soprattutto il genere Houttuynia, pubblicato da Thunberg in Flora japonica nel 1784, con una dedica laconica: "Ho imposto al genere questo nome in onore del sig. Houttuyn, olandese, botanico meritevole e dottore in medicina". Houttuynia Thunb. (famiglia Saururaceae) è un genere monospecifico rappresentato da una nota pianta da giardino, H. cordata. Originaria del sudest asiatico (e in particolare della Cina e del Giappone), è una vigorosa tappezzante amante dei terreni umidi e delle posizione ombrose. Più che per i modesti fiori bianchi, è apprezzata per le belle foglie cordate, soprattutto nella varietà 'Chameleon' (nota anche con i sinonimi 'Variegata' e Tricolor'), con vivaci variegature crema e rosso-rosate più vivide se esposta al sole. Le foglie sono aromatiche e in Giappone e in Corea sono usate secche per preparare tisane, mentre fresche sono un ingrediente della cucina vietnamita. Anche i rizomi sono eduli e sono particolarmente apprezzati nella cucina della Cina sudorientale. Talvolta i nomi botanici di piante diversissime sono così simili che si tende a confonderli. È il caso di Hottonia e Houttuynia, tanto più che la prima è una pianta acquatica e la seconda non disdegna i terreni intrisi d'acqua. La confusione è anche maggiore se guardiamo ai dedicatari: Hottonia ricorda Petrus Hotton o Hottonus, noto anche come Pieter Houttuyn, mentre Houttuynia è dedicata a Martinus Houttuyn. Entrambi olandesi, sono vissuti a circa un secolo di distanza e, a quanto risulta, non hanno alcuna parentela. In ordine di apparizione, iniziamo dunque con Petrus Hotton e la sua Hottonia.  Un botanico illustre, ma quasi dimenticato In un passo della prolusione con la quale inaugurava il corso di botanica all'università di Leida, il medico, botanico e professore universitario Petrus Hotton (1648-1709), a proposito dell'antico rizotomo Crateva, lamenta che "il tempo vorace ci invidia gli scritti degli uomini più celebri", tanto che di quell'uomo citato con elogio dai maggiori scittori antichi non rimane neppure un frammento. A Crateva Hotton doveva essere affezionato, visto che ne prese il nome quando fu eletto all'Accademia leopoldina, e, a posteriori, possiamo dire che quelle parole calzano perfettamente anche a lui. Celebre al suo tempo, anch'egli è oggi quasi dimenticato, anche se ce n'è giunta almeno qualche riga. Era figlio di Godefroy Hotton, un predicatore ugonotto di origine francese o vallona, e di sua moglie Anna Maria Ros. Non conosciamo il luogo di nascita di Hotton padre; il cognome ci riporta o alla Francia del Nord o alla Vallonia. Sappiamo invece che studiò a Heidelberg, quindi fu successivamente predicatore a Frankenthal, Aquisgrana e Brema; quando il Limburgo fu riconquistato dai Paesi Bassi, fu nominato predicatore prima delle comunità rurali poi della città di Limburgo. Intorno al 1634 si trasferì ad Amsterdam, dove divenne pastore della comunità vallona, i cui sinodi presiedette più volte. Ha lasciato una raccolta di omelie, tradotte in francese, e l'interessante De Christiana inter Europaeos Evangelicos concordia, in cui propugna la necessità di superare i contrasti tra le diverse confessioni riformate. Alla nascita del figlio Pieter (forse in famiglia sarà stato chiamato Pierre) aveva già superato la cinquantina, e il bimbo rimase orfano di padre ad appena otto anni. Della sua educazione si sarà occupata la madre, o anche la comunità vallona. In ogni caso nel 1665, a diciassette anni, lo troviamo immatricolato alla facoltà di medicina di Leida, dove nel 1672 divenne dottore in medicina con la tesi Positiones quaedam medicae. Tornò quindi ad Amsterdam dove lavorò come medico; trascorso anche qualche tempo in Danimarca, in viaggio di studio. Allievo di Arnold Syen, che probabilmente lo avviò all'uso del microscopio e orientò il suo interesse per le piante esotiche, era profondamente interessato alla botanica. Dopo la morte del maestro, fu chiamato per breve tempo (1678-1680) a insegnare botanica e dirigere l'orto botanico di Leida come supplente di Paul Hermann, che al momento si trovava ancora a Ceylon. Ritornò poi al suo lavoro medico ad Amsterdam e per qualche tempo non sappiamo nulla della sua attività come botanico. Intorno al 1684 gli fu offerta la cattedra di botanica a Groninga che rifiutò. Nel 1692 il consiglio cittadino di Amsterdam lo nominò assistente di Frederik Ruysch, che affiancava nelle lezioni di botanica farmaceutica presso l'Hortus della città (l'altro assistente era Caspar Commelin, che si occupava delle piante esotiche), con il titolo di Horti Medici botanicus. Mantenne l'incarico fino al 1696, quando, in seguito alla morte di Paul Hermann, fu nominato professore di botanica e direttore dell'orto botanico di Leida, incarico che resse fino alla morte nel 1709. Questa la sua carriera accademica. Era stimato dai suoi contemporanei, frequentava i circoli eruditi olandesi, aveva una vasta rete di corrispondenti (tra gli altri, Anton van Leeuwenhoek, John Ray, Joseph Pitton de Tournefort e gli italiani Giorgio Baglivi, Michelangelo Tilli e Giovan Battistia Trionfetti) e fu membro della Royal Society e dell'Accademia curiosorum leopoldina, nonché socio corrispondente dell'Academia delle scienze parigina. Eppure scrisse pochissimo. A parte la tesi di laurea e qualche lettera, di lui ci rimane come maggiore opera certa proprio la già citata prolusione, pronunciata il 9 maggio 1695 al momento di assumere la cattedra di botanica a Leida. Intitolata Sermo accademicus quo rei Herbariae historia et fata adumbrantur, nella prima parte è una sintetica storia della botanica, dagli antichi fino ai contemporanei che dimostra di conoscere bene, nella seconda un elogio della botanica e delle sue "magnifiche sorti e progressive". È datato marzo 1701 il suo unico contributo alle "Transactions della Royal society", De acemella et ejus facultate lithontriptica, sotto forma di lettera in cui presenta una pianta i cui semi era giunti da Ceylon all'orto botanico di Amsterdam nel 1691 (oggi Acmella paniculata, un'annuale con proprietà mediche e insetticide). Hotton conosceva bene e ammirava l'opera di Rumphius e del suo predecessore Hermann ed era entusiasta dalle prospettive mediche, farmaceutiche, economiche delle piante esotiche che sempre più copiose giungevano dai quattro angoli del mondo agli orti botanici di Leida e Amsterdam, e scambiava volentieri i loro semi con i suoi corrispondenti. Coltivava però anche interessi teorici e tassonomici e tra tutti i botanici contemporanei ammirava in massimo grado John Ray, di cui curò l'edizione olandese di Methodus plantarum emendata et aucta, rifiutata dagli editori britannici. L'interesse per la tassonomia è confermato da Hermann Boerhaave, suo allievo e successore, che ne traccia un commosso elogio nella breve storia dell'orto botanico di Leida inclusa nella sua seconda edizione del catalogo del giardino (Index alter plantarum quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, 1719). Secondo la sua testimonianza, Hotton avrebbe elaborato un proprio metodo (che egli definisce "Syntaxis herbaria perfectissima") che, pur movendo dalla lezione di Pitton de Tornefort, la integrava con una profonda conoscenza della letteratura botanica. Uomo prudente e metodico, secondo Boerhaave Hotton si muoveva con lentezza, tutto esaminando e considerando, senza fermarsi alla prima impressione. Con tanta lentezza che, ucciso a soli sessant'anni dal freddissimo inverno del 1709, non poté né completare né pubblicare il proprio metodo "con sommo detrimento della botanica". Qualche mese dopo la sua morte la sua vasta biblioteca fu messa all'asta. Contava più di 4000 volumi; oltre metà era costituita da testi di medicina ed anatomia, ma erano ricchissime anche le sezioni di scienze naturali e botanica, dove non sembra mancare nessuna opera significativa; la presenza di opere costosissime come Hortus eystettensis o i tredici volumi di Hortus malabaricus attesta poi una notevole disponibilità economica. Ma la biblioteca di Hotton non si limitava a quella che potremmo considerare letteratura professionale; troviamo infatti copiose sezioni di filosofia (ma all'epoca sotto questa etichetta finivano anche la fisica, l'astronomia, la matematica e la chimica), teologia, diritto, lessicografia, poesia e storia, che ci parlano di un uomo colto e di vasti e variegati interessi. Nonché poliglotta (sempre che quei libri li abbia letti davvero): la maggior parte delle opere è ovviamente scritta in latino (all'epoca ancora la lingua universale della scienza e della cultura), ma, tra le lingue moderne, oltre all'olandese e al francese (che, viste le origini familiari, forse era la sua lingua madre) non mancano testi in italiano (compresa la Gerusalemme liberata di Tasso e le opere complete di Machiavelli), inglese e tedesco. Quasi trent'anni dopo la morte di Hotton, proprio in Germania e in lingua tedesca uscì un'opera postuma attribuita al botanico olandese. Al piede del frontespizio di Thesaurus phytologicus, pubblicato a Norimberga nel 1738, leggiamo infatti: "di Petrus Hotton, dottore in medicina e prefetto dell'orto botanico dell'Università di Leida". Come chiarisce il chilometrico sottotitolo, è un Kräuterbuch, un erbario farmaceutico, che offre ai lettori la descrizione dettagliata e le "strane qualità, virtù ed eccellenti capacità" delle erbe medicinali provenienti dalle quattro parti del mondo, ma specialmente dall'Europa, con il modo più sicuro di usarle, rivolgendosi non solo a medici e farmacisti, ma anche a guaritori, giardinieri, padri di famiglia, casalinghe e "quei malati che vivono in campagna". Insomma, quanto di più divulgativo possibile, e anche quanto di più lontano dall'immagine di Hotton prudente, lento e metodico autore di una perfettissima Synthaxis herbaria presentatoci da Boerhaave. Più che a Ray o Tournefort e agli altri tassonomisti ammirati da Hotton, l'opera sembra guardare alla tradizione rinascimentale, se non medievale, dei Kräuterbücher, anche se rinnovata con l'inserimento di qualche esotica, come il tabacco e il caffé, con le piante elencate in ordine alfabetico e l'unica divisione in erbacee (prima parte) e arboree o arbustive (seconda parte). Che l'abbia scritta davvero Hotton non è affatto certo; come ipotizza Wijnands, egli potrebbe essere il responsabile dei soli indici, latino e tedesco; in tal caso, il suo nome in copertina è una semplice operazione pubblicitaria dei disinvolti editori-stampatori Johan Leonhard Buggel e Johann Seitz.  Piante acquatiche in pericolo Il nostro è talvolta noto con il nome olandesizzato Pieter Houttuyn, ma si firmò sempre Petrus Hotton o alla latina Hottonus. E come tale Boerhaave gli rese omaggio con la dedica del genere Hottonia, accompagnata da parole commosse: "È giusto affidare con animo pio la memoria, a me sacra, dell'uomo illustre Petrus Hotton, mio predecessore, a tutti coloro che amano e coltivano la sapienza, la virtù e la botanica. Fu infatti egli stesso quanto mai illustre in tutte queste cose. Sottratto ai loro occhi, possano i Mani percepire che sopravvive il grato ricordo di un uomo buono ed insigne". Il genere fu recepito da Linneo fin da Hortus Cliffortianus e poi ufficializzato in Species plantarum. Questo piccolo genere della famiglia Primulaceae comprende solo due specie di piante acquatiche: l'europea ed asiatica H. palustris e la nord americana H. inflata. Chiamata volgarmente violetta d'acqua per i fiori bianchi sfumati di lilla, H. palustris è l'unica primulacea completamente acquatica della nostra flora. Cresce principalmente sommersa, con fusti verde pallido che immettono ad intervalli regolari lunghe radici bianco-argentee che fluttuano nell'acqua e si radicano nel fango del fondo. Le foglie lineari, anch'esse sommerse, si dispongono a pettine su verticilli molto ravvicinati; tra maggio e giugno, emerge dall'acqua lo scapo florale eretto, alto da 20 a 40 cm, che reca un'infiorescenza con verticilli sovrapposti di 3-9 fiori; piuttosto grandi e vistosi, hanno corolle con breve tubo e cinque lobi fusi alla base, da bianche a lilla, con una macchia gialla alla fauce. È presente prevalentemente nell'Europa centrale e settentrionale e ai margini dell'area mediterranea, con colonie disgiunte in Siberia. Vive in acque stagnanti, poco profonde e povere di sostanze nutritive; ovunque è minacciata dalla riduzione dell'habitat naturale, dal drenaggio e dall'eutrofizzazione delle acque. Altro fattore negativo è la distanza tra le diverse colonie, che spesso sono formate da cloni della medesima pianta; in assenza di impollinazione incrociata, garantita da bombi, api o sirfidi, H. palustris può autofecondarsi, ma tende a produrre pochi semi. In Italia è rara e presente occasionalmente nelle regioni centro-settentrionali; è inclusa nella liste delle piante a protezione assoluta delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. È in corso un progetto di reintroduzione in alcune aree piemontesi promosso da A.Di.P.A. Piemonte, che al momento incontra difficoltà per i danni provocati dalle nutrie o castorini. H. palustris è talvolta coltivata come pianta da acquario. Per quest'uso è più frequente la specie americana H. inflata, che sopporta temperature più elevate, essendo originaria degli Stati Uniti sudorientali. Ha fiori minuscoli portati al sommo di una rachide rigonfia, da cui l'epiteto; a differenza della specie europea, che come abbiamo visto è può essere impollinata da vari insetti, è probilmente esclusivamente autogama, con conseguente impoverimento della varietà genetica. Anch'essa è fortemente minacciata dalla distruzione di gran parte dei suoi habitat storici. Si spera tuttavia che, con la reintroduzione dei castori negli Stati uniti orientali, possa esserci una ripresa anche per H. inflata che trova il suo habitat di elezione negli stagni di castori, caratterizzati da acque poco profonde con un livello di acqua costante. Si ritiene anche che i castori, raccogliendo per loro tane il fango di fondo che ne contiene i semi, ne facilitino la dispersione. Nel 1626, poco dopo essersi insediata a Batavia, di fronte alle malattie e alle epidemie che decimavano i suoi uomini nelle Indie orientali, la VOC decise di inviare in Indonesia un medico capo che coordinasse tutto il settore saniatario. La scelta cadde su Jacob de Bondt (Jacobus Bontius). Prima di cadere vittima egli stesso delle malattie che affliggevano la colonia olandese, lavorò a Giava per appena quattro anni, molto fruttuosi per le sue ricerche sulle malattie tropicali e sulla storia naturale dell'isola. Lo si ricorda soprattutto per aver descritto per primo malattie come il beriberi e la framboesia e animali come il rinoceronte di Giava e l'orango. Plumier e Linneo gli dedicarono il genere montipico Bontia, che però, dalle Indie orientali, ci porta in quelle occidentali.  Un medico olandese nell'insalubre Batavia Nel 1619 la Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC) prende il controllo della regione di Jayakarta, nel settentrione dell'isola di Giava, e sulle rovine dell'antica capitale edifica un insediamento fortificato che da quel momento ospiterà il suo quartier generale. All'inizio del 1621, con una solenne cerimonia, viene battezzato Batavia (in ricordo dei Batavi, l'antica tribù che abitava l'Olanda all'epoca romana, in cui gli olandesi riconoscono i propri antenati). Per la sua posizione, Batavia era perfetta per essere il centro amministrativo, mercantile e militare della VOC, ma pessima dal punto di vista sanitario. È stato calcolato che nel periodo che va dalla fondazione al 1739 ogni anno tra 500 e 700 dipendenti della Compagnia vi soccombessero di tifo, malaria, dissenteria, beriberi e altre malattie; la cifra si accrebbe drammaticamente dopo questa data, con 2000-3000 perdite annue. Inizialmente l'assistenza sanitaria fu affidata ai chirurghi di bordo delle navi della Compagnia e furono anche inviati alcuni medici nelle stazioni commerciali più grandi, ma nel 1626 i "17 signori" (ovvero la direzione della VOC) decisero di inviare a Batavia un medico capo che dirigesse e coordinasse tutto il settore. La scelta cadde su Jacob de Bondt (o alla latina Jacobus Bontius, 1592-1631). Bondt aveva tutte le carte in regola per assolvere pienamente il compito di medico, farmacista e ispettore dei chirurghi delle Indie orientali. Laureato in medicina all'università di Leida nel 1614, apparteneva a una famiglia di medici e docenti universitari. Suo padre Geraert de Bondt (Gerardus Bontius) fu il primo professore di medicina, matematica e astronomia dell'ateneo, e dal 1587 fu il primo titolare della cattedra di anatomia e botanica, cui nel 1598 si aggiunse la direzione dell'orto botanico. Celebre per la sua erudizione, dell'università di Leida fu anche rettore. Tre dei suoi quattro figli maschi, Reiner, Johannes e Jacob, furono medici. Il maggiore Reiner (o Reynerius Bontius) fu a sua volta professore di medicina e rettore dell'Università di Leida, nonché medico personale di Maurizio d'Orange. Il quarto fratello Willem era invece un giurista ed ebbe ruoli pubblici, incluso quello di borgomastro di Leida e si rese celebre, più che per le sue posizioni religiose ostili ai rimostranti, per aver inscenato un solenne funerale del suo cane che causò grave scandalo. Ma ciò avvenne alcuni anni dopo la morte del nostro Jacob. Quest'ultimo era il più giovane degli otto figli (c'erano anche quattro sorelle) del professor Geraert, e accettò con entusiasmo la proposta dei 17 signori, deluso delle sue prospettive di carriera in patria e convinto che un soggiorno di qualche anno nelle Indie gli avrebbe aperto la strada di una cattedra universitaria. Era talmente fiducioso di questo brillante futuro che decise di portare con sè in Indonesia la moglie e i due figli bambini. Nel marzo 1627 la famiglia Bondt si imbarcò per Giava; sulla stessa nave viaggiava in incognito, a sua volta accompagnato dalla moglie, da un figlio neonato e da altri parenti, il governatore generale delle Indie olandesi Jan Pieterszoon Coen. Bondt portava con sè anche la sua biblioteca di oltre 2000 volumi. Durante il viaggio, che si protrasse fino al 13 settembre, la moglie di Bondt morì. Era il primo dei lutti che avrebbero funestato l'avventura del medico nelle Indie olandesi. Risposatosi poco dopo l'arrivo a Batavia, nel giugno 1630 perse anche la seconda moglie, morta di colera; all'inizio del 1631, fu la volta del figlio maggiore, morto di una malattia infantile (forse morbillo). La menzione della morte di amici e conoscenti punteggia le sue opere ed egli stesso, soprattutto durante i due assedi di Batavia del 1628 e del 1629, si ammalò gravemente e per due volte fu in punto di morte. Indebolito nel corpo e nello spirito, si spense infine a soli 39 anni il 30 novembre 1631. I compiti professionali affidati a Bondt erano gravosi: come medico capo, doveva soprasiedere all'ospedale di Batavia, verificare l'equipaggiamento medico delle navi della Compagnia, ispezionare l'attività di medici e chirurghi (è possibile che a tal fine abbia fatto un viaggio di ispezione nelle Molucche e a Timor), praticare autopsie, prestare assistenza medica ai dirigenti della VOC, a cominciare dal governatore Coen (questi morì di colera durante il secondo assedio di Batavia, e Bondt nella sua opera ne descrive la malattia e la morte). Inoltre durante i due assedi fu nominato membro della corte di giustizia, nel 1630 fu advocaat fiscal e dal 1630 alla morte balivo di Batavia. Nonostante tutti questi impegni, la cattiva salute e i lutti, dedicò moltissimo tempo a investigare la medicina e la natura delle Indie olandesi, con fini sia medici sia più generali. Poco dopo il suo arrivo a Batavia, scrisse a uno dei suoi fratelli: "Mi sto applicando per raggiungere non solo la conoscenza delle erbe che crescono qui a Giava, ma soprattutto per acquisire un'idea più perfetta delle spezie di cui la nostra parte del paese è più fruttuosa". Immediatamente dopo la conclusione del secondo assedio di Batavia (maggio-settembre 1629), completò Methodus Medendi qua in Indiis Orientalibus oportet in cui descrisse 19 malattie del ventre, del torace e della pelle comuni nelle Indie ma sconosciute nei Paesi Bassi, tra cui il beriberi e la framboesia. Dimostrò anche grande ammirazione per i guaritori locali, in particolare per la loro abilità nel curare la dissenteria e altre affezioni intestinali. Ne fece i suoi informatori per conoscere le virtù delle erbe medicinali, nelle quali riconosceva il rimedio sovrano: "Dove le malattie sono endemiche, la mano generosa della natura ha piantato a profusione erbe le cui virtù sono adatte a contrastarle". Nella dedicatoria a Methodus Medendi, dedicato ai 17 signori, egli afferma di star componendo un'opera sulla storia naturale della regione e quando sarà finita promette "un commento sugli alberi, arbusti ed erbe che crescono a Giava". Lamenta anche che la malattia, che lo ha bloccato per quattro mesi gli abbia impedito di "viaggiare nel paese per esplorare liberamente le deliziose foreste di Giava e acquisire una conoscenza esatta delle erbe più nobili che vi vivono". Per scrivere quest'opera, da tempo doveva aver cominciato a raccogliere note di campo e disegni. Nel gennaio 1631 Bondt completò una seconda opera, De conservanda valetudine; si tratta di un dialogo sul modo migliore per conservare la salute nel clima difficile delle Indie, ispirato ai Coloquios dos simples e drogas da India di Garcia da Orta, che Bondt conosceva grazie all'edizione di Clusius. Gli interlocutori sono lo stesso Bondt (Bontius) e Duraeus, ovvero lo scozzese Andrew Durie, capo chirurgo del Castello e più tardi del secondo ospedale di Batavia. Fu compagno di escursioni di Bondt che lo definisce "chirurgus expertissimus". Subito dopo aver completato questo breve lavoro, in cui in vari punti si discosta da Garcia da Orta, Bondt ne analizzò più compiutamente l'opera in Animadversiones in Garciam da Orta, in cui, secondo Cook, "offre gentili correttivi e supplementi all'opera di da Orta"; al suo predecessore si ispira come metodo, ma aggiunge molte informazoni di prima mano. Così descrive Assa foetida che il portoghese conosce solo di nome e a proposto del rinoceronte che da Orta confessa di non aver mai visto, Bondt scrive: "Non solo l'ho visto un centinaio di volte nascosto nelle sue tane, ma anche mentre vaga nella foresta", per poi raccontare un incontro alquanto pauroso. Era un assaggio della quarta e ultima opera di Bondt, quella sulla storia naturale di Giava, che considerava il suo compito principale ma non riuscì a completare a causa della morte. Più di dieci anni dopo la sua scomparsa, i tre saggi completati, preceduti dalla dedicatoria a mo' di prefazione, andarono a costituire De medicina Indorum (Leida, 1642). pubblicata a cura del fratello Willem. Più tardi. non sappiamo per quali vie, il manoscritto dell'incompleta storia naturale pervenne a Willem Piso, che decise di pubblicarlo nella sua De Indiae Utriusque re naturali et medica (Amsterdam, 1658). L'opera di Bondt ne costituisce la seconda parte, Historia naturalis et medica Indiae orientalis, in sei libri; i primi quattro sono una riedizione di De medicina indorum, il quinto ("De quadrupedibus, avibus et piscibus") e il sesto ("De plantis et aromatibus") sono tratti dal manoscritto inedito. Gli animali presentati sono 33 e le piante 62. Cook, che ha riscoperto ed esaminato il manoscritto originale, conservato tra le carte appartenute al collezionista William Sherard, ha constatato che esso contiene le descrizioni, senza ordine apparente, di 16 animali e 42 piante; molte sono accompagnate da illustrazioni, note e commenti. Presumibilmente c'era un secondo volume, oggi perduto. Confrontando il manoscritto con il testo a stampa, risulta che Piso ha dato un ordine ai materiali, ha ritoccato il latino, aggiunto poemi introduttivi e informazioni occasionali, e anche introdotto qualche argomento nuovo, basandosi su informazioni ricevute da persone che erano state nelle Indie dopo Bondt. Insomma, si comportò da editor relativamente rispettoso, come abbiamo già visto per i materiali sulla flora e la fauna brasiliane ricavati da Marcgraf. Stando alle lettere di Bondt. un certo numero di immagini dovettero essere disegnate da un suo cugino, Adriaen Minten. Altre da lui stesso, ricorrendo al metodo dell'imprinting (cioè ricalcando l'impronta del soggetto). Tra quelle di animali, alcune sono notevoli. Non solo troviamo la prima immagine credibile del rinoceronte di Giava (Rhinoceros sondaicus), diverso da quello indiano, ma anche un babirussa di Sulawesi, una tigre vista presumibilmente a Bali, e persino un dodo, non ancora estinto quando il medico, in viaggio per l'Indonesia, fece scalo a Mauritius. L'immagine più intrigante è però quella dell'organo, che chiaramente Bondt non aveva mai visto di persona, ma di cui aveva sentito parlare dai locali in termini più o meno favolosi come di un "uomo dei boschi" forse persino dotato di parola. E come un uomo selvatico è raffigurato, non sappiamo per iniziativa di chi (forse di Piso o dell'editore Elzevir). Quanto alle piante, quelle descritte sono quasi tutte medicinali, più qualcuna culinaria, per le quali Bondt raccolse informazioni da donne locali. C'è anche un capitolo sul tè e le sue virtù medicinali, ma non un'immagine, perché Bondt lo conosceva solo nella forma essiccata che era commercializzata a Giava e le informazioni che aveva raccolto da più parti, tra cui Jacques Specx, che prima di essere nominato governatore generale aveva vissuto in Giappone, erano contraddittorie.  Un olivo... americano Si deve nuovamente a Plumier la dedica a Bondt di uno dei suoi generi americani, Bontia, poi fatto proprio da Linneo. Molto sobriamente, Plumier lo ricorda come "medico ordinario" della città di Batavia a Giava e come autore dei sei libri di Historia naturalis et medica Indiae orientalis, pubblicati da Piso. Egli scrive anche di conoscere una sola specie di questo genere. Ed è così anche oggi. Bontia (Scrophulariaceae) è infatti un genere monospecifico, il cui unico rappresentante è B. daphnoides, un arbusto o piccolo albero che cresce nella maggior parte delle isole dei Caraibi e lungo le coste del Venezuela e della Guyana, soprattutto nei boschi di mangrovie. Ha foglie coriacee, ellittiche, con accentuata nervatura sulla faccia inferiore, che possono ricordare quelle del genere Daphne (da qui l'eponimo), cosparse di ghiandole oleose. Ma forse l'allusiome è all'olivo, come farebbero pensare alcuni nomi volgari, come wild olive (Barbados) olivier bord de mer (Martinica) o aceituna americana (Cuba), che fanno riferimento non alle foglie, ma ai frutti, drupe grossolanamente sferiche dapprima verdi poi nere a maturazione. Curiosi i fiori, che sbocciano solitari all'ascella delle foglie. Retti da un lungo picciolo, hanno cinque sepali verdi appuntiti a forma d'uovo e cinque petali uniti alla base a formare un lungo tubo bruno-giallastro ricoperto da numerose ghiandole che poi si apre in due lobi diseguali diffusi e retroflessi. Essendo piuttosto ramificato e sempreverde, nei Caraibi è spesso utilizzato come frangivento e per siepi difensive; è stato introdotto in Florida e alle Hawaii. Decotti delle foglie sono utilizzati nella medicina tradizionale per curare varie affezione e le ricerche ne hanno confermato le proprietà antivirali, All'inizio dell'orto botanico di Leida c'è una coppia a cui il vezzo di darsi nomi latini ha donato nomi quasi identici: il prefetto Charles de l'Ecluse, che si firmava Carolus Clusius, e l'hortulanus Dirck Outgaertz. Cluyt che si firmava Theodorus Clutius. La formidabile coppia Clusius-Clutius (la mente e la mano) collaborò in amicizia, stima e armonia per pochi anni, poiché il più giovane dei due, il farmacista Clutius, morì precocemente. A succedergli avrebbe potuto essere suo figlio Outgert (alla latina Augerius Clutius), ma era troppo giovane e privo di titoli accademici; così gli amministratori dell'università gli preferirono un medico titolato. Egli non se ne adontò; viaggiò, si laureò, e divenne cacciatore di piante a beneficio del giardino creato da suo padre. Quando tornò in Olanda, esercitò la medicina ad Amsterdam e scrisse alcuni curiosi opuscoli, che gli hanno guadagnato la dedica del genere Clutia da parte della coppia Boerhaave-Linneo.  Primo atto: il padre In un'epoca in cui era consueto che i figli facessero lo stesso mestiere del padre e in cui le cariche tendenzialmente si ereditavano, anche nella storia della botanica è consueto trovare coppie di padre-figlio: rimanendo al periodo tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in questo blog abbiamo già incontrato i due John Tradescant, i due Jacob Bobart, Jean e Vespasien Robin, Il caso di Dirck e Outger Cluyt potrebbe essere simile, se dal padre il secondo, più che un incarico, non avesse ereditato un'ostilità. Quando nell'autunno del 1593, dopo un lungo corteggiamento, Clusius arrivò finalmente a Leida, era gravemente infortunato (oltre che attempato per l'epoca, con i suoi 67 anni) e gli era impossibile occuparsi fisicamente della creazione dell'orto botanico universitario. Chiese di essere assistito da un sostituto, che con sua grande soddisfazione venne individuato nella persona del farmacista Dirck Ougaertsz. Cluyt (1546-1598), che alla latina si firmava Theodorus Clutius, con la curiosa conseguenza che i nomi latini dei due fondatori dell'orto botanico di Leida differiscono solo per una lettera (Clusius/ Clutius). Cluyt/Clutius era un amico di vecchia data, con il quale Clusius da tempo corrispondeva e scambiava semi e bulbi, soprattutto di tulipani, la maggiore passione di entrambi. Era nato ad Haarlem, dove visse e gestì la propria farmacia finché l'occupazione spagnola lo costrinse a lasciare la città natale. Nel 1578 si trasferì a Delft, dove aprì una farmacia all'insegna del melograno 'De Granaetappel'. Era così famosa che L'Obel non mancò di visitarla alla ricerca di piante rare, citando con lode il proprietario nel suo Kruidboek. Cluyt era il farmacista di fiducia di Pieter van Foreest (Petrus Forestus), il medico personale di Guglielmo d'Orange; quando il 10 luglio 1584 questi fu assassinato e van Foreest dovette imbalsamarne il cadavere, gli affidò la preparazione degli ingredienti. Come molti farmacisti dell'epoca, possedeva un giardino o hortus medicus. Il suo però si distingueva da quelli dei colleghi sia per le ampie dimensioni (si trovava dietro le cinque case che il prospero farmacista possedeva sul Rietveld) che gli permettevano di coltivare alberi da frutto e tenere alveari, sia perché, oltre alle erbe medicinali necessarie alla sua professione, vi coltivava molte piante rare, tra cui numerose bulbose. Come Clusius, anche se ovviamente in dimensioni minori, anche Cluyt faceva parte di una rete internazionale di appassionati che si scambiavano piante, bulbi, semi; e uno dei suoi corrispondenti era appunto Clusius che lo cita più volte come "il dotto e meticoloso farmacista di Delft". La sua reputazione come esperto di piante rare era tale che, quando si incominciò a cercare una persona cui affidare la direzione del costruendo orto botanico dell'Università di Leida, già nel dicembre 1591 venne fatto il suo nome. Tuttavia i reggenti dell'Università respinsero la proposta, perché, come farmacista (all'epoca si formavano come apprendisti presso la bottega di un maestro), gli mancava la laurea accademica. La scelta, come già sappiamo, cadde su Clusius, che con la sua fama europea poteva garantire proprio ciò che il neonato ateneo olandese cercava: il prestigio di un grande nome. L'incarico del botanico fiammingo era più che altro onorifico: egli si era assicurato di non avere compiti di insegnamento (che detestava), di poter continuare a studiare, di avere un proprio giardino; ma oltre al suo immenso prestigio, portava con sé la sua favolosa collezioni di piante rare. Le sue pessime condizioni di salute costrinsero il senato accademico a una mossa forse inizialmente imprevista: affiancare al praefectus Clusius, il responsabile scientifico, l'hortulanus Clutius, che avrebbe provveduto alla creazione materiale e alla gestione del giardino (la bipartizione praefectus/ hortulanus esiste ancora oggi, sia a Leida sia ad Amsterdam). Clutius venne nominato l'8 maggio 1594, con uno stipendio di 400 fiorini all'anno e l'uso di una casa; in cambio, si impegnò a trasferire a Leida tutte le piante che coltivava a Delft. Egli si mise immediatamente all'opera e nell'arco di quattro mesi l'impianto dell'orto botanico era completato; nell'inverno ne disegnò la mappa che nel febbraio 1595 consegnò personalmente ai curatori dell'Università con l'elenco delle 1585 specie o varietà (un documento per noi preziosissimo, che tra il 1987 e il 1999 ha permesso di ricostruire il giardino di Clusius/ Clutius come si presentava al tempo dei fondatori). Seguirono però anche amarezze e delusioni: la casa promessa non era ancora pronta e non gli era stato pagato nulla per la sua preziosa collezione di piante, che valutava 1500 fiorini. Alla fine ne ottenne solo 100 per le spese di trasloco e 400 per le piante. Come ho anticipato, Clusius non aveva incarichi di insegnamento; la cattedra teorica di materia medica era tenuta da Gerard Bontius (Geraert de Bondt), il professore di anatomia al quale nel 1587, all'atto ufficiale di fondazione dell'orto botanico, era stato assegnato anche l'insegnamento della botanica; anche nel contratto di Cluyt non erano previsti compiti didattici, ma di fatto, proprio come Bobart il Giovane a Oxford e più tardi Vespasien Robin a Parigi, affiancava il professore come dimostratore: d'inverno insegnava agli studenti a riconoscere le piante usando il suo erbario personale di 4000 exsiccata e "sei libri di piante e fiori di ogni tipo dipinte dal vero"; d'estate accompagnava gli studenti in visite guidate del giardino e in escursioni botaniche nei dintorni. Nonostante tutti questi impegni, nei pochi anni che gli restavano da vivere (morì improvvisamente nel 1598, a soli 52 anni) riuscì anche a completare la sua unica opera, Van de Byen, hare wonderlicke oorsprong "Sulle api e la loro meravigliosa origine", un trattatello sull'allevamento delle api sotto forma di dialogo tra Clusius e Clutius, in cui emerge l'affiatamento e l'amicizia tra praefectus e hortulanus. I due forse sono rappresentati nell'incisione del frontespizio, dove si vedono due signori elegantemente vestiti in amichevole conversazione mentre osservano le arnie. Una curiosità: in onore di entrambi, una ditta olandese produce un idromele battezzato Clutius & Clusius. La morte di Dirck Cluyt, che aveva vent'anni meno di lui ed era in tutto il suo braccio destro, fu un gravissimo colpo per Clusius che lasciò l'incarico di prefetto e da quel momento si concentrò nella scrittura delle sue opere, anche se continuò a contribuire all'arricchimento delle collezioni del giardino con le novità che riceveva della sua vastissima rete di corrispondenti. 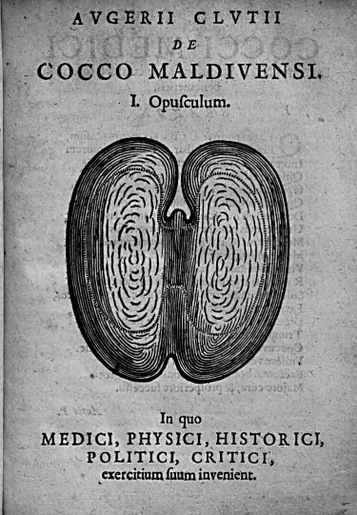 Secondo atto: il figlio A questo punto, ci si potrebbe aspettare, secondo la prassi del tempo, che a Dirk Cluyt succedesse come hortulanus, o addirittura come praefectus, il figlio maggiore Outgert (che nelle sue opere però si firmò sempre, alla latina Augerius Clutius, 1578-1636). Per lo meno, era quanto si aspettavano i diciassette studenti di medicina che nel giugno 1598 indirizzarono agli Amministratori una petizione per chiedere che gli fosse ufficialmente assegnato l'incarico di dimostrare le piante; lo definivano "un giovane esperto e preparato" e ricordavano che da tempo affiancava il padre ed era l'unico a conoscere bene il giardino e gli strumenti didattici che egli aveva messo a punto; se fosse stato nominato prefetto, avrebbe potuto aprire il giardino agli studenti almeno un'ora al giorno e dimostrare piante e minerali due volte la settimana. Gli amministratori decisero diversamente: senza consultare Clusius, nominarono direttore dell'orto botanico Bontius, affiancato da Pieter Pauw (Petrus Pavius) come professore straordinario. Erano medici e laureati, mentre il giovane Clutius era solo uno studente ventunenne senza alcun titolo. Augerius non la prese troppo male; fino al 1601, completò gli studi di artes all'università di Leida, alla quale si era iscritto nel 1594, quando la famigli si era trasferita da Delft; poi si spostò a Montpellier, dove Richer de Belleval aveva da poco fondato il Jardin du roi. Qui si laureò in medicina e divenne una specie di assistente ufficioso di Belleval, che accompagnava nelle escursioni botaniche e sostituiva all'occasione nell'insegnamento quando il professore era lontano o malato. Poi per diversi anni viaggiò: oltre che in Francia e in Germania, fu in Italia, dove visitò tra l'altro gli orti botanici di Padova e Firenze; passò poi in Spagna e da qui in Nord Africa, sempre raccogliendo materiali vegetali che inviava a Leida al professor Pauw che nel 1599 era succeduto a Bontius come praefectus. Particolarmente avventurosi furono i suoi viaggi "nel deserto della Barbaria" dove fu più volte rapinato. Rientrò in Olanda nel 1607; sembra che i responsabili dell'orto botanico di Leida lo abbiano ripagato abbastanza generosamente per le raccolte, ma nonostante l'esperienza maturata, i contatti internazionali e le considerevoli raccolte, a Leida continuava a non esserci un posto per lui; perciò si stabilì ad Amsterdam dove divenne un medico piuttosto reputato. Nel 1618 lo troviamo tra i firmatari di una petizione che chiedeva l'istituzione di un hortus medicus (Medicinale Cruythoff) - la richiesta non fu presa in considerazione e il futuro orto botanico nacque solo nel 1638, quando Clutius era già morto; più tardi (1635) fu uno dei membri della commissione incaricata di redigere una farmacopea ufficiale, presieduta da Nicolaes Tulp (il medico ritratto da Rembrandt nella famosa "Lezione di anatomia"). Oltre che di medicina (nel 1627 pubblicò un opuscolo sui calcoli renali) continuava ad interessarsi di botanica e, come il padre, di entomologia. Nel 1631 pubblicò Memorie der vreemder blom-bollen, wortelen, kruyden, planten, struycken, zaden ende vruchten ("Memoria per indicare il modo corretto di imballare e trasportare bulbose da fiore, radici, erbe, piante, alberi, semi e frutti"), tra le prime ad affrontare questo importante argomento. Nel 1634 fu la volta di Opuscula duo singularia, che raggruppa due opuscoli di argomento molto diverso, accomunati da un certo sfoggio di erudizione: De hemerobio e De nuce medica. Il primo è di argomento entomologico ed è dedicato alle effimere, in cui Clutius riconosce l'hemerobius di Aristotele. Il secondo esamina le proprietà medicinali del cocco delle Maldive Lodoicea maldivica (di cui presenta forse l'immagine a stampa più antica). Che a questa rarità, di cui non si conosceva l'origine, venissero attribuite anche proprietà mediche (come antiveleno e afrodisiaco), non stupisce. Le noci, originarie delle Seychelles, ma spinte dalle correnti marine a grandi distanze, erano oggetto di un intenso commercio, vendute per cifre altissime e esibite tra gli oggetti più preziosi delle Wunderkammer. Il testo di Clutius dipende in gran parte da Garcia da Orta, attraverso la traduzione di Clusius in Exoticorum libri decem; ma fornisce anche molte preziose informazioni sulle vie di rifornimento dei prodotti medici e delle rarità provenienti delle Indie orientali; un ruolo ancora importante di mediazione era svolto da membri della comunità sefardita oriundi della penisola iberica, che mantenevano contatti con l'India attraverso il Portogallo; ma ormai in quel mercato si era inserita attivamente la Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC): tra i suoi informatori, Clutius cita Jacobus Bontius (figlio del prefetto di Leida Gerard), medico della VOC a Batavia e autore di Historiae naturalis et medicae Indiae orientalis. Tra i fortunati possessori di questa esotica rarità cita anche John Tradescant che nella sua Arca possedeva "una noce tagliata a metà".  Un genere africano con proprietà medicinali Misurando i meriti botanici di padre e figlio, la palma sembrerebbe spettare al padre; invece fu del figlio che si ricordò Hermann Boerhaave nel catalogo dell'orto botanico di Leida, creando il genere Clutia "al cui nome è affidata la memoria di Augerius Clutius". La denominazione fu poi ripresa e ufficializzata da Linneo in Species plantarum. Si potrebbe pensare che la "dimenticanza" di Boerhaave rifletta un resto della diffidenza accademica verso il non titolato farmacista Dirck Cluyt. Il genere Clutia (Peraceae, in precedenza Euforbiaceae) comprende una cinquantina di specie di alberi, arbusti e erbacee perenni; il centro di diversità è il Sudafrica, ma il genere si estende a est fino alla Repubblica democratica del Congo e a Nord fino alla penisola arabica. Per lo più dioiche, hanno foglie semplici, intere e alternate e fiori raccolti in glomeruli ascellari, quelli femminili spesso solitari. Gli uni come gli altri hanno cinque sepali e cinque petali distinti e imbricati, ma quelli maschili sono caratterizzati da un disco con ghiandole in tre serie sui sepali, i petali e il ricettacolo, quelli femminili da sepali e petali persistenti nel frutto. L'ovario triloculare con un ovolo per loculo è seguito da un frutto che si apre in cocci con tre o due valve. Diverse specie di questo genere hanno usi medici tradizionali. Il decotto di foglie e giovani ramoscelli di C. lanceolata (una delle due specie che, dal Corno d'Africa, raggiungono la Penisola arabica) è utilizzato come antidiarroico; proprietà simili sono attribuite a C. abyssinica, C. hirsuta e C. pulchella. La decozione di radici C. abyssinica in Congo è usata per trattare febbri e malattie da raffreddamento, mentre in Africa orientale le radici vengono fatte bollire per ottenere una specie di zuppa usata per trattare problemi di fegato, la milza ingrossata, le cefalee, i disturbi dello stomaco e la malaria. Gli usi medici della pianta differiscono da un gruppo etnico all'altro; le ricerche chimiche e mediche hanno rilevato potenzialità antipiretiche, analgesiche e antinfiammatorie, ma sono ancora a uno stadio preliminare. Ad avere usi medici tradizionali, che differiscono da un'area all'altra, sono molte altre specie, compresa C. pulchella, che ha anche usi ornamentali. L'interesse non sta nei fiori, piccolissimi, ma nel fogliame verde-azzurro, intervallato qua e là da foglie arancio brillante. Sono morbide, punteggiate di ghiandole, e con nervature trasparenti alla luce. Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola. Nel Seicento, la lontana Danzica diventa uno snodo centrale del commercio olandese con la Polonia, la Prussia orientale e la Russia. Nella città casciuba si stabilisce una fiorente colonia di mercanti olandesi che commerciano, tra l'altro, la cocciniglia polacca, all'epoca ancora abbondante anche se sta già subendo la concorrenza della meno costosa cocciniglia messicana. Proprio a questo piccolo insetto deve la sua fortuna il ricchissimo mercante Jacob Breyne, che unisce all'abilità negli affari una sfrenata passione per le piante: quelle di casa, che studia e raccoglie nei suoi erbari, e quelle esotiche, che, trasportate dalle navi delle compagnie olandesi, l'EIC e la VOC, dai quattro angoli del mondo, si riversano sempre più numerose negli orti botanici di Leida e Amsterdam e nei "paradisi" (ovvero i giardini privati) dei magnati della giovane Repubblica delle province unite. In occasione dei ricorrenti viaggi nel paese d'origine della sua famiglia, Breyne li visita, osserva e annota le novità, e si porta a casa quello che può, ad arricchire il suo stesso "paradiso". Alle esotiche dedica non meno di tre libri, il primo dei quali, curatissimo nella veste editoriale e nell'apparato iconografico, affidato a pittori e incisori di vaglia, è un capolavoro dell'editoria botanica secentesca. Con questi libri, anticipando tutti, è spesso il primo a far conoscere novità sudafricane destinate a grande fortuna, come Pelargonium, Agapanthus, Mesembrianthemum. E' bravo anche a stabilire rapporti umani, creando una vasta rete di contatti che negli ultimi anni della sua vita si estende anche alla nuova potenza coloniale (e orticola) emergente: l'Inghilterra. Insieme al giardino, alla biblioteca, alle collezioni naturalistiche, la lascia in eredità al figlio Johann Philipp, che la allargherà ulteriormente e diventerà un membro riconosciuto dell'establishment scientifico internazionale. A ricordare entrambi, il loro splendido giardino e le loro opere che fecero conoscere tante piante rare, il genere Breynia (Phyllantaceae). 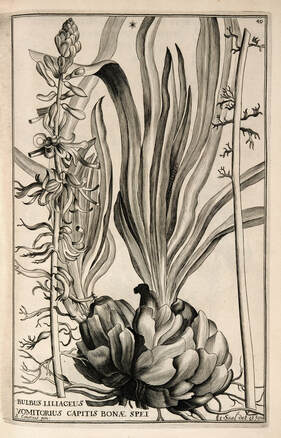 Un mercante olandese a Danzica Nel Seicento, la Repubblica delle Province unite aveva forti legami commerciali con Danzica, all'epoca il maggiore porto del Baltico, oltre che una città cosmopolita appartenente al Regno di Polonia ma con una forte presenza tedesca. I mercanti olandesi commerciavano soprattutto granaglie e l'apprezzatissimo colorante rosso ricavato dalla cocciniglia polacca, Porphyrophora polonica. La città casciuba era una piazza così importante che spesso, invece di avvalersi di agenti locali, per seguire gli affari sul posto vi mandavano un figlio cadetto. Questo destino toccò anche a Jacob Breyne senior, membro di una famiglia di mercanti che dal Brabante si era trasferita nei Paesi Bassi nel 1585, in seguito all'assedio di Anversa. A Danzica Jacob fece fortuna trasportando a Amsterdam e Leida piante medicinali e cocciniglia; si sposò con Anna Moorman, anch'essa appartenente a una famiglia di origine olandese, e nel 1637 ne ebbe un figlio: è il nostro Jacob Breyne (1637-1697), il primo protagonista di questa storia. Grazie alle buone disponibilità finanziarie del padre, egli ricevette un'ottima educazione e incominciò presto a interessarsi di scienze naturali, che del resto erano anche un ferro del mestiere per chi commerciava merci ricavate da animali e piante. Uno dei suoi professori al ginnasio accademico, Christian Mentzel, che vi insegnò dal 1648 al 1650, lo coinvolse nelle sue ricerche sulla flora locale, insegnandogli le tecniche per predisporre un erbario. All'inizio degli anni '50, il padre lo inviò a Leida da suo fratello Pieter per imparare le tecniche commerciali; Jacob junior ne approfittò per seguire le lezioni di botanica di Adolf Vortsius (1624-1663), prefetto dell'orto botanico, nelle cui aiuole egli incontrò la passione della sua vita: le piante esotiche. Dotato di un gran talento per i rapporti umani, strinse amicizie durevoli sia nell'ambiente universitario sia tra i ricchi possidenti che nei loro giardini (Paul Hermann li chiamò giustamente "paradisi") facevano a gara a coltivare le specie più rare e nuove portate ad Amsterdam dalle navi delle due compagnie olandesi, l'EIC (Compagnia olandese delle Indie occidentali) e la VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali). Alla morte del padre nel 1655, Jacob Breyne si stabilì definitamente a Danzica, ma mantenne i contatti con l'Olanda, che visitava periodicamente. Allargò il giro d'affari della famiglia, estendendolo anche all'Inghilterra. Senza però dimenticare la passione per le scienze naturali: nella sua bella casa nella centralissima via Długa creò una notevole collezione di naturalia e una fornitissima biblioteca; in una delle sue proprietà (non ne conosciamo l'ubicazione) creò anche un orto botanico privato, ispirato ai paradisi che tanto aveva ammirato nei Paesi Bassi. Riprese anche a esplorare la flora locale; all'inizio, doveva essere poco più di un passatempo. Visitava i dintorni della città e sistemava le piante che veniva raccogliendo in un erbario con i nomi in olandese e talvolta qualche annotazione sull'aspetto generale; era una specie di diario botanico privato che chiamava Herbarium vivum (la copia che ci è giunta risale al 1659). Ma negli anni '70, con una situazione economica ormai orientata al bello stabile, poté dedicare più tempo alla botanica e concepire due progetti paralleli e complementari: da una parte esplorare e fare conoscere la flora locale, dall'altra documentare le novità esotiche introdotte nei giardini europei dagli olandesi. Complementari perché, per i naturalisti del Seicento, la flora della Casciubia e della Prussia orientale era non meno esotica e inesplorata di quella sudamericana, sudafricana o indonesiana. Avvalendosi probabilmente anche di una rete di informatori e raccoglitori, nel 1673 Breyne creò un secondo, assai più ambizioso erbario, Plantes rariores borussicae et casubicae ("Piante più rare della Prussia e della Casciubia"), un corposo manoscritto in quattro volumi con i nomi e le annotazioni in latino. Con i duplicati, ne creò anche un certo numero di copie, dal contenuto variabile, che inviava come dono a protettori, amici e corrispondenti; il più importante era sicuramente l'influente uomo politico Hieronymus van Beverningh, che fu anche curatore dell'università di Leida, città nei cui dintorni possedeva uno dei più spettacolari "paradisi" della Repubblica. Nel 1697, l'anno stesso della morte di Breyne, una copia raggiunse anche James Petiver, con il quale il mercante corrispondeva da qualche anno e dal quale aveva ottenuto semi di varie piante nordamericane coltivate a Chelsea. Pur vivendo in un luogo apparentemente periferico, Breyne riuscì infatti ad inserirsi brillantemente nella grande rete dei naturalisti europei che scambiavano disegni, fogli di erbario, semi, tuberi e bulbi di piante esotiche, potendo anche approfittare dei legami commerciali della sua famiglia con l'EIC e la VOC. In cambio di esemplari dell'altrettanto esotica flora della Polonia settentrionale, riceveva materiali e preziose informazioni dai quattro angoli dell'impero olandese. Tra gli agenti della VOC con cui fu in contatto, vale la pena di citare almeno Willem ten Rhijne, medico delle VOC a Dejima tra il 1674 e il 1676, e Paul Hermann, che prima di diventare prefetto dell'orto botanico di Leida, aveva visitato Ceylon e il Capo di Buona Speranza. Dai suoi periodici viaggi in Olanda, durante i quali non mancava mai di informarsi sulle novità orticole e di visitare i più bei giardini, Breyne riportò anche l'attrezzatura per creare una propria tipografia, alla quale nel 1677-78 affidò la stampa di Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima, un corposo e curatissimo in folio con splendide illustrazioni dovute ai migliori artisti locali, tra cui il pittore Andreas (o Andrzej) Stech e l'incisore Isaak Steel. Il libro, dedicato a Hieronymus van Beverningh, contiene la presentazione in latino di cento piante, una ventina delle quali raccolte da lui stesso nella Polonia settentrionale, le altre osservate nei giardini olandesi o segnalate dai suoi corrispondenti; tra le prime Geum rivale, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla patens, Saxifraga hirculus. Le seconde sono quasi un'epitome dei traffici olandesi nel secolo d'oro: ci sono parecchie americane, giunte dal Suriname ma anche da altre parti del centro e sud America, come la splendida Caesalpinia pulcherrima (che Breyne chiama Crista pavonis, cresta di pavone), Asclepias curassavica e Jatropha multifida; da Ceylon o da Giava arrivano Gomphrena globosa, Clitoria ternatera L., Hibiscus rosa-sinensis (Breyne lo chiama Alcea javanica arborescens flore pleno, a segnalare che gli olandesi l'hanno incontrato a Giava, in una forma coltivata e stradoppia) e una delle piante che da Breyne prenderanno il nome, Frutex indicus baccifer vitis ideae secundae clusii foliis, oggi Breynia vitis-idaea; grazie a Willem ten Rhijne, dal Giappone abbiamo la canfora (Cinnamomum camphora) e la prima rappresentazione a stampa del tè The Sinensum, sive Tsia japonensibus (Camellia sinensis). Ma a fare la parte del leone è il Sudafrica, grazie allo stesso ten Rhijne ma soprattutto alle raccolte di Paul Hermann: ecco la oggi assai nota Leonotis leonurus, i primi pelargoni, Pelargonium triste e P. lacerum, parecchie Aizoaceae tra cui Cylindrophyllum calamiforme, che campeggia in un elegante vaso al centro del frontespizio, la prima Proteacea Protea conifera, la prima Restionacea Restio dichotomus. E poi ancora le bulbose Wachendorfia paniculata, Drimia elata, Oxalis purpurea, e quello che Linneo chiamò in suo onore Tulipa breyniana, oggi Moraea collina. In appendice Breyne pubblicò un trattatello sul tè scritto dal caro amico (così lo definisce, summus amicus meus) Willem ten Rhijne. Breyne sperava di pubblicare una seconda centuria; nel 1680 ne diede un'anticipazione in Prodromus fasciculi rariorum plantarum, dedicato alle piante esotiche osservate - in occasione di un viaggio del 1670 - nell'orto botanico di Leida e nei giardini di Beverningh e altri appassionati, incluso Jan Commelin, futuro commissario dell'Orto botanico di Amsterdam; nel 1689 ne pubblicò una seconda edizione, Prodromus fasciculti rariorum plantarum secundus, che include le piante viste nel viaggio in Olanda dell'estate di quello stesso anno; qui Breyne aveva potuto tra l'altro incontrare il giardiniere Georg Meister, di ritorno da Batavia e dal Giappone, che gli consegnò un pacco di esemplari inviati da Andreas Cleyer. Ad assisterlo nella pubblicazione fu il figlio Johann Philipp che all'epoca aveva solo nove anni. Sono opere di minor impegno rispetto alla Centuria prima: in entrambi i casi, si tratta una lista di piante in ordine alfabetico, priva di illustrazioni, con una descrizione sintetica e l'indicazione di dove le vide e se poté averne semi o talee. Le sudafricane anche qui hanno il primato, con l'arrivo di Agapanthus e Mesembrynathemum; da segnalare anche la pubblicazione della prima Nepenthes, raccolta da Hermann a Ceylon: Breyne le conservò il nome locale Bandura zingelensium, Linneo la ribattezzò Nepenthes distillatoria. In effetti, dato che Paradisus batavus di Hermann (anch'esso un resoconto delle piante esotiche coltivate nei grandi giardini olandesi) poté essere pubblicato postumo solo nel 1695, in qualche modo Breyne gli soffiò la primogenitura: sono spesso i suoi libri, pubblicati nella periferica Danzica, ad aver fatto conoscere a botanici e appassionati europei le piante esotiche introdotte dagli olandesi. 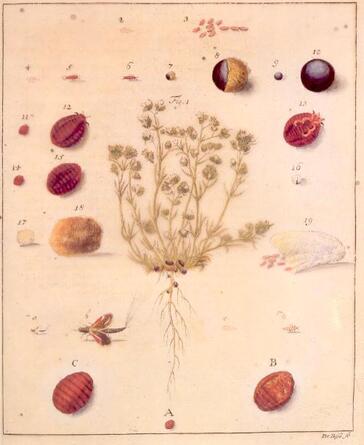 Talis pater, talis filius Breyne non riuscì mai a scrivere la progettata seconda centuria; inoltre, come confidò in una lettera all'amico Petiver e come sappiamo anche dalla testimonianza del figlio, avrebbe voluto scrivere una flora della Casciubia e della Prussia orientale, ma ne fu impedito da una penosa malattia e dalla morte, sopraggiunta nel gennaio del 1697, pochi giorni dopo il suo sessantesimo compleanno. Lasciava idealmente il compito in eredità al figlio minore Johann Philipp (1680-1764), che, come abbiamo visto, fin da bambino aveva coinvolto nei suoi progetti. Alla morte del padre Johann Philipp era un ragazzo di sedici anni. Qualche anno dopo, secondo le consuetudini familiari, anch'egli fu inviato a Leida; non però per avviarlo alla mercatura (di questo si occupava il fratello maggiore), ma per seguire i corsi di medicina del grande Hermann Boerhaave. Ottenuta la laurea di primo livello nel 1699 e quella magistrale nel 1702, munito delle lettere di presentazione dei suoi professori intraprese un grand tour scientifico attraverso l'Europa. La prima lunga tappa fu Londra, dove si trattenne per nove mesi, ospite del corrispondente del padre James Petiver, che gli fece conoscere Ray e Sloane, grazie al quale egli fu introdotto alla Royal Society, di cui divenne membro nel 1703. Fu poi la volta dell'Italia dove studiò la fauna marina nei dintorni di Ancona e visitò Padova, ospite di Vallisneri. Il viaggio proseguì attraverso Austria, Boemia e Germania, per concludersi nei Paesi Bassi, da dove rientrò a Danzica nel 1704. In una lettera del 1705 all'amico Petiver, dichiara di aver l'intenzione di riprendere e completare entrambi i progetti paterni. In realtà, per almeno venticinque anni, durante i quali esercitò con successo la professione medica, il proposito fu accantonato. Non però la passione per il giardino e le collezioni. Nel 1707 investì la dote della moglie Constantia Ludewig nell'acquisto di una casa e di un vasto giardino nel sobborgo di Brabank, dove poté sistemare le collezioni paterne che continuò ad arricchire per tutta la vita; oltre agli erbari, ai compendi di botanica, alle matrici delle opere del padre, c'erano monete, illustrazioni naturalistiche e a stampa (incluse le opere di Maria Sibylla Merian), minerali, fossili, pietre preziose o meno, ambre, preparati anatomici umani e animali conservati in formalina. Il giardino era così celebre che nel 1717 fu visitato dallo zar Pietro il Grande. Dalle testimonianze dell'epoca, sappiamo che c'erano una grotta, fontane, statue a grandezza naturale di Flora e Apollo, piante medicinali e molte esotiche: ananas, acacie, oleandri, fichi, ma anche banani, alberi di canfora, caffè e cannella. Ben noto negli ambienti scientifici europei anche grazie ai suoi viaggi, oltre che della Royal Society era membro della Leopoldina, e corrispondeva con oltre 170 scienziati, tra i quali, oltre al già citato Sloane, Leibnitz, Bernard de Jussieu, Peter Collinson e lo stesso Linneo. La corrispondenza con gli altri naturalisti europei era anche un modo per mantenere viva la fiamma della scienza in un ambiente che giudicava, se non ostile, poco interessato: "Per quanto mi riguarda, sono confinato in questo angolo d'Europa dove alla gente interessano solo i soldi", si sfogò con Hans Sloane. Alcune sue comunicazioni comparvero sporadicamente anche in precedenza sulle Transactions della Royal Society, ma l'attività scientifica occupò il centro della sua vita solo dopo il 1730, quando (anche in seguito alla morte del fratello che lo lasciò unico erede della fortuna familiare) si ritirò a vita privata. Tuttavia non scrisse mai né la seconda centuria né la progettata flora della Cascubia e della Prussia. Si accontentò di pubblicare una nuova edizione dei due fascicoli del Prodromus (1739), dandole però una splendida veste editoriale con eccellenti incisioni; in appendice vi pose una biografia del padre scritta da G. D. Seyler e un trattato sul ginseng, in origine la sua tesi di laurea. Le altre opere, per lo più brevi opuscoli usciti tra il 1730 e il 1740, dimostrano l'ecclettismo ma anche la mancanza di sistematicità dei suoi interessi: scrisse delle piante e degli insetti che aveva osservato sulla costa spagnola durante uno scalo del suo viaggio alla volta dell'Italia, del cosiddetto agnello vegetale o barometz, della cocciniglia polacca cui la sua famiglia doveva la propria ricchezza, di una foglia preistorica racchiusa nell'ambra, di alcuni tipi di molluschi fossili, delle ossa e dei denti di mammut scoperti in Siberia da un altro dei suoi amici, il conterraneo Daniel Gottlieb Messerschmidt. Come si vede, la paleontologia finì per occupare un posto importante nelle sue ricerche. Dalla moglie ebbe ben otto figli, ma tutti i maschi morirono bambini o in giovane età. In una commovente lettera a Linneo, confessa di essere vecchio e malato e provato dalla morte dell'unico maschio superstite, morto a ventiquattro anni nel 1740. Gli rimanevano invece quattro figlie, tre delle quali coltivarono gli interessi naturalistici di famiglia in uno dei pochi modi concessi all'epoca alle donne (escluse anche dalla lingua della scienza, il latino): la pittura. Saper danzare, strimpellare un clavicembalo e dipingere alla meno peggio un acquarello faceva parte dell'educazione delle fanciulle di buona famiglia, ma per Constantia Philippina (1708-?), Anna Renata (1713-1759), Johanna Henrietta (1714-1797) Breyne, cresciute praticamente in un museo naturalistico dove potevano ammirare le opere di grandi illustratori e in uno dei giardini botanici privati più belli d'Europa, dipingere piante e animali fu qualcosa di più di un passatempo. Nelle collezioni del castello di Gotha sono conservati molti loro disegni e acquerelli, caratterizzati da un livello di esecuzione notevole per delle dilettanti. Ciascuna di loro si specializzò in un capo preciso: i disegni di piante e uccelli si devono per lo più a Anna Renata (che era anche poetessa e musicista) e in parte a Constantia Philippina; Johanna Henrietta si dedicò alle immagini di animali marini. In almeno un caso, abbiamo la prova che i disegni di piante, presi dal vivo nello splendido giardino, erano destinati a illustrare le opere del padre. Furono utilizzati anche da almeno uno dei naturalisti che frequentavano casa Breyne, Jacob Theodor Klein. Impegnato anche nella creazione della prima società naturalistica polacca, Breyne fece della sua casa-museo un luogo di incontro dei naturalisti e ne incoraggiò l'attività, finanziando tra l'altro la pubblicazione della Flora quasimodogenita di Georg Andreas Helwing, di cui scrisse anche la prefazione. Johann Philipp Breyne morì nel 1764. Due anni dopo gran parte delle sue collezioni fu acquistata dagli agenti di Caterina II e finì nella Kunst Kamera imperiale di San Pietroburgo. Quasi tutti i manoscritti dei due Breyne, le lettere e i disegni rimasero però a Danzica fino alla morte dell'ultima delle sue figlie (1797); due anni dopo furono acquistati da Ernesto II di Sassonia-Gotha.  Un albero dalle foglie rosa Nonostante vivessero in una città tanto periferica, le opere e le attività di padre e figlio erano ben note ai naturalisti europei, con i quali, come abbiamo visto, i due si mantennero in assiduo contatto epistolare. Il primo a voler celebrare Breyne padre fu Plumier che ne ammirava grandemente la Centuria prima per la nitidezza dei caratteri tipografici, l'eccellenza delle incisioni e il contributo alla conoscenza di tante nuove piante. Ma nel dedicargli il genere Breynia il buon frate incorse anche in una fake news: chissà attraverso quali fonti, gli era giunta la notizia che quella Centuria fosse la sola superstite di parecchie, ma "delle quali, oh, dolore!, ne sopravvive una sola prima e ultima; tutte le altre furono distrutte dalle fiamme inique, come riferiscono, di un incendio fortuito che distrusse la casa e le opere. Ma l'opera di un tale uomo e la sua memoria tra gli uomini per bene e i botanici né le fiamme né le onde potranno farle perire". Linneo fece propria la denominazione e la ufficializzo in Species plantarum, nel 1753. Senza considerare che il nome non era più disponibile (all'epoca non c'erano ancora regole fisse) nel 1776 i Forster dedicarono ad entrambi i Breyne un secondo genere Breynia con una motivazione che ben testimonia la reputazione dei due naturalisti di Danzica: "In onore dei sommi botanici Jacob Breyne e suo figlio Johann Philipp Breyne, dottore in medicina, entrambi i quali coltivavano piante esotiche in un giardino di Danzica e molte le pubblicarono disegnate con grande arte e descritte con ingegno immortale". Benché il nome linneano preceda quello dei Forster, quest'ultimo è considerato nomen conservandum ("nome da conservare") perché comprende almeno una specie piuttosto coltivata e diverse specie alquanto diffuse nell'Asia meridionale e orientale. Breynia J.R.Forst. & G.Forst. (famiglia Phyllanthaceae) è comunque un genere dalla tassonomia travagliata, che minaccia prima o poi di confluire in Phyllanthus, Al momento attuale comprende, a seconda delle fonti, da 25-30 specie a oltre 90. Sono alberi o arbusti monoici diffusi nell'Asia tropicale, in Australia e nelle isole del Pacifico. Come abbiamo visto, una specie indiana e indocinese, Breynia vitis-idaea, fu descritta per la prima volta proprio da Jacob Breyne. La specie più nota è Breynia disticha, nativa della Nuova Caledonia e delle Vanuatu. Conosciuta con il nome comune "albero della neve", è coltivata nei giardini delle zone a clima mite per le foglie, rosa nella forma giovanile, poi crema o verde chiaro. Alcune specie di questo genere, tra cui proprio B. vitis-idaea, sono anche studiate dai biologi come esempio di mutualismo e coevoluzione con alcune falene del genere Epicephala, che impollinano i fiori, assicurando così la produzione di semi vitali, ma depongono anche le loro uova nell'ovario; i semi potrebbero essere distrutti dalle larve, se nonché in alcuni frutti esse abortiscono e non riescono a svilupparsi. Questo meccanismo è stato paragonato al mutualismo obbligato tra il fico e le sue vespe impollinatrici. Tra gli amici olandesi di Linneo, Johannes Burman merita un posto speciale: quasi suo coetaneo, fu il primo a fare la sua conoscenza e il primo a garantirgli un lavoro e ad ospitarlo a casa sua. Ma la loro amicizia non fu senza ombre: nacque con il piede sbagliato e poi si interruppe a lungo, per un motivo che oggi a noi pare futile. Poi ricominciò e non mancarono i riconoscimenti reciproci: Burman fu tra i primi ad adottare le denominazioni linneane e a utilizzare il suo sistema nelle aiuole didattiche dell'orto botanico di Amsterdam; si spinse fino a mandare suo figlio a studiare in Svezia (dopo che per generazioni gli aspiranti medici e botanici svedesi avevano fatto il contrario). Linneo gli riconobbe giustamente il merito di aver dato alle stampe ricerche e opere che senza di lui rischiavano l'oblio. Oltre a dedicargli Bibliotheca botanica (che senza la biblioteca di Burman non sarebbe mai stata scritta) lo ricordò con il curioso genere Burmannia.  Antefatti: successi e disavventure del giovane Linneo Nel 1733, il ventiseienne Linneo trascorse le vacanze di Natale a Falun, ospite della famiglia di uno dei suoi amici e allievi, Claes Sohlberg. Il padre era ispettore minerario e gli fece conoscere un giovane teologo appassionato di scienze naturali, Johannes Browallius, che a sua volta lo introdusse presso il governatore della Dalarna, Niels Reuterholm, dei cui figli era precettore. Reuterholm fu così colpito dal racconto della spedizione di Linneo in Lapponia da commissionargliene una analoga nella Dalarna settentrionale. Il viaggio sarebbe avvenuto nell’estate successiva, quando Linneo percorse oltre ottocento km in compagnia di sette dei suoi migliori studenti. A Falun egli incontrò anche l'amore, nelle vesti di Sara Lisa Moraea, la figlia diciassettenne del medico cittadino Johan Moraeus; quando la chiese in sposa, il dottore fu chiaro: prima di poter parlare di matrimonio, il giovanotto doveva essere nelle condizioni di mantenere la famiglia, quindi doveva laurearsi, e per farlo (all’epoca nessuna università svedese conferiva la laurea in medicina) doveva andare all’estero. D’altra parte, la situazione a Uppsala per Linneo si era fatta difficile. Egli era privo sia di mezzi sia di titoli accademici e doveva la sua posizione di simil-assistente al favore del suo maestro, Olaus Rudebeck il Giovane. Quando era ancora uno studente del secondo anno, quest'ultimo lo aveva accolto a casa sua e lo aveva nominato dimostratore di botanica. Linneo era un insegnante nato e le sue lezioni suscitarono l'entusiasmo degli studenti e l'invidia dei suoi detrattori. Il più accanito era Nils Rosén (1706-1773), che prima dell'arrivo di Linneo era stato l'assistente di Rudbeck che l'aveva spedito in Olanda a laurearsi. Dopo aver studiato per quattro anni a Leida con grandissimi maestri, questo giovane medico brillante (che più tardi sarebbe stato salutato come padre della medicina pediatrica), al suo rientro in patria nel novembre 1731 scoprì che il "cuculo Linneo" aveva occupato il suo nido; inizialmente, fece buon viso a cattivo gioco: come assistente dell'altro professore di medicina, Lars Roberg, tenne le letture di anatomia e medicina pratica e seguì anche le lezioni di botanica del suo rivale. Ma contemporaneamente, cercò di scalzarlo dal suo incarico. Infine, nel 1734 riuscì a convincere il senato accademico a vietargli di fare lezione, in quanto privo di laurea. Colmo di rabbia, Linneo l'assalì spada alla mano; fu trattenuto dagli amici e la cosa finì lì, ma le autorità accademiche furono costrette a espellerlo dalla città. Insomma, era ora di cambiare aria. Così, quando Sohlberg padre gli propose di accompagnare il figlio in un viaggio di studio in Olanda, non esitò ad accettare. Nei bagagli, mise i manoscritti delle sue opere, il tamburo e il costume lappone, e nell’aprile 1735 partì insieme a Claes. In programma, aveva non solo di laurearsi, ma di far conoscere il suo sistema in Europa.  Un'amicizia nata con il piede sbagliato Via Amburgo - dove Linneo aveva trovato modo di suscitare le ire del borgomastro, come ho raccontato in questo post - i due amici arrivarono ad Amsterdam il 2 giugno. Immediatamente Linneo, cui non mancava la faccia tosta, andò a presentarsi a Johannes Burman (1706-1779) che, sebbene avesse solo un anno più di lui, da quattro anni era già professore di botanica e direttore dell'orto botanico. Intendeva mostrargli le sue opere, in particolare quella che diventerà Systema naturae, convinto che l'avrebbe conquistato all'istante. Arrogante e pieno di sé, lasciò invece a Burman una pessima impressione. La seconda tappa olandese di Linneo fu Harderwijk, un diplomificio che concedeva la laurea con notevole facilità. Per sbrigare le formalità e presentare la tesi (ce l’aveva già pronta in valigia) gli bastarono due settimane. Il 23 giugno fu proclamato dottore. Subito dopo, andò a Leida dove visitò l’orto botanico e seguì qualche lezione; i soldi stavano rapidamente finendo e stava per rassegnarsi a tornare in Svezia quando incontrò Jan Frederik Gronovius. Anche a lui mostrò Systema naturae e Gronovius ne fu così entusiasta da finanziarne la pubblicazione. Inoltre lo presentò all'illustre professor Boerhaave; ormai anziano e malato, dopo aver diretto per più di vent'anni l'orto botanico di Leida e aver formato generazioni di medici (incluso Burman) si era ormai ritirato, ma continuava ad esercitare un'autorità indiscussa e a riunire intorno a sé un circolo di studiosi più giovani. Linneo gli fece visita più volte nella sua bella casa di campagna Oud Poelgeest, affascinò anche lui con il racconto delle sue imprese lapponi e ne ottenne una lettera di presentazione per Johannes Burman. Munito di credenziali tanto indiscutibili, circa un mese dopo la prima sfortunata visita, Linneo si presentò di nuovo alla porta di Burman che pensò che forse era stato precipitoso a giudicarlo male; lo mise alla prova chiedendogli di identificare una pianta difficile. Sì, lo svedese di piante si intendeva davvero. Era l’assistente di cui aveva bisogno per completare il suo libro sulla flora di Ceylon: Burman, l'astro nascente della botanica olandese, era infatti impegnato nella prima delle sue imprese editoriali: la pubblicazione dell'erbario singalese di Hermann. Per sei settimane, i due nuovi amici lavorarono fianco a fianco nella fornitissima biblioteca del colto e facoltoso Burman, che abitava in una bella casa affacciata sul prestigioso Keizersgracht. Linneo vi poté attingere liberamente per Biblioteca botanica e Fundamenta botanica e in cambio diede un valido aiuto per identificare, catalogare e descrivere le piante singalesi. Il 13 agosto i due si concessero una gita fuori porta: Burman portò Linneo a visitare De Hartekamp, forse il più bel giardino d'Olanda, di proprietà del ricchissimo George Clifford. Come ho raccontato in questo post, fu così che Linneo trovò un nuovo protettore e Burman accettò di separarsi da lui in cambio di una copia di History of Jamaica di Hans Sloane. Alla fine di settembre Linneo si trasferì a Hartekamp e Burman dovette continuare il lavoro da solo (ma le sue visite a Hartekamp erano frequenti e la corrispondenza fitta) e a settembre terminò la redazione di Thesaurus zeylanicus (pubblicato all’inizio del 1737) in cui descrisse alcune centinaia di piante, elencate in ordine alfabetico e illustrate con 110 calcografie. In un'appendice pubblicò anche i cataloghi delle specie raccolte in Sud Africa da Hermann e da Oldenland e Hartog, raccoglitori dell'orto botanico della VOC a Table Bay. A questo punto, come scrisse a Linneo, lo attendeva un compito che considerava un dovere morale: dare finalmente alle stampe l’Herbarium amboinense di Eberhard Rumphius. Un’impresa enorme, considerando che il grande cieco di Ambon aveva descritto e in gran parte disegnato non meno di 1200 specie. Il primo ostacolo fu convincere la VOC a consegnargli il manoscritto e permettergli di pubblicarlo: l'ubicazione delle piantagioni era un segreto di stato. Più difficile ancora trovare un editore e tanto meno incisori non troppo esosi. Nel 1736 Linneo si sdebitò dedicando Bibliotheca botanica al "celeberrimo e espertissimo dr. Johannes Burman, professore di botanica dell'organizzatissimo orto botanico di Amsterdam"; fu ancora suo ospite prima di lasciare definitivamente l'Olanda nel 1737. Spiace dire che poco dopo i contatti tra i due si interruppero. Sembra che Burman fosse arrabbiato con Linneo (che aveva ospitato, mantenuto e introdotto negli ambienti scientifici) perché non gli aveva mai inviato le piante lapponi che gli aveva promesso. Per circa quindici anni, i due permalosi botanici non si scrissero più, finché riallacciarono i contatti intorno al 1753 (il fatidico anno di uscita di Species Plantarum). Anche per Burman erano stati anni pieni. Nell'attesa di poter mettere mano a Herbarium amboinense, scrisse un libro sulle piante sudafricane, Rariorum Africanarum Plantarum, basato soprattutto sulla collezione di Nicolaes Witsen, un altro collezionista e magnate della VOC. Nel 1739, trovato finalmente un editore disposto a correre il rischio, si accinse all'edizione di Herbarium amboinense, un lavoro che lo avrebbe impegnato per sedici anni: il primo volume uscì nel 1741, seguito da altri cinque a intervalli variabili fino al 1750, con un’appendice (Auctarium) nel 1755. Ricordo che, passato attraverso vicende incredibili, il grande libro di Rumphius, a causa della cecità di quest'ultimo, era stato un gran parte dettato in olandese a diversi collaboratori che non conoscevano il latino; quindi Burman dovette tradurlo e dargli una veste linguistica omogenea. Tra il 1755 e il 1760 fu la volta di Plantarum Americanarum, basato sul manoscritto inedito e sui disegni di Charles Plumier. La sua ultima fatica fu un rifacimento dell’indice di Hortus malabaricus con i nomi linneani (1768). Nel 1755 Burman aveva aggiunto ai suoi doveri l'insegnamento della botanica all'Atenaeum illustre e aveva ormai ripreso a corrispondere regolarmente con Linneo, con reciproco giovamento anche per le collezioni degli orti botanici di Uppsala e Amsterdam. Nel 1760 - una scelta che ha il valore di un passaggio di testimone - decise di mandare a studiare a Uppsala suo figlio Nicolaas Laurens (1734-1793), l’unico allievo olandese di Linneo. Egli avrebbe seguito le orme del padre, pubblicando un’opera generale sulla flora tropicale, Flora Indica, e la monografia Specimen botanicum de geraniis. I due Burman divennero in un certo modo i custodi e diffusori dell'opera di Linneo nei Paesi Bassi: furono tra i primi ad aderire alla nomenclatura e al sistema linneano, Johannes a partire dall’appendice di Herbarium amboinense, Nicolaas Laurens per tutte le sue opere; per loro impulso, le aiuole didattiche dell’orto botanico di Amsterdam furono risistemate seguendo il sistema del grande svedese. E come Johannes aveva lanciato la carriera di Linneo, trentacinque anni dopo padre e figlio furono i protettori e i mecenati di Carl Peter Thunberg, cui procurarono l'ingaggio come medico della VOC che gli avrebbe permesso di diventare il padre della botanica sudafricana e giapponese.  Un genere tropicale per uno specialista di tropicali Johannes Burman è dunque un tipico "botanico da scrivania" il cui grande merito non sta né nelle ricerche sul campo né nell'originalità del pensiero, ma nell'aver messo in circolazioni ricerche e opere altrui che rischiavano di andare sepolte nell'infinito cimitero dei capolavori della botanica mai stampati. Botanico rigoroso con un'ottima preparazione filologica e un'eccellente conoscenza del mondo editoriale, era uno specialista di piante esotiche, quelle stesse che l'orto botanico di Amsterdam, da lui egregiamente diretto per quasi quarant'anni, contribuì più di ogni altro ad acclimatare e diffondere in giardini e piantagioni. Oltre a dedicargli Bibliotheca botanica, già in Hortus Cliffortianus Linneo aveva istituito in suo onore il genere Burmannia, proprio in riconoscimento (e in auspicio) dei suoi meriti editoriali: aver dato alle stampe «con sommo studio e dottrina non mediocre» la prima flora di Ceylon e accingersi a fare lo stesso con l’immenso Herbarium amboinicum, un’impresa che, se gli fosse riuscita, gli avrebbe guadagnato la riconoscenza di tutti i botanici. Linneo avrebbe poi confermato il genere in Species Plantarum; Burmannia dà il nome a una famiglia propria (Burmanniaceae), di cui è il genere più cospicuo; comprende una sessantina di piante erbacee, diffuse nelle aree tropicali e subtropicali tutti i continenti, con massima area di diversità tra Asia sud-orientale e Australia. Di collocazione tassonomica incerta (un tempo era avvicinato alle orchidee, ora si pensa sia più prossimo alle Dioscoreales), sono monocotiledoni con foglie a rosetta e curiosi fiori con i tepali disposti su due giri, quelli esterni più grandi e vistosi, quelli esterni spesso ridotti e minuscoli. Alcune specie sono fotosintetiche, altre sono saprofite che traggono nutrimento delle micorrize di alcuni funghi; queste ultime sono dunque prive di clorofilla e hanno foglie ridotte a scaglie: è un adattamento ai terreni molto poveri e umidi in cui vivono. Qualche approfondimento nella scheda. Nel Seicento, l'Olanda vive il suo secolo d'oro. E' il paese più prospero d'Europa, all’avanguardia nei commerci, nelle scienze, nella cultura, nell’arte. E nei giardini: gli olandesi, sfruttando la loro secolare esperienza nel sottrarre terra al mare, ridisegnano la natura e creano un nuovo modello di giardino, in cui le siepi sagomate dalle forbici dei giardinieri disegnano stanze, padiglioni, teatri di verzura. A differenza del giardino all’italiana, in cui il verde domina, il giardino barocco olandese è colmo di fiori, con parterre multicolori simili ai tappeti persiani tanto amati da Vermeer o Rembrandt. Molti mercanti che si sono arricchiti con i traffici o le industrie investono il loro denaro in tenute di campagna che spesso ospitano vasti giardini, uno status symbol del loro potere e della loro ricchezza. Non possono mancare collezioni di piante esotiche: sono alla base della prosperità dell'Olanda e sono anche il simbolo del suo dominio sul mondo, il segno tangibile di quel nuovo Eden, paradiso in terra ricostruito, che per qualche decennio i Paesi Bassi si illudono di essere. E così non è un caso se Paul Hermann, il più importante botanico olandese del secolo, battezza Paradisus batavus, "Paradiso olandese", il suo libro dedicato alle rarità coltivate in quei giardini. Rarità che molto ha contribuito a introdurre in Europa, prima come esploratore del Capo di Buona Speranza e dell'isola di Ceylon, poi come direttore dell'Orto botanico di Leida. Linneo lo stimava tanto da proclamarlo "principe dei botanici" e da dedicargli, complice Pitton de Tournefort, il genere Hermannia.  Sud Africa, Ceylon... Leida Nel 1658, dopo una lunga guerra in cui intervenne a fianco dei sovrani locali (che ancora non sapevano che stavano per sostituire un occupante con l'altro), la VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie, Compagnia olandese delle Indie orientali) espulse definitivamente il Portogallo da Ceylon (oggi Sri Lanka). Da quel momento, esercitò il monopolio del commercio della cannella dell'isola, la migliore in assoluto. Ma impiegati e ufficiali si ammalavano con allarmante frequenza di malattie sconosciute in Europa che i farmacisti e i chirurghi al servizio della Compagnia non sapevano come curare; le medicine portate dall'Europa nel clima tropicale non sempre servivano e perdevano presto la loro efficacia; era urgente studiare la flora locale alla ricerca di piante medicinali alternative. Un influente uomo politico, Hieronymus van Beverningh, che era anche un accanito collezionista di piante esotiche, e il prefetto dell'orto botanico di Leida Arnold Seyen raccomandarono il giovane medico tedesco Paul Hermann (1646-1695), da poco laureato alla prestigiosa università di Padova; si dice fosse interessato alle piante fin da bambino, quando, a dieci anni, rischiò di annegare per esaminare delle piante acquatiche. I suoi sponsor speravano che, oltre a soddisfare gli obiettivi della Compagnia, potesse anche arricchire le loro collezioni. Dunque, in un certo senso Hermann è il primo cacciatore di piante al servizio di un orto botanico. Partito per Ceylon all'inizio del 1672, ad aprile approfittò dello scalo al Capo di Buona Speranza per raccogliere piante sudafricane; e altrettanto fece durante il viaggio di ritorno, nel marzo del 1680. A parte il precedente della piccola raccolta di Justus Heurnius (che però era un teologo, non un botanico), si tratta del primo contatto di un botanico europeo con la flora del Capo. Con gli esemplari raccolti (circa 800, secondo la testimonianza di Linneo) formò un erbario; spedì semi e bulbi in Olanda, e altri li affidò al chirurgo di bordo Hieremias Stolle, di ritorno in Europa. Questi a sua volta li passò all'anatomista danese Thomas Bartholin che nel 1775 pubblicò la breve nota "Plantae novae Africanae", la prima pubblicazione a stampa dedicata esclusivamente a piante sudafricane. A Ceylon, come "medico ordinario e medico capo" della VOC, Hermann si stabilì a Colombo, sede del quartier generale della Compagnia; creò e diresse un ospedale, esplorò assiduamente la flora dei dintorni, annotando i nomi locali e le proprietà medicinali delle piante. Con questi materiali mise insieme diversi libri di erbari e almeno un volume di illustrazioni (non è certo se di sua mano o di altri anonimi disegnatori); inoltre inviò più volte bulbi e semi in Olanda. Sebbene siano limitate alla zona intorno a Colombo (gli olandesi controllavano solo alcune aree costiere) e includano anche diverse specie coltivate introdotte, le sue raccolte sono impressionanti per quantità e per la qualità delle annotazioni, senza contare l'eccezionale valore storico, trattandosi del primo studioso europeo a esplorare la flora dell'isola, ai suoi occhi un vero Eden. Intorno al 1674 visitò anche brevemente il Malabar dove forse incontrò van Rheede, che potrebbe averlo consultato per il progetto che poi divenne Hortus malabaricus. L'esplorazione della flora singalese diede grande fama a Hermann, tanto che nel 1678, alla morte di Arnold Seyen, i rettori dell'Università di Leida decisero di chiamarlo a succedergli come professore di botanica e prefetto dell'Orto. Hermann accettò e tra la fine del 1679 e l'inizio del 1680 lasciò Ceylon per tornare in Olanda. Nelle sue lezioni, fu il primo botanico olandese a prestare attenzione alla tassonomia; creò anche un proprio sistema, basato sui frutti, che univa e modificava quelli di Ray e Morison. Oltre che a Leida, fu adottato in altri orti botanici, tra cui Uppsala ai tempi di Rudbeck il vecchio. Deciso a fare dell'Orto di Leida il migliore d'Europa, solitamente dedicava le pause accademiche a viaggi in altri paesi europei per consultare colleghi e appassionati e procurarsi piante; nel 1682 fu in l'Inghilterra, dove visitò tra l'altro gli orti botanici di Oxford e Chelsea, e ne riportò più di 200 piante vive (soprattutto nord americane); nel 1688 andò a Parigi ad incontrare Tournefort; qui strinse amicizia con l’inglese William Sherard, che decise di seguirlo a Leida. Dal 1686, assunse anche l'insegnamento di medicina pratica. Durante la sua gestione, l'orto botanico di Leida divenne il principale centro europeo di acclimatazione e diffusione delle piante provenienti dalle colonie americane, africane e asiatiche. Oltre alle sue introduzioni dirette dall'India e dal Sud Africa, poté sfruttare i suoi contatti con la VOC e con i principali collezionisti olandesi, nonché con l'Inghilterra e la Francia, per triplicare le collezioni (il suo catalogo del 1687 registra tremila specie, contro le circa 800 di inizio secolo); molte erano subtropicali o tropicali. Nel 1681, fu tra i primi a sperimentare una serra riscaldata. 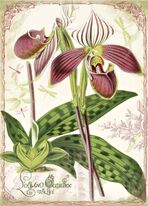 Olanda, un secondo Eden? Hermann morì nel 1695 a soli 49 anni (qui una sintesi biografica), lasciando incomplete e inedite diverse opere; l’unico suo libro pubblicato in vita fu infatti il catalogo dell’orto botanico di Leida (1687). Quella a cui teneva di più, e a cui lavorava da diversi anni, era Paradisus batavus, un catalogo illustrato delle piante di recente introduzione nei giardini olandesi. Già nel 1689 l'affezionato Sherard ne aveva pubblicato l’indice, e alla morte inaspettata del maestro e amico si assunse il compito (ingrato, visto lo stato del manoscritto) di curarne la pubblicazione; a spese della vedova di Hermann, l’opera uscì in una prima edizione relativamente economica in ottavo nel 1695, e in una seconda più pregevole edizione in quarto nel 1705 . Entrambe comprendono un centinaio di calcografie, su disegni in gran parte di mano dello stesso Hermann; per numerose specie, si tratta della prima immagine a stampa. Nonostante sia un lavoro diseguale (a causa della morte dell’autore, le piante sono trattate in modo variamente esteso e in alcuni casi l'illustrazione è priva di note d'accompagnamento) è di estremo interesse per la storia dell’introduzione delle piante orticole; tra di esse, come ho raccontato in questo post, le prime due orchidee tropicali coltivate in Europa. Ma è anche un documento in presa diretta della civiltà olandese del giardino nel secolo d’oro. Tra i giardini citati, oltre agli orti botanici di Leida e Amsterdam e a quelli principeschi di William e Mary (divenuti sovrani d’Inghilterra nel 1689, in seguito alla gloriosa rivoluzione), quelli di importanti uomini politici: il suo protettore Hieronymus van Beverningh, il segretario degli stati d’Olanda Simon van Beaumont, il pensionario di Haarlem Gaspar Fagel, il ciambellano Willem Bentinck (poi primo duca di Portland). Per questi uomini di potere, i giardini e il collezionismo di piante esotiche e rare avevano un preciso significato ideologico: come leggiamo in Den Nederlandtsen Hovenier , il popolare manuale di giardinaggio scritto da Jan van der Groen (circa 1635-1672), capo giardiniere dello statolder, la caduta di Adamo aveva reso imperfetta la natura, ma l’arte, la domesticazione e l’ordine potevano restituire la perfezione perduta e i giardini erano la prova materiale della riuscita dell’impresa. Il titolo del libro di Hermann, Paradisus batavus «paradiso olandese», si rifà esplicitamente a questa ideologia. Nel 1717, le note di campo scritte da Hermann a Ceylon furono pubblicate, sempre da Sherard, sotto il titolo Musaeum Zeylanicum. Ma per la storia della botanica sono molti più importanti gli erbari. Hermann aveva raccolto centinaia di esemplari sia per sé, sia per i suoi sponsor; al rientro da Ceylon, consegnò almeno un libro d’erbario a Beverningh e un altro a Jan Commelin, direttore dell'orto botanico di Amsterdan. Dopo la sua morte, la vedova, probabilmente per finanziare la stampa di Paradisus batavus, vendette il resto all’asta. Per cinquant’anni, se ne perse ogni traccia, finché nel 1744 giunsero nelle mani del farmacista reale danese August Günther cinque volumi, quattro d’erbario e uno di disegni. Günther li prestò a Linneo, che se ne servì sia per la sua unica pubblicazione sulla flora asiatica, Flora Zeylanica, sia per le piante singalesi di Species plantarum. Dopo diversi altri passaggi, il prezioso erbario fu acquistato da Joseph Banks e fa oggi parte delle collezioni del Natural History Museum di Londra. Il volume appartenuto a Commelin fu invece studiato dal botanico olandese Johannes Burman per il suo Thesaurus Zeylanicus.  Deliziose (e misconoscite) Hermanniae Hermann era stimatissimo dai botanici della generazione immediatamente successiva: Boerhaave lo definì «incomparabile per la conoscenza delle piante», Johannes Burman lo chiamò «sommo lume dell’Università di Leida». Quanto a Linneo, che premise a Flora Zeylanica una biografia di Hermann così elogiativa da sconfinare nella agiografia, lo salutò «principe dei botanici», un titolo che di solito riservava a se stesso, e scrisse: «Non c’era al mondo un botanico pari a Hermann per i meriti e le scoperte» . Grande stima ne aveva anche Tournefort che gli dedicò il genere Hermannia , sulla base dell’unica specie allora nota (nome attuale Hermannia hyssopifolia), una delle acquisizioni sudafricane di Hermann; il genere fu poi fatto proprio da Linneo . Hermannia L. della famiglia Malvaceae è un grande genere soprattutto sudafricano, dunque perfetto per celebrare il primo esploratore della flora del Capo. A parte una specie australiana e pochissime specie distribuite tra Messico e zone adiacenti degli Stati Uniti, buona parte delle circa 160 specie sono africane, 81 delle quali endemiche del Sud Africa, soprattutto delle province del Capo occidentale e settentrionale. Il genere è molto vario, e si è adattato a un’altrettanto grande varietà di ambienti. Sono piante erbacee o piccoli arbusti, spesso striscianti. Le specie che vivono nel veld tendono a lignificare alla base e a formare un fusto legnoso sotterraneo, in grado di superare i periodi di siccità o anche gli incendi. Anche se sono poco utilizzate nei giardini, molte specie sono assai decorative grazie alle masse di fiori penduli a campana, spesso in delicati colori pastello. Ne troverete una piccola selezione nella scheda. E' piuttosto inconsueto che un botanico affermato, professore universitario e membro dell'Accademia delle scienze del proprio paese, a cinquant'anni suonati parta per una pericolosa spedizione scientifica ai tropici. Eppure il professor de Vriese, quando il parlamento olandese gli chiede di andare in missione in Indonesia, non esita a partire, forse affascinato dalla prospettiva di vedere nel loro ambiente naturale le piante che studia da sempre in erbari e serre. Non sa ancora che il prezzo da pagare sarà la sua stessa vita. Rivolgetegli un pensiero quando ammirate la fioritura delle piante che lo celebrano, le bellissime Vriesea.  L'uomo giusto al momento giusto Impressionato dalle rivoluzioni che scuotono l'Europa, nel marzo 1848 il re d'Olanda Guglielmo II decide di trasformare il paese in una monarchia costituzionale. A capo della commissione che dovrà elaborare il testo della nuova costituzione, non esista a nominare Johan Rudolph Thorbecke, il leader dei liberali; proclamata il 3 novembre dello stesso anno, la costituzione prevede tra l'altro elezioni dirette con voto segreto, limitazioni del potere del sovrano, maggiore autonomia delle province, libertà di religione. Per la prima volta, il parlamento ottiene la giurisdizione sulle colonie, fino ad allora sotto l'esclusiva autorità del re. In Indonesia, i liberali al potere, fautori del liberismo economico, vorrebbero spezzare il sistema delle coltivazioni forzate, introdurre un'economia basata sul lavoro libero e aprire le Indie olandesi al capitale privato. Al di là delle petizioni di principio, devono muoversi con cautela perché dal batig slot, ovvero dai proventi versati al tesoro da quelle colonie, dipende larga parte del bilancio statale. Una soluzione per alleggerire le terribili condizioni dei contadini giavanesi, senza mandare in crisi il bilancio olandese, potrebbe essere l'introduzione di coltivazioni coloniali più redditizie, come sta facendo in quegli anni l'Impero britannico in India. E' in questo contesto che il governo olandese nel 1852 invia in Perù il botanico J.C. Hasskarl per cercare di procurarsi pianticelle di Cinchona, la pianta da cui si ricava il chinino, da introdurre a Giava; nel 1854 egli è di ritorno in Indonesia con un carico di virgulti che trapianta nell'orto botanico di Bogor/Buitenzorg. Non è un'iniziativa isolata. Nel 1857 il parlamento olandese decide di inviare in Indonesia un esperto di agronomia tropicale per studiare l'economia agricola delle isole e valutare le strategie migliori per affrancarla dal regime delle coltivazioni forzate. La scelta cade su Willem Hendrik de Vriese, professore di botanica dell'università e direttore dell'orto botanico di Leida. Come leggiamo nell'atto di nomina, approvato dal re, egli dovrà individuare le produzioni esotiche più adatte ai diversi climi delle isole e ricercare le piante native più utili per "le arti e il commercio". De Vriese era la persona perfetta per questo compito, per la sua profonda conoscenza della flora indonesiana e per i numerosi studi dedicati alle piante esotiche utilitarie. Medico, aveva insegnato botanica dapprima ad Amsterdam, poi a Leida, dove era succeduto a Reiwardt. Già esperto di piante esotiche, aveva particolare dimestichezza con la flora indonesiana per aver catalogato le piante raccolte dal suo predecessore e aver curato la pubblicazione del suo diario di viaggio in Plantae Indiae Batavae Orientalis : quas, in itinere per insulas archipelagi indici Javam, Amboinam, Celebem, Ternatam, aliasque, annis 1815-1821 exploravit Casp. Georg. Carol. Reinwardt (1856). Tra il 1855 e il 1856 pubblicò anche un'opera illustrata in tre volumi di orticultura e floricoltura (Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen) in cui le piante esotiche hanno larga parte. Gli si devono anche due importanti monografie su Rafflesia e sulle Marattiaceae (con Pieter Harting); era anche un esperto di felci e orchidee. Negli anni cinquanta, egli dedicò poi una serie di saggi a importanti piante tropicali di cui propugnava l'introduzione nelle colonie olandesi: nel 1855 Cinchona, nel 1856 Vanilla e Cinnamomum camphora. 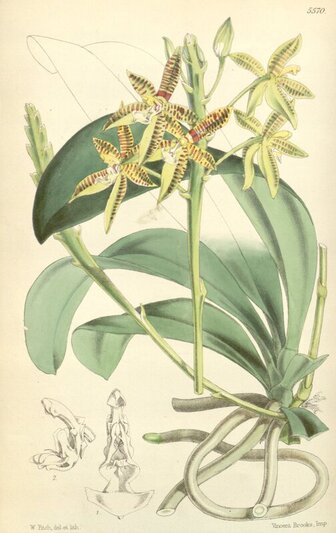 Un faticoso periplo tra le isole Il 28 ottobre 1857 de Vriese si imbarcò a Marsiglia alla volta dell'oriente; lo accompagnava il chimico de Vry, incaricato di studiare i principi attivi della Cinchona coltivata a Bogor. La prima tappa fu Ceylon, dove il botanico olandese studiò le piantagioni di caffè, all'epoca tra le più importanti del mondo; solo qualche anno più tardi, devastate da Hemileia vastatrix, sarebbero state sostituite dal tè. All'inizio dell'anno, via Singapore, si spostò a Giava, che visitò quasi per intero nel corso del 1858 e della prima metà del 1859; a questo punto si unì a Johannes Elias Teijsmann, il capo giardiniere di Buitenzorg/Bogor, con il quale visitò la parte orientale dell'isola e la desolata Madura. Teijsmann sarà ancora il suo compagno di viaggio in una impegnativa spedizione nelle Molucche, sulla quale siamo più informati grazie alla relazione che ce ne ha lasciato. Imbarcatisi a Surabaya il 15 dicembre, all'inizio del 1860 i due viaggiatori fecero scalo per qualche giorno a Makassar nell'isola di Celebes (oggi Sulawesi); si spostarono subito a Timor, dove si trattennero appena un giorno a Kupang, per poi passare a Dili e alle isole Banda: una visita doverosa, anche se ormai avevano perso l'importanza strategica che avevano rivestito per gli olandesi nell'arco di due secoli. Dal 1621 al 1810, come unico luogo al mondo dove si coltivava Myristica fragrans, avevano garantito all'Olanda il lucroso monopolio della produzione di noce moscata e macis. Un monopolio infranto dall'occupazione britannica del 1810: restituendo le isole dopo il Congresso di Vienna, gli inglesi si erano premurati da fare incetta delle preziose pianticelle, trapiantate con successo a Ceylon e in altre colonie. Ormai più importante la tappa successiva, Ambon, antico centro del commercio delle spezie, promettente per il suolo fertile e la varietà di ambienti naturali. Nei primi mesi del 1860, i due botanici vi stabilirono il loro quartier generale per l'esplorazione delle Molucche settentrionali. La prima spedizione fu dedicata alla piccola isola di Saparua ma soprattutto a Ceram (oggi anche Seram), dove de Vriese e Tejismann poterono dismettere i panni di agronomi e ispettori per tornare ad essere botanici. Ancora in gran parte ricoperta dalla foresta pluviale, questa isola dove gli animali e le piante dell'Asia si incontrano con quelli dell'Australia, con un clima caldo umido e un'intricata topografia montagnosa, dovette essere per de Vriese quasi il luogo dei sogni, dove studiare nel loro ambiente naturale le piante che amava di più: in primo luogo le felci, una delle sue specialità (oggi nell'isola si calcola ne vivano oltre 700 specie), ma anche le orchidee e le piante officinali, la cui ricognizione era uno degli obiettivi della sua missione. Nei mesi successivi fu la volta di Buru, quindi Ternate (in entrambe queste isole scalarono anche alcune cime), Tidore, Halmahera e numerosi isolotti. Ad aprile erano a Bacan, quindi, ormai sulla via del ritorno si spostarono a Celebes, dove si trattennero fino a giugno, visitando molte località delle regioni settentrionali. Alla fine del mese, erano di ritorno a Surabaya. Dato che da questo momento si separò da Tejismann, conosciamo meno dettagliatamente i viaggi successivi di de Vriese. Nella seconda parte del 1860 fu in Borneo e poi di nuovo a Giava, dove visitò le regioni centrali trascurate l'anno precedente; poi si spostò a Sumatra, dove si trovava all'inizio del 1861. Fu da Sumatra che probabilmente si imbarcò per l'Olanda, con la salute ormai compromessa da un'avventura tanto faticosa per un uomo che aveva superato la cinquantina. Al suo rientro in patria, nel marzo 1861, ebbe il dolore di perdere la moglie; ormai gravemente malato, non poté né riprendere la carriera universitaria né pubblicare i risultati della sua missione, morendo dieci mesi dopo il ritorno. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Intanto, il progetto di valorizzare le Indie orientali olandesi con l'introduzione di nuove specie andava avanti. Pur tra polemiche e mille difficoltà, la sperimentazione della coltivazione di Cinchona proseguì con successo e entro fine secolo l'Olanda si era assicurata il monopolio della produzione mondiale di chinino; intorno al 1860, a Sumatra arrivò il cacao e all'inizio del Novecento l'albero della gomma, Hevea brasiliensis. A guadagnarci, però, non furono certo i contadini indonesiani.  Vriesea, bellezza tropicale Molto prima della faticosa missione che gli sarebbe costata la salute e la vita, il professor de Vriese si era già fatto un nome negli ambienti della botanica europea. Infatti, nel 1843, quando egli insegnava ancora a Amsterdam, John Lindley, separando da Tillandsia una specie brasiliana, T. psittacina, creò il genere Vriesea in suo onore con la seguente dedica: "Ho così colto l'opportunità di onorare i meriti del dottor W. de Vriese, professore ad Amsterdam, un eccellente botanico e fisiologo". Vriesea è oggi uno dei generi più importanti e il secondo per numero di specie della famiglia Bromeliaceae (circa 250). Per lo più epifite, vivono in foreste umide anche d'altura dal Messico al Brasile. Dato che si adattano bene alla limitata luminosità delle nostre case, sono anche una tra le più popolari piante d'appartamento, grazie alla bellezza della foglie, spesso elegantemente variegate, e delle infiorescenze a forma di spiga, che si fanno notare per le brattee dai colori squillanti da cui sporgono i fiori tubolari, spesso in colore contrastante; un'accoppiata frequente è data dal rosso e dal giallo. Anche se alcune specie (come V. carinata o V. hieroglyphica) sono abbastanza coltivate, a dominare il mercato sono soprattutto gli ibridi; da questo punto di vista, del resto, tra le Bromeliaceae Vriesea vanta un duplice primato: è stato il primo genere ad essere ibridato con successo, ed attualmente è quello con un maggior numero di ibridi. Per la cronaca, il primo fu prodotto in Belgio nel 1879 da Eduard Morren, curatore dell'Orto botanico di Liegi incrociando V. psittacina e V. carinata. Altre notizie nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed