|
Nel 1586, presso l'editore Rouillé di Lione, comparvero i due tomi di Historia generalis plantarum, nota anche come "erbario di Lione". Il primo elemento che ci colpisce aprendo quest'opera poderosa è che, nonostante il reboante sottotitolo che promette al lettore la descrizione di tutte le piante note agli antichi nonché di quelle prima ignote scoperte "nelle parti orientali ed occidentali" e oltre un migliaio di illustrazioni "riccamente superiori a tutte le precedenti", il frontespizio non rechi il nome di alcun autore. Eppure un autore, o almeno un autore principale, c'era, e aveva lavorato a quell'opera per almeno un quarto di secolo. Era il medico, botanico e filologo Jacques Daléchamps. È troppo per pensare che fosse così insoddisfatto della redazione finale, che l'editore aveva affidato ad altri, da preferire che il suo nome non comparisse? Confusa, piena di errori, pesantemente censurata da Caspar Bauhin, con le sue oltre 2700 piante era comunque l'opera più ampia e ambiziosa dell'epoca e nonostante i difetti fu molto letta e consultata, specie nell'edizione francese. A ricordare il dottissmo Daléchamps, autore anche di una notevolissima edizione di Plinio, il genere Dalechampia, omaggio di Plumier replicato da Linneo. 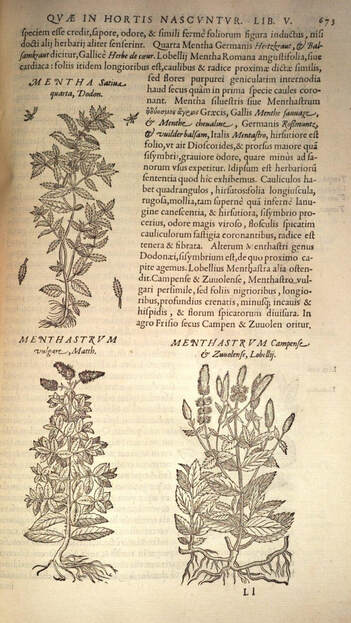 Un autore, troppi autori e un'opera anonima Nel Cinquecento, in seguito ai viaggi di esplorazione, il numero di piante conosciute incominciò ad aumentare drammaticamente, dalle poche centinaia note agli antichi alle migliaia incontrate dai viaggiatori europei nelle Americhe, in Asia, in Africa. I botanici del tempo, però, si illudevano ancora che il loro numero fosse gestibile, che fosse ancora possibile a una singola persona racchiuderle tutte in una singola opera. Dal De plantis di Andrea Cesalpino al Pinax di Caspar Bauhin, che con le sue 6000 piante segnerà allo stesso tempo il culmine e la fine di questo filone, il secondo Cinquecento è tutto un fiorire di queste opere enciclopediche che si vorrebbero onnicomprensive. Tra i tentativi più grandiosi ma allo stesso tempo sfortunati, spicca Historia generalis plantarum di Jacques Daléchamps (1513-1588). Figlio egli stesso di un medico di Caen, nel 1545, già ultratrentenne, si iscrisse all'università di Montpellier, dove fu uno dei primissimi allievi di Rondelet, con il quale rimase in termini di stretta amicizia, scrivendo in suo onore anche due dei poemi encomiastici che si leggono in De piscibus. Dopo la laurea, per qualche tempo visse a Valence e a Grenoble, finché intorno al 1550 si stabilì a Lione dove sarebbe vissuto fino alla morte. Nel 1552 fu nominato medico dell'Hôtel-Dieu dove avrebbe esercitato per circa trent'anni, nel corso dei quali fu sempre più presente nella vita cittadina. Erano anni difficili per Lione, devastata dalle guerre di religione, della povertà, dalla sifilide, da ripetute epidemie di peste. Daléchamps si fece un nome come ottimo medico e chirurgo e fu più volte chiamato a far parte delle commissioni mediche nominate dal consiglio cittadino o dal governatore per cercare di contrastare quel terribile flagello. Proprio alla peste dedicò quella che è probabilmente la sua prima opera a stampa (De Peste libri tres opera Jacobi Dalechampii, 1552), che non è un lavoro originale, ma la riedizione di un trattato trecentesco del medico di Montpellier Raymond Chalin de Vinario. È l'ingresso di Daléchamps nel mondo dell'editoria che aveva in Lione una delle sue capitali. Da quel momento egli fu molto attivo sia come autore (gli si deve tra l'altro una Chirurgie Françoise, pubblicata nel 1570), sia come filologo, traduttore e divulgatore di opere dell'antichità: tradusse in latino e commentò I deipnosofisti di Ateneo di Naucrati; tradusse in francese dal greco l'opera di Galeno e le opere mediche di Paolo Egineta e dal latino le opere mediche di Celio Aureliano. La più importante delle sue opere filologiche è senza dubbio l'edizione commentata della Naturalis historia di Plinio (1584), un lavoro dottissimo e assai apprezzato che lo impegnò per almeno un decennio. Al momento della morte, lasciò manoscritta un'edizione delle opere dei due Seneca, il retore e il filosofo, e una traduzione latina di tutte le opere superstiti di Teofrasto. Furono presumibilmente proprio questi molteplici impegni editoriali ad impedirgli di curare di persona la pubblicazione di Historia generalis plantarum e in definitiva a determinarne il fallimento. D'altra parte l'iniziativa di pubblicare una grande opera illustrata che raccogliesse tutte le piante note agli antichi e ai moderni presumibilmente non venne da lui, ma dall'editore Rouillé; nella prefazione (Lettera al lettore), quest'ultimo scrive: "Più di 20 anni fa, entrando nello studio di Jacques Daléchamps, trovai questo eccellente medico intento a consultare un grosso manoscritto di disegni di piante; la vista di questi disegni rari e squisiti mi fece pensare che avrebbero potuto essere l'infanzia e l'origine di un'opera estesa". Questa versione è confermata dal medico lionese Jacques Pons, una fonte molto affidabile in quanto collega ed amico di Daléchamps. Rouillé (in latino Rovillus), che si era formato a Venezia con i Giolito, era un abilissimo imprenditore che nei suoi 45 anni di attività pubblicò circa 830 testi, spaziando dai classici alla letteratura francese, italiana e spagnola, al diritto, alla religione, alla medicina e alle scienze. Sapeva scegliere i suoi collaboratori ed era perfettamente consapevole che il successo commerciale di un'opera di botanica dipendeva soprattutto dall'apparato iconografico, come avevano dimostrato i recenti esempi di Historia stirpium di Fuchs (1542) e dell'edizione latina illustrata dei Commentari di Mattioli (1554). Non stupisce che sia stata attratto e colpito, più che dal sapere botanico e filologico di Daléchamps, dalla sua grande ed eccellente collezione di immagini. Daléchamps iniziò a collaborare con Rouillé nel 1552 curando il già citato trattato sulla peste; nel 1558 l'editore lo coinvolse in una riedizione del commento a Dioscoride di Amato Lusitano. Stando al sottotitolo, "sono state aggiunte a quest'opera, oltre alla correzione dei lemmi, le annotazioni di R. Constantin nonché le immagini dei semplici di Leonhardt Fuchs, Jacques Daléchamps e altri", il suo ruolo dovette limitarsi a procurare alcune immagini, mentre le altre furono "piratate" da Fuchs ed altri. Della cura del testo si occupò un altro medico e filologo, Robert Constantin. Anche lui era originario di Caen e buon amico di Daléchamps, cui dedicò la sua opera più nota, il Lexicon graeco-latinum (1562). Se già a questa data egli aveva messo insieme quel grosso manoscritto di "disegni rari e squisiti", possiamo ipotizzare che Daléchamps avesse iniziato ad erborizzare, disegnare o far disegnare piante, se non nella sua giovinezza in Normandia, per lo meno negli anni di studio a Montpellier, secondo l'insegnamento di Rondelet, che incoraggiava i suoi allievi a percorrere le campagne alla ricerca di piante. Dovette dunque aderire con entusiasmo al progetto editoriale di Rouillé, che da parte sua si fece carico delle costosissime matrici xilografiche, sia originali, sia copiate da altre opere; mise a disposizione di Daléchamps il suo grande giardino, la Recluserie de Ste Hélène, dove secondo Pierre Jacquet, "i botanici lionesi coltivavano le piante descritte in Historia generalis plantarum"; tramite la sua vasta rete commerciale, gli fece inviare campioni di piante da tutto l'Occidente; infine, gli trovò in successione due aiutanti. Il primo fu Jean Bauhin (1541-1613). Allievo di Fuchs e Gessner, nell'ottobre 1561, appena ventenne, si iscrisse alla facoltà di medicina di Montpellier, laureandosi l'anno successivo. Anche lui allievo di Rondelet, durante il soggiorno in Linguadoca erborizzò intensamente con il condiscepolo Leonhard Rauwolf. Viaggiò poi in Italia e nel settembre 1563 si stabilì a Lione, prendendo alloggio a casa di Rouillé. Qui lavorò a un'opera sulle piante che, secondo diversi commentatori, altro non sarebbe che Historia generalis plantarum. Nel 1568, come protestante, dovette però lasciare la città con la famiglia (nel frattempo si era sposato con una lionese) e rifugiarsi in Svizzera. Nella sua prefazione, Rouillé non fa parola di questa collaborazione, mentre in una lettera scritta circa trent'anni anni dopo, a proposito di Historia generalis plantarum Jean Bauhin scrive "Quando questa storia mi è stata affidata, mi dedicai ad essa con coraggio e con qualche successo". Pierre Jacquet, che verso la fine del Novecento ha dedicato un approfondito articolo ai botanici lionesi del Rinascimento, soffermandosi in particolare su Daléchamps e sull'erbario di Lione, ritiene si tratti di una vanteria, corrispondente all'aspirazione di Bauhin di "essere riconosciuto come collaboratore di questa grande impresa, ma le circostanze hanno fatto sì che la sua partecipazione sia fallita e ne è derivato un grande risentimento". Jacquet è però in controtendenza; generalmente si ritiene che l'opera a cui lavorava Jean Bauhin quando viveva a Lione fosse Historia generalis plantarum e che egli abbia iniziato a lavorare alla sua Historia plantarum universalis molto dopo. Del resto, visto il pessimo giudizio di Bauhin sull'opera, è strano che desiderasse intestarsela. Tuttavia, il suo soggiorno a Lione durò appena cinque anni, il che dovette forzatamente limitare la portata del suo contributo. Daléchamps dovette continuare a lavorare alacremente al grandioso progetto nel corso degli anni '70, da una parte moltiplicando le ricerche sul campo, dall'altra leggendo, annotando, confrontando, chiosando le opere botaniche di antichi e moderni. Jacquet ha documentato una serie di viaggi in Normandia, a Parigi (dove potrebbe aver visitato giardini pubblici e privati con collezioni di piante esotiche), in Alvernia, nelle Cevenne, nel Delfinato, nel Giura, nel Vallese, nella regione di Ginevra. Daléchamps corrispondeva (e scambiava materiali) con molti botanici di primo piano, tra i quali troviamo Gessner, Camerarius e Lobel. Tuttavia, con l'intensificarsi degli altri impegni editoriali - il commento a Plinio, dopo un impegno ventennale, fu completato e pubblicato nel 1587, contemporanemente a Historia generalis plantarum, e in quegli anni Délechamps lavorava anche alle traduzioni di Teofrasto e Seneca - egli dovette rassegnarsi ad affidare ad altri la redazione finale di quella che in una lettera all'amico Camerarius definisce la "nostra opera monumentale sulle piante"; la scelta dell'editore cadde sul medico Jean Desmoulins (1530-1582). Anch'egli aveva studiato a Montpellier, ma probabilmente non fu allievo di Rondelet, morto lo stesso anno della sua iscrizione alla facoltà di medicina; collaborava da tempo con Rouillé per il quale aveva curato la traduzione francese dei Commentarii di Mattioli (Les Commentaires de M. Pierre-André Matthiole, médecin sénois, sur les six livres de P. Dioscoride, 1572 e nuovamente 1579). La natura del contributo di Desmoulins è chiarita dal ben informato Pons che, dopo aver ricordato la genesi dell'opera, il debito con gli antichi e i moderni (cita Mattioli, Dodoens, Anguillara, Fuchs, Lobel e Pena, Bock e un misterioso Tenerus) e le "non poche" descrizioni e immagini messe insieme da Daléchamps, scrive: "Il medico Molinaeus [= Jean Desmoulins], uomo di singolare erudizione e dottrina, con la massima cura e diligenza divise questa massa di piante [ovvero sia quelle raccolte e descritte da Daléchamps, sia quelle ricavate dalle opere di autori antichi e moderni] in ordini e classi, ne aggiunse molte dagli antichi, e anche qualcuna di suo, avvelendosi del consiglio di Daléchamps". Insomma, il suo ruolo fu quello di editor o, se vogliamo usare l'espressione impiegata da Jacquet, di negro, incaricato di trasformare le note più o meno organizzate accumulatesi in 25 anni di lavoro in un testo compiuto. Inoltre contemporaneamente attese a una traduzione parziale in francese. Forse la cosa avrebbe potuto funzionare, se Desmoulins non fosse morto nel 1582, quando era stata completata la stampa solo dei primi 4 libri (su 17 totali). Daléchamps - vecchio, malato, sovraccarico di lavoro - non poteva occuparsene, Rouillé voleva pubblicare a tutti i costi, viste le ingenti spese già sostenute; di fatto, tra dilazioni e ritardi, a occuparsi di quanto rimaneva sarebbero stati i tipografi, con l'accumularsi di errori di ogni tipo. Scrivendone a Clusius in una lettera del 1603, Lobel indica un colpevole: "M. Chaubin [presumibilmente il proto che si occupò della messa in pagina] è imputabile degli errori e dei gravi abusi di questo erbario e di ben 400 figure usate due o anche tre volte per la stessa pianta in paragrafi diversi". Adriaan van der Spiegel nella sua Isagoge in rem herbariam (1606) aggiunge altri responsabili: "si afferma da fonte sicura che [Daléchamps] aveva lasciato incompiuto il suo erbario; così questo libro contiene molti errori dovuti ai copisti che hanno preparato l'erbario per la stampa". Infine i due volumi furono pronti per la fiera di Lione del gennaio 1586 (a causa dell'ennesimo refuso, il primo volume reca la data 1587), ma sul frontespizio non compare il nome di nessun autore; la spiegazione più probabile è che, vedendo il disastro, Daléchamps abbia preferito non figurare come autore di un'opera così sconciata. Forse sperava di firmare una prossima seconda edizione rivista; tuttavia egli morì nel 1588, Rouillé lo seguì l'anno dopo, e il suo erede non aveva alcun interesse a mettere mano a una seconda edizione, tanto più che la prima non era esaurita; solo molti anni dopo, nel 1617, avrebbe pubblicato l'edizione francese nella traduzione di Jean Desmoulins che, al contrario, di quella latina, fu un successo editoriale .  Luci e ombre di un'opera monumentale Per dimensioni e numero di piante trattate si trattava effettivamente di un'opera enciclopedica: due volumi in folio per 2034 pagine complessive, illustrate con 2686 incisioni; le piante trattate sono 2700, molte di più di qualsiasi opera precedente (per fare due soli esempi, in Stirpium adversaria nova di Pena e Lobel erano 1200, in De plantis di Cesalpino 1500). Le piante non sono esposte in ordine alfabetico, ma raggruppate in diciotto categorie, ognuna delle quali occupa un libro. A differenza proprio di Cesalpino o anche di Lobel, non abbiamo a che fare però con un sistema, ma con raggruppamenti eclettici, basati ora sull'habitat, ora sugli usi, ora su caratteristiche delle piante stesse. Iniziando dal Libro I, troviamo gli alberi che crescono spontaneamente nei boschi; quindi gli arbusti che crescono spontaneamente nelle siepi e nei cespugli (libro II); gli alberi piantati nei frutteti (libro III); grani, leguminose e erbe selvatiche che li accompagnano (libro IV); ortaggi e erbe che crescono nei giardini e negli orti (libro V); le ombellifere (libro VI); le piante che piacciono per i loro fiori (libro VII); piante aromatiche (libro VIII); piante palustri (libro IX); piante che crescono in luoghi aspri, sabbiosi, rocciosi o aridi (libro X); piante dei luoghi ombrosi, umidi, fangosi, umiferi (libro XI); piante delle rive del mare e del mare stesso (libro XII); piante rampicanti (libro XIII); cardi e altre piante spinose e pungenti (libro XIV); piante bulbose, con radici carnose e geniculate (libro XV); piante purgative (libro XVI); piante velenose (libro XVII); piante esotiche (libro XVIII), ovvero le plantae peregrinae come si chiamavano allora. È il libro più ampio - oltre 170 pagine -attinto soprattutto da Mattioli, Clusius e Lobel. Segue un amplissimo indice plurilingue (latino, greco, arabo, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese, ceco e inglese) di una cinquantina di pagine. A questo punto l'editore dovette accorgersi che qualcosa rimaneva fuori e volle ancora aggiungere due appendici, la prima sulle piante esotiche poco note, ricavata essenzialmente dalle opere di Acosta e Garcia da Orta, la seconda sulle piante egizie e siriane inviate da Rauwolf. Dalle lettere di Daléchamps a Camerarius sappiamo che questa aggiunta fu un'idea esclusiva di Rouillé, che rallentò ulteriormente la pubblicazione e lo contrariò assai. Da eccellente editore qual era, Rouillé garantì un'opera graficamente curata, con bei capilettera e capitoli chiaramente scanditi da sottotitoli a margine; ogni capitolo è dedicato a una pianta, di cui vengono esposti i nomi (nomina), le sottospecie o tipi (genera), l'aspetto (forma), l'habitat (locus), le proprietà medicinali e gli usi, con riferimenti puntuali e citazioni di antichi e moderni; l'opera vuole infatti presentarsi come una summa di tutto ciò che è stato scritto sulle piante fino a quel tempo. Secondo Jacquet, gli autori citati sono oltre 300. Tra gli antichi i più citati sono Plinio e Dioscoride, tra i moderni Mattioli, Pena e Lobel. Un enorme sovraccarico informativo che è crollato su se stesso quando la cura dell'opera è rimasta abbandonata a Rouillé e ai suoi tipografi. I possibili disastri sono ben esemplificati dalla voce Primula del settimo libro (riprendo l'esempio dal bell'articolo di B. Olgivie The Many Books of Nature: Renaissance Naturalists and Information Overload); dopo averne elencato i nomi, vengono descritti i tre tipi menzionati da Dodoens, cui se ne aggiungono altri tre, per un totale di sei, ma le illustrazioni sono sette. Segue un lungo excursus in cui si discute se questa pianta va identificata con il verbascum di Dioscoride, che risulta del tutto inutile dato che esso viene confuso con verbasculum. Così, quando infine l'opera uscì, per citare ancora Olgivie, "molti contemporanei condivisero l'impressione che fosse una raccolta di note mal editate". Clusius la attendeva con impazienza, ma dopo la sua pubblicazione non la menzionò mai, forse anche offeso dall'omissione di molte piante trattate nelle sue opere. Anche il medico e naturalista sassone Caspar Schwenckfeld ne fu profondamente deluso: in una lettera a Caspar Bauhin, scrive che il libro è stato messo insieme con poco giudizio e in un ordine confuso. Durissimo il giudizio di Jean Bauhin: "A dire il vero, colui che ha messo insieme questo erbario di Lione ha usato i nostri materiali, ma con molte altre cose, li ha accatastati con poco giudizio, talvolta separando i generi dalle specie, talvolta introducendo, spesso a sproposito, descrizioni e rappresentazioni. Ovviamente non poteva fare diversamente, essendo mal informato in materia di piante e poco al corrente delle dotte riflessioni del sapientissimo Daléchamps, che confonde indistintamente con le nostre e quelle di qualcun altro. Ne risulta una storia confusa, mal digerita e senza giudizio e, si potrebbe dire, senza grande utilità per il vero botanico". Se Bauhin poteva essere mosso dal risentimento personale, si deve invece al devoto ricordo dell'amico scomparso e al desiderio di salvare il salvabile l'intervento di Jacques Pons. Nell'opuscolo In Historium generalem plantarum Rouillii, duobus tomis et appendice comprehensam breves annotationes & animadversiones compendiosæ, pubblicato nel 1600, dopo una breve prefazione utile per ricostruire la genesi dell'erbario di Lione, egli elencò e corresse 294 errori, per la più tipografici e non sostanziali. Pons dimostra grande ammirazione per Daléchamps, non critica l'opera in sé e di fatto il suo è un errata corrige, di cui infatti gli eredi Rouillé tennero conto nell'approntare l'edizione francese (Histoire générale des plantes, sortie latine de la bibliothèque de M. Jacques Daléchamps, puis faite française, par M. Jean de Moulins, 1615). Hanno invece tono e intento demolitorio le Animadversiones in historiam generalem plantarum Lugduni editam pubblicate nel 1601 da Caspar Bauhin; le sue critiche puntano in particolare contro le descrizioni e le figure prese di peso da altre opere e soprattutto il pasticcio delle figure, 400 delle quali sono ripetute due o anche tre volte. Le tristi vicende editoriali della sua opera botanica hanno finito anche per occultare a lungo il contributo personale di Daléchamps non come erudito o chiosatore di opere altrui, ma come botanico sul campo. Il primo ha sottolineare questo aspetto fu forse Dominique Villars nel 1786 scrivendo: "Quanto ne avrebbe guadagnato la reputazione di Dalechamps se, invece di affidare le sue note a medici che poco sapevano di botanica, a tipografi, a gente che voleva racchiudere tutto in una storia generale, avesse potuto redigere egli stesso e darci ciò che aveva visto, senza obbligare G. Bauhin a scrivere [...] un libro per rilevare gli errori grossolani in cui essi erano caduti". Qualche anno dopo, in Historia rei herbariae (1807) Curd Sprengel diede un primo elenco di 57 piante del Lionese e della Francia occidentale descritte per la prima volta da Daléchemps; tuttavia, il suo contributo come pioniere dello studio della flora delle Alpi occidentali è stato messo in luce solo all'inizio del Novecento dallo svizzero Hermann Christ. Nel suo articolo più volte citato, Jacquet ha infine individuato "131 piante nuove descritte da nostro semplicista lionese", fornendone l'elenco con i nomi di Daléchamps e quello attuali. Nel mare magnum di Historia generalis plantarum, rappresentano appena il 6%, ma sono sufficienti a dimostrare che non sbagliava Linneo in Philosophia botanica a classificare il nostro non solo tra i "commentatori degli antichi" (pensava certo al suo Plinio), ma anche tra i "descrittori utilissimi".  Una pianta degli orti e un genere singolare Il XVI capitolo del V libro, quello sulle umili piante degli orti, è dedicato a Hieracium. Se ne illustra il nome in greco, latino e francese, quindi si passa ai tipi: "Dioscoride gli assegna due tipi, il grande e il piccolo, ai quali Daléchamps aggiunge Hieracium macrocaulon [...]. Quest'ultimo prende il nome dalla lunghezza del fusto". Questo "Hieracium" dal fusto lungo e sottile oggi si chiama Hypochaeris radicata ed in realtà era già stato descritto da Dodoens e Lobel. La vera novità è il supposto H. magnum di Dioscoride, di cui Daléchamps, contestando la precedente identificazione di Mattioli, fornisce una propria illustrazione e un'accuratissima descrizione. Sono le prime in assoluto di una pianta che ancora porta il suo nome: è il boccione maggiore Urospermum dalechampii. Ma, per volere di Plumier confermato da Linneo, Daléchamps è ricordato anche da un genere esotico, che mai vide e conobbe. Dalechampia (famiglia Euphorbiaceae) è un grande genere di un centinaio di specie diffuso soprattutto dal Messico all'America tropicale, con un numero minore di specie in Africa, Madagascar e Asia meridionale; il numero maggiore di specie si concentra invece in Brasile, con una settantina di specie e una cinquantina di endemismi. È caratterizzato da fiori unisessuali secondariamente uniti in infiorescenze bisessuali (pseudanthia) che fungono da unità di impollinazione. Ciascuna infiorescenza, a simmetria bilaterale, è caratterizzata da due brattee grandi e vistose oppure piccole e ridotte a stipole, un pleiocasio di 4-50 fiori staminati (maschili) e una cimetta di 1-3 fiori pistillati (femminili); diverse specie sono munite di ghiandole resinifere. La singolarità dei fiori, unici in questa famiglia (tanto che il genere è l'unico rappresentante di una propria tribù, Dalechampiinae), e la grande varietà di forme di impollinazione ne hanno fatto uno dei gruppi più studiati tra le Euphorbiaceae. La maggior parte delle specie neotropicali sono impollinate da femmine di varie specie di imenotteri che usano la resina per costruire i nidi; una dozzina di specie è però impollinata da imenotteri maschi, che si servono della resina profumata per attirare le femmine. Le specie asiatiche sono impollinate da api Megachile racoglitrici di resina, mente quelle malgasce lo sono sia da api raccoglitrici di resina sia da api raccoglitrici di polline. Le Dalechampia sono prevalentemente rampicanti, in alcuni casi liane, più raramente arbusti o suffrutici. Hanno rami cilindrici, in alcune specie muniti di peli urticanti, morfologia fogliare molto varia, con foglie da intere a composte, con lamina lineare, obovata, cordata, lanceolata, talvolta profondamente lobata, con grande variabilità anche nello stesso individuo. Alcune specie con brattee vistosamente colorate sono talvolta coltivate; quella più comunemente offerta dai vivai è Dalechampia aristolochiifolia, con brattee viola, anche se, a causa della scorretta identificazione iniziale, è per lo più commercializzata come D. dioscoreifolia.
0 Comments
All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia). 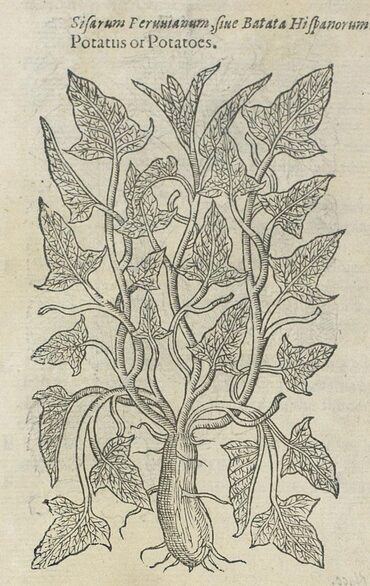 Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa. 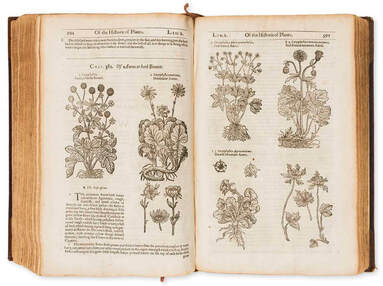 Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice. Con due libri dal ricercato titolo greco, Fabio Colonna segna una tappa decisiva per l'avvento della botanica come scienza, negli anni a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Membro dell'Accademia dei Lincei, ha ancora la formazione erudita di stampo classico e la vastità di interessi dell'uomo universale del Rinascimento, ma è già a tutti gli effetti un uomo della nuova scienza, corrispondente di Galileo e scienziato sperimentale, che più che all'auctoritas degli antichi si affida al libro della natura. I suoi contributi alla nascita di un metodo scientifico per studiare le piante e determinarne i generi gli guadagnarono il plauso di Tournefort e Linneo, per non parlare di Plumier che gli dedicò il sontuoso genere Columnea. 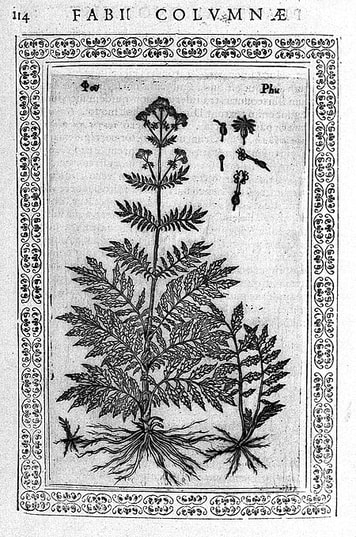 La botanica come cura Forse, se avesse goduto di buona salute, il napoletano Fabio Colonna (1567-1640) non sarebbe mai diventato un naturalista. Esponente di un ramo cadetto della celebre famiglia romana, nel 1589 si laureò utroque iure all'Università di Napoli, ma la salute precaria gli impedì di esercitare la professione. Spirito indagatore, per trovare rimedio ai suoi mali, e in particolare ai ricorrenti attacchi di epilessia, si rivolse ai testi degli antichi, a cominciare da Dioscoride, dove lesse delle proprietà antiepilettiche di una pianta chiamata Phu. Incominciò così a battere le campagne alla sua ricerca; il risultato fu che si innamorò della botanica e fece scoperte ben più interessanti dell'identificazione delle piante di Dioscoride, croce e delizia dei botanici del Rinascimento. Ma qui lascio volentieri la parola a Michele Tenore: "L'impegno di riconoscere nelle campagne la pianta che l'Anazarbeo chiamava Fu [...] lo condusse a scorrere le nostre selve, i nostri boschi e i monti; ove siccome doveva necessariamente avvenire, con giornaliero paragone delle descrizioni di Dioscoride con le piante che incontrava, invece del Fu di questo Autore, che scambiò con la Valeriana officinalis [...], riconobbe non solo la maggior parte delle piante mentovate dagli antichi scrittori; ma anche moltissime altre proprie del nostro suolo che egli scopriva per la prima volta". Nelle sue scorribande botaniche, che, a detta di Tenore, dovettero giovargli ben più del supposto rimedio dioscorideo, per memoria delle piante che incontrava, e per meglio confrontarle con le descrizioni degli antichi, Colonna dovette iniziare ad allestire un originale erbario ad impressione, testimoniato dal magnifico manoscritto in due volumi conservato a Blickling Hall nel Norfolk e intitolato Icones ipsis plantis ad vivum expressae quoad fieri potuit nova quadem arte excogitata ab ipso auctore Fabio Columna pro ipsius oblectatione, studio e memoria. Perfezionando una tecnica attestata fin dal secolo precedente, Colonna cospargeva di pigmenti l'esemplare, fresco o essiccato, ma sempre raccolto in natura (la coltivazione, aveva osservato, altera l'aspetto delle piante), quindi lo pressava su un foglio; ma, a differenza di Boccone o altri, a questo punto disegnava i particolari che l'impressione non conservava, talvolta aggiungendo anche i colori originali ad acquerello. Il poderoso erbario (oltre 500 fogli) fu certo il frutto di ricerche di molti anni, ma è probabile che egli lo abbia iniziato prima del 1592, data di pubblicazione dell'opera frutto di quelle prime escursioni e ricerche. Per identificare le piante di Dioscoride, Colonna, figlio di un agguerrito filologo ed egli stesso perfetto conoscitore delle lingue antiche, non rifuggiva dalla critica testuale, ma cercava la risposta soprattutto nel confronto tra le succinte e spesso criptiche descrizioni del testo greco con le piante raccolte in natura, minuziosamente osservate o "interrogate". E' questo il senso del curioso titolo della sua prima opera, Phytobasanos, sive plantarum aliquot historia. Come spiega Eva Cantarella, in greco il termine basanos originariamente indicava la pietra di paragone, utilizzata per saggiare l'oro, "da questo passò a indicare qualunque strumento o procedimento utile a 'mettere alla prova' una persona: e dunque, successivamente, anche la pratica che noi chiamiamo tortura". Ecco perché Phytobanos è stato variamente tradotto "Interrogazione delle piante", "Pietra di paragone della piante", "Tortura delle piante". La breve opera, stampata a Napoli a spese dell'autore nel 1592 (all'epoca Colonna aveva 25 anni) e dedicata al cardinale Marcantonio Colonna, è divisa in due parti; la prima analizza 26 piante di Dioscoride, ricavandone l'identificazione, più che dall'analisi filologica e dai pareri di altri studiosi (anche se non mancano né l'una né gli altri), dalla accurata e minuziosa descrizione della pianta stessa; la seconda parte, che si aggiunse in corso d'opera, durante la stampa della prima, tratta quattro animali marini e altre otto piante, che dovrebbero essere "nuove", cioè non descritte in precedenza. Lo era davvero la splendida Primula palinuri, che Colonna, il suo scopritore, identifica invece con la dioscoridea Alisma. Parte integrante dell'opera sono le 37 incisioni calcografiche a piena pagina, sicuramente almeno in parte ricavate da impressioni e disegni dello stesso Colonna. E' la prima volta che l'incisione su rame, con i suoi tratti molti più fini di quella su legno, viene applicata alla botanica; ed è anche la prima volta che, accanto alla pianta stessa, completa di radici, vengono raffigurati a parte, ingranditi, particolari essenziali per l'identificazione, come gli organi della fruttificazione. Stando a quanto scrive Colonna nella prefazione Ad lectorem, l'opera fu per lui, autodidatta ("nullo mostrante, aut docente"), un laborioso apprendistato; ma certo si avvalse dei consigli del farmacista Ferrante Imperato, che poi divenne il suo maestro e lo indirizzò anche allo studio dei fossili. Nel 1599, quando Imperato diede alle stampe Dell'historia naturale, Colonna contribuì con alcune tavole di serpenti disegnati dal vero. Grande influenza su di lui esercitò anche Giambattista della Porta, che più tardi l'avrebbe introdotto all'Accademia dei Lincei. 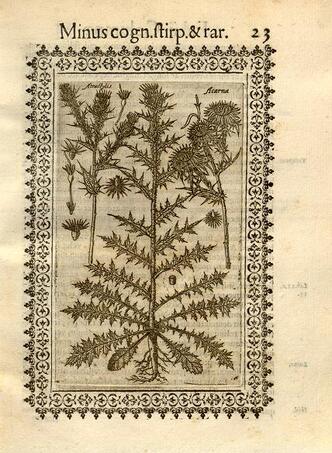 Un metodo per determinare i generi Dopo il 1593, anche se la stampa di Phytobasanos aveva alquanto intaccato il suo scarso patrimonio, ora che la migliorata salute gli permetteva di viaggiare, Colonna estese le sue ricerche oltre i confini del Napoletano, approfittando dei legami familiari. Per qualche tempo soggiornò presso un fratello a Campochiaro, dove studiò la flora del Matese, poi fu a Cerignola presso uno zio, quindi passò al servizio del duca di Zagarolo Marzio Colonna, mettendo finalmente a frutto le sue competenze giuridiche nella risoluzione di complesse controversie di confini. Era anche di frequente a Roma, dove poteva ammirare gran copia di piante esotiche nei giardini dei porporati come i famosi orti farnesiani. Ma a interessarlo erano soprattutto le specie "che nascono sotto il nostro cielo". Anche se non manca qualche esotica, sono soprattutto loro le protagoniste della seconda, più ampia opera di Colonna, Minus cognitarum stirpium aliquot ac etiam rariorum nostro coelo orientium Ekphrasis, la cui prima parte uscì a Roma presso Facciotto nel 1606. Il termine Ekphrasis è preso in prestito dal lessico artistico, dove indica la descrizione verbale, il più possibile dettagliata, di un'opera d'arte. Vi ritroviamo infatti le accuratissime descrizioni che già caratterizzavano Phytobasanos, nonché le splendide tavole calcografiche basate su disegni dello stesso Colonna; ad essere nuova è invece la consapevolezza metodologica. Ormai il botanico napoletano ha elaborato un solido metodo per lo studio scientifico delle piante, a partire dalla riconoscimento dell'importanza per la classificazione dei fiori e dei semi, ed ha maturato un metodo che farà l'ammirazione di Tournefort, che riconobbe in lui lo scopritore della "constituendorum generum ratio", ovvero del metodo per la determinazione dei generi. Né minore fu la considerazione di Linneo, che lo proclamò "primo di tutti i botanici". Importanti anche i suoi contributi alla terminologia, tra l'altro con la creazione del termine "petalo". Già pronta intorno al 1603, ma ritardata dai soliti problemi finanziari, l'opera fu dedicata da Colonna al duca di Zagarolo: tuttavia, nonostante l'alto valore scientifico e le splendide illustrazioni (in questa prima edizione sono 114, 102 delle quali dedicate a piante, le altre ad animali marini e terrestri, incluso un ippopotamo) non ebbe molta fortuna. Per qualche tempo Colonna fece la spola tra Roma e Napoli, dove tornò definitivamente intorno al 1610. In questa fase, il suo interesse principale si spostò sui fossili, con la determinazione dell'origine animale delle cosiddette glossopietre: non lingue di serpente, come si credeva, ma denti di squalo pietrificati. Nel 1612, grazie alla raccomandazione di Della Porta, entrò a far parte della colonia napoletana dell'Accademia dei Lincei di cui fu l'undicesimo membro nonché uno degli esponenti più attivi, divenendo uno stretto collaboratore di Cesi, anche come consulente e procuratore; corrispose con Galilei e fu tra i primi a capire le potenzialità dei suoi nuovi strumenti ottici. Ispirato dalle esperienze dello scienziato pisano, costruì da solo un cannocchiale con il quale replicò le osservazioni galileane del Sole e della Luna. Ancora maggiore fu il suo entusiasmo per il microscopio, che Galileo chiamava occhialino ed egli propose di battezzare enghiscopio "che vol dir occhiale da vicino, a differenza dell'altro che vede di lontano". Insoddisfatto dello strumento che Galileo aveva donato a Cesi, ne costruì uno con una lente da lui stesso molata di ampio diametro, che utilizzò per osservare l'anatomia delle api. Queste osservazioni era finalizzate a un'opera celebrativa offerta dai Lincei al cardinale Matteo Barberini, appena eletto pontefice con il nome Urbano VIII: le api, accampate sul loro stemma gentilizio, erano infatti il simbolo della famiglia Barberini. Nel 1615, alla morte di Della Porta, Colonna divenne viceprincipe, ovvero capo della colonia napoletana. Ed è orgogliosamente come Linceo che figura nel frontespizio della seconda, più ampia edizione di Ekphrasis, stampata a Roma nel 1616 da Mascardo, il tipografo di fiducia dell'Accademia; si è aggiunta qualche pianta, ma soprattutto due appendici, una dedicata alle glossopietre, l'altra alla porpora, ma soprattutto ai molluschi da cui è ricavata. Fu proprio De purpura ad assicurargli una certa fama europea; Colonna vi fonde le competenze antiquarie, con citazioni di Plinio, Aristotele, Dioscoride, la conoscenza della letteratura più recente (tra i nomi citati, Guillaume Rondelet), con l'indagine zoologica diretta delle diverse specie di molluschi del Tirreno meridionale, di cui esamina una ventina di specie, elencando anche i luoghi di crescita, da lui visitati personalmente. Intorno al 1624, Colonna fu coinvolto nel più ambizioso progetto collettivo dei Lincei, Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, più noto come Tesoro messicano, ovvero la pubblicazione commentata dell'epitome che Nardo Antonio Recchi aveva tratto dall'opera di Hernandez sulla natura messicana (le cui complesse vicende editoriali sono riassunte in questo post). Inizialmente, Cesi aveva affidato la parte botanica a Giovanni Faber e Giovanni Terrenzio, ma dopo la partenza di quest'ultimo per la Cina, insoddisfatto delle succinte note da lui redatte, si rivolse a Colonna, che, nuovamente afflitto da problemi di salute, accettò con riluttanza, soprattutto per non scontentare il principe. Temeva infatti di non essere sufficientemente aggiornato sugli sviluppi della botanica, che proprio in quegli anni stava facendo rapidi progressi (basti pensare che nel 1623 era uscito il Pinax di Caspar Bauhin). Ma, una volta entrato nel progetto, vi lavorò con il consueto impegno e serietà, redigendo le Annotationes et Additiones, che consegnò nel luglio 1628, in tempo per essere incluse nel primo volume, di cui avrebbero costituito la terza parte (pp. 847-899); sono prevalentemente dedicate alle botanica, tranne le ultime quattro, dedicate ai mineralia. Colonna, nell'esaminare le piante messicane e nel confrontarle con analoghe specie già note, ha modo di approfondire il metodo di determinazione dei generi; aggiunge inoltre la trattazione di alcune piante esotiche, non necessariamente messicane, e talvolta neppure americane. Ad esempio, in Narcissus indicus serpentarius riconosciamo il sudafricano Haemanthus coccineus, che negli stessi anni è descritto anche da Ferrari. E' invece nordamericano il Flos cardinalis Barberini, che Colonna dedicò a Francesco Barberini, protettore delle arti e della scienza, prendendo spunto dal colore rosso dei fiori, lo stesso della veste cardinalizia. Oggi si chiama Lobelia cardinalis, conservando l'eponimo voluto da Fabio Colonna. Dopo la morte di Cesi (1630), che ritardò per un ventennio l'effettiva diffusione del Tesoro messicano, Colonna fu indicato come suo possibile successore, ma la proposta non ebbe seguito. Poco sappiamo dei suoi ultimi anni, certo funestati da difficoltà finanziarie e crescenti problemi di salute. Morì nel 1640. Vale la pena di ricordare, tra i suoi poliedrici interessi, anche la musica; gli si deve anche la creazione di uno strumento musicale, il pentecontachordon o sambuca lincea, una specie di cembalo con 50 corde.  Magnificenze tropicali Come esploratore della flora dell'Italia centro-meridionale, si deve a Colonna la scoperta di almeno una ventina di specie. Diverse portano l'epiteto columnae (dalla forma latina del suo nome, Fabius Columna); tra di esse Doronicum columnae, Aubrieta columnae, Romulea columnae. Ci porta invece nell'America tropicale il genere Columnea, che gli fu dedicato da Plumier con un vero e proprio peana: "Fabio Colonna, nobile romano, nato in quella antica ed illustrissima famiglia, che occupa il primo rango tra le più nobili famiglie italiane, da lodare sopra tutti per la squisita conoscenza della storia naturale. In effetti, in questo campo nulla è paragonabile alle opere di un uomo così grande, che si guardino le immagini disegnate di sua mano o le descrizioni e le dissertazioni critiche". Già sappiamo quanto lo ammirasse anche Linneo, che fece proprio il genere. Con oltre 200 specie riconosciute, Columnea L. è il più vasto dei generi delle Gesneriaceae neotropicali. Ovviamente, è anche uno dei più vari. Diffuso dal Messico alla Bolivia e verso Est fino allo stato di Amapá in Brasile, trova il suo habitat ideale nelle foreste pluviali, dove può disporre di umidità tutto l'anno; è a sua agio soprattutto in quelle fresche ad altitudine media. Anche se il genere comprende anche arbusti ed erbacee, è fondamentalmente rappresentato da epifite che vivono sui tronchi e tra i rami degli alberi della foresta pluviale, a volte anche a considerevole altezza. Possono essere erette, ricadenti o rampicanti, e hanno per lo più foglie in coppie opposte, carnose, lucide, da ovate a lineari. Le specie più frequentemente coltivate e più utilizzate per la creazione di ibridi, come C. hirta, C. linearis o C. magnifica, appartengono alla sezione Columnea, caratterizzata da fiori tubolari fortemente bilabiati, con i due lobi superiori fusi a formare una specie di cappuccio, o galea; in genere la corolla è rossa, ma talvolta aranciata o rosa. Per la loro forma, che ricorderebbe un pesce rosso, in inglese vengono chiamata flying fish plants. La sezione Ortholoma è invece caratterizzata o da corolle piccole così fittamente ricoperte di peli da nascondere la corolla stessa (è il caso di C. purpurata) o da appendici poste alla base dal calice, che sembra emergere da una soffice palla di peli (è il caso di C. minor). I fiori delle sezioni Collandra, a sua volta assai varia, sono in genere molto meno colorati; in alcune specie a dare spettacolo e a fungere da richiamo sono le foglie: quelle di C. consanguinea sono segnate da una vistosa macchia rossa traslucida a forma di cuore. La sezione Pentadenia raggruppa specie per lo più terrestri, erbacee o arbustive, alte ed erette, con fiori tubolari o imbutiformi. Anche le specie della sezione Stygnanthe sono per lo più terresti, con corolle tubolari prive di lobi. Infine, la sezione Angustiflorae riunisce specie erbacee epifite, con rami sottili e corolla tubolare stretta ed allungata, non bilabiata. Alle già numerose specie si sono aggiunte dozzine di ibridi, in genere considerati più adattabili e quindi più facili da coltivare rispetto alle specie; inoltre spesso sono in grado di fiorire tutto l'anno. Tra i più notevoli, 'Bonfire', con corolla fortemente bilabiata, tubo giallo-aranciato e apici dei lobi rossi; 'Orange Fire', con calice verde piumoso, lungo tubo giallo e piccoli lobi arancio; 'Early Bird' (una delle varietà più popolari), con corolla bilabiata, tubo giallo vivo e galea arancio; 'Broget Stavanger' ha invece lunghi rami ricadenti e foglie variegate. Per una selezione di specie si rimanda alla scheda. L'orto botanico di Madrid rimase a lungo una roccaforte del sistema di Tournefort. Bisognò attendere la morte del primo cattedratico José Quer nel 1764 perché finalmente si aprisse alla nomenclatura e alla classificazione linneane, grazie al suo successore Miguel Barnades. Anche lui catalano, ma formato a Montpellier, era molto più aperto del suo predecessore ed educò ai nuovi principi una generazione di validi botanici, il più famoso dei quali è José Celestino Mutis. Per i suoi studenti scrisse Principios de botánica, in cui si dimostra buon conoscitore degli apporti dei botanici europei e adotta una posizione ecclettica che accanto a Linneo valorizza anche i tentativi di classificazione naturale della scuola francese, in particolare di Michel Adanson. Era la prima opera di botanica scritta in castigliano; ciò comportò la creazione di un intero vocabolario, per il quale Barnades, al semplice adattamento dal latino, spesso preferì attingere alla lingua parlata. Lo ricorda il genere sudamericano Barnadesia, omaggio dell'allievo José Celestino Mutis. Il primo manuale di botanica in lingua castigliana Come si è visto in questo post, il Reale orto botanico di Madrid, sito inizialmente a Migas Calientes, nacque nel 1755; già nel 1757 furono attivi corsi di botanica per i futuri medici e farmacisti, tenuti dal primo professore e direttore del giardino José Quer e dal secondo professore Joan Minuart. Entrambi catalani e allievi di Jaume Salvador, si erano formati nel credo tournefortiano cui improntarono anche il loro insegnamento. Tutto cambiò nel 1764 quando Quer morì e fu sostituito da un altro medico catalano, Miguel Barnades (1708-1771) che, avendo studiato a Montpellier dove era stato allievo di Boissier de Sauvages, aveva una formazione più aggiornata. Anche se non era un linneano di stretta osservanza, apprezzava sia la nomenclatura binomiale sia il sistema artificiale di Linneo, di cui riconosceva la praticità e l'efficacia didattica. Convinto assertore dell'utilità della botanica non solo per la salute pubblica, ma anche per l'economia, attraverso l'agricoltura, l'allevamento, le applicazioni industriali, per permettere al maggior numero possibile di studenti di appropriarsi dei principi della botanica decise di divulgarli in un'opera in lingua volgare, Principios de botanica: sacados de los mejores escritores y puestos en lengua castellana (Madrid 1767), come egli dichiara esplicitamente: "Il desiderio di rendere più facile alla gioventù spagnola lo studio metodico della botanica mi spinge, o lettore, a presentarti la spiegazione dei principi di questa scienza naturale in lingua castigliana". L'opera si apre con un profilo storico della botanica che dimostra quanto Barnades si tenesse aggiornato e quanto fosse privo di pregiudizi e aperto all'innovazione. Dopo un excursus sull'antichità e gli arabi, egli si sofferma sul Cinquecento, l'epoca dei restauratori, sul Seicento, l'epoca degli ordinatori, e sul proprio secolo, l'epoca dei riformatori. Tra i moderni, elogia in primo luogo Linneo, raccomandando in particolare Filosofia botanica e Genera plantarum; cita positivamente anche il suo maestro Sauvages, Ludwig, Duhamel de Monceau, Haller, Adanson e Oeder. Si noti che Familles de plantes di Adanson era stato pubblicato nel 1763-64; di Elementa botanicae di Oeder era uscito l'anno prima il primo volume, mentre del secondo si attendeva la pubblicazione, come Barnades aveva saputo dell'autore stesso, evidentemente uno dei suoi corrispondenti. L'approccio del botanico catalano era dunque eclettico e poteva conciliare la classificazione artificiale di Linneo con quella naturale di Adanson, a proposito della quale faceva notare che individuare gruppi di piante affini era particolarmente utile per la botanica farmaceutica perché "le piante della stessa famiglia naturale e anche più dello stesso genere naturale" hanno spesso proprietà simili. Dopo un capitolo dedicato all'utilità della botanica, il libro prosegue con capitoli sulla botanica in generale, le piante e le loro divisioni, le parti delle piante, distinte in durevoli, secondarie e temporanee (quelle attinenti alla fruttificazione, dal fiore al frutto al seme), la fruttificazione (definita "clandestina") di felci, muschi ed alghe. Il breve capitolo conclusivo, sulla traza ovvero l'habitus o aspetto generale, era inteso come preludio a una seconda parte che avrebbe dovuto insegnare a riconoscere in modo chiaro e distinto le piante e a nominarle in modo corretto; questo secondo volume tuttavia non fu mai scritto. Il maggiore contributo del libro di Barnades consiste indubbiamente nel tentativo di creare un'intera terminologia; nel descrivere in modo analitico le varie parti delle piante, egli introduce centinaia di neologismi. Al semplice adattamento della parola latina, in genere egli preferisce un equivalente nella lingua comune; ad esempio, per le infiorescenze troviamo le seguenti equivalenze: corymbus = maceta; umbella = copa; cyma = cimero; panicula diffusa = panoja; panicula coartata = mazorca; thyrsus = toba; racemus = racimo; spadix = tamarra; spatha = garrancha; spica = espiga; verticillus = rodajuela. E' una scelta estrema, che corrisponde al desiderio di avvicinare alla botanica anche chi non aveva alcuna familiarità con il latino, ma che ebbe poco seguito. Rimanendo al nostro esempio, gli unici termini ancora usati nella terminologia botanica spagnola sono espiga e racimo, non a caso i più vicini alla forma latina. Solitamente si considera il manuale di Barnades troppo teorico per avere lasciato una traccia permanente, ma certamente contribuì al vero merito del medico e botanico catalano: aver gettato le basi della moderna botanica iberica aprendo la strada alla metodologia linneana, che sarà poi assai approfondita dai suoi successori Casimiro Gomez Ortega e Antoni Palau y Verdera. Tra i suoi allievi, il più noto è José Celestino Mutis, con il quale strinse amicizia durante il suo soggiorno a Cadice e che poi lo seguì a Madrid, dove la sua attività didattica dovette iniziare in modo ufficioso prima della nomina a professore all'Orto botanico, visto che Mutis lasciò la Spagna nel 1760.  Una dedica americana Si deve proprio a lui (con la complicità del figlio di Linneo) l'omaggio al botanico catalano del genere Barnadesia, descritto dal primo ma pubblicato dal secondo in Supplementum Plantarum (1781) con questa breve annotazione: "In memoriam Botanici Hispanici Barnadez dixit Mutis". Questo genere della famiglia Asteraceae, esclusivamente sudamericano, comprende 22 specie di arbusti e piccoli alberi, distribuite dalla Colombia all'Argentina, per lo più andine, tranne una singola specie che dal sudest del Perù si spinge fino al Brasile. Tra le caratteristiche distintive, la presenza di spine lungo i fusti e all'ascella delle foglie, i lunghi peli unicellulari presenti in tutte le parti del capolino e le corolle bilabiate dei fiori del raggio e talvolta anche di quelli del disco. I colori prevalenti delle corolle sono il rosa e il viola; alcune specie producono grandi quantità di nettare, il che ha fatto pensare siano impollinate da colibrì. L'analisi del DNA di Bernadesia e altri generi affini ha segnato un'importante tappa negli studi filogenetici sull'evoluzione delle piante. Nel 1987 un team guidato da Jansen e Palmer scoprì che in questi generi è assente una particolare mutazione (inversione) del DNA, presente invece in tutte le altre Asteraceae (oltre 20,000 specie) e assente nelle altre angiosperme. Ciò significa che questo gruppo (che proprio in base a questa scoperta è andato a costituire la sottofamiglia Barnadesieae - 10 generi e 85 specie) è il più antico delle Asteraceae, precedente la mutazione che si ipotizza sia avvenuta tra 38 e 42 milioni di anni fa. Le Barnadesiae sono piante molto attraenti soprattutto al momento della fioritura, ma sono raramente coltivate al di fiori dei paesi d'origine: piante d'altura delle Ande tropicali di cui si è detto che ogni giorno si sperimenta l'estate e ogni notte l'inverno, vivono in condizioni estreme difficili da riprodurre ad altre latitudini o in serra. A Santa Maria dell'Anima, la chiesa della nazione tedesca a Roma, un tempo si poteva leggere la commovente epigrafe funebre di un giovane rapito agli amici da una febbre crudele; era di carattere gentile ed amabile; pieno di talento, conosceva le erbe e sapeva svelare i segreti della natura a quelli più vecchi di lui; non contento di aver esplorato la Germania, era venuto in Italia spinto dalla sete di conoscenza. Ma la natura matrigna, che non ammette che si carpiscano i suoi segreti, lo spazzò via, a soli ventinove anni. Quel "giovane meraviglioso" era il botanico tedesco Valerius Cordus, morto a Roma l'ultima settimana di settembre 1544 martire del suo amore per il sapere, il primo di una lunghissima serie di naturalisti periti per la scienza. Cresciuto tra le erbe fin dalla culla, come ricorda Plumier dedicandogli il genere Cordia, se il destino gli avesse concesso ancora qualche anno forse avrebbe cambiato la storia della botanica. Talis pater, talis filius Intorno al 1515, Heinrich Ritze (1485-1535) viveva nel villaggio di Simsthausen dove lavorava come cancelliere della vedova del langravio; fare lo scrivano non era ciò che sognava da ragazzo, quando frequentava la scuola latina di Marburg e i circoli umanistici dell'Assia. Poi si era iscritto all'università e aveva cominciato a farsi conoscere per i suoi versi in latino; aveva persino trovato uno splendido pseudonimo: Euricius Cordus, il bravo Enrichetto nato tardi (era l'ultimo di tredici figli). Ma mancavano i soldi per continuare gli studi; era stato costretto a tornare al paesello, si era trovato un lavoro, e a poco più di vent'anni si era sposato. Forse si sarebbe rassegnato, ma non voleva questo destino per i suoi figli, che intanto si stavano moltiplicando (ne ebbe in tutto otto). A loro voleva dare altre opportunità, e seguire di persona la loro educazione. Fu così che a quasi trent'anni Euricius Cordus tornò sui banchi dell'università di Erfurt e si laureò in lingue antiche e filologia. Insieme a due amici, il poeta Eobanus Hessus (che in realtà si chiamava Koch) e Joachim Camerarius il vecchio (che invece si chiamava Kammermeister) nel 1520 aprì una scuola latina a Erfurt. Non potevano scegliere un momento peggiore, con il paese scosso dalla Riforma luterana, alla quale tra l'altro tutti e tre avevano aderito con entusiasmo. La scuola chiuse presto i battenti e Euricius, per mantenere la famiglia, decise di diventare medico. Grazie a uno sponsor, partì per l'Italia e si laureò nella prestigiosa università di Ferrara, dove fece in tempo ad essere uno degli ultimi allievi del medico umanista Niccolò Leoniceno, all'epoca ultranovantenne. Dal suo maestro imparò soprattutto due cose: leggere gli antichi con spirito critico e studiare le piante dal vivo, non solo sui libri. Dopo aver lavorato per qualche tempo come medico cittadino a Braunschweig, nel 1527 il langravio Filippo di Assia lo chiamò a insegnare medicina a Marburg, nella prima università riformata. Qui Euricius divenne l'idolo degli studenti e lo zimbello dei suoi colleghi: che razza di professore era, uno che invece di spiegare Dioscoride e Galeno portava i suoi allievi a scarpinare in campagna a cercare piante nei boschi e nei fossi? Cordus, che era famoso per la ferocia dei suoi epigrammi, rispondeva letteralmente per le rime, finché i suoi nemici la ebbero vinta e lo espulsero dal Senato accademico. Dopo sette anni di insegnamento, fu costretto a lasciare l'università e trasferirsi a Brema, di nuovo come medico cittadino; qui morì un anno dopo, ad appena 49 anni. Una testimonianza diretta del suo metodo di insegnamento e del suo approccio alla botanica è la sua unica opera sulle piante, Botanologicon (ovvero "Dialogo sulle erbe"), sotto forma di dialogo tra lo stesso Cordus e quattro suoi ex allievi dei tempi di Erfurt. Insieme ai suoi ospiti visitiamo il piccolo orto dei semplici che il medico aveva creato accanto alla sua casa, e poi partecipiamo a un'escursione botanica per raggiungere il più ricco giardino che egli aveva allestito fuori città, una specie di orto botanico ante litteram. Per identificare le piante, uno degli ospiti ha portato due libri: Materia medica di Dioscoride e l'ultima novità editoriale, le prime due parti di Herbarum novae eicones di Brunfels. Prima a casa, dove fanno colazione, poi in giardino, quindi lungo il cammino, i cinque discutono dell'argomento preferito dei botanici del Rinascimento: la corretta identificazione delle piante di Dioscoride. Cordus è un grande filologo (e il più importante poeta satirico del Rinascimento tedesco), ma la sua conoscenza delle piante non è libresca: deriva dalla consuetudine quotidiana e amorevole. E' stato in Italia, e, a differenza di Brunfels, gli è chiaro che le piante che crescono in Germania non sono le stesse dei paesi mediterranei e non ha senso cercare di identificarle a forza con le piante di Dioscoride. Tanto meno bisogna fidarsi delle etichette dei vasi dei farmacisti, che spacciano tutt'altro sotto i nomi delle piante degli antichi. Purtroppo il suo libro, un dialogo dotto in latino, senza figure, non è mai diventato un bestseller come gli erbari illustrati di Brunfels e Fuchs; Cordus non è mai entrato nel canone dei "padri tedeschi della botanica"; ma oltre a questo piccolo libro, ha dato alla botanica un altro lascito: suo figlio Valerius, che fa capolino in qualche riga del Botanologicon. All'epoca ha quindici o sedici anni e suo padre lo descrive come «un ragazzo diligente e uno studioso osservatore». Fin da piccolissimo, ha dimostrato un ingegno precoce e, come dirà Plumier, è stato allevato tra le erbe fin dalla culla. E' il migliore allievo di Euricius che gli ha insegnato a padroneggiare perfettamente il latino e il greco (tanto che consegue il baccalaureato a sedici anni) ma soprattutto ad amare, studiare, osservare le piante. 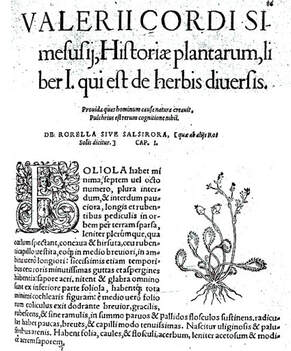 Un giovane geniale e una morte tragica Quando il padre muore, Valerius ha diciannove anni. Va a vivere a Lipsia da suo zio Johannes Ralla (uno degli interlocutori del Botanologicon); studia all'università, ma contemporaneamente lavora nella farmacia di famiglia, e impara tutto quello che c'è da imparare sulla preparazione dei farmaci e anche sulla chimica. Su suggerimento dello zio, scrive un prontuario delle ricette in uso nelle farmacie: per Valerius, è solo un passatempo, un'esercitazione, senza nulla di originale, ma suo zio lo stima tanto che attraverso alcuni amici lo fa pervenire a Norimberga, dove avrà l'onore di essere adottato come farmacopea ufficiale della città, la prima al di là delle Alpi. Nel 1539 Valerius si trasferisce a Witteberg, per completare gli studi e laurearsi in medicina. Tra i suoi insegnanti, c'è anche Filippo Melantone. Contemporaneamente, tiene lezioni in cui commenta Dioscoride; sono molto brillanti e attirano numerosi studenti, anche dall'estero. Uno di loro è il francese Pierre Belon (1517-1564), che ha appena due anni in meno e diventa un amico. Molti anni dopo la morte di Cordus, sulla base degli appunti di qualche allievo, Gessner pubblicherà questi Commentari insieme alla Historia stirpium. Il giovane è assetato di sapere e non tralascia la chimica, tanto che nel 1540 è il primo a sintetizzare l'etere. Si interessa di mineralogia e geologia, ma la sua vera passione sono le piante. Nei momenti di sospensione dell'attività didattica, da solo o in compagnia di amici-allievi come Belon, perlustra la Germania centrale e meridionale, per raccogliere campioni di minerali ma soprattutto per studiare le piante dal vivo, nel loro ambiente naturale. Abbiamo visto che lo faceva anche Bock, ma il suo era un approccio da autodidatta, per così dire d'istinto. Invece Valerius ha una conoscenza perfetta delle lingue classiche, conosce a memoria i testi di Dioscoride e soci, ed è dotato di una strabiliante memoria fotografica: gli basta aver letto la descrizione di una pianta per riconoscerla la prima volta che la vede. Ha una mente filosofica e fin da bambino è abituato a osservare, confrontare, dedurre. Non è interessato solo alle virtù medicinali delle erbe, ma alle piante di per sé e, come avrebbe detto Teofrasto, è alla ricerca di un metodo "proprio" per studiarle. Entro il 1542, ha messo insieme un manoscritto in quattro libri, suddivisi in 446 capitoli, ciascuno dei quali è dedicato a una specie. Nel 1544 si laurea in medicina e parte per l'Italia (dove era già stato due anni prima per seguire corsi a Padova e Ferrara), deciso ad estendere le sue ricerche alla penisola, per verificare se le piante descritte da Dioscoride trovano una più stretta corrispondenza nella flora mediterranea. Vuole anche incontrare i botanici italiani e imparare dalle loro esperienze all'avanguardia. Viaggia con uno dei suoi professori di Wittenberg, il medico e astronomo Hyeronimus Schreiber, e due allievi francesi, uno dei quali molto probabilmente va identificato in Pierre Belon. Visitano molte città, tra cui Padova, Venezia, Bologna e Firenze; a Bologna si trattengono a lungo, per fare visita a Luca Ghini. Verso la metà di settembre sono a Siena, da dove intendono raggiungere Roma attraversando la Maremma. E' una zona notoriamente insalubre, infestata dalla malaria, ma anche ricca di piante particolari, dunque irresistibile per Valerius che si addentra dove non dovrebbe. E' così che molto probabilmente contrae la malaria; forse è già ammalato quando viene ferito a una gamba dal calcio di un cavallo. E' una brutta ferita e la febbre sale rapidamente; i suoi compagni con grande fatica riescono a trasportarlo a Roma, dove sono accolti da altri amici della comunità tedesca. Valerius sembra riprendersi, tanto che Schreiber e i due francesi decidono di proseguire per Napoli; ma quando rientrano a Roma, scoprono che il loro amico è morto. Dopo una battaglia con le autorità pontificie (come luterano eretico il suo cadavere rischia di essere gettato nel Tevere) possono infine farlo seppellire a Santa Maria dell'Anima, la chiesa della nazione tedesca. Il loro strazio e la consapevolezza di quanto sua irreparabile per la scienza la perdita di quella giovane vita traspare dalla lapide funeraria, che purtroppo non esiste più ma ci è stata tramandata da un viaggiatore secentesco: "Per Valerius Cordus di Simsthausen in Assia, figlio di Euricio, medico e poeta. Con il suo carattere innocente, il suo talento e la sua straordinaria gentilezza si guadagnò l'ammirazione di tutti i medici. Lui giovane spiegava a quelli più vecchi i misteri della natura e le virtù delle piante. Dopo aver vagato per la Germania, poiché la sua sete di conoscenza non poteva essere soddisfatta, venne in Italia dove fu tenuto in molto onore, ma era appena arrivato a Roma quando fu spazzato via da una febbre crudele al culmine dei 29 anni, mentre le lacrime degli amici scorrevano per l'insostituibile perdita per la scienza". Seguono alcuni distici che chiamano in causa la natura matrigna gelosa dei suoi segreti e il crudele dio Apollo. Una sintesi della breve vita di colui che possiamo considerare il primo martire della botanica nella sezione biografie. 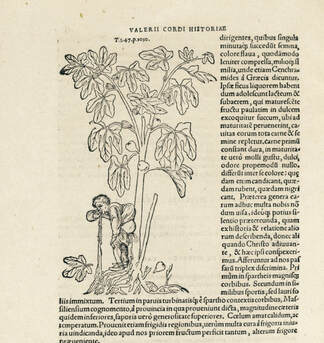 Un'opera pionieristica e la nascita della fitografia Che la perdita per la scienza fosse gravissima è innegabile. Per fortuna, benché giovanissimo, Valerius aveva già scritto molto, ma le sue opere (ad eccezione di Dispensatorium pharmacorum omnium, la farmacopea scritta per Norimberga) vennero pubblicate più di vent'anni dopo la sua morte. Il manoscritto di Historia stirpium venne inviato a Gessner, che ne capì immediatamente il valore e si diede da fare perché fosse stampato; ma purtroppo accettò la proposta dell'editore Rihelius, che deteneva le tavole dell'erbario di Bock, di accompagnare il testo con circa 250 illustrazioni; dato che molte piante non erano mai state descritte in precedenze e Gessner non le conosceva, egli commise molti errori nell'associare le figure al testo; errori che più tardi vennero ingiustamente attributi all'autore anziché al curatore. Nonostante ciò, l'importanza dell'opera di Cordus non sfuggì a grandi botanici come Tournefort e Haller: per il primo egli fu "il primo a eccellere nella descrizione delle piante"; per il secondo fu "il primo a rompere con la dipendenza dalle povere descrizioni degli antichi e a descrivere nuovamente le piante dal vero". Secondo il botanico statunitense Spargue, che ne fu in un certo senso lo scopritore dopo secoli di oblio, "supera di gran lunga Bock per l'esattezza e la natura dettagliata delle sue descrizioni, che ne fanno il vero padre della fitografia". In effetti Cordus, invece di prendere a modello le descrizioni di Dioscoride, come avevano fatto tutti i botanici prima di lui, inventò un metodo del tutto innovativo, che non teorizzò in modo esplicito, ma che è possibile ricavare dalle sue descrizioni. In primo luogo, egli presenta ciascuna pianta dal punto di vista di un osservatore che abbia davanti a sé non un campione di erbario, ma una pianta viva, un esemplare maturo, o almeno nel momento della fioritura; e torna ad osservarla nel momento della fruttificazione, non trascurando mai frutti e semi. La descrizione inizia con la parte più cospicua, più evidente per l'osservatore: per le piante erbacee, prima le foglie, poi il fusto; per le piante con fusto significativo, prima il fusto poi le foglie. Il terzo elemento è il fiore, di cui indica la stagione di fioritura e descrive con precisione analitica calice e corolla. Passa poi al frutto e ai semi, descritti sempre in modo molto preciso, annotando ad esempio il numero di celle, le linee di deiscenza, il numero e la forma dei semi. L'ultimo elemento è quasi sempre la radice, che l'osservatore non vede senza estrarre la pianta dal terreno; è il contrario di quanto facevano gli antichi che partivano proprio da quella, di solito la parte della pianta più importante dal punto di vista erboristico. Per le piante erbacee, se gli è noto, non manca di indicare se sono perenni, biennali o annuali; inoltre aggiunge elementi come il colore, il gusto, l'odore (secondo suo padre, una caratteristica essenziale per il riconoscimento). Benché Valerius avesse lavorato per anni in una farmacia e fosse un esperto di farmaci, le informazioni sulle proprietà officinali sono ridotte al minimo: è chiara la sua intenzione di emancipare la botanica descrittiva dagli usi pratici. Lo schema è applicato sia alle piante nuove (in tutto 66) sia a quelle descritte dagli antichi, di cui non copia mai le descrizioni, come aveva fatto invece lo stesso Bock. Cordus dedicò particolare cura all'osservazione e alla descrizione delle infiorescenze; fu il primo dopo Teofrasto a distinguere le infiorescenze centrifughe (con fioritura dal centro verso l'esterno) e centripete (con fioritura dall'esterno verso il centro), fornendo una descrizione molto precisa delle complesse infiorescenze delle umbellifere. Fu il primo a chiamare corimbo l'infiorescenza di diverse comuni composite, e descrisse con precisione le brattee (anche se il nome non esisteva ancora). Esaminò e descrisse una dozzina di felci (tra l'altro, è il primo a descrivere Matteuccia struthiopteris). A proposito della felce maschio Dryopteris filix-mas scrive: "Cresce copiosamente sulle rocce umide, anche se non produce né fusti, né fiori, né semi. Ma si riproduce da sola per mezzo della polvere che si sviluppa sulla pagina inferiore delle foglie, come tutte le felci". Egli è infatti il primo a capire a grandi linee il meccanismo di riproduzione delle felci e che quella "polvere" è qualcosa di diverso dai semi. In Historia stirpium le piante sono distinte in erbacee (I e II libro), arbustive e arboree (III e IV libro. Dato che nel primo libro sono esaminate "Diverse erbe" e nel secondo "Piante la cui storia è stata trasmessa in modo inesatto dagli antichi, o sono state omesse del tutto", ne consegue che specie, che oggi assegneremmo alla stessa famiglia, o anche allo stesso genere, si trovano separate. Ciò nonostante Greene, che ha studiato molto attentamente i raggruppamenti interni dell'opera di Cordus, dimostra che egli aveva individuato, anche se non esposto in modo esplicito, diversi gruppi naturali, basati fondamentalmente sulle strutture del fiore. E' una grande novità che anticipa di oltre un secolo gli sviluppi della botanica; Cesalpino, che scrive parecchi decenni dopo ed è l'autore del primo tentativo di classificazione delle piante, ignorerà quasi del tutto i fiori, e si baserà invece sui frutti e sui semi (il cui legame con i fiori di cui sono la trasformazione gli era molto meno chiaro che a Cordus); e infatti Greene conclude il suo esame della "tassonomia implicita" di Cordus con queste parole: "Cesalpino, della fine del XVI secolo, è considerato il fondatore della Botanica sistematica. Ma se Valerius Cordus avesse potuto vivere altri ventinove anni, è facile pensare che il grande italiano avrebbe perso i suoi allori".  Cordia, un genere mille usi Come molti botanici del Rinascimento, anche Valerius Cordus deve il suo ingresso nella nomenclatura botanica a padre Plumier, che come sempre sa trovare le parole giuste: "Valerius Cordus di Simsthausen in Assia nacque dal medico e famosissimo poeta Euricius Cordus. Fu sommo commentatore di Dioscoride e felicissimo indagatore di piante precedentemente sconosciute. Fu infiammato dall'esempio di tanto padre, che fin dalla culla volle educarlo tra erbe e fiori". Poi validato da Linneo, il genere Cordia, della famiglia Boraginaceae, comprende circa 250 specie di alberi e arbusti distribuiti nella fascia tropicale e subtropicale di America, Africa, Asia e Oceania. E' presente in vari ambienti, con molte specie notevoli per diverse ragioni. Alcune specie arboree trovano impiego come alberi da legname; quello più pregiato, detto bocote, ricavato da diverse specie messicane e centro americane, è caratterizzato da una piacevole trama zebrata e da proprietà acustiche che lo fanno apprezzare per la costruzione di strumenti musicali; impieghi simili ha il legname di C. dodecandra, noto come ziricote. Molte specie producono frutti eduli, consumati crudi, cotti o come sottaceti, come è il caso di C. dichotoma, una specie asiatica e australiana di ampia diffusione i cui frutti immaturi sottaceto sono una specialità di Taiwan. Il loro nocciolo ha proprietà medicinali, come varie parti di altre specie di questo versatile genere. Non mancano neppure gli usi ornamentali: sono piante dal bel portamento ordinato con vistose fioriture, anche se purtroppo adatte solo ai climi più miti. Forse la più bella, o per lo meno quella che più si fa notare, è C. sebestena, un alberello originario di un'area che va dalla Florida al Centro America, caratterizzato da rutilanti fiori rosso aranciato. Di grande impatto estetico anche due arbusti con fiori bianchi provenienti dagli Stati Uniti meridionali, C. boissieri e C. parviflora, notevoli per la resistenza alla siccità e la prolungata fioritura. Qualche approfondimento nella scheda. Più o meno negli stessi anni in cui Dante Alighieri dà inizio al "poema sacro cui ha posto mano e cielo e terra", più modestamente un giurista bolognese in pensione, Pietro de' Crescenzi, scrive un trattato di agricoltura in cui la lettura dei testi classici è arricchita da ciò che ha visto e appreso nei suoi viaggi nell'Italia settentrionale o ha ricavato dall'esperienza diretta di proprietario terriero. Elaborato tra il 1304 e il 1309, nasce così Liber ruralium commodorum, il primo e l'unico trattato di agricoltura del Medioevo. L'opera gode di immediata popolarità: ce ne sono giunti circa 120 manoscritti; è quasi subito tradotta in toscano e nel 1373 il re di Francia Carlo V la fa tradurre in francese; fin dal 1471 è stampata e entro il 1500 se ne contano 12 incunaboli, seguiti il secolo successivo da numerosissime edizioni in latino e nelle principali lingue europee. Oggi gli studiosi sono divisi sul reale valore del trattato di Crescenzi; Linneo invece lo apprezzò abbastanza da dedicargli il genere Crescentia, i cui frutti sorprendenti hanno dato il nome alle chicchere, le tazzine in cui le dame del Settecento sorbivano il caffè o la cioccolata. 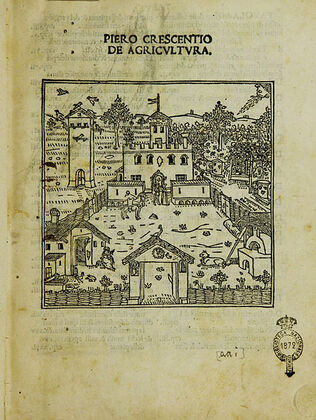 Un giudice in pensione rilancia l'agronomia Nei turbolenti anni a cavallo tra Duecento e Trecento, un giurista formatosi nella prestigiosa università di Bologna aveva una carriera assicurata. Se era nobile o proveniva da una famiglia di magnati, e magari alla competenza giuridica univa il mestiere delle armi, era richiestissimo dai comuni del Nord Italia come podestà; se proveniva dalle classi medie, poteva far parte dello staff podestarile come aiutante, consigliere ed esperto di diritto. Per quasi trent'anni, fu questo il lavoro di Pietro de' Crescenzi. Nato proprio a Bologna, ebbe una formazione ampia e variegata, che comprendeva logica, filosofia, medicina, scienze naturali ma soprattutto diritto. Anche se non conseguì la laurea, poté fregiarsi del titolo di "iudex" e a partire dal 1268 lo troviamo al fianco di vari podestà nei ruoli di assessore e giudice. Quell'anno è a Ravenna, l'anno dopo a Senigallia, nel 1271 a Asti, nel 1283 a Imola, nel 1286 a Ferrara, nel 1287 a Pisa, nel 1293 nuovamente a Imola, nel 1298 a Piacenza. Non furono però le sole località dove soggiornò e lavorò: secondo quanto egli stesso dichiara, fu anche ad Ancona, Bergamo, Chioggia, Cortona, Cremona, Cesena, Forlì, Mantova, Milano, Modena, Padova, Pistoia e Verona. Insomma, in trent'anni di carriera fu un po' dappertutto nell'Italia centro-settentrionale, e dappertutto osservò le coltivazioni e le pratiche agricole. Investì oculatamente ciò che riuscì a mettere da parte in case a Bologna e in terreni attorno a una residenza rurale, Villa dell'Olmo, situata nel territorio di Urbizzano (oggi Rubizzano, frazione di San Pietro in Casale, a circa 25 km da Bologna). Quando si ritirò, divise la sua vecchiaia tra la residenza di Bologna e la villa di campagna. Su sollecitazione degli amici, nacque il desiderio di mettere per iscritto ciò che aveva osservato nella sua carriera itinerante, ciò che egli stesso aveva messo in pratica come proprietario terriero e soprattutto ciò che aveva ricavato da ampie letture degli antichi e dei contemporanei; ormai settuagenario (le date della stesura sono comprese tra il 1304 e il 1309), Pietro de' Crescenzi scrisse così Ruralium Commodorum libri XII , detto anche Liber ruralium commodorum, ovvero "Libro dei benefici agricoli". Prima (e unica) opera complessiva sull'agricoltura dell'Occidente medievale, il trattato di Crescenzi colma una lacuna secolare. Mentre nel mondo islamico (compresa la Spagna, con Il libro di agricoltura del sivigliano Ibn al-Awwan, XII secolo) al progresso delle pratiche agricole si era unita la riflessione teorica, nell'Europa cristiana per trovare un antecedente bisogna risalire addirittura al IV secolo d.C., con il De re rustica di Palladio (una delle fonti principali di Crescenzi). Crescenzi scrive in latino, la lingua dei dotti, e infarcisce il suo trattato di citazioni classiche; ma il suo pubblico di riferimento sono le persone come lui: quei ricchi cittadini del ceto medio che investono nella campagna i guadagni di attività cittadine; desiderano far fruttare le loro terre nel modo migliore, ma anche trarre dalla "villa" (dal significato antico, latino, di "podere", sta incominciando ad assumere quello moderno di dimora signorile di campagna) tutto il piacere possibile. E dunque i commoda ruralia sono sì i benefici materiali, i proventi, delle terre, ma anche gli agi, i piaceri che vi si possono godere: la caccia, le cavalcate, la bellezza e la serenità dei giardini. Senza contare che possedere una proprietà agricola nel contado è anche il più ricercato degli status symbol di questi nuovi ricchi che aspirano ad entrare nella nobiltà, ma ovviamente non dimenticano la propensione all'utile. Crescenzi concepisce il Liber ruralium commodorum come un trattato organico in cui trova spazio ogni aspetto della gestione di un podere agricolo, dalla scelta del terreno, alla costruzione degli edifici rurali, alla scelta delle colture, alla coltivazione delle produzioni principali, in una concezione filosofica che punta all'equilibro tra le parti e il tutto, l'uomo e i quattro elementi (acqua, aria, terra, fuoco). E' stato sottolineato che la maggiore novità dell'opera sta proprio in questo disegno unitario, anche se i contenuti delle singole parti sono quasi sempre ripresi da altre fonti (tanto che non sono mancate le accuse di plagio). Dopo la lettera dedicatoria a Carlo II d'Angiò, re di Napoli, il primo libro tratta dei requisiti della villa e dei criteri di scelta del sito, tenendo conto del terreno, dei venti, del regime delle piogge. Il secondo libro espone i principi generali dell'agronomia, illustra le principali operazioni agricole e fornisce indicazioni per l'analisi del terreno. Si passa quindi alle colture specifiche, con il terzo libro dedicato alle principali colture dei campi (cereali, leguminose, piante tessili), il quarto al vigneto e alla vinificazione, il quinto al frutteto e agli alberi in generale, il sesto all'orto e alle erbe (inclusi i semplici, ovvero le erbe medicinali), il settimo ai prati e ai boschi, l'ottavo ai giardini. Il nono libro, il più lungo del trattato, è interamente dedicato all'allevamento, dal bestiame grosso fino agli animali da cortile, con un'ampia parte riservata ai cavalli. Il decimo libro è dedicato alla caccia (compresa la falconeria) e alla pesca. L'undicesimo libro è un sommario generale dell'opera, mentre il dodicesimo è un calendario delle operazioni agricole mese per mese.  Giardini minimi, mezzani, regali Diamo un'occhiata più da vicino all'ottavo libro, dedicato, come si è detto ai giardini. Già nel sesto libro Crescenzi si era occupato di uno dei tipi di giardino più diffusi nel Medioevo, il giardino d'erbe o verziere, destinato alla coltivazione delle erbe medicinali, ma in questo libro troviamo una trattazione organica dei giardini di piacere. Il primo capitolo (un plagio quasi parola per parola di passi di De vegetabilibus et plantis di Alberto Magno) fornisce indicazioni sulla scelta del sito e la sua accurata preparazione, in modo da poter ospitare con successo una grande varietà di erbe ed alberi. Il giardino deve essere recintato, per proteggerlo dai venti, e deve esserci una fonte d'acqua, se possibile un pozzo o una fontana. Immancabili un prato d'erba fine e dei sedili ricoperti d'erba, alberi o una pergola per donare ombra e frescura, ma badando che l'ombra non sia troppo fitta e lasci circolare l'aria. I vialetti saranno abbastanza ampi da far sì che un ragno non possa tendervi le sue ragnatele. I fiori e le erbe saranno scelti tra quelli odorosi e medicinali, per giovare insieme al corpo e allo spirito. I due capitoli successivi, dedicati ai giardini di dimensioni maggiori, sono invece un contributo originale di Crescenzi. Il giardino mezzano, destinato alla classe media, occuperà da due a quattro iugeri; sarà circondato da fossati o da una siepe di rose o piante spinose; ci saranno alberi da frutto, potati in modo formale e filari di viti; il prato dovrà essere rasato almeno una volta l'anno per conservare la sua bellezza; ci saranno pergole e padiglioni di verzura formati da tralicci rivestiti di rampicanti. Ancora più vasto il giardino regale, che può misurare diversi ettari ed è circondato da muri. E' preferibile che ci sia una sorgente, con canaletti d'irrigazione che alimentano una peschiera; a nord ci sarà un boschetto che dia rifugio ad animali selvatici, inclusi cervi. Per il ristoro e le passeggiate della corte, ci saranno lunghi viali alberati che si dipartono radialmente dal palazzo. Oltre agli alberi da frutto, ci saranno alberi "più nobili" e padiglioni di piante vive, dove il re e la regina possano trovare riparo dal sole o dalla pioggia. E, per destare meraviglia, alberi innestati con diverse varietà di frutta o voliere create sulla chioma degli alberi con rami intrecciati.  L'albero delle zucche... e delle chicchere Ruralium commodorum libri XII ottenne immediato successo. Ce ne sono giunti oltre 120 manoscritti, redatti tra Trecento e fine Quattrocento. Verso la metà del XIV secolo, fu reso accessibile anche a chi non leggeva il latino da una versione in toscano, redatta da un anonimo forse fiorentino e in genere nota sotto il titolo Dell'agricoltura. Nel 1373 il re di Francia Carlo V ordinò che fosse tradotto in francese. L'invenzione della stampa giovò ancora di più alla diffusione del libro di Crescenzi, che fu una delle prime opere ad essere stampata: l'editio princeps, stampata da Schlusser ad Augusta, è del 1471. La seconda edizione, del 1474, è anche il primo libro stampato a Lovanio. Le edizioni di soli incunaboli (ovvero, di libri stampati entro l'anno 1500) sono ben 15. Il successo continuò almeno fino metà secolo, con una ventina di edizioni italiane, 15 edizioni francesi, 12 edizioni tedesche e due edizioni polacche. Poi la sua fortuna cominciò a declinare, mano mano che si scoprivano i testi antichi originali, si affermavano scuole agricole nazionali e nuove tecniche agraricole. In tempi più recenti, a partire dall'Ottocento, gli studiosi si sono divisi sul reale valore dell'opera: chi ne sottolinea il pesante debito con altri autori, tanto da parlare apertamente di Crescenzi come di un plagiario; chi invece indica la vera originalità dell'opera non nelle sue parti, ma nell'impianto complessivo; chi ne mette in rilievo il valore documentario; chi al contrario ne sottolinea il carattere astratto e letterario. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Rimane l'importanza storica del Liber ruralium commodorum, che non sfuggì a Linneo il quale, prima in Hortus Cliffortianus, poi in Species plantarum rinominò Crescentia una pianta già segnalata da Plumier con il nome indigeno Cujete. Il genere Crescentia della famiglia Bignonianceae comprende sei specie di alberi neotropicali, diffusi dal sud degli Stati Uniti al Brasile e al Perù, ma anche introdotti altrove, in particolare nell'Africa occidentale e in Sud Africa. La caratteristica più notevole sono i grandi frutti sferici con la polpa morbida e un guscio sottile ma duro e resistente che è tradizionalmente usato per fabbricare contenitori. La specie più nota e più diffusa è proprio quella tipo, C. cujete, la cui diffusione va dalla Florida meridionale fino al Sud America settentrionale, passando per il Messico, le Antille e l'America centrale. Pianta sacra in molte culture indigene, è stata domesticata da secoli, tanto che è impossibile determinare quale sia la zona d'origine. E' un albero che può superare i dieci metri, spesso con tronchi multipli, chioma leggera irregolare e molto ramificata con foglie semplici ellittiche raccolte su brevi germogli lungo i rami; i fiori nascono direttamente lungo il tronco o i rami principali e sono seguiti da grandi frutti sferici, che possono raggiungere i 25 cm di diametro. Sia per la forma, sia per gli usi del guscio essiccato, questi frutti possono ricordare piccole zucche; da qui i nomi in molte lingue: calabash o gourd tree in inglese, calabasse, calebassier in francese, calabacero in portoghese, cui possiamo aggiungere il nostro "albero delle zucche" (anche se Crescentia, Bignoniaceae, non ha nulla a che fare con le vere zucche, Cucurbitaceae). L'importanza culturale di questo albero è davvero straordinaria: i frutti sono utilizzati per contenitori spesso decorati e con funzioni rituali, ma anche per strumenti musicali. A Haiti se ne ricava il sonaglio sacro emblema del sacerdote vudu; nelle Antille, suppellettili di calabaca sono prescritti nei pasti rituali del movimento rastafariano. In Costa Rica, se ne fanno contenitori spesso coloratissimi utilizzati in feste e balli popolari. In Brasile, oltre che come contenitore, è abitualmente usato come cassa di risonanza del berimbau, uno strumento tradizionale ad arco con funzioni rituali nella capoeira. In Messico, gli Aztechi li tagliavano a metà e li trasformavano in scodelle dette xicalli, usate per sorbire il cioccolato e altre bevande calde; gli spagnoli adattarono il nome nahuatl in jicara, che poi passò alle tazzine in ceramica con la stessa forma e gli stessi usi. E' questa l'etimologia del nostro chicchera, come si spiega in questo articolo. Le altre specie, con un'area di diffusione minore, alcune endemiche di zone limitate, hanno localmente usi analoghi. Di C. alata inoltre la polpa, dal gusto simile a quello della liquirizia, è consumata fresca o in bevande rinfrescanti; inoltre ha usi medicinali. Altre informazioni nella scheda. Con otto edizioni durante la vita dell'autore (l'ultima era un mostro di otto chili di peso) The Gardeners Dictionary di Philip Miller fu la più importante opera di orticultura e giardinaggio del XVIII secolo. Ancora oggi, è un testo di riferimento per chi vuole ricostruire non solo le tecniche orticole del tempo, ma anche la storia dell'introduzione delle piante esotiche in Europa. Miller, grazie ai suoi contatti con raccoglitori, studiosi e collezionisti, ne introdusse in coltivazione a centinaia. Non era però solo un giardiniere (anzi, il "principe dei giardinieri" per dirla con Linneo), ma anche un eccellente botanico educato alla scuola di Ray e Tournefort; per decenni rifiutò ostinatamente sia il sistema sia i nomi di Linneo, con il risultato di "salvare" molte denominazioni prelinneane: i generi che portano il nome assegnato da Miller, spesso recuperato in tal modo, sono dozzine e dozzine. La dedica di Milleria, una curiosissima Asteracea dell'America centrale che fiorì per la prima volta nel giardino di Chelsea dai semi inviati a Miller da uno dei suoi corrispondenti, risale a quest'ultimo, William Houstoun, ma fu fatta propria e validata dall'amico-nemico Linneo.  Una nuova stagione per il giardino di Chelsea Per il Chelsea Physic Garden, ovvero il giardino della Società dei farmacisti londinesi, il 1722 segna una duplice svolta. Fondato nel 1673 per provvedere le piante medicinali per i suoi membri, il giardino sorgeva in un terreno cintato lungo il Tamigi, all'interno della proprietà di lord Cheyne a Chelsea, all'epoca un villaggio di poche case a due miglia da Londra. Dopo un inizio brillante, durante il quale era stato anche stabilito un proficuo rapporto di scambio con l'orto botanico dell'Università di Leida, da qualche tempo, la Società aveva difficoltà a sostenere le spese di affitto e gestione. Nel 1712 Hans Sloane, il medico e naturalista che aveva fatto fortuna con le piantagioni di zucchero e da lì a qualche anno sarebbe diventato il presidente della Royal Society, acquistò la proprietà e appunto nel 1722 decise di cederla in perpetuo alla Società dei farmacisti in cambio di un affitto simbolico di 5 sterline annue, ma a una condizione: ogni anno la Società doveva fornire alla Royal Society 50 esemplari d'erbario di specie nuove, fino a raggiungere un totale di 2000 specie. Un compito che richiedeva un cambio di gestione, e un capo giardiniere all'altezza. Su raccomandazione dello stesso Sloane, al quale a sua volta era stato segnalato dal chirurgo e membro della Royal Society Patrick Blair, il comitato direttivo decise di assumere un giovane e preparato vivaista, Philip Miller. Egli avrebbe mantenuto l'incarico per 48 anni, e avrebbe trasformato il Chelsea Physic Garden nell'orto botanico più importante del mondo. Philip Miller era figlio d'arte e aveva imparato il mestiere dal padre, un giardiniere scozzese che intorno al 1660 si era trasferito a Londra e aveva creato un fiorente vivaio a Deptford, grazie ai cui proventi aveva potuto garantire al figlio un'eccellente educazione. Miller parlava fluentemente diverse lingue e da ragazzo aveva viaggiato a lungo sia in Gran Bretagna sia nei Paesi Bassi, che all'epoca erano il paese più all'avanguardia per le tecniche orticole e floricole. Al momento dell'assunzione, gestiva un proprio vivaio a St George's Fields a Southwark, specializzato nella coltivazione di fiori. Per rispettare la condizione posta da Sloane, il giardino doveva essere rinnovato, in modo da poter accogliere il maggior numero possibile di specie esotiche, coltivate secondo le tecniche più aggiornate. Poiché molte piante esotiche erano delicate e sarebbe stato impossibile coltivarle all'aperto, nel 1727 Miller tornò in Olanda per studiare le più innovative serre olandesi. Propose i suoi progetti al Comitato di gestione e nel 1732 Hans Sloane posò la prima pietra dei nuovi edifici del giardino, incluse una serra fredda e due "stufe", ovvero serre riscaldate con aria calda immessa nelle intercapedini dei muri. Miller introdusse anche la pratica dei lettorini caldi, che aveva ugualmente appreso in Olanda. Per procurarsi piante esotiche sempre nuove, Miller creò una vastissima rete di corrispondenti e fornitori: i colleghi vivaisti, altri orti botanici con cui scambiare esemplari (oltre a quello di Leida e di Parigi, spiccano quelli di Oxford e Edimburgo), studiosi e botanici come lo stesso Linneo, viaggiatori e raccoglitori occasionali o professionisti ai quattro angoli del globo. Tra i corrispondenti più attivi, ad esempio, il chirurgo William Houstoun che gli inviò dal Messico e dai Caraibi (dove prestava servizio sulle navi negriere) numerose specie neotropicali. La sua rete in qualche modo anticipò quello che Linneo fece con i suoi apostoli e quello che Banks (che disponeva di mezzi infinitamente superiori) fece con i cacciatori di piante di Kew. Non c'è bisogno di dire che Miller fu uno dei principali sottoscrittori degli invii di Bartram a Collinson, le famose "Bartram Boxes", cui si deve l'arrivo in Inghilterra di almeno 2000 specie di piante nordamericane. Durante la sua gestione, il numero di specie coltivate a Chelsea passò da 1000 a 4000. Come Kew a fine secolo (all'epoca era ancora soltanto il giardino privato della Principessa di Galles), Chelsea giocò anche un ruolo nell'introduzione di nuove coltivazioni nelle colonie: fu proprio Miller, nel 1732, a inviare a James Oglethorpe, il fondatore della Georgia, i primi semi di cotone da cui sarebbe nata un'intera economia di piantagione. 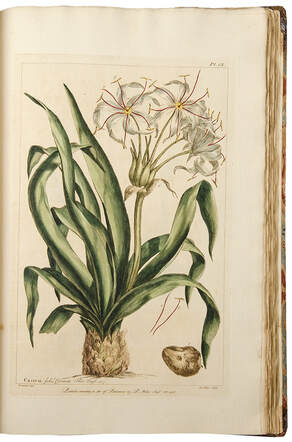 Un capolavoro dell'orticoltura e del giardinaggio L'abilità professionale di Miller era leggendaria. Linneo, che visitò tre volte il giardino di Chelsea durante il suo viaggio in Inghilterra del 1736, lo proclamò "principe dei giardinieri". Ma Miller, vero figlio di quel secolo della divulgazione che fu il Settecento, non tenne per sé le sue conoscenze: fu anche l'autore della più importante opera di orticoltura e giardinaggio dell'epoca, il celebre (e celebrato) The Gardeners Dictionary. L'attività editoriale di Miller iniziò poco dopo l'assunzione a Chelsea, con The Gardeners and Florists Dictionary or a Complete System of Horticulture, due volumi in quarto di quasi 1000 pagine usciti nel 1724. Con la formula del dizionario con voci in ordine alfabetico, è un'opera essenzialmente compilatoria in cui Miller riassunse nozioni riprese da altri testi. Una soluzione che lasciò insoddisfatto per primo lo stesso autore, che invece nelle sue opere successive preferì sempre riscontrare i pareri autorevoli con l'esperienza diretta. L'anno successivo Miller fu tra i fondatori della Society of Gardeners, un club informale che riuniva una ventina di importanti vivaisti dell'area londinese; una volta al mese, gli aderenti si riunivano in un caffè o forse nel vivaio di uno di loro per mostrarsi le piante di nuova introduzione e individuarne il nome preciso. In una fase in cui il mercato inglese era sommerso da incessanti arrivi di piante esotiche, avidamente ricercate dai collezionisti, capitava spesso che la stessa pianta fosse introdotta con nomi diversi; inoltre, il miglioramento delle strade aveva favorito la nascita di un mercato nazionale delle piante e anche in questo caso era frequente che piante autoctone o da tempo introdotte nelle isole britanniche fossero note, e commercializzate, con nomi diversi nelle varie regioni del paese. A più di un vivaista era capitato di dover affrontare un cliente inferocito che, dopo aver pagato a caro prezzo una "novità", aveva scoperta che la possedeva già, sotto un altro nome. I nomi usati dai botanici di professione (siamo in epoca prelinneana) erano lunghissime e inutilizzabili descrizioni in latino, senza contare che variavano da un botanico all'altro. L'unica soluzione era quella di stilare un catalogo collettivo (una specie di antenato di Plant Finder) con la descrizione delle piante e le varie denominazioni. Miller, che era il segretario della società, collaborò attivamente alla stesura del Catalogus plantarum, di cui purtroppo uscì solo il primo volume, nel 1730, dedicato agli alberi e agli arbusti. Subito dopo la società si sciolse. In ogni caso, l'esperienza gli fu poi molto utile per The gardeners dictionary, la cui prima edizione uscì l'anno successivo. L'opera si propone come una vera e propria enciclopedia pratica del giardinaggio, come sottolinea il sottotitolo Containing the Methods of Cultivating and Improving the Kitchen, Fruit and Flower Garden, and the Wilderness, "con i metodi di coltivazione e miglioramento dell'orto, del frutteto, del giardino dei fiori e le piante selvatiche". Voce dopo voce, Miller spiega quali verdure coltivare nel corso dell'anno, come scegliere gli alberi e gli arbusti per parchi e giardini, come coltivare insieme fiori nativi ed esotici; fornisce istruzioni (e illustrazioni) per costruire strutture per il giardino, come lettorini, serre e stufe; elenca e spiega come coltivare nel modo migliore centinaia di piante. Pubblicata in un poderoso in-folio illustrato con 215 carte (ovvero 430 pagine), The gardeners dictionary era un'opera piuttosto costosa; per venire incontro a lettori meno abbienti, nel 1735 Miller ne pubblicò un'edizione ridotta in due volumi in quarto. Da quel momento, fino alla morte, egli non avrebbe cessato di aggiornare e accrescere il suo dizionario, curandone ben otto edizioni successive; l'ultima è del 1768, tre anni prima della morte dell'autore, ed è un mastodonte alto 48 cm, di quasi settecento pagine e otto chili di peso. In un periodo in cui le tecniche orticole erano in costante progresso, e sempre più numerose piante esotiche giungevano in Europa, le edizioni successive del dizionario di Miller sono dunque anche uno strumento straordinario per ricostruire la storia dell'orticultura e datare l'introduzione di nuove specie nel nostro continente. A lungo Miller, che in gioventù aveva conosciuto personalmente Ray, rimase fedele al suo sistema e rifiutò le denominazioni binomiali di Linneo, nonostante la loro evidente praticità. La cocciutaggine di questo giardiniere scozzese scorbutico e di pessimo carattere ha avuto risvolti positivi per la storia della botanica: grazie a lui, molte denominazioni introdotte dai botanici precedenti, e respinte da Linneo, sono state conservate e sono state poi accolte dai botanici successivi. I generi creati da Miller sono decine e decine, e a elencarli ci vorrebbero molte pagine; mi accontento di citare generi "pesanti" come Larix, Castanea, Acacia, Helianthemum, Petasites, Ananas, Cereus, Opuntia, Muscari, Polygonatum, Helichrysum, Foeniculus, Cotinus, Senna. Dopo un'ostinata battaglia durata più di trent'anni, Miller si arrese e, dopo una parziale apertura nella settima edizione, nell'ottava, e ultima edizione del The Gardeners Dictionary adottò finalmente le denominazioni binomie linneane; in fondo, gli affari sono affari, ed era quello che volevano i suoi clienti. Sfogliamola dunque insieme, questa mastodontica ottava edizione. Potete farlo comodamente da casa cliccando qui. Il volume si apre con un dizionario dei termini botanici, seguito da tavole con le varie parti delle piante e le strutture di fiori e frutti. Segue il dizionario vero e proprio, con le voci in ordine alfabetico. Ci sono le tecniche di coltivazione, propagazione, impianto, potatura; le indicazioni per realizzare sentieri, viali, aiuole, siepi, staccionate, grotte, lettorini, serre; i suggerimenti su come prevenire o rimediare ai danni del gelo, del fuoco, della pioggia, della neve e della siccità, di malattie e parassiti. E tante, tantissime piante, nelle intenzioni di Miller tutte le piante coltivate nelle isole britanniche e tutte quelle che vengono "dalle Alpi, i Pirenei, la Boemia, il Levante, l'Egitto, la Siberia, il nord e il sud America, l'est e l'ovest, l'India, la Cina e il Giappone". Ogni voce si apre con il nome generico in latino, seguito da una descrizione in inglese delle caratteristiche comuni al genere; segue poi l'elenco delle specie con il nome binomio e una breve diagnosi in latino, ricavata da Linneo o altri autori; per le specie coltivate, sono fornite dettagliate informazioni sull'origine, la data di introduzione, le varietà, la coltivazione. Dotata di indici in inglese e in latino e di un calendario dell'operazioni orticole, l'opera è anche riccamente illustrata; le piante di nuova introduzione sono accompagnate da tavole disegnate da artisti di grido, tra cui Georg Ehret, che era anche imparentato con Miller, avendo sposato la sorella di sua moglie. Nel 1729 Miller era stato accolto nella Royal Society e contribuì alle Transactions con molti interventi; la sua bibliografia conta non meno di 120 titoli. Il suo lavoro al Chelsea Physical Garden si protrasse fino al 1770, quando, riluttante, dopo uno sgradevole braccio di ferro con il Comitato di gestione, fu costretto al pensionamento. I testi dell'epoca parlano impietosi di "imbecillità e irascibilità dovuta alla tarda età". Malleabile non lo era stato mai. Ma, soprattutto, era cambiato il clima, e l'ostinata resistenza al sistema linneano era diventata imperdonabile; e se Miller si era rassegnato ad accettare la nomenclatura binomiale nel dizionario, non era disposto a fare altrettanto con il sistema di Linneo nelle sue aiuole, ancora rigorosamente ordinate secondo il sistema di Ray. Infatti, uno dei primi compiti del suo successore, William Forsyth, fu riorganizzare le piante secondo il nuovo sistema. Miller non assistette a tanto scempio; morì infatti un anno dopo il ritiro, a ottant'anni d'età (una sintesi della sua vita nella sezione biografie). Ma non finì la vita del suo capolavoro, un testo di riferimento tradotto nella principali lingue europee. A tenerlo aggiornato e a pubblicarne ulteriori edizioni pensarono altri botanici: la più importante è quella curata da George Don, pubblicata tra il 1832 e il 1838 con il titolo A general system of Gardening and Botany, founded upon Miller's Garden Dictionary.  La curiosa Milleria I rapporti tra Miller e Linneo furono quanto meno contraddittori. In occasione delle sue visite a Chelsea nel 1736, lo svedese dovette fare appello a tutta la sua diplomazia per non contrariare lo scorbutico scozzese e farsi donare qualche esemplare per il suo datore di lavoro George Clifford; ovviamente tutti i suoi tentativi di fargli accettare il suo sistema fallirono, anzi Miller sentenziò che "sarebbe stato di corta durata". Nondimeno, tra i due si instaurò una corrispondenza che durò tutta la vita, con scambi di piante e pareri. E Linneo fu prodigo di lodi per The Gardeners Dictionary, anche se era evidente che si poneva in aperta concorrenza con Species plantarum. Di buon grado, accettò anche di far proprio il genere che rendeva omaggio all'amico-nemico, Milleria. Nel 1731, William Houstoun raccolse in Campeche una pianticella piuttosto curiosa di cui inviò i semi a Miller, proponendo di battezzarla in suo onore Milleria. Miller la pubblicò nell'edizione del 1735 del Dictionary, e Linneo accolse la denominazione prima in Hortus cliffortianus, poi nel secondo volume di Species plantarum. Com'è noto, Linneo amava che ci fosse qualche relazione tra la pianta e il dedicatario. In questo caso, i sepali piuttosto corti che si chiudono a coppa potevano suggerire la figura atticciata di Miller, mentre il calice che racchiude totalmente i semi richiamava "l'impegno di Miller per procurarsi rari semi americani e per preservarli", o magari più malignamente la sua riluttanza a dividerli con altri. D'altra parte, Milleria quinqueflora (l'unica specie nota a quel momento e l'unica oggi accettata) è una pianta interessante e curiosa, ma non particolarmente bella, anzi potrebbe rientrare tranquillamente nella categoria delle erbacce. Cioè in quella dove Linneo andava a scegliere le piante da dedicare ai colleghi che ostacolavano il cammino trionfale del suo sistema. Sia come sia, il genere Milleria Houst. ex L. si distingue all'interno della sua famiglia, le Asteraceae, per le caratteristiche singolari del fiori. Monotipico, è rappresento unicamente appunto da M. quinqueflora, abbastanza comune nei terreni disturbati in un'area che va dal Messico al sud America settentrionale. E' un'erbacea annuale piuttosto alta (anche due metri) con esili fusti molto ramificati e foglie cordate in basso e ovate nella parte alta, con nervature evidenti; in estate porta molti minuscoli capolini gialli sottesi da brattee, che da lontano possono richiamare il fiore di una labiata, con il labbro inferiore giallo trilobato; in realtà sono infiorescenze formate da quattro fiori del disco (maschili) che emergono dal ricettacolo a calice e da un unico fiore del raggio (femminile) giallo sgargiante che funziona da richiamo e da pista d'atterraggio per gli impollinatori. Singolare anche il frutto, ovviamente uno solo per capolino, un achenio racchiuso in una specie di borsetta legnosa raggrinzita. Le foglie e gli steli sono usati nella medicina tradizionale per curare le infezioni della pelle. Le radici essiccate sono talvolta vendute come dimagranti. Qualche approfondimento nella scheda. La pubblicazione di The Cactaceae dei botanici statunitensi Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose segna una pietra miliare nella classificazione dei cactus e ne rivoluziona la tassonomia. I quattro volumi, editi tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution for Science, sono anche una sontuosa opera d'arte, grazie ai disegni in bianco e nero e alle tavole a colori, di impressionante precisione, della pittrice britannica Mary Emily Eaton e delle sue collaboratrici; centinaia di fotografie in bianco e nero ne arricchiscono l'apparato iconografico. Anche se da allora le Cactaceae hanno subito numerose revisioni, almeno 50 dei 79 generi stabiliti da Britton e Rose rimangono validi, e i volumi di The Cactaceae sono ricercati da ogni cactofilo. L'opera nasce dalla stretta collaborazione tra Nathaniel Britton, all'epoca direttore del New York Botanical Garden, e Joseph Nelson Rose, un grande e metodico tassonomista al cui il destino ha riservato il ruolo dell'eterno secondo. A ricordarlo i generi Rhodosciadium (Apiaceae) e Roseodendron (Bignoniaceae). 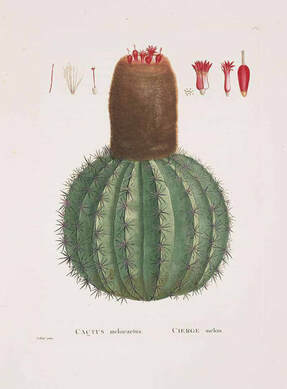 Una classificazione spinosa Come ben sanno gli appassionati di cactus, abituati a fare i conti con continue revisioni e cambi di nome, la classificazione delle Cactaceae è una faccenda spinosa; a ciò contribuiscono diversi fattori: citiamo soltanto la grande variabilità morfologica che spesso rende difficile distinguere specie da specie, specie da sottospecie, specie da varietà; l'alto grado di convergenza evolutiva di queste piante di habitat estremi che fa sì che piante lontane dal punto di vista genetico tendano ad assomigliarsi perché devono affrontare le stesse condizioni ambientali; la difficoltà di raccogliere, seccare e preservare esemplari d'erbario di queste piante spinose, con forme arrotondate e tessuti succulenti. Con la sola eccezione di Rhipsalis baccifera, si tratta di una famiglia esclusivamente americana, in cui gli europei si sono imbattuti con le scoperte geografiche. Probabilmente la prima specie ad arrivare in Europa, forse già con i viaggi di Colombo, fu il fico d'India (qui le Indie sono quelle occidentali) Opuntia ficus-indiae, ma la prima ad essere attestata è un Melocactus "cactus a melone" noto a Londra intorno al 1570. Qualche anno dopo nell'erbario di Tabaernemontanus vengono descritti sia cactus globosi, sia cactus colonnari, che il botanico tedesco chiama Cereus, ovvero "cero, candela". A cavallo tra Cinquecento e Seicento diverse specie sono descritte da altri botanici, come Clusius, L'Obel e Gerard. Pitton de Tournefort pubblica Melocactus e Opuntia, mentre Plumier riporta dai suoi viaggi nelle Antille Pereskia. Questa è la situazione prima di Linneo che nel 1753, in Species Plantarum, descrive 22 specie ma sorprendentemente le raggruppa nell'unico genere Cactus, nome che ricava dal gr. kaktos, una pianta spinosa di Teofrasto non meglio identificata. Più analitico di lui Philip Miller che nella quarta edizione di The Gardener's Dictionary (1754) descrive quattro generi: Cactus, Cereus, Opuntia e Pereskia. Tuttavia, nella nona edizione (1787) farà marcia indietro e si adeguerà alla posizione di Linneo. Poco dopo, nel 1789, Antoine Laurent de Jussieu crea la famiglia Cactaceae. A rimescolare le carte è Haworth che nel 1812 dichiara il genere linneano Cactus inutilizzabile, riservandolo al solo Cactus melocactus L., e lo smembra in Cactus, Cereus, Epiphyllum, Mammillaria, Opuntia, Pereskia e Rhipsalis (creato da Gaertner nel 1788). Nel terzo volume del Prodromus (1828) de Candolle opta per la prudenza, descrivendo sette generi e 174 specie, suddivisi nei grandi gruppi di cactus epifiti e cactus non epifiti. Il grande collezionista principe di Salm-Dyck, che nel suo castello nei pressi di Düsseldorf possedeva la più importante collezione di Cactaceae dell'epoca, in Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (1850) pubblica 20 generi, dividendo la famiglia in due gruppi: Cacteae Rotatae, con fiori a disco, e Cacteae Tubulosae, con fiori tubolari. Nel corso del secolo, mano a mano che gli ambienti aridi del Nuovo mondo vengono esplorati e sempre nuove specie vengono scoperte e inviate ai giardini botanici ma anche ai vivai europei, si aggiunge una grande quantità di specie che i botanici tendono a riunire in pochi grandi generi. Nel 1891 nella sua revisione di Genera Plantarum, Otto Kuntze torna addirittura all'antico, ovvero a Linneo, riconoscendo solo tre generi: i piccoli Pereskia e Pterocactus e un super genere Cactus con oltre 1000 specie. La sistematizzazione più influente a cavallo tra i due secoli è tuttavia la monumentale Gesamtbeschreibung der Kakteen, "Descrizione generale dei cactus", di Karl Moritz Schumann, in tredici volumi pubblicati tra il 1897 e il 1898, con un appendice nel 1903. Rifacendosi soprattutto a Salm-Dick, egli accetta 21 generi e 640 specie. Divide poi la famiglia in tre tribù: Rhipsaloideae, Mammillarieae, Echinocactaceae. Una posizione in parte più aperta è quella di Alwin Berger, curatore dei giardini Hambury, che accetta 41 generi e propone di dividere il vasto genere Cereus in 5 1sottogeneri. E' questa la situazione quando entrano in scena i nostri protagonisti, Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose. 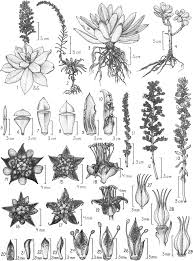 Un botanico taciturno, eterno secondo Britton e Rose incominciarono a studiare le Cactaceae nel 1904; entrambi conoscevano bene le flore degli Stati Uniti, dei Caraibi e del Messico e inizialmente il loro intento era pubblicare una revisione complessiva delle specie nordamericane. Solo più tardi, nel gennaio 1911, Daniel MacDougal, il direttore del Desert Laboratory di Tucson, suggerì loro di allargare le ricerche all'intera famiglia e di chiedere il sostegno finanziario della Carnegie Institution for Science. Di Britton ho già parlato in questo post; è ora di conoscere meglio Rose. Aaron M. Socha, un esperto di cactus che ha lavorato per il Giardino botanico di New York, lo ha definito "un individuo così spiccato che neppure Shakespeare avrebbe potuto renderlo universale". Era un uomo taciturno, riservato, modesto e disinteressato agli onori, ma allo stesso tempo determinato; come botanico, un ricercatore instancabile (qualcuno lo ha definito un "cavallo da tiro"), un descrittore minuzioso e un tassonomista di estremo rigore. Ripercorrendo la sua carriera, a me è sembrato un eterno secondo, un Bartali della botanica. E a Bartali assomiglia anche per la forza di volontà, la bontà d'animo, la generosità, la profonda religiosità. Nato nell'Indiana e rimasto presto orfano durante la guerra di Secessione, studiò nel piccolo college di Wabash; mentre seguiva i corsi post laurea di biologia, divenne assistente del suo professore di botanica, John Merle Coulter, che lo volle al suo fianco per studiare un'altra famiglia difficile, le Apiaceae (a quei tempi, si chiamavano ancora Umbellifere); la collaborazione tra professore e allievo iniziò con Revision of the North American Umbelliferae (1888) e, dopo una serie di articoli su vari generi, culminò con Monograph of the Umbelliferae (1900). Secondo i biografi, a fare il lavoro duro fu Rose, mentre Coulter ebbe piuttosto un ruolo di revisore. Nel frattempo, Rose si era sposato e si era trasferito a Washington per iniziare la sua carriera professionale nel Dipartimento di Agricoltura (USDA) come assistente di George Vasey, botanico capo dell'USDA e curatore dell'erbario nazionale. Rose lo affiancò nella pubblicazione delle raccolte di Edward Palmer in Messico e Centro America, con grande apprezzamento di quest'ultimo che nel 1897 lo invitò ad accompagnarlo in Messico; grazie a questa spedizione, Rose si familiarizzò con il lavoro sul campo e imparò le tecniche di raccolta e conservazione anche di piante difficili come le succulente messicane. Nel 1896 l'Erbario nazionale era passato sotto la giurisdizione dello Smithsonian, e Rose fu promosso assistente curatore di botanica, poi dal 1905 curatore associato. Fu questo il vertice della sua carriera, come notiamo anche dal ruolo di vice presidente - in armonia con il suo carattere e il suo destino - di associazioni attive nella capitale come Botanical Society, Washington Botanical Society, Washington Society, Washington Biological Society (di cui, a dire la verità, dopo essere stato il vicepresidente dal 1909 al 1917, divenne presidente nel 1918). Come assistente curatore dell'USDA, organizzò nove spedizioni in Messico e in Centro America, di cui pubblicò i risultati in Studies of Mexican and Central American Plants, 1897-1911. Intorno all'inizio del secolo, incominciò a corrispondere con Britton, cui inviò molti esemplari per il New York Botanical Garden; entrambi erano particolarmente interessati alle Crassulaecae e a partire dal 1903 incominciarono a scrivere vari articoli a quattro mani su questa famiglia, pubblicati per lo più sul Bollettino del New York Botanical Garden. I loro primi lavori comuni sulle Cacataceae risalgono al 1905. Il progetto suggerito da MacDougall fu presentato da Britton e Rose alla Carnegie all'inizio del 1911 e fu immediatamente approvato. Nel 1912 Rose prese un congedo non pagato dallo Smithsonian e fu nominato ricercatore associato della Carnegie, affiancato da due assistenti, W.R. Fitch e P.G. Russel. Britton, che continuava a dirigere l'orto botanico di New York, fu nominato ricercatore associato onorario (ovvero senza paga), mentre il suo collaboratore R.S. Williams fu incaricato di selezionare e preservare gli esemplari per le illustrazioni. 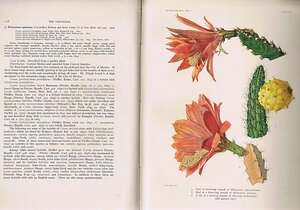 Una rivoluzione tassonomica Quando Britton e Rose incominciano il loro lavoro, la situazione è confusa al massimo grado. Nel corso di un secolo, le specie di cactus, spesso introdotte direttamente non da botanici, ma da raccoglitori di piante al servizio di collezionisti e vivai, si sono moltiplicate a dismisura; e insieme si sono moltiplicati gli errori. Un caos perfettamente descritto dai due botanici nella prefazione del I Volume di The Cactaceae: "descrizioni interpretate scorrettamente, piante identificate in modo sbagliato, errori perpetuati; così la distribuzione geografica di molte specie è stata pubblicata in modo erroneo e le conclusioni basate su dati di questo tipo risultano inaffidabili. Non solo ci sono nomi specifici attribuiti a piante cui non spettano, ma i nomi generici sono diventati interscambiabili e le leggi della priorità sono state ignorate". Quella che Britton e Rose decidono di operare è una rivoluzione; il botanico Lyman Benson ha osservato che, se gli stessi criteri fossero stati applicati a tutte le piante "almeno un milione di piante avrebbero dovuto cambiare nome". Nei quattro volumi di The Cactaceae, i 21 generi accettati da Schumann esplodono e diventano 124, mentre le specie classificate sono 1325. Insomma, per la tassonomia delle Cactaceae, dopo un secolo di prudenza e di enormi super generi, è arrivata l'ora dell'audacia e della suddivisione in molti generi più piccoli, basati sia sulle evidenze morfologiche, sia sulla distribuzione geografica. Anche se i due botanici ottimizzano il tempo, dividendosi il lavoro sia di ricerca sia di scrittura e sono affiancati da una dozzina di collaboratori, il compito è immenso e i cinque anni previsti inizialmente si dilatano a dieci. Bisogna reperire e leggere tutte le descrizioni originali e verificarle quanto più possibile sugli esemplari tipo custoditi negli erbari, quindi confrontarle con le piante vive in coltivazione e/o in natura. Senza dimenticare che il lavoro (1912-1923) verrà a cadere a cavallo della Prima Guerra Mondiale e anche il Messico si chiuderà alle ricerche a causa della rivoluzione messicana. Le Cactaceae vivono nei deserti delle Americhe, ma nell'Ottocento sono state prevalentemente studiate e classificate da studiosi europei, commercializzate da vivai europei e collezionate da collezionisti europei. Ecco perché le ricerche di Rose, già nei primi mesi del 1912, si spostano in Europa. A Londra visita gli erbari di Kew, del Natural History Museum e della Linnean Society e a Parigi l'Hérbier National. Passa poi in Italia dove visita piccole collezioni pubbliche e private di Roma, Napoli, Firenze e Venezia. La tappa principale è però la Riviera, dove Rose va a trovare Alwin Berger; i due botanici corrispondono fin dal 1905, quando Rose aveva scritto a Berger per complimentarsi per il suo studio sulle Cactaceae. E' poi la volta della Germania con gli erbari e gli orti botanici di Monaco e Berlino, la collezione privata di Leopold Quehl ad Halle, il vivaio Haage & Schmidt a Erfurt e l'orto botanico di Darmstadt. Prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, Rose fa ancora un salto ad Anversa per esaminare la collezione privata di Frans de Laet. Le spedizioni sul campo iniziano l'anno successivo. Insieme a sua moglie Elizabeth Knight Britton, all'amica Delia West Marble, membro del Botanical Club, pittrice e fotografa, e al raccoglitore dell'orto botanico di New York John Adolph Shafer, Nathaniel Britton visita le Isole vergini americane, Porto Rico e Curaçao; Rose e i suoi assistenti percorrono Saint Croix, St. Kitts, Antigua e Hispaniola. Nel 1914, mentre in Europa si accendono i fuochi di guerra, Britton torna a Porto Rico per esplorare le isole dell'arcipelago, mentre Rose, accompagnato dalla moglie Lou Beatrice Sims, parte per il suo lungo giro in Sud America. Dopo due brevi tappe in Giamaica e Panama, nel 1915 esplora le zone ricche di cactus di Perù, Bolivia centrale, Cile settentrionale e centrale; come aveva fatto in Europa, a Santiago del Cile esamina le specie tipo raccolte il secolo precedente da Rodolfo Amando Philippi e le specie rare dell'orto botanico. Passa in Brasile, dove studia soprattutto le aree di Bahia e Rio de Janeiro, quindi in Argentina, dove si concentrata sulle province di Mendoza e Cordoba. Come in Europa e in Cile, visita botanici e collezionisti da cui ottiene esemplari e informazioni di prima mano. Nel 1916 Britton è a Cuba insieme a Percy Wilson, mentre Rose e sua moglie concludono il viaggio sudamericano con Curaçao e Venezuela. Per i due botanici è arrivata l'ora del lavoro da scrivania, tanto più che la guerra ora rende difficile gli spostamenti anche in America. Nel 1918, per Rose c'è ancora un viaggio (ad accompagnarlo questa volta è suo figlio Thomas) in Ecuador. Inoltre sono stati coinvolti altri raccoglitori, come J.K. Small inviato nel 1916 in Florida alla ricerca di rare specie di Opuntia o Shafer che nell'inverno 1916-17 fa importanti raccolte in Bolivia, Argentina, Paraguay e Uruguay. Altri esemplari furono inviati da collezionisti, curatori di orti botanici e erbari, studiosi e appassionati. Il primo volume, dedicato alle tribù Pereskieae e Opuntieae, uscì infine nel 1919; il secondo, dedicato alle sottotribù Cereanae e Hylocereanae della tribù Cereae, nel 1920; il terzo, dedicato alle sottotrbù Echinocereanae, Echinocactanae e Cactanae, seguì nel 1922; il quarto, dedicato alle sottotribù Coryphanthanae, Epipyllanae y Rhipsalidanae, completò l'opera nel 1923. Nel 1922 Rose era tornato una seconda volta in Europa, per consultare nuovamente Berger, con il quale aveva continuato a corrispondere, almeno finché la guerra non lo aveva reso impossibile. Ma appena il conflitto era finito, si era affrettato a inviare dall'opulenta America un ricco pacco di cibo all'amico e alla sua famiglia, alle prese con la fame nella Germania postbellica. Pubblicati dalla Carnegie Institution of Science senza badare a spese, oltre ad essere una pietra miliare della botanica, i quattro volumi di The Cactaceae sono una raffinata opera d'arte grazie al ricchissimo apparato iconografico con tavole a colori, disegni e fotografie in bianco e nero nel corpo del testo. A dipingere tre quarti delle 800 tavole fu la pittrice inglese Mary Emily Eaton, che all'epoca lavorava per l'orto botanico di New York; per la precisione del tratto e la vivezza dei colori questa eccellente artista fu definita dai contemporanei "la più grande pittrice di piante dal vivo". A coadiuvarla, un team tutto al femminile: Deborah Griscom Passmore, Helen Adelaide Wood, Kako Morita. Britton e Rose partirono dalle revisioni di Schumann e di Berger, ma si spinsero molto più in là, creando molti generi più piccoli; oltre a correggere le denominazioni di molte specie, ne pubblicarono numerose per la prima volta. Anche se nel secolo che è intercorso da allora la storia tassonomica della Cactaceae ha continuato ad essere travagliata e molte sono state le revisioni, è significativo della qualità del loro lavoro il fatto che ben 50 dei 79 generi da loro creati continuato ad essere accettati, anche se spesso ne sono stati ridefiniti i confini. Inoltre, anche grazie alla splendida veste editoriale, The Cactaceae ebbe anche il merito di destare l'interesse del grande pubblico per una famiglia di piante che all'epoca era ancora poco di moda.  Modeste piante aromatiche e alberi d'oro Terminata l'impresa, Rose riprese il suo lavoro allo Smithsonian. Non cessò però la sua collaborazione con Britton; negli anni '20 i due botanici scrissero insieme la trattazione delle Mimosaceae e delle Caesalpinaceae per la North American Flora. Rose diede ancora prova delle sue grandi capacità di tassonomista ridefinendo il super genere Cassia, il cui status all'epoca era estremamente confuso. Egli morì nel 1928, sei anni prima dell'amico e compagno di avventura. Nella sezione biografie, una sintesi della vita di questo grande botanico, che il destino e l'ordine alfabetico collocano in seconda posizione anche come autore di The Cactaceae. Vorrei salutarlo con le parole di Alwin Berger che lo definì "uno degli uomini meno egoisti e di animo più gentile che io abbia mai incontrato". Come a Britton, anche a Rose furono dedicati numerosi generi (c'è anche una dedica comune, Brittonrosea Speg., oggi sinonimo di Echinocactus); a essere attualmente validi sono due: Rhodosciadium e Roseodendron. Come abbiamo visto, nella sua lunga carriera di tassonomista specializzato nel riportare ordine nella sistematica di famiglie complicate, i primi lavori di Rose furono dedicati alle Apiaceae. E proprio a questa famiglia appartiene Rhodosciadium, che nel 1889 gli fu dedicato dall'illustre botanico Sereno Watson. Il nome, un composto di rhodon, "rosa" e sciadeion "ombrello", si basa su un gioco di parole tra rose, "rosa" in inglese, e Rose, il cognome del nostro botanico e significa "ombrellifera dedicata a Rose". Il genere è distribuito tra Stati Uniti meridionali e Guatemala e gli sono attribuite da cinque a quindici specie. Sono erbacee perenni degli ambienti montani, con ombrelle rade con pochi fiori viola o giallo-verdastro. E' curioso che proprio Rose nel 1895 abbia separato dal genere dedicato a lui stesso alcune specie messicane, assegnandole al nuovo genere Deanea (oggi non accettato). In rete sono disponibili davvero poche informazioni su questo genere discusso; Rhodosciadium longipes (una specie pubblicata per la prima volta da Rose con il nome Deanea longipes) in Messico, dove è chiamata espico, è considerata una pianta medicinale. Una sintetica presentazione del genere nella scheda. Le ricerche di Rose prima in Messico e poi in Sud America ne hanno fatto una figura quasi leggendaria per i botanici dell'America latina. Non stupisce che Faustino Miranda, forse il più noto botanico messicano, nel separare da Tabebuia due specie abbia voluto dedicare a Rose il nuovo genere Roseodendron (1965), ovvero "albero di Rose". La denominazione di Miranda tuttavia fu presto respinta, e le piante furono assegnate a Cybistax, per poi ritornare a Tabebuia. Ricerche molecolari pubblicate nel 2007 hanno però dato ragione a Miranda, raccomandando di resuscitare Roseodendron. Appartenente alla famiglia Bignoniaceae, comprende due sole specie: R. donnell-smithii, e R. chryseum. R. donnell-smithii è la specie più diffusa; raccolta in Messico da Palmer, fu pubblicata proprio da Rose nel 1892 come Tabebuia donell-smithii. E' un albero magnifico che al momento della fioritura si ricopre di grandi fiori dorati; è nota con il nome colloquiale "primavera"; ha un areale abbastanza ampio (dal Messico meridionale al Guatemala) ma è anche frequentemente coltivata. R. chryseum è invece un endemismo delle foreste aride del Venezuela nordoccidentale e della Colombia settentrionale. Rispetto all'altra specie è di dimensioni minori e presenta infiorescenze meno compatte. Qualche approfondimento nella scheda. C'è chi lo chiama il Plinio tedesco (anche se non era tedesco, ma svizzero, era erudito quanto Plinio, ma molto più dotato di senso critico), oppure il Leonardo svizzero (dato che, oltre a essere un genio poliedrico, era anche un disegnatore di talento, il paragone calza di più). In ogni caso, anche per gli standard del Rinascimento, epoca che coltivò più d'ogni altra l'aspirazione all'uomo universale, lo svizzero Conrad Gessner fu certamente una personalità d'eccezione. Fu teologo, medico, insegnante, linguista, filologo, bibliografo, naturalista, un poligrafo che scrisse degli argomenti più diversi. Per i posteri è il padre di due discipline tanto lontane come la bibliografia e la zoologia, con le enciclopediche Bibliotheca universalis e Historia animalium. Ma per i contemporanei, e forse per lui stesso, era soprattutto un botanico; la morte precoce e improvvisa gli impedì di completare e pubblicare quella che riteneva la vera grande opera della sua vita, l'altrettanto enciclopedica Historia plantarum. Rimasta manoscritta e pubblicata parzialmente solo duecento anni dopo la morte dell'autore, è la grande opera mancata della botanica rinascimentale. A rivelarci il metodo innovativo di Gessner, basato sull'osservazione minuziosa delle piante e sul confronto tra il maggior numero possibile di specie alla ricerca di una chiave di classificazione, sono soprattutto le lettere ai numerosissimi corrispondenti e ancor più i disegni allestiti per il suo magnum opus, sorprendenti per la precisione e per la scelta dei particolari, del tutto inconsueti per l'epoca. Il poligrafo svizzero era anche un alpinista entusiasta, oltre che il primo in età moderna a rimarcare il legame tra la distribuzione delle piante, il terreno e l'altitudine. Inoltre fu uno degli animatori della grande rete di scambio di informazioni, semi, piante, esemplari che caratterizzò l'ambiente naturalistico del Cinquecento; in relazione con molti dei maggiori botanici del suo tempo, influenzò direttamente l'opera di Jean Bauhin, che fu suo allievo. Stimato dai botanici delle generazioni successive, fu ricordato da Plumier (e da Linneo) con la dedica del genere Gesneria, che dà il nome alla famiglia Gesneriaceae.  Una memorabile ascensione Nel 1541, Conrad Gessner (all'epoca aveva ventisei anni) in una lettera all'amico Jakob Vogel, poi pubblicata come dedicatoria dell'opuscolo Libellus de lacte ac operibus lactariis, espresse tutto il suo entusiasmo per le montagne e promise: "Mi propongo per il futuro, finché Dio mi concede di vivere, di scalare le montagne, o almeno di scalare una montagna all'anno". Sappiamo che tenne fede alla promessa, ma di queste escursioni annuali purtroppo ci rimane un solo resoconto: quella della scalata del Grepfstein (1926 m. sul livello del mare), una delle cime del gruppo del Pilatus, alle spalle di Lucerna, nell'agosto 1555. Insieme ad alcuni amici, da Zurigo, dove abitava, Gessner raggiunse Lucerna, dove assunse una guida, dal momento che le autorità cittadine vietavano di accedere al Pilatus da soli. Si credeva infatti che la montagna fosse infestata dal fantasma di Ponzio Pilato, che qui sarebbe stato esiliato e qui sarebbe morto suicida; meglio non sfidare quell'anima in pena, che alla minima provocazione scatenava terribili tempeste! Gessner non ci crede più di tanto e si gode la gita con tutti i sensi: la vista ammaliata dallo spettacolo delle cime e dal magnifico panorama; il tatto piacevolmente solleticato dalle fresche e pure brezze alpine, tanto in contrasto con l'inquinata aria cittadina; l'olfatto deliziato dal profumo dei fiori e delle erbe; persino il gusto è appagato da uno rustico spuntino a base di pane e acqua di fonte: "Dubito che i sensi umani possano assaporare un piacere più grande e più epicureo". Prima di affrontare l'ultimo tratto, nell'ultima malga Gessner vede e ascolta un corno delle Alpi e, quasi per sfida, prova a suonarlo. Quindi la guida li conduce alla cima, attraverso un cammino abbastanza arduo e non segnato da sentieri. Sulla cima, gli amici incidono il loro nome sulle rocce, come hanno fatto molti altri viandanti prima di loro; di Pilato nessun segno, da nessuna parte. Gessner conclude: "Da parte mia, sono inclinato a pensare che non sia mai stato qui". All'andata e al ritorno, il naturalista osserva gli animali (le trote del torrente Rumling, camosci, stambecchi, marmotte) e erborizza, raccogliendo una quarantina di specie diverse. E' affascinato dalla maestosità delle montagne, che per un uomo profondamente religioso come lui è segno e prova della grandezza di Dio, e dalla varietà della natura alpina: "In nessun altro luogo come in montagna è possibile incontrare tanta varietà; a parte ogni altra considerazione, solo in montagna è possibile contemplare e sperimentare le quattro stagioni, estate, autunno, inverno e primavera, riuniti in una sola giornata". Al ritorno a Zurigo, racconterà l'escursione in Descriptio Montis fracti sive Montis Pilati ut vulgo nominant, la prima monografia dedicata alla descrizione di un ambiente alpino, tanto precisa da essere in gran parte valida ancora oggi. In quel laboratorio all'aria aperta che è per lui la montagna, Gessener osserva le piante nel loro ambiente naturale e, secoli prima di Humboldt, è il primo naturalista a intuire l'influenza della temperatura e dell'altitudine sulla distribuzione della flora alpina. Per le sue precise notazioni sull'ecologia delle piante osservate, Descriptio Montis fracti è considerata la prima opera di geografia botanica. 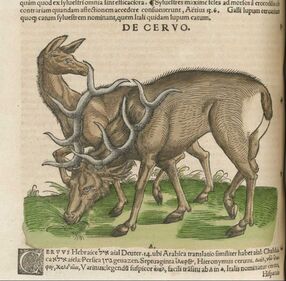 L'opera poliedrica di un genio universale Quando organizza la memorabile escursione, Gessner ha già dato alle stampe Bibliotheca universalis (1545-1549) ed è impegnato nella stesura e nella pubblicazione di Historia animalium (1551-1587). Sono le due grandi opere enciclopediche che hanno consegnato la sua fama ai posteri. Gessner era nato a Zurigo in una famiglia con troppi figli e troppi pochi soldi. Il padre, che secondo alcune fonti era un pellicciaio, era un seguace di Zwingli e morì insieme a lui nella battaglia di Kappel. Il quindicenne Conrad fu affidato a uno zio materno, un canonico che coltivava un piccolo giardino ed era esperto di erbe medicinali; fu lui, a quanto pare, a trasmettergli l'amore per la natura. Per il dotatissimo adolescente iniziava una vita errabonda: sempre a corto di soldi e dipendente dal sostegno finanziario di diversi mecenati, lo troviamo a studiare ebraico a Strasburgo, lingue classiche e medicina a Brouges, teologia e medicina a Parigi. Nel 1535 tornò in patria e a soli 19 anni si sposò con una ragazza povera quanto lui nonché malaticcia. Una scelta che egli stesso anni dopo giudicherà avventata e che lo privò momentaneamente dell'aiuto dei suoi protettori. Per vivere, fu costretto a insegnare per qualche tempo in una scuola elementare. Presto fu perdonato e poté riprendere gli studi di medicina a Basilea, quindi si spostò a Losanna, dove per tre anni (1537-1540) insegnò latino e greco all'Accademia cittadina, appena fondata; fu un periodo relativamente tranquillo, durante il quale godette di una certa tranquillità economica e iniziò a pubblicare i primi scritti di medicina, filologia e filosofia. Risalgono a questi anni anche le prime escursioni nel Giura, nel Vallese e sulle Alpi della Savoia e i primi testi di botanica, in cui l'interesse per le piante si coniuga con quelle per le lingue: Historia plantarum ordine alphabetico ex Dioscoride sumtis descriptionibus, et multis ex Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis (1541), una lista in ordine alfabetico dei nomi di piante che compaiono negli autori dell'età classica e del primo Medioevo; Catalogus Plantarum Latine, Graece, Germanice, et Gallice, un catalogo quadrilingue (1542) in ordine alfabetico dei nomi delle piante in latino, greco, tedesco e francese. Nel 1540, sollecitato dalla città di Zurigo che gli offrì una borsa di studio, Gessner riprese gli studi di medicina a Montpellier; un soggiorno breve, ma decisamente importante, che consolidò le sue conoscenze in botanica e anatomia e gli permise di stringere legami personali con altri studiosi, primo fra tutti Rondelet. L'anno successivo si laureò in medicina a Basilea e tornò a Zurigo; qui, a parte le consuete escursioni in montagna e qualche viaggio occasionale, sarebbe rimasto fino alla morte, mantenendosi con vari incarichi: lettore di Aristotele al Carolinum; medico capo della città dal 1554; docente di fisica, scienze naturali ed etica al Carolinum dal 1557 alla morte, avvenuta nel 1565 in seguita a un'epidemia di peste. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Negli anni zurighesi Gessner pubblicò numerose traduzioni e edizioni di testi classici, soprattutto di argomento medico, e scrisse copiosamente di teologia, medicina, linguistica, zoologia, botanica. Soffermiamoci solo sulle opere maggiori. Subito dopo il ritorno a Zurigo, egli fu impegnato nella stesura della monumentale Bibliotheca universalis: impressionato dalla distruzione della biblioteca di Buda, data alle fiamme dai Turchi, che aveva causato la perdita di numerosi inestimabili manoscritti, egli decise di pubblicare un catalogo completo di tutte le opere "esistenti o no, antiche o più recenti fino ai giorni nostri, dotte o no, pubblicate o conservate manoscritte nelle biblioteche". Dopo tre anni di ricerche, che egli stesso definì "un labirinto", il grandioso catalogo uscì infine a Zurigo nel 1545. E' la prima bibliografia dell'età moderna. Nel 1548, l'erudito svizzero la completò con le Pandectae, un indice tematico in cui i testi sono catalogati in 19 materie e 3000 voci; potremmo definirlo il primo motore di ricerca della storia. Subito dopo, egli iniziò a lavorare alla enciclopedia zoologica Historia animalium, una grandiosa opera in cinque volumi: il primo uscì nel 1551, l'ultimo nel 1587, ventidue anni dopo la morte dell'autore. L'intento di Gessner era presentare tutti gli animali conosciuti, nonché una bibliografia di tutte le opere di storia naturale a partire dall'antichità. In mancanza di un criterio di classificazione globale soddisfacente, gli animali, divisi in quadrupedi (I volume), ovipari (II volume), uccelli (III volume), pesci e animali acquatici (IV volume), serpenti e scorpioni (V volume), compaiono in ordine alfabetico; tuttavia alcune grandi categorie sono raggruppate insieme: ad esempio, tutti i bovini sono trattati sotto la voce Bos e tutte le scimmie sotto la voce Simia. Historia animalium è indubbiamente un'opera contraddittoria, con un piede nel passato e uno nel futuro. Da una parte è una compilazione erudita, in cui si riversa il patrimonio di conoscenze zoologiche ereditato dall'antichità o anche dal folklore, tanto che, accanto agli animali reali, non mancano quelli fantastici. Dall'altra parte, Gessner cerca di distinguere i fatti dai miti, e spesso si basa sull'osservazione diretta degli animali e delle loro abitudini; inoltre introduce informazioni sugli animali esotici recentemente conosciuti nelle Americhe o nelle Indie orientali. Di grande rilevanza è poi l'apparato iconografico, con oltre 1500 tavole spesso di grande precisione e realismo. Tra gli autori delle xilografie, va ricordato Albrecht Dürer. Nel 1555, Gessner pubblicò una terza opera notevole, Mithridates sive de differentiis linguarum, che possiamo considerare il testo fondante della linguistica comparata. Il breve opuscolo contiene un elenco in ordine alfabetico di 130 lingue e dialetti, corredato da osservazioni linguistiche, da informazioni sui popoli che li parlano, da esempi testuali e dal testo del Padre nostro in ventisei lingue.  Alla ricerca di una chiave per classificare le piante Nonostante questa mole di lavori in altri campi, il principale interesse di Gessner fin dagli anni di Losanna, quando si era innamorato delle piante alpine del Vallese, era la botanica. Negli anni in cui scriveva le grandi opere erudite, continuava a raccogliere e studiare le piante: nei suoi viaggi ne scoprì almeno 200 specie. Corrispondeva con molti colleghi, con cui scambiava esemplari e osservazioni e talvolta polemizzava, nonostante il carattere mite e conciliante (celebre è la controversia con Mattioli sull'identificazione dell'Aconitum primum di Dioscoride). Negli anni cinquanta, diede alle stampe una serie di brevi opere botaniche, talvolta in forma di lettera, tra cui De raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias ob causas, Lunariae nominantur (1556) in cui si occupa del fenomeno della luminescenza e espone le sue osservazioni sulle differenze tra alcune piante con nomi simili. All'inizio del decennio successivo risale De hortis Germaniae (1561), che contiene la descrizione di varie giardini botanici tedeschi, svizzeri, polacchi, francesi e italiani, incluso quello dello stesso Gessner a Zurigo, piccolo ma ricco di piante particolari; seguono indicazioni per la scelta e la coltivazione delle piante e una lista di piante coltivate in ordine alfabetico. E' interessante sottolineare che non si tratta solo di specie officinali o utilitarie, ma anche ornamentali. Terminata la stesura di Historia animalium (anche se la pubblicazione, come abbiamo già visto, si protrasse per decenni oltre la sua morte), Gessner decise che era venuto il tempo di dedicarsi interamente alle piante. Gli ultimi dieci anni della sua vita furono così consacrati alle ricerche e alla scrittura di un'altrettanto enciclopedica Historia plantarum. Fu un lavoro febbrile, una lotta contro il tempo: da sempre di salute cagionevole, miope e con la vista compromessa dallo studio e dall'uso delle lenti di ingrandimento, il grande naturalista temeva che la sua vita non sarebbe durata abbastanza per consentirgli di portare a termine l'impresa. E, come abbiamo visto, purtroppo non si sbagliava. Nella sua casa, che già da tempo era un piccolo museo naturalistico, incominciarono ad ammassarsi fogli di erbario inviati da amici (come Daléchamps e l'allievo Jean Bauhin, piuttosto nervoso quando il maestro li trattenne molto oltre le promesse), testi di altri botanici con le pagine fitte di annotazioni di mano di Gessner, e soprattutto disegni su disegni. Le oltre 1500 illustrazioni, in gran parte disegnate da lui stesso (era un disegnatore di grande talento) o affidate a collaboratori sotto la sua supervisione, erano diventate il suo principale strumento di lavoro, un modo per fissare sulla carta e rendere evidenti i particolari anatomici di ciascuna specie: ogni pianta era "fotografata" in tutti gli stadi di sviluppo, con tutti gli organi disegnati con la massima precisione e gli ingrandimenti di particolari significativi come i petali, gli organi riproduttivi, il sacco pollinico, i frutti e i semi. Attorno ai disegni, una ragnatela di annotazioni in una scrittura minutissima, con osservazioni sulla località di crescita, le forme di sviluppo, i particolari morfologici, le caratteristiche distintive. Attraverso queste osservazioni e questi disegni, Gessner stava cercando di scoprire una chiave di classificazione del vasto mondo vegetale, i cui confini non facevano che allargarsi con l'afflusso di sempre nuove specie da altri continenti. Una fatica di Sisifo e un fallimento annunciato. Anche se da nessuna parte Gessner ha esposto le sue conclusioni e in Historia plantarum le piante sono effettivamente raggruppate in modo incoerente ed empirico, dai particolari su cui insiste nei disegni e da alcune lettere possiamo ricavare chiaramente che aveva capito l'importanza dei fiori, dei frutti e dei semi per classificare le piante. Non a caso, la sua opera fu particolarmente apprezzata da Tournefort che possedeva una copia di De raris et admirandis herbis fittamente annotata. Inoltre fu tra i primi a distinguere con una certa chiarezza i concetti di genere e specie, scrivendo tra l'altro: "Non esiste quasi pianta che costituisca un genere che non possa essere diviso in due o tre specie. Gli antichi descrissero una specie di genziana. Io ne conosco dieci o più". Abbiamo già anticipato che Historia plantarum rimase incompleta ed inedita. Alla morte dell'autore i disegni furono acquistati da Camerario il Giovane che ne utilizzò una quarantina per il suo Hortus medicus (1588); il manoscritto passò per varie mani e fu parzialmente riscoperto da Trew, che lo pubblicò sotto il titolo Opera botanica tra il 1753 e il 1759, quando ormai era troppo datato per influire sugli sviluppi della scienza botanica. Circa 150 disegni furono scoperti nel 1927 nella Biblioteca di Erlangen; il terzo volume dell'opera, che si credeva perduto, è stato ritrovato solo nel 2013 nella biblioteca dell'Università di Tartu.  Gesneria, tropicali per intenditori L'ammirazione di Tournefort per Gessner era condivisa dal suo amico Plumier, che volle celebrare il botanico svizzero dedicandogli uno dei suoi nuovi generi americani. La dedica di Gesneria fu poi confermata da Linneo, che riteneva Gessner uno dei botanici più importanti delle generazioni precedenti e gli riconosceva il merito di essere stato il primo ad usare la struttura dei fiori come criterio di classificazione delle piante. Grazie a Plumier e Linneo, Gessner è diventato così il patrono non solo del genere Gesneria, ma delle Gesneriacae, una grande famiglia di più di 150 generi e 3500 specie, per lo più tropicali, caratterizzate da fiori vistosi e di grande bellezza. Molto meno nota delle cugine Achimenes, Gloxinia, Sinningia, Streptocarpus o Saintpaulia, anche Gesneria non manca di farsi notare per le fioriture smaglianti. Con circa cinquanta specie di piccoli arbusti, suffrutici ed erbacee perenni, è un genere quasi esclusivamente caraibico, ad eccezione di due o tre specie dell'America meridionale. Le Gesneriae sono vere tropicali, abitanti delle foreste d'altura, dove vivono sulle rocce e sulle pareti rocciose, godendo di ombra luminosa, suolo ricco e sciolto e umidità costante. Condizioni difficili da riprodurre in coltivazione, tanto più che basta che il terreno secchi troppo anche per un breve periodo per ucciderle; ecco perché sono piante da collezione, da coltivare in un terrario o in una serra protetta. Tra le poche specie relativamente diffuse, G. cuneifolia, nativa dei Caraibi orientali; è una erbacea in miniatura con foglie alternate lucide e fiori tubolari arancio vivo. Ne sono stati introdotti anche alcuni ibridi. G. ventricosa, nativa della Giamaica e delle piccole Antille, è invece un arbusto relativamente grande che vive in spazi semi-aperti sulla sommità delle colline nelle foreste pluviali di mezza montagna; ha corolle a imbuto rosso aranciato lievemente ricurve e rigonfie. Qualche approfondimento nella scheda. I secoli centrali del Medioevo tendono alle imprese gigantesche: si costruiscono cattedrali che toccano il cielo, Dante osa un poema che percorre i tre regni ultraterreni, il domenicano Vincenzo di Beauvais in Speculum majus sintetizza in oltre ottanta volumi tutto lo scibile. Non da meno il confratello Alberto di Bollstädt, più noto con il soprannome Alberto Magno, ovvero Alberto il Grande, che espose per i suoi allievi l'intero corpus aristotelico, spaziando dalla teologia, alla morale, alla logica, alla psicologia, ai diversi settori delle scienze naturali. A differenza di Vincenzo, egli non fu solo un compilatore, ma un pensatore originale, che seppe riunire la più stringente logica aristotelica all'esperienza diretta. E' sua l'unica opera di botanica generale nei diciotto secoli che separano Teofrasto dal Rinascimento, De vegetabilibus et plantis, in cui, tra l'altro, fu il primo a distinguere monocotiledoni e dicotiledoni. Lo storico della botanica Ernest Meyer, curatore della prima edizione critica di questa opera, volle celebrarlo con la dedica della bellissima Alberta magna.  Il dottore universale Maestro di san Tommaso, insieme al quale Dante lo fa comparire tra gli spiriti sapienti del cielo del Sole, il domenicano Alberto di Bollstädt, più noto come Alberto Magno, ovvero Alberto il Grande, fu uno dei più grandi pensatori dell'età medievale, un filosofo, un teologo e uno studioso di tale sapienza da essersi guadagnato il soprannome di "dottore universale". Gli sono ascritte almeno venti opere (più altrettante spurie) che spaziano dalla teologia, alla logica, alla metafisica, all’etica, alla politica, alla psicologia, alla astronomia, alla musica, alla mineralogia, alla zoologia e alla botanica. In questo campo, fu anzi l'unico, nel lunghissimo periodo che separa Teofrasto dal Rinascimento, ad aver studiato le piante di per sé, e non per i loro usi pratici, Intorno al 1250, l’ordine domenicano lo incaricò di dirigere lo Studio generale di Colonia, destinato alla formazione dei membri tedeschi dell’ordine. Per “rendere intellegibile” ai suoi allievi la filosofia aristotelica appena riscoperta, Alberto decise di esporla in una serie di commenti, in forma di parafrasi accompagnate da approfondimenti e digressioni. In tal modo, sulla scorta delle opere di Aristotele (vere o presunte), venne a comporre una vera e propria enciclopedia universale, in cui le scienze naturali occupano uno spazio non secondario. Anche se non conosciamo con precisione le date di redazione delle singole opere, è probabile che dopo aver redatto il commento a De anima, in cui si distinguono tre tipi di anima (vegetativa, sensitiva, razionale), Alberto abbia lavorato contemporaneamente al commento delle opere del corpus aristotelico sulle piante (dotate di anima vegetativa) e sugli animali (dotati di anima vegetativa e sensitiva). Per questi ultimi, nel suo De animalibus egli si rifece a tre opere del filosofo greco: Historia animalium, De partibus animalium, De generatione animalium, tradotte all'arabo intorno al 1220 da Michele Scoto e riunite appunto sotto il titolo De animalibus. Il testo di riferimento di De vegetabilibus et plantis è invece lo pseudo aristotelico De plantis, che nel Medioevo veniva attribuito a Aristotele, ma in realtà si deve probabilmente a Nicola Damasceno, storico e filosofo vissuto all’epoca di Augusto. Per arrivare fino al nostro studioso domenicano, queste opere avevano compiuto una strada lunga e tortuosa. A partire dal VI secolo d.C., diversi libri del corpus aristotelico vennero tradotti dal greco in siriaco; nel corso del Medioevo, gli studiosi arabi a loro volta li tradussero in arabo; in questa veste, non molti anni prima della nascita di Alberto approdarono in Europa dove furono tradotti in latino. Di questo gruppo fa parte anche il breve trattato di Nicola sulle piante, tradotto il latino da Alfredo di Sarhesel (Alfredus Anglicus) intorno al 1200. Si trattava di un'operina esile, e certamente insoddisfacente. Alberto ne fece il punto di partenza per una trattazione ben più articolata, arricchita da informazioni ricavate da altre fonti, in particolare il Canone di Medicina di Avicenna e la Practica del medico salernitano Matteo Plateario per le piante officinali, e l’Opus agricolturae di Palladio per l’agricoltura, dall'interrogazione di erboristi e agronomi, ma soprattutto delle osservazioni e dalle indagini dello stesso Alberto, convinto che “in queste questioni la migliore maestra è l’esperienza”.  Logica aristotelica e conoscenza sperimentale De vegetabilibus et plantis comprende sette libri, a loro volta divisi in trattati suddivisi in più capitoli. Il primo libro ha funzione di introduzione. Nel primo trattato, Alberto spiega perché, dopo aver studiato l’anima, è bene dedicarsi ai vegetali, esseri viventi dotati di anima vegetativa. Seguono puoi varie riflessioni (sono le prime “digressioni”) sulla vita delle piante, le loro percezioni sensoriali, le loro manifestazioni. Alberto conclude che quella dei vegetali è una vita nascosta (vita occulta): non possiamo studiare direttamente l’anima delle piante, che lavora in modo inavvertito, mentre si manifesta materialmente nel corpo delle piante e nelle funzioni di nutrizione, crescita e propagazione. Nel secondo trattato, Alberto commenta il primo libro dello pseudo aristotelico De plantis, in una parafrasi che funge quasi da sommario degli argomenti che svilupperà in modo originale nel secondo libro (le parti delle piante, il confronto degli organi dei vegetali con quelli degli animali, la classificazione); segue un’analisi delle differenze tra piante coltivate e piante selvatiche, in termini di collocazione, alimentazione, varietà di frutti, profumo, gusto, propagazione. Il cuore dell’opera di Alberto, la parte più originale e interessante ai nostri occhi, è il secondo libro, anch’esso articolato in due trattati, l’unica “botanica generale” dai tempi di Teofrasto, in cui la logica aristotelica si unisce all’esperienza diretta per studiare le piante nella loro essenza (per principium vitae occultae, “secondo l’essenza della loro vita nascosta”) e nella loro manifestazione materiale. Come già in Aristotele e Teofrasto, le piante sono classificate in alberi, arbusti, suffrutici (olus), erbe e funghi, una categoria introdotta per la prima volta dallo stesso Alberto. Comunque il sapiente domenicano si affretta ad osservare che questa divisione è illogica, perché nel corso del suo sviluppo una pianta può passare da una forma all’altra (come le rose, tra le piante da lui più attentamente studiate, che possono presentarsi come arbusti ma anche veri e propri alberi). Egli passa quindi ad esaminare le singole parti, o organi, delle piante, divisi in tre categorie: organi integrali essenziali (partes integrales essentiales); organi accidentali essenziali (partes accidentales essentiales); organi accidentali non essenziali (partes accidentales non essentiales). Gli organi integrali essenziali sono la linfa (succus) che contiene in sé (in potentia) tutte le altre parti della pianta, e le parti attive della pianta (in actu); queste ultime sono loro volta suddivise in membri organici (membra officilia), ovvero quelli che servono a mantenere l’individuo in vita, cioè la radice (radices), i canali attraverso cui scorre la linfa (venae), i nodi (nodi), il midollo (medulla) e la corteccia (cortex), e membri similari (membra similia) che includono il legno, per gli alberi, e la “carne”, ovvero il fusto, per le erbe. La parti accidentali essenziali sono quelle che servono a conservare la specie, non l’individuo: le foglie, i fiori, i frutti e i semi. Nella loro descrizione, Alberto dimostra eccezionale precisione e grande capacità di osservazione: discute la forma e le dimensioni di vari tipi di foglie, e analizza il fiore come presagio del futuro frutto, descrivendo stami, ovario, colori. Inoltre, trattando della corteccia, è forse il primo a distinguere monocotiledoni (tunicatae, ovvero piante dotate di tunica) e dicotiledoni (corticatae, ovvero piante dotate di corteccia). Gli elementi non essenziali sono le spine, distinte per la prima volta da Alberto in quelle derivate dalla modificazione dei fusti e in quelle derivate dalla modificazione delle foglie. Egli è infatti conscio che gli organi delle piante si trasformano; ritiene ad esempio che i viticci delle viti siano grappoli mai formati. Il terzo libro è occupato da due digressioni, la prima dedicata ai frutti e alle loro differenze rispetto alle altre parti della pianta; segue l’esame di vari esempi di frutti e semi, dei loro colori e dei tipi di germinazione. Nel secondo trattato si studiano vari tipi di gusti e odori di frutti, succhi e semi, un elemento che secondo Alberto (che qui si rifà all’esperienza degli erboristi) è essenziale per riconoscere le diverse specie. Il quarto libro è di nuovo una parafrasi dello pseudo aristotelico De plantis, in quattro trattati. Nel primo si esamina la relazione tra le piante e i quattro elementi; nel secondo si trattano le regioni favorevoli o ostili alla fruttificazione; nel terzo le basi della propagazione e della fruttificazione delle piante dotate di radice (con una lunga digressione sulle differenze tra i vari tipi di spina); nel quarto il colore delle piante, la differenza tra sempreverdi e caducifoglie, la linfa di alberi e erbe, la crescita degli aghi di pino in inverno. I due trattati del quinto libro ospitano altrettante digressioni. La prima integra vari argomenti già esposti in precedenza e aggiunge questioni come se possa esserci fusione tra le anime di due piante che crescono insieme (come l’olmo e la vite) e se le piante possano trasformarsi l’una nell’altra. La seconda si occupa delle virtù delle piante, in associazione con i quattro elementi, con particolare attenzione alle piante alimentari, officinali e magiche. Il sesto libro è un vero e proprio erbario ordinato alfabeticamente, in cui Alberto si rifà a Avicenna e Plateario per le piante officinali, ma attinge ampiamente alle proprie conoscenze dirette per trattare specie dell’Europa centrale e del Mediterraneo. È diviso in due trattati, il primo (in 36 capitoli) dedicato agli alberi, il secondo (in 22 capitoli) a arbusti e erbe; di ogni specie, è fornita la descrizione, l’habitat, le proprietà e gli usi. Infine, il settimo libro, basato fondamentalmente su Palladio, è un trattato di agricoltura.  Un albero fiammeggiante per il protettore dei naturalisti Riconosciuto già in vita come auctoritas per la sua somma sapienza, per i suoi studi nei campi dell'astronomia, dell'astrologia, della mineralogia e dell'alchimia Alberto ebbe anche fama di mago. Si arrivò ad attribuirgli la scoperta della pietra filosofale e sotto il suo nome circolarono diverse opere spurie, la più nota delle quali è il Libro dei segreti, Liber Secretorum Alberti Magni virtutibus herbarum, lapidum and animalium quorumdam, meglio noto come "Grande Alberto", in contrapposizione al "Piccolo Alberto", un libro di magia alchemica e cabalistica comparso all'inizio del XVIII secolo. Quanto alla Chiesa cattolica, nel 1622 Alberto fu beatificato da Gregorio XV; nel 1931, su sollecitazione dei vescovi tedeschi, fu proclamato santo da Pio XI e riconosciuto come dottore della Chiesa; dieci anni più tardi, Pio XII lo dichiarò patrono dei cultori delle scienze naturali. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Come naturalista, fu noto e apprezzato soprattutto in Germania; tra i suoi estimatori, lo stesso Humboldt. Tuttavia a riscoprire il contributo di Alberto Magno alla botanica fu il tedesco Ernest Meyer, che nella sua Geschichte der Botanik (1854-57) scrisse di lui: "Nessun botanico che sia vissuto prima di Alberto può essere paragonato a lui, tranne Teofrasto, che non conosceva; e dopo di lui nessuno ha dipinto la natura in tali vividi colori, o l'ha studiata così approfonditamente, fino all'arrivo di Conrad von Gessner e Andrea Cesalpino. Tutti gli onori, dunque, vanno tributati all'uomo che ha fatto tali stupefacenti progressi nella scienza della natura, da non trovare nessuno, non che lo sopravanzi, ma che lo eguagli nei tre secoli successivi." Meyer, che fu anche il curatore della prima edizione critica di De vegetabilibus, volle onorare Alberto anche con la dedica di una pianta, battezzando Alberta magna E. Mey. (1838) una spettacolare pianta sudafricana. Appartenente alla famiglia Rubiaceae, è un arbusto o un piccolo albero con lucide foglie sempreverdi simili a quelle degli agrumi, verde scuro nella pagina superiore, più pallide in quella inferiore, e smaglianti infiorescenze di fiori tubolari rosso brillante; nel paese d’origine, fiorisce dalla tarda estate all’autunno (tra febbraio e giugno). In passato furono assegnate al genere Alberta altre specie originarie del Madagascar, che tuttavia successivamente sono state trasferite ad altri generi; oggi Alberta è dunque un genere monotipico endemico delle foreste e dei fondi valle del Transkei nelle province del Capo Orientale e del KwaZulu-Natal. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
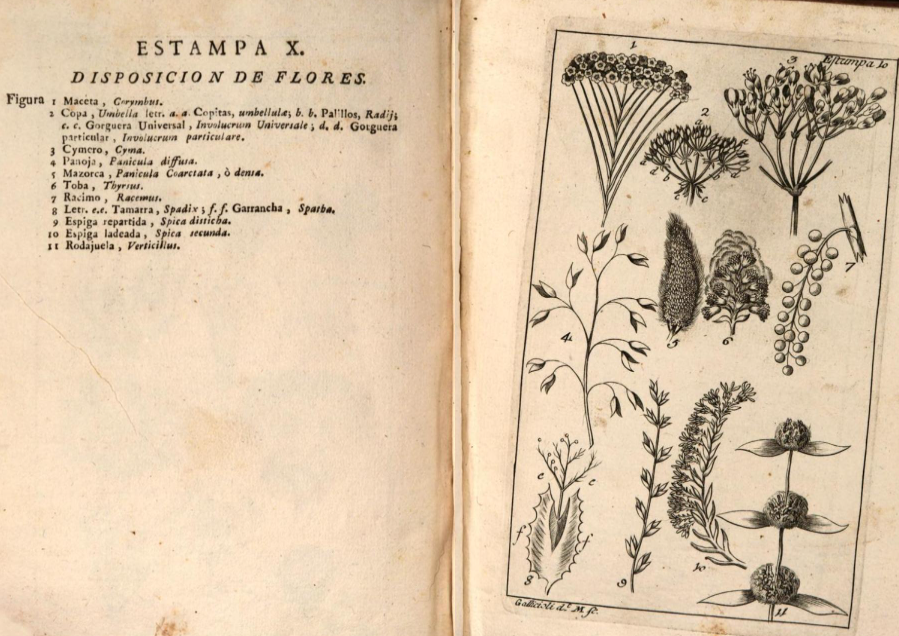

 RSS Feed
RSS Feed