|
All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia). 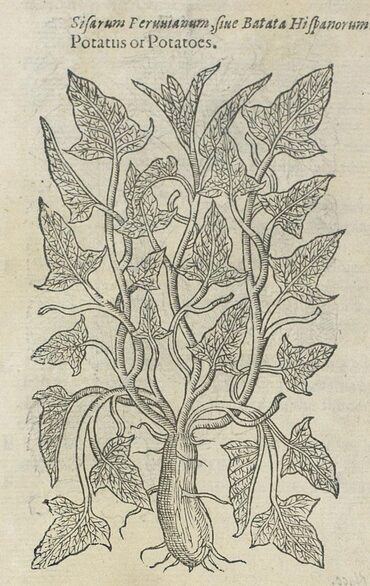 Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa. 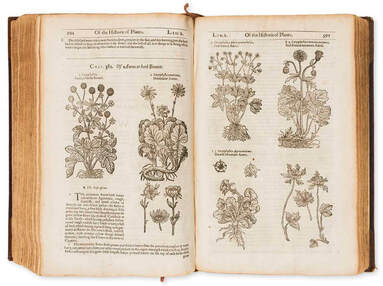 Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice.
0 Comments
Anche se siamo da tempo entrati nell'era dei cataloghi on-line, sono ancora molti i vivai e i negozi di sementi che mettono a disposizione dei clienti cataloghi cartacei. Quasi sempre, si punta sulle immagini, con didascalie e indicazioni ridotte al minimo. In fondo, è ancora il formato inaugurato dal primo catalogo commerciale di piante a noi pervenuto: il Florilegium aplissimum et selectissimun, predisposto dal mercante olandese Emanuel Sweert per la fiera di Francoforte del 1612. Le sue immagini a grandezza naturale sono così belle da aver indotto Linneo a dedicargli l'interessante genere Swertia (Gentianaceae). 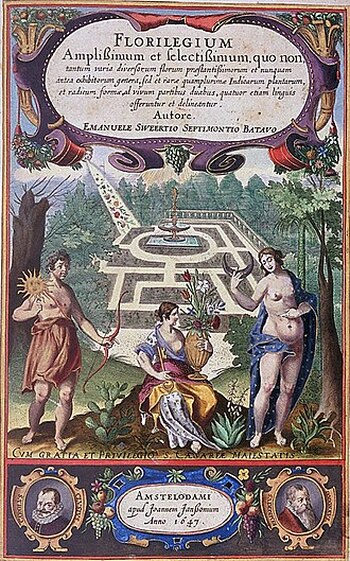 Florilegio o catalogo? Come sempre, anche nell'anno di grazia 1612 la fiera d'autunno di Francoforte aveva attirato visitatori da tutto l'impero e oltre; tra gli stand di maggiore richiamo, quello del mercante olandese Emanuel Sweert; non era la prima volta che partecipava alla fiera, ma quell'anno offriva una selezione particolarmente ricca di bulbi e piante esotiche, portate dalle Indie orientali e occidentali dalle navi della Repubblica delle Province Unite. Diverse vareità si vedevano per la prima volta; e c'era un'altra novità: per permettere agli acquirenti di farsi un'idea di che cosa stavano per acquistare, Sweert aveva fatto stampare un catalogo con più 500 piante magnificamente illustrate. Quell'opera dovette fare sensazione. Era lo spettacolare Florilegium aplissimum et selectissimum, stampato per conto di Sweert da due tipografi della città tedesca, Antonius Kempner e Erasmus Kempffer. Per il grande formato (34 x 21 cm), il numero di tavole (ben 110), la tecnica utilizzata (l'ancora recente calcografia), la bellezza e la cura dei disegni a grandezza quasi naturale, rientrava in un genere editoriale che stava diventando di moda, molto praticato anche da artisti e incisori di Francoforte: il florilegio, ovvero la raccolta di illustrazioni di fiori. Ma era anche altro: appunto uno catalogo commercialedi piante, il primo giunto sino a noi. Quasi tutto ciò che sappiamo sull'uomo che l'aveva commissionato proviene dal catalogo stesso. Emanuel Sweert (o Sweerts, o ancora alla latina Swertius, 1552-1612), come è dichiarato nel cartiglio del frontespizio, era nato a Zevenberger nel Brabante settentrionale, ma si era trasferito ad Amsterdam prima del 1584. Al momento della stampa del Florilegium era sessantenne, come recita la scritta che contorna il suo ritratto anteposto al testo. Nella prefazione Ad candidum lectorem rivela che fin da giovane egli aveva amato viaggiare e collezionare "le mirabili creature di Dio onnipotente" e le curiosità che i marinai olandesi portavano dalle Indie orientali ed occidentali, nonché dalle plaghe australi e settentrionali; ma su ogni cosa ad ispirare la sua massima ammirazione era la straordinaria varietà di piante, alberi, erbe e soprattutto fiori. Che le piante non si limitasse a collezionarle, ma le vendesse la dice esplicitamente l'annuncio pubblicitario stampato sul retro del frontespizio: "Signori, se qualcuno desidera acquistare questo libro e le piante e fiori che vi sono descritti, li troverà nel corso della fiera di Francoforte nella Roemerplatz o nella bottega dell'autore davanti al municipio; oppure, successivamente, alla fiera di Amsterdam e presso il tipografo Paulus Arnoldus van Ravenstein". Che, per inciso, era il marito di una delle sue figlie. Proseguendo nella lettura, risulta chiaro che Swertius era attivo sul mercato internazionale come mercante sia di piante sia di curiosità venute da tutto il mondo (conchiglie, minerali, fossili, insetti e così via) e che il suo migliore cliente era l'imperatore Rodolfo II, che cercò inutilmente di convincerlo a dirigere i suoi giardini a Praga e lo incoraggiò a pubblicare il florilegio-catalogo. Che fosse ben inserito nell'ambiente colto olandese ce lo dicono anche le due liriche che seguono la prefazione; al di là degli elogi sperticati tipici del genere encomiastico, si devono a due personaggi di un certo spessore. Il primo è il poeta neolatino Damas van Blyenburg, autore tra l'altro di una grande antologia di poesia erotica intitolata Veneres Blyenburgicae sive amorum hortus (ovvero giardino degli amori), che raccoglie 1137 poesie di 148 autori, distribuite in cinque "aiuole". Il secondo è Outgers Cluyt (Augerius Clutius), figlio del capo giardiniere dell'orto botanico di Leida all'epoca di Clusius, a sua volta botanico, viaggiatore, raccoglitore di piante e medico ad Amsterdam. Clusius era indubbiamente uno dei numi tutelari di Swertius, che volle fosse ritratto ai piedi del frontespizio, insieme a Dodoens; infatti (lasciando sottotraccia lo scopo commerciale), sempre nella prefazione egli dichiara che il primo scopo del suo libro è ridare vita alle innumerevoli forme delle piante dottamente descritte dai sapienti fiamminghi Dodoens, L'Obel e soprattutto Clusius; ma i loro testi erano corredati di piccole immagini, ben lungi dall'accontentare gli amatori; quindi prosegue "in questo grande formato ho messo ogni diligenza non solo nel rappresentare la vita, ma anche pressoché la grandezza dei fiori e dei loro bulbi o radici, così come crescono d'ordinario". Se ne è dedotto che Swertius fosse anche un'artista botanico (pittore e/o incisore) e fosse l'autore di almeno alcune di quelle splendide immagini. Su questo punto però gli studiosi sono divisi. Per alcuni, egli si limitò a far disegnare e a far incidere a artisti (o meglio ancora artigiani sconosciuti) immagini attinte da opere di Mattioli, Dodoens, L'Obel e Clusius, e per le bulbose da un florilegio pubblicato l'anno prima sempre a Francoforte, il Florilegium novum di Johann Theodor de Bry (il nonno di Maria Sybilla Merian), che a sua volta le aveva in gran parte riprese, a volte ruotandole di 180 gradi, dal florilegio di Vallet e Robin Le Jardin du roy très chrestien Henry IV. Carla Oldenburger-Ebbers pensa il contrario: poiché Sweert ottenne il privilegio di stampa del suo catalogo già nel 1609, le tavole del volume sulle bulbose (tra l'altro, molto migliori tanto nel disegno quanto nell'incisione di quelle del secondo volume, tutte attinte da erbari precedenti) potrebbero essere state preparate prima del 1612, e potrebbe essere stato de Bry a copiare da Sweert e non viceversa. La questione però è tutt'altro che risolta, quindi è impossibile definire lo status professionale dell'olandese: solo vivaista e mercante, o anche pittore e incisore? Da parte mia, propendo per la prima ipotesi: mente de Bry era un brillantissimo incisore, di cui conosciamo molti altri lavori, non ci è nota nessun altra opera di Sweert; difficile pensare che abbia potuto produrre disegni così precisi e raffinati e padroneggiare a tal punto la tecnica dell'incisione a bulino se non fosse stato un professionista. Il suo status di mercante è invece confermato dall'atto di battesimo del più giovane dei suoi figli, Hieronymus, nato nel 1603 (che invece è un pittore noto, padre di un anche più noto omonimo, tipografo, editore, incisore e poeta). Ma è ora di sfogliare questo splendido catalogo. Scritto in quattro lingue (latino, olandese, tedesco e francese) per raggiungere una clientela internazionale, dopo una paginetta con succinte istruzioni di coltivazione, elenca le specie e varietà poste in vendita, con descrizioni essenziali (spesso limitate al colore), seguite dalle tavole calcografiche. E' diviso in due parti o libri. Il primo, più cospicuo, è dedicato alle piante all'epoca più amate e ricercate, ovvero le bulbose, per un totale di 330 specie o varietà e 67 tavole e si conclude con un elenco di "piante esotiche delle Indie orientali e occidentali e altre, che vedono ora la luce con l'opera di Emanuel Sweert, ovvero inedite", in tutto 27, tutte bulbose o rizomatose. Il secondo libro elenca 243 specie tra perenno da fiore e le tipiche piante da aranciera, come limoni, oleandri e melograni, illustrate in 43 tavole. Non mancano però anche altre curiosità, come la melanzana (mala insana), il pomodoro (poma amoris) e la patata (papas americanorum) o i cinque "fiori africani" della tavola 26 che sono riconoscibilissimi Tagetes (per inciso, originari del Messico). Tra le bulbose, tralasciando i generi minori, di cui sono poste in vendita una o due varietà, troviamo in ordine alfabetico 38 varietà di anemoni, 8 di crochi primaverili e 6 di crochi autunnali, 10 di colchici, 4 di ciclamini, 2 di corona imperiale e 7 di fritillaria, 5 di gladioli (compreso il misterioso Gladiolus maximus capitis aut promontorii bonae spei magnitudine alias species superans), 44 di giacinti, 30 di iris, 16 di gigli, 9 di "Moly" ovvero di Allium e affini, 5 di Narcisso-lyrion, ovvero di bucaneve e Leucojum, 55 di narcisi (ma all'epoca sotto quest'etichetta poteva capitare di tutto), 7 di Ornithogalum, 12 di ranuncoli, 10 di Satyrion, ovvero vari tipi di orchidee, 32 tulipani, tra cui diversi di quelli fiammati che di lì a qualche anno avrebbero scatenato la tulipomania. Tra le iris, va segnalata Iris latifolia alba [f]loris caeruleis che Lamarque, attestando che era coltivata da molto tempo al Jardin de Roy, volle battezzare Iris swertii; oggi è considerata sinonimo di Iris pallida subsp. pallida. Tra i Narcissus, all'epoca un'etichetta generica che si assegnava spesso e volentieri a bulbose esotiche ignote, ne troviamo due, uno proveniente dalle Indie orientali, l'altro dalle Indie occidentali, "dette Swertius", che non avevano ancora fiorito, a conferma che il nostro era un importatore, in contatto con capitani e marinai delle Compagnie delle Indie olandesi, ma anche che il mercato era desideroso di accaparrarsi novità anche "a scatola chiusa". L'opera era stampata in bianco e nero, ma ne esistono anche esemplari colorati a mano con maggiore o minore cura, presumibilmente venduti a prezzi diversi. Ebbe un notevole successo, trascendendo lo scopo iniziale (del resto, sia Sweert sia Rodolfo, che secondo la prefazione avrebbe incoraggiato l'opera, morirono in quello stesso 1612), tanto che se ne conoscono diverse edizioni: una uscita ancora a Francoforte nel 1614 presso Kaempfer, e due a Amsterdam, presso Johannes Janson, rispettivamente nel 1646 e nel 1654. Non più un catalogo, ormai, ma un bel libro da sfogliare per godere le figure.  Petali come una tavolozza di pittore Nella didascalia che accompagna il ritratto Sweert è definito "principe dei rizotomi batavi", nel frontespizio della seconda parte "studioso di botanica". Ma fu come pittore (o presunto tale) che Linneo decise di immortalarlo dedicandogli il genere Swertia. In Hortus cliffortianus, separando da Gentiana Swertia perennis, una specie con fiori a stella azzurro-violacei spruzzati di macchie più scure, egli infatti scrive "Ho chiamata Swertia questa pianta, i cui fiori si fregiano di molte screziature, come poste sulla tavolozza di un pittore, da Emanuel Swertius, al quale dobbiamo tante piante egregiamente dipinte". Il genere Swertia (Gentianaceae) comprende oggi più di 150 specie di erbacee perenni, biennali o annuali native degli ambienti subartici, subalpini e montani dell'emisfero boreale e delle montagne dell'Africa tropicale. Sono simili alle genziane, ma hanno fiori a stella raccolti in pannocchie. Anche la nostra flora ne annovera una specie, S. perennis (la specie tipo di Linneo), nota con il nome comune genzianella stellata; piuttosto rara, è presente sparsamente in tutto l'arco alpino, dalle Alpi marittime al Cadore, nonché in poche stazioni dell'Appennino tosco-emiliane. Anche al di fuori della penisola, questa specie, legata all'ambiente delle torbiere umide, ha una distribuzione fortemente discontinua; in Europa vive nelle montagne di orogenesi alpina (oltre alle Alpi, i Pirenei, le Alpi dinariche, i Carpazi, i Sudeti, la Foresta Boema, il Caucaso) ma anche nelle paludi torbose dell'Europa centrale e della Russia; una seconda area va dalla Manciuria al Giappone, e, quindi, attraverso le Curili e le Aleutine, raggiunge l'Alaska e da qui tutta la costa dell'America settentrionale, fino alla California. Si ritiene che il centro di dispersione del genere sia l'Asia; in Cina sono presenti 75 specie e in India 40, anche in questi caso sparsamente disperse nell'Himalaya occidentale e orientale e nei Ghati occidentali. Diverse specie hanno una lunga tradizione di piante officinali. La più nota di questo gruppo è probabilmente S. chirayita, una biennale originaria dell'Himalaya temperato, usata nella medicina tradizionale indiana, pakistana e tibetana per curare una larga gamma di malattie, dai disordini epatici alla malaria al diabete. S. japonica è invece una delle erbe medicinali più popolari in Giappone, apprezzata per le sue virtù stomatiche e antidiarroiche. Sul mercato asiatico, le specie officinali sono molto richieste, tanto che l'eccessiva raccolta in natura ne mette a rischio la sopravvivenza. Al momento, la coltivazione è ancora occasionale o presente in piccole aree. Nonostante l'indubbio valore estetico, rara è anche la coltivazione nei giardini. Tra le poche eccezioni, S. bimaculata, una biennale o perenne di breve vita originaria dell'Asia orientale, con fiori a coppa bianchi puntinati di viola e due vistosi nettari per ogni lobo, talvolta offerta da vivai specializzati. Richiede terreno fresco, acido, umido, e posizioni semi ombreggiate. Dopo la tulipomania, che nel Seicento bruciò tanti capitali, nel Settecento infuriò la giacintomania. Tra le sue vittime, sir James Justice, un legale scozzese che dilapidò tutta la sua fortuna per coltivare piante rare, tra cui appunto i preziosi giacinti doppi che acquistava a caro prezzo in Olanda. Grande sperimentatore di tecniche di coltivazione, fu probabilmente il primo a far fruttificare gli ananas in Scozia, creando per loro una serra riscaldata all'avanguardia. Un successo che gli guadagnò la quasi immediata ammissione alla Royal Society. Nell'arco di pochi anni, alle prese con debiti sempre più enormi, fu costretto a vendere la tenuta di Crichton dove aveva creato il più raffinato giardino di Scozia. Seguirono processi, un divorzio, l'ignominia del carcere per debiti, l'espulsione dalla Royal Society per morosità. Alla sua morte, alla vedova e al figlio bambino rimase un capitale di 60 sterline, ovvero il prezzo a cui veniva venduto al momento della sua apparizione il giacinto 'Gloria florum suprema'. A ricordare Justice rimangono il notevole The Scots Gardiners Director, ma soprattutto il genere Justicia, oggi il più vasto della famiglia Acanthaceae.  Giacinti e giacintomania Il 22 ottobre 1730 la Royal Society ammise un nuovo membro, presentato dal presidente in persona sir Hans Sloane, dal capo giardiniere di Chelsea Philip Miller e da John Martyn, che due anni dopo sarebbe stato nominato professore di botanica a Cambridge. Il nuovo socio era un legale scozzese, sir James Justice (1698-1763), alto funzionario della corte di Edimburgo (Principal Clerk to the Court of Sessions), ma soprattutto appassionato giardiniere. Ad attirare l'attenzione di sponsor tanto prestigiosi erano stati i suoi esperimenti orticoli. Sfidando il rigido clima scozzese, nella sua tenuta di Crichton, a circa 20 km a sud di Edimburgo, egli si era fatto costruire una serra riscaldata all'avanguardia (tra l'altro, una delle poche all'epoca ad avere anche il tetto vetrato) dove era riuscito a fare fruttificare gli ananas. Vi coltivava anche banani, guaiave, piante del cacao e del caffè; era riuscito a far fruttificare anche queste ultime, che avevano dato semi fertili da cui erano nate pianticelle. Fu il momento di massima gloria di Justice, che per tutta la vita (anche quando, come vedremo, non ne aveva più diritto) fece sempre orgogliosamente seguire al suo nome la sigla FRS, Fellow of Royal Society. All'epoca aveva poco più di trent'anni e aveva cominciato i suoi esperimenti orticoli forse intorno al 1727. Apparteneva a una facoltosa famiglia di mercanti e legali scozzesi, la cui parabola - tanto per rimanere nei cliché - ricorda quella dei Buddenbrook. All'inizio, ovviamente, c'è un fondatore, in questo caso il mercante James Justice (morto nel 1711) che fu bailie (magistrato municipale) e prevosto di Edimburgo e acquistò la proprietà di Crichton. Il rappresentante della seconda generazione, anche lui James, entrò a fare parte della nobiltà di toga, aggiungendo un titolo baronale alla tenuta e divenendo Principal Clerk to the Court of Sessions, incarico che mantenne fino al 1727, quando vendette la carica e la riacquistò per il figlio; la terza generazione è appunto quella di James il botanico. Infine la dinastia si chiude con il quarto James, l'unico figlio sopravvissuto, militare noto come "Captain Justice", eccentrico quanto il padre (anche se la sua passione andava più alle fanciulle che ai fiori). La passione del padre James III per l'orticultura era nata in Olanda, dove era stato inviato a laurearsi in giurisprudenza, secondo una consuetudine abituale nella Scozia del tempo. Mentre non provava alcun interesse per la carriera legale, si innamorò dell'orticoltura e del vivaismo olandesi. Per impadronirsi delle tecniche di coltivazione più aggiornate, oltre a frequentare assiduamente i vivai di Haarlem, in un lungo grand tour orticolo dovette visitare anche la Francia ( dove si interessò soprattutto della coltivazione a spalliera di peschi e altri alberi da frutto) e l'Italia. Non conosciamo le date di questo viaggio, che probabilmente si protrasse per diversi anni. Al suo rientro in Scozia, Justice era un raffinato gentiluomo per padroneggiava l'inglese senza "scotismi", il latino, l'olandese e il francese, conosceva bene la letteratura botanica del tempo e le nuove tecniche orticole messe a punto nel continente. Era ansioso di sperimentarle per "migliorare" la tenuta di Crichton. Come il padre era infatti membro della Honourable Society of Improvers in the Knowledge of Agriculture in Scotland, che si proponeva di migliorare l'orticoltura scozzese introducendo tecniche che aumentassero le rese. Certamente piantò alberi e introdusse migliorie nella gestione della tenuta, ma soprattutto si concentrò sulla coltivazione delle esotiche, facendo costruire per loro una serra all'epoca quasi avveniristica. Il suo interesse principale dovette però transitare ben presto alle piante da fiore, in particolare le bulbose. Nel 1730 infatti lo troviamo a Bruxelles, per studiare le tecniche di coltivazione di François Beaulinx, specialista nella produzione di tulipani Bizard da seme. Altri contatti nelle Fiandre e in Olanda erano Jan van Leuwen di Rotterdam, famoso per i suoi Iris persica azzurri, e soprattutto i vivai van Zompel e Voorhelm di Haarlem. Questi ultimi furono all'origine della giacintomania che infuriò in Olanda nella prima metà del Settecento. I giacinti Hyacinthus orientalis all'epoca erano abbastanza diversi da quelli che coltiviamo oggi. Quelli a fiore singolo avevano pannocchie piuttosto rade, con fiori piccoli, ancora simili alle forme selvatiche; occasionalmente nascevano piante a fiore doppio, che inizialmente non suscitarono alcun interesse, anzi i vivaisti si affrettavano a scartarle perché sterili. Nel 1684 il vivaista di Haarlem Peter Voorhelm cadde ammalato, lasciando il vivaio per qualche tempo abbandonato a se stesso; quando poté occuparsi della cernita dei giacinti, ne trovò uno doppio particolarmente bello; scoprì anche che ai suoi clienti piaceva ed erano disposti a pagarlo di più degli altri. Continuò a coltivarlo e a sviluppare nuove varietà. La prima ad aver successo e a scatenare la giacintomania fu 'Koning for Groot Brittanien' (così chiamata in onore di Guglielmo d'Orange, re d'Inghilterra come Guglielmo III), con fiori bianchi e cuore rosa intenso, una robusta varietà ancora segnalata da Loudon all'inizio dell'Ottocento. Al suo apparire, nel 1702, un singolo bulbo costava l'equivalente di 100 sterline. I prezzi erano così alti perché i giacinti doppi erano rari, ci volevano cinque anni per portarli a fioritura, e con il loro insieme di colori eccitavano il gusto del bizzarro, proprio come i tulipani variegati all'origine della tulipomania. La giacintomania raggiunse il suo apice negli anni '20-'30 del 1700, ovvero esattamente nel periodo in cui Justice frequentò l'Olanda prima come studente poi come acquirente di bulbi. I Voorhelm continuavano ad essere il vivaio leader di questa produzione, ma ora erano affiancati da molti altri produttori che ogni anno immettevano sul mercato centinaia di varietà. Tuttavia, avevano imparato la lezione dal crollo della bolla dei tulipani, e nei loro cataloghi offrivano un'ampia gamma di giacinti dai prezzi diversificati, riuscendo a mantenere alti quelli delle novità più pregiate. Così due produzioni dei Voorhelm (molto ammirate da Justice) 'Gloria Mundi', azzurro chiaro con cuore blu scuro, e 'Gloria Florum suprema', bianco neve con cuore scarlatto, al loro apparire furono venduti rispettivamente a 500 e 600 fiorini a bulbo, cioè 50 e 60 sterline. I prezzi raggiunsero il picco tra il 1733 e il 1736, per poi crollare quasi all'improvviso: il mercato ormai era saturo, le varietà veramente di valore erano introvabili, e per vendere i vivaisti furono costretti a tagliare i prezzi. Nei cataloghi del 1738 vediamo 'Staaten General' passare da 210 a 20 fiorini e 'Gekroont Salomon’s Jewel' da 80 a 3. 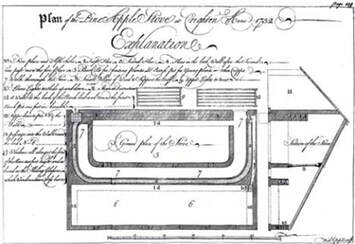 Rovinarsi per le piante In Olanda Justice si era innamorato dei giacinti e non se li fece mancare nel giardino di Crichton, in stile francese, considerato il più bello e raffinato della Scozia. Quanto avesse pagato i suoi giacinti e le innumerevoli altre bulbose che li affiancavano non sappiamo. Ma certo fu vittima, se non della sola giacintomania, della sua irresistibile passione per il giardinaggio. Non badava a spese per far venire bulbi dall'Olanda e per acquistare piante e semi tanto a Londra quanto in Scozia. I guai arrivarono presto; i debiti erano tanti che, per salvare il salvabile, il padre James II predispose un atto di successione a favore del nipote anziché del figlio e si risolse a vendere la tenuta. Nel 1738, poco più di un anno dopo la sua morte, la vendita fu infine conclusa dal nostro James III, con un ricavo di 7000 sterline. Egli tentò anche di impugnare l'atto paterno, ma vi rinunciò, vedendo che era insufficiente a tacitare i creditori. Pagati almeno una parte dei debiti, investì quanto gli rimaneva in una tenuta di minore estensione chiamata Ugston nella parrocchia di Channelkirk (Berwikshire) che da quel momento fu ribattezzata Justicehall. Anche qui piantò alberi e coltivò bulbose, tanto che uno studioso di storia locale ha raccolto la voce che facesse addirittura arrivare la terra dall'Olanda per offrire agli amati bulbi la terra natìa; la notizia è improbabile (come vedremo, tra i più importanti esperimenti di Justice vi era la produzione di terricci su misura per le varie coltivazioni), ma ci dice molto sulla fama di eccentricità del personaggio. A rovinare del tutto la sua reputazione, ai debiti si aggiunse lo scandalo: iniziò una relazione con una giovane domestica e la moglie chiese il divorzio. Ne seguì un'intricata vicenda processuale in cui Justice arrivò ad accusare un ex amico di aver tentato di assassinarlo. Erano condotte che la puritana società scozzese non era disposta a tollerare; così, nell'ottobre 1744 Justice se ne andò in volontario esilio nell'Inghilterra settentrionale, con il risultato di contrarre altri debiti. Tornato in Scozia nel novembre 1746, prese in affitto una casa con giardino ad Edimburgo; era sempre più perseguitato dai creditori (in una lettera li chiama "diavoli") e nel 1748 subì anche una breve incarcerazione per debiti, da cui fu liberato grazie alla malleveria di lord Milton, alto magistrato e suo lontano cugino; con il suo aiuto, cercò inutilmente di liberarsi dell'odiato lavoro in tribunale. Nel 1750 si sposò con la ragazza dello scandalo, che però presto si ammalò e dopo appena due anni lo lasciò vedovo. Seguì un terzo matrimonio, e nel 1755, ormai quasi sessantenne, gli nacque l'unico figlio superstite (il maggiore era morto nel 1750). Nel 1757, non avendo pagato da anni la quota associativa, subì lo smacco di essere espulso dalla Royal Society. Nel 1758 si trasferì nella sua ultima casa, nel distretto di Leigh, dove sarebbe morto nel 1763. Anche qui c'era un giardino, che riempì di fiori, tra cui una spettacolare collezione di auricola; erano piante di grande valore, su cui contava per garantire un gruzzoletto alla moglie e al figlioletto dopo la sua morte. Invece quando la vedova le mise in vendita, ne ricavò solo 20 sterline, un terzo dell'eredità che le rimaneva.  Una guida per i giardinieri scozzesi Nel 1754, a suo dire cedendo alle pressioni di amici ed estimatori, Justice si risolse a mettere per iscritto quanto aveva appreso dalle sue esperienze trentennali in ogni campo dell'orticoltura, trasfondendole in una guida all'orto famigliare e al giardino, The Scots Gardiners Director. Anche se l'identità dell'autore era un segreto di Pulcinella, inizialmente la pubblicò anonima (era pur sempre un rispettabile funzionario); il nome compare nell'edizione del 1759, intitolata The British Gardener's New Director; nell'edizione riveduta del 1764 (uscita postuma) tutte le remore sono cadute: sir James arriva a reclamizzare e porre in vendita alcune delle sue produzioni. Il libro è interessante da diversi punti di vista. Era una delle prime pubblicazioni del genere in Scozia (grazie ad essa, Justice è stato definito il padre dell'orticultura scozzese) ed ebbe un notevole successo, venendo ristampato anche in Irlanda. Era anzi la prima ad essere concepito appositamente per il clima e i terreni della Scozia, tanto diversi da quelli della più temperata e fertile Inghilterra. Soprattutto, non aveva nulla di libresco e si basava su esperienze di prima mano, esposte dall'autore in modo dettagliato e potremmo dire generoso. Così, le pagine di The Scots Gardiners Director sono per noi una specie di macchina del tempo per conoscere le pratiche orticole del Settecento, i successi e i fallimenti di sir James e il mondo del vivaismo olandese (egli vi riportò interi cataloghi delle loro produzioni, in particolare quelle dell'amico Joris Voorhelm, autore a sua volta di uno dei primi trattati sui giacinti). Il volume è diviso i due parti. La prima è dedicata all'orto famigliare; è un orto-frutteto, un walled garden recintato da muri che lo proteggono dal rigido clima settentrionale. Justice fornisce dettagliate istruzioni sull'esposizione ideale, sulla scelta dei fruttiferi più adatti, sulla coltivazione a spalliera e la potatura; spiega come allestire lettorini caldi (incluso uno per i funghi) e muri riscaldati dotati di intercapedini dove far passare aria calda per far maturare l'uva e altri frutti che non riuscirebbero a farlo nel clima scozzese. Non dimentico del suo primo successo, non trascura la coltivazione degli ananas e offre ai lettori due progetti di serre calde. La prima parte si conclude con la rassegna delle orticole e delle erbe aromatiche. La seconda parte (è una novità non trascurabile) è interamente dedicata alla coltivazione dei fiori; si intitola etimologicamente Anthologia, selezione di fiori, e occupa un po' di più della metà del volume. Mentre le piante da aiuola, ad eccezione di poche specie, sono trattate spesso sommariamente, a fare la parte del leone sono le bulbose, che Justice espone seguendo il ritmo delle stagioni, iniziando con l'aconito d'inverno, ovvero Eranthis hyemalis, e i bucaneve, per terminare con i colchici autunnali. E così, con dovizia di indicazioni sulle varietà, la coltivazione, la semina, la preparazione dei terreni, ecco sfilare le epatiche, a proposito delle quali Justice confessa un insuccesso: ripetendo le semine per molti anni, è riuscito a ottenere diversi colori e forme semidoppie, ma mai le varietà doppie disponibili in Olanda; gli economici crochi che l'amico Voorhelm (ne propone 12 varietà) vende a 1 fiorino per 100 bulbi; gli aristocratici iris persiani, che si acquistano a Rotterdam ed è impossibile riprodurre da seme, ma possono essere forzati in vaso per ornarne la casa all'inizio della primavera; i narcisi, di cui ci sono innumerevoli varietà e tipi, da piantare in massa 100 alla volta; i ciclamini rustici; il colchico di Spagna, ovvero Bulbocodium vernum; il dente di cane Erythronium dens-canis. Su Fritillaria meleagris si dilunga per illustrare le tecniche di semina che gli hanno permesso di ottenere sette varietà del tutto nuove entrate a far parte del catalogo Voorhelm; segue la corona imperiale F. imperialis, gloria dei vivai olandesi che la chiamano William Rex e ne offrono almeno quindici varietà. Tra le rarità dei loro cataloghi c'è anche quello che chiamano Lilium persicum, in cui riconosciamo F. persica. A questo punto entrano in scena i giacinti "una delle principali bellezze della primavera". Justice - dichiara subito che sono la sua pianta preferita - dedica loro moltissime pagine, con dettagliate istruzioni su come trattare i bulbi giunti dall'Olanda, su come allestire una root-room per conservarli e moltiplicare i bulbi, sulle semine e sul terriccio ideale, che egli prepara secondo una ricetta di sua elaborazione che comprende sabbia, letame maturo e compost di foglie. Ne aveva già parlato nel suo primo scritto noto, Directions for propagating Hyacinths, pubblicato nel 1743 nelle Transactions della Hourable Society of Improvers. Per i giacinti Justice ha speso capitali, ma anche ottenuto grandi successi; mentre i suoi conterranei, sono costretti a sostituire continuamente i bulbi, lui grazie al suo terriccio e alle perfette tecniche di coltivazione riesce a mantenere i fiori grandi come il primo anno; non parliamo poi delle semine, che gli hanno permesso di ottenere novità di pregio. Nel 1764 Voorhelm gliene dedicherà una commemorativa, 'Mijnherr Justice', un bianco singolo con tocchi di rosa. Justice spiega anche come forzare i bulbi in caraffe di vetro, una tecnica messa a punto pochi anni prima in Svezia e introdotta nel Regno unito dal corrispondente Philip Miller. Per pagine e pagine, egli si profonde quindi nella descrizione di dozzine di varietà; quelle a fiore singolo (10 bianchi, 10 rosa, 16 blu scuro e 20 azzurro chiaro) ammette di averle coltivate tutte; ovviamente va pazzo (e sappiamo fino a che punto) per quelle a fiore doppio, ma forse neppure lui avrà sperimentato tutte le 86 varietà offerte nel 1752 da Voorhlem e van Zompel, che però descrive puntigliosamente, certo in più di un caso per conoscenza diretta. Tra di esse le costosissime 'Gloria mundi' e 'Gloria florum suprema. Ma a suo parere "i più belli dei doppi per il loro colore ammirevole" sono i rossi, di cui menziona 9 varietà. Dopo i giacinti, tocca ai tulipani. Forse sono stati una passione giovanile, e non li trascura, ma è chiaro che il suo cuore va ai giacinti, tanto che non hai mai provato a riprodurli per seme. A paragone, dedica più spazio ai ranuncoli, di cui invece ha praticato la semina su larga scala, ottenendo parecchie pregevoli varietà. Lasciate le bulbose, come si è detto la trattazione si fa più scarna, con qualche eccezione, come le primule orecchie d'orso (Primula auricola); negli ultimi anni della sua vita, quando non disponeva più dei larghi spazi delle tenute di campagna, ma solo di un piccolo giardino urbano, hanno sostituito nel suo cuore i giacinti e per ospitarle degnamente ha persino inventato un apposito scaffale con ripiani doppi. Un'altra eccezione è l'astro della Cina Callistephus chinensis; si trattava in effetti di una new entry nei giardini europei. I primi semi erano approdati dalla Cina al Jardin des plantes di Parigi intorno al 1730 (se ne attribuisce erroneamente l'invio a padre Incarville, che però all'epoca viveva in Canada); qui se li era procurati Philip Miller che aveva incominciato subito a seminarli e a sperimentare la creazione di diverse varietà, ottenendo dopo molti anni le prime doppie. Probabilmente Justice ottenne i semi da lui e ne sperimentò la semina ripetuta, separando i semi delle piante più promettenti, fino a riuscire a produrre addirittura una forma doppia bicolore, che secondo la sua biografa Priscilla Minay rivaleggia con le migliori varietà moderne.  Un grande genere pantropicale Anche se ci è rimasta solo una delle lettere di Justice a Miller, scritta poco dopo l'amissione alla Royal Society, è probabile che i due abbiano corrisposto per molti anni; erano uniti dalle origini scozzesi e da un approccio molto simile all'orticoltura, fatto di prove ed esperimenti ripetuti con tenacia e caparbietà. Forse un conoscente comune era un terzo scozzese, il chirurgo William Houstoun; in un passo di The Scots Gardiners Director Justice mostra di conoscere le sue ricerche su Mirabilis jalapa, mentre Houstoun lo stimava abbastanza da dedicargli uno dei suoi generi di piante americane. Fatto proprio e validato da Linneo, Justicia è oggi il più vasto genere della famiglia Acanthaceae. Distribuito nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo, comprende al momento attuale oltre 900 specie di erbacee perenni, arbusti e suffrutici di morfologia piuttosto variabile; tra i tratti comuni, foglie con nervature molto evidenti e fiori tubolari caratterizzati da una corolla bilabiata con labbro superiore bilobato e labbro inferiore trilobato. Nella sua storia tassonomica, i confini di questo genere si sono più volte modificati. Nella prima metà del Novecento, prevaleva la linea di riconoscere come separati una serie di generi più piccoli, i più noti dei quali per giardinieri e appassionati sono Jacobinia e Beloperone. Nel 1988, uno studio di W. A. Graham ha inaugurato la linea opposta, con un vastissimo genere Justicia diviso in 16 sezioni e 7 sottosezioni, in cui sono confluiti molti generi minori. La soluzione continua a prevalere ed è stata confermata da studi recenti, ma è anche contestata sulla base di evidenze molecolari che dimostrano che Justicia nel senso di Graham è largamente parafiletico, ovvero artificiale. In attesa di cambiamenti che non mancheranno, godiamoci la bellezza di queste piante, apprezzate in natura da farfalle, api e colibrì e da tutti noi nei giardini o nelle serre (purtroppo, con l'eccezione parziale di J. americana, non sono rustiche). E' probabile che molti giardinieri e appassionati conoscano le due specie più note e coltivate sotto i vecchi nomi. La prima è Justicia carnea, in precedenza Jacobinia carnea, un arbusto di origine brasiliana (uno dei centri di diversità del genere) apprezzato per le spettacolari spighe di fiori tubolari rosa. La seconda è Justicia brandegeeana, in passato Beloperone guttata, nota nei paesi anglofoni con il curioso nomignolo shrimp plant, ovvero pianta gamberetto. A suggerirlo sono la forma e il colore delle brattee che sottendono i fiori sovrapposti come i segmenti della corazza di questo crostaceo. Comunque la si voglia chiamare, è un arbusto piacevole e dalle fioriture singolari, che dove il clima lo consente si protraggono per mesi. Tra le altre specie di questo numerosissimo genere, vale la pena di ricordare J. aurea, simile a J. carnea, ma con infiorescenze gialle; J. floribunda, un piccolo arbusto con fiori tubolari penduli bicolori gialli e scarlatti che qualcuno chiama molto impropriamente "fuchsia brasiliana"; la messicana J. spicigera, propria delle foreste aride, con brillanti infiorescenze aranciate, nota anche per le sue proprietà medicinali come depurativo e stimolante. Approfondimenti su queste e altre specie nella scheda. Tra gli amici olandesi di Linneo, Johannes Burman merita un posto speciale: quasi suo coetaneo, fu il primo a fare la sua conoscenza e il primo a garantirgli un lavoro e ad ospitarlo a casa sua. Ma la loro amicizia non fu senza ombre: nacque con il piede sbagliato e poi si interruppe a lungo, per un motivo che oggi a noi pare futile. Poi ricominciò e non mancarono i riconoscimenti reciproci: Burman fu tra i primi ad adottare le denominazioni linneane e a utilizzare il suo sistema nelle aiuole didattiche dell'orto botanico di Amsterdam; si spinse fino a mandare suo figlio a studiare in Svezia (dopo che per generazioni gli aspiranti medici e botanici svedesi avevano fatto il contrario). Linneo gli riconobbe giustamente il merito di aver dato alle stampe ricerche e opere che senza di lui rischiavano l'oblio. Oltre a dedicargli Bibliotheca botanica (che senza la biblioteca di Burman non sarebbe mai stata scritta) lo ricordò con il curioso genere Burmannia.  Antefatti: successi e disavventure del giovane Linneo Nel 1733, il ventiseienne Linneo trascorse le vacanze di Natale a Falun, ospite della famiglia di uno dei suoi amici e allievi, Claes Sohlberg. Il padre era ispettore minerario e gli fece conoscere un giovane teologo appassionato di scienze naturali, Johannes Browallius, che a sua volta lo introdusse presso il governatore della Dalarna, Niels Reuterholm, dei cui figli era precettore. Reuterholm fu così colpito dal racconto della spedizione di Linneo in Lapponia da commissionargliene una analoga nella Dalarna settentrionale. Il viaggio sarebbe avvenuto nell’estate successiva, quando Linneo percorse oltre ottocento km in compagnia di sette dei suoi migliori studenti. A Falun egli incontrò anche l'amore, nelle vesti di Sara Lisa Moraea, la figlia diciassettenne del medico cittadino Johan Moraeus; quando la chiese in sposa, il dottore fu chiaro: prima di poter parlare di matrimonio, il giovanotto doveva essere nelle condizioni di mantenere la famiglia, quindi doveva laurearsi, e per farlo (all’epoca nessuna università svedese conferiva la laurea in medicina) doveva andare all’estero. D’altra parte, la situazione a Uppsala per Linneo si era fatta difficile. Egli era privo sia di mezzi sia di titoli accademici e doveva la sua posizione di simil-assistente al favore del suo maestro, Olaus Rudebeck il Giovane. Quando era ancora uno studente del secondo anno, quest'ultimo lo aveva accolto a casa sua e lo aveva nominato dimostratore di botanica. Linneo era un insegnante nato e le sue lezioni suscitarono l'entusiasmo degli studenti e l'invidia dei suoi detrattori. Il più accanito era Nils Rosén (1706-1773), che prima dell'arrivo di Linneo era stato l'assistente di Rudbeck che l'aveva spedito in Olanda a laurearsi. Dopo aver studiato per quattro anni a Leida con grandissimi maestri, questo giovane medico brillante (che più tardi sarebbe stato salutato come padre della medicina pediatrica), al suo rientro in patria nel novembre 1731 scoprì che il "cuculo Linneo" aveva occupato il suo nido; inizialmente, fece buon viso a cattivo gioco: come assistente dell'altro professore di medicina, Lars Roberg, tenne le letture di anatomia e medicina pratica e seguì anche le lezioni di botanica del suo rivale. Ma contemporaneamente, cercò di scalzarlo dal suo incarico. Infine, nel 1734 riuscì a convincere il senato accademico a vietargli di fare lezione, in quanto privo di laurea. Colmo di rabbia, Linneo l'assalì spada alla mano; fu trattenuto dagli amici e la cosa finì lì, ma le autorità accademiche furono costrette a espellerlo dalla città. Insomma, era ora di cambiare aria. Così, quando Sohlberg padre gli propose di accompagnare il figlio in un viaggio di studio in Olanda, non esitò ad accettare. Nei bagagli, mise i manoscritti delle sue opere, il tamburo e il costume lappone, e nell’aprile 1735 partì insieme a Claes. In programma, aveva non solo di laurearsi, ma di far conoscere il suo sistema in Europa.  Un'amicizia nata con il piede sbagliato Via Amburgo - dove Linneo aveva trovato modo di suscitare le ire del borgomastro, come ho raccontato in questo post - i due amici arrivarono ad Amsterdam il 2 giugno. Immediatamente Linneo, cui non mancava la faccia tosta, andò a presentarsi a Johannes Burman (1706-1779) che, sebbene avesse solo un anno più di lui, da quattro anni era già professore di botanica e direttore dell'orto botanico. Intendeva mostrargli le sue opere, in particolare quella che diventerà Systema naturae, convinto che l'avrebbe conquistato all'istante. Arrogante e pieno di sé, lasciò invece a Burman una pessima impressione. La seconda tappa olandese di Linneo fu Harderwijk, un diplomificio che concedeva la laurea con notevole facilità. Per sbrigare le formalità e presentare la tesi (ce l’aveva già pronta in valigia) gli bastarono due settimane. Il 23 giugno fu proclamato dottore. Subito dopo, andò a Leida dove visitò l’orto botanico e seguì qualche lezione; i soldi stavano rapidamente finendo e stava per rassegnarsi a tornare in Svezia quando incontrò Jan Frederik Gronovius. Anche a lui mostrò Systema naturae e Gronovius ne fu così entusiasta da finanziarne la pubblicazione. Inoltre lo presentò all'illustre professor Boerhaave; ormai anziano e malato, dopo aver diretto per più di vent'anni l'orto botanico di Leida e aver formato generazioni di medici (incluso Burman) si era ormai ritirato, ma continuava ad esercitare un'autorità indiscussa e a riunire intorno a sé un circolo di studiosi più giovani. Linneo gli fece visita più volte nella sua bella casa di campagna Oud Poelgeest, affascinò anche lui con il racconto delle sue imprese lapponi e ne ottenne una lettera di presentazione per Johannes Burman. Munito di credenziali tanto indiscutibili, circa un mese dopo la prima sfortunata visita, Linneo si presentò di nuovo alla porta di Burman che pensò che forse era stato precipitoso a giudicarlo male; lo mise alla prova chiedendogli di identificare una pianta difficile. Sì, lo svedese di piante si intendeva davvero. Era l’assistente di cui aveva bisogno per completare il suo libro sulla flora di Ceylon: Burman, l'astro nascente della botanica olandese, era infatti impegnato nella prima delle sue imprese editoriali: la pubblicazione dell'erbario singalese di Hermann. Per sei settimane, i due nuovi amici lavorarono fianco a fianco nella fornitissima biblioteca del colto e facoltoso Burman, che abitava in una bella casa affacciata sul prestigioso Keizersgracht. Linneo vi poté attingere liberamente per Biblioteca botanica e Fundamenta botanica e in cambio diede un valido aiuto per identificare, catalogare e descrivere le piante singalesi. Il 13 agosto i due si concessero una gita fuori porta: Burman portò Linneo a visitare De Hartekamp, forse il più bel giardino d'Olanda, di proprietà del ricchissimo George Clifford. Come ho raccontato in questo post, fu così che Linneo trovò un nuovo protettore e Burman accettò di separarsi da lui in cambio di una copia di History of Jamaica di Hans Sloane. Alla fine di settembre Linneo si trasferì a Hartekamp e Burman dovette continuare il lavoro da solo (ma le sue visite a Hartekamp erano frequenti e la corrispondenza fitta) e a settembre terminò la redazione di Thesaurus zeylanicus (pubblicato all’inizio del 1737) in cui descrisse alcune centinaia di piante, elencate in ordine alfabetico e illustrate con 110 calcografie. In un'appendice pubblicò anche i cataloghi delle specie raccolte in Sud Africa da Hermann e da Oldenland e Hartog, raccoglitori dell'orto botanico della VOC a Table Bay. A questo punto, come scrisse a Linneo, lo attendeva un compito che considerava un dovere morale: dare finalmente alle stampe l’Herbarium amboinense di Eberhard Rumphius. Un’impresa enorme, considerando che il grande cieco di Ambon aveva descritto e in gran parte disegnato non meno di 1200 specie. Il primo ostacolo fu convincere la VOC a consegnargli il manoscritto e permettergli di pubblicarlo: l'ubicazione delle piantagioni era un segreto di stato. Più difficile ancora trovare un editore e tanto meno incisori non troppo esosi. Nel 1736 Linneo si sdebitò dedicando Bibliotheca botanica al "celeberrimo e espertissimo dr. Johannes Burman, professore di botanica dell'organizzatissimo orto botanico di Amsterdam"; fu ancora suo ospite prima di lasciare definitivamente l'Olanda nel 1737. Spiace dire che poco dopo i contatti tra i due si interruppero. Sembra che Burman fosse arrabbiato con Linneo (che aveva ospitato, mantenuto e introdotto negli ambienti scientifici) perché non gli aveva mai inviato le piante lapponi che gli aveva promesso. Per circa quindici anni, i due permalosi botanici non si scrissero più, finché riallacciarono i contatti intorno al 1753 (il fatidico anno di uscita di Species Plantarum). Anche per Burman erano stati anni pieni. Nell'attesa di poter mettere mano a Herbarium amboinense, scrisse un libro sulle piante sudafricane, Rariorum Africanarum Plantarum, basato soprattutto sulla collezione di Nicolaes Witsen, un altro collezionista e magnate della VOC. Nel 1739, trovato finalmente un editore disposto a correre il rischio, si accinse all'edizione di Herbarium amboinense, un lavoro che lo avrebbe impegnato per sedici anni: il primo volume uscì nel 1741, seguito da altri cinque a intervalli variabili fino al 1750, con un’appendice (Auctarium) nel 1755. Ricordo che, passato attraverso vicende incredibili, il grande libro di Rumphius, a causa della cecità di quest'ultimo, era stato un gran parte dettato in olandese a diversi collaboratori che non conoscevano il latino; quindi Burman dovette tradurlo e dargli una veste linguistica omogenea. Tra il 1755 e il 1760 fu la volta di Plantarum Americanarum, basato sul manoscritto inedito e sui disegni di Charles Plumier. La sua ultima fatica fu un rifacimento dell’indice di Hortus malabaricus con i nomi linneani (1768). Nel 1755 Burman aveva aggiunto ai suoi doveri l'insegnamento della botanica all'Atenaeum illustre e aveva ormai ripreso a corrispondere regolarmente con Linneo, con reciproco giovamento anche per le collezioni degli orti botanici di Uppsala e Amsterdam. Nel 1760 - una scelta che ha il valore di un passaggio di testimone - decise di mandare a studiare a Uppsala suo figlio Nicolaas Laurens (1734-1793), l’unico allievo olandese di Linneo. Egli avrebbe seguito le orme del padre, pubblicando un’opera generale sulla flora tropicale, Flora Indica, e la monografia Specimen botanicum de geraniis. I due Burman divennero in un certo modo i custodi e diffusori dell'opera di Linneo nei Paesi Bassi: furono tra i primi ad aderire alla nomenclatura e al sistema linneano, Johannes a partire dall’appendice di Herbarium amboinense, Nicolaas Laurens per tutte le sue opere; per loro impulso, le aiuole didattiche dell’orto botanico di Amsterdam furono risistemate seguendo il sistema del grande svedese. E come Johannes aveva lanciato la carriera di Linneo, trentacinque anni dopo padre e figlio furono i protettori e i mecenati di Carl Peter Thunberg, cui procurarono l'ingaggio come medico della VOC che gli avrebbe permesso di diventare il padre della botanica sudafricana e giapponese.  Un genere tropicale per uno specialista di tropicali Johannes Burman è dunque un tipico "botanico da scrivania" il cui grande merito non sta né nelle ricerche sul campo né nell'originalità del pensiero, ma nell'aver messo in circolazioni ricerche e opere altrui che rischiavano di andare sepolte nell'infinito cimitero dei capolavori della botanica mai stampati. Botanico rigoroso con un'ottima preparazione filologica e un'eccellente conoscenza del mondo editoriale, era uno specialista di piante esotiche, quelle stesse che l'orto botanico di Amsterdam, da lui egregiamente diretto per quasi quarant'anni, contribuì più di ogni altro ad acclimatare e diffondere in giardini e piantagioni. Oltre a dedicargli Bibliotheca botanica, già in Hortus Cliffortianus Linneo aveva istituito in suo onore il genere Burmannia, proprio in riconoscimento (e in auspicio) dei suoi meriti editoriali: aver dato alle stampe «con sommo studio e dottrina non mediocre» la prima flora di Ceylon e accingersi a fare lo stesso con l’immenso Herbarium amboinicum, un’impresa che, se gli fosse riuscita, gli avrebbe guadagnato la riconoscenza di tutti i botanici. Linneo avrebbe poi confermato il genere in Species Plantarum; Burmannia dà il nome a una famiglia propria (Burmanniaceae), di cui è il genere più cospicuo; comprende una sessantina di piante erbacee, diffuse nelle aree tropicali e subtropicali tutti i continenti, con massima area di diversità tra Asia sud-orientale e Australia. Di collocazione tassonomica incerta (un tempo era avvicinato alle orchidee, ora si pensa sia più prossimo alle Dioscoreales), sono monocotiledoni con foglie a rosetta e curiosi fiori con i tepali disposti su due giri, quelli esterni più grandi e vistosi, quelli esterni spesso ridotti e minuscoli. Alcune specie sono fotosintetiche, altre sono saprofite che traggono nutrimento delle micorrize di alcuni funghi; queste ultime sono dunque prive di clorofilla e hanno foglie ridotte a scaglie: è un adattamento ai terreni molto poveri e umidi in cui vivono. Qualche approfondimento nella scheda. Insieme a Hieronymus Bock e Leonhart Fuchs, Otto Brunfels è uno dei tre "padri della botanica tedesca" (o, secondo alcuni, della botanica tout court). E' vero che, in area tedesca, il suo Herbarum Vivae Eicones è il primo a superare gli erbari figurati di tradizione medievale, messi insieme con il copia-incolla. Ma se il volume segna una tappa nella storia della botanica, non è tanto per i suoi testi (anch'essi ben poco originali) quanto per le incisioni di Hans Weiditz , il primo a ritrarre le piante dal vero e a farle vivere sulla pagina stampata. Il primo vero illustratore botanico della storia avrebbe meritato un genere celebrativo, ma così non è; invece a celebrare Brunfels, per volontà di Plumier e Linneo, c'è il magnifico genere Brunfelsia. Come si confeziona un prodotto editoriale di successo Come ho raccontato in questo post, il mercato editoriale tedesco aveva scoperto precocemente le potenzialità economiche degli erbari figurati, con una vivace produzione di Kräuter Bücher in lingua tedesca, assai apprezzati da un pubblico relativamente vasto di "illetterati", ovvero di persone che non conoscevano il latino. Costruiti con il copia-incolla riprendendo testi e immagini dalla tradizione manoscritta medievale, non brillavano certo per originalità. Il primo a capire che il mercato era pronto per qualcosa di nuovo fu probabilmente l'editore di Strasburgo Johann Schott, tanto più che aveva sotto mano la persona giusta per scrivere il testo; da qualche anno si era infatti trasferito in città il teologo Otto Brunfels che, oltre ad aver aperto una scuola per i ragazzi, era un poligrafo che aveva già pubblicato per lui due libri di biografie, l'una dedicata agli uomini illustri dell'Antico e del Nuovo testamento, l'altra ai medici celebri. Non era un medico (lo sarebbe diventato poco dopo), ma, oltre ad essere un eccellente latinista, si interessava di botanica ed era aggiornato sulle ultime tendenze che arrivavano dall'Italia. Per altro, più che sul testo, l'avveduto Schott puntava sulle immagini; e anche per quelle aveva la persona giusta: il pittore e incisore Hans Weiditz, figlio di un affermato scultore locale e allievo di Albrecht Dürer. Le xilografie del suo nuovo erbario non sarebbero state l'ennesimo rifacimento di miniature medievali, ma, per la prima volta in assoluto, avrebbero ritratto le piante dal vivo, secondo il nuovo stile naturalistico imposto appunto da Dürer. Che nelle intenzioni di Schott le immagini fossero l'elemento più importante si vede fin dal titolo: Herbarum vivae eicones, ad naturae imitationem, summa cum diligentia et artificio effigiatae, ovvero "Immagini vive delle erbe, effigiate con la massima diligenza e virtuosismo, in modo da imitare la natura". Un titolo che equivale a uno spot pubblicitario. Grazie a quelle immagini senza precedenti, Herbarum vivae eicones di Brunsfeld segnò una tappa fondamentale nella storia della botanica, tanto che Julius von Sachs nella sua Geschicte der Botanik scelse la sua data di pubblicazione, il 1530, come anno di inizio della storia della botanica moderna e proclamò l'autore, insieme a Bock e Fuchs, padre della botanica. Un titolo quanto meno esagerato, anche se l’autore ha i suoi meriti e il libro ne ha ancora di più. Da teologo, a botanico e medico Quando arrivò a Strasburgo, Brunfels era sulla trentina, ma aveva già alle spalle una vita travagliata, vissuta nel fuoco della passione per il rinnovamento religioso e morale, ma anche civile e politico annunciato dalla Riforma. Figlio di un bottaio, giovanissimo si laureò in filosofia e teologia, quindi si fece monaco, prima nella certosa della città natale Magonza, poi in quella di Königshofen nei pressi di Strasburgo. Qui poté frequentare gli ambienti umanistici e pubblicare i suoi primi scritti, dedicati a problemi morali e teologici sulla scia di Erasmo da Rotterdam. La Riforma protestante lo vide in prima fila, schierato al fianco di Lutero ma ancora di più di Ulrich von Hutten, il leader della guerra dei cavalieri. Le sue posizioni erano dunque decisamente radicali e lo costrinsero prima ad abbandonare il monastero, poi a diventare una specie di pastore itinerante, in conflitto non solo con la Chiesa cattolica ma anche con Zwingli e lo stesso Lutero. Negli anni caldi della nascita della Riforma, tra il 1519 e il 1524 egli scrisse copiosamente di argomenti morali e teologici, che spesso avevano anche risvolti politici: in particolare, denunciò l'arbitrarietà delle decime, anche se non fino al punto di invitare i contadini a non pagarle; la sconfitta della guerra dei cavalieri e la morte di von Hutten (che difese ancora dopo la sua scomparsa contro le critiche di Erasmo, ai suoi occhi un opportunista che non aveva avuto il coraggio di schierarsi apertamente con la Riforma) lo spinsero a moderare le sue posizioni e soprattutto ad abbandonare la polemica religiosa, per tornare a Strasburgo. Città libera dell'Impero, ma in posizione decentrata, e dominata dalle posizioni conciliatrici di Martin Butero, rispetto alla Germania poteva essere un asilo abbastanza sicuro e quasi un'oasi di tranquillità. Come ho già accennato, negli otto anni in cui visse a Strasburgo, forse anche in connessione con la professione di maestro, scrisse di molti argomenti, anche se Herbarum vivae eicones rimane la sua opera di maggior impegno. Divisa in tre parti, uscite rispettivamente nel 1530, nel 1532 e nel 1536, si concluse solo dopo la morte dell'autore, avvenuta nel 1534. Non sappiamo se Brunfels si fosse già interessato di botanica in precedenza, magari fin dagli anni in cui era monaco certosino; ma, a parte la raccolta di biografie di medici pubblicata da Schott, non aveva mai scritto nulla né di medicina né di piante medicinali. Ma si appassionò tanto all'argomento che, benché avesse ormai superato la quarantina, andò a Basilea a studiare medicina e, dopo essersi laureato nel 1532, si trasferì a Berna come medico della città. Qui morì nel 1534. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. 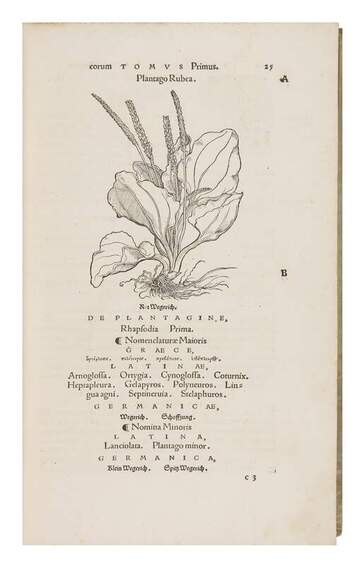 Quando le immagini prevalgono sul testo E' molto probabile che Herbarium vivae eicones come lo leggiamo oggi non corrisponda affatto al progetto che aveva in mente Brunfels quando iniziò a scriverlo. Sulla scorta delle indicazioni degli umanisti italiani, in particolare dei medici dello Studio ferrarese Niccolò Leoniceno e Giovanni Manardo, che invitavano ad abbandonare Plinio per riscoprire Dioscoride nella sua veste originale, e a verificare l'identificazione delle piante dal vivo, l'ex teologo si proponeva di superare i vecchi erbari tedeschi attingendo direttamente alle fonti antiche, prima tra tutte la Materia medica di Dioscoride. Probabilmente intendeva presentare le piante in ordine alfabetico, dando la precedenza o forse l'esclusiva alle specie medicinali citate dagli antichi. Per identificarle correttamente, anche lui, seguendo l'esempio di Leoniceno e Manardo, percorreva le campagne attorno a Strasburgo cercando di identificare le piante mediterranee nominate da Dioscoride nella ben diversa flora del centro Europa, ovviamente incappando in identificazioni forzate o arbitrarie. e le cose non andarono come avrebbe voluto, la colpa (o il merito) fu di Hans Weidnitz. Il pittore doveva essere uno spirito indipendente (e intraprendente) e prese l'iniziativa di ritrarre dal vivo anche piante non previste dall'autore, non solo mai citate da Dioscoride o Plinio, ma spesso pure prive di proprietà officinali. Insomma, vere e proprie erbacce. Brunfels le avrebbe espunte volentieri, o almeno relegate in un'appendice, ma l'editore premeva perché il lavoro procedesse in fretta, e, mano a mano che le matrici erano pronte, venissero stampate le xilografie con i testi relativi. Così l'ordine previsto da Brunfels saltò, e le specie vennero disposte in un ordine casuale, dettato dalle esigenze editoriali. Per Brunfels fu sicuramente uno smacco, tanto che si scusa addirittura con i lettori di aver inserito queste piante nel corpo del testo e le chiama spregiativamente “plantae nudae”, indegne di essere illustrate perché non coperte dal prestigio di una designazione autorevole. Eppure sono proprio le spregevoli piante nude a rendere interessante il libro di Brunfels ai nostri occhi: su 258 specie o varietà illustrate, quelle mai descritte in precedenza sono 47, e sono le uniche per le quali il supposto "padre della botanica" scrive ciò che vede con i suoi occhi o ha saputo dai suoi informatori, e non ciò che riprende diligentemente dalle fonti antiche. Per scoprire i loro nomi e sapere qualcosa dei loro eventuali usi, senza alcuna spocchia intellettuale, egli si rivolse infatti agli erboristi e anche alle «vecchiette espertissime» che «non conoscono le piante grazie ai libri, ma sono stati ammaestrati dall'esperienza». E sicuramente non gli spiacque che l’editore prendesse l’iniziativa di affiancare all'edizione latina una versione tedesca, il Contrafayt Kreüterbuoch (ovvero “Libro d’erbe illustrato”), con l’aggiunta di una cinquantina di illustrazioni originali. Oggi si tende sostanzialmente a ridimensionare il valore storico dell’opera di Brunfels, giudicata un lavoro sostanzialmente compilatorio, mentre non si manca di sottolineare l’altissima qualità delle illustrazioni di Hans Weiditz (1497-1537 circa). Probabilmente si deve a lui la maggior parte delle immagini dei primi due volumi dell’Herbarum Vivae Eicones, anche se fu assistito da altri pittori e da uno o più incisori. Weiditz, come abbiamo già visto, scelse con una certa autonomia le piante da ritrarre; le disegnò e le dipinse da vivo, non in modo idealizzato, ma estremamente realistico tanto che in alcune tavole vediamo fiori appassiti, foglie strappate o mangiate dagli insetti. Da questo punto di vista, le sue immagini sono abbastanza lontane dalle future convenzioni dell’illustrazione botanica che rappresenta le piante non in modo individuale, ma ideale; invece troviamo già le piante decontestualizzate, disposte sul foglio bianco staccate dal loro habitat; in alcuni esemplari sono presentati diversi stati della vita della pianta ritratta, con fiori e frutti insieme. Nel 1930 a Berna, in un volume appartenuto a Felix Platter, furono ritrovati settantasette acquarelli di piante dipinte da Weiditz: si tratta di una parte degli originali da cui furono tratte le xilografie dei volumi di Brunfels. Rispetto a queste ultime, sono ancora più notevoli per virtuosismo e naturalismo; gli incisori non di rado le adattarono alla pagina, spesso disponendole in posizioni innaturali e le riprodussero con un tratto piuttosto sottile, senza chiaroscuro; inoltre le dimensioni delle xilografie sono molto variabili, dalla pagina piena a pochi centimetri, con il testo che si dispone intorno in modo a volte un po' disordinato. Probabilmente, erano previste copie di lusso acquarellate a mano, di cui gli originali di Weiditz costituiscono il modello per i colori. Le illustrazioni di Weidnitz imposero un nuovo standard, tanto che furono immediatamente piratate: nel 1533 l’editore Egenolph ne fece copiare alcune (invertite e ridotte nelle dimensioni) per illustrare il Kreutterbuoch di Eucharius Rösslin; Schott gli fece causa e l’editore rivale fu costretto a desistere (ne ho parlato in questo post). Qualche anno più tardi, esercitarono una notevole influenza sugli artisti che illustrarono De historia stirpium di Fuchs.  Fiori profumati, fiori cangianti A far entrare Brunfels nella terminologia botanica con la dedica di uno dei suoi generi americani fu il solito padre Plumier, che con tono lievemente apocalittico sottolinea il ruolo di precursore del botanico-teologo: «Per primo in Germania cercò di strappare la botanica medica, quasi estinta, da profondissime tenebre». E ciò resta vero non solo per il pionieristico Herbarum vivae eicones, ma anche per aver stimolato e incoraggiato altri botanici a seguirlo sulla stessa strada: fu lui a persuadere Hieronymus Bock a pubblicare il suo erbario tedesco, sobbarcandosi un viaggio a piedi da Strasburgo a Hornbach per convincerlo di persona; in appendice a Herbarum vivae eicones, pubblicò i primi scritti dello stesso Bock e di Fuchs; e fu certo l’interesse suscitato dal libro di Brunfels a spingere Euricius Cordus a scrivere e pubblicare il suo Botanologicon. Validato da Linneo nel 1753, il genere Brunfelsia, della famiglia Solanaceae, comprende una cinquantina di specie di piccoli alberi e arbusti, più qualche liana, diffuse esclusivamente nell'America tropicale, dalle Antille all'Argentina. Hanno grandi fiori profumati tubolari, con corolla piatta, lievemente zigomorfi, con cinque grandi lobi, simili a quelli delle petunie (i generi sono piuttosto affini e appartengono alla medesima tribù, quella delle Petunieae). Come molte piante di questa famiglia, contengono sostanze medicinali e alcaloidi, le cui proprietà sono state scoperte e sfruttate dalle culture indigene; tuttavia diverse componenti sono tossiche e possono causare problemi sia all'uomo sia agli animali domestici. Diverse specie di Brunfelsia sono coltivate per il grande valore ornamentale nei paesi a clima mite. Le più note sono B. americana e B. pauciflora. B. americana è un piccolo albero originario delle Antille, dove lo vide e lo descrisse padre Plumier; sempreverde, ha grandi fiori solitari dapprima bianchi poi giallo crema, che si aprono di notte diffondendo un forte profumo che gli ha guadagnato il soprannome di “signora della notte”. Da noi è però più coltivata l’arbustiva B. pauciflora, originaria del Brasile, che al momento della fioritura dà spettacolo con le sue corolle in tre colori. Infatti i suoi fiori hanno la curiosa particolarità di cambiare colore: al momento dell’apertura sono viola purpureo, quindi lavanda, infine, poco prima di appassire, bianchi. Ecco perché gli inglesi la chiamano yesterday-today-tomorrow, “ieri, oggi, domani”. Nessuna delle due specie è rustica. Garantisce invece una buona resistenza al freddo B. australis, che come dice il nome specifico ha una distribuzione più meridionale (dal Brasile meridionale all’Argentina); è simile a B. pauciflora, ma con portamento più compatto e fiori più piccoli, anch'essi in tre colori. Qualche approfondimento nella scheda. Nel Cinquecento il mercato editoriale tedesco è uno dei più vivaci centri della produzione di testi di botanica e "materia medica". Da una parte ci sono le opere in latino, spesso innovative e scritte da studiosi con una preparazione filologica o medica come Brunfels e Fuchs, che si rivolgono soprattutto a medici e studenti di medicina; dall'altra c'è una vasta produzione di Krauterbucher, "libri di erbe", che a parte qualche eccezione (come il New Kreütter Büch di Bock), sono per lo più rifacimenti di erbari manoscritti medievali, dal contenuto ben poco originale; di carattere eminentemente pratico, ma anche ricchi di curiosità, soddisfano un pubblico molto più ampio e poco esigente, che comprende farmacisti, padri di famiglia, semplici curiosi. Requisito essenziale del loro successo sono le illustrazioni xilografiche che, proprio come i testi, passano disinvoltamente da un'edizione all'altra. Tra i protagonisti di questo mondo editoriale di riedizioni, rifacimenti, riscritture, maestro del copia-incolla, è il medico e botanico Adam Lonitzer; nella maturità, divenuto egli stesso editore dopo aver sposato la figlia di uno dei maggiori stampatori e editori tedeschi, seppe fare del suo Kräuterbuch un long seller che gli sopravvisse per due secoli: uscito per la prima volta nel 1557, raggiunse infatti 27 edizioni, l'ultima delle quali è del 1783. Come gli altri autori di questo tipo di prodotto, fu anch'egli poco più di un abile compilatore; il genere Lonicera, dedicatogli da Linneo raccogliendo un suggerimento di Plumier, non premia dunque né l'originalità né la profondità di pensiero, ma il successo di un libro che ancora nel Settecento non mancava nella biblioteca di ogni studioso di botanica. 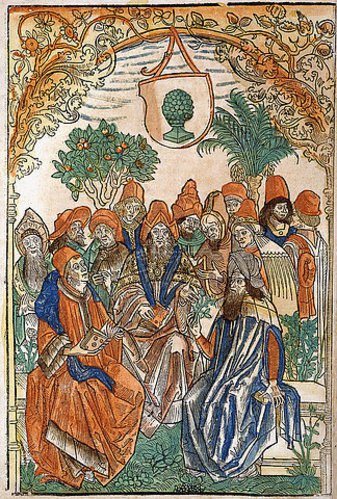 Successi commerciali e una causa per plagio Con l'invenzione della stampa, i libri si fanno più accessibili e incominciano a raggiungere un pubblico più ampio. Accanto alla Bibbia e ai classici, tra i primi testi a suscitare l'interesse di stampatori e lettori ci sono anche i manuali di medicina pratica e i libri di erbe. Particolarmente vivace è il mercato tedesco, dove il primo erbario (noto come Herbarius latinus o Herbarius moguntinus, "erbario di Magonza") venne stampato nel 1484 da Peter Schöffer, il principale collaboratore di Gutenberg; entro il 1499 giunse a toccare undici edizioni. L'anno successivo lo stesso Schöffer dava alle stampe il primo Krauterbuch ("libro d'erbe") in lingua tedesca, Gart der Gesundheit (corrispettivo del latino Hortus sanitatis), attribuito al medico della città di Francoforte Johann Wonnecke von Kaub, anche noto con il nome latinizzato Johannes de Cuba. Anche quest'opera nell'arco di pochi anni ebbe molteplici edizioni nonché adattamenti e traduzioni. Mentre l'erbario latino si rivolgeva al pubblico più tradizionale dei medici e dei farmacisti, quello in lingua locale rispondeva alle esigenze e alle curiosità di una sempre più vasta fascia di lettori che non conoscevano il latino. Né l'uno né l'altro erano opere dal contenuto originale, ma compilazioni basate sugli erbari manoscritti medievali, risalenti a loro volta ai rifacimenti medievali di Dioscoride, magari attraverso la mediazione araba. A costituire un valore aggiunto erano soprattutto le illustrazioni xilografiche, apprezzate anche dagli illetterati. A capirlo perfettamente fu il tipografo-editore Christian Egenolff (1502-1555), che operava sulla importante piazza di Francoforte sul Meno. Dotato di grande fiuto commerciale, era un editore eclettico che pubblicava di tutto, incluse partiture musicali. Nel 1533 entrò nel mercato degli erbari illustrati pubblicando Kreutterbuch von allem Erdtgewächs, un rifacimento del libro di Johannes de Cuba curato dal medico cittadino Eucharius Rösslin. Per illustrarlo, fece eseguire solo poche nuove xilografie, prendendo le altre (rimpicciolite e ruotate di 180 gradi) da Vivae icones herbarium di Brunfels, pubblicata l'anno prima a Strasburgo dell'editore Schott. Quest'ultimo, che aveva ottenuto un privilegio imperiale che gli concedeva l'esclusiva dell'opera per sei anni, lo citò in giudizio presso la Suprema corte di giustizia dell'Impero. In quella che può essere considerata la prima causa per plagio della storia dell'editoria, Egenolff si difese sostenendo in primo luogo che copiare da un libro vecchio di trenta o quarant'anni è lecito, anzi in questo caso benemerito, considerando i benefici che ne derivano per la salute pubblica; in secondo luogo, la sua non poteva considerarsi una copia del volume di Brunfels, visto che, oltre ad avere un testo completamente diverso, conteneva anche immagini originali; in terzo luogo, il privilegio editoriale riguardava la trattazione delle piante, non le loro forme: queste le impone la natura, e qualsiasi illustrazione delle piante non potrà che assomigliarsi. Un argomento specioso, ma che ben testimonia il nuovo modo rinascimentale di concepire la natura e la sua rappresentazione. Non sappiamo come finì la causa, ma è certo che Egenolff continuò imperterrito a illustrare i suoi numerosi libri di medicina e botanica con xilografie altrui. Erano pubblicazioni pensate per grandi tirature, né innovative né originali nei contenuti, ma perfette per il gusto del largo pubblico. Insomma, una specie di Reader's Digest del Rinascimento. Inoltre, per conquistare un'ulteriore fetta di mercato, Egenolff, seguendo l'esempio di Isengrin, l'editore di Fuchs, nel 1546 pubblicò un album costituito unicamente da immagini, prevalentemente di piante ma anche di animali, minerali e manufatti utilizzati in farmacia con il titolo Herbarum, arborum, fruticum, frumentorum ac leguminum... iconae. Non c'è bisogno di dire che anche in questo caso si trattava di xilografie pirata (copiate tra l'altro anche da opere di Fuchs). Sebbene non sia indicato il nome del curatore del testo, limitato all'indice e ai nomi latini e tedeschi dei semplici, gli studiosi lo identificano in Adam Lonitzer, all'epoca insegnante di matematica e promettente studente di medicina. 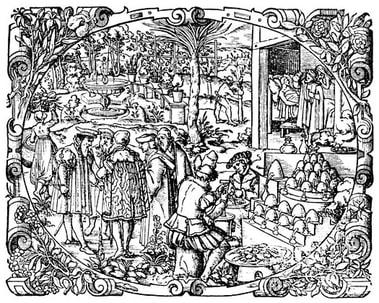 Un insuccesso editoriale e un long seller Figlio di un filologo e docente universitario di lingue classiche, Adam Lonitzer (Lonicerus nella forma latinizzata) aveva probabilmente familiarità con il mondo editoriale fin dall'infanzia. Dopo aver studiato filosofia e medicina nella sua città natale, Marburg, per completare gli studi nel 1545 si trasferì a Francoforte, dove probabilmente poco dopo entrò in contatto con Egenolff, con cui collaborò come correttore di bozze e curatore di volumi di medicina. Egenolff, che continuava a sfruttare il successo commerciale del vecchio testo di Johannes de Cuba (dopo il rifacimento di Rösslin, nel 1540 ne aveva pubblicato un'ulteriore edizione, con il titolo Botanicon, firmata da Theodor Dorstein), pensò di affidargli un'opera decisamente più ambiziosa. In effetti quel filone d'oro stava ormai esaurendosi, reso obsoleto dalle opere dei grandi botanici del Rinascimento come Mattioli, Gessner, Bock e Fuchs. Lonitzer, pur basandosi ancora una volta su quel vecchissimo testo, avrebbe dovuto attualizzarlo, dandogli una patina di novità grazie alle informazioni attinte dai più affermati moderni. Egenolff puntò su un'edizione di lusso: in lingua latina, con il titolo pliniano Naturalis historia, erano due grossi volumi in folio di 744 pagine con oltre 700 xilografie; inoltre, a quanto pare, fu messa in commercio solo la versione con le tavole acquarellate a mano (che mediamente costava il doppio di quella in bianco e nero). Per una volta, il fiuto commerciale di Egenolff sembrò venuto meno. Fu un clamoroso flop, se ancora quattordici anno dopo, nel 1565, i suoi eredi cercarono di liberarsi delle copie invendute cambiando il frontespizio per spacciarle per un'opera nuova intitolata Botanicon. In effetti, il vecchio Egenolff aveva sbagliato il target: un'opera così costosa, scritta in latino, avrebbe dovuto trovare il suo pubblico tra i dotti, agli occhi dei quali, per abile che fosse stato Lonitzer nel suo copia-incolla, si palesava immediatamente per quello che era: un centone, un patchwork con ben poca originalità. Nessuna originalità neppure nelle tavole, riciclate da opere precedenti della casa editrice e in buona parte piratate. Intanto Lonitzer faceva carriera. Nel 1553 ottenne una cattedra di matematica a Marburg e nel 1554 conseguì il dottorato in medicina; lo stesso anno fu nominato medico della città di Francoforte (incarico che avrebbe mantenuto fino alla morte, nel 1586) e sposò Magdalena, una delle figlie di Egenolff, legando per sempre le sue sorti alla casa editrice di cui, dopo la morte del suocero, nel 1555, divenne una specie di direttore editoriale. E in tale veste riuscì ad ottenere il più grande e più duraturo successo della ditta: il suo Kräuterbuch, prima edizione 1557, cui avrebbero fatte seguito altre tre durante la sua vita (1564, 1573, 1578); con rifacimenti e riadattamenti, questo long seller avrebbe totalizzato ventisette edizioni, l'ultima delle quali nel 1783. E che cos'era questo prodotto editoriale di successo? Nient'altro che la catastrofica Historia naturalis che, tradotta in tedesco, aveva finalmente trovato il suo pubblico: non più i facoltosi, dotti e smaliziati ma riluttanti acquirenti della versione latina, ma lettori di media cultura, più interessati a informazioni pratiche esposte in modo chiaro che a disquisizioni filologiche sull'identificazione delle piante di Dioscoride e Teofrasto. Del resto, sebbene sia fondamentalmente il frutto di un abile lavoro di copia-incolla, l'opera di Lonitzer ha il pregio della chiarezza e, soprattutto nella parte botanica, contiene anche qualche informazione tratta dall'esperienza diretta di medico e osservatore della natura. Ad esempio, egli fu il primo a segnalare e descrivere l'agente dell'ergotismo, il fungo parassita della segale Claviceps purpurea. Tra le parti più apprezzate del suo erbario, il primo ampio capitolo, dedicato alla distillazione. L'arte della distillazione, sconosciuta agli antichi, era un'invenzione araba che si era diffusa in Occidente nel corso del Medioevo; era dunque ancora relativamente recente e quanto mai necessaria a medici e farmacisti, perché permetteva di ricavare gli estratti alcoolici poi utilizzati per la preparazione dei farmaci. Intendiamoci, neppure qui non c'è nulla di nuovo o originale: Lonitzer riprese le sue informazioni da fonti precedenti, in particolare dal Liber de arte distillandi de simplicibus di Hyeronimus Braunswig. Tuttavia la sua esposizione e le immagini che accompagnano il testo sono tanto chiare e dettagliate che un'équipe internazionale di ricercatori le ha utilizzate per ricostruire sperimentalmente il processo di distillazione del XVI secolo. Sicuramente proprio questa parte contribuì non poco al successo del libro, tanto più che Lonitzer seppe valorizzarla fin dal frontespizio dove, sulla sinistra, in primo piano è rappresentato un farmacista che, assistito da un aiutante, sta distillando i semplici. Inoltre, c'erano anche informazioni sulla coltivazione dei giardini, anch'essa raffigurata nel frontespizio, in secondo piano sulla destra, dietro a un gruppo di dottori a consulto. Una sintesi della vita di Lonitzer come sempre nella sezione biografie.  Lonicera: bellezza e profumo Campione di vendite, il nome di Lonitzer era dunque ben noto ai cultori di botanica; grazie a questa fama Plumier gli dedicò uno dei suoi nuovi generi americani, battezzato Lonicera sulla base del cognome latinizzato Lonicerus. D'altra parte, è probabile che egli conoscesse solo i titoli dei suoi libri, visto che nella nota che accompagna la dedica cita come tre opere distinte Historia naturalis, Botanicon e un "herbarium vernacula lingua", ovvero il Krauterbuch. Il genere Lonicera di Plumier non è per altro quello a noi oggi familiare: appartenente alla famiglia Loranthaceae, corrisponde all'attuale genere Psittacanthus, che riunisce alcune piante parassite delle Antille e del Centro America affini al vischio. Se non fosse in contrasto con la candida personalità del buon padre Plumier, si potrebbe sospettare uno di quei ritratti vegetali al vetriolo che tanto deliziavano Linneo. Invece quest'ultimo, che aveva una copia del Krauterbuch nella sua biblioteca, volle dedicare al nostro protagonista un genere diverso e ben più importante, forse riconoscendo l'apporto di Lonitzer alla divulgazione del sapere botanico tra il vasto pubblico. Lo scrittore tedesco ci guadagnò immensamente nel cambio, aggiudicandosi Lonicera L., famiglia Caprifoliaceae, un vastissimo genere di oltre 180 specie, molte delle quali sono tra i rampicanti e gli arbusti più coltivati nei nostri giardini. Finalmente possiamo parlare di un genere anche europeo, anzi di uno di più ricchi di specie del nostro continente (ma presente anche in America settentrionale e in Asia; la sola Cina, centro di diversità del genere, ne vanta un centinaio). E quindi abbiamo a disposizione anche un nome comune, caprifoglio (dalla credenza che le capre si nutrissero delle sue foglie). In Italia ne abbiamo una dozzina di specie spontanee, legate ad ambienti diversi, le più note delle quali sono probabilmente la mediterranea L. caprifolium, la madreselva o caprifoglio comune (che dà anche il nome alla famiglia), diffusa in tutta la penisola, ma non nelle isole; l'atlantica L. periclymenum, presente solo nelle regioni settentrionali, il caprifoglio europeo più coltivato, con diverse pregevoli varietà da giardino; la montana L. xylostemum, il caprifoglio peloso, che non è un rampicante, ma un arbusto. Se infatti nell'immaginario collettivo tendiamo ad associare al nome caprifoglio a rampicanti dalle copiose e profumate fioriture, in realtà la maggior parte delle specie sono arbustive. I nostri caprifogli sono coltivati da secoli immemorabili e hanno lasciato la loro impronta anche in letteratura, ad esempio nel Lai du chievrefoil di Marie de France o nella poesia di Shakespeare. Hanno anche ispirato l'arte pittorica, dalle miniature medievali stile mille fleurs alle carte da parati di Morris. A partire dal Settecento, alle europee si è anche aggiunta la popolosa legione straniera delle asiatiche, come la profumatissima L. fragrantissima dalle fioriture precoci; la bella ma iperinfestante L. japonica; le arbustive L. nitida e L. pileata, la prima ottima pianta da siepe, la seconda eccellente tappezzante; L. tatarica, un grande arbusto dalla fioritura abbondante e prolungata. Già da un secolo era arrivata L. sempervirens, il caprifoglio della Virginia, con brillanti fiori tubolari che nel paese d'origine sono la delizia dei colibrì. Ma l'elenco potrebbe continuare, tanto più che alle già numerose specie si sono aggiunti molti ibridi orticoli. Su almeno qualcuno troverete qualche informazione nella scheda. Aa! No, non è un'esclamazione di sorpresa o di gioia, ma il nome di un genere, il più breve e il primo in ordine alfabetico dell'intera tassonomia botanica, a consolazione di quelli che sostengono che i nomi botanici sono troppo lunghi e difficili da pronunciare. Perché il grande orchidologo Heinrich Gustav Reichenbach abbia chiamato così questo genere di orchidee terrestri andine non si sa con certezza, ma abbiamo tre ipotesi. Ovviamente la mia preferita è quella che lo considera un nome celebrativo, in onore del tipografo olandese Pieter var der Aa, vissuto a cavallo tra Seicento e Settecento. Che con le orchidee c'entra parecchio. 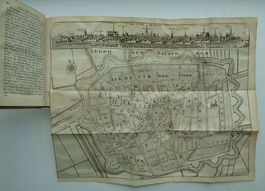 Tre ipotesi per il genere AA Nel 1854 l'orchidologo tedesco Heinrich Gustav Reichenbach separò dal genere Altensteinia (che comprende orchidee del Sud America andino) due specie, che rinominò Aa argyrolepis e Aa paleacea, creando il nuovo genere Aa. Non avendo mai l'autore spiegato le ragioni di questo strano nome (il primo in ordine alfabetico, il più breve e il più semplice della nomenclatura botanica), non possiamo che affidarci alle ipotesi. Ne sono state avanzate tre. La prima - la più gettonata - è che Reichenbach abbia voluto semplicemente creare una denominazione che venisse sempre per prima in tutte le liste alfabetiche dei nomi botanici, analogamente all'AAA che si usa negli annunci economici. Che questa ipotesi non sia poi così strampalata lo dimostra il fatto che non sarebbe affatto un caso isolato: nella nomenclatura zoologica c'è un genere di coleotteri denominato Aaaba, poi ribattezzato addirittura Aaaaba. Non manca neppure il caso opposto di un nome creato proprio per essere l'ultimo della lista; in botanica è il genere Zyzyxia. Ha una storia così curiosa che, se anche non è un nome celebrativo, permettetemi di raccontarla. Nel 1991 il botanico statunitense John Strother stava lavorando a una revisione della sottotribù delle Ecliptinae nordamericane (Asteraceae della tribù Heliantheae, quella dei girasoli); il lavoro era giù in bozza quando si rese conto che una specie prima assegnata al genere Wedelia ne differiva abbastanza da meritare un genere tutto per sé. Sottopose il problema all'editore che accettò l'inserimento di un nuovo genere, purché le pagine da ricomporre fossero ridotte al minimo. Dato che i generi erano in ordine alfabetico, la soluzione più pratica era creare una dominazione che venisse dopo l'ultimo nome della lista, Zexmenia. Strother così creò - del tutto arbitrariamente, come dichiara esplicitamente nella monografia stessa - il genere Zyzyxia, combinando le ultime consonanti e l'ultima vocale dell'alfabeto. Ma torniamo ad Aa e vediamo la seconda ipotesi: si tratterebbe di un'abbreviazione creata prendendo la prima e l'ultima lettera di AltensteiniA. Non impossibile, non trova però molti seguaci. Rimane la terza ipotesi: Aa è un nome celebrativo, che onora il tipografo olandese Pieter var der Aa (1659-1753). Contestata, ma del tutto credibile, visto che tra questo personaggio e le orchidee c'è un affascinante legame che Reichenbach - uno dei maggiori orchidologi dell'Ottocento - sicuramente non ignorava. Pieter var der Aa fu uno dei più importanti editori di quello che è considerato il secolo d'oro dell'editoria olandese. Dapprima libraio, poi tipografo-editore, operando a Leida, il prestigioso centro universitario, poté contare sulla collaborazione di importanti studiosi accademici, ma seppe anche sfruttare abilmente la passione per l'esotismo (la stessa che notiamo nei quadri dell'epoca, alimentata dall'espansione dei commerci e delle colonie olandesi nelle Americhe, in Sud Africa, nelle Indie orientali). Dapprima produsse soprattutto grandi opere universitarie, pubblicando ad esempio il Thesaurus delle opere dell'antichità greche di J. Gronovius (il padre del nostro botanico) o le opere di antiquaria di Graevius; nel suo catalogo non mancarono opere di scienza e medicina (tra gli altri, anche di Malpighi). In un secondo tempo, si specializzò soprattutto in atlanti e in collezioni di racconti di viaggi. L'opera più celebre uscita dalla sua tipografia è la Galierie agréable du monde, una serie di 66 volumi con oltre 3000 tavole calcografiche, in parte costituite da mappe, ma anche da immagini di nativi, monumenti, paesaggi, episodi storici. Nel suo vasto e variegato catalogo non mancarono le opere di botanica: Icones arborum, fructicum et herbarum exoticarum di Albrecht van Haller (senza data); Botanicon parisiense di S. Vaillant, con le incisioni di Aubriet, pubblicato a cura di H. Boerhaave (1723); ma soprattutto Paradisus Batavus di Paul Hermann (1698). E' infatti proprio a quest'opera che potrebbe essere dovuta la dedica del genere Aa. Qualche notizia in più sulla vita del librario-tipografo nella sezione biografie. 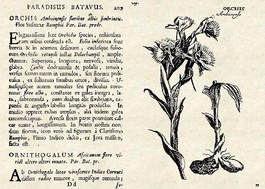 Orchidee dalle due Indie L'opera di Hermann è il catalogo dell'Orto botanico di Leida, di cui egli fu curatore dal 1679 alla morte, avvenuta nel 1695. E' interessante tra l'altro per la descrizione di diverse specie esotiche, soprattutto sudafricane, da poco introdotte in Europa; inoltre, proprio grazie a van der Aa, si giova di una bella veste grafica con tavole illustrate di buona qualità. Agli appassionati di orchidee è nota perché documenta l'introduzione delle due primissime orchidee tropicali coltivate in Europa. Arrivavano dai capi opposti dell'impero commerciale olandese: una dalle Indie occidentali, ovvero dall'isola di Curaçao, nel mar dei Caraibi meridionale; l'altra dalle Indie Orientali, ovvero dall'isola di Ambon nell'arcipelago delle Molucche. L'americana (l'illustrazione compare a p. 207) è una specie epifita ancora oggi molto apprezzata per l'aspetto curioso e soprattutto per profumo notturno; qui contrassegnata dal nome-descrizione Epidendron corassavicum folio crasso sulcato (ovvero "pianta epifita proveniente da Curaçao con foglie succulente con una profonda nervatura centrale"), è oggi denominata Brassavola nodosa. L'incisione di Paradisus Batavus è stata realizzata a partire dal un disegno dal vivo di un esemplare coltivato dal collezionista Casper Fagel (1634-85). Si ritiene sia stata la prima orchidea tropicale ad approdare in Europa, come ho raccontato in questo post. L'asiatica (l'illustrazione è a p. 209, tav. 73) ha una storia ancora più interessante. Contrassegnata dal nome-descrizione Orchis amboinensis floribus altis, Flos Susannae Rumphii ("orchidea di Ambon a fiori alti, fiore di Susanna di Rumphius), l'illustrazione è tratta dal manoscritto dell'Herbarium Amboinense del grande botanico G. E. Rumphius, all'epoca ancora inedito; fu infatti pubblicato solo a partire dal 1741 da Burman, quasi quarant'anni dopo la morte dell'autore. Rumphius visse per oltre trent'anni ad Ambon al servizio della Compagnia olandese delle Indie, sposò una donna del luogo e si dedicò allo studio della fauna e della flora dell'arcipelago. Una serie di tragedie funestò la sua vita: intorno al 1670 perse la vista e nel 1674 sia la moglie sia la figlia minore furono vittime di uno tsunami che devastò l'isola. Per Rumphius fu una duplice tragedia: da quando era cieco, l'amata moglie Suzanne era diventata i suoi occhi e le sue mani. Per ricordarla, volle dedicarle proprio la nostra orchidea, con queste parole: "Poiché non sono riuscito a trovare un nome locale, ha deciso di assegnarle il nome latino Flos Susannae, Bunga Susanna in malese, per commemorare colei che è stata la mia prima compagna e il mio aiutante nel raccogliere erbe e piante, nonché colei che mi ha mostrato questo fiore per prima". Il testo di Hermann ci informa che questa elegantissima orchidea non era ancora fiorita nei giardini olandesi, dove era giunta grazie a Rumphius, salutato come "dotto Plinio delle Indie". Oggi il suo nome è Pecteilis susannae: per fortuna l'omaggio alla moglie e compagna di Rumphius è stato accolto da Linneo, rimanendo nella onomastica botanica. E' una delle bellissime orchidee di questo genere, i cui fiori sono stato spesso paragonati a candide colombe in volo.  Il fascino discreto (?) delle Aa Come ho già anticipato, Reichenbach creò il genere Aa nel 1854, separandolo da Altensteinia. Tuttavia una ventina di anni dopo cambiò idea, e reinserì le due specie nel genere originario. Qualche decennio dopo, nel 1912 il genere Aa fu infine ripristinato da Rudolf Schlechter, anche perché nel frattempo ne erano state scoperte diverse nuove specie che ne giustificavano meglio l'indipendenza. Non hanno nulla di tropicale le nostre Aa, né nell'aspetto né nelle caratteristiche ecologiche e, all'interno della fascinosa famiglia delle Orchidaceae, rischiano di giocare il ruolo di parente povero. Vengono dagli habitat freddi delle Ande prossimi alla linea delle nevi e la loro discretissima presenza è dovuta all'adattamento alle temperature rigide e alle fortissime escursioni termiche degli ambienti in cui vivono (quello più tipico è il paramo, le lande che si estendono tra Costa Rica, Perù e Ecuador, di cui è stato detto "inverno tutte le notti, estati tutti i giorni"); sono piccole piante erbacee, con poche foglie basali a rosetta, talvolta carnose; l'infiorescenza, eretta in alcune specie, arcuata in altre, è formata da numerosissimi piccoli fiori a campana (uncospicuous, li definiscono i siti anglofoni) di solito bianchi e marrone che si aprono successivamente. A guardarli da vicino, sono sicuramente molto graziosi, con il labello a cappuccio che li racchiude quasi totalmente; ma in molte specie sono quasi invisibili, perché avvolti in brattee di consistenza cartacea che assicurano la necessaria protezione dai freddi notturni. Neanche il "profumo", se così possiamo chiamarlo, accresce di molto il loro fascino, se non per le mosche, che ne sono fortemente attratte. Se ne conoscono circa ventisei specie, distribuite nei paramos della Costa Rica e negli altipiani andini, fino al Perù e all'Argentina settentrionale. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|




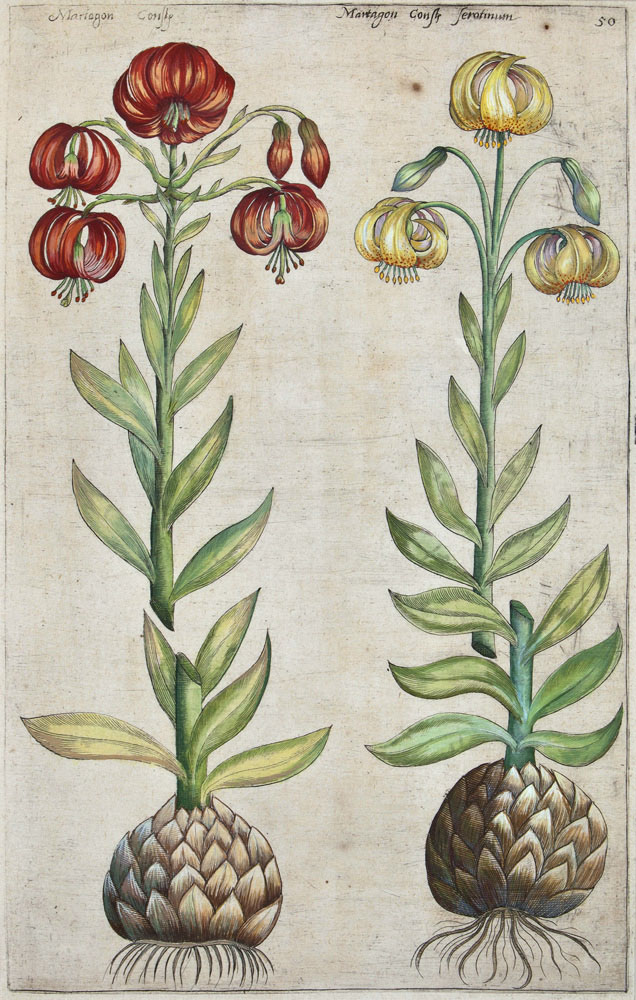


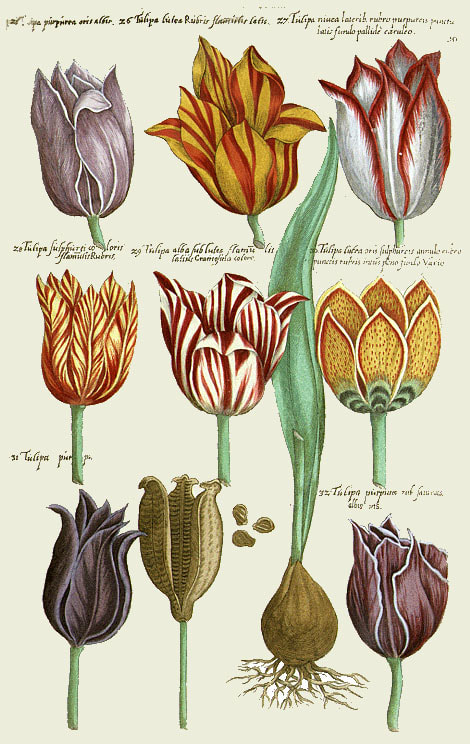
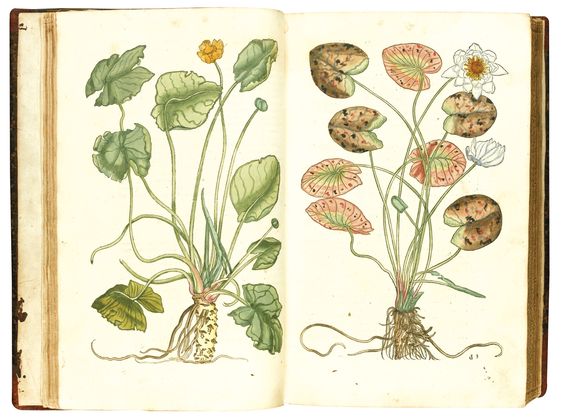

 RSS Feed
RSS Feed