|
Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola.
1 Comment
Ognuno ha i suoi talenti. Quelli di Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria e imperatore più di nome che di fatto, non erano né la politica né le armi, ma gli affari (per i quali è considerato addirittura un genio), le arti e le scienze. Fu un grande mecenate e lasciò la sua impronta più visibile nel parco di Schönbrunn, dove volle ci fossero anche un serraglio e un orto botanico ricchi di animali e piante esotiche. Su suggerimento dell'archiatra van Swieten, a crearlo furono due giardinieri olandesi, Adrianus van Stekhoven e Ryk van der Schot. Per popolare gabbie e aiuole, l'imperatore progettò di persona e finanziò una spedizione nelle Antille che ebbe grandissimo successo, certo grazie alla competenza e alle capacità organizzative del botanico von Jacquin, ma anche all'ingegno del giardiniere van der Schot che riuscì nell'impresa, rara all'epoca, di fare arrivare vive decine e decine di piante rare. Meritatissima dunque la dedica dell'esotico e sfavillante genere Schotia. 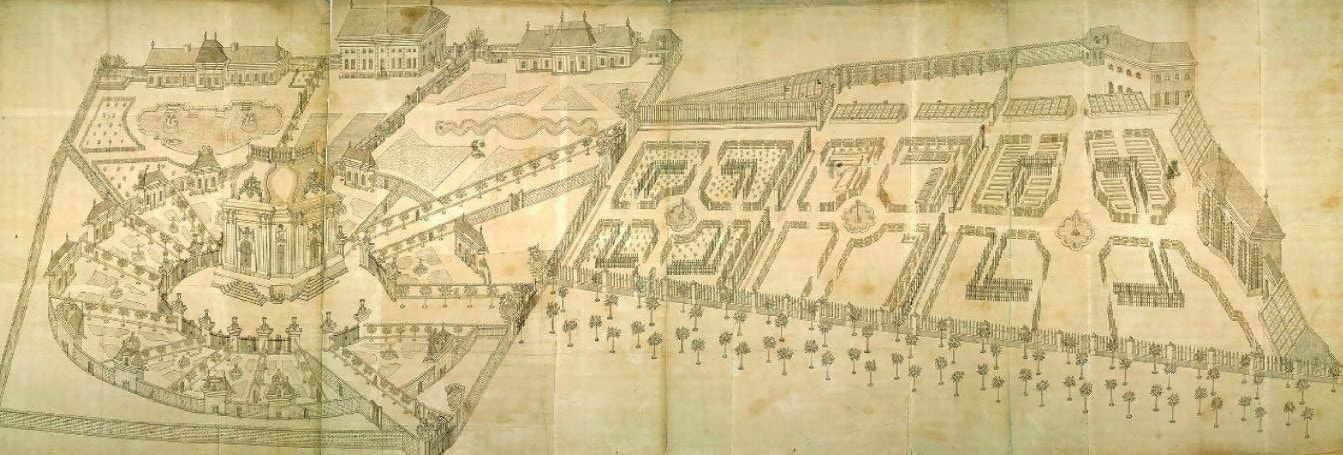 La nascita di un giardino imperiale Avere tempo libero può essere un ottimo affare. Francesco Stefano di Lorena, il marito francese dell'imperatrice Maria Teresa, anche dopo essere stato nominato imperatore come Francesco I, lasciò la cura dello stato alla consorte, che se ne intendeva molto più di lui, e si dedicò a consolidare il patrimonio familiare (abilissimo, lo separò da quello statale e lo moltiplicò, divenendo multimilionario grazie agli ottimi investimenti e a manifatture all'avanguardia) e alle sue svariate passioni. Patito cacciatore e coureur de femmes, buon violinista e mecenate di musicisti e compositori, amante del teatro, fu soprattutto collezionista) collezionava monete e medaglie) e protettore delle scienze. Quando divenne granduca di Toscana, acquistò per 40.000 scudi il ‘Cabinét de curiosités’ dell'erudito Jaen de Baillou, un'ampissima collezione di minerali, fossili, conchiglie, insetti ed altre curiosità naturali, e lo fece venire a Vienna insieme allo stesso Baillou come direttore della sua collezione privata, il primo nucleo del futuro Naturistorische Museum. Gli esemplari vennero sistemati in un palazzo sulla Wallnerstrasse (noto come Kaiserhaus) dove Francesco Stefano aveva i quartieri privati in cui poteva ricevere discretamente diplomatici e i suoi vari emissari, nonché gli scienziati che amava riunire attorno a sé; disponeva di una biblioteca e di un laboratorio ben attrezzato, dove venivano condotti esperimenti utili alle sue attività commerciali. Uno dei frequentatori più assidui era sicuramente l'archiatra van Swieten e probabilmente fu lui a suggerirgli di trasformare anche una parte del parco di Schönbrunn in un vero e proprio centro di ricerca, con un serraglio e un orto botanico. Il palazzo di Schönbrunn era inizialmente un casino di caccia, molto caro dall'imperatrice cui era stato ceduto dal padre, l'imperatore Carlo VI, quando era una giovane sposa; a partire dal 1743, la sovrana ordinò grandi ampliamenti per trasformarlo nella residenza estiva della famiglia imperiale, sontuosa come Versailles ma allo stesso tempo più intima e familiare. Della sistemazione dei giardini si occupò il marito, che si avvalse di diversi artisti fatti venire dalla Lorena. Era un giardino formale alla francese, con viali diagonali che confluivano al centro lungo un asse longitudinale. Di fronte alla facciata sud del palazzo, si allungava un vasto parterre con aiuole a disegni (parterre de broderie), delimitato lateralmente dai "boschetti", stanze verdi con siepi ed alberi potati in forme geometriche. Questa era la parte pubblica e di rappresentanza del parco. C'erano poi giardini riservati alla sola famiglia imperiale, tra cui proprio il settore a vocazione scientifica voluto da Francesco Stefano. Intorno al 1750 egli acquistò dalla comunità di Hietzing un terreno situato all'estremità occidentale del parco. In primo luogo vi fece allestire il serraglio; costruito nel 1751 su disegno dell'architetto lorenese Jean-Nicolas Jadot, ha pianta radiale; il centro è occupato da un padiglione da cui si godeva una vista a 360° sui viali a stella che portavano alle singole gabbie e voliere; è una leggenda che nel sotterraneo si trovasse un laboratorio imperiale segreto. Inaugurato con un grande ricevimento nell'estate del 1752 e, benché trasformato, ancora esistente, è considerato il più antico giardino zoologico del mondo. Nel 1753, iniziarono i lavori per l'annesso orto botanico. Su suggerimento di Van Swieten, fu assunto un esperto orticultore di Leida, la città natale dell'archiatra: Adrianus van Stekhoven (o, alla tedesca, Adrian Steckhoven, 1704/05-1782) arrivò a Vienna insieme al suo assistente Ryk (o Richard) van der Schot (1733-1790), nativo di Delft; portavano con loro 10.000 bulbi e una collezione di piante esotiche, tra cui una palma con una storia. Stekhoven sosteneva che nel 1684 l'avesse fatta venire dall'India lo Statolder Guglielmo d'Orange, poi Guglielmo III d'Inghilterra; all'epoca, la pianta aveva un'eta stimata di 30 anni. Nel 1702 fu donata al re Federico I di Prussia; nel 1739 il suo successore l'aveva donata a lui. Egli la trapiantò nel giardino viennese nel 1753 e nel 1765, con assidue cure, riuscì a farla fiorire e persino a fruttificare. Da quel momento fu per tutti la "palma di Maria Teresa". Scomparsa da molto tempo, non è mai stata identificata con certezza, anche se è stato supposto potesse trattarsi di Corypha umbraculifera, una palma monocarpica nota per la crescita lenta e per aver l'infiorescenza ramificata più grande del mondo. In tal caso, sarà morta poco dopo la prodigiosa fioritura. Ma torniamo al giardino che, creato da maestranze olandesi, è noto come "Giardino olandese". Aveva pianta grosso modo rettangolare; separato dal serraglio sul lato nord da una palizzata, era diviso in tre riquadri, ciascuno dei quali comprendeva quattro aiuole simmetriche, con una fontana centrale, nel punto d'intersezione dei sentieri; nel primo riquadro vennero piantati i bulbi portati dall'Olanda e altri fiori, in quello centrale orticole e piante da fiore, nell'ultimo specie delicate da proteggere in inverno, non ci è noto se in piena terra o in vaso. Al di fuori del giardino, lungo il lato occidentale, c'erano piante da frutto; altri fruttiferi, potati a spalliera, erano coltivati lungo il muro orientale. All'estremità del giardino venne costruita una grande serra, cui più tardi vennero aggiunte due ali; sul lato occidentale, c'erano quattro serre più piccole, forse più simili a cassoni vetrati, e sul fondo la casa del capo giardiniere. Nell'arco di un anno, il giardino fu pronto. Era certo ben organizzato, con le piante sistemate in modo scientifico, secondo il modello dell'orto botanico di Leida, ma appariva ancora molto vuoto, e un po' troppo casalingo e troppo simile simile a un orto. Francesco Stefano avrebbe voluto qualcosa di decisamente più imperiale. Stando alle memorie che Nikolaus Joseph von Jacquin dettò al figlio Joseph Franz, non gli sfuggì che quel giovanotto frequentava assiduamente il recentissimo giardino: ne stava infatti catalogando le piante secondo il sistema di Linneo, ancora ignoto negli Stati austriaci (del resto, Species plantarum è del 1753). Sentito il solito van Swieten, capì che era la persona giusta per popolare quelle aiuole e quelle gabbie troppo vuote. Gli propose di partire per le Indie occidentali a fare incetta di piante e animali esotici. Von Jacquin accettò, e il 9 dicembre 1754, munito di precise istruzioni imperiali e accompagnato dal solo aiuto giardiniere van der Schot, partì all'avventura. Mi riservo di raccontare questa spedizione in un altro post, per concentrarmi qui sul giardino e i suoi giardinieri. Basti ora dire che la spedizione si protrasse per cinque anni e toccò gran parte delle Antille; Von Jacquin si rivelò un ottimo organizzatore e inviò periodicamente a Vienna animali, piante e casse di curiosità naturali; il primo invio dalla Martinica giunse già nell'agosto 1755. All'inizio del 1756, era pronto un invio particolarmente prezioso: 266 tra alberi e arbusti, di 40 specie differenti, in gran parte ancora ignoti in Europa; mediamente gli alberi erano alti un metro, con un tronco del diametro di un braccio e più. Van der Schot li aveva accuratamente preparati al viaggio, estirpandoli dal terreno con una gran parte delle radici; le zolle, che potevano pesare anche 100 libbre, venivano poi avvolte in foglie di banano e assicurate con corde di Hibiscus tiliaceus. Inoltre, per limitare al massimo il fabbisogno d'acqua, le chiome erano state accuratamente potate, mantenendo la forma naturale. Nonostante questi preparativi, se nessuno se ne fosse preso cura durante il viaggio oceanico quelle piante sarebbero in gran parte perite. Ecco perché ad accompagnarle fu van der Schot in persona, che il 28 febbraio si imbarcò con il prezioso carico alla volta dell'Europa su un vascello dal nome ben augurante, l'Espérance. Oltre alle piante c'erano 27 uccelli esotici, un formichiere, un uistitì e dieci casse di conchiglie, pesci essiccati, fossili, minerali e oggetti etnografici. Le piante erano state preparate così bene e seguite con tanta cura che, ad eccezione delle Heliconia divorate dai ratti di bordo, arrivarono tutte sane e salve: uno straordinario successo per l'epoca dei velieri, quando la percentuale di piante vive che riusciva a superare i viaggi transoceanici era bassissima. Von Jacquin spedì a Vienna in tutto sette invii. Con l'ultimo, partito dall'Havana nel gennaio 1759, viaggiava egli stesso, insieme all'ultimo dei suoi compagni, l'uccellatore toscano Barculli. Grazie alla fortunatissima spedizione, il serraglio e il giardino olandese si trovarono d'un colpo a eguagliare se non a superare le collezioni dei giardini reali di Parigi o Londra. Nominato giardiniere imperiale e direttore del giardino di Schönbrunn, Van Stekhoven lo diresse abilmente per molti anni, intervenendo anche nel resto del parco, dove aggiunse tra l'altro una grotta artificiale al di sopra della bella fontana che gli dà il nome. Anche se nel 1765 l'imperatore morì all'improvviso, le collezioni continuarono a crescere; le conosciamo grazie al catalogo manoscritto redatto da Richard var der Schott tra il 1774 e il 1779. Finché, in una fredda giornata del novembre 1780, si produsse un increscioso incidente: mentre van Stekhoven, ormai anziano, giaceva a letto per un attacco di gotta e van der Schot era influenzato, uno degli aiuti dimenticò di ricaricare la stufa della grande serra; al mattino, il capo giardiniere accorse e completò il disastro caricandola troppo: così le piante che erano sopravvissute al gelo morirono per il caldo eccessivo. Non c'è da stupirsi se fu messo a riposo e sostituito da van der Schot, che diresse i giardini imperiali fino alla morte nel 1790, inaugurando anche una dinastia di giardinieri; suo figlio Joseph tra il 1794 e il 1804 fu il capo giardiniere dell'orto botanico universitario di Vienna. In precedenza, era stato uno dei membri della spedizione Märter, decisa da Giuseppe II proprio per rimediare i guasti dell'incidente del 1780. Oltre a lavorare nei giardini imperiali, padre e figlio furono attivi come progettisti di giardini in Boemia. Nel 1785 Richard van der Schot disegnò il parco all'inglese del castello di Veltrus per il conte Johann Chotek, mentre all'inizio dell'Ottocento il figlio passò alle dipendenze del principe di Liechenstein che lo mandò in America a fare incetta di piante per trasformare il parco di Lednice in stile paesaggistico.  Splendide fioriture Van Stekhoven è ricordato da una via di Vienna (Steckovengasse) ma da nessuna pianta, al contrario di van der Schot, onorato dal genere Schotia, istituito da von Jacquin con una dedica che ben testimonia la sua stima per l'antico compagno di viaggio: "Questo alberetto che nel mese di ottobre fiorisce copiosamente e in modo assai elegante nella serra calda del giardino imperiale di Schönbrunn costituisce un nuovo genere; perciò gli ho dato un nuovo nome, desunto dall'eccellente Richard van der Schot, giardiniere imperiale e prefetto del giardino imperiale di Schönbrunn, un tempo mio compagno di viaggio in America, grazie alla cui cura indefessa e all'eccezionale abilità in quel giardino sono oggi coltivate tante piante rare che ogni anno producono fiori". Von Jacquin espresse la sua stima anche scegliendo una pianta particolarmente bella, come lo sono tutte le quattro specie di questo piccolo genere di Fabaceae endemico dell'Africa meridionale. Sono alberi da piccoli a grandi, con vistose fioriture, scarlatte per Schotia afra, S. brachypetala e S. capitata, rosa per S. latifolia. I colori giusti per attirare i loro principali impollinatori, gli uccelli nettarinidi. In effetti producono enormi quantità di nettare, un richiamo e una risorsa anche per api e altri insetti, ma un problema quando vengono piantati in aree pavimentate. Il fogliame decorativo e il portamento aggraziato ne fanno ottime piante da ombra nelle aree non soggette a gelate; nei paesi d'origine hanno però molti alti usi: i semi di tutte le specie sono eduli, e i baccelli vengono raccolti ancora verdi e poi arrostiti; la corteccia di alcune specie veniva usata per produrre coloranti; corteccia, e talvolta foglie e radici, hanno proprietà medicinali. Qualche approfondimento nella scheda. A partire dalla seconda metà del Settecento, l'Università di Vienna acquisì grande rinomanza per la sua scuola di medicina. Il merito spetta all'olandese Gerard van Swieten, che, nominato archiatra dell'imperatrice Maria Teresa, trapiantò nella capitale austriaca gli insegnamenti del suo maestro Boerhaave, riformando profondamente il fino ad allora arretrato insegnamento della medicina. Tra i suoi meriti, anche l'introduzione della chimica e della botanica nel curriculum dei futuri medici e la fondazione dell'orto botanico universitario di Vienna. Il suo allievo Nikolaus von Jacquin, che tanto gli doveva anche a livello personale, volle ricordarlo dedicandogli Swietenia, il genere cui appartengono gli alberi da cui si ricava il bellissimo mogano.  Un medico riformatore A Vienna, al centro della piazza omonima, campeggia il gigantesco monumento all'imperatrice Maria Teresa d'Austria, voluto da Francesco Giuseppe per celebrare la sua antenata e insieme le glorie dell'impero austriaco. La sovrana è assisa sul trono, al sommo di un alto pilastro in granito, ciascuno dei cui lati è ornato da un timpano con un gruppo ad alto rilievo ed una statua indipendente, che rievocano i quattro settori in cui eccelse l'Austria dei lumi: la politica, l'amministrazione, le armi, le scienze e le arti. A rappresentare queste ultime nel rilievo il numismatico Joseph Hilarius Eckhel, lo storico György Pray e i musicisti Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart bambino; davanti a loro la statua dell'archiatra Gerard van Swieten (1700-1772), fondatore della scuola di medicina di Vienna, che dell'imperatrice non fu solo il medico personale, ma ascoltatissimo consigliere e anima di molte riforme non solo in campo medico. Eppure egli non era né austriaco né suddito imperale, ed aveva accettato il prestigioso incarico con estrema riluttanza. Olandese, era nato a Leida in una famiglia cattolica di origini nobili. Iniziò gli studi nella città natale in modo brillante, ma a 12 anni perse il padre, un affermato notaio che lavorava soprattutto per una clientela cattolica. Inviato dai suoi tutori a studiare filosofia a Lovanio, si appassionò di scienze naturali. Avrebbe voluto studiare medicina a Leida, ma al momento non ne aveva la possibilità economica. Così a 15 anni fu messo a bottega ad Amsterdam presso il farmacista Laurens Tatum; tuttavia nel 1717 contrasse il vaiolo e, una volta guarito ritornò a Leida; ne approfittò immatricolarsi nella facoltà di medicina, in quegli anni dominata dal grande Boerhaave, un medico famoso in tutta Europa, che insegnava medicina, chimica, botanica e dirigeva l'orto botanico universitario. Fu così folgorato dalla sua versatile sapienza e dal suo metodo innovativo (Boerhaave fu il primo a portare i suoi studenti al capezzale dei malati, creando di fatto la medicina clinica) che per anni, anche quando era già lui stesso medico, continuò a seguire le sue lezioni (si dice ne abbia persa solo una). Tra il 1718 e il 1720 completò la formazione come farmacista presso Nicolaas Stam, decano della corporazione dei farmacisti e ottimo chimico (suo padre David era stato il maestro di chimica di Boerhaave), ottenendo la licenza nel 1720. Senza interrompere gli studi di medicina, aprì una propria bottega a Leida e nel 1725 si laureò con una tesi sulle arterie e le loro funzioni. Per qualche tempo affiancò le due attività di farmacista e medico, ma del 1727 si concentrò sulla medica e prese anche ad impartire lezioni private di chimica e medicina, finché nel 1734 gli venne vietato dall'Università. Come medico aveva un'ampia clientela ed era molto stimato, tanto che nel 1738, quando morì Boerhaave, sarebbe stato il più indicato a succedergli: ma ciò era impossibile, in quanto cattolico. Ne aveva seguito le lezioni fino alla morte, e nel 1742 iniziò a pubblicare i suoi aforismi con i propri commenti (Commentaria in Hermani Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, "Commenti sugli aforismi di Boerhaave su come diagnosticare e curare le malattie"); l'opera, arricchita con la sua personale pratica clinica, l'avrebbe accompagnato per tutta la vita, fino all'ultimo volume, uscito nel 1772. La sua fama intanto aveva travalicato i confini dell'Olanda; nel 1742 morì l'archiatra imperiale e, su raccomandazione del futuro cancelliere von Kaunitz, che all'epoca amministrava i Paesi Bassi austriaci e aveva sentito parlare della sua competenza professionale e della sua indipendenza di pensiero, il posto fu offerto a van Swieten che inizialmente rifiutò, scrivendo a un amico che preferiva rimanere "un piccolo repubblicano piuttosto che portare un titolo pomposo che nasconde un'esistenza da schiavo". La diplomazia imperiale però continuò a lavorarlo ai fianchi, finché, dopo un anno e mezzo, nell'ottobre 1744, forse soprattutto considerando che, come cattolico, aveva poche prospettive di carriera in patria, cedette, e da repubblicano si fece monarchico. Subito dopo l'accettazione, fu chiamato a Bruxelles, per assistere la sorella minore di Maria Teresa, governatrice dei Paesi Bassi, mai ripresasi dopo aver dato alla luce un bimbo nato morto. Purtroppo van Swieten non poté salvarla, ma non perse perciò la fiducia dell'imperatrice. Nel maggio 1745, dopo aver venduto i propri beni olandesi, si trasferì a Vienna con la famiglia; infatti, nel frattempo si era sposato con Maria ter Beeck van Coesfelt, anch'essa figlia di un notaio e sorella di un antico compagno di scuola di Lovanio, e ne aveva avuto cinque figli; la sesta, chiamata Maria Teresa, in onore della sovrana, sua madrina, sarebbe nata a Vienna. Van Swieten, le cui idee innovative (nonché i modi borghesi) erano tutt'altro che graditi a cortigiani e maggiorenti austriaci, godette della stima e dell'assoluta fiducia della sovrana; oltre che archiatra, fu nominato prefetto della biblioteca imperiale e nel 1749 gli fu affidata la riforma della facoltà di medicina dell'Università di Vienna, all'epoca molto arretrata e dominata dai gesuiti e dalla corporazione dei medici. Come preside della facoltà, Van Swieten, oltre a tenere egli stesso conferenze di fisiologia e medicina generale nella biblioteca di corte, rinnovò il corpo insegnante; dotò l'università di aule e strutture adeguate; istituì le cattedre di medicina teorica, medicina pratica, anatomia, chirurgia, chimica e botanica; rinnovò totalmente la conduzione degli ospedali di Vienna, trasformati in veri e propri centri di ricerca in cui furono create classi di medicina strutturate, dove gli studenti completavano la loro formazione al capezzale dei malati, imparavano a redigere una diagnosi motivata e assistevano alle autopsie. Tra i suoi maggiori collaboratori in campo medico, un altro olandese, Anton de Haen (1704-1776), da lui chiamato a reggere la cattedra di medicina pratica, che fu, tra l'altro, il primo a introdurre il controllo regolare della temperatura corporea e l'uso del termometro. Nel 1751, come bibliotecario imperiale, van Swieten fu nominato presidente della commissione di censura, dalla quale esautorò i gesuiti, cercando, anche se non sempre con successo, di analizzare i libri sulla base di criteri razionali, come l'utilità e la rilevanza scientifica. Nel 1752 l'Università divenne un'istituzione statale e riforme furono introdotte anche nelle facoltà di teologia, filosofia e giurisprudenza. L'imperatrice, che lo ascoltava anche in altri campi, nel 1755 gli affidò un'inchiesta su un preteso caso di vampirismo avvenuto in Moravia; van Swieten dimostrò che si trattava di una superstizione e in Abhandlung des Daseyns der Gespenster ("Discorso sull'esistenza dei fantasmi") diede una spiegazione scientifica dei vari fenomeni all'origine del mito; il risultato fu un decreto imperiale che vietava antiche pratiche macabre come esumare e trafiggere o bruciare i cadaveri dei supposti vampiri. Si dice che Bram Stoker si sia ispirato a lui per il personaggio del cacciatore di vampiri van Helsing del suo romanzo Dracula. La creazione dell'orto botanico di Vienna si inquadra nella generale azione riformatrice di van Swieten. Prima di lui all'università di Vienna non si insegnavano né la botanica né la chimica; inoltre, l'università non disponeva di edifici adeguati. Gradualmente, durante la sua gestione furono creati un anfiteatro anatomico, un laboratorio chimico, una clinica di facoltà e appunto un orto botanico, istituito nel 1754 in un'area di un ettaro sul Rennweg, adiacente al palazzo di Belvedere. Concepito come Hortus medicus, era destinato all'insegnamento della botanica applicata a medici e farmacisti e vi era annesso il laboratorio di chimica. Il progetto e la sistemazione delle piante vennero affidati al francese Robert Laugier (1722-1793), primo titolare della cattedra di chimica e botanica fin dal 1749, e poi primo direttore dell'orto botanico, che fece sistemare le aiuole didattiche secondo il sistema di classificazione di Boissier de Sauvages basato sulla forma delle foglie. Laugier diresse il giardino per una quindicina di anni, finché van Swieten, che ne aveva scarsa stima (gli rimproverava l'insufficiente conoscenza del latino e, come amico e corrispondente di Linneo, certo poco apprezzava il sistema di Sauvages), riuscì a costringerlo alle dimissioni, convincendo l'imperatrice a tagliargli lo stipendio: aveva infatti pronto per rimpiazzarlo un botanico di ben altro valore: il suo conterraneo, allievo e protetto Nikolaus Joseph von Jacquin, secondo prefetto dell'orto botanico e titolare delle cattedre di chimica e botanica dal 1768. Gli ultimi anni di van Swieten furono funestati, oltre che da un serie di malattie (nel 1772, in seguito a un tumore, subì anche l'amputazione di una gamba), dallo scontro con il figlio maggiore di Maria Teresa, divenuto imperatore come Giuseppe II nel 1765 in seguito alla morte del padre Francesco Stefano di Lorena. Egli infatti imputava al medico olandese la morte delle due mogli e delle due uniche figlie: nel 1763 la prima moglie era morta di vaiolo insieme alla secondogenita neonata, nel 1767 sempre di vaiolo era morta anche la seconda, mentre nel 1770, l'adorata figlia maggiore Maria Teresa era morta di pleurite ad appena otto anni. Quale fosse la responsabilità del vecchio medico in queste tragedie non saprei, ma certo egli inizialmente si era opposto all'inoculazione del vaiolo, una pratica ancora molto rischiosa. Il vaiolo lo era anche di più: tra le vittime di questa malattia implacabile ben cinque dei sedici figli dell'imperatrice; solo dopo la morte della sedicenne arciduchessa Maria Giuseppina, van Swieten si convinse e scrisse a William Pringle, il medico di Giorgio III, chiedendo di inviare a Vienna un medico esperto per inoculare il vaiolo all'intera famiglia imperiale. La scelta cadde su un altro olandese, Jan Ingenhousz, che aveva già inoculato con successo i famigliari di Giorgio III. Dopo aver brillantemente espletato il suo compito, rimase a Vienna come medico imperiale e qui completò i suoi studi in cui gettò le basi della comprensione del meccanismo della fotosintesi. Va dunque ascritto a merito di van Swieten aver portato a Vienna, oltre a de Haen e von Jacquin, anche questo dotatissimo connazionale. Il figlio maggiore Gottfried si illustrò in altri campi. Dapprima diplomatico, poi prefetto della biblioteca imperiale e presidente della commissione di censura dopo il padre, è celebre soprattutto per i suoi interessi musicali. Ambasciatore a Berlino negli anni '70, commissionò sei sinfonie a Carl Philipp Emanuel Bach, che gli dedicò una delle sue opere più famose, la terza raccolta delle Sonate per intenditori ed appassionati; a Berlino inoltre raccolse molti manoscritti di Bach e Händel, che poi fece regolarmente eseguire nei concerti domenicali che si tenevano nella biblioteca di corte, influenzando profondamente tanto Mozart quanto Haydn. Nel 1780, proprio nell'intento di far conoscere e diffondere la musica degli antichi maestri, fondò la Società dei cavalieri associati, per la quale tra il 1789 e il 1790 Mozart arrangiò diversi opere di Händel, tra cui il Messiah, che il salisburghese diresse più volte al clavicembalo. Alla sua morte, fu van Swieten a pagarne il funerale, quindi organizzò la prima esecuzione del Requiem, tenuta come concerto di beneficenza a favore della vedova e dei figli. Van Swieten figlio ebbe stretti rapporti anche con Haydn, per il quale scrisse i libretti della Creazione e delle Stagioni, e con il giovane Beethoven, che gli dedicò la prima sinfonia.  Il mogano, un legname troppo sfruttato Nikolaus von Jacquin non mancava mai di ricordare coloro che in un modo o in un altro lo avevano aiutato nelle sue ricerche; non poteva certo dimenticare il suo maestro, colui che gli aveva aperto la strada di Vienna e aveva gettato lo basi della sua carriera scientifica. Per onorarlo degnamente, scelse una pianta speciale: quella da cui si ricava il più ricercato e bello dei legnami, il mogano. Linneo, come i botanici dell'epoca, pensava che avesse qualche affinità con i cedri e lo collocò nel genere Cedrela come C. mahagoni. Von Jacquin lo assegnò al nuovo genere Swietenia, come S. mahagoni (1760). Questo grande albero delle Antille all'epoca era l'unica specie nota, o almeno fino all'inizio dell'Ottocento si pensava che le variazioni che si riscontravano nel legname proveniente da altre zone fossero dovute al suolo o alle condizioni di crescita, finché nel 1837, studiando esemplari raccolti durante una spedizione nella costa pacifica del Messico, Zuccarini ne identificò una seconda specie di dimensioni minori che chiamò S. humilis. Infine nel 1886, George King, il sovrintendente dell'orto botanico di Calcutta, ne identificò una terza specie, proveniente dall'Honduras e appunto coltivata in quel giardino, e la denominò S. macrophylla. Sono queste le tre specie del genere (famiglia Meliaceae), abbastanza simili tra loro, ma presenti in areali diversi e solo in parte contigui: S. mahagoni è esclusivo della Florida meridionale e delle Antille (Bahamas, Cuba, Giamaica, Hispaniola); S. humilis occorre lunga la costa pacifica dal Messico all'America centrale; S. macrophylla, infine, la specie di maggiore diffusione, vive invece lungo la costa atlantica di Messico e America centrale e si spinge in Sud America fino all'Honduras, alla Bolivia e al Brasile. Sono alberi da medi a grandi (il maggiore, S. mahagoni, può superare i quaranta metri, con un tronco dal diametro di due metri), piuttosto ramificati, con foglie pinnate, da decidue a semi sempreverdi, a seconda dell'area di crescita; i fiori, raccolti in infiorescenze lasse, sono piccoli, con cinque petali ovati da bianchi a verde giallastro; i frutti invece sono grandi capsule legnose più o meno ovoidali che si aprono in cinque valve e contengono numerosissimi semi alati. Gli europei probabilmente conobbero il mogano, o almeno il suo legname, fin dal loro arrivo nelle Antille. Si dice che sia fatta di mogano una croce, datata 1512, conservata nella cattedrale di Santo Domingo, così come alcuni arredi dell'Escorial del tempo di Filippo II. Gli spagnoli però lo utilizzarono soprattutto per le costruzioni navali, e anche nei possedimenti francesi delle Antille fu scarsamente sfruttato. A lanciarne la voga furono dunque gli inglesi, soprattutto dopo il 1721, quando un decreto del Parlamento britannico eliminò i dazi per il legname importato dalle Indie britanniche. Nel corso del secolo, divenne uno dei legnami più apprezzati per ebanisteria, mobili e finiture di prestigio, tanto in Gran Bretagna quanto nelle Tredici colonie; il 90% arrivava dalla Giamaica, il resto dalle Bahamas, con piccoli contributi da altre isole, cui, dopo la temporanea occupazione di Cuba durante la guerra dei Sette anni, si aggiunse anche quest'isola. Attraverso le colonie britanniche, ci è giunto anche il nome mogano. Mentre in spagnolo l'albero - ma anche il suo legname - veniva (e viene) chiamato caoba, un nome derivato da una lingua dei Caraibi, e in francese acajou, dalla lingua tupi, nelle Antille britanniche incominciò ad essere noto come mahogany, una parola dall'etimologia discussa. La spiegazione più diffusa, ma non certo accettata da tutti, la fa risalire a m’oganwo, un nome che gli sarebbe stato dato dagli schiavi neri giamaicani per la sua somigliano con un albero africano (Khaya ivoriensis), chiamato in yoruba oganwo, ovvero "re del legno". Come che sia, il commercio del mogano americano, che nell'Ottocento si estese anche alle altre due specie, divenne così imponente da mettere a rischio la sopravvivenza di questi alberi; il mogano delle Antille era già raro all'inizio del Novecento, e un secolo dopo anche quello centro e sudamericano era avviato sulla stessa strada. Oggi tutte e tre le specie sono incluse nella lista rossa delle piante minacciate; nel 1975 Swietenia humilis è stato inclusa nell'Appendice II CITES (la lista delle piante a rischio di estinzione senza una stretta regolamentazione), seguita nel 1992 da S. mahagoni e nel 2003 da S. macrophylla. Questa è di fatto l'unica specie oggi di una qualche importanza commerciale; dopo che nel 2001 il Brasile ne ha vietato l'esportazione, il maggior produttore è divenuto il Perù, da cui proviene circa il 74% della produzione mondiale, purtroppo in gran parte tagliata illegalmente nella foresta amazzonica. La coltivazione di S. macrophylla, in seguito alle crescenti restrizioni del commercio del mogano americano, alla fine del Novecento è stato introdotta in vari paesi asiatici (India, Bangladesh, Indonesia) e nelle Fiji, ma queste piantagioni sono ancora recenti, con alberi giovani: ecco perché il commercio illegale continua. La soluzione più sostenibile è dunque non acquistare prodotti ricavati dal legname di questi alberi minacciati. D'altro canto nelle Filippine, dove sia S. mahagoni sia S. macrophylla sono state introdotte all'inizio del Novecento, sono considerate specie invasive, con un impatto negativo sul suolo e la biodiversità naturale. Dunque anche l'introduzione al di fuori della loro area d'origine non è senza rischi. Nel 1755 l'Isle de France (ovvero Mauritius) è il teatro dello scontro tra due uomini di piante, o forse due modi di intendere la botanica coloniale: da una parte c'è Pierre Poivre, intenzionato a trasformare l'isola nell'avamposto francese della coltivazione delle spezie; dall'altra Jean Baptiste Christophe Fusée-Aublet, impegnato a sperimentare coltivazioni utili non solo per la Compagnia delle Indie, ma anche per gli abitanti. Poivre, anni dopo, quando tornerà nell'isola come sovrintendente delle Mascarene, riuscirà davvero a farvi prosperare alberi di noce moscata, cannella e chiodi di garofano, ma per ora le poche piante che è riuscito faticosamente a procurarsi soccombono una dopo l'altra. Di chi è la colpa, se non di Fusée-Aublet, geloso dei suoi successi? E' stato lui, ne è certo, a sabotarli, avvelenandoli o innaffiandoli con acqua bollente. Le accuse di Poivre non vengono prese troppo sul serio dalla Compagnia delle Indie, ma bastano a costringere il suo rivale a lasciare l'isola e da quel momento saranno una macchia incancellabile sulla sua reputazione, tanto che nel suo capolavoro, Histoire des plantes de la Guiane françoise, pubblicato vent'anni dopo il fattaccio, si vedrà ancora costretto a confutarle. Inutilmente, almeno nel web, dove ancora oggi domina la versione di Poivre, e il venticello delle sue calunnie continua a far "l'aria rimbombar". E' ora di rendere giustizia a Fusée-Aublet, un grande botanico, la cui sola colpa probabilmente fu amare la verità e l'umanità, al punto da essere uno dei primissimi abolizionisti. Nonché l'autore di un'opera di riferimento per la flora sudamericana, in cui, anticonformista anche in questo, i nomi dei nuovi generi sono per lo più tratti dalle denominazioni locali. 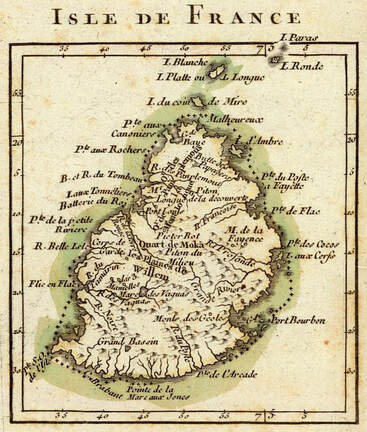 Un soggiorno tempestoso e una leggenda nera dura a morire Il 20 settembre 1761 il farmacista e botanico Jean Baptiste Christophe Fusée-Aublet (1723-1778) lascia definitivamente l'Isle de France (oggi Mauritius), dove per nove anni ha diretto il laboratorio farmaceutico e il giardino sperimentale della Compagnia francese delle Indie. Tre giorni prima, ha accompagnato a visitarlo l'astronomo Guy Pingré. Nelle sue memorie di viaggio, quest'ultimo descrive con ammirazione il giardino e traccia un ritratto memorabile del suo ospite: "Credo questo chimico-naturalista un uomo onesto e intelligente, ma è troppo sincero; non può tenere per sé nessuna verità, la diffonde ovunque; ma, come dice il proverbio, non tutte le verità devono essere dette. All'Isle de France si è fatto quasi altrettanti nemici quanti abitanti". Tra le verità che è meglio non dire ci sono soprattutto le sue convinzioni sui neri e sulla schiavitù, che lo mettono in urto con i coloni dell'isola, che traggono le loro ricchezze dalle piantagioni lavorate da schiavi. Ed è stata probabilmente una verità di troppo a farlo diventare la bestia nera di Pierre Poivre. Ma andiamo con ordine, per inquadrare meglio la personalità di Aublet, indubbiamente un uomo anticonformista e dal carattere spigoloso, anche se non il caratteriale che talvolta viene dipinto. Quando arriva all'Isle de France, nel 1752, è sulla trentina ed ha già alle spalle molte esperienze. Figlio di un farmacista di Salon, in Provenza, fin dall'infanzia è stato "quasi dominato da una grande passione per le diverse parti della Storia naturale, e specialmente per le piante". Come il conterraneo Tournefort prima di lui, spesso marina la scuola per erborizzare nelle campagne, ma le piante provenzali non gli bastano. Quando viene a sapere che a Tolone si sta armando una flotta diretta in Spagna, scappa dal collegio e si imbarca, senza informarne la famiglia. Giunto a Granada, per un anno è apprendista del farmacista Antonio Sanchez Lopez, da cui apprende l'arte della distillazione, finché viene scoperto e riportato a casa. Dopo un breve soggiorno a Salon, eccolo a Montpellier per seguire i corsi di chimica di Fitzgerald e di botanica di Boissier de Sauvages; quindi passa qualche mese a Lione, dove frequenta la bottega di Christophe de Jussieu, fratello maggiore dei botanici del Jardin du roi. Anche da lui c'è molto da imparare, ma l'inquieto desiderio di viaggiare spinge Aublet ad arruolarsi nell'esercito dell'infante Filippo (ovvero il futuro Filippo I di Borbone-Parma), impegnato nel teatro italiano della guerra di successione austrica. Vi resiste per due campagne, ma scopre presto che "questo lavoro essendo molto tumultuoso e poco istruttivo, non favoriva quanto avevo sperato il mio gusto per la ricerca di piante". Così lascia l'esercito e nel 1745 è a Parigi, dove lavora all'ospedale della Charité, stringe amicizia con il chimico Gabriel François Venel e segue corsi di chimica e botanica al Jardin du roi, legandosi particolarmente con Bernard de Jussieu (che definisce un'enciclopedia vivente); frequenta anche i salotti parigini e trova qualche protettore, tra cui il barone d'Holbac. A Parigi rimane fino al 1752, divenendo un eccellente chimico-farmacista e un ottimo botanico; progetta di andare in Prussia a studiare con il celebre chimico Johann Heinrich Pott, quando, su raccomandazione del ministro della marina Berryer, viene assunto dalla Compagnia delle Indie per fondare un laboratorio di chimica e un giardino sperimentale all'Isle de France. Entrambi avrebbero dovuto fornire medicinali e cibo per rifornire le navi della Compagnia che facevano scalo a Mauritius sulla rotta dell'Oriente, Con il titolo di botanico e primo compositore-farmacista della Compagnia della Indie, parte da Parigi nel dicembre 1752; per mantenersi in esercizio e prepararsi al nuovo compito, si reca al porto di Lorient a piedi, facendo raccolte lungo la strada. Arriva all'Isle de France nell'agosto 1753 e quando sbarca senza bagagli, se non i suoi strumenti scientifici, suscita subito i sospetti dei locali: contrariamente all'uso, non ha approfittato del viaggio per portare con sé, come tutti fanno, la cosiddetta "paccottiglia", ovvero mercanzie da commerciare a proprio vantaggio. Crea il laboratorio e un primo giardino a Pamplemousses, ma presto iniziano gli scontri con i vicini, che lo accusano di usare troppa acqua e passano alle vie di fatto, tagliando al piede le sue piante. Così, pur mantenendo a Pamplemousses un orto, in autunno trasferisce il giardino sperimentale e il laboratorio a Le Réduit nel quartiere di Moka, una dozzina di km più a sud, in un luogo protetto e naturalmente fortificato. Vi si è appena trasferito quando il suo destino si incrocia con quello di Pierre Poivre, che è riuscito a convincere la Compagnia, piuttosto scettica e riluttante, a inviarlo in missione segreta nelle Filippine e nelle Molucche, da dove conta di contrabbandare piante o semi di noce moscata e chiodi di garofano da acclimatare a Mauritius, per spezzare il monopolio olandese delle spezie; dopo diverse vicissitudini, a Manila, è riuscito a procurarsi 32 piante di noce moscata (Myristica fragrans), mentre è fallito il suo tentativo di contrabbandare piante di chiodi di garofano (Syzigium aromaticum). Durante il viaggio, le piante muoiono una dopo l'altra; quando infine nel dicembre 1753 Poivre sbarca all'Isle de France, ne rimangono in vita solo cinque, una sola delle quali vigorosa e di buona qualità. Nella quasi totale indifferenza della Compagnia, le affida a tre coloni e a maggio riparte per una seconda missione. Che è un totale fallimento: le Filippine sono in guerra e non ha modo di procurarsi le piante che gli erano state promesse; quanto alle Molucche non gli è neppure possibile avvicinarsi. Così, quando nel giugno 1755 rientra nel porto dell'Isle de France, nelle stive della sua nave, oltre a un carico di noci moscate e chiodi di garofano, c'è solo una misera cassetta con una giovane pianta di noce moscata e una noce germinata. Le notizie cattive non sono finite: chiamato ad esaminare il carico, Aublet constata non solo che le noci e i chiodi di garofano sono troppo vecchi per germinare, ma anche che l'albero e la noce germinata non sono di noce moscata, ma di palma di Betel (Areca catechu). Una "verità" che Poivre non è disposto ad accettare; quando poi scopre che durante la sua assenza tutte e cinque le piante portate dal primo viaggio sono morte, gli è chiaro che deve esserci un colpevole, e quel colpevole è Aublet, che avrebbe volutamente sabotato l'introduzione delle spezie a Mauritius per non vedere smentita la sua tesi che l'isola è inadatta alla loro coltivazione, o peggio, perché è in combutta con il direttore Duvelaër, chiaramente un traditore dato quel cognome che suona olandese. Anche se cerca di rifiutarsi, sapendo che la sua morte gli verrebbe imputata, la pianta superstite viene affidata a Aublet, e muore anche quella. Nei mesi successivi, prima a Mauritius, che lascia nell'aprile 1756, poi a Parigi, Poivre moltiplica le denunce e le memorie inviate ai vertici della Compagnia, a dire il vero senza ottenere il minimo credito. Ma intanto il venticello della calunnia ha incominciato a soffiare, e all'Isle de France è alimentato dall'ostilità generale dei coloni contro il farmacista-botanico. E' efficiente, attivo, competente ed ha trasformato il giardino del Réduit in un paradiso, colmo di piante da frutto e di piante "utili, rare o curiose, venute da ogni parte del mondo", ma ha una grave colpa: la totale mancanza di pregiudizi contro i neri. Ha imparato ad apprezzarli lavorando a fianco a fianco con loro; quando un tifone devasta l'isola, per settimane è stato impegnato a creare nuove strade "dormendo nei boschi" con una squadra di schiavi malgasci "intelligenti, energici, pieni di risorse"; ne riconosce anche la sapienza etnobotanica e li consulta per individuare piante medicinali o alimentari utili. Quando i coloni, per tagliare i viveri ai maroons e impedire che gli schiavi fuggano per unirsi a loro, chiedono al Governatore di distruggere il songo, una specie di taro che fornisce loro cibo, Aublet si oppone, sottolineando che la pianta sarà utile a tutti in tempi di carestia. Tra le verità che sarebbe meglio tenere per sé c'è il convincimento, come proclamerà a chiare lettere in "Observations sur les Nègres Esclaves", pubblicato in appendice a Histoire des plantes de la Guiane françoise, che "non è vero che i negri, in generale, siano pigri, mascalzoni, bugiardi, dissimulatori; queste caratteristiche sono frutto della schiavitù, non della natura". La schiavitù va abolita, tanto per rispetto dell'umanità quanto per convenienza economica: "Se restituirete loro la libertà non saranno più mentitori, ladri o disonesti della gente agiata delle città europee. Li vedrete economi, abili e intelligenti in tutto ciò che vorranno intraprendere per il loro proprio profitto". Tra i suoi nemici ci sono anche i farmacisti locali, che lo accusano di non fornire loro i medicinali richiesti (in effetti, preferisce le meno costose e più efficaci medicine locali che ha imparato a riconoscere proprio dai disprezzati schiavi neri), nonché i chirurghi delle navi della Compagnia, a cui fornisce solo quelli necessari, impedendo loro di fare la cresta rivendendo il sovrappiù. Come racconta nella autobiografia premessa a Histoire des plantes de la Guiane françoise, nell'atmosfera avvelenata dell'isola il risentimento di Poivre trova terreno fertile: "Mentre ero impegnato in queste attività, la presentazione di un supposto albero di noce moscata e di noci da parte del signor Poivre mi causò molti fastidi, perché non potei né volli riconoscere in questo albero e in queste bacche le vere noci moscate. Ne informai la Compagnia con una memoria, e questa condotta mi procurò molti nemici, che si vendicarono calunniandomi". Nel 1761 l'atmosfera si è fatta così pesante che Aublet decide di lasciare l'isola e di rientrare in Francia; ma prima di partire, coerente con le sue idee, affranca tutti i suoi schiavi, tra cui una giovane donna, Armelle Conan, che ha riscattato dalla Compagnia; ne ha avuto un figlio e in patria diventerà sua moglie. In Francia, però, lo hanno preceduto anche le voci diffuse da Poivre che, quando questi diventerà Intendente delle Mascarene e trasformerà in realtà il vecchio sogno di coltivarvi le spezie, diventeranno la vulgata, la verità ufficiale. Smentita dalla ricerca (si segnala in particolare questo documentatissimo articolo), la leggenda nera di Fusée-Aublet distruttore di alberi resiste imperterrita nel web. Basti fra tutti (ma gli esempi sono innumerevoli, e non manca qualche sito italiano) la versione francese di Wikipedia, alla voce "Poivre, Pierre", in cui non c'è quasi una parola vera: "Al suo ritorno all'Isle de France nel 1755, con 3000 [sic!] noci moscate, piante di spezie e frutti diversi, scopre le sue prime piante di noce moscata morte. Quando anche le nuove piante muoiono, un'inchiesta [mai avvenuta] rivela che Fusée-Aublet, che pretendeva che la noce moscata non poteva essere naturalizzata all'Isle de France, aveva volontariamente ucciso le giovani piante innaffiandole con acqua bollente".  Un botanico eroico nelle foreste della Guyana Aublet è da poco tornato in Francia ed ha fatto appena in tempo a fare una scappata a Salon, dove intende creare un giardino d'acclimatazione con le piante tropicali che ha portato con sé, quando il Ministro della Marina, il duca di Choiseuil, lo invita a recarsi in Guyana come farmacista-botanico del re. Il botanico, che ha superato la quarantina e , dopo l'avventura di Mauritus, ne ha abbastanza delle colonie, esita, ma quando gli viene assicurato che gli verrà lasciato mano libera per erborizzare a suo piacimento, si lascia convincere: alla prospettiva di essere il primo esploratore di quella flora quasi sconosciuta dimentica tutti i problemi e la sua passione per le piante si riaccende irresistibile. Il suo compito sarà niente meno che "vedere ed esaminare tutto ciò che può essere relativo alle vostre conoscenze sui prodotti della nuova terra; farne delle buone memorie e rendere conto di tutto ciò che si può fare per un paese che merita più attenzione di quanto ne abbia finora ricevuta". Insomma, un programma immenso, ma in un certo senso illuminista che non manca di solleticare il suo amor proprio. Imbarcatosi nel porto militare di Blaye alla fine di maggio, già a luglio sbarca in Guyana. Inizialmente è ospite della piantagione gesuita di Loyola, presso Cayenne, la capitale della colonia. I gesuiti, installati in Guyana fin dal secolo precedente, vi hanno creato molte missioni, controllano le maggiori proprietà ed esercitano un vero e proprio monopolio spirituale sugli indios. La loro mediazione è indispensabile a Aublet per entrare in contatto con questi ultimi, che gli sono necessari come guide, portatori e detentori di conoscenze sulle piante e i loro usi. Il momento non potrebbe essere peggiore: la Francia è nel pieno della campagna che nel 1764 porterà all'espulsione dei gesuiti dal regno; anche in Guyana, l'effettiva presa di possesso della colonia da parte francese passa attraverso l'esautoramento della Compagnia di Gesù. Aublet cerca di destreggiarsi, facendo mostra di tatto e diplomazia, ma gli è presto chiaro che i gesuiti vedono in lui una spia, l'agente di un potere nemico, dunque cercano di sabotarlo, impedendogli di allontanarsi più di tanto da Cayenne e di entrare in contatto con gli indios. Solo ad ottobre riesce finalmente a visitare la missione di Kourou, a una sessantina di km a nord di Cayenne, all'imboccatura del fiume omonimo, dove scopre che i padri, oltre a sfruttare la manodopera indiana, praticano un vero e proprio commercio illegale con il Suriname olandese. Secondo la sua relazione al ministro Choiseuil, oltre a tenerlo lontano dagli indios, il padre O'Reilly li ha prevenuti contro di lui, facendo girare la voce che "sotto il pretesto di cercare fiori e simili, quando avrà visto tutto, farà venire dalla Francia una nave con soldati che ci prenderanno con le nostre donne e i nostri figli per venderci come schiavi del re di Francia". Nei mesi successivi le relazioni del botanico francese con i gesuiti giungono al punto di rottura, ma ora egli è in grado di muoversi senza di loro; nell'aprile 1763, lascia Cayenne in canoa, risalendo i fiumi Tour de l’Ile e Oyak, fino a raggiungere la prima settimana di maggio il territorio galibi; è l'inizio della vera e propria esplorazione della foresta, descritta in Histoire des plantes de la Guiane françoise come un mondo alieno, pericoloso ed ostile: "Solo le persone che sono entrate nelle foreste della Guyana possono farsi un'idea dell'estrema difficoltà che si incontra per penetrarvi, a causa delle liane, degli arbusti spinosi, delle erbe taglienti che occupano gli spazi tra i grandi alberi; perché, per poco che ci si allontani dalle abitazioni, non si trovano né sentieri né passaggi: bisogna aprirseli ad ogni passo. [...] Bisogna essere penetrati in queste foreste per comprendere il pericolo che si corre ad ogni istante di ferirsi, di storpiarsi, di essere attaccati da neri maroons o scappati e arrabbiati, o da animali feroci; di calpestare un serpente che si vendica in modo crudele, di cadere in profonde buche colme d'acqua, di rovi o altre piante, di melma, tanto che un uomo solo non riuscirebbe mai a cavarsene fuori". A confronto, sono solo fastidi le punture degli insetti, il caldo soffocante, le piogge improvvise e di un'intensità ignota in Europa, la scomodità dei bivacchi, la difficoltà stessa di raccogliere piante, fiori, frutti, semi in una foresta vergine (sempre che nel frattempo non siano appassiti, o siano stati distrutti da uccelli o insetti). Per superare tutto questo e resistere, il botanico viaggiatore (così si autodefinisce Aublet) deve essere animato da un invincibile ardore, una passione a tutta prova, indispensabile come le altre qualità che elenca puntigliosamente, un po' per costruirsi agli occhi del lettore una figura eroica, un po' per mettere sull'avviso i botanici che volessero imitarlo: una forte costituzione, una salute perfetta, senza difetti ereditari o acquisiti; fermezza d'animo, risolutezza, spirito gaio (la malinconia e la nostalgia sono un pericolo peggiore di calpestare un serpente), ardimento, sensi ben svegli e all'erta. Nel marzo dell'anno successivo Aublet continua la sua esplorazione risalendo il fiume Orapu e raggiungendo il Monte Kaw; quindi, risalendo il torrente Timoutou, raggiunge nuovamente il Tour de l’Ile, da cui inizia il viaggio di ritorno, che lo riporta di nuovo a Cayenne, con una puntata alle Iles du Salut. In tre anni di esplorazione, mette insieme raccolte eccezionali; oltre agli animali e alle piante vive e alle casse di minerali, conchiglie, insetti che invia regolarmente in Francia, lo testimoniano l'imponente erbario e le oltre 500 specie ignote alla scienza frutto delle sue erborizzazioni. Non avrebbe potuto raggiungere questo risultato senza l'aiuto degli unici che sanno come percorrere quelle foreste impenetrabili: gli schiavi e gli indios che si è costretti ad assumere come guide e portatori; ma anche loro, si affretta ad aggiungere Aublet "sono un oggetto di inquietudine quasi continuo: bisogna indovinare le loro intenzioni, i loro complotti, fare in modo di farsi rispettare, temere ed amare, se ciò è possibile, in modo che non vi abbandonino in mezzo ai boschi, o magari vi uccidano". Bisogna anche armarli, e il nostro botanico, che sa bene come pesare torti e ragioni, aggiunge "un europeo viene così a trovarsi con dieci o venti persone armate che hanno tutte le ragioni di lamentarsi degli europei". Agli ostacoli fisici e psicologici, si aggiunge un ostacolo conoscitivo: il botanico deve fare i conti con una flora quasi totalmente ignota; per venirne a capo, non ci sono che due strade: da una parte, moltiplicare l'attenzione, tutto osservando, tutto annotando; dall'altro, immergersi in quell'ambiente naturale, frequentare gli indigeni, raccogliendo dalle loro bocche, e dal loro esempio, tutte le notizie possibili su quelle piante, il loro nome, i loro usi, le loro virtù e i loro pericoli. Aublet, malato, lascia la Guyana nel 1764. Di passaggio a San Domingo, vi si trattiene otto mesi su richiesta del governatore, il conte d'Estaing, che chiede il suo aiuto per l'insediamento nella colonia di un gruppo di rifugiati acadiani; come direttore della piazzaforte di Môle-Saint-Nicolas, collabora all'allestimento del sito di Bombardopolis, così chiamato in onore di uno dei suoi protettori parigini, il finanziere Pierre-Paul Bombarde de Beaulieu. Poi la salute, già compromessa, lo costringe a lasciare anche questo incarico, che considera onorifico e in qualche modo la prova che "le calunnie che erano state diffuse dai nemici che mi ero fatto all'Isle de France non avevano lasciato nemmeno i più leggeri sospetti su di me". Rientrato a Parigi all'inizio del 1655, dopo aver soggiornando per qualche tempo nel sud per recuperare la salute, dedica i dieci anni seguenti al compito non meno eroico di scrivere e pubblicare Histoire des plantes de la Guiane françoise, un'impresa che sarebbe stata impossibile senza l'aiuto del suo maestro e biblioteca vivente Bernard de Jussieu. Il risultato è imponente: quattro volumi, due di testi e due di figure, con la descrizione di 576 generi e 1241 specie, quasi metà delle quali nuove. L'opera, molto curata graficamente e certo costosa, rispetta tutti i crismi della scientificità (accurate diagnosi in latino, classificazione delle piante secondo il sistema linneano), ma vuole coinvolgere anche un pubblico più ampio di appassionati e curiosi; così Aublet adotta il francese non solo per la prefazione (in gran parte, un'autobiografia dai toni appassionati) e le appendici, ma anche per le descrizioni, sempre corredate del luogo di raccolta, dell'eventuale periodo di fioritura, del nome vernacolare e non di rado di indicazione dell'uso che ne fanno gli indigeni, il che ne fa anche uno dei primi testi di etnobotanica. Aublet creò circa 200 nuovi nomi generici (molti dei quali tuttora accettati) e, contrariamente all'uso dominante, non li trasse né dal latino né dal nome di personaggi illustri, ma (a parte pochi dedicati a persone che lo avevano aiutato in Guyana) per lo più dai nomi locali, soprattutto galibi (74 denominazioni). Tra i tanti, vorrei ricordare almeno Hevea, il genere cui appartiene l'albero della gomma, per il quale Aublet scelse il nome vernacolare in uso nella provincia di Esmeraldas in Ecuador. Le 400 tavole che formano il terzo e il quarto volume, basate almeno in parte su disegni dello stesso Aublet e affidate a diversi pittori e incisori, sono di eccellente qualità. Alla fine del secondo volume sono riunite varie appendici (Memorie o osservazioni), dedicate a produzioni particolari (caffè, canna da zucchero, manioca, vaniglia, diverse palme), a informazioni etnografiche sui galibi, alla distillazione degli oli essenziali di erbe aromatiche, o ancora a qualche notizia sulla flora dell'Isle de France. Tra tutte spicca il già citato "Observation sur les Negres esclaves" in cui il botanico perora l'abolizione della schiavitù; citiamone ancora un passaggio significativo: abolendo la schiavitù "l'umanità non sarà più umiliata dai vizi che rimproverate a questi schiavi, e che sono in parte opera vostra, o l'effetto di circostanze che trasformano l'uomo naturalmente buono nell'essere più malvagio della natura. Voi risparmierete i rimproveri che il vostro cuore deve farvi per aver trattato o fatto trattare come bestie esseri che non differiscono in niente da voi, se non per circostanze che dovrebbero invece intenerirvi in loro favore". Davvero, non siamo molto lontani da Rousseau; e certo, anche se i particolari della loro relazione ci sono ignoti, i due dovettero conoscersi e frequentarsi, se una parte dell'erbario di Aublet passò al filosofo ginevrino. Il grosso, invece, alla morte del botanico, avvenuta nel 1778, fu venduto dalla vedova a Banks, e ora si trova al Natural History Museum di Londra. 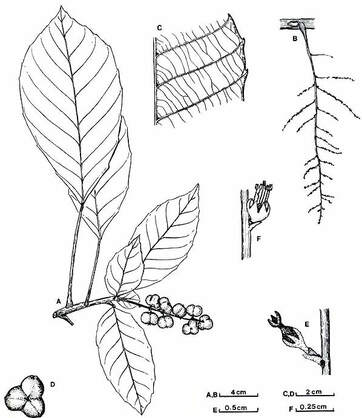 Dediche rischiose Per citare Lucille Allorge, "Come si può credere che un uomo così abbia scientemente distrutto gli pseudo-alberi di noce moscata di Poivre?". Speriamo che le celebrazioni del terzo centenario della nascita, che cade in questo 2023, gli portino finalmente giustizia. I botanici lo hanno fatto da un pezzo, ricordandolo con molti generi. Prima ancora che pubblicasse il suo opus magnum, nel 1771, il botanico del Jardin du roi Le Monnier, che insieme a Bernard de Jussieu lo aveva raccomandato per la missione in Guyana, gli dedicò un primo Aubletia, poi ripubblicato due anni dopo come Obletia (la grafia si rifà alla pronuncia), nome inutile perché sinonimo di Verbena. Qualche anno dopo, nel 1788, il botanico tedesco Joseph Gaertner gli dedicò un secondo Aubletia, un genere monospecifico della famiglia Lythraceae rappresentato solamente da A. caseolaris, che alla fine dell'Ottocento venne riclassificata come Sonneratia caseolaris: una vera beffa se si pensa che Sonnerat era nipote di Poivre, nonché il principale artefice dell'introduzione delle spezie all'Isle de France. Nel frattempo altri generi Aubletia erano stati creati in successione da Schreber, Loureiro e Persoon, tutti ugualmente illegittimi perché bloccati dalla denominazione di Gaertner. Né miglior sorte arrise a Aubletella Pierre, sinonimo di Chrysophyllum. Insomma, per un buon secolo il nostro eroico viaggiatore è stato un botanico senza Nobel, come chiamo i grandi botanici privi del riconoscimento di un genere valido. A riparare l'ennesima ingiustizia ha provveduto nel 2000 il botanico colombiano José Carmelo Murillo Aldana, con la dedica di Aubletiana (Euphorbiaceae), da lui istituito separando da Conceveiba, uno dei generi creati da Aublet, le due specie africane, di conseguenza rinominate A. lepstostachys e A. macrostachys. Anche se egli non lo dice esplicitamente, certo in tal modo l'autore, uno specialista della flora dell'Amazzonia colombiana, avrà anche voluto rendere omaggio a uno dei padri fondatori della botanica neotropicale. Le due specie, sulle quali non si trovano molte notizie, si differenziano da Conceveiba per essere monoiche anziché dioiche, non secernono latice e hanno semi elissoidali senza arillo. Sono alberi dello strato più basso della foresta tropicale del Gabon e del Cameron. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed