|
Talvolta i nomi botanici di piante diversissime sono così simili che si tende a confonderli. È il caso di Hottonia e Houttuynia, tanto più che la prima è una pianta acquatica e la seconda non disdegna i terreni intrisi d'acqua. La confusione è anche maggiore se guardiamo ai dedicatari: Hottonia ricorda Petrus Hotton o Hottonus, noto anche come Pieter Houttuyn, mentre Houttuynia è dedicata a Martinus Houttuyn. Entrambi olandesi, sono vissuti a circa un secolo di distanza e, a quanto risulta, non hanno alcuna parentela. In ordine di apparizione, iniziamo dunque con Petrus Hotton e la sua Hottonia.  Un botanico illustre, ma quasi dimenticato In un passo della prolusione con la quale inaugurava il corso di botanica all'università di Leida, il medico, botanico e professore universitario Petrus Hotton (1648-1709), a proposito dell'antico rizotomo Crateva, lamenta che "il tempo vorace ci invidia gli scritti degli uomini più celebri", tanto che di quell'uomo citato con elogio dai maggiori scittori antichi non rimane neppure un frammento. A Crateva Hotton doveva essere affezionato, visto che ne prese il nome quando fu eletto all'Accademia leopoldina, e, a posteriori, possiamo dire che quelle parole calzano perfettamente anche a lui. Celebre al suo tempo, anch'egli è oggi quasi dimenticato, anche se ce n'è giunta almeno qualche riga. Era figlio di Godefroy Hotton, un predicatore ugonotto di origine francese o vallona, e di sua moglie Anna Maria Ros. Non conosciamo il luogo di nascita di Hotton padre; il cognome ci riporta o alla Francia del Nord o alla Vallonia. Sappiamo invece che studiò a Heidelberg, quindi fu successivamente predicatore a Frankenthal, Aquisgrana e Brema; quando il Limburgo fu riconquistato dai Paesi Bassi, fu nominato predicatore prima delle comunità rurali poi della città di Limburgo. Intorno al 1634 si trasferì ad Amsterdam, dove divenne pastore della comunità vallona, i cui sinodi presiedette più volte. Ha lasciato una raccolta di omelie, tradotte in francese, e l'interessante De Christiana inter Europaeos Evangelicos concordia, in cui propugna la necessità di superare i contrasti tra le diverse confessioni riformate. Alla nascita del figlio Pieter (forse in famiglia sarà stato chiamato Pierre) aveva già superato la cinquantina, e il bimbo rimase orfano di padre ad appena otto anni. Della sua educazione si sarà occupata la madre, o anche la comunità vallona. In ogni caso nel 1665, a diciassette anni, lo troviamo immatricolato alla facoltà di medicina di Leida, dove nel 1672 divenne dottore in medicina con la tesi Positiones quaedam medicae. Tornò quindi ad Amsterdam dove lavorò come medico; trascorso anche qualche tempo in Danimarca, in viaggio di studio. Allievo di Arnold Syen, che probabilmente lo avviò all'uso del microscopio e orientò il suo interesse per le piante esotiche, era profondamente interessato alla botanica. Dopo la morte del maestro, fu chiamato per breve tempo (1678-1680) a insegnare botanica e dirigere l'orto botanico di Leida come supplente di Paul Hermann, che al momento si trovava ancora a Ceylon. Ritornò poi al suo lavoro medico ad Amsterdam e per qualche tempo non sappiamo nulla della sua attività come botanico. Intorno al 1684 gli fu offerta la cattedra di botanica a Groninga che rifiutò. Nel 1692 il consiglio cittadino di Amsterdam lo nominò assistente di Frederik Ruysch, che affiancava nelle lezioni di botanica farmaceutica presso l'Hortus della città (l'altro assistente era Caspar Commelin, che si occupava delle piante esotiche), con il titolo di Horti Medici botanicus. Mantenne l'incarico fino al 1696, quando, in seguito alla morte di Paul Hermann, fu nominato professore di botanica e direttore dell'orto botanico di Leida, incarico che resse fino alla morte nel 1709. Questa la sua carriera accademica. Era stimato dai suoi contemporanei, frequentava i circoli eruditi olandesi, aveva una vasta rete di corrispondenti (tra gli altri, Anton van Leeuwenhoek, John Ray, Joseph Pitton de Tournefort e gli italiani Giorgio Baglivi, Michelangelo Tilli e Giovan Battistia Trionfetti) e fu membro della Royal Society e dell'Accademia curiosorum leopoldina, nonché socio corrispondente dell'Academia delle scienze parigina. Eppure scrisse pochissimo. A parte la tesi di laurea e qualche lettera, di lui ci rimane come maggiore opera certa proprio la già citata prolusione, pronunciata il 9 maggio 1695 al momento di assumere la cattedra di botanica a Leida. Intitolata Sermo accademicus quo rei Herbariae historia et fata adumbrantur, nella prima parte è una sintetica storia della botanica, dagli antichi fino ai contemporanei che dimostra di conoscere bene, nella seconda un elogio della botanica e delle sue "magnifiche sorti e progressive". È datato marzo 1701 il suo unico contributo alle "Transactions della Royal society", De acemella et ejus facultate lithontriptica, sotto forma di lettera in cui presenta una pianta i cui semi era giunti da Ceylon all'orto botanico di Amsterdam nel 1691 (oggi Acmella paniculata, un'annuale con proprietà mediche e insetticide). Hotton conosceva bene e ammirava l'opera di Rumphius e del suo predecessore Hermann ed era entusiasta dalle prospettive mediche, farmaceutiche, economiche delle piante esotiche che sempre più copiose giungevano dai quattro angoli del mondo agli orti botanici di Leida e Amsterdam, e scambiava volentieri i loro semi con i suoi corrispondenti. Coltivava però anche interessi teorici e tassonomici e tra tutti i botanici contemporanei ammirava in massimo grado John Ray, di cui curò l'edizione olandese di Methodus plantarum emendata et aucta, rifiutata dagli editori britannici. L'interesse per la tassonomia è confermato da Hermann Boerhaave, suo allievo e successore, che ne traccia un commosso elogio nella breve storia dell'orto botanico di Leida inclusa nella sua seconda edizione del catalogo del giardino (Index alter plantarum quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, 1719). Secondo la sua testimonianza, Hotton avrebbe elaborato un proprio metodo (che egli definisce "Syntaxis herbaria perfectissima") che, pur movendo dalla lezione di Pitton de Tornefort, la integrava con una profonda conoscenza della letteratura botanica. Uomo prudente e metodico, secondo Boerhaave Hotton si muoveva con lentezza, tutto esaminando e considerando, senza fermarsi alla prima impressione. Con tanta lentezza che, ucciso a soli sessant'anni dal freddissimo inverno del 1709, non poté né completare né pubblicare il proprio metodo "con sommo detrimento della botanica". Qualche mese dopo la sua morte la sua vasta biblioteca fu messa all'asta. Contava più di 4000 volumi; oltre metà era costituita da testi di medicina ed anatomia, ma erano ricchissime anche le sezioni di scienze naturali e botanica, dove non sembra mancare nessuna opera significativa; la presenza di opere costosissime come Hortus eystettensis o i tredici volumi di Hortus malabaricus attesta poi una notevole disponibilità economica. Ma la biblioteca di Hotton non si limitava a quella che potremmo considerare letteratura professionale; troviamo infatti copiose sezioni di filosofia (ma all'epoca sotto questa etichetta finivano anche la fisica, l'astronomia, la matematica e la chimica), teologia, diritto, lessicografia, poesia e storia, che ci parlano di un uomo colto e di vasti e variegati interessi. Nonché poliglotta (sempre che quei libri li abbia letti davvero): la maggior parte delle opere è ovviamente scritta in latino (all'epoca ancora la lingua universale della scienza e della cultura), ma, tra le lingue moderne, oltre all'olandese e al francese (che, viste le origini familiari, forse era la sua lingua madre) non mancano testi in italiano (compresa la Gerusalemme liberata di Tasso e le opere complete di Machiavelli), inglese e tedesco. Quasi trent'anni dopo la morte di Hotton, proprio in Germania e in lingua tedesca uscì un'opera postuma attribuita al botanico olandese. Al piede del frontespizio di Thesaurus phytologicus, pubblicato a Norimberga nel 1738, leggiamo infatti: "di Petrus Hotton, dottore in medicina e prefetto dell'orto botanico dell'Università di Leida". Come chiarisce il chilometrico sottotitolo, è un Kräuterbuch, un erbario farmaceutico, che offre ai lettori la descrizione dettagliata e le "strane qualità, virtù ed eccellenti capacità" delle erbe medicinali provenienti dalle quattro parti del mondo, ma specialmente dall'Europa, con il modo più sicuro di usarle, rivolgendosi non solo a medici e farmacisti, ma anche a guaritori, giardinieri, padri di famiglia, casalinghe e "quei malati che vivono in campagna". Insomma, quanto di più divulgativo possibile, e anche quanto di più lontano dall'immagine di Hotton prudente, lento e metodico autore di una perfettissima Synthaxis herbaria presentatoci da Boerhaave. Più che a Ray o Tournefort e agli altri tassonomisti ammirati da Hotton, l'opera sembra guardare alla tradizione rinascimentale, se non medievale, dei Kräuterbücher, anche se rinnovata con l'inserimento di qualche esotica, come il tabacco e il caffé, con le piante elencate in ordine alfabetico e l'unica divisione in erbacee (prima parte) e arboree o arbustive (seconda parte). Che l'abbia scritta davvero Hotton non è affatto certo; come ipotizza Wijnands, egli potrebbe essere il responsabile dei soli indici, latino e tedesco; in tal caso, il suo nome in copertina è una semplice operazione pubblicitaria dei disinvolti editori-stampatori Johan Leonhard Buggel e Johann Seitz.  Piante acquatiche in pericolo Il nostro è talvolta noto con il nome olandesizzato Pieter Houttuyn, ma si firmò sempre Petrus Hotton o alla latina Hottonus. E come tale Boerhaave gli rese omaggio con la dedica del genere Hottonia, accompagnata da parole commosse: "È giusto affidare con animo pio la memoria, a me sacra, dell'uomo illustre Petrus Hotton, mio predecessore, a tutti coloro che amano e coltivano la sapienza, la virtù e la botanica. Fu infatti egli stesso quanto mai illustre in tutte queste cose. Sottratto ai loro occhi, possano i Mani percepire che sopravvive il grato ricordo di un uomo buono ed insigne". Il genere fu recepito da Linneo fin da Hortus Cliffortianus e poi ufficializzato in Species plantarum. Questo piccolo genere della famiglia Primulaceae comprende solo due specie di piante acquatiche: l'europea ed asiatica H. palustris e la nord americana H. inflata. Chiamata volgarmente violetta d'acqua per i fiori bianchi sfumati di lilla, H. palustris è l'unica primulacea completamente acquatica della nostra flora. Cresce principalmente sommersa, con fusti verde pallido che immettono ad intervalli regolari lunghe radici bianco-argentee che fluttuano nell'acqua e si radicano nel fango del fondo. Le foglie lineari, anch'esse sommerse, si dispongono a pettine su verticilli molto ravvicinati; tra maggio e giugno, emerge dall'acqua lo scapo florale eretto, alto da 20 a 40 cm, che reca un'infiorescenza con verticilli sovrapposti di 3-9 fiori; piuttosto grandi e vistosi, hanno corolle con breve tubo e cinque lobi fusi alla base, da bianche a lilla, con una macchia gialla alla fauce. È presente prevalentemente nell'Europa centrale e settentrionale e ai margini dell'area mediterranea, con colonie disgiunte in Siberia. Vive in acque stagnanti, poco profonde e povere di sostanze nutritive; ovunque è minacciata dalla riduzione dell'habitat naturale, dal drenaggio e dall'eutrofizzazione delle acque. Altro fattore negativo è la distanza tra le diverse colonie, che spesso sono formate da cloni della medesima pianta; in assenza di impollinazione incrociata, garantita da bombi, api o sirfidi, H. palustris può autofecondarsi, ma tende a produrre pochi semi. In Italia è rara e presente occasionalmente nelle regioni centro-settentrionali; è inclusa nella liste delle piante a protezione assoluta delle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. È in corso un progetto di reintroduzione in alcune aree piemontesi promosso da A.Di.P.A. Piemonte, che al momento incontra difficoltà per i danni provocati dalle nutrie o castorini. H. palustris è talvolta coltivata come pianta da acquario. Per quest'uso è più frequente la specie americana H. inflata, che sopporta temperature più elevate, essendo originaria degli Stati Uniti sudorientali. Ha fiori minuscoli portati al sommo di una rachide rigonfia, da cui l'epiteto; a differenza della specie europea, che come abbiamo visto è può essere impollinata da vari insetti, è probilmente esclusivamente autogama, con conseguente impoverimento della varietà genetica. Anch'essa è fortemente minacciata dalla distruzione di gran parte dei suoi habitat storici. Si spera tuttavia che, con la reintroduzione dei castori negli Stati uniti orientali, possa esserci una ripresa anche per H. inflata che trova il suo habitat di elezione negli stagni di castori, caratterizzati da acque poco profonde con un livello di acqua costante. Si ritiene anche che i castori, raccogliendo per loro tane il fango di fondo che ne contiene i semi, ne facilitino la dispersione.
0 Comments
I primi orti botanici tedeschi nascono sul modello di Padova a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Tra i massimi protagonisti della loro nascita, il medico e botanico Ludwig Jungermann, che disegnò e curò successivamente l'orto botanico di Gießen, il primo ad occupare ancora parzialmente la sede originale, e quello di Altdorf, celebre per la bellezza e la ricchezza di piante rare. Jungermann fu anche il primo in Germania a scrivere flore locali e a tenere ufficialmente una cattedra di anatomia e botanica. Nella sua prassi didattica, poterono così integrarsi le lezioni teoriche, la dimostrazione delle piante nell'orto botanico e le escursioni nel territorio. È ricordato dal genere di epatiche Jungermannia, dalla storia tassonimica alquanto travagliata.  Flore locali ed orti botanici Tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in Germania vennero fondati diversi orti botanici universitari che si rifacevano direttamente al modello di Padova. Il primo fu quello di Lipsia, nato nel 1580 forse dalla trasformazione di un precedente giardino monastico, seguito nel 1586 da quello di Jena e nel 1593 da quello di Heidelberg. Travolti dalla guerra dei Trent'anni, nessuno di questi giardini è sopravvissuto. Il primo a trovarsi ancora almeno in parte nella collocazione originale - anche se assai ingrandito e con un aspetto totalmente mutato - è quello di Gießen, la cui fondazione ufficiale risale al 1609. L'università di Gießen (oggi Justus-Liebig-Universität Gießen) era recentissima; nel 1605 alcuni professori luterani del vicino ateneo di Marburg, da poco passato al calvinismo, si spostarono a Gießen dove, auspice il langravio Ludovico V di Assia-Darmstadt, fondarono l'Illustre et principale Gymansium Giessense che nel 1607, ottenuto il brevetto imperiale, si trasformò appunto in università. Come ateneo luterano, il suo scopo principale era formare pastori e funzionari, ma fin dall'inizio ci fu una facoltà di medicina che appunto nel 1609 fu dotata di un hortus medicus, grazie ancora al langravio che a tal fine aveva donato all'università un piccolo giardino di piacere situato presso la torre del castello. A presiederlo e di fatto a crearlo fu chiamato, con un salario di 50 talleri, il candidatus, ovvero dottorando in medicina, Ludwig Jungermann (1572-1653); allievo dell'anatomista Gregor Horstius, egli fu uno dei primi laureati in medicina della facoltà, ottenendo la licenza "summos honores in arte medica" con la tesi Assertiones medicae de catarrho nel dicembre 1610 e il dottorato nell'aprile 1611, con una tesi in cui si esaminava l'efficacia dei decotti di lattuga e ruta per curare l'"amore insano". Jungermann veniva da una famiglia doppiamente illustre. Il padre Caspar Jungermann fu professore di diritto e per ben sette volte rettore dell'università di Lipsia; la madre Ursula Camerarius era figlia dell'illustre umanista e collaboratore di Melantone Joachim Camerarius il Vecchio e sorella del medico e botanico Joachim Camerarius il Giovane. Mentre il padre avrebbe voluto avviarlo a studi giuridici, Ludwig scelse la medicina e la botanica, seguendo l'esempio dello zio materno nonché del compianto fratello maggiore Joachim. Joachim Camerarius (1531-1561) era stato un giovane estremamente brillante; dotato disegnatore, è il più accreditato autore del Camerarius florilegium, lo spettacolare erbario figurato fatto eseguire dallo zio, che lo considerava il suo erede scientifico, ancora più del figlio Joachim Camerarius III. Nel 1588 venne a studiare in Italia e si fece conoscere nell'ambiente dei naturalisti della penisola con il nome italianizzato Gioacchino Giovenio. Visitò Napoli dove fu tra i pochi a vedere il manoscritto di Hernández portato in Italia da Nardo Antonio Recchi e riuscì anche a copiare "con destrezza" alcune figure. Oltre che con lo zio (ci rimane un espistolario di oltre 100 lettere), corrispondeva con altri botanici tra cui Clusius cui inviò numerosi esemplari. Mentre studiava a Padova, fece diverse escursioni botaniche; tra l'altro fu in Tirolo con un altro corrispondente di Clusius, Tobias Roels. Nel 1590 Casabona lo inviò ad accompagnarlo a Creta, ma Jungermann rifiutò. L'anno successivo tuttavia si imbarcò a sua volta per Costantinopoli con quattro connazionali; durante il viaggio, a bordo scoppiò un'epidemia che gli fu fatale. Ludwig, più giovane di lui di undici anni, al momento della sua morte aveva diciannove anni ed era deciso a seguirne le orme. Tuttavia, forse memore della sua sorte, non si allontanò mai dalla Germania e divenne uno specialista della flora locale. Iniziò gli studi accademici a Lipsia, dove iniziò a creare un erbario e a scrivere una flora sulle piante del territorio; terminato entro il 1600 ma rimasto manoscritto (oggi è conservato presso l'università di Erlangen), il suo Viridarium lipsiense spontaneum è considerata la più antica flora locale e cittadina in terra tedesca; elenca e descrive in ordine alfabetico circa 800 piante spontanee di Lipsia e dei suoi dintorni. Jungermann proseguì quindi gli studi a Jena e ad Altdorf, una cittadina universitaria a circa 25 km da Norimberga, dal cui consiglio cittadino dipendeva. Qui strinse amicizia con il coetaneo Caspar Hoffmann (1572-1648), che prima di iscriversi ad Altdorf aveva frequentato le università di Strasburgo, Padova e Basilea, dove era stato allievo di Felix Platter e Caspar Bauhin. Né ad Altdorf né in altre università tedesche esisteva ancora una cattedra formale di botanica; fu dunque al di fuori del curriculum ufficiale che i due amici incominciarono ad esplorare la flora dei dintorni; come aveva fatto a Lipsia, Jungermann trasse da queste ricerche un catalogo che, nel partire per Gießen, affidò a Hoffmann per la pubblicazione. Prima che ciò avvenisse, tuttavia, passarono alcuni anni pieni di impegni per entrambi. Hoffmann era rimasto ad Altdorf e aveva assunto la cattedra di medicina teorica, mentre Jungermann era fortemente impegnato nella direzione dell'orto botanico di Gießen, cui nel 1614 si aggiunse la cattedra di anatomia e botanica, la prima ufficiale in terra tedesca. Inoltre, intorno al 1612 gli fu affidata la redazione dei testi di Hortus Eystettensis, grazie presumibilmente sia alla sua crescente fama come esperto di piante, sia alla relazione familiare con Camerarius, il cui giardino aveva fatto da modello a quello di Eichstätt. Constatando, come professore di medicina, quanto carenti fossero le conoscenze botaniche dei futuri medici, Hoffmann si ricordò di quel vecchio catalogo; gli era evidente che Jungermann non avrebbe potuto occuparsene perché "due lavori allo stesso tempo sono già sufficienti". Con il suo accordo, si decise a "mettere mano nella messe altri". Il risultato fu Catalogus plantarum circa Altorfium Noricum et vicinis quibusdam locis, pubblicato ad Altdorf nel 1615. Nel frontespizio, Jungermann figura come autore, mentre Hoffmann come revisore. Nella lettera dedicatoria al senatore di Norimberga Georg Christoph Volckamer, firmata da Hoffmann, questi sintetizza la genesi e gli scopi dell'opera, ribadisce che il materiale risale a Jungermann, ma che il lavoro redazionale è stato in gran parte svolto da lui. Il catalogo vero e proprio, in ordine alfabetico, è costituito da un elenco di nomi di piante in latino, essenzialmente basato su Phytopinax di Caspar Bauhin; seguono i sinonimi di altri autori (tra più citati Lobel e Dodoens), spesso il nome tedesco e quasi sempre l'indicazione dell'habitat: generica come nei boschi, in luoghi sabbiosi, in luoghi umidi, ecc; o più specifica come "nella Pfaffenthal", "presso la fortezza di Hollenstein". Le piante segnalate come nuove sono sei in tutto, ad esempio Chamaedrys fruticosa nostra, Pseudocamaedrys elatior Jungermannii, di cui si dà una breve diagnosi con le differenze rispetto a specie affini. Possono essere nuove però anche altre specie non segnalate come tali ma non seguite da referenze bibliografiche. Tra di esse parecchi muschi. Jungermann lavorò e insegnò a Gießen fino al 1625, pubblicando ancora due flore locali: Cornucopiae Florae Giessensis e Catalogus herbarum circa Giessam, pubblicate nel 1623 ed entrambe oggi perdute. Nel 1625, nell'ambito della guerra dei Trent'anni, il langravio occupò Marburg e decise di traferire in quella sede storica l'università, chiudendo quella di Gießen. Anche l'orto botanico fu abbandonato. Su invito di Hoffmann, Jungermann preferì trasferirsi a Altdorf; portò con sè quanto poteva delle piante del giardino di Gießen, con le quali creò un hortus medicus privato, Con il sostegno di Hoffmann, riuscì a convincere il consiglio cittadino di Norimberga a finanziare la sua trasformazione in orto botanico universitario (tre anni prima l'accademia di Altdorf si era ufficialmente trasformata in università). Il giardino, noto come Hortus medicus altdorfinus o Doktorgarten, si trovava al di fuori delle mura cittadine, a sud-ovest dell'edificio universitario; a pianta quadrata, era circondato da un muro di arenaria e misurava inizialmente 3000 m2. I due viali principali, incociandosi al centro, occupato da un padiglione, lo dividevano in quattro quadranti di uguali a dimensioni; i due posti a nord, che confinavano con gli edifici universitari, avevano funzione ornamentale, con ramages di gusto barocco disegnati da basse siepi di bosso; le erbe medicinali erano coltivate in quelli a sud, che avevano anche funzione di orto e vivaio. Il giardino cercava dunque di conciliare la funzione didattica con le esigenze estetiche di un giardino di piacere. Nel progetto di Jungermann confluiva un variegato bagaglio di esperienze: il ricordo del giardino di suo zio Camerarius a Norimberga, le suggestioni del giardino vescovile di Eichstätt, il modello degli orti botanici italiani e la sua stessa esperienza come prefetto dell'orto botanico di Gießen. Anche se erano gli anni difficili della guerra dei Trent'anni, nell'arco di pochi anni egli riuscì a creare un giardino rinomato per la sua bellezza e la ricchezza di piante esotiche e rare; alcune le portò con sè da Giessen, altre le ottenne da Eichstätt e da giardini monastici, altre ancora dai suoi numerosi corrispondenti. Molti sono citati nella breve prefazione del catalogo del giardino, Catalogus plantarum, quae in horto medico et agro Altdorphino reperiuntur, pubblicato da Jungermann nel 1635. Sono soprattutto tedeschi, medici o generosi proprietari di giardini privati (tra i pochi nomi che oggi ci dicono ancora qualcosa Gillenius, ovvero Arnold Gille, medico di Cassel, e Wilhelm Ernst Scheffer, medico di Francoforte), ma ci sono anche il prefetto di Leida Adolphus Vortius e Giovanni Pona, "farmacista veronese celeberrimo". Fino fine dei suoi giorni (morì ottantenne nel 1653), Jungermann visse ad Altdorf, come praefectus dell'orto botanico e professore di anatomia e botanica; fu anche più volte rettore. Faceva regolarmente lezione nel giardino e accompagnava i suoi studenti in escursioni botaniche. I contemporanei lo consideravano un "botanico non secondo a nessuno"; rifiutò ripetutamente nomine onorevoli, compresa quella di successore di Mathias Lobel come botanico del re d'Inghilterra. Era un uomo simpatico e affabile, versato anche nella poesia latina. Non si sposò mai; secondo un aneddoto, agli amici che lo esortavano a prendere moglie, rispondeva che lo avrebbe fatto quando qualcuno gli avesse portato una pianta che non conosceva. Alla sua morte lasciò in eredità alla biblioteca di Altdorf il suo notevole erbario di 2000 campioni. Due parole sulle vicende successive dell'orto botanico di Altdorf. Poco dopo la morte di Jungermann, fu ampliato, portando la superficie a 4500 m2 e dotato di un hibernaculum, ovvero una limonaia, che poteva essere riscaldata da due stufe. Fino alla fine del Settecento, fu tra i più ricchi e reputati della Germania. Il suo ultimo catalogo, redatto nel 1790 dal prefetto e professore di botanica Benedict Christian Vogel, che esclude le piante "indigene e volgari", registra 2500 piante esotiche. Una di esse era un'Agave americana che fiorì e fruttificò nel 1798. Dopo il congresso di Vienna, Norimberga, fin ad allora città libera, fu annessa al Regno di Baviera. L'università di Altdorf venne sciolta e il giardino smantellato. Poche piante, tra cui una cicadacea e un grande albero di canfora, furono trasferite nell'orto botanico dell'Università di Erlangen, mentre il grosso andò ad arricchire le aiuole e le serre del recentemente fondato orto botanico di Monaco di Baviera.  Un genere con una storia travagliata Come ho anticipato, invece il giardino di Gießen esiste ancora. Dopo la pace di Westfalia, nel 1650, l'università di Gießen fu ripristinata e anche il suo orto botanico tornò a rivivere. All'inizio del Settecento, vi studiò Heinrich Bernhardt Ruppius, che era nativo proprio di quella città. Come Jungermann un secolo prima, studiava la flora locale e nella sua Flora jenensis (1718) si ricordò del suo predecessore dedicandogli il genere Jungermannia, poi convalidato da Linneo in Species plantarum. Si trattava del primo genere di epatiche fogliose ad essere descritto; ha dato il nome alla famiglia Jungermanniaceae e all'ordine Jungermanniales. Inizialmente incluse tutte le epatiche fogliose, poi nel corso dell'Ottocento, in base a specifiche caratteristiche degli organi riproduttivi, ne vennero via via separati numerosi generi. Nella seconda metà del Novecento prevalse invece l'idea di raggrupparli nuovamente in un vastissimo Jungermannia, che comprendeva tra 120 e 200 specie, distribuite in tutto il mondo, in ogni ambiente, eccetto i deserti, le savane e le foreste pluviali tropicali. A cavallo tra la fine del Novecento e gli anni Duemila, gli studi molecolari filogenetici hanno drasticamente mutato questo quadro, dimostrando che Jungermannia inteso in senso largo era un gruppo artificiale che raggruppava specie poco correlate tra loro. A Jungermannia in senso stretto, diviso da Liochlaena e Solenostoma sulla base di caratteristiche come la forma del perianzio e l'assenza di periginio, sono al momento attuale attribuite 9-10 specie prevalentemente distribuite nelle zone temperate dell'emisfero boreale. Una delle più diffuse è J. atrovirens, presente anche nella nostra flora; caratterizzata dal colore verde scuro che le dà il nome, è una specie alquanto variabile che cresce in una varietà di situazioni su suolo calcareo, in luoghi umidi o anche come acquatica in laghi e torrenti; dioica, ha foglie ovoidali concave che avvolgono gli steli da eretti a prostrati e può formare densi tappeti erbosi. Fresco di laurea, il medico di Basilea Werner de Lachenal si affrettò ad inviare la sua tesi ad Albrecht von Haller. Per anni, mentre lavorava come medico e farmacista, ne fu uno dei più assidui corrispondenti, informatori e raccoglitori, divenendo un reputato esperto della flora di Basilea e del Giura. Solo dopo diversi anni ottenne la cattedra di anatomia e botanica presso l'Università di Basilea, illustrandosi con due benemerenze: fece rinascere l'orto botanico universitario, pagando in gran parte di tasca propria, e salvò quanto rimaneva dell'erbario di Caspar Bauhin, oggi perla dell'erbario di Basilea. A ricordarlo il bellissimo genere di bulbose sudafricane Lachenalia, che meriterebbe di essere coltivato più spesso. 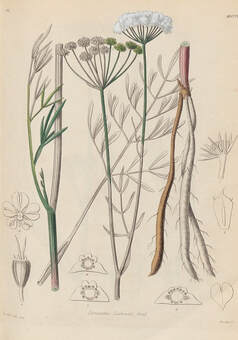 Una lunga collaborazione con von Haller Come abbiamo visto in questo post, per ottenere gli esemplari e le informazioni necessari alle due edizioni della sua monumentale flora della Svizzera, Albrecht von Haller si servì, oltre della raccolta diretta, di una vasta rete di informatori, corrispondenti, raccoglitori. Ciò divenne tanto più indispensabile quando l'età, la gotta e la corpulenza lo costrinsero a delegare ad altri il grosso del lavoro di raccolta. I candidati ideali erano giovani medici o studenti di medicina, di cui nel suo saggio Making Natural History: Doing the Enlightenment, Bettina Dietz ha tracciato un identikit: "essere fisicamente abbastanza robusti da far fronte alle fatiche di escursioni in montagna protratte per diverse settimane; avere una buona conoscenza della botanica; avere scarse pretese per i pagamenti, che Haller sborsava di tasca propria; seguire le sue istruzioni su cosa cercare; consegnare ad Haller il bottino delle loro escursioni botaniche in ottimo stato". Quando entrò in contatto con von Haller, il neo-medico di Basilea Werner de Lachenal (1736-1800), che fu uno dei principali raccoglitori-informatori per Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, apparve subito riunire tutti in requisiti. Figlio di un farmacista, fu egli stesso avviato alla farmacia, per poi iscriversi all'università di Basilea; nel 1755 ottenne il titolo di magister di filosofia e nel 1759 la licenza per esercitare la medicina con una tesi (Specimen Inaugurale Observationum Botanicarum) dedicata ad alcune piante poco note o mal determinate della flora locale. Si affrettò a mandarne copia a von Haller che ne fu piacevolmente colpito, gli rispose con una lettera di elogi e gli chiese di inviargli campioni di alcune di quelle specie rare. La corrispondenza proseguì mentre il giovane medico completava la sua formazione all'università di Strasburgo e il tirocinio pratico a Montbéliard con il medico di corte del Württemberg David Charles Emmanuel Berdot. Avendo ormai verificato la sua preparazione e la sua affidabilità, Haller gli propose una prima escursione botanica per suo conto e a sue spese, che nell'estate del 1760 portò Lachenal nel Vallese e nelle Alpi Graie fino al Piccolo San Bernardo. L'estate successiva, insieme a un altro giovane medico, Jean Jacques Châtelain (1736-1822), lo inviò fino a Mendrisio in Canton Ticino. un'area che riteneva quasi inesplorata. Anche se Lachenal fu piuttosto deluso della flora della meta designata, molto meno ricca di quanto pensasse, durante il viaggio fece molte raccolte e ne informò puntualmente von Haller, così soddisfatto del lavoro dei due botanici da elogiarli con insolito calore: "Non potevo sperare di riunire in un medesimo viaggio due compagni di uguale ardore. E' impossibile che l'uno superi l'altro per perizia e per passione". L'anno dopo avrebbe ancora voluto inviare Lachenal in Valtellina e in Engadina, ma questa terza spedizione non avvenne mai. Per il medico di Basilea era infatti ora di pensare a una sistemazione stabile. Haller aveva sì cercato di usare tutta la sua influenza per fargli assegnare una cattedra a Gottinga, ed egli era stato incluso nella terna dei nomi selezionabili, ma non si era andati oltre. Nel 1763 Lachenal conseguì il dottorato in medicina, quindi rilevò la licenza decennale per una farmacia. Con gli impegni professionali come medico e farmacista, i lunghi viaggi erano fuori discussione; continuò invece ad esplorare la flora dei dintorni e quella del vicino Giura borgognone e a soddisfare con sollecitudine le richieste di Haller, che non di rado gli chiedeva di procurargli questa o quella pianta. Raccoglieva anche per sè, in vista di una flora della regione di Basilea. La relazione tra Lachenal e Haller non era ovviamente paritaria, ma tipicamente quella tra discepolo e maestro; una volta il bernese giunse persino a rimproverare il suo giovane corrispondente per aver usato il nome linneano per designare Trifolium fragiferum; al che Lachenal ritenne necessario giustificarsi, spiegando che aveva usato quel nome perché al momento non ne aveva a disposizione nessun altro La corrispondenza tra i due botanici svizzeri durò 18 anni (dal 21 aprile 1759 al 31 giugno 1774). Durante questo lungo periodo, che lo vide trasformarsi da giovanissimo neolaureato in affermato medico di mezza età e riconosciuto esperto della flora locale, oltre che con moltissimi invii di campioni di erbario, Lachenal si rese utile al suo maestro come correttore delle bozze dei supplementi alla flora elvetica (Emendationes et auctaria ad stirpium Helveticarum historiam), pubblicati presso un tipografo di Basilea; compito difficilissimo e ingrato, vista l'impazienza di Haller e la sua grafia sempre più illegibile.  La rinascita dell'orto botanico La grande svolta nella vita di Lachenal, forse inattesa persino per lui, avvenne nel 1776, quando per sorteggio gli fu infine assegnata la cattedra di anatomia e botanica all'università di Basilea. Era una cattedra prestigiosa con una lunga storia: quella di anatomia era stata creata addirittura nel 1571 da Felix Platter, grande anatomista e allievo di Rondelet a Montpellier, a sua volta maestro di Caspar Bauhin che nel 1589 fondò l'orto botanico universitario, uno dei più antichi d'Europa e il fu il primo titolare della cattedra di anatomia e botanica. Quando Lachenal assunse la cattedra, erano glorie del passato. Il suo predecessore Johann Rudolf Stähelin (titolare della cattedra di anatomia e botanica dal 1753, dal 1776 passò alla cattedra di medicina teorica) all'insegnamento preferiva l'esercizio della professione e i segni della trascuratezza si facevano sentire. Da un sopralluogo di quello stesso anno il teatro anatomico risultò "così fatiscente che rischiava di crollare da un momento all’altro”. Lachenal suggerì addirittura di demolirlo e trasferirlo nell'orto botanico; il consiglio cittadino preferì ristrutturarlo, rendendolo più ampio e luminoso. Né migliore era la sitazione dell'orto botanico; c'era un solo giardiniere, che, salvo qualche piccola regalia occasionale, non riceveva alcun salario; di fatto, gli era stato permesso di trasformare l'orto botanico in orto, frutteto e vigna, dalla vendita dei cui prodotti ricavava il suo unico reddito. Nel 1754 il Comune fece costruire una modesta casetta, composta da un atrio, due stanze e alcuni locali laterali, che serviva sia da appartamento del professore sia da auditorium per le lezioni. Anch'essa era inadeguata. Lachenal chiese la ristrutturazione del giardino, condizioni migliori per il giardiniere, un appartamento dignitoso per il professore. Offrì di pagare un quarto delle spese e di cedere all'università la sua biblioteca; in cambio, chiedeva di mantenere la cattedra vita natural durante e il versamento di una pensione alla moglie, nel caso gli fosse sopravvissuta. Nell'agosto 1777 le condizioni furono accettate e i lavori procedettero abbastanza celermente. L'orto botanico poté disporre di un budget annuale e da quel momento rinacque. Venne anche costruita una serra che, a quanto pare, Lachenal pagò di tasca propria. Nel venticinquennio in cui insegnò all'università di Basilea, egli acquisì una solida reputazione internazionale, anche se non pubblicò quasi nulla. Corrispondeva con numerosi colleghi, con i quali scambiava esemplari d'erbario, scriveva articoli per qualche rivista, ma non riuscì mai a completare e pubblicare la sua flora di Basilea (Catalogus stirpium Basiliensis). Conosciamo la sua esistenza, oltre che dalla corrispondenza con von Haller, che più volte lo sollecitò a concluderla, da diverse testimonianze contemporanee, ma dopo la morte di Lachenal l'opera scomparve. Il manoscritto incompleto è stato riscoperto solo nel 1987 durante lavori di ristrutturazione dell'Istituto botanico di Basilea e rimane inedito. Presumibilmente, Lachenal lo aveva lasciato in eredità all'istituto botanico, insieme a tutti i suoi libri e al suo erbario, di enorme importanza storica perché egli vi aveva incluso l'erbario di Caspar Bauhin, che aveva acquistato da un discendente del grande botanico intorno al 1774. Contrariamente all'uso del tempo, l'erbario di Bauhin non era rilegato, ma costituito da fogli sciolti, che egli poteva così facilmente riorganizzare per i suoi lavori tassonomici. Ciò ne aveva però favorito anche la dispersione, perché nel corso dei decenni la famiglia Bauhin aveva permesso a diversi botanici di consultarlo e anche di attingervi; quando Lachenal lo acquistò, era ridotto a un terzo dell'originale. Nuovamente separato da quello di Lachenal, oggi costuisce una collezione separata dell'erbario di Basilea ed è preziosissimo, sia come testimonianza del lavoro di uno dei padri fondatori della botanica moderna, sia come uno dei pochissimi erbari rinascimentali giunti fino a noi, Quanto all'erbario personale di Lachenal, comprendeva circa 3000 specie, in prevalenza elvetiche, ma anche un certo numero di esotiche, ottenute da corrispondenti o orti botanici; è interessante notare che per etichettare le piante svizzere egli usò le denominazioni di von Haller, per tutte le altre quelle di Linneo.  Splendide bulbose sudafricane A ricordare Lachenal è oggi un busto nell'orto botanico di Basilea che ebbe il merito di far rinascere, l'eponimo di alcune piante più o meno rare che fu il primo a raccogliere o segnalare, come Hieracium lachenalii, Carex lachenalii, Festuca lachenalii e Oenanthe lachenalii, ma anche il bellissimo genere sudafricano Lachenalia, omaggio di Joseph Franz von Jacquin (il figlio di Nikolaus) che era uno dei suoi corrispondenti e gli fece visita quando passò dalla Svizzera durante il suo viaggio in Europa del 1788-91. In una lettera dell'ottobre 1790 al padre, lo ricorda con grande affetto e gli chiede di scrivergli per ringraziarlo delle tante cortesie che gli ha dimostrato. Ma a ben vedere lo aveva già ringraziato lui anticipatamente (la dedica risale al 1784) dedicandogli questo notevolissimo genere. Lachenalia (famiglia Asparagaceae) comprende circa 130 specie di bulbose perenni originarie della Namibia e del Sudafrica, distribuite in zone con piogge invernali; durante la stagione estiva, calda e arida, vanno in dormienza per poi entrare in vegetazione alle prime piogge autunnali; la fioritura, che è di relativamente lunga durata, avviene in inverno o all'inizio della primavera. Le foglie, che in alcune specie sono emesse prima dei fiori, in altre quasi contemporaneamente ad essi, sono basali e spesso graziosamente maculate, così come gli steli fiorali. I fiori campanulati, tubolari o cilindrici sono raccolti in spighe o racemi; a seconda delle specie, le corolle presentano una grande varietà di colori, dal bianco al rosa, dal lilla all'azzurro, dal giallo all'arancio e al rosso vivo. Il colore più raro e straordinario è il verde-turchese dei fiori di L. viridiflora. In varie specie, i fiori sono molti colori grazie agli apici più scuri. Le dimensioni dei bulbi e delle piante in fioritura sono molto varie, dai 5 cm di L. ensifolia e L. flava ai 40 di certe varietà di L. aloides. Lachenalia ha una lunga storia orticola, ma non è mai diventatomun genere popolare. La prima attestazione è un disegno dell'attuale L. hirta, risalente alla spedizione del Namaqualand del 1685-1686; da quel momento varie specie, sotto vari nomi, fecero qua e là la loro comparsa nel mercato dei bulbi e nelle raccolte dei collezionisti; il primo a studiare sistematicamente questo genere fu però verso la fine del Settecento von Jacquin padre, grazie alle raccolte sudafricane dei cacciatori di piante di Schönbrunn; come ho anticipato, il genere fu creato nel 1784 da suo figlio. Mano a mano che venivano scoperte nuove specie, con la loro grande varietà di dimensioni, forme e colori, attirarono l'attenzione degli ibridatori; il primo ibrido riconosciuto venne realizzato nel 1888 dal reverendo John G. Nelson, incrociando L. reflexa e L. aloides. A partire dal 1965, un vasto programma di ibridazioni è stato avviato dal Roodeplant Vegetable and Ornamental Plant Institute del Sudafrica; lo scopo era produrre, più che bulbi da giardino, fiori da taglio (i fiori di Lachenalia durano da due a quattro settimane) e piante fiorite in vaso per l'esportazione. I primi ibridi furono commercialmente disponibili nel 1997-1998, ma il programma fu rallentato da vari fattori, che vanno dall'isolamento politico del paese a causa dell'apartheid alle peculiarità del clima sudafricano che resero difficile adattare le condizioni di crescita di crescita all'emisfero nord. I primi ibridi (è la serie African Beauty) furono commercializzati alla fine del secolo, ma la risposta del mercato europeo fu minore di quanto sperato; il potenziale di queste splendide piante è ancora in gran parte da scoprire. Sono ancora soprattutto piante da collezionisti, piuttosto costose e non sempre facili da reperire. Anche in Olanda sono essenzialmente commercializzate da specialisti di bulbose rare; talvolta, come altre bulbose sudafricane, come Albuca o Ledebouria, sono offerte tra le succulente. Eppure sono bellissime e, a quanto pare, di non difficile coltivazione. Wilibald Besser e il giardino di Kremenc', ovvero come nacque, fiorì e fu distrutto un orto botanico10/11/2023 Fondato nel 1806, l'orto botanico del Liceo di Kremenec' fu il primo nel territorio dell'attuale Ucraina, e nell'arco di pochissimi anni si impose come uno dei più ricchi dell'intero impero russo. Merito dei suoi due creatori: il giardiniere paesaggista irlandese Denis McClair che lo progettò e il botanico austriaco Wilibald Besser che lo diresse per più di vent'anni e lo arricchì di migliaia di piante, native ed esotiche. Prima di arrivare a Kremenec', il giovane Besser aveva già all'attivo molte ricerche e un libro sulla flora della Galizia, e nei trent'anni che trascorse in Volinia e in Ucraina divenne uno dei maggiori esperti della flora delle regioni sudoccidentali dell'Impero russo. Il magnifico giardino che aveva fatto crescere con amore e sapienza durò meno di trent'anni e al povero Besser toccò l'ingrato compito di presiedere al suo smantellamento, atto di forza e di vendetta dell'imperialismo russo. A ricordarlo il bellissimo genere messicano Bessera.  Antefatto: un liceo prestigioso e un orto botanico Nel 1803, lo zar Alessandro I autorizzò la fondazione di un istituto scolastico desinato alla formazione dei giovani della parte sud-orientale dell'ex Confederazione polacco-lituana, passata sotto il dominio russo con la spartizione del 1795, e ne affidò la realizzazione al pedagogista Tadeusz Czacki, importante esponente dell'illuminismo polacco, membro della Commissione d'educazione nazionale all'epoca dell'indipendenza e ora direttore dei distretti scolastici dei governatorati di Volinia, Podolia e Kiev. Czacki individuò il luogo ideale in Kremenec' (Krzemieniec in polacco) nella regione storica della Volinia, che offriva il vantaggio di non essere lontana dalla frontiera con la Galizia austriaca, da cui sperava di attirare studenti di lingua madre polacca. La scuola fu sistemata negli edifici del precedente collegio gesuitico e in un palazzo della famiglia Wiśniowiecki; offriva corsi dalle elementari alle secondarie e ammetteva anche allievi ebrei. Inizialmente fu chiamata Ginnasio della Volinia, per poi diventare dal 1819 Liceo di Kremenec'; ma il suo prestigio era tale che per molti era semplicemente l'"Atene della Volinia". Impartiva un insegnamento laico e aperto in lingua polacca e polacchi erano tutti i suoi insegnanti, ad eccezione di uno che presto conosceremo. Sovvenzionata da molti donatori, che vedevano nel liceo di Kremenec' un modo per preservare almeno l'eredità culturale della nazione polacca, cancellata e divisa dalle spartizioni, avendo potuto incorporare le collezioni dell'ultimo re di Polonia Stanislao Poniatowski, la scuola vantava una biblioteca di quasi 35.000 volumi, era ben dotata di attrezzature e forniva un vasto programma educativo che comprendeva anche l'insegnamento della lingua inglese ed offriva agli studenti migliori la possibilità di perfezionarsi a Edimburgo o in altre università britanniche. Il particolare legame con il mondo anglosassone era visibile in un altro dei fiori all'occhiello del prestigioso istituto: l'orto botanico. Fondato nel 1806, fu disegnato dal giardiniere paesaggista irlandese Denis McClair (1762-1853) e posto sotto la direzione dal primo docente di botanica del liceo, il polacco Franciszek Scheldt, che in precedenza aveva diretto l'orto botanico di Cracovia. L'avventurosa storia dell'uomo che importò in Polonia e in Ucraina il giardino paesaggistico all'inglese merita una piccola digressione. McClair era figlio di un fittavolo che, avendo partecipato alla Rivolta dei Whiteboys del 1777, fu condannato a morte; per salvarsi, fuggì e si arruolò prima nell'esercito prussiano poi in quello polacco dove fece una discreta carriera, divenendo maggiore di artiglieria. Nonostante la situazione difficile, il giovane Denis studiò botanica e scienze naturali all'Università di Dublino, poi si trasferì a Londra dove incominciò a lavorare come giardiniere, lavorando anche per il duca di Bedford. Dopo altre avventure, nel 1790 incontrò la principessa Izabela Lubomirska, venuta appositamente nella capitale inglese per ingaggiare un abile giardiniere paesaggista. Anche nella speranza di ritrovare il padre, McClair accettò il suo invito di seguirla in Polonia e, anche se non incontrò mai il genitore (questi nel frattempo aveva approfittato di un'amnistia e era ritornato in Irlanda, dove sarebbe morto in un'altra rivolta, quella del 1798), incominciò ad essere sempre più apprezzato dai committenti polacchi. Creò vari giardini sia a Varsavia sia in altre località polacche. In Volinia arrivò nel 1792, quando il principe Lubomirski gli affidò la realizzazione del parco "Palestina" a Dubno; nonostante fossero gli anni difficili che portarono alla terza spartizione della Polonia e all'annessione sia di questa regione sia della Podolia da parte della Russa, i grandi proprietari polacchi conservarono le loro terre e McClair - che in Polonia era diventato Dionizy Mikler - continuò a lavorare per loro; nell'arco di oltre trent'anni progettò una cinquantina di parchi nelle terre dell'attuale Ucraina occidentale. Tra di essi appunto l'orto botanico del Liceo di Kremenec', il più antico dell'Ucraina. Nel 1805 McClair ricevette da Czacki l'incarico di progettarlo, nel 1806 il giardino fu inaugurato, ma fu completato solo nel 1809; si estendeva su 4.5 ettari, comprendeva un parco all'inglese, un roseto, tre arancere, serre e le vere e proprie aiuole didattiche, con piante medicinali; nei primi tre anni della sua esistenza (1806-1809) conteneva 760 specie esotiche e 460 specie di flora locale, raccolte da McClair. Lo sappiamo dal primo catalogo del giardino, Catalogue des plantes du Jardin botanique de Krzemieniec en Volhynie, pubblicato nel 1810 dal vero protagonista di questa storia: il botanico e entomologo austriaco Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784-1842). 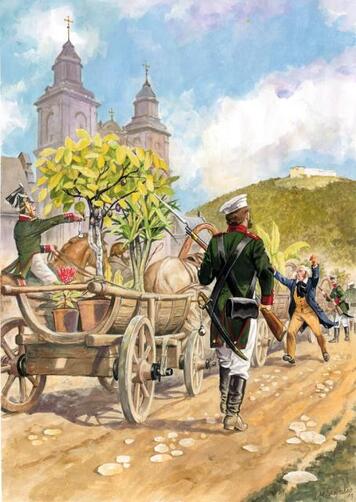 Dalla flora della Galizia a quella dell'Ucraina Senza una duplice disgrazia, il destino di Wilibald Besser sarebbe stato totalmente diverso. Nato a Innsbruck, nel 1797, quando aveva appena 13 anni, perse in un'epidemia entrambi i genitori, Samuel Gottlieb Besser e Josepha von Lansenhoffer; a occuparsi del piccolo orfano fu un parente della madre e suo padrino, il botanico Swibert Burkhard Schiverek (1741-1806). Questi, dopo aver insegnato per vari anni chimica e botanica all'università di Innsbruck (dove aveva posto mano a una Flora Tyrolensis, mai completata), in seguito alla soppressione di questa nel 1783, era stato trasferito all'Università di Leopoli di cui fu il primo professore di chimica e botanica. Egli prese con sé il ragazzo, lo fece studiare al Liceo di Leopoli e poi alla facoltà di medicina dell'Università, di cui era anche rettore. Soprattutto, gli trasmise la passione per le scienze naturali, in particolare per botanica e entomologia. Schiverek, più che insegnare ex cathedra, amava guidare i suoi studenti in escursioni sul campo. Lo aveva fatto a Innsbruck, lo faceva a Leopoli e lo avrebbe fatto a Cracovia, la sua terza sede, dove nel 1805, quando anche l'università di Leopoli venne chiusa, fu trasferito come curatore dell'orto botanico e direttore del dipartimento di storia naturale. Inutile dire che Besser (ora diciannovenne) era con lui. Purtroppo l'anno successivo Schiverek morì e Besser perse un secondo padre. Trovò però un altro validissimo maestro nel suo successore alla cattedra di botanica, Josef August Schultes. Se da Schiverek aveva assorbito l'amore per piante e insetti e aveva imparato come muoversi sul campo, con Schultes perfezionò la competenza tassonomica. Già a Leopoli, da solo o con l'aiuto di amici, aveva raccolto una vasta collezione di piante galiziane, che andava ad aggiungersi al notevole erbario ereditato da Schiverek, e a Cracovia lo ampliò ulteriormente grazie alle escursioni organizzate da Schultes, che toccarono anche i Carpazi. Notevolissima anche la sua collezione di insetti. Besser si laureò in medicina nel dicembre 1807 e quasi immediatamente fu assunto come assistente presso la Clinica universitaria di Cracovia. Benché fosse un bravo medico (esercitò la professione per tutta la vita ed era apprezzato dai suoi pazienti), la sua vera vocazione era la botanica. Così quando nel 1808 Czacki gli offrì la cattedra vacante di professore di botanicae zoologia e il posto di direttore dell'orto botanico del liceo di Kremenec' (Scheldt, il primo titolare, era morto nel 1807), egli non esitò ad accettare, nonostante le due condizioni poste dal governo russo e da Czacki: che egli prendesse la cittadinanza russa e si impegnasse a insegnare in polacco. Del resto, l'offerta era generosa. Prima di assumere il suo incarico a Kremenec', egli fu infatti inviato a Vienna e gli furono forniti i fondi per pubblicare un'opera sulla flora della Galizia austriaca, basata sulle raccolte proprie e di Schiverek (Primitia Florae Galiciae Austriacae utriusque in due volumi). In cambio, doveva attenersi alle precise istruzioni scritte di Czacki: praticare gli ambienti scientifici, acquistare libri aggiornati per la biblioteca del Liceo, contattare un artigiano cui commissionare modelli didattici di piante, frequentare la comunità polacca per perfezionare il suo polacco, che aveva appreso dal vivo vivendo in Galizia fin dall'adolescenza. Il soggiorno viennese duro quasi un anno, e permise a Bessere anche di approfondire gli studi di entomologia sotto la guida di Franz Anton Ziegler. Dopo questa fruttuosa parentesi, il giovane professore (aveva 25 anni) iniziò a svolgere i suoi compiti a Kremenec' nell'agosto 1809. Poiché si è conservato il programma delle sue lezioni, sappiamo che si teneva aggiornato sugli sviluppi della biologia (tra l'altro, illustrò ai suoi allievi le tesi di Lamarck) e che era attento alle relazioni tra piante e substrato, come dimostrano le sue lezioni su piante alofile come Salsola e Chenopodium. Si innamorò subito della varia vegetazione dei dintorni di Kremenec' e dedicò tutta la sua passione arricchimento dell'orto botanico. I progetti del suo predecessore Scheldt erano stati presto interrotti dalla malattia e dalla morte e probabilmente anche le collezioni di McClair gli parevano insufficiente, se questi nel 1811 questi fu inviato a procurarsi altre piante in un lungo giro in cui toccò San Pietroburgo, Danimarca, Finlandia, Svezia e Inghilterra. Grazie a questa ampia spedizione, le piante coltivate a Kremenec salirono a 2270 specie, come ci informa la seconda edizione del catalogo e i suoi supplementi, pubblicati da Besser tra il 1811 e il 1815. Finita la collaborazione con McClair nel 1811, Besser continuò ad incrementare le collezioni con scambi con altri orti botanici e con doni di appassionati e dei proprietari terrieri che finanziavano copiosamente il liceo. Riuscì anche ad ottenere dal conte Rumjancev le piante raccolte durante la spedizione Kotzebue. Nel 1830, alla vigilia della sua soppressione, il giardino misurava 20 ettari e ospitava 12000 piante. Quel gran numero si doveva anche alle raccolte dello stesso Besser che, come aveva fatto a Leopoli e a Cracovia, esplorò a fondo la flora prima dei dintorni della città e dei monti Kremenec', quindi estese sempre più il campo delle sue ricerche ce spaziarono dalla Polesia al mar Nero, dalla Volinia e dalla Podolia fino alla riva destra del Dnepr; in queste raccolte seppe anche coinvolgere tanto i suoi studenti quanto un gruppo di amici e appassionati, per i quali scrisse in polacco Przepisy do układania zielników ("Regole per la compilazione di un erbario" , Vilnius 1826). Il più attivo dei suoi collaboratori fu A. L. Andrzejowski, che divenne il suo assistente e lo accompagnò in molti viaggi, aiutandolo a raccogliere un ricchissimo materiale d'erbario, ampliato ed esteso anche grazie agli scambi con altri botanici. Besser non mancò di fare raccolte anche nei dintorni di Vilnius in Lituania, dove si era recato per confermare il titolo di dottore in medicina in modo da poter esercitare la professione in Russia; infatti al suo rientro ottenne l'incarico di medico cittadino di Kremenec', che andò ad aggiungersi all'insegnamento, alla direzione dell'orto botanico e all'attività scientifica. Nel 1821 pubblicò un articolo sulla flora di Vilnius; nel 1822 uscì la sua opera più importante (Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, Gub. Kiioviensi, Bessarbia Cis-Tyraica et circa Odessam collectarum), dedicata alle piante raccolte nel corso dei suoi viaggi nelle regioni sud-occidentali dell'Impero russo; nel 1834 il più breve saggio Über die Flora des Baikal. Tra il 1832 e il 1834, a Besser toccò il più doloroso dei compiti: liquidare lo splendido giardino cui aveva dedicato tanto amore e tanti sforzi. Dopo la morte di Alessandro I, che lo aveva favorito e protetto, il Liceo di Kremenec' cominciò a declinare e ad attirare i sospetti del rigido successore Nicola I, che vi vedeva sempre più un covo della resistenza polacca al dominio russo. Così la rivolta polacca, iniziata nel novembre 1830, segnò la fine dell'Atene della Volinia. Il liceo venne chiuso e nel 1834 la biblioteca e molti professori vennero traferiti all'ateneo di Kiev, contestualmente fondato dallo zar. Tra di loro c'era anche Besser, primo titolare della cattedra di botanica. Ma prima di trasferirsi nella capitale ucraina, dovette presiedere allo smantellamento dell'orto botanico; nel 1832 il giardino fu chiuso e fu decretato il trasferimento delle piante più preziose a Kiev. Espiantate, imballate e preparate secondo le indicazioni di Besser, circa 500 piante lasciarono Kremenec' in un lungo convoglio di carri sotto scorta militare, come si faceva per i deportati e i condannati. Per i polacchi, era uno sfregio e un gesto di vendetta, tanto più che a Kiev non c'era alcun orto botanico ad accoglierle. Così esse furono temporaneamente sistemate nel giardino imperiale. Per la nascita ufficiale dell'orto botanico dell'Università di Kiev si dovette attendere il 1839, ma a occuparsi del trapianto delle esuli di Kremenec' non fu Besser. Egli infatti rimase a Kiev solo tre anni, dal 1834 al 1837. Era sempre stato un grande lavoratore, ma il compito di creare dal nulla il dipartimento di botanica comportò un super lavoro che finì per minare la sua salute; inoltre, mentre parlava fluentemente polacco, non conosceva il russo ed era costretto a fare lezione in latino. Così nel 1837 diede le dimissioni e tornò nell'amata Kremenec', dove sarebbe morto nel 1842. Prima di lasciare Kiev, donò la sua vasta collezione di insetti all'università che, dopo la sua morte, avrebbe acquistato dalla vedova il suo vastissimo erbario e la sua notevole biblioteca. Besser dedicò gli ultimi della sua vita principalmente agli studi tassonomici, campo in cui era così reputato che l'orto botanico di Berlino chiese il suo aiuto per la classificazione di generi controversi; era uno specialista di Asteraceae ed in particolare di Artemisia, cui dedicò otto monografie che molto contribuirono a chiarire questo difficile genere, tanto che de Candolle adottò quasi integralmente la sua sistemazione nel Prodromus. Forse vi piacerà scoprire che l'orto botanico di Kremenec' esiste di nuovo: nel 1990, alla vigilia dell'indipendenza, il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina decretò la ricostruzione del giardino, anche se i lavori veri e propri iniziarono nel 2001 quando esso passò sotto la gestione del Ministero dell'ecologia e delle risorse naturali dell'Ucraina. Certo, con le sue 2000 specie e varietà è ben lontano dalle passate glorie, ma è comunque una realtà importante, con un arboreto di oltre 200 specie, una collezione di piante native, undici delle quali elencate nella lista rossa delle piante in pericolo da salvare, e diversi dipartimenti scientifici che riprendono la tradizione interrotta di Besser. Il giardino - che, com'era un simbolo della resilienza polacca a inizio '800 ora è un simbolo dell'identità e dell'orgoglio nazionale ucraino - non dimentica i suoi due fondatori: Besser è ricordato da un monumento, McClair da un cippo commemorativo; nel nome di quest'ultimo è in atto un progetto di collaborazione con diversi partner irlandesi, tra cui l'orto botanico nazionale di Dublino, ed è stato realizzato un "angolo irlandese" con specie provenienti dalla sua patria.  Bessera, una fantasmagoria di colori Autorevole esponente della comunità scientifica tanto germanica quanto russa, Besser fu membro tra l'altro della Società imperiale dei naturalisti di Mosca, della Società medica imperiale di Vilnius, dell'Accademia Leopoldina e, come socio corrispondente, della Royal Society e dell'Accademia Imperiale delle Scienze di San Pietroburgo. Nel 1828 fu ammesso alla nobiltà del Governatorato di Volinia e aggiunse al cognome l'ambita particella von. Ad attestare la stima in cui era tenuto è anche la quadruplice dedica di un genere Bessera: in ordine cronologico troviamo infatti nel 1809 Bessera (Boraginaceae) da parte del suo maestro Josef August Schultes, oggi sinonimo di Pulmonaria; nel 1815 da parte di K.P.J. Sprengel Bessera (Phyllanthaceae), sinonimo di Flueggea; nel 1829 Bessera (Nyctaginaceae) da parte del brasiliano Vellozo, sinonimo di Guapira, e Bessera (Asparagaceae) da parte di Julius Hermann Schultes, figlio di Josef August. Poiché per un motivo o l'altro le altre denominazioni sono illegittime, a essere valido è quest'ultimo. Ne era ben consapevole Schultes junior che creò questo genere sia per rispettare la volontà paterna, sia per evitare che un botanico tanto stimabile rimanesse privo di un genere celebrativo; nella dedica, sotto forma di lettera a D.F.L. von Schlechtendal, egli infatti scrive: "Poiché il genere Bessera fondato da mio padre non è stato accettato e quello di Sprengel è stato emendato dallo stesso autore, ho creato un nuovo Bessera in onore del dottore e professor Besser, ottimo amico di mio padre e benemerito dello studio delle piante, come è noto a te e a tutti i botanici". Non scelse una pianta a caso, ma una specie di grande bellezza (Schultes la definisce pulchra "bella") appena giunta dal Messico, Bessera elegans. Oggi a questo piccolo genere di geofite tuberose sono assegnate quattro-cinque specie, tutte endemiche del Messico. Come Brodiaea, di cui ho scritto in questo post, appartiene alla sottofamiglia Brodiaeoideae delle Asparagaceae. Fino a pochi anni fa, le specie riconosciute era solo due: appunto B. elegans, con una vasta distribuzione nel versante pacifico del Messico (dal Sinaloa al Durango nella Sierra Madre Occidental, alla parte meridionale del Deserto di Chihuahua e alla Sierra Madre del Sur nell'Oaxaca), e B. tuitensis, un endemismo della Sierra de El Cuale nello stato di Jalisco. Nel 2021, lo studio di 21 popolazioni di B. elegans e delle loro variazioni morfologiche ha portato all'individuazione di altre due specie, B. ramirezii e B. elegantissima. Incerto è invece lo status di una eventuale quinta specie, B. tenuiflora. a seconda se si include o meno in Bessera il genere Behria. Plants of the World on line sposa la prima posizione e denomina questa specie Bessera tenuiflora, mentre il sito della Pacific Bulb Society, sulla base degli studi dei botanici dell'Università di La Paz in Baja California, mantiene separati i due generi e riporta la specie come Behria tenuiflora. Si tratta della posizione più convincente a cui mi atterrò anch'io. Le Bessera posseggono cormi rivestiti da uno strato membranoso di minute fibrille, da cui emergono strette foglie lineari e lunghi scapi che terminano con un'ombrella di eleganti fiori penduli a campana dai colori vividi: le corolle sono rosso rubino in B. elegans, rosso chiaro, scarlatto, viola, magenta o fucsia in B. elegantissima, da rosa a lilla in B. tuitensis, viola scuro in B. ramirezii. Ma i colori non finiscono qui: in B. elegans il tubo è bianco e il pistillo, racchiuso tra lunghi filamenti rossi, è viola, mentre il polline è grigio. Questa fantasmagoria di colori e la forma dei fiori ci dicono che queste bellissime piante sono impollinate dai colibrì. Solo i cormi di B. elegans (in inglese la chiamano molto giustamente coral drops, gocce di corallo) sono talvolta disponibili da noi; poiché non è rustica e va mantenuta rigorosamente asciutta durante il riposo vegetativo, è consigliabile la coltivazione in vaso. Altre informazioni nella scheda. Quando il sistema e la reputazione scientifica di Linneo sono ridicolizzati e messi in discussione da Siegesbeck, al suo fianco si schiera inaspettatamente il giovane botanico tedesco Johann Gottlieb Gleditsch, subito ripagato con la dedica di uno dei più begli alberi americani, Gleditsia triacanthos. Ma non è l'unico merito di questo notevolissimo e versatile studioso: dalla rifondazione dell'orto botanico di Berlino agli esperimenti sulla fecondazione e i movimenti delle piante, da un metodo per classificare i funghi alla fondazione della silvicoltura scientifica, sono molti i campi in cui ha lasciato un'impronta significativa. 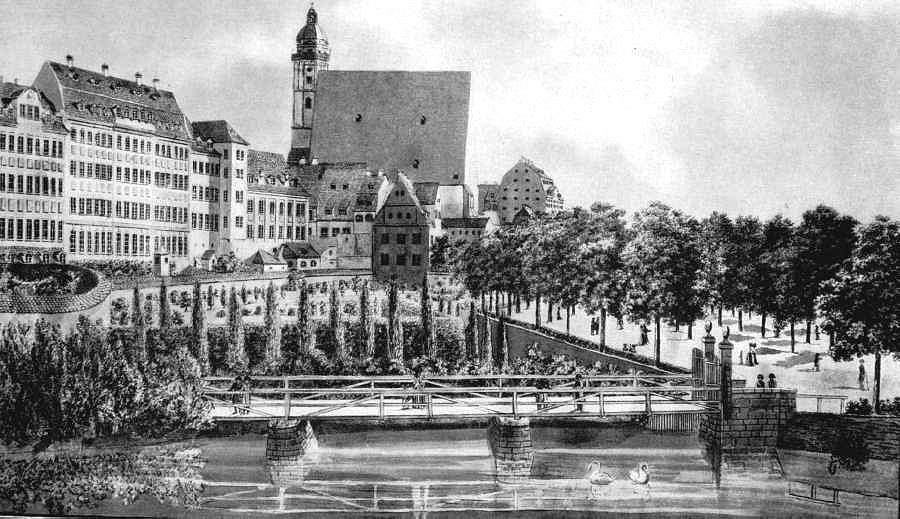 Una lettera inattesa dalla Germania Nella primavera del 1739, Linneo viveva forse il punto più basso della sua carriera. Rientrato in Svezia dall'Olanda alla fine di giugno dell'anno precedente, tre mesi dopo era si stabilito a Stoccolma dove contava di lavorare come medico. Aveva invece scoperto che il libello di Siegesbeck che attaccava il suo sistema sessuale come "pornografia botanica" lo aveva coperto di ridicolo e soprattutto gli aveva alienato i potenziali e timorati clienti, tanto che, come scrisse con qualche esagerazione a von Haller, nessuno era disposto a fargli curare nemmeno un cane. Come ho già raccontato in questo post, avendo promesso a Boerhaave di non farsi trascinare in nessuna disputa scientifica, aveva affidato la sua difesa all'amico Browallius, ma in suo soccorso giunse un aiuto inaspettato, sotto forma di una lettera dalla Germania. A scrivere al "nobilissimo, magnifico, espertissimo e dottissimo botanico e filosofo Carlo Linneo" era il giovane medico Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), all'epoca venticinquenne. Egli esprimeva tutta la sua ammirazione per gli scritti di Linneo, ed in particolare per Fundamenta botanica, in cui aveva ritrovato la sua stessa concezione della botanica come scienza autonoma. Lamentava poi il deplorevole stato della botanica in Germania, dove persisteva la sudditanza alla medicina e i botanici più reputati disquisivano di piante vistose ed esotiche e consideravano felci, muschi, funghi ed alghe alla stregua di escrementi della natura. Raccontava anche di sé, della sua precoce passione per le scienze naturali, osteggiata dalla famiglia e anche all'università di Lipsia dove gli ripetevano che non era degno di uno studente di medicina andare in cerca di erbe per boschi e pantani a sporcarsi le scarpe, i vestiti e la testa ben incipriata. Ma lui non aveva dato loro ascolto: aveva studiato diversi sistemi di classificazione che lo delusero per la mancanza di una chiara definizione di genere; per undici anni aveva esplorata la flora tedesca tenendo un diario di campo, raccolto piante alpine, pietre, fossili, minerali. Poi, proprio come Linneo con George Clifford, da poco aveva trovato un mecenate nel generale von Zieten, che gli aveva affidato la catalogazione del proprio giardino di Trebnitz. Ora sperava in una collaborazione con Linneo e lo stesso Clifford. E forse Linneo gli sarebbe stato utile per realizzare il suo sogno di trasferirsi in America. Lo scopo principale della missiva emerge però solo nel poscritto, in cui Gleditsch scrive: "In autunno ho letto l'Epicrisis di Siegesbeck contro i tuoi scritti [...] Le sue argomentazioni sul tuo sistema e i tuoi fondamenti botanici non sono di alcun valor valore [...] tanto da non meritare risposta". Chiede tuttavia il permesso di pubblicare "le due cosette che ho già concepito" sotto forma di lettera pubblica a Breyne. Dato che del carteggio Gleditsch-Linneo sono conservate solo le nove lettere scritte dal tedesco, non sappiamo cosa abbia risposto Linneo. Ma certo, come si può ricavare da ulteriori due lettere del 1740, diede il permesso e seguì da vicino le vicende della pubblicazione dell'opuscolo promesso, che con il titolo Consideratio epicriseos Siegesbeckianae uscì solo alla fine del 1740 e fu indirizzato non a Breyne ma a Christian Wolf. Siegesbeck rispose con il rabbiosoVaniloquentiae botanicae specimen, a M. Jo. Gottlieb Gleditsch, ma ormai, grazie a Gleditsch, la reputazione di Linneo era ristabilita anche in Germania.  L'Experimentum berolinense Al di là del suo coinvolgimento nella celebre controversia, Johann Gottlieb Gleditsch fu un botanico versatile e di notevole valore che vale la pena di conoscere meglio. Figlio di un musicista di Lipsia, come racconta egli stesso nella sua prima lettera a Linneo, fin dall'infanzia si innamorò della botanica, una passione osteggiata dalla famiglia che voleva destinarlo a più alti studi. Nel 1728, quattordicenne, si immatricolò all'università di Lipsia per studiare filosofia e medicina; fin da quel momento prese ad esplorare la flora di Lipsia, dello Harz e della Turingia. Prima ancora di aver conseguito il primo grado accademico (magister artium) nel 1732, attirò l'attenzione del suo professore di botanica, Johann Ernst Hebenstreit, che nel 1731, nel partire per l'Africa in cerca di rarità per la Wunderkammer di Augusto il forte, nonostante la giovanissima età gli affidò la cura dell'orto botanico universitario e dello spettacolare giardino barocco della famiglia Bose. Scopriamo così che Lipsia non era il deserto botanico dipinto da Gleditsch: Hebenstreit era un botanico sufficientemente stimato da guadagnare la dedica di un genere da parte dello stesso Linneo; ma forse era proprio lui uno di quei botanici che egli stigmatizzava per le loro tassonomie contraddittorie (era un continuatore di Rivinus) e per la predilezione per le piante esotiche. Come che sia, fino al 1735, quando in seguito alla morte del sovrano Hebenstreit fu richiamato, il nostro resse i due giardini e proseguì gli studi di medicina nella città natale. Quindi per breve tempo fu medico pratico a Annaberg, finché si trasferì a Berlino per approfondire lo studio dell'anatomia e della chirurgia presso il Collegium medico-chirurgicum, recentemente fondato e strettamente legato alla Charité. Ebbe così modo di collaborare con il medico cittadino Christian Gottfried Habermaaß nella creazione di barriere, recinzioni e piantumazioni per contrastare la sabbia trasportata dal vento che rendeva aride e non coltivabili intere zone della città. Dovette così attirare l'attenzione del generale Georg Friedrich von Ziethen che gli commissionò un catalogo delle piante del suo vasto giardino di Trebnitz, presso Müncheberg. Pubblicato nel 1737, il Catalogus Plantarum Trebnitzii è la prima opera a stampa di Gleditsch; oggi ne sopravvive un'unica copia nella biblioteca universitaria di Göttingen. Gleditsch si trovava sicuramente a Trebnitz nel marzo 1739 quando scrisse la prima lettera a Linneo, dalla quale scopriamo anche che era in contatto con Pier Antonio Micheli e che la morte di questi nel 1737 lo aveva privato del suo principale corrispondente; forse anche per questo cercava in Linneo un nuovo mentore, o almeno un "fratello maggiore". Poi, invece di partire per l'America, rimase in Prussia, dove percorse una carriera di straordinario successo. Nel 1740 fu nominato "medico rurale" del distretto di Lebus e nel 1742 conseguì il dottorato presso l'Università di Francoforte sull'Oder, dove tenne anche corsi di fisiologia vegetale e materia medica. Nel 1744 Federico il Grande lo chiamò a Berlino come professore di botanica al Collegium medico-chirurgicum, membro effettivo della reale accademia della scienze e botanico reale, ovvero direttore dell'orto botanico. Prima di trasferirsi nella capitale, un viaggio in Turingia gli offrì importanti esperienze botaniche e forestali. Nel 1746, fu invitato a San Pietroburgo con uno stipendio di 2.000 rubli, ma dopo che Federico II gli aumentò lo stipendio di 200 Reichstaler, preferì rimanere a Berlino. Vi sarebbe rimasto fino alla morte, per oltre 40, divenendo di fatto il fondatore di quella scuola botanica. Tra i suoi allievi, va ricordato almeno Willdenow. Professore stimato e molto impegnato nelle lezioni, dedicò molto del suo tempo anche alla ricostruzione dell'orto botanico, che al momento in cui ne assunse la direzione era assai trascurato. Le origini del giardino risalivano al 1679 quando, in seguito alla costruzione di un bastione e di un fossato che tagliava in due il giardino di piacere (Lustgarten) del palazzo elettorale, il grande elettore chiese al suo medico Johann Sigismund Elsholtz di ristrutturare un terreno sito del villaggio di Schöneberg in precedenza adibito alla coltivazione di luppolo per le birrerie reali; dopo la trasformazione, divenne allo stesso tempo una fattoria reale, un giardino di piacere, aperto al pubblico e molto amato dai berlinesi, e un orto botanico con piante medicinali coltivate anche a fini didattici, anche se incominciò a essere chiamato orto botanico solo a partire dal 1718, quando venne affiliato all'Accademia delle scienze. L'area occupata dall'orto botanico era relativamente estesa e offriva una certa varietà di terreni, più o meno fertili e da aridi a umidi, il che permise a Gleditsch di sfruttare la sua vasta conoscenza della flora tedesca puntando sulle piante autoctone rustiche, per cercare le quali fece molti viaggi. Altre se le procurò con scambi con altri orti botanici (nella sua successiva corrispondenza con Linneo, gli chiese ad esempio di inviargli piante siberiane o in genere adatte al freddo clima berlinese). Ovviamente non mancavano le esotiche, per le quali fece costruire nuove serre; venne creato anche un vivaio. Nelle aiuole didattiche le piante furono collocate seguendo il sistema di Linneo (anche se, come vedremo, Gleditsch creò anche un proprio sistema). Per la ricchezza delle collezioni (nell'arco di poco tempo, le piante superarono le 6000) per la prima volta il giardino assunse rinomanza europea. A dargli fama, furono anche gli esperimenti di Gleditsch, in particolar modo il cosiddetto Experimentum berolinense. La sessualità delle piante era già stata dimostrata dagli esperimenti di Camerarius e Vaillant, ma all'epoca era ancora una questione controversa e delicata, come dimostra la stessa polemica Linneo-Siegesbeck. Nell'orto botanico di Berlino c'era un esemplare femminile di Chamaerops humilis che fioriva ma non produceva frutti. Nel 1749 Gleditsch la impollinò con il polline di un esemplare maschile della stessa specie che si fece spedire dall'orto botanico di Lipsia (egli probabilmente lo conosceva fin dagli anni universitari). Ripeté l'esperimento nel 1750 e nel 1751, utilizzando anche polline proveniente da Karlsruhe, sempre con pieno successo. Quell'anno pubblicò i risultati in un saggio in francese sull'inseminazione artificiale. Nel 1752, come controprova e per togliere ogni argomento agli avversari, la palma non venne impollinata e non fruttificò. Fin dal primo anno, i frutti maturi furono interrati e produssero pianticelle vitali di entrambi i sessi, che furono inviate in dono ad altri orti botanici. Una delle prime, un esemplare di due anni, raggiunse Linneo, accompagnata da una lettera di Gleditsch datata 1 febbraio I753. L'esperimento, anche per il modo esemplare con cui venne condotto, fornì la prova definitiva della sessualità delle piante e diede grande fama al suo autore. 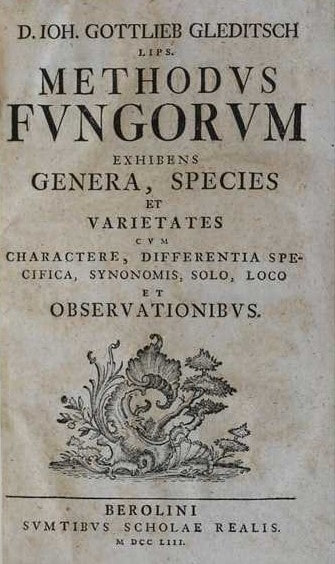 Padre della silvicoltura Gleditsch, oltre a ripetere esperimenti di impollinazione su altre piante dioiche, applicò l'approccio sperimentale ad altri soggetti: il ruolo degli insetti nell'impollinazione, la fecondazione dei funghi, la fecondazione artificiale dei pesci, l'influsso dei fattori meteorologici sui movimenti delle piante. Si occupò anche di sistematica: nel 1753 pubblicò il notevole Methodus Fungorum Exhibens Genera, Species et Varietates, il primo reale trattato di micologia, e nel 1764 in Systema plantarum a staminum situ espose il proprio sistema, basato sul numero e la posizione degli stami. Gleditsch non trascurò le applicazioni pratiche della botanica; nel 1760 fondò la rivista Almanach der Ökonomischen Botanik ("Almanacco di botanica economica") in cui promosse l'introduzione e la diffusione di piante utili e il miglioramento delle pratiche orticole. I suoi contributi degli anni '60 tanto sulla fisiologia vegetale quando sulla botanica economica sono raccolti in Vermischte physicalisch-botanisch-oeconomische Abhandlungen ("Trattati misti di botanica fisica ed economica", 1765). La sua più duratura eredità è però la fondazione della silvicoltura su basi scientifiche. Interessato agli alberi fin dall'adolescenza, a partire dal 1770 fu il primo professore universitario ad insegnare questa materia nella neonata Scuola Superiore di Scienze Forestali di Berlino. Prima di allora, la gestione dei boschi e la coltivazione degli alberi erano trattate in modo puramente empirico; egli le trattò invece in modo scientifico e sistematico, come possiamo riscontrare nella sua opera principale in due volumi, Systematische Einleitung in die neuere, aus ihren eigenthümlichen physikalisch-ökonomischen Gründen hergeleitete Forstwissenschaf ("Introduzione sistematica alla nuova scienza forestale, derivata dalle sue peculiari ragioni fisico-economiche", 1774-75). Proprio come faceva all'orto botanico di Berlino, anche in campo forestale Gleditsch puntò a un equilibrio tra la valorizzazione delle specie autoctone e l'introduzione di specie esotiche. Incoraggiò la piantumazione di alberi di alta qualità come il rovere e il pino; promosse una conoscenza scientifica delle varie specie e delle loro diverse esigenze; introdusse nelle foreste tedesche nuove specie, anche per diversificare le risorse forestali e migliorare la resistenza alle malattie e agli insetti; riconobbe l'importanza della conservazione delle foreste per le generazioni future, evitando l'eccessiva deforestazioni. Il suo insegnamento (cui dedicava da otto a dieci ore al giorno) e i suoi scritti ebbero un'influenza duratura sulla gestione delle foreste tedesche ed europee tanto da fargli riconoscere l'appellativo di "padre della silvicoltura". Membro di istituzioni scientifiche come l'accademia delle scienze di Berlino, della Società berlinese degli amici dei ricercatori naturali, della Leopoldina e delle accademie di Roma, San Pietroburgo e Stoccolma, Gleditsch rivesti anche incarichi pubblici: era supervisore del Gabinetto di Storia Naturale dell'Accademia delle Scienze di Berlino e dal 1780 fu membro della Commissione della Farmacia di Corte. 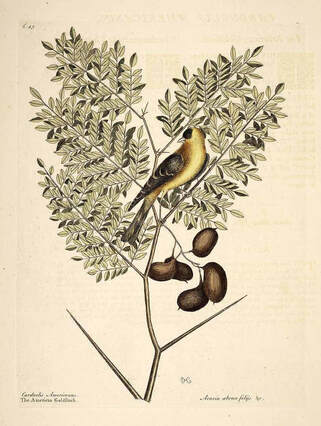 Foglie d'oro e spine minacciose Gleditsch morì nel 1786, a 72, a quanto pare a causa di una malattia insorta vari anni prima in seguito a una brutta caduta mentre esplorava una delle sue amate foreste. Sul suo tumulo fu posta una Gleditsia, ovvero l'albero che Linneo gli aveva dedicato ai tempi della sua giovinezza per ringraziarlo di essersi schierato al suo fianco contro Siegesbeck. La pianta che Linneo avrebbe denominato Gleditsia triacanthos aveva già fatto la sua comparsa in Europa a fine Seicento (è citata in Plukenet come Acacia americana), ma a diffonderne la coltivazione nei giardini inglesi fu soprattutto Catesby; a dispetto delle feroci spine, era (ed è) estremamente apprezzata per il bellissimo fogliame autunnale. Linneo la descrisse in Hortus cliffortianus (1737) ancora come Acacia; la denominazione Gleditsia compare per la prima volta in Flora Virginica del maestro e amico Gronovius, in cui la piante è descritta sulla base della determinazione di Clayton; il nome fu però certamente suggerito da Linneo. Il testo uscì nel 1739, dunque prima dell'effettiva pubblicazione di Consideratio epicriseos Siegesbeckianae. Linneo poi la riprese in Hortus upsaliensis (1748) e la ufficializzò in Species plantarum (1753). Il genere Gleditsia (famiglia Fabaceae) comprende 12-14 specie di alberi decidui, per lo più muniti di spine, con una classica distribuzione disgiunta: il Caucaso, l'Asia orientale, l'America orientale, il Sud America. Si ritiene che il centro evolutivo originario del genere sia l'Asia orientale da cui potrebbe aver raggiunto il Nord America ai tempi in cui i due continenti erano congiunti dal ponte di terra della Beringia. Oggi sono note una specie caucasica, due nordamericane, una sudamericana, mentre tutte le altre sono distribuite dall'Himalaya alle Filippine e al Giappone attraverso la Cina (il maggior centro di diversità con 5 specie). Sono alberi decidui, talvolta arbusti, con fusti e rami spesso armati di spine dure; hanno foglie composte con foglioline dai margini serrati o finemente dentati; fiori unisessuali o poligami solitamente poco vistosi, bianchi o verdastri, raccolti in infiorescenze terminali o ascellari, seguiti da baccelli piatti, dritti, angolati o ritorti. La specie più nota, largamente usata in giardini e alberate, è l'americana Gleditsia triacanthos, originaria degli Stati Uniti sudorientali e del Messico. Molto apprezzata per il veloce ritmo di crescita, la resistenza alla salsedine, al vento e all'inquinamento, la rusticità, la bellezza del portamento e il fogliame autunnale, è spesso utilizzata per piantumare zone di recente urbanizzazione, terreni poveri ed aree esposte. I baccelli, inizialmente verdi, con una polpa dolce (da cui il nome americano honey locust) commestibile, a maturazione diventano legnosi e brunastri. Il fusto e i rami, tortuosi e intricati, sono armati da temibili spine disposte in gruppi di tre. In Italia si è naturalizzata in gran parte delle regioni; in Australia è considerata una delle più pericolose piante invasive. In natura si trovano occasionalmente forme senza spine (Gleditsia triacanthos var. inermis) e spesso senza semi, che sono state selezionate come varietà orticole, solitamente preferite a quelle spinose per situazioni pubbliche come parchi e alberate dove possono costituire un pericolo per bambini e animali. Tra di esse, la più nota è 'Sunburst', con foglie nuove giallo intenso che in estate virano al verde. Altre variet sono elencate nella scheda. L'altra specie nordamericana è G. aquatica che, a differenza della precedente (una specie eliofila a suo agio nei terreni aridi), predilige terreni umidi e un'esposizione semi ombrosa. Produce caratteristici baccelli piatti lenticolari. Forma ibridi naturali con G. triacanthos noti come G. x texana. Più raramente sono coltivate Gleditsia caspica e le altre specie asiatiche, alcune delle quali, come Gleditsia japonica e Gleditsia sinensis hanno una lunga tradizione di usi medicinali tradizionali. All'inizio dell'orto botanico di Leida c'è una coppia a cui il vezzo di darsi nomi latini ha donato nomi quasi identici: il prefetto Charles de l'Ecluse, che si firmava Carolus Clusius, e l'hortulanus Dirck Outgaertz. Cluyt che si firmava Theodorus Clutius. La formidabile coppia Clusius-Clutius (la mente e la mano) collaborò in amicizia, stima e armonia per pochi anni, poiché il più giovane dei due, il farmacista Clutius, morì precocemente. A succedergli avrebbe potuto essere suo figlio Outgert (alla latina Augerius Clutius), ma era troppo giovane e privo di titoli accademici; così gli amministratori dell'università gli preferirono un medico titolato. Egli non se ne adontò; viaggiò, si laureò, e divenne cacciatore di piante a beneficio del giardino creato da suo padre. Quando tornò in Olanda, esercitò la medicina ad Amsterdam e scrisse alcuni curiosi opuscoli, che gli hanno guadagnato la dedica del genere Clutia da parte della coppia Boerhaave-Linneo.  Primo atto: il padre In un'epoca in cui era consueto che i figli facessero lo stesso mestiere del padre e in cui le cariche tendenzialmente si ereditavano, anche nella storia della botanica è consueto trovare coppie di padre-figlio: rimanendo al periodo tra fine Cinquecento e inizio Seicento, in questo blog abbiamo già incontrato i due John Tradescant, i due Jacob Bobart, Jean e Vespasien Robin, Il caso di Dirck e Outger Cluyt potrebbe essere simile, se dal padre il secondo, più che un incarico, non avesse ereditato un'ostilità. Quando nell'autunno del 1593, dopo un lungo corteggiamento, Clusius arrivò finalmente a Leida, era gravemente infortunato (oltre che attempato per l'epoca, con i suoi 67 anni) e gli era impossibile occuparsi fisicamente della creazione dell'orto botanico universitario. Chiese di essere assistito da un sostituto, che con sua grande soddisfazione venne individuato nella persona del farmacista Dirck Ougaertsz. Cluyt (1546-1598), che alla latina si firmava Theodorus Clutius, con la curiosa conseguenza che i nomi latini dei due fondatori dell'orto botanico di Leida differiscono solo per una lettera (Clusius/ Clutius). Cluyt/Clutius era un amico di vecchia data, con il quale Clusius da tempo corrispondeva e scambiava semi e bulbi, soprattutto di tulipani, la maggiore passione di entrambi. Era nato ad Haarlem, dove visse e gestì la propria farmacia finché l'occupazione spagnola lo costrinse a lasciare la città natale. Nel 1578 si trasferì a Delft, dove aprì una farmacia all'insegna del melograno 'De Granaetappel'. Era così famosa che L'Obel non mancò di visitarla alla ricerca di piante rare, citando con lode il proprietario nel suo Kruidboek. Cluyt era il farmacista di fiducia di Pieter van Foreest (Petrus Forestus), il medico personale di Guglielmo d'Orange; quando il 10 luglio 1584 questi fu assassinato e van Foreest dovette imbalsamarne il cadavere, gli affidò la preparazione degli ingredienti. Come molti farmacisti dell'epoca, possedeva un giardino o hortus medicus. Il suo però si distingueva da quelli dei colleghi sia per le ampie dimensioni (si trovava dietro le cinque case che il prospero farmacista possedeva sul Rietveld) che gli permettevano di coltivare alberi da frutto e tenere alveari, sia perché, oltre alle erbe medicinali necessarie alla sua professione, vi coltivava molte piante rare, tra cui numerose bulbose. Come Clusius, anche se ovviamente in dimensioni minori, anche Cluyt faceva parte di una rete internazionale di appassionati che si scambiavano piante, bulbi, semi; e uno dei suoi corrispondenti era appunto Clusius che lo cita più volte come "il dotto e meticoloso farmacista di Delft". La sua reputazione come esperto di piante rare era tale che, quando si incominciò a cercare una persona cui affidare la direzione del costruendo orto botanico dell'Università di Leida, già nel dicembre 1591 venne fatto il suo nome. Tuttavia i reggenti dell'Università respinsero la proposta, perché, come farmacista (all'epoca si formavano come apprendisti presso la bottega di un maestro), gli mancava la laurea accademica. La scelta, come già sappiamo, cadde su Clusius, che con la sua fama europea poteva garantire proprio ciò che il neonato ateneo olandese cercava: il prestigio di un grande nome. L'incarico del botanico fiammingo era più che altro onorifico: egli si era assicurato di non avere compiti di insegnamento (che detestava), di poter continuare a studiare, di avere un proprio giardino; ma oltre al suo immenso prestigio, portava con sé la sua favolosa collezioni di piante rare. Le sue pessime condizioni di salute costrinsero il senato accademico a una mossa forse inizialmente imprevista: affiancare al praefectus Clusius, il responsabile scientifico, l'hortulanus Clutius, che avrebbe provveduto alla creazione materiale e alla gestione del giardino (la bipartizione praefectus/ hortulanus esiste ancora oggi, sia a Leida sia ad Amsterdam). Clutius venne nominato l'8 maggio 1594, con uno stipendio di 400 fiorini all'anno e l'uso di una casa; in cambio, si impegnò a trasferire a Leida tutte le piante che coltivava a Delft. Egli si mise immediatamente all'opera e nell'arco di quattro mesi l'impianto dell'orto botanico era completato; nell'inverno ne disegnò la mappa che nel febbraio 1595 consegnò personalmente ai curatori dell'Università con l'elenco delle 1585 specie o varietà (un documento per noi preziosissimo, che tra il 1987 e il 1999 ha permesso di ricostruire il giardino di Clusius/ Clutius come si presentava al tempo dei fondatori). Seguirono però anche amarezze e delusioni: la casa promessa non era ancora pronta e non gli era stato pagato nulla per la sua preziosa collezione di piante, che valutava 1500 fiorini. Alla fine ne ottenne solo 100 per le spese di trasloco e 400 per le piante. Come ho anticipato, Clusius non aveva incarichi di insegnamento; la cattedra teorica di materia medica era tenuta da Gerard Bontius (Geraert de Bondt), il professore di anatomia al quale nel 1587, all'atto ufficiale di fondazione dell'orto botanico, era stato assegnato anche l'insegnamento della botanica; anche nel contratto di Cluyt non erano previsti compiti didattici, ma di fatto, proprio come Bobart il Giovane a Oxford e più tardi Vespasien Robin a Parigi, affiancava il professore come dimostratore: d'inverno insegnava agli studenti a riconoscere le piante usando il suo erbario personale di 4000 exsiccata e "sei libri di piante e fiori di ogni tipo dipinte dal vero"; d'estate accompagnava gli studenti in visite guidate del giardino e in escursioni botaniche nei dintorni. Nonostante tutti questi impegni, nei pochi anni che gli restavano da vivere (morì improvvisamente nel 1598, a soli 52 anni) riuscì anche a completare la sua unica opera, Van de Byen, hare wonderlicke oorsprong "Sulle api e la loro meravigliosa origine", un trattatello sull'allevamento delle api sotto forma di dialogo tra Clusius e Clutius, in cui emerge l'affiatamento e l'amicizia tra praefectus e hortulanus. I due forse sono rappresentati nell'incisione del frontespizio, dove si vedono due signori elegantemente vestiti in amichevole conversazione mentre osservano le arnie. Una curiosità: in onore di entrambi, una ditta olandese produce un idromele battezzato Clutius & Clusius. La morte di Dirck Cluyt, che aveva vent'anni meno di lui ed era in tutto il suo braccio destro, fu un gravissimo colpo per Clusius che lasciò l'incarico di prefetto e da quel momento si concentrò nella scrittura delle sue opere, anche se continuò a contribuire all'arricchimento delle collezioni del giardino con le novità che riceveva della sua vastissima rete di corrispondenti. 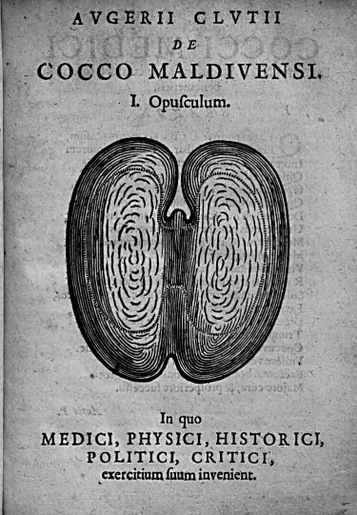 Secondo atto: il figlio A questo punto, ci si potrebbe aspettare, secondo la prassi del tempo, che a Dirk Cluyt succedesse come hortulanus, o addirittura come praefectus, il figlio maggiore Outgert (che nelle sue opere però si firmò sempre, alla latina Augerius Clutius, 1578-1636). Per lo meno, era quanto si aspettavano i diciassette studenti di medicina che nel giugno 1598 indirizzarono agli Amministratori una petizione per chiedere che gli fosse ufficialmente assegnato l'incarico di dimostrare le piante; lo definivano "un giovane esperto e preparato" e ricordavano che da tempo affiancava il padre ed era l'unico a conoscere bene il giardino e gli strumenti didattici che egli aveva messo a punto; se fosse stato nominato prefetto, avrebbe potuto aprire il giardino agli studenti almeno un'ora al giorno e dimostrare piante e minerali due volte la settimana. Gli amministratori decisero diversamente: senza consultare Clusius, nominarono direttore dell'orto botanico Bontius, affiancato da Pieter Pauw (Petrus Pavius) come professore straordinario. Erano medici e laureati, mentre il giovane Clutius era solo uno studente ventunenne senza alcun titolo. Augerius non la prese troppo male; fino al 1601, completò gli studi di artes all'università di Leida, alla quale si era iscritto nel 1594, quando la famigli si era trasferita da Delft; poi si spostò a Montpellier, dove Richer de Belleval aveva da poco fondato il Jardin du roi. Qui si laureò in medicina e divenne una specie di assistente ufficioso di Belleval, che accompagnava nelle escursioni botaniche e sostituiva all'occasione nell'insegnamento quando il professore era lontano o malato. Poi per diversi anni viaggiò: oltre che in Francia e in Germania, fu in Italia, dove visitò tra l'altro gli orti botanici di Padova e Firenze; passò poi in Spagna e da qui in Nord Africa, sempre raccogliendo materiali vegetali che inviava a Leida al professor Pauw che nel 1599 era succeduto a Bontius come praefectus. Particolarmente avventurosi furono i suoi viaggi "nel deserto della Barbaria" dove fu più volte rapinato. Rientrò in Olanda nel 1607; sembra che i responsabili dell'orto botanico di Leida lo abbiano ripagato abbastanza generosamente per le raccolte, ma nonostante l'esperienza maturata, i contatti internazionali e le considerevoli raccolte, a Leida continuava a non esserci un posto per lui; perciò si stabilì ad Amsterdam dove divenne un medico piuttosto reputato. Nel 1618 lo troviamo tra i firmatari di una petizione che chiedeva l'istituzione di un hortus medicus (Medicinale Cruythoff) - la richiesta non fu presa in considerazione e il futuro orto botanico nacque solo nel 1638, quando Clutius era già morto; più tardi (1635) fu uno dei membri della commissione incaricata di redigere una farmacopea ufficiale, presieduta da Nicolaes Tulp (il medico ritratto da Rembrandt nella famosa "Lezione di anatomia"). Oltre che di medicina (nel 1627 pubblicò un opuscolo sui calcoli renali) continuava ad interessarsi di botanica e, come il padre, di entomologia. Nel 1631 pubblicò Memorie der vreemder blom-bollen, wortelen, kruyden, planten, struycken, zaden ende vruchten ("Memoria per indicare il modo corretto di imballare e trasportare bulbose da fiore, radici, erbe, piante, alberi, semi e frutti"), tra le prime ad affrontare questo importante argomento. Nel 1634 fu la volta di Opuscula duo singularia, che raggruppa due opuscoli di argomento molto diverso, accomunati da un certo sfoggio di erudizione: De hemerobio e De nuce medica. Il primo è di argomento entomologico ed è dedicato alle effimere, in cui Clutius riconosce l'hemerobius di Aristotele. Il secondo esamina le proprietà medicinali del cocco delle Maldive Lodoicea maldivica (di cui presenta forse l'immagine a stampa più antica). Che a questa rarità, di cui non si conosceva l'origine, venissero attribuite anche proprietà mediche (come antiveleno e afrodisiaco), non stupisce. Le noci, originarie delle Seychelles, ma spinte dalle correnti marine a grandi distanze, erano oggetto di un intenso commercio, vendute per cifre altissime e esibite tra gli oggetti più preziosi delle Wunderkammer. Il testo di Clutius dipende in gran parte da Garcia da Orta, attraverso la traduzione di Clusius in Exoticorum libri decem; ma fornisce anche molte preziose informazioni sulle vie di rifornimento dei prodotti medici e delle rarità provenienti delle Indie orientali; un ruolo ancora importante di mediazione era svolto da membri della comunità sefardita oriundi della penisola iberica, che mantenevano contatti con l'India attraverso il Portogallo; ma ormai in quel mercato si era inserita attivamente la Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC): tra i suoi informatori, Clutius cita Jacobus Bontius (figlio del prefetto di Leida Gerard), medico della VOC a Batavia e autore di Historiae naturalis et medicae Indiae orientalis. Tra i fortunati possessori di questa esotica rarità cita anche John Tradescant che nella sua Arca possedeva "una noce tagliata a metà".  Un genere africano con proprietà medicinali Misurando i meriti botanici di padre e figlio, la palma sembrerebbe spettare al padre; invece fu del figlio che si ricordò Hermann Boerhaave nel catalogo dell'orto botanico di Leida, creando il genere Clutia "al cui nome è affidata la memoria di Augerius Clutius". La denominazione fu poi ripresa e ufficializzata da Linneo in Species plantarum. Si potrebbe pensare che la "dimenticanza" di Boerhaave rifletta un resto della diffidenza accademica verso il non titolato farmacista Dirck Cluyt. Il genere Clutia (Peraceae, in precedenza Euforbiaceae) comprende una cinquantina di specie di alberi, arbusti e erbacee perenni; il centro di diversità è il Sudafrica, ma il genere si estende a est fino alla Repubblica democratica del Congo e a Nord fino alla penisola arabica. Per lo più dioiche, hanno foglie semplici, intere e alternate e fiori raccolti in glomeruli ascellari, quelli femminili spesso solitari. Gli uni come gli altri hanno cinque sepali e cinque petali distinti e imbricati, ma quelli maschili sono caratterizzati da un disco con ghiandole in tre serie sui sepali, i petali e il ricettacolo, quelli femminili da sepali e petali persistenti nel frutto. L'ovario triloculare con un ovolo per loculo è seguito da un frutto che si apre in cocci con tre o due valve. Diverse specie di questo genere hanno usi medici tradizionali. Il decotto di foglie e giovani ramoscelli di C. lanceolata (una delle due specie che, dal Corno d'Africa, raggiungono la Penisola arabica) è utilizzato come antidiarroico; proprietà simili sono attribuite a C. abyssinica, C. hirsuta e C. pulchella. La decozione di radici C. abyssinica in Congo è usata per trattare febbri e malattie da raffreddamento, mentre in Africa orientale le radici vengono fatte bollire per ottenere una specie di zuppa usata per trattare problemi di fegato, la milza ingrossata, le cefalee, i disturbi dello stomaco e la malaria. Gli usi medici della pianta differiscono da un gruppo etnico all'altro; le ricerche chimiche e mediche hanno rilevato potenzialità antipiretiche, analgesiche e antinfiammatorie, ma sono ancora a uno stadio preliminare. Ad avere usi medici tradizionali, che differiscono da un'area all'altra, sono molte altre specie, compresa C. pulchella, che ha anche usi ornamentali. L'interesse non sta nei fiori, piccolissimi, ma nel fogliame verde-azzurro, intervallato qua e là da foglie arancio brillante. Sono morbide, punteggiate di ghiandole, e con nervature trasparenti alla luce. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, anche in Sud Africa alle donne si apre la carriera accademica. La prima ad insegnare botanica in istituto universitario sudafricano fu la statunitense Bertha Stoneman, che era stata una delle primissime laureate in scienze naturali del suo paese. La sua allieva Augusta Vera Duthie fu la prima persona formata in Sudafrica ad ottenere un lettorato di botanica, nel 1902, all'università di Stellenbosch. All'epoca aveva solo 21 anni. Come lettrice, poi come lettrice senior, vi avrebbe lavorato per quasi quarant'anni, dedicando le sue ricerche principalmente alle piante e all'ecologia degli Stellenbosch Flats, la pianura alluvionale dove sorge la città. A preservare almeno in parte questa flora ricca di endemismi, provvede la piccola riserva naturale che le è stata dedicata. Suo merito anche aver gettato le basi dello Stellenbosch Botanical Garden, il più antico orto botanico universitario del Sudafrica. A ricordarla la rara iridacea Duthiastrum linifolium.  Esplorare la flora... del campus universitario Il primo orto botanico universitario sudafricano, quello dell'Università di Stellenbosch, nacque nel 1902, e a fondarlo fu la botanica Augusta Vera Duthie (1881-1963), che fu anche la prima persona educata in Sudafrica ad ottenere un lettorato di botanica in un'università del paese. Augusta (ma in famiglia la chiamavano Avie) aveva trascorso l'infanzia nella tenuta di Belvidere, posta in splendida posizione panoramica sulla laguna di Knysna (Provincia occidentale del Capo) che apparteneva alla sua famiglia da oltre un secolo. Come i suoi fratelli, fu inizialmente educata in casa, finché a 17 anni si iscrisse all'Huguenot College di Wellington per studiare matematica e fisica. A indirizzarla verso la botanica fu una straordinaria insegnante, Bertha Stoneman (1866-1943), la prima donna in assoluto ad insegnare in un istituto universitario sudafricano. Nata negli Stati Uniti, nel 1894 Stoneman si era laureata in scienze naturali alla Cornell University di New York, specializzandosi in micologia (era una delle primissime donne a farlo). Dopo alcune esperienze di insegnamento in patria, nel 1897 accettò un incarico di un anno come lettrice di botanica all'Huguenot College, che era stato fondato appena due anni prima e fu il primo istituto sudafricano di istruzione superiore riservato alle ragazze. A convincerla a trasformare quell'incarico temporaneo nella sua occupazione per la vita furono, da una parte, la straordinaria ricchezza della flora sudafricana; dall'altra il suo impegno a favore dell'educazione scientifica femminile. Stoneman creò praticamente dal nulla il dipartimento di botanica del College, dotandolo di un erbario con le piante che raccoglieva nelle escursioni cui dedicava il tempo libero. Per le sue allieve nel 1906 pubblicò Plants and their Ways in South Africa che per molti decenni fu uno dei manuali scolastici più diffusi nel paese. Eccellente insegnante, formò generazioni di allieve preparate, tra le quali oltre a Avie Duthie, vale la pena di citare l'illustratrice Olive Coates Palgrave, autrice insieme al figlio Keith Coates Palgrave di Trees of Southern Africa; la micologa Averil Maud Bottomley, che lavorò presso il dipartimento delle crittogame dell'erbario nazionale di Pretoria, cui contribuì con importanti raccolte di funghi; e soprattutto la micologa e batteriologa Ethel Doidge, la prima donna ad ottenere un dottorato in Sudafrica, autrice del monumentale The South African fungi and lichens e di ricerche fondamentali sui patogeni di diverse colture agricole. All'inizio del Novecento, l'Hugenot College non assegnava ancora diplomi; così Augusta Duthie completò gli studi all'Università di Città del Capo e nel 1901 fu una delle prime allieve di Stoneman ad ottenere il diploma di Bachelor of Arts; l'anno dopo (aveva appena 21 anni) fu nominata lettrice di botanica presso il Victoria College (oggi Università di Stellenbosch). Come la sua maestra all'Huguent College, dovette creare dal nulla il dipartimento di botanica: aveva una stanza per le lezioni, ma non c'era né un laboratorio, né un erbario, né un orto botanico dove mostrare le piante agli allievi; per non parlare di microscopi e tanto meno di assistenti. Fortunatamente, però, benché sorgessero in una delle zone del Sudafrica più battute fino dal Seicento (Stellenbosch si trova a una cinquantina di km ad est di Cape Town), proprio attorno agli edifici universitari c'era molto da scoprire. Posta ai piedi dei rilievi della Stellenbosch Mountain, la città si trova in una pianura alluvionale (Stellenbosch Flats) con suolo argilloso e una vegetazione diversa da quella delle dune sabbiose dei Cape Flats di cui costituisce la continuazione. E' una zona di confine tra il fynbos granitco di Boland e il renosterveld dello Swartland, dove non mancano le piante rare o endemiche. Anche se era oberata dal lavoro (era costretta a supplire i magri proventi dello stipendio di lettrice con lezioni di inglese, storia e botanica in una scuola media), Duthie incominciò ad esplorare questo ricco terreno di caccia per creare un erbario e accanto all'edificio principale del Campus allestì alcune aiuole didattiche, il primo nucleo del futuro orto botanico. Per tre anni di seguito, il suo dipartimento riuscì a vincere il premo assegnato dal Dipartimento per l'educazione del Capo al miglior erbario montato e classificato, grazie al quale poterono essere acquistati libri, dieci microscopi e un microtomo. Nel 1904, l'erbario aveva raggiunto i 500 esemplari. Nel 1909, venne finalmente assunto un assistente part time, anche se in compartecipazione con il dipartimento di zoologia. Intanto Augusta aveva continuato a studiare e nel 1910 conseguì la laurea magistrale (Master of Arts) all'Università del Capo. Nel 1912 fu affiancata da un secondo lettore di botanica, l'inglese Sidney Garside, che si era laureato all'università di Manchester ed era specializzato in fisiologia vegetale. Duthie ne approfittò per ottenere un anno di congedo di studio, che trascorse in Inghilterra all'Università di Cambridge. Al suo ritorno in Sudafrica, nel 1913, riprese immediatamente ad occuparsi dell'espansione del dipartimento: entro il 1920, fu creato un laboratorio sperimentale e un museo botanico che presto divenne il più ampio del paese. Nel 1920, ottenne un secondo congedo per ragioni di salute, che trascorse in Australia ad erborizzare. All'inizio degli anni '20, al dipartimento di botanica ci furono molti cambiamenti: nel 1920 Garside tornò in Inghilterra; nel 1921 l'università decise di creare una cattedra di botanica, che però non fu assegnata ad Augusta Duthie, ma a uno dei suoi ex allievi, Gert Cornelius Nel, che dopo aver ottenuto la laurea di primo livello a Stellenbosch si era perfezionato a Berlino dove aveva studiato tra l'altro con Engler. Da quel momento, a Duthie, che era stata promossa lettrice senior, fu assegnato soprattutto l'insegnamento delle Crittogame e dei funghi; ma essendo venute meno molte incombenze amministrative, poté dedicare più tempo alle ricerche sul campo. Anche se fece raccolte pure nella zona di Knysna, si concentrò sulla flora degli Stellenbosch Flats che, grazie a una serie di articoli pubblicati da Duthie tra il 1924 e il 1940 sulla rivista dell'Università, Annale van die Universiteit van Stellenbosch, divenne la più studiata del paese. Il più ampio di questi lavori, Vegetation and Flora of the Stellenbosch Flats, pubblicato nel 1929 e presentato come tesi di laurea di dottorato all'Università del Capo, è un approfondito studio sull'intera ecologia dell'area e ancora oggi, dopo quasi un secolo, è un testo di riferimento. L'area è particolarmente ricca di bulbose e le sei specie di Angiosperme la cui scoperta e pubblicazione si deve a Duthie appartengono tutte alla famiglia Asparagaceae (generi Eriospermum, Ornithogalum e Drimia). Le sue ricerche toccarono però anche le crittogame dei generi Selaginella e Isoetes e i funghi Myxomyceti. Nel 1933 un evento tragico mutò la sua vita: in seguito alla morte dell'ultimo dei suoi fratelli, si trovò ad essere l'unica in grado di occuparsi della gestione della tenuta di famiglia. Alla fine del 1939, diede le dimissioni dal dipartimento di botanica e nell'agosto 1940 tornò a Knysna. Da quel momento non avrebbe più pubblicato e si sarebbe dedicata interamente all'azienda, dove morì ultraottantenne nel 1963.  Omaggi floreali e non solo Augusta Duthie era un'insegnante preparata e trascinante, e diversi dei suoi allievi diedero un importante contributo allo studio della flora sudafricana. Era anche una persona colta e affabile, in rapporti di scambio scientifico e amicizia con colleghi botanici in patria e all'estero. Particolarmente stretta fu la sua relazione con un'altra grande botanica sudafricana, Louisa Kensit Bolus, la curatrice dell'erbario Bolus, che le dedicò un Impatiens, un'Erica e tre specie di Aizoaceae da lei scoperte: Membryanthemum duthieae (oggi Ruschia duthieae), Psilocaulon duthieae (oggi Mesembryantemum articulatum), Stomatium duthieae. Anche il genere che la ricorda le è stato dedicato da una botanica, Miriam Phoebe de Vos, a sua volta grande specialista di bulbose, che fu sua allieva a Stellenbosch. Nel 1975 le dedicò con il nome Duthiella linifolia una nuova specie di Iridaceae; il nome però era illegittimo, perché esisteva già un genere Duthiella (famiglia Leskeaceae, muschi dell'Asia orientale e dell'Australia settentrionale); così ripubblicò il genere come Duthiastrum, commettendo però un errore ortografico (a rigori, il nome dovrebbe essere Duthieastrum, grafia adottata da diversi repertori, compreso il sito del SANBI, South African National Biodiversity Institute). L'unica specie di questo genere monotipico è Duthiastrum linifolium, una geofita endemica del Karoo settentrionale (Provincia settentrionale del Capo). Affine al genere Sparaxis, è una piccola bulbosa dotata di cormo con lunghi fiori tubolari aranciati con sei lobi lunghi e stretti disposti a stella, da cui il nome, letteralmente "stella di Duthie". Di lunga durata, per diversi giorni successivi si aprono all'inizio del pomeriggio e si chiudono subito dopo il tramonto. Come alcune specie di crochi, una volta che il fiore è stato fecondato, lo stelo si piega in modo che l'ovario rimanga interrato e maturi i frutti sottoterra (geocarpia). A ricordare Augusta Duthie e le sue ricerche, ci sono però anche l'orto botanico di cui gettò le basi e una riserva naturale. Lo Stellenbosch University Botanical Garden era originariamente ubicato di fronte all'edificio principale (Main Building) al lato occidentale del campus. Nel 1922, il neonominato Nel riuscì a convincere l'università ad assegnare al giardino un terreno apposito non lontano dal centro cittadino; la pianta del nuovo guardino, ispirato all'orto botanico di Padova, previde quattro aiuole principali a cerchi concentrici, separate da quattro viali a croce, più aiuole didattiche con le piante disposte per famiglie. Vennero anche costruite alcune serre, per proteggere le piante delicate dalle piogge invernali e dall'eccessivo calore estivo. Il giardino fu inaugurato ufficialmente nel 1925 ed ebbe come primo curatore il tedesco Hans Herre, che si era formato a Dalhem con Engler. Viste le limitate dimensioni del giardino, egli decise di concentrare le collezioni sulle piante succulente e per popolarlo fece molte spedizioni soprattutto nel Namaqualand. Oggi il compito principale del giardino, oltre agli scopi didattici, è la conservazione della flora nativa della regione del Capo, anche se non mancano rarità esotiche e collezioni speciali. Quando l'università si trasferì della vecchia sede, fu deciso di trasformare una parte dei terreni in una riserva naturale, battezzata Duthie Nature Reserve in onore della botanica che aveva dedicato tanta parte della sua vita allo studio della sua rara flora. Ricchissima di specie rare ed endemiche (per farvene un'idea potete sfogliare questa gallery), è oggi uno dei pochissimi luoghi dove cresce ancora in natura il rarissimo Haemanthus pumilio, oggetto di un progetto di riproduzione e salvataggio dell'Università di Stellenbosch. I due più antichi orti botanici della Lombardia nascono quasi contemporaneamente, nell'ultimo quarto del Settecento, nell'ambito delle grandi riforme teresiane che ebbero tra gli obiettivi anche lo svecchiamento dell'istruzione con una maggiore attenzione alla scienza. Erano infatti strettamente legati a due istituzioni didattiche: l'Università di Pavia e le scuole palatine di Brera. Anche se il personaggio è enigmatico e le decisioni in definitiva venivano prese a Vienna, nella loro nascita e primo sviluppo ebbe un qualche ruolo il conte Firmian, plenipotenziario per la Lombardia austriaca. Un merito che gli venne riconosciuto da Marsili con la dedica del notevole genere Firmiana (Malvaceae). 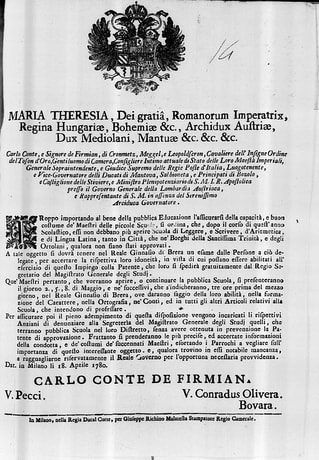 Mecenate delle arti e della scienza Intorno al 1760, all'abate Filippo Antonio Farsetti, proprietario del celebre giardino di Sala nel Padovano, giunsero "mandate non so da chi né da qual paese" sementi contrassegnate con la vaghissima etichetta Arbor excelsa ex China ("albero di grande altezza della Cina"). Seminate dall'abile giardiniere Francesco Pomai, produssero molte pianticelle che furono poi trapiantate tanto in serra quanto all'aperto; una, che "aveva perduto la cima e si era lateralmente divaricata in tre rami" fu donata da Sala a Giovanni Marsili, prefetto dell'Orto dei semplici di Padova. Allevata "diligentemente" e protetta d'inverno nella serra fredda, trapiantata in vasi via via più grandi, prosperò e "fu sì grata e cortese che in pochi anni volle a me dare il geniale e desiderato spettacolo de' primi suoi fiori coi primi suoi frutti condotti a perfetta maturità". Così Marsili racconta la prima fioritura in Europa della spettacolare Firmiana simplex, avvenuta nell'orto botanico padovano nel 1775. Diversi degli altri esemplari di Sala giunsero anch'essi a fioritura, ma solo qualche tempo dopo. La pianta, seppure sotto altri nomi, non era una novità assoluta. Sloane l'aveva vista in fioritura, ma in Giamaica (la pubblicò come Malva arborea), mentre Linneo, che ne possedeva un esemplare dal fusto non ramificato (per questo lo chiamò Hibiscus simplex) non lo aveva mai visto fiorire. Dunque Marsili fu il primo a poterne studiare fiori e frutti, capendo che andava assegnata a un genere proprio. Era un albero senz'altro di grande bellezza, dunque perfetto da dedicare a un potente. Marsili scelse il conte Carlo Firmian, ministro plenipotenziario della Lombardia austriaca, morto pochi anni prima, che poteva vantare qualche merito come mecenate della botanica: "E' a lui dovuto dai Botanici tributo di particolare riconoscenza per la recente fondazione del Regio Giardino di Pavia, portato in breve spazio d' anni, mercé le provide di Lui cure, la Sovrana munificenza, e la perizia, vigilanza e dottrina de' valenti suoi Presidi e Direttori, a tal grado di floridezza e di celebrità , che già gareggia co' più rinomati d'Europa". Come altre piante portano i nomi di Begon, Bignon, Eugenio di Savoia, Carlo di Braunschweig (dedicatario di Brunsvingia) o il patrizio veneto Morosini (dedicatario di Maurocenia), "la cui memoria anima l'industria, risveglia all' azione gl' ingegni e rincuora l' umanità - concludeva - passi a' posteri al pari d'esse nobilitato e fastoso con quello di FIRMIANA". Il conte Carlo Giuseppe Gottardo (Karl Joseph Gotthard) von Firmian (1716-1782) fu ministro plenipotenziario della Lombardia per 23 anni, dal 1758 alla morte. Gli storici sono divisi sul suo ruolo nella grande stagione delle riforme austriache in Lombardia: si va da chi vede in lui "il can da guardia dell'assolutismo" o almeno un mero esecutore, per altro indolente, delle direttive di Vienna, a chi al contrario ne sottolinea il ruolo propulsivo, soprattutto per quanto riguarda le riforme ecclesiastiche e l'applicazione delle dottrine giurisdizionaliste. Cadetto di una famiglia della nobiltà trentina che da secoli forniva funzionari tanto al principe vescovo di Trento quanto agli Asburgo e che nel Settecento ebbe un momento di gloria grazie all'arcivescovo di Salisburgo Leopold Anton Eleutherius von Firmian, zio del nostro, ebbe una formazione cosmopolita prima in Baviera e in Austria, poi nei Paesi Bassi dove studiò giurisprudenza, quindi a Parigi, dove frequentò gli ambienti giansenisti; un lungo viaggio di formazione lo portò in Italia, prima a Firenze poi a Roma, dove entrò in contatto con vari circoli intellettuali e iniziò a coltivare interessi filologici e antiquari. Tornato a Vienna, fu ammesso al Consiglio aulico; piuttosto attivo e impegnato nel suo ruolo, riunì attorno a sé una piccola accademia privata, in cui si discutevano e diffondevano le idee di Muratori, Genovesi, Montesquieu. Dal 1752 al 1758 fu ministro plenipotenziario, ovvero ambasciatore, a Napoli, quindi fu trasferito a Milano. In Lombardia la sua stella brillò soprattutto nel decennio 1760-1771: il suo stesso carattere indolente corrispondeva al prudente riformismo teresiano; spiacque invece a Giuseppe II, fin da quando visitò Milano nel 1769: lo giudicava titubante e inadeguato, così come riteneva datate e superate le sue idee. Per rispetto alla madre, che invece aveva grande stima del vecchio funzionario, lo mantenne al suo posto, ma lo affiancò con uno dei suoi fratelli, l'arciduca Ferdinando, nominato governatore di Milano nel 1771; dal 1778, fu costretto a coabitare con il suo successore designato, il conte Wilczek. Per altro, i suoi ultimi anni furono di estremo decadimento anche fisico. Al di là della difficoltà di separare quanto nelle sue azioni politiche si deve a lui e quanto alle direttive di Vienna, anche gli estimatori di Firmian ammettono che la sua presenza fu più incisiva come mecenate che come politico. Amava circondarsi di artisti e intellettuali; alla sua morte (oltre a una montagna di debiti) lasciò una collezione di quadri e di stampe e una biblioteca di oltre 40.000 volumi. Cesare Beccaria gli dedicò Dei delitti e delle pene, e sempre ne ebbe stima, al contrario di Pietro Verri che ne lasciò un giudizio impietoso sul piano tanto fisico (oggi si parlerebbe di body shaming) quanto morale. Talvolta suggerite da lui, talaltra da Vienna, troviamo lo zampino di Firmian in diverse iniziative collegate alla riforma scolastica, già iniziata in Austria intorno al 1757 e estesa alla Lombardia a partire dal 1765; sia pure con molte lentezze e contraddizioni, si ebbe un deciso avanzamento dell'accesso all'istruzione dei ceti popolari e uno svecchiamento dei metodi e dei contenuti didattici, con una forte valorizzazione delle materie scientifiche. In un suo memoriale del 1765, Firmian la collocò al primo posti tra le riforme più urgenti a necessarie. A giovarsi del vento di riforma fu in primo luogo l'Università di Pavia. Nel 1769, per interessamento di Firmian, ad insegnare scienze naturali venne chiamato Lazzaro Spallanzani; nel 1771, con l'arrivo da Vienna di sette casse di minerali e altri materiali naturalistici, che avrebbero permesso al professore "di dimostrare colla loro spiegazione le varie vie che tiene la Natura nel suo operare", prendeva avvio il Museo di Scienze naturali. Erano i primi atti del rilancio dell'ateneo patavino, a insegnare nel quale nel giro di pochi anni sarebbero stati chiamati altri scienziati di risonanza europea: il botanico Giovanni Antonio Scopoli, l'anatomista Antonio Scarpa, il fisico Alessandro Volta, che sarebbe diventato anche rettore. Nel 1772 fu aperta al pubblico la Biblioteca universitaria, dal 1779 ospitata dallo splendido Salone teresiano, e nel 1773 fu fondato l'orto botanico, la cui sede fu individuata dallo stesso Firmian nell'area della chiesa di S. Epifanio e del convento dei Canonici Lateranensi. La creazione di strutture scientifiche riguardò anche Milano. Nel 1773, il barnabita Ermenegildo Pini fu incaricato di creare un Museo di storia naturale presso le scuole Arcimboldi. Forse l'iniziativa fu presa a Vienna, ma certo fu Firmian a suggerire la trasformazione del complesso di Brera in una vera e propria cittadella della cultura. Il Palazzo di Brera era stato costruito nella seconda metà del Cinquecento per ospitare il Collegio della Compagnia di Gesù; intorno al 1760 vi venne realizzato un osservatorio astronomico, diretto da padri gesuiti che erano anche rinomati astronomi. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia, il palazzo e le aree adiacenti divennero di proprietà dello stato, che veniva così a disporre in pieno centro di un luogo ideale per riunirvi tutte le istituzioni culturali che la città aspettava da tempo. Firmian ne fu entusiasta e così scrisse a Kaunitz: "Brera dovrebbe servire per il Ginnasio ed Istituto di scienze di questa città di Milano[…] Si dovrebbero riunire in Brera le scuole Palatine, l’Aula per le dimostrazioni di Fisica sperimentale, la Camera ottica, il Laboratorio per la fusione dei metalli, il Museo delle antichità sacre e civili ed il Museo di storia naturale […] Al detto Istituto di Scienze si potrà trasportare la Biblioteca Pertusati, e formare una sala con quella di Brera […] Resterà in Brera la Specola e l’abate Lagrange […] In Brera vi sono poi le scuole inferiori […] Finalmente si potrebbe formare in Brera l’Accademia delle Arti e delle Scienze combinandola con tutti”. Il progetto trovò quasi completa attuazione negli anni successivi: già a partire dal 1774 vennero trasferite a Brera le scuole palatine, destinate all'istruzione superiore; nel 1776 venne aperta l'Accademia di Belle Arti; nel 1786, la Biblioteca Braidense, che oltre ad accogliere le biblioteche degli stessi gesuiti e quella del conte Pertusati, acquistata nel 1763 dalla Congregazione dello Stato di Milano, ricca di oltre 24.000 volumi, si divise con Pavia quella del celebre scienziato elvetico Albrecht von Haller, acquisita nel 1778 da Giuseppe II insieme al suo importantissimo erbario. Dei lavori di riallestimento del palazzo fu incaricato l'architetto Piermarini, che, oltre a predisporre le aule e ridisegnare la biblioteca, elevò nuove torri per l'osservatorio astronomico e fu coinvolto nella progettazione dell'orto botanico. Quest'ultimo fu sistemato in un terreno adiacente al lato meridionale del palazzo, che già al tempo dei Gesuiti ospitava un boschetto e un giardino, allo stesso tempo luogo di passeggio e meditazione e orto per le necessità di cucina. Al contrario di quello di Pavia, concepito come un grande orto botanico chiamato, oltre che a servire le esigenze didattiche della cattedra di chimica e botanica, a dare lustro all'Università con collezioni ricche di piante esotiche, Firmian pensava a un piccolo orto dei semplici didattico, dove coltivare le piante da utilizzare durante le lezioni pratiche (dimostrazioni) impartite agli studenti di botanica delle scuole palatine; sempre su sua proposta, nel 1774 la cattedra fu assegnata all'abate villambrosiano Fulgenzio Vitman (o Withman), che era stato il primo prefetto del giardino di Pavia. Secondo le intenzioni iniziali di Firmian, egli avrebbe dovuto provvedere anche al riadattamento del vecchio giardino dei gesuiti che, si illudeva, sarebbe avvenuto "senza spese alcuna"; per rifornirlo delle piante necessarie alle lezioni da avviare nella primavera successiva egli riteneva sufficienti due viaggi che Vitman compì tra l'estate e l'autunno del 1774, uno negli Appennini fino a Villombrosa, l'altro all'orto botanico di Torino. La realizzazione di un vero orto botanico e la coltivazione di piante esotiche dovevano aspettare tempi futuri. Vitman giunse a Milano all'inizio del 1775 e si recò ad ispezionare il giardino insieme a Piermarini, tecnici ed amministratori, scoprendo che erano necessarie opere ben più impegnative e costose; venne predisposto un progetto, che includeva anche una serra disegnata da Piermarini. Il governo approvò, ma lesinò il denaro, con la conseguenza che la serra non fu mai costruita. Vitman, tra mille difficoltà, riuscì comunque ad accrescere le collezioni, grazie a contatti con altri orti botanici, tanto in Italia quando all'estero: in primo luogo quello di Torino, ma anche Firenze e Parma, Vienna, Zurigo, Parigi e Madrid, tanto che nel 1778 il poligrafo Carlo Amoretti poté scrivere che il professore di botanica "ha un giardino sufficientemente ben fornito per le sue dimostrazioni". Un pochino lo aiutò anche Firmian che nel 1782 scrisse a Londra e a Zurigo per ordinare semi di alberi esotici per il boschetto.  Le grandi foglie dell'albero parasole Insomma, sono ben due gli orti botanici che, più o meno direttamente, devono la loro nascita e il primo sviluppo a Firmian. Dunque, d'accordo con Marsili, possiamo concludere che si sia meritata la fastosa dedica di Firmiana. Il genere, appartenente alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), comprende circa 18 specie di alberi o più raramente arbusti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e il Pacifico, con centro di diversità in Cina. Decidui, sono caratterizzati da grandi foglie palmate e da fiori unisessuali riuniti in grandi infiorescenze panicolate o più raramente racemose; la stessa pianta porta sia fiori staminati sia fiori pistillati; uno dei tipo prevale, con pochi fiori dell'altro tipo. Per favorire l'impollinazione incrociata, i fiori maschili tendono ad aprirsi prima di quelli femminili. I frutti sono follicoli con endocarpo membranoso che rimangono a lungo sulla pianta prima di aprirsi. La specie più nota e coltivata è senza dubbio F. simplex, anche nota come parasole cinese. Di medie dimensioni (10-15 metri), si fa notare soprattutto per le grandissime foglie lobate dal diametro fino a 30 cm; a maturità ha una chioma arrotondata che offre una densa ombra. Di crescita rapida, è relativamente rustica, ma per fiorire ha bisogno di sole e di un'estate calda; i fiori giallo-verdastri, raccolti in appariscenti pannocchie pendule, sono seguiti da frutti piuttosto decorativi, a volte usati in composizioni di fiori e frutti secchi. Non invasiva alle nostre latitudini, lo è invece negli Stati Uniti meridionali, dove è stata introdotta come albero da legname a crescita rapida. In Cina era tradizionalmente piantata nei giardini di letterati e poeti, di cui è dunque diventata emblema. In Cina e Corea corteccia, foglie e semi hanno diversi usi medicinali. Ad attirare gli sguardi su F. colorata sono invece i fiori, campanelle pendule ricoperte di una soffice peluria rosso-aranciata, tanto più che la fioritura si produce quando l'albero è ancora spoglio. Piuttosto comune nelle foreste umide dei Ghati occidentali e del Deccan, è presente anche nello Yunnan meridionale e in Indocina. Ha anch'essa belle foglie palmate e, poiché il fusto tende ad ingrossarsi alla base, è talvolta commercializzata come caudiciforme da vaso. Studiare la natura per sollievo dell'animo, ovvero le vicissitudini di Giovanni Antonio Scopoli23/2/2023 Autore di cinquantasette pubblicazioni che spaziano dalla medicina alla zoologia, alla botanica, alla chimica, alla mineralogia, Giovanni Antonio Scopoli fu salutato dai contemporanei come "Linneo dell'impero austriaco". Il suo biografo Otto Guglia lo ha definito "il primo europeo anazionale", visto che nacque in Trentino, ma fu suddito austriaco, studiò in Italia e in Austria, lavorò e fece le sue ricerche in Slovenia, Slovacchia, Lombardia. Come botanico, è soprattutto l'iniziatore dello studio della flora slovena, grazie alla sua Flora carniolica. Come la sua gemella Entomologia carniolica, non sarebbe mai nata se il destino fosse stato più generoso con lui e non lo avesse relegato nel "carcere" di Idria, una cittadina mineraria della Slovenia, e soprattutto non l'avesse privato di tutti gli affetti più cari. Egli cominciò a battere campagne e montagne alla ricerca di insetti e piante proprio per trovare sollievo a tante disgrazie. Sebbene meno tragiche, anche le sue vicende successive furono segnate da continue contrarietà personali e professionali, tanto che egli intitolò la sua autobiografia Vitae meae vices, "Le vicissitudini della mia vita". L'ultima, beffarda e allo stesso tempo patetica, lo attendeva a Pavia, dove pensava di aver finalmente trovato il meritato riconoscimento. Grazie all'illustre von Jacquin che prima gli fu amico e poi (a sentir lui) ostile, lo ricorda la tossica Scopolia, da cui fu inizialmente estratta la scopolamina, a lungo uno dei principali anestetici. Né lo dimentica il Museo di scienze di Lubiana che ha ugualmente intitolato "Scopolia" la sua rivista ufficiale. 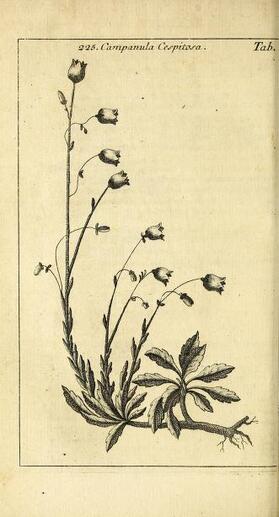 Insetti e piante della Carniola Nella prefazione della sua Entomologia Carniolica, Giovanni Antonio Scopoli (1723-1788) ebbe a scrivere: «ricordatevi sempre che non coltivo il teatro della Natura per amore dello studio, ma per sollievo dell’animo, in verità per alleviare i tristissimi dolori della mia esistenza». Pensava certo alla tragica moglie della moglie e dei figlioletti, periti in un incendio, ma anche alle difficoltà della sua carriera, che per sedici anni lo relegò nella periferica Idria, che nella sua autobiografia definirà senza mezzi termini "carcere". Quando vi era arrivato poco più che trentenne, aveva ben altre aspirazioni, e alla sola vista di quel villaggio montano costituito solo dalle "miserrime casette inedificate dei minatori" avvertì un presago di sventura. Scopoli era nato a Cavalese in Val di Fiemme, figlio del commissario militare del principe vescovo di Trento e di una nobildonna trentina che era anche pittrice. Dopo aver iniziato gli studi a Trento, si laureò in medicina a Innsbruck, quindi esercitò la professione per qualche tempo in Val di Fiemme e a Trento. Importante fu il soggiorno a Venezia del 1745, che gli permise di approfondire le conoscenze mediche con Lotario Giuseppe Lotti, di frequentare i giardini veneziani, in particolare quello di Lionardo Sesler, e di conoscere il sistema linneano, di cui sarebbe diventato un convinto sostenitore. Tornato a Trento, si sposò e, grazie alla protezione del protomedico Borsieri, fu assunto come segretario privato del principe vescovo Leopoldo Ernesto Firmian, che accompagnò a Graz e a Passau. Approfittò dei due anni trascorsi in Stiria per preparare l'esame di abilitazione che gli avrebbe consentito di esercitare in tutto il territorio soggetto agli Asburgo; lo superò in modo brillante nel 1753, alla presenza dello stesso van Swieten; impressionato dalla sua tesi su un nuovo metodo di classificazione botanica (Methodus plantarum enumerandis stirpibus ab eo hucusque repertis destinata), questi gli promise il primo posto vacante in una condotta medica. Scopoli sperava in Linz, invece fu Idria. A fare la fortuna - o anche la sfortuna, vista la pericolosità di questo materiale - di questa cittadina annidata nelle Prealpi della Carniola fu il mercurio, scoperto negli ultimi anni del 1400; pochi anni dopo vi fu aperta una miniera e Idria si trasformò nel centro più importante della Slovenia dopo Lubiana. La vita dei minatori era precaria; vivevano stipati nelle "casone", e la loro speranza di vita non andava oltre i 40 anni. Quando vi giunse Scopoli, con le loro famiglie costituivano una comunità di 2000 persone. Già il viaggio non aveva fatti presagire nulla di buono; dopo la nomina, Scopoli era tornato in patria a prendere la moglie Albina de’ Miorini, figlia del presidente della Magnifica Comunità di Fiemme, e la figlioletta; quindi a Hall nel Tirolo la famigliola si era imbarcata per un viaggio fluviale sull'Inn, gonfio di pioggia; il giorno dopo, l'imbarcazione fu colpita da un tronco e fece naufragio; Scopoli e i suoi furono tratti in salvo, ma tutti i bagagli, compresi i libri e gli strumenti medici, andarono perduti. Ospitato a Salisburgo e poi tornato a Vienna, Scopoli sperava che l'infortunio suscitasse la benevolenza reale, e che gli fosse assegnata la condotta di Linz, che sapeva ancora vacante. Ottenne invece un dono personale di 500 fiorini da parte dell''imperatrice, informata dell'incidente, poi dovette rassegnarsi a raggiungere Idria. Anche prima della tragica morte di moglie e figli, vi si trovò malissimo. Veniva pagato attraverso i proventi del monopolio sul vino, una beffa se si pensa che l'alcolismo era uno dei problemi sanitari che affliggevano i minatori e le loro famiglie, aggiungendosi agli effetti deleteri dei vapori del mercurio. Non conoscendo la lingua del paese, poco capiva i suoi pazienti; pessimi poi erano i suoi rapporti con il direttore della miniera, interessato solo al guadagno e per nulla sollecito della salute dei lavoratori. Il lavoro era pesante, e per nulla remunerativo; dopo nove anni di tormenti, Scopoli si rassegnò a chiedere il trasferimento con una supplica. Non lo ottenne, ma nel 1763 gli fu assegnata la cattedra di metallurgia chimica alla neoistituita scuola superiore di Idria con uno stipendio annuo di 400 fiorini. A consolarlo dalle vicissitudini personali e professionali c'era solo l'ambiente naturale, con una flora e una fauna ancora del tutto inesplorate. Secondo quanto egli stesso scrive nella prefazione alla seconda edizione di Flora carniolica, le sue escursioni iniziarono intorno al 1755 con l'esplorazione dei monti e dei boschi del distretto di Idria; nel 1756 percorse le paludi e le campagne di Lubiana; nel 1757 il monte Nanos; nel 1758 i territori di Škofja Loka e di Kranj, il monte Storžič e la catena montuosa che si estende fino al fiume Kokra; nel 1759 l'area tra Lubiana e Kočevje e i monti Grintovec, Kočna e Kalški Greben; nel 1760 i pascoli alpini e i dintorni del lago di Cerknica; nel 1761 nuovamente il monte Nanos e il Senožeče, il Carso e Trieste; nel 1762 gran parte della Carniola superiore e i monti di Bohinjska Bistrica; nel 1764 i circondari di Gorizia e Duino e la costa adriatica. Il primo risultato di queste ricerche fu la prima edizione di Flora carniolica (1760), della cui pubblicazione Scopoli informò il suo idolo Linneo con una lettera datata 1 settembre 1760. Fu l'inizio di una corrispondenza che sarebbe stata interrotta solo dalla malattia e poi dalla morte dello scienziato svedese. Nel 1763 seguì l'ancor più importante Entolomologia carniolica in cui vengono descritte 1153 specie di insetti (o meglio di artropodi), più della metà delle quali nuove per la scienza, classificati in sette classi sulla base di un sistema proprio; più olistico rispetto a quello di Linneo (basato sulle ali) o di Fabricius (basato sull'apparato boccale), tenta di tenere conto di più caratteristiche possibili per giungere a una classificazione naturale. Come medico, Scopoli fu anche il primo a rendersi conto dei nefasti effetti del mercurio, illustrati in De Hydroargyro Idriensi Tentamina (1761), che fa parte della più complessivo Tentamina physicochymico-medica, un'opera che, con i suoi suggerimenti sulla sicurezza dei lavoratori, fa di Scopoli uno di padri della medicina del lavoro. Tradotta (e piratata) in Germania, insieme alla successiva Introductio ad diagnosim et usum fossilium (1763), legata all'insegnamento di metallurgia chimica, incominciò a farlo conoscere a livello internazionale. Dalla Slovacchia all'Insubria Fu certamente questa fama crescente a liberarlo finalmente dalla "prigione" di Idria. Nel 1766 gli fu proposta la cattedra di mineralogia all'Accademia di San Pietroburgo, ma egli la rifiutò, così come l'incarico di medico personale del vescovo di Passau, preferendo rimanere al servizio degli Asburgo, tanto più che contava che l'arrivo di un altro medico, Balthasar Hacquet, lo sollevasse dai compiti più ingrati. Nel 1769, accettò invece di succedere a von Jacquin alla cattedra di mineralogia e metallurgia all’Accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica in Slovacchia). Il periodo slovacco fu molto fruttuoso sul piano professionale, con la pubblicazione di molte opere che spaziano sui tre regni della natura: Anni historico-naturales (1769-1772), scritti vari di mineralogia, cristallografia, micologia e zoologia, che contengono tra l'altro la descrizione di diverse specie di uccelli provenienti da varie collezioni; Dissertationes ad scientiam naturalem pertinentes (1772), di argomento prevalentemente mineralogico; Principia mineralogiae systematice et praticae (1772), scritto come manuale per i suoi studenti; la seconda edizione di Flora carniolica (1772); Crystallographia hungarica (1776); Introductio ad historiam naturalem (1777), un tentativo di sintetizzare i "caratteri essenziali" dei generi dei tre regni della natura. Anche se continuava a interessarsi di zoologia e botanica, in questi anni, a occupare il centro dei suoi studi erano soprattutto la chimica e la mineralogia, un altro campo in cui diede contributi originali. La seconda edizione di Flora carniolica non è un semplice ampliamento della prima, ma un'opera di impostazione del tutto diversa. Nella Flora del 1760, Scopoli aveva descritto 756 specie di fanerogame e 256 di crittogame, in gran parte autoctone, dedicando anche una notevole attenzione ai funghi. Fu in effetti uno dei primi a studiare la flora e la fauna della grotte (incluso il famoso proteo Proteus anguinus); anche se apprezzava già Linneo, definito nella prefazione Princeps botanicorum, utilizzò le tradizionali denominazioni polinomiali, costituite da brevi diagnosi, e una propria classificazione "naturale" in 33 classi, una rielaborazione di quella di Tournefort. E' ancora l'opera di un medico-farmacista, e come tale Scopoli si preoccupò di integrare le descrizioni con note più o meno ampie sulle proprietà medicinali e gli eventuali altri usi. Non ci sono illustrazioni. La Flora del 1672 è quella di un linneano ortodosso, ed è esclusivamente botanica; le note farmacologiche scompaiono; di Linneo vengono adottati tanto le denominazioni binomiali quanto il sistema. Le specie lievitano a 384 crittogame, 1251 fanerogame, 141 tra funghi, licheni, alghe. Molte quelle descritte per la prima volta, e molte anche quelle che conservano ancora oggi il nome dato loro da Scopoli: tra i generi Ostrya, Rorippa, Sesleria, tra le specie Cotinus coggygria, Centaurea kartschiana, Cirsium carniolicum, Tragopogon dubius, Ostrya carpinifolia, Cakile maritima, Campanula cespitosa, Euonymus verrucosus, Genista sylvestris, Onobrychis viciifolia, Vicia grandiflora, Gentiana pannonica, Tilia platyphyllos, Sanguisorba minor, Salix alpina. Tra i funghi, ricordiamo almeno che si deve a Scopoli l'eponimo dell'ovolo reale Amanita caesarea (per lui, Agaricus caesareus), calco del nome volgare tedesco della Carniola Kaiserling. In due volumi, l'opera è illustrata da 66 tavole incise da F. Rein a partire da disegni dello stesso Scopoli. Anche negli anni slovacchi, così ricchi di pubblicazioni, non mancarono pene e contrarietà. Scopoli subì la perdita della seconda moglie Caterina de' Franchenfeldt; fu costretto a lavorare in un laboratorio umido e angusto che, oltre a mettere a dura prova la sua salute, era del tutto inadatto alle lezioni; la commissione di corte per i minerali gli proibì di pubblicare senza uno specifico permesso. Ma soprattutto la sua carriera era di nuovo bloccata; in una lettera a Linneo del 1773, lamenta che von Jacquin, che in precedenza gli era tanto amico, ora non vuole più avere nulla a che fare con lui e lo ostacola in tutto. Quando all'Università di Vienna venne istituita una seconda cattedra di storia naturale, accanto a quella di chimica e botanica tenuta appunto da von Jacquin, fece domanda per ottenerla, ma gli fu preferito l'oscuro farmacista viennese Jacob Well. Nel 1776 si risolse così ad accettare la cattedra di botanica e chimica all'Università di Pavia, dove incominciò ad insegnare nel 1777. Tra i suoi compiti la direzione dell'orto botanico, che era stato istituito nel 1773 nell'ambito delle riforme dell'insegnamento universitario promosse in Lombardia dal plenipotenziario degli Asburgo conte Firmian. Scopoli ne fece regolarizzare la superficie, creò due arboreti, rispettivamente ad est dell'edificio che ospitava il laboratorio di chimica e a nord delle serre in legno fatte costruire dal suo predecessore Valentino Brusati. Lo spazio centrale fu diviso in aiuole regolari separate da viali. La tradizione vuole che nel 1778, per commemorare l'amato Linneo, abbia fatto piantare l'esemplare di platano (Platanus x hispanica) che oggi costituisce l'albero più venerabile del giardino. Grazie ai suoi molti corrispondenti (all'epoca era membro di innumerevoli società scientifiche) inserì il nuovo giardino nel circuito internazionale degli orti botanici, accrescendone notevolmente le collezioni attraverso scambi. La sistemazione dell'orto botanico e del laboratorio di chimica lo distolsero per qualche tempo da nuove pubblicazioni, tanto più che era impegnato nella traduzione del Dizionario di chimica di Macquer. Ambiva però a pubblicare una grande opera illustrata, con la descrizione di specie rare e inedite; il progetto si tradusse nella raffinata e costosa ultima opera di Scopoli, Deliciae florae et faunae insubricae, in tre parti (1786-1788), una rassegna illustrata di animali, piante e minerali, in parte raccolti da lui stesso durante le sue escursioni naturalistiche in Lombardia o da allievi e corrispondenti, in parte coltivati nell'orto botanico o conservati nelle collezioni museali; vi pubblicò anche mammiferi e uccelli esotici raccolti da Pierre Sonnerat durante i suoi viaggi. Nel terzo e ultimo volume incluse un'autobiografia (Vitae meae vices, ovvero "Le vicissitudini della mia vita"). Deliciae florae et faunae insubricae, per altri aspetti pregevole, segnò la fine di Scopoli, che, nella smania di pubblicare, di tenere alta la propria fama internazionale, magari con uno scoop naturalistico, incappò in un madornale errore; nel 1785, mentre era alla ricerca di materiali curiosi e soprattutto inediti per la prima serie, fu avvicinato da un sedicente medico di campagna che gli offrì uno " singolarissimo verme" conservato sott'alcool; a suo dire, lo aveva vomitato una donna piemontese poco prima del parto. Con la bocca aperta e due tubi divergenti, era davvero mai visto e entusiasmò Scopoli che si affrettò a farlo disegnare e lo pubblicò nel primo fascicolo come Physis intestinalis, con tanto di dedica a Joseph Banks. Il povero Scopoli era stato vittima di un truffatore (o forse di una beffa): non si trattava di un verme, ma di un artefatto, la trachea e l'esofago di una gallina con la parte inferiore cucita. La verità sarebbe venuta a galla tre anni dopo, in seguito a uno squallido episodio in cui, purtroppo, il nostro protagonista fece una pessima figura. Fin dal suo arrivo a Pavia, si era delineata una forte tensione con un altro scienziato universale, Lazzaro Spallanzani, titolare della cattedra di scienze naturali e creatore del Museo di scienza naturale dell'Università, al quale lo stesso Scopoli vendette una parte delle sue collezioni; Spallanzani ne aveva controllato il catalogo, rilevando diverse mancanze, con grande disappunto del nostro, che in tal modo passava per ladro o imbroglione. C'era poi una rivalità scientifica: Scopoli era un sistematico, un catalogatore linneano, per il quale il compito principale della scienza era catalogare la natura, e la massima aspirazione era aggiungere un nuovo tassello alla lista; Spallanzani era un fisiologo, attento soprattutto alle funzioni e ai meccanismi fisiologici. Si aggiunga l'antipatia personale, alimentata dal dileggio dell'emiliano Spallanzani per il "dialetto germanico-italico" del trentino Scopoli. Fu certamente quest'astio a spingere quest'ultimo a divenire parte attiva di una vera e propria congiura ordita dal custode del Museo naturale, Giovanni Serafino Volta (omonimo e non parente di Alessandro, all'epoca rettore dell'Università), il quale, approfittando dell'assenza di Spallanzani, che era andato a Costantinopoli in viaggio di studio, lo accusò di essersi impadronito di diversi esemplari del Museo per arricchire la propria collezione privata. Rivelò la sua presunta scoperta, oltre che a Scopoli, al medico e anatomista Antonio Scarpa, titolare della cattedra di anatomia, e al matematico Gregorio Fontana, direttore della biblioteca universitaria; nell'estate del 1786 i quattro inviarono una denuncia sia al governo imperiale della Lombardia sia alla Commissione ecclesiastica degli studi (Spallanzani era infatti abate). Scopoli si incaricò di informare del fattaccio urbi et orbi, scrivendo una lettera circolare che fu inviata ai membri delle università italiane e a personalità della scienza e della cultura europea: certamente in buona fede, ma accecato dal rancore vide nella vicenda la "mano di Dio", che aveva ritorto la stessa accusa infamante contro colui che l'aveva ingiustamente accusato di furto. All'epoca Pavia era la più quotata università italiana; l'accusato era illustre, e lo erano altrettanto almeno due degli accusatori, Scarpa e Scopoli. Lo scandalo era dunque clamoroso. Le autorità austriache si affrettarono ad ordinare un'inchiesta, diretta del plenipotenziario Wilczeck; Spallanzani fu del tutto scagionato con tanto di editto imperiale, che allontanò Volta e ammonì i tre professori per "per il danno arrecato alla reputazione di Spallanzani, accusandolo senza prove sufficienti", per essersi fidati ciecamente delle false affermazioni di Volta. Ma, purtroppo per Scopoli, anche se conservò la cattedra, la storia non finì lì. Nel 1788, vennero pubblicate due lettere al "signor Dottore Scopoli", datate da Zoopoli, a firma di una certo dottor Francesco Lombardini bolognese. Anche se egli lo negò sempre, l'autore era Spallanzani che, nel tono più beffardo, coprì Scopoli di ridicolo per aver scambiato le viscere di un pollo per un inedito verme intestinale. Il vaso con il "verme singolarissimo" sparì prontamente dal Museo, ma ormai il danno era fatto. Travolto dal discredito, l'8 maggio 1788, mentre si celebrava la festa di san Pio, in onore di papa Pio V, fondatore del Collegio Ghislieri, il povero Scopoli si accasciò per un ictus sotto il portico dell'Istituto.  Dediche botaniche Insomma, il destino giocò con Scopoli fino alla fine, preparandogli una morte al tempo stesso tragica e grottesca, di cui si spiacque ormai troppo tardi anche lo stesso Spallanzani. La sgradevole vicenda non intaccò per altro la stima per una luminosa carriera scientifica, costellata di più di cinquanta pubblicazioni con contributi originali in tutti i campi che aveva toccato. Per limitarci alla botanica, Flora carniolica è ancora oggi una pietra miliare, per aver avviato lo studio della flora della Slovenia e più in generale delle Alpi orientali. Nella tassonomia botanica, celebrano Scopoli l'eponimo di due specie soprattutto balcaniche, Arabis scopoliana e Senecio scopolii, una centro europea ma presente anche in Italia, Scrophularia scopolii; recentissima è la dedica di Hieracium scopolii, endemismo del monte Lesima tra Piacenza e Pavia. A dedicare al naturalista trentino un genere Scopolia furono in parecchi; ad aprire le danze fu Adanson (che tra l'altro Scopoli ammirava moltissimo: entrambi aspiravano a un sistema naturale); seguirono von Jacquin, i Forster, il figlio di Linneo, James Edward Smith. Tutti nomi di peso che attestano la sua fama europea. Poiché la denominazione di von Jacquin era più nota di quella di Adanson, tanto da essere fatta propria da Linneo, è quella conservata (nomen conservandum); e non si tratta di una dedica da poco. Nella prima edizione di Flora carniolica Scopoli descrisse una pianta che "vive in tutti i boschi ombrosi nei pressi di Idria" con la seguente diagnosi: "Atropa caule herbaceo, foliis ovatis interis, calycibus erectis, fructu capsulari" (belladonna con fusto erbaceo, foglie ovate intere, calici eretti, frutto a capsula). La mise poi a confronto con Atropa belladonna, chiarendone con grande precisione caratteristiche comuni e differenti. Tre anni dopo von Jacquin, che da poco si era trasferito a Banská Štiavnica ad occupare la cattedra che poi sarebbe stata di Scopoli, individuò in questa specie un nuovo genere, che dedicò opportunamente allo scopritore: "Scopola carniolica. Questa pianta che nasce spontaneamente nei boschi ombrosi di Idria, se non erro, fu scoperta e descritta per primo da Giovanni Antonio Scopoli, medico di Idria e indefesso cultore della storia naturale; poiché mi pare richieda assolutamente un nuovo genere, l'ho chiamata Scopola dal suo scopritore". Come si vede, von Jacquin chiamò il nuovo genere, scorrettamente, Scopola, senza i. Sembra che il nome spiacesse a Scopoli, visto che in veneziano una scopola è uno schiaffone. Nel 1767 Linneo aggiustò le cose, modificando la denominazione in Scopolia, anche se come eponimo, visto che attribuì la specie al genere Hyoscyamus come H. scopolia. Velenosissima, è una delle tre specie di questo genere delle Solanaceae, che sembra in effetti collocarsi a metà tra i generi Atropa, che ricorda per il rizoma, le foglie e i fiori, e Hyoscyamus, che ricorda per i frutti. E' probabile che ben prima che Scopoli la "scoprisse", fosse ben nota a guaritrici e fattucchiere; secondo alcune fonti, fin dal tardo Medioevo era utilizzato come narcotico, anestetico e ingrediente di filtri amorosi, oltre che per scopi criminali; contiene infatti diversi alcaloidi (iosciamina, atropina, scopolamina), con proprietà simili a quelle della belladonna. Del resto, nel 1554 era già stata descritta da Mattioli che l'aveva raccolta sul monte Sabotino quando viveva a Gorizia e la pubblicò come Solanum somnificum alterum. Nel 1824, Ernst A. Schmidt dell'università di Marburg estrasse dal rizoma di Scopolia carniolica il principio attivo chiamato scopolamina, un alcaloide con effetti narcotici ed allucinogeni, estremamente tossico anche in piccole dosi. Nell'Ottocento, ebbe un certo uso come anestetico, tanto che la società slovena di anestesiologia ha scelto Scopolia carniolica come proprio simbolo, anche se il suo uso è stato abbandonato da tempo. Nella seconda metà del Novecento la scopolamina venne usata come componente del siero della verità dalla CIA e da altre agenzie, finché si capì che altera talmente la percezione della realtà da dare risultati inaffidabili. Scopolia carniolica è diffusa in modo discontinuo nell'Europa centro-meridionale e sud-orientale, in particolare nei Carpazi e nella penisola balcanica; è presente anche altrove (Germania, Danimarca, Ucraina, Russia), ma potrebbe essere stata introdotta come pianta medicinale, importante nell'Ottocento per l'estrazione di atropina e scopolamina. Anche la sua distribuzione in Italia è disgiunta: la si trova infatti nel Biellese e in poste stazione delle Prealpi Giulie lungo il confine con la Slovenia. Endemica di quest'ultima è la rara S. carniolica var, hladnikiana. Le altre specie sono S. caucasica, nativa del Caucaso settentrionale, e S. japonica, presente in Corea e Giappone. Per finire, un ultimo omaggio... cartaceo. Per celebrare colui che è indubbiamente il fondatore dello studio della flora slovena, l'organo del Museo di scienze naturali di Lubiana è stato battezzata "Scopolia". A partire dalla seconda metà del Settecento, l'Università di Vienna acquisì grande rinomanza per la sua scuola di medicina. Il merito spetta all'olandese Gerard van Swieten, che, nominato archiatra dell'imperatrice Maria Teresa, trapiantò nella capitale austriaca gli insegnamenti del suo maestro Boerhaave, riformando profondamente il fino ad allora arretrato insegnamento della medicina. Tra i suoi meriti, anche l'introduzione della chimica e della botanica nel curriculum dei futuri medici e la fondazione dell'orto botanico universitario di Vienna. Il suo allievo Nikolaus von Jacquin, che tanto gli doveva anche a livello personale, volle ricordarlo dedicandogli Swietenia, il genere cui appartengono gli alberi da cui si ricava il bellissimo mogano.  Un medico riformatore A Vienna, al centro della piazza omonima, campeggia il gigantesco monumento all'imperatrice Maria Teresa d'Austria, voluto da Francesco Giuseppe per celebrare la sua antenata e insieme le glorie dell'impero austriaco. La sovrana è assisa sul trono, al sommo di un alto pilastro in granito, ciascuno dei cui lati è ornato da un timpano con un gruppo ad alto rilievo ed una statua indipendente, che rievocano i quattro settori in cui eccelse l'Austria dei lumi: la politica, l'amministrazione, le armi, le scienze e le arti. A rappresentare queste ultime nel rilievo il numismatico Joseph Hilarius Eckhel, lo storico György Pray e i musicisti Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart bambino; davanti a loro la statua dell'archiatra Gerard van Swieten (1700-1772), fondatore della scuola di medicina di Vienna, che dell'imperatrice non fu solo il medico personale, ma ascoltatissimo consigliere e anima di molte riforme non solo in campo medico. Eppure egli non era né austriaco né suddito imperale, ed aveva accettato il prestigioso incarico con estrema riluttanza. Olandese, era nato a Leida in una famiglia cattolica di origini nobili. Iniziò gli studi nella città natale in modo brillante, ma a 12 anni perse il padre, un affermato notaio che lavorava soprattutto per una clientela cattolica. Inviato dai suoi tutori a studiare filosofia a Lovanio, si appassionò di scienze naturali. Avrebbe voluto studiare medicina a Leida, ma al momento non ne aveva la possibilità economica. Così a 15 anni fu messo a bottega ad Amsterdam presso il farmacista Laurens Tatum; tuttavia nel 1717 contrasse il vaiolo e, una volta guarito ritornò a Leida; ne approfittò immatricolarsi nella facoltà di medicina, in quegli anni dominata dal grande Boerhaave, un medico famoso in tutta Europa, che insegnava medicina, chimica, botanica e dirigeva l'orto botanico universitario. Fu così folgorato dalla sua versatile sapienza e dal suo metodo innovativo (Boerhaave fu il primo a portare i suoi studenti al capezzale dei malati, creando di fatto la medicina clinica) che per anni, anche quando era già lui stesso medico, continuò a seguire le sue lezioni (si dice ne abbia persa solo una). Tra il 1718 e il 1720 completò la formazione come farmacista presso Nicolaas Stam, decano della corporazione dei farmacisti e ottimo chimico (suo padre David era stato il maestro di chimica di Boerhaave), ottenendo la licenza nel 1720. Senza interrompere gli studi di medicina, aprì una propria bottega a Leida e nel 1725 si laureò con una tesi sulle arterie e le loro funzioni. Per qualche tempo affiancò le due attività di farmacista e medico, ma del 1727 si concentrò sulla medica e prese anche ad impartire lezioni private di chimica e medicina, finché nel 1734 gli venne vietato dall'Università. Come medico aveva un'ampia clientela ed era molto stimato, tanto che nel 1738, quando morì Boerhaave, sarebbe stato il più indicato a succedergli: ma ciò era impossibile, in quanto cattolico. Ne aveva seguito le lezioni fino alla morte, e nel 1742 iniziò a pubblicare i suoi aforismi con i propri commenti (Commentaria in Hermani Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, "Commenti sugli aforismi di Boerhaave su come diagnosticare e curare le malattie"); l'opera, arricchita con la sua personale pratica clinica, l'avrebbe accompagnato per tutta la vita, fino all'ultimo volume, uscito nel 1772. La sua fama intanto aveva travalicato i confini dell'Olanda; nel 1742 morì l'archiatra imperiale e, su raccomandazione del futuro cancelliere von Kaunitz, che all'epoca amministrava i Paesi Bassi austriaci e aveva sentito parlare della sua competenza professionale e della sua indipendenza di pensiero, il posto fu offerto a van Swieten che inizialmente rifiutò, scrivendo a un amico che preferiva rimanere "un piccolo repubblicano piuttosto che portare un titolo pomposo che nasconde un'esistenza da schiavo". La diplomazia imperiale però continuò a lavorarlo ai fianchi, finché, dopo un anno e mezzo, nell'ottobre 1744, forse soprattutto considerando che, come cattolico, aveva poche prospettive di carriera in patria, cedette, e da repubblicano si fece monarchico. Subito dopo l'accettazione, fu chiamato a Bruxelles, per assistere la sorella minore di Maria Teresa, governatrice dei Paesi Bassi, mai ripresasi dopo aver dato alla luce un bimbo nato morto. Purtroppo van Swieten non poté salvarla, ma non perse perciò la fiducia dell'imperatrice. Nel maggio 1745, dopo aver venduto i propri beni olandesi, si trasferì a Vienna con la famiglia; infatti, nel frattempo si era sposato con Maria ter Beeck van Coesfelt, anch'essa figlia di un notaio e sorella di un antico compagno di scuola di Lovanio, e ne aveva avuto cinque figli; la sesta, chiamata Maria Teresa, in onore della sovrana, sua madrina, sarebbe nata a Vienna. Van Swieten, le cui idee innovative (nonché i modi borghesi) erano tutt'altro che graditi a cortigiani e maggiorenti austriaci, godette della stima e dell'assoluta fiducia della sovrana; oltre che archiatra, fu nominato prefetto della biblioteca imperiale e nel 1749 gli fu affidata la riforma della facoltà di medicina dell'Università di Vienna, all'epoca molto arretrata e dominata dai gesuiti e dalla corporazione dei medici. Come preside della facoltà, Van Swieten, oltre a tenere egli stesso conferenze di fisiologia e medicina generale nella biblioteca di corte, rinnovò il corpo insegnante; dotò l'università di aule e strutture adeguate; istituì le cattedre di medicina teorica, medicina pratica, anatomia, chirurgia, chimica e botanica; rinnovò totalmente la conduzione degli ospedali di Vienna, trasformati in veri e propri centri di ricerca in cui furono create classi di medicina strutturate, dove gli studenti completavano la loro formazione al capezzale dei malati, imparavano a redigere una diagnosi motivata e assistevano alle autopsie. Tra i suoi maggiori collaboratori in campo medico, un altro olandese, Anton de Haen (1704-1776), da lui chiamato a reggere la cattedra di medicina pratica, che fu, tra l'altro, il primo a introdurre il controllo regolare della temperatura corporea e l'uso del termometro. Nel 1751, come bibliotecario imperiale, van Swieten fu nominato presidente della commissione di censura, dalla quale esautorò i gesuiti, cercando, anche se non sempre con successo, di analizzare i libri sulla base di criteri razionali, come l'utilità e la rilevanza scientifica. Nel 1752 l'Università divenne un'istituzione statale e riforme furono introdotte anche nelle facoltà di teologia, filosofia e giurisprudenza. L'imperatrice, che lo ascoltava anche in altri campi, nel 1755 gli affidò un'inchiesta su un preteso caso di vampirismo avvenuto in Moravia; van Swieten dimostrò che si trattava di una superstizione e in Abhandlung des Daseyns der Gespenster ("Discorso sull'esistenza dei fantasmi") diede una spiegazione scientifica dei vari fenomeni all'origine del mito; il risultato fu un decreto imperiale che vietava antiche pratiche macabre come esumare e trafiggere o bruciare i cadaveri dei supposti vampiri. Si dice che Bram Stoker si sia ispirato a lui per il personaggio del cacciatore di vampiri van Helsing del suo romanzo Dracula. La creazione dell'orto botanico di Vienna si inquadra nella generale azione riformatrice di van Swieten. Prima di lui all'università di Vienna non si insegnavano né la botanica né la chimica; inoltre, l'università non disponeva di edifici adeguati. Gradualmente, durante la sua gestione furono creati un anfiteatro anatomico, un laboratorio chimico, una clinica di facoltà e appunto un orto botanico, istituito nel 1754 in un'area di un ettaro sul Rennweg, adiacente al palazzo di Belvedere. Concepito come Hortus medicus, era destinato all'insegnamento della botanica applicata a medici e farmacisti e vi era annesso il laboratorio di chimica. Il progetto e la sistemazione delle piante vennero affidati al francese Robert Laugier (1722-1793), primo titolare della cattedra di chimica e botanica fin dal 1749, e poi primo direttore dell'orto botanico, che fece sistemare le aiuole didattiche secondo il sistema di classificazione di Boissier de Sauvages basato sulla forma delle foglie. Laugier diresse il giardino per una quindicina di anni, finché van Swieten, che ne aveva scarsa stima (gli rimproverava l'insufficiente conoscenza del latino e, come amico e corrispondente di Linneo, certo poco apprezzava il sistema di Sauvages), riuscì a costringerlo alle dimissioni, convincendo l'imperatrice a tagliargli lo stipendio: aveva infatti pronto per rimpiazzarlo un botanico di ben altro valore: il suo conterraneo, allievo e protetto Nikolaus Joseph von Jacquin, secondo prefetto dell'orto botanico e titolare delle cattedre di chimica e botanica dal 1768. Gli ultimi anni di van Swieten furono funestati, oltre che da un serie di malattie (nel 1772, in seguito a un tumore, subì anche l'amputazione di una gamba), dallo scontro con il figlio maggiore di Maria Teresa, divenuto imperatore come Giuseppe II nel 1765 in seguito alla morte del padre Francesco Stefano di Lorena. Egli infatti imputava al medico olandese la morte delle due mogli e delle due uniche figlie: nel 1763 la prima moglie era morta di vaiolo insieme alla secondogenita neonata, nel 1767 sempre di vaiolo era morta anche la seconda, mentre nel 1770, l'adorata figlia maggiore Maria Teresa era morta di pleurite ad appena otto anni. Quale fosse la responsabilità del vecchio medico in queste tragedie non saprei, ma certo egli inizialmente si era opposto all'inoculazione del vaiolo, una pratica ancora molto rischiosa. Il vaiolo lo era anche di più: tra le vittime di questa malattia implacabile ben cinque dei sedici figli dell'imperatrice; solo dopo la morte della sedicenne arciduchessa Maria Giuseppina, van Swieten si convinse e scrisse a William Pringle, il medico di Giorgio III, chiedendo di inviare a Vienna un medico esperto per inoculare il vaiolo all'intera famiglia imperiale. La scelta cadde su un altro olandese, Jan Ingenhousz, che aveva già inoculato con successo i famigliari di Giorgio III. Dopo aver brillantemente espletato il suo compito, rimase a Vienna come medico imperiale e qui completò i suoi studi in cui gettò le basi della comprensione del meccanismo della fotosintesi. Va dunque ascritto a merito di van Swieten aver portato a Vienna, oltre a de Haen e von Jacquin, anche questo dotatissimo connazionale. Il figlio maggiore Gottfried si illustrò in altri campi. Dapprima diplomatico, poi prefetto della biblioteca imperiale e presidente della commissione di censura dopo il padre, è celebre soprattutto per i suoi interessi musicali. Ambasciatore a Berlino negli anni '70, commissionò sei sinfonie a Carl Philipp Emanuel Bach, che gli dedicò una delle sue opere più famose, la terza raccolta delle Sonate per intenditori ed appassionati; a Berlino inoltre raccolse molti manoscritti di Bach e Händel, che poi fece regolarmente eseguire nei concerti domenicali che si tenevano nella biblioteca di corte, influenzando profondamente tanto Mozart quanto Haydn. Nel 1780, proprio nell'intento di far conoscere e diffondere la musica degli antichi maestri, fondò la Società dei cavalieri associati, per la quale tra il 1789 e il 1790 Mozart arrangiò diversi opere di Händel, tra cui il Messiah, che il salisburghese diresse più volte al clavicembalo. Alla sua morte, fu van Swieten a pagarne il funerale, quindi organizzò la prima esecuzione del Requiem, tenuta come concerto di beneficenza a favore della vedova e dei figli. Van Swieten figlio ebbe stretti rapporti anche con Haydn, per il quale scrisse i libretti della Creazione e delle Stagioni, e con il giovane Beethoven, che gli dedicò la prima sinfonia.  Il mogano, un legname troppo sfruttato Nikolaus von Jacquin non mancava mai di ricordare coloro che in un modo o in un altro lo avevano aiutato nelle sue ricerche; non poteva certo dimenticare il suo maestro, colui che gli aveva aperto la strada di Vienna e aveva gettato lo basi della sua carriera scientifica. Per onorarlo degnamente, scelse una pianta speciale: quella da cui si ricava il più ricercato e bello dei legnami, il mogano. Linneo, come i botanici dell'epoca, pensava che avesse qualche affinità con i cedri e lo collocò nel genere Cedrela come C. mahagoni. Von Jacquin lo assegnò al nuovo genere Swietenia, come S. mahagoni (1760). Questo grande albero delle Antille all'epoca era l'unica specie nota, o almeno fino all'inizio dell'Ottocento si pensava che le variazioni che si riscontravano nel legname proveniente da altre zone fossero dovute al suolo o alle condizioni di crescita, finché nel 1837, studiando esemplari raccolti durante una spedizione nella costa pacifica del Messico, Zuccarini ne identificò una seconda specie di dimensioni minori che chiamò S. humilis. Infine nel 1886, George King, il sovrintendente dell'orto botanico di Calcutta, ne identificò una terza specie, proveniente dall'Honduras e appunto coltivata in quel giardino, e la denominò S. macrophylla. Sono queste le tre specie del genere (famiglia Meliaceae), abbastanza simili tra loro, ma presenti in areali diversi e solo in parte contigui: S. mahagoni è esclusivo della Florida meridionale e delle Antille (Bahamas, Cuba, Giamaica, Hispaniola); S. humilis occorre lunga la costa pacifica dal Messico all'America centrale; S. macrophylla, infine, la specie di maggiore diffusione, vive invece lungo la costa atlantica di Messico e America centrale e si spinge in Sud America fino all'Honduras, alla Bolivia e al Brasile. Sono alberi da medi a grandi (il maggiore, S. mahagoni, può superare i quaranta metri, con un tronco dal diametro di due metri), piuttosto ramificati, con foglie pinnate, da decidue a semi sempreverdi, a seconda dell'area di crescita; i fiori, raccolti in infiorescenze lasse, sono piccoli, con cinque petali ovati da bianchi a verde giallastro; i frutti invece sono grandi capsule legnose più o meno ovoidali che si aprono in cinque valve e contengono numerosissimi semi alati. Gli europei probabilmente conobbero il mogano, o almeno il suo legname, fin dal loro arrivo nelle Antille. Si dice che sia fatta di mogano una croce, datata 1512, conservata nella cattedrale di Santo Domingo, così come alcuni arredi dell'Escorial del tempo di Filippo II. Gli spagnoli però lo utilizzarono soprattutto per le costruzioni navali, e anche nei possedimenti francesi delle Antille fu scarsamente sfruttato. A lanciarne la voga furono dunque gli inglesi, soprattutto dopo il 1721, quando un decreto del Parlamento britannico eliminò i dazi per il legname importato dalle Indie britanniche. Nel corso del secolo, divenne uno dei legnami più apprezzati per ebanisteria, mobili e finiture di prestigio, tanto in Gran Bretagna quanto nelle Tredici colonie; il 90% arrivava dalla Giamaica, il resto dalle Bahamas, con piccoli contributi da altre isole, cui, dopo la temporanea occupazione di Cuba durante la guerra dei Sette anni, si aggiunse anche quest'isola. Attraverso le colonie britanniche, ci è giunto anche il nome mogano. Mentre in spagnolo l'albero - ma anche il suo legname - veniva (e viene) chiamato caoba, un nome derivato da una lingua dei Caraibi, e in francese acajou, dalla lingua tupi, nelle Antille britanniche incominciò ad essere noto come mahogany, una parola dall'etimologia discussa. La spiegazione più diffusa, ma non certo accettata da tutti, la fa risalire a m’oganwo, un nome che gli sarebbe stato dato dagli schiavi neri giamaicani per la sua somigliano con un albero africano (Khaya ivoriensis), chiamato in yoruba oganwo, ovvero "re del legno". Come che sia, il commercio del mogano americano, che nell'Ottocento si estese anche alle altre due specie, divenne così imponente da mettere a rischio la sopravvivenza di questi alberi; il mogano delle Antille era già raro all'inizio del Novecento, e un secolo dopo anche quello centro e sudamericano era avviato sulla stessa strada. Oggi tutte e tre le specie sono incluse nella lista rossa delle piante minacciate; nel 1975 Swietenia humilis è stato inclusa nell'Appendice II CITES (la lista delle piante a rischio di estinzione senza una stretta regolamentazione), seguita nel 1992 da S. mahagoni e nel 2003 da S. macrophylla. Questa è di fatto l'unica specie oggi di una qualche importanza commerciale; dopo che nel 2001 il Brasile ne ha vietato l'esportazione, il maggior produttore è divenuto il Perù, da cui proviene circa il 74% della produzione mondiale, purtroppo in gran parte tagliata illegalmente nella foresta amazzonica. La coltivazione di S. macrophylla, in seguito alle crescenti restrizioni del commercio del mogano americano, alla fine del Novecento è stato introdotta in vari paesi asiatici (India, Bangladesh, Indonesia) e nelle Fiji, ma queste piantagioni sono ancora recenti, con alberi giovani: ecco perché il commercio illegale continua. La soluzione più sostenibile è dunque non acquistare prodotti ricavati dal legname di questi alberi minacciati. D'altro canto nelle Filippine, dove sia S. mahagoni sia S. macrophylla sono state introdotte all'inizio del Novecento, sono considerate specie invasive, con un impatto negativo sul suolo e la biodiversità naturale. Dunque anche l'introduzione al di fuori della loro area d'origine non è senza rischi. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|
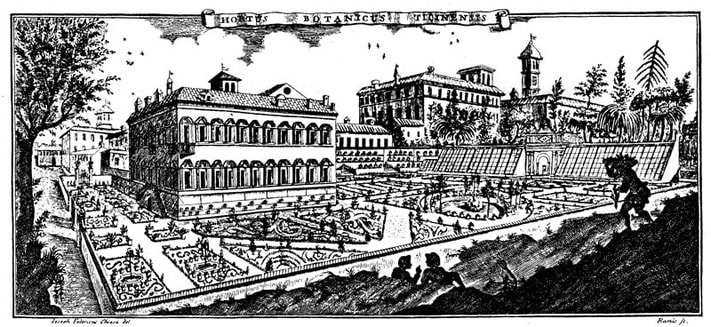

 RSS Feed
RSS Feed