|
Nel 1696, il frate francescano Francesco Cupani pubblica lo straordinario Hortus Catholicus: è il catalogo delle circa 3000 tra specie e varietà che crescevano nello splendido giardino di Misilmeri, voluto da Giuseppe del Bosco principe di Cattolica. Accanto alle officinali di prammatica, c'erano le specie sicule, molte delle quali raccolte di persona da Cupani, assiduo esploratore della flora dell'isola, e le esotiche più rare, giunte in Sicilia grazie alla rete di corrispondenti italiani e europei abilmente coltivata dal botanico francescano. Rimase invece incompleta e inedita l'ultima opera di Cupani, l'ancor più grandioso Panphyton siculum. Il confratello Plumier volle ricordarlo con il genere Cupania, cui più tardi si affiancò Cupaniopsis. Al suo allievo Bonanno, che tentò di completarne l'opera inedita, è invece toccato il monotipico Bonannia. 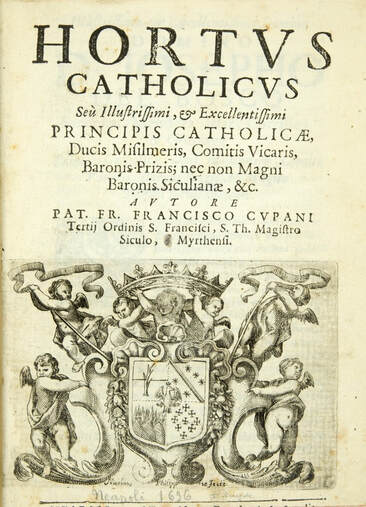 Un giardino straordinario e il suo catalogo Intorno al 1690, Giuseppe del Bosco, principe di Cattolica, decise di trasformare in orto botanico il Giardino Grande del suo palazzo di Misilmeri, a una quindicina di km da Palermo; già esistente almeno dal XV secolo, godeva di acque abbondanti grazie a una vicina sorgente. Non conosciamo nei particolari la genesi del progetto, che voleva anzitutto venire in soccorso delle genti bisognose del feudo attraverso la coltivazione di piante medicinali utili, ma è probabile che sia stato determinante l'incontro con il frate francescano Francesco Cupani (1657-1710), che da qualche anno si stava dedicando all'assidua esplorazione della flora siciliana. Nato a Mirto in provincia di Messina, come riferisce egli stesso nel prologo di Hortus Catholicus, Cupani inizialmente studiò medicina a Palermo, appassionandosi soprattutto di botanica; tuttavia a 24 anni entrò nel terzo ordine francescano, e lasciò lo studio della natura per la filosofia e la teologia, che in seguito insegnò prima a Verona poi a Palermo. La passione per le piante, relegata a svago marginale, si riaccese con forza al ritorno in Sicilia, alimentata dalla frequentazione di medici e speziali come Ignazio Arceri, medico del Regio nosocomio palermitano, e l'aromataro Nicola Gervasi (1632-1681), console del Collegio dei farmacisti e autore dell'Antidotarium Panormitanum Pharmaco-Chimico; di quest'ultimo, che Cupani definisce affettuosamente praceptor meus, "mio maestro", egli loda il giardino palermitano ricchissimo di piante rare. Ma la spinta determinante venne dall'esempio di Paolo Silvio Boccone, suo modello e assiduo corrispondente, che lo incoraggiò a proseguire le ricerche sulla flora indigena. Frutto di quattro anni di erborizzazioni, sfidando il caldo estremo dell'estate e i geli dell'inverno, è la prima opera edita di Cupani, Catalogus plantarum sicularum noviter adinventarum, pubblicata a Palermo nel 1692. Sono appena quattro pagine, con una lista di circa 150 piante in ordine alfabetico; secondo l'uso del tempo Cupani si avvale di nomi-descrizione polinomiali; ad esempio, l'attuale Euphorbia pithyusa subsp. cupanii figura come Tithymalus exiguus, pumilus, saxatilis, Portulaceae foliolis, flosculis rubentibus. A conclusione della lista, in una breve nota il francescano esprime la speranza di poter presto pubblicare le immagini delle piante, a meno che non lo faccia per lui il reverendo Silvio Boccone "famosissimo per la competenza erboristica", al quale ha inviato generosamente tutti gli exsiccata "mosso dall'onore della patria". Al momento dell'uscita del catalogo, il principe di Cattolica gli aveva già affidato la realizzazione del giardino di Misilmeri, in cui alle piante medicinali tanto native quanto esotiche si sarebbero affiancate ornamentali, piante esotiche rare, alberi da frutto e orticole. Per le piante medicinali e autoctone, il frate si avvalse della collaborazione di farmacisti ed erboristi come Pietro Citraro e Francesco Scaglione, nonché degli invii di numerosi corrispondenti che vivevano in parti dell'isola non esplorate di persona; ma continuò anche il lavoro sul campo, tanto che già nel 1694 fu in grado di stampare una seconda lista di piante siciliane, Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum, pubblicata sempre a Palermo, in cui le specie e varietà elencate sono salite a 300. Intanto il giardino cresceva grazie alla munificenza del principe, che lo trasformò in un luogo fatato con statue, fontane e addirittura uno zoo con animali esotici; lo circondava un muro coronato da oltre 600 vasi di piante esotiche, quasi un'anticipazione della ricchissima collezione di piante che racchiudevano. A farle arrivare in Sicilia fu una vasta rete di corrispondenti italiani ed europei che Cupani mise insieme forse con la mediazione iniziale di Boccone. Tra i corrispondenti più assidui troviamo infatti uno dei contatti di Padre Silvio, William Sherard, che a sua volta fece da tramite con botanici, appassionati e collezionisti britannici, gli inviò piante esotiche in cambio di semi siciliani, gli procurò libri (tra gli altri, Historia plantarum di John Ray). Determinante per la crescita del giardino fu poi Giovanni Battista Trionfetti, il curatore dell'orto botanico della Sapienza a Roma, che poté far giungere a Misilmeri le novità che affluivano a Roma grazie a gesuiti e sacerdoti viaggiatori. Tra i corrispondenti di Cupani troviamo molti altri grandi nomi della botanica del tempo: lo stesso Ray, Pitton de Tournefort, Caspar Commelin, i tedeschi Johann Georg Volkamer e Johannes Böhm. Questi scambi epistolari, oltre ad arricchire il giardino, consentirono al botanico siciliano di superare l'isolamento di una località periferica e di tenersi aggiornato sui progressi della botanica e sui grandi dibattiti del suo tempo, procurandosi i testi di riferimento indispensabili per catalogare le piante del giardino; nella nota di autorità premessa a Hortus Catholicus, egli elenca ben 90 titoli, tra i quali, oltre a testi già classici della botanica rinascimentale o del primo Seicento, troviamo libri di pubblicazione recente o recentissima, come il catalogo delle piante canadesi di Cornut (1635), Flora sinica di Boym (1656), la Centuria e il Prodromus di Breyne (rispettivamente 1678 e 1680), il catalogo delle piante olandesi di Jan Commelin (1683), i primi sei volumi di Hortus Malabaricus (1678-1686), il catalogo dell'orto botanico di Montpellier di Magnol (citato nella seconda edizione di Hortus Catholicus, e uscito lo stesso anno 1697). Come si vede, si tratta principalmente di cataloghi di orti botanici e di rassegne di flore esotiche: il problema principale che si poneva Cupani, come si evince anche dalla corrispondenza con Sherard, era infatti la corretta identificazione, per evitare di presentare come nuove piante già pubblicate in precedenza. Nonostante la grande mole di piante da identificare e descrivere, già nel 1696 Cupani fu in grado di dare alle stampe la prima edizione di Hortus Catholicus, accompagnata da un primo supplemento e seguita l'anno dopo da un secondo. E' un'opera imponente, che elenca circa 3000 tra specie e varietà; per le identificazioni e le denominazioni, Cupani rimase fedele all'insegnamento di Boccone, scegliendo una soluzione un po' datata: come punto di riferimento principale per l'identificazione dei generi (il concetto, anche se in modo ancora impreciso, si andava ormai affermando) si affidò all'autorità di Robert Morison, e al suo sistema basato sulla fruttificazione (che in qualche modo poteva essergli familiare, visto che anche Castelli, maestro del suo praeceptor Gervasi, si era basato sui frutti); per le specie e le denominazioni, oltre a Morison stesso, all'ancora più datato Pinax di Caspar Bauhin e all'Historia plantarum di Jean Bauhin. Come nelle liste precedenti, anche in Hortus Catholicus le piante si susseguono in ordine alfabetico, da Abies alba a Yucca. Per quelle già note, tipicamente Cupani parte dalla denominazione del Pinax, seguita, se differenti, da quelle di Jean Bauhin e di Morison; la voce si conclude (e questa invece è una novità) con il nome vernacolo siciliano, nel desiderio di allargare la conoscenza delle piante anche a chi non leggeva il latino. A mo' di esempio, ecco la voce iniziale (corrispondente a Abies alba Mill): Abies alba, seu foemina CBP [ovvero Caspar Bauhin Pinax], sive elate Thilia IB [ovvero Jean Bauhin], vulgo Erva di S. Filippu, o Arvulu cruci, Arvulu caccia diavuli. Ovviamente, se la pianta nel Pinax non compare, Cupani ricorre ad una o più altre autorità, ad esempio per l'attuale Hibiscus mutabilis L. a Paul Hermann, Morison e Ferrari: Althaea arborea, Rosea, Sinensis, flore multiplici HLB [Hermann, Hortus logduno-batavus], Althaea arborea, Sinensis Moris. Hist. 2 [Morison, Historia universalis Oxoniensis vol. 2], Rosa sinensis Ferrari Florae cult. vulgo Rosa Indiana. Per le piante non descritte in precedenza, Cupani usa una denominazione polinomiale, costituita dal nome generico seguito da uno o più epiteti. A tale proposito, si è spesso detto che egli abbia anticipato Linneo, facendo largo uso di nomi binomiali. Lasciando da parte i binomi ripresi da Bauhin (che a sua volta è ritenuto l'inventore dei nomi binomiali, ma non li usò in modo sistematico), vediamo se è vero con un esempio, tratto ancora dalla lettera A. Oltre a sei specie di Acetosa già descritte dai Bauhin e/o da Morison, Cupani ne descrive cinque nuove: "Acetosa Nebroides Arisari pallido-virenti folio", "Acetosa peregrina, lanceolata, vesiculis trigonis, venis sanguineis inscriptis", "Acetosa alienigena caule carens, sterilis, radice nimio reptatu, foecunda", "Acetosa lanceolato folio, e basi lata polyfido, Etnensis", "Acetosa montana angusto folio sagittae". Si tratta, evidentemente, di nomi descrizione polinomiali; anzi, nella secondo supplemento, Cupani esprime la sua perplessità di fronte a nomi troppo brevi che, egli teme, impedirebbero il riconoscimento proprio delle specie nuove. Per dirlo in altri termini, la separazione tra denominazione e descrizione, che Linneo stesso raggiungerà solo in Species plantarum, non è ancora avvenuta. Infatti, in Bibliotheca botanica, lo svedese collocò Cupani non certo tra gli innovatori o i sistematici, ma tra i curiosi, ovvero "coloro che raccolsero piante prima del tutto ignote o mal conosciute e le illustrarono con descrizioni e immagini". Il merito maggiore di Cupani sta ovviamente nell'esplorazione della flora siciliana, di cui fu instancabile raccoglitore e descrittore, segnando un passo avanti notevolissimo anche rispetto a Boccone. Da segnalare è anche l'attenzione alle produzioni agricole locali e soprattutto alle varietà delle piante fruttifere, che ne fanno un antesignano della pomologia: ad esempio, sono elencate e puntigliosamente descritte 35 varietà di mandorli, 48 di fichi, 45 di meli, 73 di peri, 48 di viti, 20 di limoni, 21 di aranci, 5 di cedri. Mentre scriveva Hortus Catholicus, Cupani già pensava a un progetto ancora più ambizioso: una vasta opera illustrata che avrebbe fatto conoscere al mondo la natura siciliana, descrivendo non solo le piante, ma anche gli animali, le conchiglie, i fossili, i minerali. Secondo quanto scrive nel prologo della prima edizione di Hortus Catholicus, intorno al 1696 il lavoro era già abbastanza avanzato: erano state incise 600 delle 800 lastre di rame previste (a pagarle fu evidentemente il generoso principe di Cattolica, che contava di trarre gloria europea dal munifico investimento); per quanto riguarda le piante era sua intenzione specificarne la denominazione secondo le indicazioni dei Bauhin e di Morison, il luogo di origine, le proprietà officinali, l'etimologia, i sinonimi in latino, il nome volgare, il segno celestiale, l'astro dominante e l'epoca più indicata di raccolta. Nel supplemento dell'anno successo, ci informa che ormai le lastre erano tutte pronte e il manoscritto a buon punto, tanto che contava, Dio volendo, di completarlo in pochi mesi. Ma, evidentemente, Dio non volle: il lavoro di raccolta e verifica si prolungò più del previsto e nel 1710 Cupani morì prematuramente, a poco più di cinquant'anni, lasciando l'opera incompleta. Torneremo più avanti sulla sorte di quell'opera sfortunata, per soffermarci sulle vicende successive del giardino di Misilmeri. Morto Cupani, che lo aveva fondato e diretto per quasi vent'anni, la direzione passò successivamente a due suoi collaboratori, Pietro Citraro e Francesco Scaglione. Nel 1714 ricevette la visita di Vittorio Amedeo II, appena divenuto re di Sicilia. Tuttavia nel 1721 Giuseppe del Bosco morì senza lasciare eredi diretti, e le proprietà e i feudi passarono al figlio di una sorella, Francesco Bonanno del Bosco. Nel corso del Settecento, i Bonanno sperperarono il patrimonio familiare. A risentirne fu anche lo splendido ma dispendioso giardino, via via sempre più trascurato. Intorno alla metà del secolo, ebbe ancora un sussulto, grazie all'arrivo da Padova dell'abile capo giardiniere Giovanni Maria Lattini, ma quando questi lasciò l'incarico, insoddisfatto del salario, il declino divenne inarrestabile. Nel 1785, all'atto della fondazione dell'orto botanico di Palermo, con il benestare del principe in carica, 2000 piante tra le più rare furono espiantate e traslate nel nuovo giardino, insieme a vasche di marmo, sedili di pietra e altro materiale. Da quel momento dell'antico Hortus Catholicus del principe Giuseppe del Bosco e di Francesco Cupani rimase solo il ricordo.  Da Cupania a Cupaniopsis A testimoniare il ruolo di Cupani nella scoperta delle piante sicule sono le diverse specie che lo ricordano nell'epiteto, come Colchicum cupanii, Genista cupanii, Aira cupaniana e la già citata Euphorbia pithyusa subsp. cupanii. Tributo alla fama europea del giardino e del suo creatore è invece la dedica del genere Cupania da parte di Plumier, che cita il giardino "ricchissimo di piante fatte venire dalle più remote contrade del mondo" nonché il suo "ordinatissimo catalogo". Poi validato da Linneo, il genere Cupania, della famiglia Sapindaceae, esclusivo dell'America tropicale, dal Messico all'Argentina, con centro di diversità in Brasile, comprende circa 60 specie di alberi e arbusti, che vivono in vari habitat, dalle foreste stagionalmente aride alle foreste pluviali. Benché presentino sia fiori femminili sia fiori maschili sulla stessa pianta, sono funzionalmente dioiche e poligame, poiché i fiori staminati (maschili) e quelli nettariferi (femminili) si aprono in momenti diversi. Hanno foglie composte alternate, con nervature molto evidenti, generalmente coriacee, spesso con faccia superiore glabra e inferiore tomentosa; i fiori, piccoli, con cinque petali e cinque sepali, sono raccolti in grandi infiorescenze spesso molto ramificate e sono seguiti da capsule che contengono semi arillati. Tra le specie di maggiore diffusione, citiamo C. cinerea, originaria delle foreste umide dalla Costa Rica al Brasile, a volte coltivata come ornamentale; particolarmente notevoli i frutti, che a maturazione si aprono formano una stella coriacea con al centro semi neri avvolti in un arillo aranciato. Per la sua chioma elegante, è spesso utilizzata nelle alberature anche C. vernalis, diffusa dalla Bolivia al Brasile e all'Argentina settentrionale. A celebrare indirettamente Cupani, si è aggiunto il genere Cupaniopsis ("simile a Cupania"), stabilito da L.A.T. Radlkofer nel 1879. Anch'esso appartenente alla famiglia Sapindaceae, raggruppa una quarantina di specie di alberi e arbusti diffusi in Nuova Guinea, in Australia e nelle isole del Pacifico; ricorda Cupania per le foglie composte e i frutti a capsula. Purtroppo molte piante di questo genere, endemiche di piccole aree, sono minacciate, in pericolo di estinzione o addirittura già estinte, come C. crassivalvis della Nuova Caledonia, dichiarata estinta nel 1998. La specie più nota è l'australiana C. anacardioides, nota con il nome vernacolare tuckeroo. E' un piccolo albero originario delle foreste litoranee dell'Australia orientale e settentrionale. Più che al momento della fioritura, diventa spettacolare al momento della fruttificazione, quando produce grandi grappoli di capsule aranciate che si aprono in tre lobi, rivelando i semi scuri ricoperti da un arillo arancio brillante; sono appetiti da numerose specie di uccelli. Per la sua bellezza, anche questa specie è spesso utilizzata nelle alberature stradali, soprattutto nelle zone costiere vista la sua tolleranza alla salinità.  Un'opera maledetta e una pianta tossica Per concludere, resta ancora da raccontare della sorte dell'ultima opera inedita di Cupani. Nel 1713, probabilmente per volontà del principe, sotto il titolo Panphyton siculum vennero stampate le sole immagini, con una tiratura di poche copie (se ne conoscono in tutto sette), per altro diverse tra loro, tanto da fare pensare a prove di stampa. I manoscritti furono invece affidati, perché li completasse e li preparasse per la stampa, al farmacista Antonio Bonanno, nei testi d'epoca spesso chiamato Antonino, figlio di Vincenzo, uno dei collaboratori di Cupani, e di una figlia di Nicola Gervasi (per questo motivo, è anche noto come Bonanno Gervasi). Bonanno riuscì a rivedere e predisporre un primo volume, con 187 tavole, che fu stampato nel 1719, ma lo stesso anno morì. Come abbiamo già visto, nel 1721 morì anche il principe, e con la sua morte ebbe fine ogni tentativo di pubblicare quell'opera sfortunata. I manoscritti furono ereditati da un'altra famiglia di farmacisti imparentata con i Bonanno, i Chiarelli, che custodirono gelosamente una copia di Panphyton Siculum in quattro volumi, appartenuta a Antono Bonanno con le sue annotazioni manoscritte, e 16 volumi di note manoscritte di Cupani. Desideravano pubblicarli, ma mancavano le risorse finanziarie. Il momento giusto sembrò arrivare quando entrarono in contatto con il botanico statunitense Rafinesque, che visse in Sicilia dal 1805 al 1815. Deciso a far risorgere il Panphyton, da lui ribattezzato Panphysis sicula, fece approntare copie delle incisioni e cercò di coordinare i suoi sforzi con quelli dei Chiarelli, ma poi anche lui dovette rinunciare. Nel 1815, quando ripartì dall'America, portò con sé le 121 tavole di incisioni che era riuscito a far preparare; al largo del Connecticut si inabissarono nelle acque dell'oceano, insieme alla biblioteca di Rafinesque e circa 60 casse di collezioni; il botanico salvò la vita, ma dovette ricominciare dal nulla. Non stupisce che egli abbia voluto ricordare il tentativo dell'altrettanto sfortunato Bonanno; nel 1814 pubblicò su un giornale siciliano, Specchio delle scienze, il genere Bonannia (Sapindaceae) con queste parole "Questo genere ha gran somiglianza con Cupania [...]; gli ho perciò dato il nome di Bonannia in onore di Antonino Bonanni Gervasi, discepolo ed illustratore del P. Cupani, e del P. Filippo Bonanni gesuita, autore di una conchilogia". Pubblicato su una rivista locale, il nuovo genere passò inosservato. Come nomen rejicendum, è oggi sinonimo di Blighia. Nel 1826, fu la volta del boemo Presl che in Flora Sicula creò un secondo genere Bonannia (Brassicaceae), in onore tanto di Vincenzo quanto di Antonio Bonanno "coetanei e discepoli del reverendo Cupani". Oggi è sinonimo di Brassica. Infine, nel 1843 Gussani in Florae Siculae Synopsis creò un terzo genere Bonannia (Apiaceae); anche se non lo cita esplicitamente, il riferimento a una tavola del volume curato da Bonanni, fa presumere che il dedicatario sia sempre lui; benché sia l'ultimo arrivato, fu accettato dalla comunità scientifica ed è tuttora valido come nomen conservandum. Si tratta di un genere monotipico, rappresentato dalla sola B. graeca, una rara erbacea dei pascoli montani aridi, presente in Sicilia dal Messinese al Palermitano, in Calabria nella Sila e nel Pollino e in poche località sparse in Grecia e nell'Egeo. E' un'erbacea perenne, alta fino a 30 cm, con foglie basali lanceolate e foglie cauline ridotte a guaine, e fiori gialli riuniti in ombrelle. Tutta la pianta emana una resina giallastra tossica, che può causare la morte degli agnelli.
0 Comments
Nel 1638, il medico e botanico romano Pietro Castelli ottiene dal senato di Messina il terreno e i finanziamenti per creare l'orto dei semplici universitario. E' il primo della Sicilia, anzi del Sud Italia, guarda al modello di Padova, ma due elementi lo rendono unico: la disposizione delle piante, per la prima volta sistematica, e l'attenzione alla flora endemica con le piante provenienti dalle pendici dell'Etna. Di colpo, Messina diventa una delle capitali europee della botanica, e gli allievi di Castelli Boccone e Cupani ne metteranno a frutto gli insegnamenti. A ricordarlo il genere monotipico Castellia, la cui unica rappresentante è presente in Italia solo in pochissime località di Sicilia e Sardegna.  Anni romani L'orto botanico "Pietro Castelli" di Messina fu il primo della Sicilia e dell'Italia meridionale; a fondarlo nel 1638 fu il romano Pietro Castelli (1583-1661) che abbiamo già incontrato in questo post, a proposito della paternità dell'opera sugli orti farnesiani Exactissima descriptio. Il senato accademico lo aveva chiamato a Messina ad occupare la prima cattedra di medicina; malgrado all'epoca avesse già pubblicato molto e fosse da anni un personaggio di spicco dell'ambiente medico-botanico romano, la sua vita fino a quel momento presenta molti punti oscuri, a iniziare dalla stessa data di nascita. A. De Ferrari, nella voce a lui dedicata nel Dizionario biografico degli italiani (che è anche la biografia più ampia del nostro) lo dice nato a Roma "tra il 1570 e il 1575 da Francesco e Diana de Giorgi". Erik Neil, in un interessante articolo sulla nascita dell'Hortus messanensis, fa notare che la data sembra piuttosto alta se consideriamo che pubblicò le prime opere intorno al 1620, ovvero tra i 50 e i 45 anni; possiamo aggiungere che al suo arrivo a Messina avrebbe superato la sessantina. Il mistero della data di nascita può essere facilmente sciolto se identifichiamo il padre Francesco Castelli con il pittore fiammingo Frans van de Casteele o Kasteele, attivo a Roma almeno dagli anni '70 del Cinquecento e noto come Francesco de Castelli. Dalla voce a lui dedicata dal Dizionario biografico, scritta da Nicole Dacos, risulta che sua moglie si chiamava Diana de Giorgis e che la coppia ebbe tre figli: Pietro nel 1583, Michele nel 1587, Stefano nel 1595. C'era anche una sorella, Caterina Castelli, che nel 1603 sposò un altro fiammingo romanizzato, Hendrik De Raef, che a Roma si faceva chiamare Enrico o Arrigo Corvino e gestiva la celebre farmacia "All'aquila imperiale". La parentela non è sfuggita agli storici dell'arte e ai biografi della nipote, la notevole miniatrice Maddalena Corvina, figlia di Enrico e Caterina, che collaborò tra l'altro al trattato De Florum cultura di Giovanni Battista Ferrari, ma soprattutto è confermata dallo stesso Pietro Castelli che nel 1621 dedicò una delle sue prime opere, Discorso della durazione de medicamenti tanto semplici quanto composti, "alli molto illustri signori li SS. Francesco Castelli e Diana de Georgi, padre e madre miei carissimi"; segue un ditirambo che funge da epitaffio al padre, morto nell'ottobre di quell'anno. Frans van de Casteele era un pittore piuttosto noto, più volte eletto principe dell'Accademia di San Luca; poté quindi garantire al figlio maggiore una buona educazione. Pietro studiò medicina all'università di Roma, dove ebbe tra i suoi maestri Andrea Bacci, Marsilio Cagnati e Andrea Cesalpino, certamente il più influente e venerato, tanto che in Hortus Messanensis lo celebra come "medico, peripatetico e semplicista illustrissimo, e amorevolissimo maestro nostro". Una seconda figura di riferimento fu certamente il cognato Enrico Corvino che in Exactissima descriptio è definito "insigne farmacopio e botanico" ed è citato con elogio e affetto in Hortus Messanensis. La farmacia di Corvino era un punto di incontro dei naturalisti romani, frequentato tra l'altro da Federico Cesi, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, e dall'erudito e collezionista Cassiano dal Pozzo. Grazie agli insegnamenti di Bacci e Cesalpino, e agli incoraggiamenti del cognato, Castelli dovette incominciare a farsi un nome come semplicista, ovvero come esperto di piante officinali; scrivendo di sé stesso in Hortus messanensis (pubblicato nel 1640) dice "40 anni continui ho fatto il maestro de' semplici in Roma e altrove", quindi più o meno dall'inizio del secolo; il che significa che probabilmente insegnava botanica privatamente. Improbabile che abbia terminato gli studi nel 1594, come afferma De Ferrari; certo si laureò entro il 1615, data in cui è indicato come medico nell'archivio di S. Lorenzo in Lucina. Nel 1619, presso Mascardi (l'editore dei Lincei) pubblicò la sua prima opera edita Defensio antiquorum utentium Arsenico et Sandaraca, che gli diede una certa rinomanza europea. E' il primo degli undici titoli pubblicati presso lo stesso editore fra il 1619 e il 1634, di argomento prevalentemente farmacologico, ma anche botanico, come le epistole De Elleboro (1622) in cui dimostrò che negli scritti di Ippocrate quando si parla di elleboro si fa riferimento a quello bianco (Veratrum album) e non a quello nero (Helleborus niger). In una data imprecisata divenne medico personale di Lelio Biscia (1573-1638), collezionista e mecenate delle arti, una figura influente dei pontificati di Paolo V e Urbano VIII, che lo fece cardinale nel 1626. Su sua sollecitazione scrisse un trattato sulle eruzioni del Vesuvio (Incendio del Monte Vesuvio, 1632) e annotazioni all'Antidotario romano, nella cui prefazione ricorda con riconoscenza che il cardinale gli procurò "un luogo nel fioritissimo studio di Padova con amplo stipendio". Nulla sappiamo del soggiorno padovano di Castelli, neppure se precede o segue l'incarico di lettore dei semplici presso la Sapienza che giunse nel 1625-26 grazie alla protezione del cardinale Francesco Barberini; nel 1629, alla morte di Johannes Faber, da "simplicista straordinario", che dimostrava i semplici i giorni festivi, divenne "simplicista ordinario", ovvero insegnante teorico di medicina e botanica; nel 1627 le sue lezioni trattarono i sintomi, nel 1628 le urine, nel 1629 le malattie infantili, nel 1630 i libri I e II di Dioscoride, nel 1631 i minerali. Faber era stato anche direttore dell'orto botanico pontificio e non è chiaro se Castelli gli subentrò anche in questo incarico. Diversi studiosi sostengono di sì, ma da un'amara lettera inviata anni dopo da Messina a Cassiano dal Pozzo sembrerebbe che gli sia stato preferito Tobia Aldini: "essendo io in Roma lettor de Semplici, ero senza Horto, hora ho l’horto e non la lettura de semplici [...]. Dunque Tobia [ha] l’Horto". E aggiunge "Roma non mi volse ne per Teorico ne per Prattico". A me sembrerebbe escluderlo anche il frontespizio di Hortus messanensis, in cui Castelli esibisce orgogliosamente tutti i suoi titoli; mentre si proclama "primo prefetto e fondatore dell'orto botanico universitario", per il periodo romano si descrive come "nell'arciginnasio romano dapprima lettore di filosofia, quindi di medicina e dei semplici"; certo non avrebbe passato sotto silenzio un incarico così prestigioso come la direzione dell'orto dei semplici pontificio. 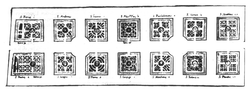 Un orto botanico senza uguali Come che sia, gli sembrava che la sua carriera romana fosse giunta a un punto morto, tanto che nel 1634 decise di accettare una cattedra di medicina all'ateneo di Messina, benché quella città di paresse "l'estremo d'Italia e del mondo". Dovette giungervi nell'aprile 1635, come risulta da una lettera a Cassiano dal Pozzo datata Messina li 12 d’Aprile 1635. Quasi subito iniziò la sua battaglia con il senato per ottenere la creazione di un orto botanico: "arrivato che qui fui, considerando quanto era necessario l'Horto de' semplici per compimento dello Studio, per correggere gli errori che potevano occorrere dall'ignoranza, e il danno che per difetto dei semplici era imminente, ne feci più volte istanza all'illustrissimo senato". La richiesta fu infine accolta nel 1638, con l'assegnazione di un terreno di considerevoli dimensioni (circa 580 metri x 50) situato nel fossato all'esterno delle vecchie mura e compreso tra due ponti preesistenti, il Ponte di Porta Imperiale e il Ponte della Porta della Maddalena; gli spazi sotto i ponti furono adattati per ospitare un laboratorio di chimica, un museo naturalistico e una cappella, mentre dai ponti stessi i cittadini potevano godere una vista panoramica del giardino anche durante le ore di chiusura. I più antichi documenti esistenti risalgono all'agosto 1638 e riguardano un anticipo di 100 onze per lavori murari. Nella progettazione presumibilmente fu coinvolto l'architetto e ingegnere della città di Messina Giovanni Antonio Ponzello che negli stessi creò il Teatro marittimo o Palizzata, che ridisegnò il lungomare e le vie d'accesso, con lo smantellamento delle mura di cinta liberando tra l'altro lo spazio del fossato poi occupato dal giardino; quest'ultimo, con le sue eleganti aiuole barocche, divenne così parte integrante di quel progetto complessivo che ridisegnava la città in forme aperte, ordinate e esteticamente ricercate. Stretto ed allungato, il giardino comprendeva 14 hortuli o parterres più o meno quadrati, ciascuno intitolato a un santo e a sua volta suddiviso in aiuole dalle eleganti forme geometriche con sentieri che convergevano al centro dell'hortulus, occupato da una vasca per le piante acquatiche. Più che in queste forme, indubbiamente ispirate all'orto padovano e volute, forse più che da Castelli, dal Senato ("questi signori si sono risoluti di fare un horto di semplici `a gara di quello di Padova", scrive in una lettera all'amico Cassiano), l'originalità del progetto sta nella disposizione delle piante. Mentre negli altri orti botanici coevi esse erano solitamente raggruppate in base alle loro virtù medicinali, Castelli adottò un criterio sistematico, suddividendole in quattordici classi sulla base dei frutti e in qualche caso la disposizione dei fiori, secondo l'insegnamento del suo maestro Cesalpino. Iniziando dall'hortulus I S. Petri troviamo le specie con un solo seme Unisemina; quindi nel II con un solo loculo Univascula; III con due semi Bisemina; IV con silique Siliquosa; V con tre semi Trisemina; VI con due loculi Bivascula; VII erbacee con quattro semi Quadrisemina herbacea; VIII con tre loculi Trivascula; IX legnose con quattro semi Quadrisemina surculosa; X con molti loculi Multivascula; XI con capolini Capitata; XII con corimbi Corymbifera; XIII a corona Coronaria; XIV con spine o aculei Aculeata. Una quindicesima classe era costituita da felci, muschi e piante acquatiche, poste nella vasche al centro di ogni parterre. Al di là delle semplici etichette, non sappiamo però quali piante fossero assegnate a ciascuna categoria, dato che nel catalogo che conclude Hortus Messanensis le piante sono elencate in ordine alfabetico e divise in tre gruppi di natura differente: semplici, orticole e fruttiferi, selvatiche. L'anatomista danese Thomas Bartholin che visitò il giardino nel 1644, quindi poco dopo il suo completamento, lo lodò in tono entusiastico, riferendo che, oltre a piante medicinali di ogni tipo, vantava anche piante esotiche tra cui persino un baobab. Castelli se le era procurate in primo luogo ricorrendo al cognato Enrico Corvino e, dopo la sua morte nel 1639, al nipote Francesco Corvino; molte piante gli furono poi inviate dallo speziale Girolamo Cardo di Francavilla, suo compagno di escursioni sull'Etna e molte le raccolse egli stesso nelle sue erborizzazioni sulle pendici del vulcano. Era infatti la flora etnea a rendere unico il giardino di Messina, anche se Castelli mobilitò tutti i suoi contatti per arricchirlo di piante esotiche e rare: "[mi hanno somministrato] altri amici da altre parti, e molte n'aspetto, onde spero tra pochissimo tempo dover avere un fioritissimo Horto de semplici, un Horto Hesperide, un Paradiso Terrestre". E, stando alla testimonianza di Bartholin, ma anche di altri visitatori inclusi Francis Willughby e John Ray, ci riuscì. Castelli era molto orgoglioso della sua creatura, che curava personalmente e da cui sperava di ottenere tanta gloria da essere richiamato a Roma; scriveva infatti al solito dal Pozzo che, sebbene a Messina ricevesse uno stipendio di 1000 once, e molte di più ne ottenesse come medico, "più volentieri starei in Roma per 300". E così si affretto a dare alle stampe la descrizione e il catalogo del giardino (Hortus messanensis, 1640), dedicato al papa Urbano VIII, e continuò a scrivere opere di medicina e farmacologia, "pur voglio, che per il Mondo si sappia che son vivo, non cessando dar gran voci, e risonanti bombi con le mie stampe". Ma senza esito: rimase a Messina fino alla morte nel 1661. Il magnifico giardino che aveva creato purtroppo ebbe breve vita. Ancora fiorente quando vi lavorò Malpighi, andò totalmente distrutto in seguito alla rivolta dei messinesi contro il dominio spagnolo del 1674. Infatti, quando gli spagnoli ripresero la città nel 1678, per spregio lo trasformarono prima in un pascolo per i cavalli dell'esercito poi in un campo di bietole. Bisognò attendere più di due secoli perché l'università di Messina avesse nuovamente un orto botanico. Ma nel frattempo l'insegnamento di Castelli aveva lasciato buoni frutti in un folto gruppo di discepoli: il medico Domenico Bottone, il farmacista, chimico e botanico Niccolò Gervasi, il pittore e "curioso della natura" Agostino Scilla. I due grandi botanici della generazione successiva, Paolo Silvio Boccone e Francesco Cupani, anche se non furono suoi allievi diretti come spesso si pretende, certo risentirono l'eco del suo insegnamento.  Una rara graminacea mediterranea Non a caso fu un botanico siciliano, Vincenzo Tineo, a sua volta grande esploratore della flora siciliana, a dedicare al suo illustre predecessore uno dei due nuovi generi contenuti nei tre fascicoli di Plantarum rariorum Siciliae minus cognitarum, Castellia (Poaceae). E' un genere monotipico rappresentato da un'unica specie, l'annuale Castellia tuberculosa. E' una modesta graminacea che può ricordare il loglio, con ciuffi di foglie piane, lunghe fino a 20 cm, da cui emergono i culmi eretti, rigidi, alti fino a un metro, che culminano in un'infiorescenza con racemi semplici o un poco ramificata in basso, con spighette solitarie, disposte lungo la rachide in due serie laterali; la caratteristica più spiccata è il lemma arrotondato, quasi interamente ricoperto nella pagina dorsale da piccoli tubercoli uncinati e appiattiti lateralmente. In Italia è rara ed inclusa nella lista rossa delle piante a rischio; è presente solo nella Sardegna occidentale presso Cuglieri e a Linosa nell'arcipelago delle Pelagie. Specie di habitat aperti e aridi, è distribuita dalle Canarie all'Iran, passando per la sponda meridionale del Mediterraneo. Negli anni decisivi in cui il Chelsea Physic Garden, grazie alla generosità di Hans Sloane e alla sapienza orticola dell'inarrestabile capo giardiniere Philip Miller, si trasforma da hortus medicus, ancora per lo più riservato alle piante medicinali, in un grande orto botanico di acclimatazione delle esotiche, a guidarlo come dimostratore e praefectus è il farmacista Isaac Rand, cui si devono una gestione accorta, i primi cataloghi, l'apertura agli artisti che vengono a ritrarre dal vivo le piante delle sue aiuole. Lo ricorda il genere Randia (Rubiaceae), omaggio di Houstoun validato da Linneo. 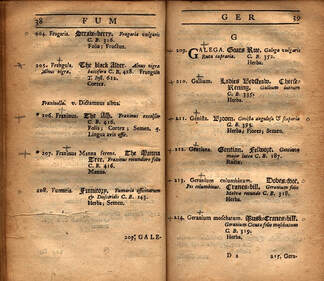 Una gestione accorta ed efficente Nel 1718, alla morte di James Petiver, prese il suo posto come dimostratore del giardino dei farmacisti di Chelsea il suo collega Isaac Rand (1674–1743) che già da qualche anno lo affiancava nelle attività didattiche. Rand era figlio d'arte e godeva di ottima reputazione come botanico. Il padre James Rand faceva parte della commissione che nel 1674 aveva deciso di proteggere il giardino con un muro di cinta; il figlio ne rilevò l'attività e intorno al 1700 gestiva una farmacia sull'Haymarket. Doveva essersi appassionato di botanica durante l'apprendistato, ed è citato da diversi botanici della generazione precedente per il suo occhio di lince, capace di scovare piante fino ad allora mai notate anche in zone molto battute. In Almagesti botanici mantissa (1700) Plukenet lo ricorda per aver scoperto nei Tothill Fields a Westminster la pianta che oggi si chiama Rumex palustris e lo definisce "farmacista londinese diligentissimo indagatore delle piante e botanico di belle speranze". A Doody invece segnalò un'altra specie di Rumex, R. maritimus, che cresceva nei luoghi umidi vicino a Burlington House. Adam Buddle gli attribuisce la scoperta di Mentha dumetorum (sin. M. pubescens) lungo le rive di certi stagni presso Marybone e Petiver quella di Oxybasis glauca (sin. Chenopodium glaucum) che battezzò in suo onore "blito quercino di Rand". Di Buddle e dei colleghi Doody e Petiver doveva essere compagno di scorribande botaniche, che evidentemente avevano per teatro la stessa Londra e le immediate vicinanze, quelle dove insieme allo stesso Petiver guidava gli herborizing degli apprendisti farmacisti. Nella società dei farmacisti divenne presto un elemento di primo piano; nel 1707 lo troviamo tra i membri della commissione incaricata di valutare il mantenimento del giardino, per fare sopravvivere il quale fece una donazione e affittò persino una parte del terreno. Assistente e successore di Petiver, si trovò poi alla guida del giardino in un momento decisivo della sua storia. Come ho raccontato in questo post, nel 1722 sir Hans Sloane prese il Physic Garden sotto le sue ali protettrici, cedendo in perpetuo alla Worshipful Society il terreno del giardino in cambio di un affitto simbolico e della fornitura di 50 esemplari d'erbario alla Royal Society. Lo stesso anno, su suggerimento dello stesso Sloane, fu assunto anche Philip Miller. Fu Rand a gestire il delicato cambio di gestione, e di vocazione, del giardino, che, da orto dei semplici dove si coltivava anche qualche esotica, in seguito all'obbligo di fornire ogni anno cinquanta esemplari di specie esotiche preferibilmente inedite veniva trasformato in giardino botanico di acclimatazione che guardava sempre più ai modelli di Leida e Parigi. Nel 1725 Rand divenne il primo direttore ufficiale del Chelsea Physic Garden e dal 1733 portò il pomposo titolo Horti Praefectus et Praelector Botanicus Chelseiani, in cui si uniscono le funzioni amministrativa e didattica: come già Petiver prima di lui, suo compito era infatti, oltre a guidare gli herborizing, tenere almeno due lezioni in horto al mese nella stagione estiva. Fu incaricato di stendere un progetto di miglioramento del giardino; approvato dalla Società dei farmacisti, ottenne il sostegno finanziario di Sloane, che convinse sia il Collegio dei medici sia la Royal Society a versare un contributo; ne seguirono grandi trasformazioni, con la costruzione di un’aranciera, che ospitava anche una biblioteca e una sala per le riunioni, di alloggi per il prefetto e il capo giardiniere, di una serra fredda e di due serre riscaldate con un sistema di riscaldamento dal basso. La prima pietra di questi nuovi edifici fu posta ovviamente da Sloane nel 1732. Tra i compiti di Rand c'era anche aumentare e documentare le collezioni. Teneva i contatti con altri orti botanici, in particolare con quello di Leida, con il quale intensificò il programma di scambi. Era lui a occuparsi della preparazione degli esemplari da consegnare alla Royal Society, il primo gruppo di cinquanta dei quali, debitamente etichettato, fu presentato nel marzo del 1723. Gli si deve il primo catalogo, 57 anni dopo la fondazione del giardino; pensato per la formazione degli apprendisti, elenca 518 specie officinali, specificando quali parti vanno utilizzate. Meno legato alla originaria vocazione di hortus medicus è il secondo catalogo, pubblicato nel 1739, in cui vengono elencate circa mille piante raggruppate in 749 generi Rand capì anche quanto potesse essere utile documentare le piante affiancando all'ormai tradizionale erbario immagini di buona qualità. Quando il medico Alexander Blackwell finì in carcere per debiti, incoraggiò la moglie Elizabeth a stabilirsi vicino al giardino e a frequentarlo liberamente, per ritrarre le piante esotiche dal vivo (il risultato fu A Curious Herbal che permise alla coppia di uscire dalla loro situazione disperata). Un altro artista protetto da Rand fu il tedesco Dyonisius Ehret che si legò anche più a Chelsea quando sposò la cognata di Philip Miller. Non ultimo merito di Rand fu riuscire a tenere a bada l'irrefrenabile capo giardiniere. Dopo la sua morte (1743) e quella dell'immediato successore Joseph Miller (prefetto dal 1743 al 1746), la Società dei farmacisti rinunciò a nominare un prefetto, affidando la gestione a un comitato che ben poco poteva di fronte all'esuberanza del testardo Miller. Rand si ricordò dell'amato giardino anche nel testamento, lasciandogli in eredità la sua biblioteca botanica, 22 volumi di erbario e un lascito di 50 sterline annue destinato al rinnovamento dell'erbario del dimostratore con esemplari freschi.  Gardenie spinose Rand era amico di Mark Catesby e fu tra i sottoscrittori di Natural History of Carolina; doveva godere almeno della stima di William Houstoun visto che - sebbene ancora vivo - risulta tra i dedicatari di uno dei 14 nuovi generi creati dal chirurgo scozzese in Plantae Houstonianae. Randia (Rubiacaeae) fu poi validato da Linneo; in precedenza un vasto genere pantropicale, è stato ristretto fondamentalmente all'America tropicale e subtropicale, dagli Stati Uniti meridionali all'Argentina, con un centinaio di specie di arbusti, liane e piccoli alberi. Continuano a farne parte anche tre specie australiane (le altre sono state state trasferite al genere Atractocarpus) che però appaiono abbastanza diverse da quelle americane. Per lo più dioiche, con fiori dei due sessi su piante diverse, sono arbusti o piccoli alberi sempreverdi o caducifogli, spesso armati di spine, con foglie opposte o raggruppate in verticilli agli apici dei rami. I fiori, uniti in cime o grappoli all'ascella delle foglie o solitari all'apice di brevi rametti, hanno calice troncato, dentato o lobato, tubo corollino cilindrico con cinque lobi, che in boccio si presenta ritorto. I frutti sono bacche succulente che contengono molti semi. Il centro di diversità è probabilmente il Messico, con una quarantina di specie. Ma qualcuna si spinge anche negli Stati Uniti meridionali, come R. aculeata, una delle più diffuse, con un areale che dalla Florida raggiunge la Colombia, passando per il Messico e le Antille. E' un piccolo albero, sempreverde o deciduo in base alla piovosità, con rami quasi orizzontali, molto spinosi, foglie verde brillante quasi ovali, bei fiori bianchi a stella con cinque lobi seguiti da bacche tondeggianti biancastre a maturazione (da cui il nome white indigoberry), molto apprezzate dagli uccelli, la cui polpa in passato veniva usata per produrre un colorante blu. Tra le australiane, merita una segnalazione R. moorei, un arbusto o alberello originario dell'estremità nordorientale del Nuovo Galles del Sud e delle aree adiacenti del Queensland. Anch'essa è spinosa, a volte anche lungo il tronco, ha foglie largamente ovoidali con apice acuto. Porta fiori bianchi molto profumati, raggruppati in gruppi di tre all'apice dei rami o lungo i rami stessi che le hanno guadagnato il nome di spiny gardenia, "gardenia spinosa". Le bacche, dapprima giallo aranciato, diventano nere a maturazione. Rara, è minacciata dalla progressiva distruzione del suo ambiente naturale, il sottobosco della foresta pluviale su suolo basaltico. La sua appartenenza al genere Randia è per altro discussa e ne è stato proposto lo spostamento in Xeromphis. Altre informazioni nella scheda. Il secondo orto botanico inglese nasce un po' per caso nel 1673 per volontà della Corporazione dei farmacisti londinesi. Siamo ancora lontani dalle future glorie: gli inizi sono confusi e contrastati, con la Corporazione sempre indecisa se continuare o meno quell'impresa rivelatasi troppo dispendiosa. Per qualche anno, a dirigere il giardino è il farmacista Samuel Doody, amico e compagno di scorribande botaniche di Buddle e Petiver, specialista di crittogame, stimato anche da John Ray. La dedica del genere di felci Doodia appare dunque quanto mai appropriata.  Un inizio travagliato Il secondo orto botanico inglese nacque un po' per caso, oltre mezzo secolo dopo il primo, quello di Oxford. A prendere l'iniziativa fu la Corporazione londinese dei farmacisti (Worshipful Society of Apothecaries), nell'ambito di un lungo braccio di ferro legale con il Collegio dei medici. Gli statuti reali concedevano alla Worshipful society ampia autonomia e la facoltà di addestrare ed esaminare i propri membri, che erano ammessi alla professione dopo un tirocinio in bottega di otto anni, durante il quale imparavano a riconoscere i semplici, a preparare i medicamenti e a somministrarli correttamente. Non erano però autorizzati a prescriverli, compito riservato ai soli medici autorizzati. Tuttavia, la rapida crescita della popolazione londinese e le ricorrenti epidemie resero insufficiente il numero di questi ultimi, e la società dei farmacisti ricorse alla legge per veder riconosciuto ai propri membri il diritto legale di praticare la medicina di base: dopo anni, la battaglia fu infine vinta nel 1704, quando la Camera dei Lord si pronunciò a favore dei farmacisti contro l’ordine dei medici; il diritto della Corporazione londinese dei farmacisti di impartire un'istruzione medica primaria e di concedere licenze professionali a chirurghi, ostetriche e ginecologi sarebbe perdurato fino al 1999. Per accreditarsi agli occhi dei tribunali e dei Lord, la Corporazione doveva dimostrare la competenza professionale dei propri membri, in particolare la perfetta conoscenza delle erbe officinali, da cui si traeva la maggior parte dei medicamenti. Essa possedeva un hortus medicus a Westminster, di cui sappiamo ben poco, ma il principale strumento didattico sembra fossero le herborizing, escursioni nelle campagne dei dintorni in cui gli apprendisti erano guidati dai maestri a raccogliere e riconoscere le erbe. Da resoconti dell'epoca, sappiamo che si collocavano a metà tra l'occasione didattica e l'allegra scampagnata, e si concludevano immancabilmente in un'osteria. Poiché le strade erano scomode o poco sicure, apprendisti e maestri raggiungevano le località prescelte con una barca affittata allo scopo; tuttavia nel 1673 la società decise l’acquisto di un’imbarcazione, da usare anche per le feste solenni, come la parata annuale organizzata dal sindaco di Londra; in tali occasioni, veniva pavesata a festa, con nastri, pennoni, bandiere, lo stemma dei farmacisti e sculture di unicorni e rinoceronti. Si poneva il problema di trovare un posto per ricoverare la "barca sociale", che, diversamente dall’hortus di Westminster, avesse accesso diretto dal fiume. A tal fine, la Società dei farmacisti affittò da Charles Cheyne, proprietario del Chelsea Manor, un terreno di quattro acri situato nel villaggio di Chelsea, poco distante dal Tamigi, e vi fece costruire tre rimesse, una per la propria barca, le altre due da affittare ad altre corporazioni. Non era lontano neppure dall’affollato mercato di Chelsea, per cui l’anno successivo fu deciso di proteggerlo con un muro di cinta. Solo a questo punto, la Società decise di approfittare del suolo fertile e della posizione riparata per spostare qui le piante fino ad allora coltivate a Westminster e creare un Physic garden (ovvero hortus medicus), destinato sia alla produzione di erbe medicinali da vendere o da elaborare nel proprio laboratorio, sia all’addestramento degli apprendisti. Per gestire il trasferimento e creare il nuovo giardino, fu assunto il giardiniere Spencer Piggott, che però si rivelò disonesto, tanto che dopo un anno o due il contratto non gli venne rinnovato. Il 1678 gli succedette il più affidabile Richard Pratt che procedette ai trapianti, piantò diverse piante da frutto e preparò le aiuole didattiche, divise in pulvilli sul modello di Leida. Dal 1680 la gestione generale fu affidata al farmacista John Watts, un abile uomo d'affari e un intenditore di piante esotiche, che coltivava in uno splendido giardino privato a Enfield. Con l'assistenza di due giardinieri, il suo compito principale era arricchire il giardino di piante autoctone ed esotiche; per ospitare queste ultime, egli fece subito allestire una serra riscaldata, presumibilmente la prima del paese. Nel 1682 le collezioni erano già abbastanza ricche da meritare una visita di Paul Hermann, che invitò Watts a Leida. Nacque così il primo programma di scambi a noi noto tra orti botanici. Nel 1683 Watts andò a Leida in compagnia di George London, il giardiniere del vescovo Compton, e ne ritornò con moltissime piante, tra cui i famosi quattro cedri del Libano che divennero il simbolo del giardino. Inoltre Watts, che era un mercante specializzato nel commercio internazionale, con interessi anche in Cina, organizzò almeno una spedizione botanica, inviando in Virginia il cacciatore di piante James Harlow. Tuttavia, sul piano finanziario, anche la sua gestione si rivelò un disastro: i giardinieri divennero ben sei, la serra consumava impressionanti quantità di legname e di soldi, Watts si fece anche raddoppiare lo stipendio da 50 a 100 sterline annue e usò liberamente il terreno per coltivazioni in proprio, con eterne questioni su quali piante fossero sue e quali della società. Per di più, spremuto lo spremibile, prese ad assentarsi sempre di più, finché nel 1692 il contratto non gli fu rinnovato.  Il secondo curatore del Physic garden Pur tra tante difficoltà, il giardino aveva cominciato ad assolvere il suo compito di formare una generazione di giovani farmacisti, alcuni dei quali divennero anche appassionati botanici. Tra di loro troviamo due amici e quasi coetanei, Samuel Doody (1656-1706) e James Petiver (1663 – 1718), entrambi venuti a Londra dalla provincia per diventare apprendisti farmacisti. Le gite fuori porta stimolarono la loro passione per le erborizzazioni in compagnia, che condividevano con altri amici, come Hans Sloane, che, prima di andare a studiare medicina e botanica in Francia, aveva frequentato insieme a loro le aiuole di Chelsea e le allegre herborizing. Intorno al 1685, quasi contemporaneamente, i due si abilitarono alla professione e aprirono le loro farmacie, Doody nello Strand e Petiver a Islington. A quel punto dovevano già essere membri attivi di quel circolo londinese di studiosi di botanica e scienze naturali che a partire dal 1689 prese a riunirsi nel cosiddetto Temple Coffee House Botanical Club. Oltre a Sloane, che ne era l'animatore, un punto di riferimento era John Ray, anche se quest'ultimo era tornato a vivere nel villaggio natale di Black Notley e veniva solo occasionalmente a Londra. Insieme al curatore dell'orto botanico di Oxford Jacob Bobart il giovane, a Sloane e al suo amico Tancred Robinson, i due farmacisti collaborarono con le loro raccolte e le loro note a Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum di John Ray, la cui prima edizione uscì nel 1690. È stato anzi supposto che tra di loro si fosse stabilita una certa divisione dei compiti, nell'intento comune di riconoscere e recensire il maggior numero possibile di piante della flora britannica. Doody si specializzò in un campo ancora poco battuto, quello delle crittogame, in particolare muschi e licheni. Su questo argomento corrispondeva con il reverendo Adam Buddle, che talvolta veniva a Londra per erborizzare con lui e Petiver, o per confrontare le raccolte, discutendone davanti a un bicchiere di vino o un boccale di birra al Greyhound Tavern di Fleet Street o in altre taverne londinesi. Un altro corrispondente di Doody era Edward Lhwyd, il custode dell'Ashmolean Museum, che invece si era concentrato nello studio dei fossili. Grazie a questi contatti e alla collaborazione con Ray, il farmacista aveva ormai una solida reputazione di botanico che sicuramente pesò quando, nel 1692, fu chiamato a sostituire Watts come curatore del Chelsea Physic Garden. Era in qualche modo un tentativo di salvare il giardino, che molti membri della società avrebbero preferito dismettere. Doody, come il predecessore, ricevette un salario di 100 sterline, al quale tuttavia rinunciò a partire dal 1696 quando prese in affitto una parte dell'appezzamento. Il suo primo compito fu catalogare le piante per sbrogliare la matassa di quali spettassero alla Society e quali a Watts. Quindi anch'egli si diede da fare per incrementare le collezioni, organizzando una spedizione alle Canarie nel 1694. Si impegnò molto nelle herborizing, durante le quali faceva sfoggio del suo sapere botanico. Sia lui sia Petiver entrarono a far parte del comitato che seguiva la disputa legale con il Collegio dei medici e nel 1695 furono ammessi nella medesima seduta alla Royal Society, di cui da poco l'amico Sloane era diventato uno dei segretari. L'unico contributo di Doody alle Transactions della Società fu una comunicazione su un caso di idropisia (1697). Anche sulla sua gestione del Physic Garden non sappiamo molto altro; in ogni caso fu breve, perché egli morì nel 1706. A presiedere la cerimonia funebre fu Adam Buddle. I suoi libri, l'erbario e qualche manoscritto confluirono nelle collezioni di Sloane. Il pezzo di maggior interesse è una copia della seconda edizione della Synopsis methodica di Ray, interfogliata con note di pugno di Doody che riguardano soprattutto funghi, muschi e licheni e furono utilizzate da Dillenius per la terza edizione.  Felci ruvide Fu il ruolo pionieristico di Doody in questo campo a suscitare l'interesse di Robert Brown che nel 1810 gli dedicò il genere Doodia con questa breve motivazione: "L'ho dedicato alla memoria del farmacista londinese Samuel Doody, quasi il primo in Inghilterra ad esplorare le crittogame". Doodia è un piccolo genere di felci della famiglia Blechnaceae, con 15-20 specie distribuite tra l'Asia sud-orientale, l'Australia e la Nuova Zelanda, di status tassonomico discusso. Secondo il gruppo di lavoro diretto da M. J. M. Christenhusz (2011) è annidato in Blechnum, nel quale va fatto confluire. Secondo il Pteridophyte Phylogeny Group (PPG, 2016) va mantenuto come genere autonomo, uno dei diversi un cui va smembrato il polifiletico Blechnum. Sono piante terrestri, in genere sempreverdi, con fronde unipinnate, foglie lanceolate e ruvide al tatto (da cui il nome comune inglese rasp fern, "felce rasposa"); i sori sono disposti in file ai lati della nervatura centrale delle pinnae e le loro tracce sono ben visibili sulla superficie superiore. In genere al momento dell'apertura le fronde sono da rosate a rossastre, per poi diventare verde scuro. E' questa la maggiore attrattiva di queste felci, di cui in giardino si coltivano soprattutto due specie australiane, tendenzialmente tappezzanti e di facile coltivazione, ma purtroppo non del tutto rustiche, D. aspera e D. media. Alcune specie di ridotte dimensioni, come l'australiana e neozelandese D. caudata, sono anche adatte alla coltivazione in un giardino alpino. Qualche approfondimento nella scheda. Mentre, grazie al ruolo di stimolo dei naturalisti di Tranquebar, la Presidenza di Madras della Compagnia delle Indie sosteneva le ricerche naturalistiche e aveva alle sue dipendenze un botanico, niente di simile avveniva in Bengala. A introdurre un primo cambiamento fu un militare e un funzionario di lungo corso, il colonnello Kyd, che nel 1787 propose alla Compagnia di creare a Calcutta un grande giardino di acclimatazione. Nacque così l'orto botanico di Calcutta, oggi Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Botanic Garden, destinato a diventare il più importante dell'Asia, grazie soprattutto al secondo intendente dopo Kyd, il grande botanico William Roxburgh, il "padre della botanica indiana". Il colonnello Kyd è ricordato dal genere Kydia (Malvaceae), mentre nessun genere valido onora Roxburgh. Consoliamoci con la bellissima Rosa roxburghii. 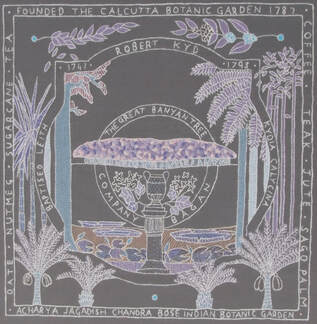 Un colonello molto attivo e la nascita di un giardino Grazie ai naturalisti di Tranquebar e soprattutto all'attività di König, nell'ultimo quarto del Settecento nell'India meridionale si registra una vivace ricerca naturalistica, sostenuta dalla Presidenza di Madras della Compagnia delle Indie che nel 1778 assume lo stesso König come naturalista ufficiale. Si tratta sia di esplorare le risorse del paese, sia di introdurre da altri paesi dal clima simile piante medicinali, alimentari e industriali. Da questo punto di vista, l'iniziativa più importante è la fondazione di una stazione sperimentale a Samalkot, a duecento miglia a nord di Madras, affidata al medico scozzese William Roxburgh (1751-1815). Arrivato in India nel 1776, ha lavorato come medico e chirurgo all'ospedale della Compagnia di Madras e ha incominciato a interessarsi di botanica e a fare le sue prime raccolte di piante grazie all'amicizia con König. Nel 1781 diventa intendente di Samalkot, dove sperimenta la coltivazione di pepe nero; purtroppo le piante non riescono a fruttificare. Maggiore successo incontrano le coltivazioni di caffè, canna da zucchero, alberi del pane, gelsi. Non c'è niente di simile nell'India settentrionale, come era ben chiaro a Joseph Banks che così si esprime in una lettera a un membro del Consiglio privato del re, George Yonge: "A dire la verità, si sa poco dei prodotti naturali del Bengala. La costa del Malabar è stata ben studiata dagli olandesi […] e il lavori del fu dr. Koenig mi hanno dato una conoscenza accettabile del Coromandel. Ma il Bengala e il suo entroterra rimangono una vasta pagina bianca nel libro delle informazioni”. E' dunque forse ispirandosi a Samalkot che nel 1786 il colonnello Robert Kyd (1746-1796) propone alla Compagnia la creazione di un ben più vasto giardino di acclimatazione nei pressi di Calcutta. Kyd è arrivato in India nel 1764 e ha percorso una brillante carriera militare: luogotenente un anno dopo, capitano nel 1768, maggiore nel 1780, e luogotenente colonnello nel 1782, quando viene nominato segretario del dipartimento militare di ispezione del Bengala. Non ha una formazione come botanico, ma possiede una proprietà a Shibpur, di fronte a Calcutta sull'altra riva dell'Hoogly (il braccio del delta del Gange su cui sorge la città) e ama sperimentare la coltivazione di piante utili indiane o importate. Nell'aprile del 1786 scrive una prima lettera al Governo del Bengala in cui insiste sull'opportunità per la Compagnia di fondare un giardino dove coltivare piante alimentari per poi moltiplicarle e trapiantarle in ogni villaggio. Gli inglesi hanno dato pace e ordine all'India, scrive, ma per giustificare la loro presenza agli occhi degli indiani devono dare loro benefici più concreti, mettendo fine alle due peggiori piaghe del paese: la fame e le epidemie, che ne sono la conseguenza. La proposta si precisa nella seconda lettera, del giugno dello stesso anno: un giardino della Compagnia "ci permetterebbe di superare i nostri rivali in ogni produzione utile che la natura ha confinato in questa parte del globo”; insiste sugli scopi pratici del giardino e sui suoi vantaggi economici per la nazione: non va creato “per raccogliere piante rare (sebbene anch’esse abbiano i loro usi) come oggetti di pura curiosità o che gratificano il piacere del lusso, ma per stabilire una scorta per la disseminazione di quelle piante che si riveleranno utili sia per gli abitanti sia per i nativi della Gran Bretagna, che ora tendono ad espandere il commercio e la ricchezza nazionali”. Tra le piante di cui suggerisce l'introduzione, le palme da dattero e di sagù e gli alberi di teak, che potranno fornire legname di qualità per le navi della Compagnia. La proposta di Kyd cade in un momento particolarmente opportuno. In Inghilterra, la politica di puro sfruttamento della Compagnia e la rapacità dei suoi funzionari hanno incominciato a destare molte critiche. D'altra parte, non pochi dei suoi uomini condividono gli ideali illuministici e molti nutrono un interesse personale per le scienze naturali, a cominciare dal governatore Warren Hastings, che ha creato egli stesso un raffinato giardino nella tenuta di Belvedere ad Alipore e nel 1784 ha incoraggiato la fondazione dell'Asiatic Society. Una migliore conoscenza del patrimonio naturale del paese sarà utile per l'economia e la medicina, senza contare che sponsorizzare la ricerca scientifica, dopo tutto, è un modo a basso costo per ripulire l'immagine della Compagnia, che sta pure affrontando un momento di crisi economica: il mercato delle cotonine indiane è ormai saturo, l'indipendenza delle colonie americane ha chiuso un sbocco importante e la drastica riduzione delle tasse sul tè (la fonte di maggiori proventi) ha ulteriormente ridotto i dividendi. Del resto, conoscere meglio l'ignota, aliena e spesso minacciosa natura indiana, è il primo passo per dominarla; è dunque rassicurante. Accolta con favore dai vertici della Compagnia in Bengala, la proposta arriva a Londra dove trova un sostenitore entusiasta in Joseph Banks. Egli guarda decisamente al modello di Pamplemousses a Mauritius, dove i francesi, introducendo la coltivazione del pepe, del chiodo di garofano, della noce moscata, sono riusciti addirittura a intaccare il monopolio olandese delle spezie. Vede già un Bengala trasformato nel principale produttore di materie prime dell'Impero, da esportare, chissà, persino in Cina. E, se Kyd vede nella palma di Sagù la pianta miracolosa che metterà fine alle carestie indiane, Banks pensa piuttosto all'albero del pane. Così nel luglio 1787 la direzione della Compagnia approva la creazione dell'Orto botanico di Calcutta, affidandone la direzione a Kyd, nominato intendente onorario, ovvero senza stipendio. Egli sceglie un terreno di 310 acri situato lungo la riva dell'Hoogly, attiguo alla sua residenza di campagna. Molto attivo, si dà molto da fare per realizzarlo; sollecita donazioni di privati, allestisce squadre di raccoglitori, sterratori e giardinieri, riceve invii dall'Europa e da altre colonie inglesi. Fa piantare manghi, alberi di teak, palma da dattero e da sagù, alberi del pane, manioca. Nel clima caldo-umido del Bengala, nessuno prospera; l'unica produzione alimentare ad essere un successo è la canna da zucchero, la cui coltivazione diverrà redditizia soprattutto dopo l'inizio delle guerre con la Francia, che ostacolano i commerci con le Antille e fanno lievitare i prezzi. Nel 1790, dalla Cina arrivano 272 pianticelle di tè; anche in questo caso, l'esperimento fallisce: per l'introduzione del tè cinese in India bisognerà aspettare il 1848 e Robert Fortune. Pessima sorte tocca anche agli alberi da frutta arrivati dall'Europa. Si stabilisce invece una proficua collaborazione con l'orto botanico di Saint Vincent e il suo sovrintendente, Alexander Anderson, da cui Kyd riceve alberi del pane e annatto (Bixa orellana). Nel 1793 il giardino è in grado di distribuire semi di canapa indiana, tabacco, indaco, caffè, teak e di spedire pianticelle in altre parti dell'India, a Sant'Elena, nelle Indie occidentali e in Inghilterra. Banks ammira l'attivismo di Kyd, ma gli spiace che non abbia alcuna preparazione scientifica e che il giardino (troppo vasto, ha la stessa estensione di Kew) sia concepito esclusivamente come giardino di acclimatazione. Le cose cambiano con l'arrivo di Roxburgh. Kyd muore all'improvviso nel 1796, quando il giardino ha meno di dieci anni. Anche se finora non ha dato i risultati sperati, e si è rivelato una fonte di spese crescenti (Kyd aveva preventivato un costo mensile di 200 rupie, nel 1800 la cifra sarà più che decuplicata), la Compagnia decide di mantenerlo in vita e di nominare secondo intendente William Roxburgh (che lascia Samalkot alle cure di Heyne, come ho raccontato in questo post). Quando Roxburgh arriva a Calcutta, nel giardino si coltivano 300 varietà di piante. Secondo le indicazioni della Compagnia, continua a sperimentare piante alimentari e da reddito. Incrementa la piantagione di teak, tenta la coltivazione del cotone (che va male) e intensifica quella dell'indaco (che va molto bene); ma soprattutto trasforma il giardino in un vero orto botanico, grazie a una rete di raccoglitori che inviano piante dalle Presidenze di Bengala, Bombay e Madras e da altre colonie dell'Asia britannica. La Compagnia fa fatica ad accettare il nuovo corso e ammette lo scopo scientifico del giardino solo nel 1807. Nel 1814, quando Roxburgh, malato, lascia l'India, le specie e varietà che vi si coltivano sono passate a 3500.  Una dedica fraterna Fu proprio Roxburgh a ricordare il suo predecessore con la dedica di Kydia, un piccolo genere della famiglia Malvaceae, con due sole specie, entrambe distribuite tra subcontinente indiano e sud-est asiatico; per sottolineare il legame di amicizia e riconoscenza con Kyd, denomina addirittura K. fraterna una delle due specie che riconosce e descrive (oggi è considerata sinonimo di K. calycina). Sono alberi dalla densa chioma arrotondata, con foglie lobate e piccoli fiori bianchi o rosa raccolti in grandi grappoli. La specie più diffusa, K. calycina, talvolta coltivata, di crescita veloce, è utilizzata per il legname, ma soprattutto per le fibre ricavate dalla corteccia, usate per fabbricare corde o filtri per chiarificare lo zucchero. Meno fortunato di Kyd da questo punto di vista Roxburgh, uno dei tanti grandi botanici cui è toccato di essere onorato da un genere non più valido. Roxburghia, dedicatagli da W. Jones, è infatti sinonimo di Stemona Lour. Pur non potendo essere protagonista di un post, non mancherà occasione di parlare di lui, approfondendo la nostra conoscenza con la botanica indiana. Sono comunque numerosissime le piante che lo ricordano nel nome specifico; tra di esse, vorrei ricordare almeno la bellissima Rosa roxburghii, una spettacolare specie himalayana e cinese, notevole sia per i fiori sia per i grandi cinorrodi spinosi. A pochi km da Bangalore, capitale del Karnataka, si trova uno spettacolare giardino, Lalbagh (un nome spiegato in vari modi, forse "giardino rosso"). Nato come giardino reale nel 1760, passò attraverso varie vicissitudini, finché nella seconda metà dell'Ottocento divenne orto botanico governativo. All'inizio del secolo, subito dopo la conquista inglese, era stato diretto per qualche anno dal medico e botanico tedesco Benjamin Heyne; vissuto per quasi trent'anni in India, fece importanti raccolte e fu il primo a notare un fenomeno connesso con il metabolismo acido delle Crassulaceae. A ricordarlo il piccolo genere Heynea. Piccola storia del "giardino rosso" Come abbiamo già visto parlando di Johann Gerhard König, l'avamposto danese di Tranquebar funzionò in un certo senso da fucina di naturalisti che poi passarono al servizio della Compagnia delle Indie. E' il caso anche del medico tedesco Benjamin Heyne (1770-1819) che però, al contrario di König, era venuto in India non per lavorare alla missione luterana di Halle, ma alla "rivale" missione morava. Heyne arrivò in India nel gennaio del 1792, ventiduenne. Nato a Döbra in Sassonia, probabilmente non molto prima di partire si era laureato in medicina a Dresda. Forse viaggiò da Copenhagen a Tranquebar in compagnia di un altro giovane collega, Johann Gottfried Klein, figlio di uno dei pastori della missione luterana, Jakob Klein. Nato in India, il giovane Klein era stato mandato in Germania a studiare medicina e ora tornava a casa per diventare medico della missione. Anche se uno dipendeva dai moravi, l'altro dai luterani, due medici missionari erano troppi per quel piccolo avamposto. Heyne trovò difficile sbarcare il lunario, tanto che pensò di tornare in Germania. Sarebbe stato un peccato, pensò Christoph Samuel John (1746-1813), il pastore-capo della missione luterana; buon amico di König e Roxburgh, era anch'egli un notevole naturalista e aveva potuto apprezzare le vaste competenze di Heyne soprattutto nel campo della botanica e della mineralogia. Nell'agosto 1783 scrisse a Roxburgh per chiedergli di raccomandarlo alla Compagnia delle Indie. Roxburgh lo prese con sé nel giardino della Compagnia a Samalkot, a circa 200 km a nord di Madras, dove egli sperimentava la coltivazione di piante industriali e alimentari. Un mese dopo Heyne vi si traferì e a ottobre la sua assunzione fu approvata dalla Compagnia. Pochi mesi dopo, nel marzo 1794, quando il botanico scozzese fu nominato sovrintendente dell'orto botanico di Calcutta, lo sostituì "come Botanico della Compagnia durante l'assenza del Dr. Roxburgh". Nel 1796, l'incarico gli fu confermato ufficialmente, insieme alla nomina ad assistente chirurgo. In questi anni, Heyne fece cospicue raccolte e fece eseguire numerosi acquerelli botanici da artisti locali (Plants of the Coromandel coast: a collection of 394 botanical watercolour drawings of plants and flora), che tuttavia non vennero mai pubblicati. Nel 1799, dopo la presa di Mysore, gli fu ordinato di unirsi alla ricognizione del territorio appena conquistato. Se all'inizio l'obiettivo fondamentale di quello che è passato alla storia come Mysore Survey (1799-1810) era procedere al rilievo trigonometrico della regione al fine di disegnarne una carta aggiornata, presto divenne un'indagine a tutto campo, che prevedeva di raccogliere ogni sorta di informazione (e di materiale) sulla storia, l'archeologia, la religione, i costumi, le arti, le risorse naturali, l'industria, i commerci. I ricognitori, che comprendevano interpreti, disegnatori, cartografi, vennero divisi in tre squadre, capeggiate rispettivamente dall'ingegnere militare Colin Mackenzie, dal geografo Francis Buchanan Hamilton e appunto da Benjamin Heyne. Come botanico e naturalista, doveva studiare la flora, la fauna, le produzioni agricole; come geologo, le risorse minerarie e le tecniche industriali (tra l'altro, si occupò della produzione della soda e delle manifatture di rame e ferro); come medico, che aveva studiato i testi medici tamil, doveva verificare la disponibilità nei mercati di medicinali per l'esercito della Compagnia, specialmente per combattere la malaria, il principale ostacolo all'espansione britannica in India. Quanto alla botanica, le istruzioni del governatore generale Wellesley puntualizzavano: "Bisogna assolutamente privilegiare le piante utili rispetto a quelle che si raccomandano solo per la loro rarità o la loro bellezza [...]. Occorre raccogliere con cura tutto ciò che è connesso alle arti e alle produzioni di questo paese, o che promette di essere utile al nostro; prestare la dovuta attenzione al legname impiegato nelle varie province che toccherà nel suo percorso [...] e raccogliere con particolare diligenza le preziose piante legate alla sua professione immediata, cioè alla medicina". Il governatore aggiunse un compito specifico: trovare una sede più adatta di Samalkot per il giardino botanico della Compagnia nella presidenza di Madras. La scelta di Heyne cadde su un giardino già esistente: quello di Lalbagh nei pressi di Bangalore. A farlo costruire, intorno al 1760, fu il sultano di Mysore Hyder Alì che si inspirò al modello dei giardini Moghul, in particolare quello di Sira. Esteso su 40 acri, comprendeva una serie di ambienti squadrati, separati da viali, sentieri e canali alimentati da una cisterna. Era sia un giardino di piacere, sia un orto-frutteto. Nelle aiuole fiorivano una profusione di rose e altri fiori rossi, che potrebbero aver dato il nome al giardino (Lalbagh potrebbe significare "giardino rosso", ma anche "giardino prediletto"). Lungo i viali erano piantati cipressi. C'erano specchi d'acqua con loti e diversi frutteti, ciascuno dedicato a diversa varietà di alberi: tra gli altri, banani, melograni, papaye, jackfruit, fichi. Il giardino fu ulteriormente arricchito dal figlio e successore Tipu Sultan, che vi fece piantare alberi di mango (si dice che qualcuno ancora sopravviva) e ogni sorta di alberi e fiori rari, fatti venire dall'Afghanistan, dalla Persia, dalla Turchia e dall'isola di Mauritius. Dato che l'acqua della cisterna era insufficiente per irrigare il giardino, fece anche costruire un pozzo. Tipu morì nel maggio del 1799 mentre tentava di difendere la sua capitale dall'assalto dell'esercito della Compagnia delle Indie. Il regno di Mysore divenne uno stato satellite dell'impero anglo-indiano e vari distretti passarono direttamente alla Compagnia, che già nel corso della guerra aveva fissato il quartier generale del proprio esercito a Bangalore. La bellezza del giardino non lasciò insensibili i britannici, che inizialmente però lo utilizzarono soprattutto per coltivare patate, cavoli, rape ed altri ortaggi per il rancio delle truppe. Nel 1802 Heyne venne ufficialmente promosso "Botanico della Compagnia" e da quell'anno al 1808 diresse Lalbagh, lavorando duramente per riportarlo alla sua bellezza e trasformarlo in un vero orto botanico; vi trapiantò le piante del giardino di Samalcot, dismesso dalla Compagnia. Molte piante le raccolse egli stesso, soprattutto nei distretti di Bangalore e Combatore; gli è accreditata la scoperta di circa 350 specie. Spedì molti esemplari al botanico tedesco Albrecht Wilhelm Roth, che se ne servì per Novae plantarum species praesertim Indiae orientali, che dipende in gran parte dalle raccolte di Heyne. Nel maggio del 1808 l'incarico di "Botanico della Compagnia" fu soppresso. Siamo poco informati sui movimenti di Heyne in questo periodo; secondo alcuni rimase a dirigere Lalbagh fino al 1812, secondo altri la lasciò appunto nel 1808. Sappiamo invece con certezza perché lo riferisce egli stesso che nel 1811, essendo la sua salute compromessa dopo vent'anni in India, ottenne dalla Compagnia un congedo di tre anni. Si recò quindi a Calcutta per salutare Roxburgh, ma anche nella speranza di trovare un ingaggio come medico di bordo di una nave in partenza per l'Inghilterra. Non lo trovò, ma in compenso poté imbarcarsi su un mercantile diretto a Sumatra, dove fece qualche raccolta. Solo nel 1813 poté raggiungere Londra, dove fu ammesso alla Linnean Society alla quale presentò le sue osservazioni su Cotyledon calycina (oggi Kalanchoe pinnata): assaggiandone le foglie, egli aveva notato che di primo mattino erano fortemente acide; con il passare delle ore, perdevano la loro acidità, finché verso mezzogiorno erano totalmente prive di sapore. Si tratta della prima descrizione dei fenomeni connessi alla fotosintesi CAM (Metabolismo acido delle Crassulaceae): oggi sappiamo che molte piante succulente dei climi caldi e aridi di notte aprono gli stomi - chiusi di giorno per limitare la traspirazione - consentendo l'ingresso dell'anidride carbonica che va a formare acidi carbossilici, i responsabili di quel gusto "aspro come l'acetosella, se non di più" osservato da Heyne. Approfittò del soggiorno londinese anche per pubblicare la sua opera principale, Tracts, historical and statistical, on India: with journals of several tours through various parts of the peninsula: also, an account of Sumatra, in a series of letters, che contiene il resoconto delle sue esplorazioni dell'India e di Sumatra; a fare la parte del leone, però, più che la botanica sono la geologia, la mineralogia e le tecniche industriali tradizionali. L'opera anche una delle prime mappe geologiche dell'India meridionale. Terminato il suo congedo, già nella primavera del 1815 Heyne rientrò a Madras, dove riassunse l'incarico di naturalista e botanico della Compagnia delle Indie. Il breve soggiorno in Europa non era stato sufficiente a restituirgli la salute, visto che morì nel 1819, ad appena 49 anni. Come si capisce tra le righe anche da Tracts, historical and statistical on India, almeno negli ultimi anni le sue relazioni con la Compagnia non dovette essere idilliache. Nel 1807 quest'ultima aveva nominato custode di Lalbagh il proprio ufficiale pagatore, il capitano - e più tardi maggiore - Gilbert Waugh, e, come abbiamo già visto, nel 1808 soppresse l'incarico di botanico di Heyne. E' dunque probabile che egli non sia rimasto a Bangalore. Del resto, sappiamo che la gestione di Waugh non lasciava spazio a coabitazioni; egli prese il controllo assoluto del giardino che ben presto fu noto come "giardino di Waugh"; interessato agli aspetti pratici della botanica, introdusse coltivazioni sperimentali di canna da zucchero e caffè. Nel 1814, il giardino passò sotto il controllo del governo di Mysore, che prese a eliminare gli alberi per lasciare spazio a un grande orto. Preoccupato, Waugh scrisse a lord Hastings, il governatore generale dell'India, proponendo che il giardino fosse posto sotto la giurisdizione dell'orto botanico di Calcutta. Consigliato in tal senso da Nathaniel Wallich che riteneva che Lalbagh potesse diventare "un vivaio di passaggio o un deposito per l'introduzione e l'acclimatazione di piante da frutto in Inghilterra", Hastings accettò. Troppo impegnato a Calcutta, Wallich dovette limitarsi a qualche visita e la soluzione giovò poco al giardino di Bangalore (le due città per altro sono lontanissime). La situazione si protrasse fin al 1831 quando, con la fine dello stato fantoccio di Mysore, anche il giardino passò sotto il controllo governativo. Affidato per qualche anno all'effimera Società agricola dell'India, fu rilanciato solo a partire del 1856, quando divenne ufficialmente Government Botanical Garden e fu affidato alla direzione di un botanico di Kew, William New. Nel 1899, in occasione della visita del nipote della regina Vittoria Albert Victor (che pose la prima pietra), venne costruita una grande serra ispirata al Crystal Palace di Londra, che è ancora la maggiore attrazione del giardino. Oggi, con un'estensione di 240 acri, continua ad essere uno dei più vasti e importanti giardini dell'India; anche se non ha più la funzione di orto botanico, ma piuttosto di parco, è famoso sia per la rarità delle collezioni sia per il pregio estetico, che con le sue fontane e i suoi specchi d'acqua richiama le origini, il "giardino rosso" di Hyder Alì.  Una dedica amichevole Benjamin Heyne entra a fare parte della nostra galleria di dedicatari di generi botanici grazie all'amico William Roxburgh che nel 1815 denominò in suo onore Heynea trijuga un albero nativo del Nepal i cui semi erano stati spediti all'orto botanico di Calcutta da un altro comune conoscente, Francis Buchanan. La dedica ricorda che "il Dr. Heyne per molti anni ha prestato grande attenzione alla storia naturale dell'India; recentemente è tornato al servizio della Compagnia. Per il suo talento e la sua industriosità possiamo attenderci molte altre utili informazioni". Come sappiamo, la morte gli impedì di soddisfare queste lusinghiere aspettative. Heynea, della famiglia Meliaceae, comprende solo due specie, appunto H. trijuga e H. velutina; la prima è un piccolo albero, diffuso dal subcontinente indiano alla Malesia, il secondo un arbusto diffuso dalla Cina meridionale all'Indocina. Hanno foglie disposte a spirale e minuti fiori bisessuali con quattro-cinque petali imbricati disposti in tirsi, seguiti da frutti a capsula, che contengono uno-due semi avvolti in un arillo. Quelli di H. trijuga vengono raccolti per ricavarne olio illuminante. Questa specie, la nota delle due, di crescita veloce e con una chioma espansa e densa, nella Thailandia settentrionale trova impiego nella riforestazione di aree disturbate, anche perché i frutti sono molto apprezzati da uccelli e pipistrelli, favorendo la dispersione dei semi. Di notevole bellezza, è anche coltivato nei giardini. Le foglie e la corteccia, di gusto amaro, sono utilizzate nella medicina tradizionale. Altre informazioni nella scheda. A partire dalla fine degli anni '30 del Settecento, a San Pietroburgo c'erano ben due orti botanici: uno dipendeva dalla Cancelleria medica e ospitava soprattutto specie medicinali; l'altro era annesso all'Accademia delle scienze ed era essenzialmente un giardino didattico e di acclimatazione. A volere fortemente il secondo fu il professore di botanica Johann Amman che, educato a Leida, pensava che il "vecchio" giardino (vecchio per modo di dire: aveva poco più di vent'anni) fosse ormai obsoleto, oltre che troppo lontano dall'Accademia. Ben presto i due giardini furono diretti dalla stessa persona e la bipartizione perse via via significato, finche nel 1823 vennero fusi a formare il nuovo Imperiale orto botanico. Amman, morto giovanissimo, fu ricordato dall'amico William Houstoun con il genere Ammania; Linneo lo fece proprio, ma lo ribattezzò Ammannia (con due enne) e lo dedicò a un omonimo: Paul Amman, direttore secentesco dell'orto botanico di Lipsia e precursore della classificazione naturale. 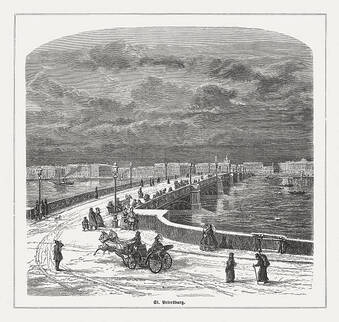 Un giardino, anzi due... A studiare la storia russa, si ha sempre l'impressione che tutto sia complicato, non lineare, contraddittorio. E così capita che nell'arco di meno di mezzo secolo, l'autorità imperiale prenda l'iniziativa di fondare tre orti botanici, che poi continuano la loro vita parallela in una gran confusione di funzioni, conflitti personali, sperpero di denaro. Si comincia a Mosca nel 1706, quando Pietro il Grande ordina di creare un orto dei farmacisti (Aptekarskij ogorod) destinato alla coltivazione di piante officinali per le farmacie cittadine. Lo zar ci tiene tanto che, si racconta, vi piantò di sua mano tre conifere (l'ho raccontato qui). Il giardino è gestito dalla Cancelleria delle farmacie, un organismo tradizionale controllato da membri dell'alta aristocrazia. Ma intanto Pietro ha deciso di creare ex novo, facendola sorgere letteralmente dal mare e dalle paludi, la sua nuova capitale, San Pietroburgo, dove trasferisce a forza la corte e tutte le strutture amministrative. Mette mano anche alla riforma della medicina, affidandola al suo medico personale, lo scozzese Robert Erskine, che crea un nuovo organismo, la Cancelleria medica, che d'ora in avanti controllerà l'attività dei medici civili e militari e dei farmacisti. E' in un certo senso un doppione della Cancelleria dei farmacisti, che però per non creare un conflitto immediato con l'aristocrazia moscovita non viene abolita, ma svuotato dall'interno. Erskine dirige un gigantesco trasferimento di documenti, materiali e piante. La centrale operativa della Cancelleria medica viene stabilita in una delle isole settentrionali del delta della Neva, piuttosto distante dal nucleo centrale, dove vengono costruiti la sede degli uffici, un laboratorio per la preparazione dei medicamenti e un vasto orto botanico, la cui fondazione è decretata verso la fine del 1713. Si chiamerà Aptekarskij sad (giardino dei farmacisti) e l'isola stessa prenderà il nome Aptekarskij ostrog, Isola dei farmacisti. I due giardini hanno la stessa funzione, ma vista la distanza è sensato avere due giardini medici che coltivano piante officinali per le farmacie delle rispettive aree; un po' meno che uno dipenda dalla Cancelleria dei farmacisti (dunque da un organismo semi autonomo), l'altro dalla Cancelleria medica (dunque direttamente dal sovrano, attraverso il suo archiatra). Le cose si complicano quando, sull'esempio degli orti botanici di Parigi e Leida, si decide di farne anche dei giardini di acclimatazione delle piante esotiche ottenute con lo scambio semi da orti botanici europei e delle specie raccolte in natura nel vastissimo e variegato impero russo dalle numerose spedizioni naturalistiche che si succedono nel corso del secolo. Finisce per imporsi una certa specializzazione "geografica": fatto salvo che il centro è San Pietroburgo, le spedizioni che esplorano la Russia europea, le rive del mar Nero, il Caucaso tendono a far capo a Mosca, e il giardino moscovita si arricchisce soprattutto di piante delle steppe. I materiali raccolti dalle spedizioni che operano al di là degli Urali ed esplorano la Siberia fino alle rive del Pacifico, i confini con la Cina, l'Asia centrale tendono ad affluire all'Isola dei farmacisti. Le prime spedizioni, come quella di Messerschmidt in Siberia (1719-1727) o di Buxbaum (1724-1727) a Costantinopoli, sono organizzate dalla Cancelleria medica, ma nel 1724 viene fondato un terzo organismo, con compiti scientifici e didattici: l'Accademia russa delle Scienze, con sede nell'isola Vasil'ekskij, accanto all'edificio dove è conservata la Kunstkamera, la camera delle meraviglie imperiali. L'imperatore e il suo archiatra considerano tutto ciò che viene riportato dalle spedizioni russe un tesoro nazionale che va ad arricchire la Kunstkamera e deve essere studiato e pubblicato esclusivamente dai professori dell'Accademia. E così succede che le piante vive e i semi raccolti da Gmelin durante la Grande spedizione del Nord (salvo quelli che egli coltiva nel suo giardino privato) finiscono nelle aiuole dell'isola dei farmacisti, mentre gli esemplari d'erbario sono custoditi nell'isola Vasil'evskij. Qui il professore di botanica del ginnasio e dell'Università accademica tiene le lezioni teoriche, mentre lezioni pratiche, le "dimostrazioni", toccano al dimostratore del Giardino dei farmacisti. 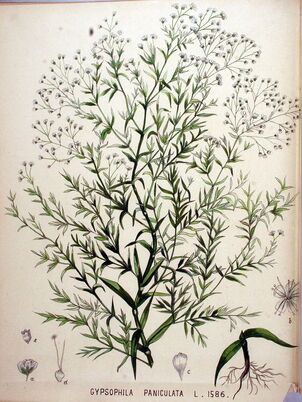 Meglio ancora, tre! All'inizio del 1733, mentre i professori dell'Accademia si preparano a partire per la Grande spedizione del Nord, da Londra arriva il giovane medico svizzero Johann Amman (1707-1741). Ha appena venticinque anni, ma ha ottime referenze: in primo luogo si è laureato a Leida con Boerhaave, il più grande professore di medicina e botanica dell'epoca; in secondo luogo, ha lavorato per tre anni come curatore della collezione naturalistica di Hans Sloane, il presidente della Royal Society, alla quale egli stesso è stato ammesso nel 1731. Viene immediatamente nominato professore di botanica e scienze naturali in sostituzione di Gmelin in partenza per la Siberia e gli viene affidata la pubblicazione delle raccolte di Buxbaum e Messerschmidt. Nel 1735, dopo anni senza un direttore, al Giardino dei farmacisti viene nominato direttore e dimostratore il tedesco Johann Georg Siegesbeck, celebre per la sua polemica con Linneo e il suo pessimo carattere. La convivenza con Amman non è facile; Siegesbeck è frustrato perché briga inutilmente per essere ammesso all'Accademia e al rango di professore, Amman - la cui salute è purtroppo precaria - considera uno spreco di tempo e un disagio sempre più gravoso dover fare la spola tra le due isole, specie d'inverno, nel clima proverbialmente pessimo della capitale petrina. Incomincia così a fare pressioni perché l'Accademia si doti di un proprio orto botanico, dove studiare le piante dal vivo e impartire le lezioni pratiche. Educato a Leida, pensa che sia ora che anche San Pietroburgo abbandoni la vecchia concezione strumentale dell'hortus medicus, e si doti di un vero orto botanico moderno per la didattica e l'acclimatazione di piante esotiche e novità botaniche. Come ci informano le sue lettere a Sloane, l'idea fa breccia lentamente nell'amministrazione: all'inizio ha a disposizione solo un giardinetto, e come serra la sua stessa stanza. I finanziamenti per fare le cose in grande arrivano solo nel 1738 o nel 1739, quando la grande massa di piante giunte dalla Siberia e dalla Kamčatka grazie a Gmelin, Krašeninnikov e Steller rende urgente trovare loro una sede adeguata. E così, a San Pietroburgo, a pochi km di distanza, ci saranno due orti botanici: quello dell'Isola dei farmacisti, dipendente dalla cancelleria medica e principalmente orientato alle piante medicinali, e quello dell'isola Vasilev'skij, dipendente dall'Accademia, orientato alla didattica e alla coltivazione delle piante esotiche. Nel 1741 Amman, afflitto da ricorrenti problemi di salute fin dal suo arrivo a San Pietroburgo, morì a soli 34 anni. Siegesbeck ottenne finalmente la sospirata ammissione all'Accademia e gli succedette sia come professore sia come direttore del neonato orto accademico, mantenendo la direzione anche del Giardino dei farmacisti. Pochi anni dopo sarebbe stato scacciato con ignominia per il suo pessimo carattere e per la sua discutibile preparazione. Dopo di lui, i due giardini furono quasi sempre diretti dalla stessa persona, rendendo via via più assurdo il doppione, tanto più se si considerano gli angusti spazi dell'isola Vasil'evsij e il progressivo miglioramento dei trasporti urbani. Bisognò però attendere il 1823 perché i due orti botanici pietroburghesi fossero fusi in uno solo (denominato Imperiale orto botanico di san Pietroburgo), anche se il giardino dell'Accademia continuò ad esistere fino all'inizio del Novecento come sezione staccata.  Un'Ammannia per due (forse) Prima di concludere, ancora due parole su Ammann. Testimonianze contemporanee lo descrivono come un uomo di grande cultura e insieme di grande umanità, che parlava molte lingue ed era profondamente dedito allo studio. La salute gli impedì di partecipare a raccolte sul campo, a parte brevi escursioni nei dintorni della capitale, ma fu un attivissimo "botanico da scrivania". Oltre a completare la pubblicazione dell'opera di Buxbaum, seminò nel giardino dell'Accademia i semi inviati dai suoi numerosi corrispondenti europei e raccolti dalle spedizioni di Orenburg, in Siberia e in Kamčatka e trasse un notevole erbario dagli esemplari adulti. Descrisse le specie nuove raccolte soprattutto da Heinzelmenn durante la spedizione di Orenburg, da Messerscmidt e da Gmelin in Siberia in Stirpium Rariorum in Imperio Rutheno Sponte Provenientium Icones et Descriptiones (1739) in cui descrisse 285 piante. Quest'opera illustrata, di grande impegno editoriale, fu una una delle prime a fare conoscere piante precedentemente inedite del Caucaso, dell'Asia centrale e della Siberia centro-meridionale. Oltre che con Sloane, era in corrispondenza con Collinson, Dillenius e Miller in Gran Bretagna cui inviò molte piante e ne ottenne i semi di molte piante nordamericane che fu il primo a introdurre in Russia. Fu uno dei primi corrispondenti di Linneo, neo professore a Uppsala, e molto contribuì al suo "giadino siberiano". Si ritiene che attraverso di lui abbiano fatto il loro ingresso nei giardini europei Lonicera tatarica, Gypsophila paniculata e Delphinium grandiflorum. Quando studiava a Leida, Amman aveva stretto amicizia con William Houstoun, che fu proprio la persona che lo presentò a Sloane. L'amico volle ricordarlo con uno dei nuovi generi da lui scoperti in Messico e nelle Antille, Ammania; egli non motivò la dedica, che però è confermata dalla testimonianza dell'amico comune Philip Miller. Linneo riprese il genere da Houstoun e lo ufficializzò in Species plantarum come Ammannia. In Critica botanica (1737) dichiara però di averlo dedicato al medico e botanico tedesco Paul Amman (1631-1694). Se pensiamo che all'epoca Johann Amman era ancora vivo, non aveva scritto nulla e la sua stessa corrispondenza con Linneo era ancora al di là da venire, non è strano che egli abbia cambiato il dedicatario. Inoltre, dal punto di vista di Linneo, Paul Amman (Paulus Ammannus) era certamente meritevole di essere ricordato. Direttore dell'hortus medicus di Lipsia nella seconda metà del Seicento ne fece il più importante della Germania; famoso per il suo sarcasmo e le sue critiche corrosive, oltre al primo catalogo del giardino, che comprende anche le piante della flora locale, scrisse Character plantarum naturalis (1676) in cui diede una prima diagnosi dei generi, basandosi principalmente sul frutto, e tentò una classificazione delle piante che riprende il sistema di Robert Morrison. Era dunque uno dei quei "sistematici" che Linneo considerava suoi predecessori. Per non fare torto né a Houstoun né a Linneo, ricordiamo dunque entrambi gli Amman, sia Johann sia Paul, delle cui vite troverete una sintesi nella sezione biografie. Il genere Ammannia L. (famiglia Lythraceae) - in seguito alla confluenza dell'affine genere Nesaea -comprende un centinaio di specie di piante erbacee acquatiche o di palude provenienti da varie zone temperate o tropicali; per lo più annuali, hanno fusti eretti o decombenti, che possono crescere sulle rive o fluttuare semisommersi, foglie da arrotondate a lanceolate o lineari, fiori minuti con 4-5 petali (ma talvolta apetali), in genere rosa, seguiti da capsule che contengono un grandissimo numero di semi. Questi ultimi, concavo-convessi, sono atti a fluttuare sulle acque e si mantengono vitali relativamente a lungo. Alcune specie (solitamente in precedenza classificate come Nesaea) sono utilizzate come piante da acquario. Tra di esse A. pedicellata, originaria di ambienti acquatici dell'Africa sudorientale, con folti ciuffi semisommersi di foglie lunghe e strette, che nella cultivar 'Golden' sono giallo dorato; A. gracilis ha invece foglie verdi nella parte inferiore e rosso vivo in quella superiore o emersa. Alcune specie sono presenti come avventizie nella nostra flora, soprattutto come occasionali infestanti delle risaie: A. coccinea (il nome deriva dal fatto che i fusti sono spesso rossastri) cresce in ambienti umidi della pianura padana, come fossi e arginelli delle risaie; A. robusta è segnalata in Lombardia e in Veneto; A. verticillata è naturalizzata in Sardegna e sporadicamente ritrovata altrove. Qualche approfondimento nella scheda. L'Università di Oxford vanta il più antico orto botanico della Gran Bretagna, fondato nel 1621, uno dei primissimi al mondo, nato addirittura prima di quello di Parigi. Ma per essere operativo ci mise vent'anni e per diventare un vero orto botanico universitario quasi mezzo secolo. A coltivarlo e custodirlo, due eccentrici personaggi: Jacob Bobart il vecchio e il giovane. Forse quasi tutto quello che si racconta su di loro appartiene più alla leggenda che alla realtà, ma sarebbe un peccato. In ogni caso, Linneo ne aveva abbastanza stima da onorarli con l'interessante genere Bobartia.  Bobart padre e figlio: due eccentrici? Nel 1621 un gentiluomo della corte di Carlo I Stuart, Henry Danvers, primo conte di Danby, fece dono all'Università di Oxford di 250 sterline per affittare un terreno dove allestire un «vivaio dei semplici, dove un professore di botanica passa leggere le piante e mostrare i loro usi e virtù agli uditori». Sicuramente guardava ai modelli italiani; sappiamo che suo fratello minore John era un grande appassionato di giardini e ne aveva creato uno raffinatissimo a Chelsea, appunto sul modello italiano. Tuttavia la benemerita impresa partì con il piede sbagliato: fu scelto un terreno appartenente al Magdalene College situato sulla riva del fiume Cherquell soggetto a periodiche inondazioni; fu necessario bonificarlo con centinaia e centinaia di carrettate di buona terra e proteggerlo con un muro. Prima che fosse pronto, erano passati dodici anni. Di pianta quadrata, era un hortus conclusus al quale si accedeva da una porta monumentale, diviso in quattro quadranti da due viali perpendicolari. Era costato 5000 sterline, e ormai il generoso donatore era a corto di quattrini. Fu così che solo nel 1641 poté ingaggiare un abile giardiniere per prendersi cura del giardino, Aveva pensato addirittura a John Tradescant, che però mori prima di assumere l'incarico. Ripiegò allora sul tedesco Jacob Bobart. Le fonti lo dicono nativo di Brunswick, un ex soldato arrivato in Inghilterra per sfuggire alla guerra dei Trent'anni. Il contratto stipulato con Danby gli concedeva il diritto di usare e vendere i frutti del giardino. Ma già nel 1644 il nobiluomo morì, mentre ormai imperversava la guerra civile. Le sue proprietà furono poste sotto sequestro dai seguaci del Parlamento, e Bobart si trovò senza stipendio. A permettergli di mantenere se stesso e la numerosa famiglia (sposato due volte, ebbe due figli e una nidiata di sei figlie) più ancora dei prodotti dell'hortus medicus, o Physic garden, erano il commercio di piante medicinali e esotiche e la locanda The Greyound Inn, situata proprio di fonte al giardino. Era un giardiniere appassionato e di talento, ma anche alquanto bizzarro: ostentava una lunga barba, che nei giorni di festa ornava con tasselli d'argento, e come animale da compagnia, anziché un cane, teneva un caprone. Per venticinque anni, fu il signore e padrone del giardino, che trasformò in un paradiso terrestre: ai lati della porta monumentale, dispose una coppia di tassi a mo’ di guardiani, creò mirabili sculture verdi in topiaria, piantò tutte le piante esotiche che poté procurarsi nonostante il periodo difficile. Nel 1648 ne pubblicò il primo catalogo, anonimo: le specie e varietà, menzionate con il nome comune e una frase descrittiva in latino, sono 1639. Circa seicento sono native, ma ci sono anche numerose specie nordamericane. Poi la guerra finì, e così l'effimera Repubblica inglese. Nel 1660 Carlo II recuperò il trono e tornò in Inghilterra accompagnato dal medico personale e botanico reale Robert Morison. Proprio lui nel 1669 (48 anni dopo la fondazione) divenne il primo professore di botanica di Oxford e il primo direttore dell'orto botanico (praefectus horti). Bobart il vecchio era già sulla settantina e non sappiamo come prese la convivenza. Forse, a collaborare con il neo professore, più che lui, fu suo figlio Jacob il giovane, che già nel 1658 aveva aiutato il padre a scrivere una seconda edizione del catalogo. Morison era un grande botanico, ma era anche celebre per la sua alterigia: come Ray, era alla ricerca di un metodo naturale per classificare le piante e riteneva che tutti i botanici del presente e del passato che si erano imbarcati nella stessa impresa avessero scritto solo fregnacce (allucinazioni, Hallucinationes, diceva lui). Riuscì a convincere l'Università di Oxford a pubblicare la sua ambiziosissima Historia Plantarum Universalis Oxoniensis, in cui intendeva presentare tutte le piante note, catalogandole in gruppi naturali sulla base dei frutti e dei semi. Il compito dei Bobart era procurargli le piante e allestire l'erbario. Probabilmente Jacob il giovane (non risulta invece che lo avesse fatto il padre) lo assisteva durante le dimostrazioni delle piante (anche a Parigi le lezioni pratiche erano impartite dal capo giardiniere). Nel 1680 succedette al padre come curatore del giardino e nel 1683, alla morte improvvisa di Morison in seguito a un incidente stradale, ne divenne praefectus; fu nominato professore assistente e l'Università gli affidò il completamento di Historia Plantarum Universalis. Morison aveva fatto in tempo a pubblicare solo il secondo volume; Bobart riuscì a completare il terzo, mentre il primo non fu mai scritto. Senza essere un botanico di primo piano, se la cavò con scrupolo e onore, aggiungendo anche molte piante nuove, ma ebbe cura di espungere i feroci attacchi di Morison contro gli "allucinati" botanici del passato e del presente. Tuttavia, la costosissima impresa editoriale portò la casa editrice universitaria sull'orlo del fallimento. Vissuto fino in tarda età, poco prima della morte fu costretto alle dimissioni, con grande rincrescimento di William Sherard che era stato suo allievo e ne aveva grande stima. Il suo maggiore merito è la creazione di un grande erbario, che costituisce il primo nucleo dell'Erbario dell'Università di Oxford. Su di lui si racconta un curioso aneddoto: avendo trovato nel giardino un grosso topo morto, ne alterò la testa e la coda e ne distese la pelle per simulare due ali, in modo che assomigliasse all’immagine tipica di un drago. Esaminato dai professori di Oxford, l’artefatto fu creduto autentico e celebrato in versi nelle società erudite; qualcuno ne spedì persino una descrizione a Antonio Magliabechi, bibliotecario del granduca di Toscana. Solo a questo punto Bobart confessò l’inganno. Un visitatore lamentò che, con la mani e la faccia sporche di terra, più che un grande botanico, sembrava un qualsiasi giardiniere. 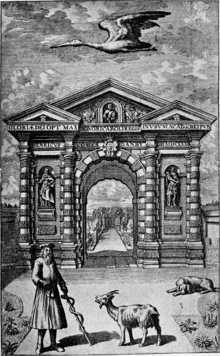 Leggenda e realtà Fin qui l'immagine tradizionale dei due Bobart: due eccentrici dai modi anticonvenzionali, due figure pittoresche. Ma come capita spesso, quando una storia è troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. La studiosa tedesca Karin Seber, che ha attentamente studiato le poche fonti disponibili su Jacob il vecchio, è giunta alla conclusione che quasi tutto ciò che sappiamo su di lui è falso o va interpretato in modo totalmente diverso. In primo luogo, non era affatto un oscuro soldato tedesco senza né arte né parte giunto in Inghilterra dalla natia Brunswick. Apparteneva a un'eminente famiglia (il nome originale è Bobert) di mercanti di Danzica, e forse era addirittura figlio del borgomastro della città; uno dei suoi parenti - forse un fratello - commerciava con l'Olanda; come dimostrano i libri che lasciò al figlio e furono poi da questi donati all'Univeristà, già in patria aveva studiato botanica medica. Seber ipotizza che si sia trasferito in Inghilterra come mercante, forse già specializzato nel commercio di piante medicinali e altri semplici. Difficile pensare che lord Danby, che avrebbe voluto ingaggiare John Tradescant, giardiniere del re e massimo esperto di giardinaggio del tempo, abbia assunto al suo posto un signor nessuno. Forse già prima di entrare al suo servizio, Bobart aveva affittato (o acquistato) la locanda, utilizzandone i terreni per coltivare piante medicinali e i locali come base del suo commercio, facendosi notare per la sua grande competenza di giardiniere e esperto di piante officinali. Secondo Seber, anche le sue abitudini bizzarre vanno rilette; nel frontespizio di Vertumnus, un poema di Abel Evans in onore di Jacob il giovane, alla sinistra della porta monumentale del giardino è stato rappresentato il suo primo custode con una chioma fluente e una lunga barba; nella mano sinistra impugna il bastone di Asclepio, simbolo della medicina. Accanto a lui, una capra (simbolo della voracità naturale domata dalle arti del giardiniere?); più oltre un cane addormentato. Dunque, quei tratti eccentrici fanno parte di una voluta autorappresentazione come depositario e custode dei segreti delle erbe medicinali. Ovviamente, anche la storia del drago di Oxford è stata rimessa in discussione dagli scettici, che fanno notare che la prima attestazione scritta (nella Biographical history of England di Granger e Walpole) è del 1774, più di mezzo secolo dopo la morte del suo protagonista; inoltre non è mai stato trovato neppure uno degli scritti che gli sarebbero stati dedicati dalle società erudite. Forse dunque l'aneddoto è altrettanto posticcio quanto il topo-dragone. D'altra parte, sta a testimoniare la fama di eccentricità che circondava i Bobart, padre e figlio.  I fiori effimeri di Bobartia Linneo in persona li stimava abbastanza da dedicare loro il genere Bobartia, della famiglia Iridaceae. Con una quindicina di specie, tutte sudafricane, anzi ristrette alle Provincia del Capo, questo piccolo genere è caratterizzato da sottili rizomi orizzontali o eretti, ciuffi di foglie sottili che in alcune specie ricordano il giunco, lunghi scapi fiorali con infiorescenze terminali di fiori lievemente asimmetrici con sei tepali solitamente gialli (ad eccezione di B. lilacina, che li ha lilla chiaro). Sono graziosi, ma di breve durata (meno di una giornata). Forse questo spiega perché le specie di questo genere sono raramente coltivate. Vivono per lo più in ambienti montani, con terreni sabbiosi e poveri di nutrienti, e tendono a fiorire più copiosamente dopo gli incendi. Qualche informazione in più nella scheda. Nel Seicento, l'Olanda vive il suo secolo d'oro. E' il paese più prospero d'Europa, all’avanguardia nei commerci, nelle scienze, nella cultura, nell’arte. E nei giardini: gli olandesi, sfruttando la loro secolare esperienza nel sottrarre terra al mare, ridisegnano la natura e creano un nuovo modello di giardino, in cui le siepi sagomate dalle forbici dei giardinieri disegnano stanze, padiglioni, teatri di verzura. A differenza del giardino all’italiana, in cui il verde domina, il giardino barocco olandese è colmo di fiori, con parterre multicolori simili ai tappeti persiani tanto amati da Vermeer o Rembrandt. Molti mercanti che si sono arricchiti con i traffici o le industrie investono il loro denaro in tenute di campagna che spesso ospitano vasti giardini, uno status symbol del loro potere e della loro ricchezza. Non possono mancare collezioni di piante esotiche: sono alla base della prosperità dell'Olanda e sono anche il simbolo del suo dominio sul mondo, il segno tangibile di quel nuovo Eden, paradiso in terra ricostruito, che per qualche decennio i Paesi Bassi si illudono di essere. E così non è un caso se Paul Hermann, il più importante botanico olandese del secolo, battezza Paradisus batavus, "Paradiso olandese", il suo libro dedicato alle rarità coltivate in quei giardini. Rarità che molto ha contribuito a introdurre in Europa, prima come esploratore del Capo di Buona Speranza e dell'isola di Ceylon, poi come direttore dell'Orto botanico di Leida. Linneo lo stimava tanto da proclamarlo "principe dei botanici" e da dedicargli, complice Pitton de Tournefort, il genere Hermannia.  Sud Africa, Ceylon... Leida Nel 1658, dopo una lunga guerra in cui intervenne a fianco dei sovrani locali (che ancora non sapevano che stavano per sostituire un occupante con l'altro), la VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie, Compagnia olandese delle Indie orientali) espulse definitivamente il Portogallo da Ceylon (oggi Sri Lanka). Da quel momento, esercitò il monopolio del commercio della cannella dell'isola, la migliore in assoluto. Ma impiegati e ufficiali si ammalavano con allarmante frequenza di malattie sconosciute in Europa che i farmacisti e i chirurghi al servizio della Compagnia non sapevano come curare; le medicine portate dall'Europa nel clima tropicale non sempre servivano e perdevano presto la loro efficacia; era urgente studiare la flora locale alla ricerca di piante medicinali alternative. Un influente uomo politico, Hieronymus van Beverningh, che era anche un accanito collezionista di piante esotiche, e il prefetto dell'orto botanico di Leida Arnold Seyen raccomandarono il giovane medico tedesco Paul Hermann (1646-1695), da poco laureato alla prestigiosa università di Padova; si dice fosse interessato alle piante fin da bambino, quando, a dieci anni, rischiò di annegare per esaminare delle piante acquatiche. I suoi sponsor speravano che, oltre a soddisfare gli obiettivi della Compagnia, potesse anche arricchire le loro collezioni. Dunque, in un certo senso Hermann è il primo cacciatore di piante al servizio di un orto botanico. Partito per Ceylon all'inizio del 1672, ad aprile approfittò dello scalo al Capo di Buona Speranza per raccogliere piante sudafricane; e altrettanto fece durante il viaggio di ritorno, nel marzo del 1680. A parte il precedente della piccola raccolta di Justus Heurnius (che però era un teologo, non un botanico), si tratta del primo contatto di un botanico europeo con la flora del Capo. Con gli esemplari raccolti (circa 800, secondo la testimonianza di Linneo) formò un erbario; spedì semi e bulbi in Olanda, e altri li affidò al chirurgo di bordo Hieremias Stolle, di ritorno in Europa. Questi a sua volta li passò all'anatomista danese Thomas Bartholin che nel 1775 pubblicò la breve nota "Plantae novae Africanae", la prima pubblicazione a stampa dedicata esclusivamente a piante sudafricane. A Ceylon, come "medico ordinario e medico capo" della VOC, Hermann si stabilì a Colombo, sede del quartier generale della Compagnia; creò e diresse un ospedale, esplorò assiduamente la flora dei dintorni, annotando i nomi locali e le proprietà medicinali delle piante. Con questi materiali mise insieme diversi libri di erbari e almeno un volume di illustrazioni (non è certo se di sua mano o di altri anonimi disegnatori); inoltre inviò più volte bulbi e semi in Olanda. Sebbene siano limitate alla zona intorno a Colombo (gli olandesi controllavano solo alcune aree costiere) e includano anche diverse specie coltivate introdotte, le sue raccolte sono impressionanti per quantità e per la qualità delle annotazioni, senza contare l'eccezionale valore storico, trattandosi del primo studioso europeo a esplorare la flora dell'isola, ai suoi occhi un vero Eden. Intorno al 1674 visitò anche brevemente il Malabar dove forse incontrò van Rheede, che potrebbe averlo consultato per il progetto che poi divenne Hortus malabaricus. L'esplorazione della flora singalese diede grande fama a Hermann, tanto che nel 1678, alla morte di Arnold Seyen, i rettori dell'Università di Leida decisero di chiamarlo a succedergli come professore di botanica e prefetto dell'Orto. Hermann accettò e tra la fine del 1679 e l'inizio del 1680 lasciò Ceylon per tornare in Olanda. Nelle sue lezioni, fu il primo botanico olandese a prestare attenzione alla tassonomia; creò anche un proprio sistema, basato sui frutti, che univa e modificava quelli di Ray e Morison. Oltre che a Leida, fu adottato in altri orti botanici, tra cui Uppsala ai tempi di Rudbeck il vecchio. Deciso a fare dell'Orto di Leida il migliore d'Europa, solitamente dedicava le pause accademiche a viaggi in altri paesi europei per consultare colleghi e appassionati e procurarsi piante; nel 1682 fu in l'Inghilterra, dove visitò tra l'altro gli orti botanici di Oxford e Chelsea, e ne riportò più di 200 piante vive (soprattutto nord americane); nel 1688 andò a Parigi ad incontrare Tournefort; qui strinse amicizia con l’inglese William Sherard, che decise di seguirlo a Leida. Dal 1686, assunse anche l'insegnamento di medicina pratica. Durante la sua gestione, l'orto botanico di Leida divenne il principale centro europeo di acclimatazione e diffusione delle piante provenienti dalle colonie americane, africane e asiatiche. Oltre alle sue introduzioni dirette dall'India e dal Sud Africa, poté sfruttare i suoi contatti con la VOC e con i principali collezionisti olandesi, nonché con l'Inghilterra e la Francia, per triplicare le collezioni (il suo catalogo del 1687 registra tremila specie, contro le circa 800 di inizio secolo); molte erano subtropicali o tropicali. Nel 1681, fu tra i primi a sperimentare una serra riscaldata. 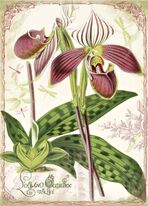 Olanda, un secondo Eden? Hermann morì nel 1695 a soli 49 anni (qui una sintesi biografica), lasciando incomplete e inedite diverse opere; l’unico suo libro pubblicato in vita fu infatti il catalogo dell’orto botanico di Leida (1687). Quella a cui teneva di più, e a cui lavorava da diversi anni, era Paradisus batavus, un catalogo illustrato delle piante di recente introduzione nei giardini olandesi. Già nel 1689 l'affezionato Sherard ne aveva pubblicato l’indice, e alla morte inaspettata del maestro e amico si assunse il compito (ingrato, visto lo stato del manoscritto) di curarne la pubblicazione; a spese della vedova di Hermann, l’opera uscì in una prima edizione relativamente economica in ottavo nel 1695, e in una seconda più pregevole edizione in quarto nel 1705 . Entrambe comprendono un centinaio di calcografie, su disegni in gran parte di mano dello stesso Hermann; per numerose specie, si tratta della prima immagine a stampa. Nonostante sia un lavoro diseguale (a causa della morte dell’autore, le piante sono trattate in modo variamente esteso e in alcuni casi l'illustrazione è priva di note d'accompagnamento) è di estremo interesse per la storia dell’introduzione delle piante orticole; tra di esse, come ho raccontato in questo post, le prime due orchidee tropicali coltivate in Europa. Ma è anche un documento in presa diretta della civiltà olandese del giardino nel secolo d’oro. Tra i giardini citati, oltre agli orti botanici di Leida e Amsterdam e a quelli principeschi di William e Mary (divenuti sovrani d’Inghilterra nel 1689, in seguito alla gloriosa rivoluzione), quelli di importanti uomini politici: il suo protettore Hieronymus van Beverningh, il segretario degli stati d’Olanda Simon van Beaumont, il pensionario di Haarlem Gaspar Fagel, il ciambellano Willem Bentinck (poi primo duca di Portland). Per questi uomini di potere, i giardini e il collezionismo di piante esotiche e rare avevano un preciso significato ideologico: come leggiamo in Den Nederlandtsen Hovenier , il popolare manuale di giardinaggio scritto da Jan van der Groen (circa 1635-1672), capo giardiniere dello statolder, la caduta di Adamo aveva reso imperfetta la natura, ma l’arte, la domesticazione e l’ordine potevano restituire la perfezione perduta e i giardini erano la prova materiale della riuscita dell’impresa. Il titolo del libro di Hermann, Paradisus batavus «paradiso olandese», si rifà esplicitamente a questa ideologia. Nel 1717, le note di campo scritte da Hermann a Ceylon furono pubblicate, sempre da Sherard, sotto il titolo Musaeum Zeylanicum. Ma per la storia della botanica sono molti più importanti gli erbari. Hermann aveva raccolto centinaia di esemplari sia per sé, sia per i suoi sponsor; al rientro da Ceylon, consegnò almeno un libro d’erbario a Beverningh e un altro a Jan Commelin, direttore dell'orto botanico di Amsterdan. Dopo la sua morte, la vedova, probabilmente per finanziare la stampa di Paradisus batavus, vendette il resto all’asta. Per cinquant’anni, se ne perse ogni traccia, finché nel 1744 giunsero nelle mani del farmacista reale danese August Günther cinque volumi, quattro d’erbario e uno di disegni. Günther li prestò a Linneo, che se ne servì sia per la sua unica pubblicazione sulla flora asiatica, Flora Zeylanica, sia per le piante singalesi di Species plantarum. Dopo diversi altri passaggi, il prezioso erbario fu acquistato da Joseph Banks e fa oggi parte delle collezioni del Natural History Museum di Londra. Il volume appartenuto a Commelin fu invece studiato dal botanico olandese Johannes Burman per il suo Thesaurus Zeylanicus.  Deliziose (e misconoscite) Hermanniae Hermann era stimatissimo dai botanici della generazione immediatamente successiva: Boerhaave lo definì «incomparabile per la conoscenza delle piante», Johannes Burman lo chiamò «sommo lume dell’Università di Leida». Quanto a Linneo, che premise a Flora Zeylanica una biografia di Hermann così elogiativa da sconfinare nella agiografia, lo salutò «principe dei botanici», un titolo che di solito riservava a se stesso, e scrisse: «Non c’era al mondo un botanico pari a Hermann per i meriti e le scoperte» . Grande stima ne aveva anche Tournefort che gli dedicò il genere Hermannia , sulla base dell’unica specie allora nota (nome attuale Hermannia hyssopifolia), una delle acquisizioni sudafricane di Hermann; il genere fu poi fatto proprio da Linneo . Hermannia L. della famiglia Malvaceae è un grande genere soprattutto sudafricano, dunque perfetto per celebrare il primo esploratore della flora del Capo. A parte una specie australiana e pochissime specie distribuite tra Messico e zone adiacenti degli Stati Uniti, buona parte delle circa 160 specie sono africane, 81 delle quali endemiche del Sud Africa, soprattutto delle province del Capo occidentale e settentrionale. Il genere è molto vario, e si è adattato a un’altrettanto grande varietà di ambienti. Sono piante erbacee o piccoli arbusti, spesso striscianti. Le specie che vivono nel veld tendono a lignificare alla base e a formare un fusto legnoso sotterraneo, in grado di superare i periodi di siccità o anche gli incendi. Anche se sono poco utilizzate nei giardini, molte specie sono assai decorative grazie alle masse di fiori penduli a campana, spesso in delicati colori pastello. Ne troverete una piccola selezione nella scheda. Il medico austriaco di origine croata Nicolaus Thomas Host dedicò tutta la vita alla ricerca, alla pubblicazione e alla valorizzazione della flora nativa del vasto e variegato impero austriaco, tanto da fondare un "Giardino delle terre della Corona". E' dunque curioso che oggi sia ricordato, più che per questa impresa o per le sue pubblicazioni, per aver dato il nome a un genere che arriva da molto lontano. Le specie del genere Hosta, oggi tra le piante più amate e coltivate, sono infatti originarie dell'Estremo oriente. Le prime hanno fatto timidamente la loro comparsa in pochi orti botanici europei negli ultimi anni del Settecento; la loro vera diffusione in Europa si deve però a Siebold, che a partire dal 1830 ne importò dal Giappone una ventina tra specie e varietà. Questa rimase più o meno la situazione per circa un secolo, tanto che si dice che buona parte delle piante coltivate in Europa all'inizio del '900 discendesse in un modo o nell'altro dagli esemplari importati da Siebold. Ancora nel 1950, in Olanda se ne coltivavano non più di una trentina di varietà. Ma nel secondo dopoguerra la selezione di cultivar e ibridi è cresciuta in modo esponenziale, tanto che ormai essi si contano a migliaia (anche più di 10.000 secondo alcune fonti). 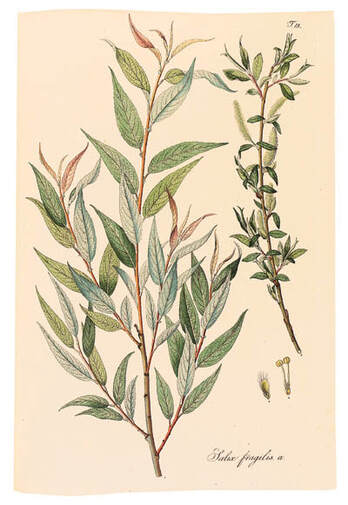 Alla ricerca delle piante native La monarchia asburgica, nata dall'accumulo secolare di eredità disparate più ancora che dalle conquiste territoriali, è nota per essere l'antitesi dello stato nazionale: ne facevano parte territori molto diversi tra loro per lingua, cultura, storia, strutture economiche. Ovviamente, queste considerazioni valgono anche per l'ambiente naturale: dalla vegetazione tipicamente alpina del Tirolo a quella continentale dell'Austria orientale e della Pannonia, per non parlare delle aree con flore peculiari come l'Istria. Con i cinque volumi della spettacolare Florae austriacae (1773-78), Nicolaus Joseph von Jacquin aveva cominciato a rendere disponibile questo variegato patrimonio; tuttavia, il suo lavoro si limitava all'arciducato d'Austria, escludendo dunque non solo territori che oggi fanno parte di altri stati come l'Ungheria, la Croazia, la Boemia, l'Istria, la Carniola, la contea di Gorizia, ma anche la Stiria, la Carinzia, l'Austria anteriore, il Tirolo, il principato di Salisburgo. Forse non è strano che l'idea di allargare l'indagine quanto più possibile a tutti questi territori, che all'epoca erano raggruppati sotto l'etichetta Kronländer, "terre della corona", sia venuta a un suddito dell'impero originario di una regione di confine: il croato Nicolaus Thomas (o Nikola Toma) Host. Era a nato a Fiume / Rijeka, una città multietnica che dopo aver fatto parte per circa duecento anni prima della Carniola quindi della Bassa Austria, dal 1776 era stata unita al regno d'Ungheria come porto franco e corpus separatum, ovvero entità autonoma. Molto giovane Host si trasferì a Vienna per studiare medicina; fu accolto nell'entourage di von Jacquin, suo professore di botanica, e strinse amicizia con suo figlio Joseph Franz; insieme i due iniziarono ad esplorare la flora di aree ancora poco studiate, come la Stiria, il Tirolo, l'Istria. Laureatosi nel 1786, Host rimase a Vienna dove si fece un nome come medico, tanto nel 1792, a poco più di trent'anni, fu scelto come medico personale dall'imperatore Francesco II che più tardi lo volle come consigliere. Nel frattempo Host aveva continuato ad alternare all'attività professionale lunghe escursioni nelle terre della corona, incluse l'Ungheria e la Croazia, raccogliendo non solo esemplari d'erbario ma anche piante vive e semi che coltivava nel suo giardino. Nel 1793 propose all'Imperatore di creare un orto botanico esclusivamente dedicato alle piante native; Francesco II, grande appassionato di botanica, accolse la proposta con entusiasmo e gli mise a disposizione un'area del parco di Belvedere, adiacente all'orto botanico imperiale. Durante i suoi soggiorni estivi sul Danubio, l'imperatore si faceva suo allievo e gli chiese di dare lezioni ai suoi fratelli minori, gli arciduchi Johann, Anton e Rainer. Per il loro uso, Host creò un giardino didattico nel parco di Schönbrunn con le piante collocate secondo il sistema di Linneo. Il primo nucleo del Garten der Kronländer fu costituito dalle piante coltivate da Host nel suo giardino privato, cui si aggiunsero via via le piante native che andava raccogliendo nelle sue escursioni botaniche in molte parti dell'Impero. Funzionale alla realizzazione del giardino fu anche la prima pubblicazione di Host, Synopsis plantarum in Austria (1797), che contiene molte nuove specie; a differenza della monumentale opera illustrata di Jacquin, costosissima, stampata in poche copie e diventata presto quasi irreperibile, vuole essere un'opera di consultazione il più possibile completa (conta oltre 600 pagine) ma relativamente agile e di ampia diffusione; proprio per questo è priva di illustrazioni. Il capolavoro botanico di Host tuttavia è Icones et descriptions graminum austriacorum (1801-09), una magnifica opera in quattro volumi in folio con le illustrazioni di Johann Ibmayer che illustra le graminacee dell'Austria e dell'Europa centrale. Ugualmente splendido è Salix (1808), anch'esso illustrato da Ibmayer, dedicato ai salici delle provincie austriache. L'ultima fatica di Host fu ancora un'opera complessiva sulla flora dei territori asburgici, Flora austriaca, in due volumi (1827-1831), particolarmente importante per l'inclusione di specie di aree all'epoca poco note e ricche di endemismi, l'Istria e la Dalmazia, con tavole tratte da acquarelli di Ibmayer. Anche se Host è stato a volte criticato perché tendeva a moltiplicare le specie, classificando come specie distinte qualsiasi variazione, si tratta di lavori molto importanti che arricchirono notevolmente la conoscenza della flora dell'Austria e delle aree limitrofe. Host morì a Schönbrunn nel 1834. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Sembra che dopo la sua morte il giardino che aveva concepito, creato e diretto sia caduto presto nella trascuratezza. Intorno al 1865, quanto rimaneva della collezione di piante alpine fu trasferita al Belvedere e divenne il primo nucleo dell'attuale giardino alpino.  Hosta, una po' di storia Come medico imperiale ed esponente di punta della scuola botanica di Vienna, Host era in contatto con molti colleghi in patria e all'estero. Tra i suoi corrispondenti ed amici troviamo anche Leopold Trattinick che 1812 volle onorarlo ribattezzando Hosta plantaginea una pianta giapponese precedentemente pubblicata da Thunberg come Hemerocallys japonica. Nacque così il genere Hosta, famiglia Asparagaceae; oggi è una superstar dei giardini, ma a quel tempo solo due specie erano arrivate in Europa ed erano ancora una curiosità coltivata in pochissimi orti botanici. A rigori, il nome di Trattinick era illegittimo, perché la denominazione era già stata utilizzata da von Jacquin per un genere poi riconosciuto sinonimo di Cornutia. Nel 1817 il botanico prussiano Kurt Sprengel propose una denominazione alternativa, ribattezzando il genere Funkia, in onore del botanico bavarese Heinrich Christian Funck. Questo nome ottenne un certo successo, tanto da fornire il nome comune in varie lingue, tra cui il tedesco Funkie; venne inoltre largamente usato in campo orticolo ed è ancora presente in vecchie pubblicazioni. Tuttavia, anche la denominazione di Sprengel era altrettanto illegittima, perché preceduta da Funckia Willd. (sinonimo di Astelia). Per farla corta (vennero proposte anche altre denominazioni, che però per una ragione o per l'altra non si affermarono), la questione venne risolta solo nel 1905, quando il Congresso internazionale di botanica optò per Hosta. E così, un botanico che aveva dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla valorizzazione della flora nativa si è trovato associato a un genere che arriva da molto lontano, ovvero dall'Estremo oriente (Cina, Giappone, Corea, Russia sud-orientale). Il primo incontro tra i botanici europei e le Hosta avvenne in Giappone, dove queste piante sono chiamate giboshi e, oltre a crescere in natura (le isole giapponesi sono il centro di diversità del genere) sono coltivate almeno dall'ottavo secolo. Engelbert Kaempfer, che soggiornò a Deshima tra il 1690 e il 1692 come medico della Compagnia olandese orientale, descrisse e disegnò Joksan, vulgo gibbooschi Gladiolus plantagenis folio che è stata identificata come Hosta lancifolia. Quasi un secolo dopo fu la volta di Carl Peter Thunberg, che fu a Deshima tra il 1775 e il 1776 e pubblicò due specie, assegnandole al genere Hemerocallis. Tuttavia le prime specie di Hosta raggiunsero l'Europa dalla Cina. La prima fu H. plantaginea, arrivata nel Jardin des Plantes di Parigi nel 1784 grazie ai semi inviati dal console francese a Macao. I semi germinarono e nel 1788 Lamarck descrisse la pianta come Hemerocallis plantaginea. La seconda specie arrivò a Londra nel 1790 e qualche anno dopo fu descritta da Salisbury come Bryocles ventricosa. Ma il personaggio più importante per l'introduzione delle Hosta in Europa fu senza dubbio Philipp Franz von Siebold, anche lui medico a Deshima per la Compagnia olandese delle Indie tra il 1823 e il 1828. Al suo ritorno in Europa ne portò con sé diversi esemplari, aprendo anche un proprio vivaio a Leida; più tardi, quando poté ritornare in Giappone, ne importò altri ancora; grazie a lui, il numero di specie o cultivar coltivate in Europa passò di colpo da due a una ventina. Non a caso, due tra le specie più note portano il suo nome: H. sieboldiana e H. sieboldii. Dall'Europa le Hosta raggiunsero anche gli Stati Uniti; tuttavia negli anni '70 Thomas Hogg, un vivaista che lavorava in Giappone per il governo statunitense, aprì un canale di importazione diretto. Le Hosta incominciarono via a via ad acquistare popolarità, ma fino alla seconda guerra mondiale le varietà disponibili erano ancora più o meno quelle note nell'Ottocento. Intorno al 1950, nei Paesi Bassi, se ne coltivavano una trentina di specie. Si era alla vigilia della grande esplosione dei nuovi ibridi e della selezione di cultivar sempre nuove, il cui numero nell'arco di mezzo secolo è cresciuto in modo esponenziale. Nel 2009 il vivaista e ibridatore americano Mark Zilis nella sua Hostapedia ha elencato 7000 tra specie, ibridi e cultivar. Ovviamente, quelle non selezionate sono ancora di più. Altre informazioni su questo genere molto amato nella scheda, dove troverete soprattutto una selezione di link per approfondire la conoscenza con il "pianeta Hosta". |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed