|
Il "Viaggio di scoperta alle Terre australi", più noto come "Spedizione Baudin", avrebbe dovuto assicurare la gloria scientifica della nuova Francia di Napoleone; invece, nonostante gli indubbi successi, con la ricognizione di ampi tratti delle coste australiane e la raccolta di migliaia di esemplari, è passato alla storia come una spedizione maledetta. Defezioni, malattie e morti ne falcidiarono l'imponente équipe scientifica: alla partenza da Le Havre, a bordo del Géographe e del Naturaliste, senza contare uno stato maggiore di una sessantina di eccellenti ufficiali, diversi dei quali recentemente diplomati dell'Ecole polytechnique, c'erano ventidue tra scienziati e artisti; alla partenza da Mauritius alla volta dell'Australia, il secondo gruppo si era ridotto a quattordici (contando anche due artisti reclutati nel frattempo); alla partenza da Port Jackson per la seconda parte della spedizione, erano diventati nove. In Francia ne tornarono solo sei, tre dei quali morirono nel giro di pochi anni in seguito alle malattie contratte durante il viaggio. Dunque, un vero disastro sul piano umano, non compensato dai risultati scientifici, imponenti ma in gran parte rimasti inediti. Occorreva un capro espiatorio, e fu facilmente trovato nel capitano Baudin: un outsider ammesso da pochissimo nella marina militare, dopo aver servito per anni una potenza nemica, per di più impossibilitato a difendersi, essendo morto lui stesso durante il viaggio. A costruire la leggenda nera provvidero solerti gli autori della relazione ufficiale, prima lo zoologo Péron poi l'ufficiale Louis de Freycinet, che per motivi diversi nutrivano astio nei confronti dello sventurato comandante. Solo in anni relativamente recenti, la pubblicazione del giornale di bordo di Baudin ha permesso di riequilibrare un poco quel quadro. Eppure, i risultati erano sotto gli occhi di tutti: nel parco della Mailmaison scorrazzavano canguri ed emù e cigni neri si dondolavano sul laghetto, mentre i giardini e i viali di Francia incominciavano a popolarsi di eucalipti e di mimose, germinate dai semi giunti dall'Australia. Tra ufficiali-cartografi e scienziati, contando sia quelli che rimasero fino alla fine sia quelli che lasciarono la spedizione, sono almeno una dozzina quelli che hanno ricevuto l'onore di un genere botanico; due soli sono validi, e per una strana coincidenza ricordano due dei salvati tornati a Le Havre a bordo del Géographe: l'ultimo comandante, Pierre Bernard Milius, colui che lo riportò in Francia dopo la morte di Baudin, e l'unico tra i giardinieri o botanici rimasto fino alla fine: il ragazzo giardiniere Antoine Guichenot, sedicenne quando lasciò Le Havre. La spedizione si sfilaccia: Le Havre-Ile de France Dopo il successo della spedizione della Belle Angelique e la trionfale partecipazione alla Festa della libertà, Nicolas Baudin, che ormai godeva della stima e dell'amicizia di Antoine Laurent de Jussieu, il direttore del Museum National, propose al Direttorio una missione scientifica più ambiziosa: niente meno che la circumnavigazione del globo, per rinnovare la gloria del viaggio di Bougainville in salsa repubblicana. Sempre a corto di quattrini, il Direttorio tergiversò, finché Baudin e i suoi sponsor del Museum tornarono alla carica con il nuovo padrone della Francia, Napoleone Bonaparte. Il primo console ricevette il capitano e una delegazione dell'Institut national des sciences et des arts, approvò il progetto, ma fissò una meta e un compito più circoscritti: l'esplorazione e la mappatura delle coste meridionali, occidentali e settentrionali della Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Non di meno, per il numero di persone coinvolte e l'ampiezza degli obiettivi scientifici, che oltre alla cartografia includevano mineralogia, astronomia, zoologia, botanica ed etnografia, si trattava di un'impresa grandiosa, che avrebbe dovuto sancire la preminenza scientifica della nuova Francia. Nulla fu lasciato al caso. Una commissione, che comprendeva molti dei più bei nomi del Museum, stilò precise istruzioni (quelle antropologico-etnografiche furono scritte da Cuvier), l'itinerario venne fissato nei minimi particolari, furono allestite due corvette di recente fabbricazione, la Galathée et la Menaçante, prontamente ribattezzate Géographe e Naturaliste, cui venne aggiunto un ponte per ricavare spazio per le provviste, le attrezzature e il personale scientifico, costituito da ben 22 tra scienziati, giardinieri e artisti. La attrezzature erano all'ultimo grido e comprendevano persino un alambicco per distillare e rendere potabile l'acqua marina. Si era in guerra, e fu necessario ottenere il beneplacito dell'Inghilterra, che fu concesso grazie alla mediazione di Joseph Banks, anche se lui stesso e la Royal Navy temevano che dietro quella facciata scientifica si nascondessero mire coloniali; ecco perché venne immediatamente allestita una contro-spedizione, quella del capitano Matthiew Flinders sull'Investigator, con la missione dichiarata di mappare le coste dell'Australia e quella segreta di sorvegliare i francesi. Il Géographe e il Naturaliste salparono da Le Havre il 19 ottobre 1800. A bordo del Géographe, comandato da Nicolas Baudin con l'assistenza del capitano di fregata Alexandre Le Bas de Sainte Croix, c'erano 118 uomini, tra ufficiali (tra i quali vale la pena di segnalare almeno il figlio di Bougainville Hyacinthe e Henri de Freycinet), marinai, personale di bordo, e un'équipe scientifica che comprendeva il geografo Charles-Pierre Boullanger, l'astronomo Frédéric Bissy, il mineralogista Louis Depuch, gli zoologi René Maugé, Stanislas Levillain e François Péron, il botanico Jean Baptiste Leschenault de La Tour, i giardinieri Anselme Riedlé, Antoine Sautier e Antoine Guichenot, gli artisti Louis Lebrun e Jacques Gerard Gilbert. Erano invece 120 le persone imbarcate sul Naturaliste, comandato dal capitano di corvetta Jacques Félix Hamelin des Essarts con l'assistenza del secondo Pierre Bernard Milius; tra gli ufficiali, il minore dei Freycinet, Louis; l'équipe scientifica comprendeva il geografo Pierre Ange Faure, il mineralogista Joseph Charles Bailly, l'astronomo Pierre-François Bernier, gli zoologi Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, i botanici Jacques Delisse e André Michaux, assistito dai giardinieri Jean François Cagnet e Merlot (un ex schiavo nero quattordicenne che Michaux aveva portato con sé dagli Stati Uniti), l'artista Michel Garnier. Sul Géographe, fin dall'inizio si creò un solco tra Baudin e i suoi ufficiali: quasi tutti di origine aristocratica, giovani, ambiziosi, diversi di loro da poco diplomati all'École polytechnique, mal tolleravano un comandante venuto dalla marina mercantile, che oltre tutto aveva servito per anni sono bandiera nemica; il carattere chiuso e autoritario di Baudin non aiutava. Il 2 novembre le navi gettarono l'ancora a Tenerife, dove si trattennero undici giorni. Michaux fu ospite di Broussonet, sull'isola in qualità di commissario delle relazioni commerciali del governo francese, che informò i compatrioti dell'imminente partenza per l'Europa di un battello con prigionieri inglesi; alcuni marinari ne approfittarono per disertare. Ma soprattutto nacquero le prime tensioni tra Baudin e i naturalisti: dopo qualche giorno passato a fare entusiasmanti raccolte, furono trattenuti a bordo in attesa di un'imminente partenza che però veniva rinviata di giorno in giorno. Eppure l'ordine non valeva per gli antichi compagni di Baudin sulla Belle Angélique, il giardiniere Riedlé e gli zoologi Maugé e Levillain. Le navi lasciarono Tenerife il 13 novembre, con qualche inconveniente dovuto alla maggiore lentezza del Naturaliste e alla difficoltà di allineamento tra le due navi. Al largo di Madera, il Géographe fu fatto segno di un colpo di cannone da un vascello spagnolo, che lo aveva scambiato per una nave britannica. Fu forse il rischio di altri incontri pericolosi a far optare Baudin per una rotta più prossima alla costa africana, anziché quella consueta più vicina alla costa brasiliana (alcuni però pensano a una scelta obbligata, dovuta alla caduta degli alisei); rallentata dalla bonaccia, la navigazione si allungò di un mese e mezzo. Con due conseguenze disastrose: il moltiplicarsi di casi di scorbuto e il crollo della fiducia nelle capacità marinare del comandante. Il Capo di Buona speranza venne avvistato solo a metà gennaio, senza farvi scalo. Dopo aver superato una tempesta, l'Ile de France fu raggiunta il 16 marzo 1801, con due mesi buoni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Qui le navi avrebbero dovuto esser rifornite di viveri e attrezzature, rifiutati però dalle autorità locali che avevano i magazzini sguarniti e temevano un attacco inglese. Baudin fu costretto a ricorrere a un prestito garantito dal console danese. Molti degli uomini erano malati, quasi tutti erano scontenti. A rompere gli indugi fu forse l'esempio di André Michaux. Il vecchio botanico, contrariato dalle regole d'ingaggio che stabilivano che le raccolte sarebbero appartenute esclusivamente allo Stato, diede le dimissioni, seguito dai suoi aiutanti Merlot e Cagnet. Dichiarandosi malati, lo imitarono l'astronomo Bissy, gli zoologi Bory de Saint-Vincent e Desiré Dumont, il farmacista e botanico Jacques Delisse e tutti gli artisti. Baudin, che non credeva più di tanto a queste malattie più o meno diplomatiche, non li rimpianse, accontentandosi di trasferire Bernier sul Géographe e di sostituire gli artisti con due giovani di talento che si erano imbarcati come aiuto-cannonieri, Charles Alexandre Lesueur e Nicolas Martin Petit. Gli spiacque molto di più la diserzione di ventun marinai. 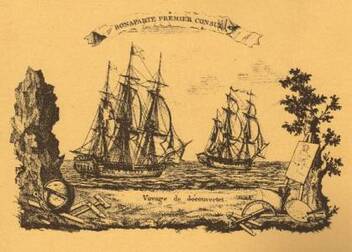 Malattia a bordo: Ile de France-Port Jackson È dunque con l'équipe scientifica dimezzata e gli effettivi ridotti che la spedizione riparte il 25 aprile 1801. Eccetto due giorni di tempesta, la navigazione è tranquilla e sospinta da venti favorevoli; la costa australiana è avvistata all'altezza del Capo Leuwen il 27 maggio. A causa del ritardo accumulato, Baudin ha infatti deciso di iniziare le ricognizioni non dalla Tasmania, secondo le istruzioni del Ministero della marina, ma dalla costa occidentale. Il primo contatto dei naturalisti con la terra australiana è nei pressi del capo che viene battezzato Naturaliste (31 maggio): i francesi si stupiscono nel vedere come una terra così arida ospiti una tale varietà di alberi e arbusti. Viene quindi esplorata la baia battezzata Géographe, dove va perduta una lancia e annega un marinaio. Il 10 giugno una tempesta separa le due navi. Avendo mancato i diversi punti d'incontro, non si riuniranno fino a Timor. Il Géographe esplora la costa tra Shark Bay e il North-West Cape, e in particolare l'isola Bernier dove l'attivissimo capo giardiniere Riedlé fa molte raccolte interessanti; poi, con diversi casi di scorbuto a bordo e provviste al lumicino, fa vela per Timor dopo getta l'ancora il 22 agosto. Il Naturaliste invece esplora a fondo la foce dello Swan river e le isole adiacenti, poi anch'esso si dirige a Timor, dove giunge un mese dopo l'ammiraglia. Lo scalo a Timor è necessario per rifornire la nave, ma notoriamente pericoloso. Molti si ammalano di dissenteria e muoiono sei uomini, tra cui il capo giardiniere Riedlé. Quando le navi lasciano Timor, il 13 novembre, i malati a bordo sono molti; tra di loro anche Leschenault, che è stato trasferito sul Naturaliste. Con grande gioia di Baudin, deve invece rimanere a terra il suo detestato secondo Le Bas de Sainte Croix, rimasto ferito in un duello contro l'ingegnere Ronsard. Lo sostituisce il maggiore dei Freycinet, Henri, Ora la spedizione fa rotta verso la Terra di van Diemen (ovvero la Tasmania). Prima di raggiungerla, sul Géographe si contano altri sette morti, tra cui il giardiniere Sautier (15 novembre) e lo zoologo Levillain (23 dicembre). Il 13 gennaio 1802 le due navi navigano lungo il Canale d’Entrecasteaux che separa la Tasmania dall'isola Bruny, dove gettano l'ancora. Il giorno dopo incontrano per la prima volta un gruppo di aborigeni. Iniziano a mappare accuratamente le coste sud-orientali dell'isola. Il 18 gennaio gettano l'ancora nella Great Oyster Bay, sulla costa occidentale di Maria Island. Qui muore e viene sepolto Maugé, che non si è mai ripreso; è un grave colpo per il comandante che con lui perde l'ultimo compagno della Belle Angelique e forse l'unico amico. Il 27 febbraio le due navi lasciano l'isola e fanno rotta a nord per continuare la ricognizione della costa orientale della Tasmania. Il 6 marzo un canotto con il geografo Boullanger, l'aspirante Maurouard e sei marinai è incaricato di rilievi più ravvicinati, ma a causa del cattivo tempo perde il contatto con il Géographe; tre giorni dopo, è recuperato dal brigantino inglese Harrington, che porta i francesi a bordo del Naturaliste, il quale a sua volta ha perso di vista l'altra nave. Come in precedenza, anche questa volta tutti i punti d'incontro verranno mancati, a partire da quello di Waterhouse, dove le due corvette passano il 19 marzo, a poche ore di distanza, senza riuscire a vedersi a causa della nebbia. Non si incontreranno più fino a Port Jackson (Sidney). Dopo qualche giorno di tempo tempestoso, Hamelin riprende i rilievi della costa orientale della Tasmania; ne parte il 7 aprile, e dopo aver fissato la posizione del Wilson Promontory e mappato la costa di Western Port, essendo a corto di viveri e acqua, fa rotta per Port Jackson dove getta l'ancora il 26 aprile. Ne riparte il 18 maggio, ma non avendo potuto doppiare la Tasmania a causa del cattivo tempo, vi rientra il 28 giugno. Invece Baudin, navigando verso nord, il 27 marzo ha raggiunto il Wilson Promontory e ha proseguito esplorando da est a ovest la costa meridionale dell'Australia. L'8 aprile si vede arrivare incontro un'altra nave: pensa si tratti del Naturaliste, invece è l'Investigator di Matthew Flinders: ovviamente, il capitano inglese sa benissimo che i francesi potrebbero essere da queste parti, e a ogni buon conto ordina di armare i cannoni, ma fa anche issare la bandiera bianca. I due capitani ignorano che pochi giorni prima (il 25 marzo) è stata firmata la pace d'Amiens; per quanto ne sanno, i loro paesi sono in guerra. Ma dopo tutto comandano una missione scientifica. L'Investigator affianca il Géographe e Flinders sale a bordo, i due capitani si salutano cordialmente e scambiano informazioni sulle loro rispettive scoperte. Un secondo incontro si avrà il mattino dopo. Il punto d'incontro (a 5 miglia dalla costa meridionale dell'Australia di fronte all'attuale Adelaide) sarà battezzato da Flinders Encounter Bay. Nonostante l'entusiasmo per aver incontrato un collega che stima e di cui conosce l'abilità di cartografo, Baudin è certo deluso per aver scoperto di non essere il primo ad aver mappato la costa meridionale dell'Australia, per altro solo per un breve tratto. Quindi la navigazione riprende. Poco dopo l'incontro con gli inglesi, nel golfo di St Vincent la nave è sballottata da onde così violente che Baudin lo ribattezza Golfe de la Mauvaise. Il 25 aprile il Géographe tocca le isole St Peter e St Francis, mappa la costa est della penisola Eyre, finché la scarsità di viveri e le malattie che continuano a imperversare a bordo convincono Baudin a raggiungere Port Jackson; il cattivo tempo lo costringe a prendere la rotta più lunga e difficile che contorna la Tasmania. Arriverà a Port Jackson il 20 giugno; il 28 le due corvette si riuniscono dopo quasi quattro mesi di separazione.  Ritorno: Port Jackson-Ile de France-Francia Accolti ospitalmente dagli inglesi (nonostante qualche tensione in occasione del decennale della Repubblica il 22 settembre 1802), i francesi si fermano a Port Jackson per quasi cinque mesi. A corto di uomini per le morti e le malattie, Baudin decide di acquistare una nave più piccola e più adatta ai rilievi oceanografici, la Casuarina (così chiamata dal legname usato per costruirla) e di rinviare in Francia il Naturaliste, con a bordo le carte, le memorie, le osservazioni scientifiche e le collezioni fatte nella prima parte del viaggio. A preparare le piante vive è il giovanissimo apprendista giardiniere Antoine Guichenot (sedicenne al momento della partenza, ora deve avere circa diciotto anni), l'unico rimasto dopo la defezione o la morte dei suoi quattro compagni. Nonostante i pochi anni, è solerte e capace, ed accompagna Baudin a bordo del Naturaliste per un'ultima ispezione quando il comandante vi sale per impartire a Hamelin dettagliate raccomandazioni su come trattare quel traporto tanto fragile quanto prezioso. Le tre navi lasciano insieme Port Jackson il 18 novembre; il 6 dicembre gettano l'ancora in una baia dell'isola King che appare letteralmente ricoperta di leoni marini, da cui il nome Sea Elephant Bay; agli occhi dei francesi, l'isola, con la sua vegetazione lussureggiante, la ricchezza di acqua e l'abbondanza di animali, è un vero paradiso terrestre. Péron, Lesueur, Guichenot e Leschenault, che si è riunito agli amici, sono ovviamente i più entusiasti, e vi si attardano alcuni giorni, mentre il Géographe è tenuto al largo dal cattivo tempo. Nel frattempo la Casuarina, comandata dal più giovane dei fratelli Freycinet, è stata inviata ad esplorare le isole Hunter. L'8 dicembre, mentre il Naturaliste si prepara alla partenza, arriva da Port Jackson la Cumberland, comandata dal capitano Charles Robbins, spedita dal governatore King per accertarsi che i francesi non abbiano l'intenzione di preparare un insediamento in Tasmania. Hamelin viene a sapere da uno degli uomini di Robbins che loro stessi hanno lo stesso compito, ma non ne informa Baudin. Poco dopo c'è l'addio definitivo. Il Naturaliste arriverà a le Havre il 7 giugno 1803, dopo essere stato trattenuto per breve tempo dagli inglesi a Portsmouth. Il 15 dicembre, nel corso delle manovre d'attracco nella Sea Elephant Bay, il Géographe perde una lancia. Riuscirà ad ancorarsi e a recuperare i naturalisti solo il 25 dicembre. Due giorni dopo si riunisce con la Casuarina e i due vascelli procedono insieme fino all'isola dei Canguri (scoperta l'anno prima da Flinders), di cui cartografano la costa meridionale. Quindi la Casuarina va ad esplorare i golfi St Vincent e Spencer, mentre il Géographe è all'ancora all'Eastern Cove, con gli uomini impegnati nella costrizione di una nuova lancia; ne parte il 1 febbraio 1803 e fa vela verso ovest; alle due è segnalata, in direzione opposta, la Casuarina: Freycinet non vira per seguire il comandante, e le due navi rimarranno separate per due settimane. Raggiunta la costa del continente nei pressi di Streaky Bay, il 7 febbraio il Géographe getta l'ancora a Denial Bay; durante la sosta di quattro giorni per i rilievi cartografici, i naturalisti hanno modo di incrementare le loro raccolte. Intanto la Casuarina ha visitato alcune delle isole Nuyts, per poi dirigersi verso il King George Sound, dove il 17 febbraio le due navi si riuniscono. L'area viene attentamente mappata, permettendo di nuovo ai naturalisti di scendere a terra. E' forse il luogo dove Guichenot e Leschenault fanno le raccolte più abbondonati. Il 20 febbraio, il sotto-luogotenente Ransonnet, che sta esplorando un tratto di costa, incontra la nave baleniera americana Union il cui comandante il giorno dopo fa visita a Baudin; in ricordo di questo incontro, la baia verrà denominata Two People Bay. Il 1 marzo la spedizione lascia il King George Sound, per doppiare il capo Leuwen e risalire la costa occidentale dell'Australia. Le due navi si perdono ancora una volta di vista, finché il 13 marzo si ritrovano alla Rottnest Island, fissata come punto d'incontro. Proseguono insieme fino a Shark Bay, dove Péron, Lesueur e Guichenot fanno notevoli raccolte, quindi esplorano la costa dal North-West Cape a un gruppo di isole, ribattezzato Bonaparte Archipelago. Alla fine di aprile, Baudin, già assai malato di tubercolosi, decide di dirigersi a Timor, per caricare acqua e rifornimenti. Vi arrivano il 6 maggio e ne ripartono il 3 giugno; Leschenault, anch'egli gravemente malato, viene lasciato a terra. Le due navi si dirigono a sud est, per iniziare la ricognizione della costa settentrionale dell'Australia, che esplorano fino all'altezza dell'isola Melville; il 5 giugno Bernier muore per una febbre contratta a Timor. L'equipaggio è sfinito, l'acqua sempre più scarsa, il comandante quasi in fin di vita: il 7 luglio, si rassegna a mettere fine alla spedizione e a tornare in Francia via Mauritius. Il Géographe vi arriva il 7 agosto, seguito il 12 dalla Casuarina, da cui era stato separato per l'ennesima volta da una tempesta. Il 16 settembre Baudin muore e viene sepolto con gli onori dovuti al suo rango, ma poco rimpianto dai suoi uomini. La Casuarina viene disarmata e venduta; uomini, attrezzature e raccolte vengono trasferite sul Géographe, che affronta l'ultimo tratto di viaggio sotto il comando di Pierre Bernard Milius. Nel maggio 1802 il secondo di Hamelin era stato lasciato malato a Port Jackson. Prima dell'arrivo del Géographe e del ritorno del Naturaliste, si era imbarcato per Canton e da qui nel febbraio 1803 aveva raggiunto l'Ile de France. Tra gli ufficiali della spedizione, è il più anziano, per questo viene preferito (con grande disappunto di quest'ultimo) al secondo di Baudin, Henri de Freycinet. Con un grande carico di collezioni portate da Timor e dalla Nuova Olanda o procurate in loco, il Géographe lascia il porto di Saint Louis il 16 dicembre, per terminare il suo viaggio a Lorient il 25 marzo 1804. Altre piante vengono aggiunte durante lo scalo al Capo di Buona Speranza.  Bilancio: disastro o successo? Il disastro umano, con la morte del comandante, di metà dei membri dell'équipe scientifica e di un decimo dell'equipaggio (una percentuale per altro non inconsueta nei viaggi oceanici dell'epoca) ha finito per eclissare i risultati geografici e scientifici della spedizione, che furono notevolissimi ma rimasero poco noti perché molto parzialmente pubblicati. Lo scopo principale della missione, rilevare le coste sud, ovest e nord dell'Australia, visitando le aree ancora ignote e rettificando le carte, era stato raggiunto almeno per la costa est della Tasmania, la costa ovest e ampi tratti della costa meridionale dell'Australia. A sancire questi risultati, la pubblicazione nel 1811 della cosiddetta "carta di Freycinet", inclusa nella seconda parte dell'Atlante storico che accompagna la relazione ufficiale del viaggio, scritta da Péron e Louis de Freycinet. Tuttavia, la spedizione di Baudin si intrecciò con quella di Flinders, con uno strascico di polemiche sulla priorità delle scoperte tra francesi e britannici che oscurò in parte anche questo successo. Per le scienze naturali, i contributi maggiori riguardano la zoologia e l'antropologia, e si devono alla stessa persona, François Péron. Con la defezione di Bory de Saint Vincent e Dumont e la morte di Levillain e Maugé, questo giovane allievo di Cuvier (aggregato alla spedizione soprattutto per le ricerche antropologiche), divenuto il solo zoologo della spedizione, dovette estendere il suo campo d'indagine alla biologia marina (il suo settore d'elezione), alle osservazioni metereologiche e all'intera fauna, Era un vero personaggio romantico (basti pensare che si era imbarcato in seguito a una delusione amorosa), con un carattere focoso e appassionato, ambizioso e ribelle che, spinto dal suo zelo di conoscenza, spesso si trovò in conflitto con Baudin. Preso dalla foga dell'esplorazione, tendeva a trascurare ogni prudenza e ad allontanarsi rischiando di perdersi e di ritornare ormai esausto e sulla soglia della disidratazione. Una di queste imprese (che ebbe come teatro la penisola della Shark Bay che oggi porta il suo nome e ospita il François Péron National Park) portò all'esasperazione il capitano Baudin che il 19 marzo 1803 scrisse sul giornale di bordo: "E' la terza scappata di questa natura che combina il nostro colto naturalista, ma sarà anche l'ultima, perché non gli permetterò più di scendere a terra, a meno che io stesso sia sulla stessa barca". Con l'aiuto dei disegnatori Lesueur e Petit, Péron mise insieme una collezione di 100.000 esemplari di 4000 specie diverse di cui 2500 nuove per la scienza. Impegnato nella stesura della relazione ufficiale della spedizione e morto pochi anni dopo il ritorno in Francia (durante la spedizione anche lui si era ammalato di tubercolosi), non poté catalogare e pubblicare le sue raccolte, che tuttavia diedero un contributo fondamentale alla conoscenza della fauna australiana, di cui poterono usufruire Lamarck e gli autori del Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle. Molto importanti anche le sue osservazioni antropologiche, soprattutto sui popoli aborigeni della Tasmania, che di lì a pochi anni sarebbero stati quasi totalmente sterminati dalle malattie e da una guerra genocida. Di fronte all'immensità delle collezioni del prorompente zoologo, quelle botaniche sembrano passare in secondo piano; anch'esse non furono pubblicate né dell'unico botanico sopravvissuto, Jean-Baptiste Leschenault de La Tour (tornato in Francia solo nel 1807) né da La Billardière, cui furono affidate come esperto di flora australiana. In realtà, erano di notevole importanza e hanno lasciato una traccia tangibile nel paesaggio francese (e non solo). Secondo Antoine Laurent de Jussieu, l'erbario messo insieme da Riedlé, Sautier, Guichenot e Leschenault conteneva non meno di 1500 specie, in numerosi esemplari, preparati e conservati in modo eccellente. Come abbiamo visto, Riedlé morì durante il primo scalo a Timor e Sautier ebbe la stessa sorte durante la navigazione verso la Tasmania; così tutto il lavoro botanico ricadde sui due più giovani e inesperti, Guichenot sul Géographe e Leschenault sul Naturaliste. Si deve certamente a loro il grosso delle raccolte botaniche che riempivano le stive e il ponte del Naturaliste nel suo viaggio di ritorno e, secondo una testimonianza dell'epoca ammontavano, a più di mille pacchi di semi e cinquantacinque casse di piante; c'erano inoltre 3.560 esemplari d'erbario, raccolti da Riedlé, Leschenault e Maugé, ben impacchettati in 14 casse. Ancora maggiori le raccolte della seconda parte della spedizione, in cui i due poterono lavorare fianco a fianco; contando anche gli esemplari caricati all'Ile de France e al Capo di Buona Speranza, si trattava di 63 casse o mezzi barili con più di mille piante vive, cui vanno aggiunte due casse di semi e cinque casse di esemplari d'erbario. Durante il lunghissimo viaggio verso l'Europa, ovviamente le piante vive ebbero molto a soffrire. Thouin, che visitò il Naturaliste poco dopo l'arrivo della nave a Le Havre, dovette tristemente constatare che su circa 800 individui raccolti tra Timor e la Nuova Olanda, forse venti davano ancora segni di vita, e non più di 12 o 15 sembravano in buona salute; tutti gli altri erano morti per mancanza d'acqua o erano stati distrutti dai ratti che infestavano la nave. Un inventario redatto qualche mese dopo, cita tra le piante sopravvissute qualche albero da frutto cinese imbarcato all'Ile de France e sette piedi di Phormium tenax. Alcuni semi contenuti nelle balle di terra, fatte prudentemente trasportare al Museum, germinarono: erano graminacee e alcune specie dei generi Opercularia, Mimosa, Casuarina. Ventenat, nel suo splendido catalogo del giardino della Malmaison (cui, secondo le disposizioni di Napoleone, era destinato il meglio delle raccolte), cita espressamente quattro piante nate da semi trasportati dal Naturaliste: quella con cui volle incensare la neo-imperatrice Josephinia imperatricis (oggi Sesamum imperatricis), Apium prostratum, Hibiscus heterophyllus e Callistachys lanceolata. Il ricco carico del Géographe, che, anziché essere lasciato a se stesso, poté godere delle cure di Guichenot, ebbe sorte migliore, ma molte piante morirono per il freddo e le piogge incessanti in cui la nave incappò alla latitudine di Bordeaux. Ne sopravvissero circa 230; 98 tra le specie più sane furono scelte da Mirbel, il sovrintendente della Mailmaison, per le serre dell'imperatrice. Alcune furono poi moltiplicate per essere acclimatate nella Francia meridionale, soprattutto a Tolone e Nizza. Tra queste ultime, varie specie dei generi Ecalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, Acacia, tra cui la più nota di tutte, A. dealbata, ovvero la mimosa, che fiorì per la prima volta alla Malmaison nel 1811. Dunque, da molti punti di vista, un successo. Ma non quello che Napoleone avrebbe voluto: la gloria di aver mappato per primi le coste australiane era venuta meno e c'erano troppi morti e troppi errori da occultare. Farlo era semplice: attribuire tutto il buono a ufficiali, cartografi e scienziati, tutto il cattivo al capitano Baudin. Che essendo morto, non poteva difendersi. Un aneddoto vuole che, al rientro della spedizione, Napoleone abbia esclamato: "Baudin ha fatto bene a morire. Altrimenti l'avrei fatto fucilare". E' certamente apocrifo, ma rende bene l'idea. I primi a spargere maldicenze sul capitano erano stati ovviamente alcuni dei transfughi di Mauritius, desiderosi di attribuire la responsabilità della loro defezione a Baudin, raffigurato come incompetente, tirannico, vendicativo, nonché corrotto. Il colpo di grazia gli fu inferto dal resoconto ufficiale,Voyage de découvertes aux terres australes: exécuté par ordre de Sa Majesté l'empereur et roi, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la goëlette le Casuarina, pendent les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, scritto da François Péron e completato da Louis de Freycinet. Come si vede fin dal titolo, Baudin è sparito. Infatti Péron evita di nominarlo se non in modo indiretto (notre commandant) e non esita a denigrarlo, spesso alterando i fatti; inoltre, per compiacere Napoleone, spesso e volentieri attribuisce nomi francesi a luoghi già scoperti dagli inglesi: così la costa sud-est dell'Australia diventa Terre Napoléon; in seguito alle proteste inglesi, queste denominazioni verranno cancellate nell'edizione definitiva del 1815, curata da Freycinet. Se le radici dell'astio dell'aristocratico Freycinet, che insieme al fratello maggiore più volte si era scontrato con Baudin, sono chiare, perché Péron si prestò? Alcuni parlano di vecchie ruggini, altri di ambizione, ma forse la spiegazione più convincente è che capitano e zoologo non potevano intendersi perché incarnavano due modi di concepire il sapere: Baudin (e i suoi raccoglitori Levillain, Maugé e Riedlé) quello dell'enciclopedismo settecentesco, Péron (e in qualche senso Leschenault) quello della specializzazione dei saperi. Purtroppo per Baudin, l'operazione riuscì perfettamente e la sua spedizione fu nota al mondo attraverso il resoconto alterato di Péron e Freycinet. Solo in tempi recenti, la pubblicazione dei diari di bordo, il confronto tra le testimonianze e le ricerche di archivio hanno cominciato a rendergli giustizia. Determinante è stata anche la mostra The Art of Science: Baudin’s Voyages 1800–1804, a cura del National Museum of Australia (30 marzo-24 giugno 2018), con molti materiali prestati dal Muséum d’histoire naturelle di Le Havre, tra cui i disegni e le splendide tavole di Lesueur per l'Atlas che accompagnava il resoconto ufficiale. Di notevole interesse anche il sito The Baudin Legacy project, a cura dell'Università di Sidney.  Epilogo: omaggi botanici La spedizione ha lasciato una notevole traccia nella nomenclatura botanica; tra i suoi membri, almeno una dozzina sono stati onorati dalla dedica di un genere botanico, anche se alcuni di loro lo hanno guadagnato in circostanze precedenti o successive. E' il caso ovviamente di André Michaux, che da tempo si era conquistato questo alloro con i suoi viaggi in Oriente e in America. Meriti successivi lo assicureranno agli altri transfughi di Mauritius Jean-Baptiste Bory de St Vincent e Jacques Delisse, che meritano un post a parte, così come Louis de Freycinet e Jean-Baptiste Leschenault de La Tour, per i quali il Viaggio nelle terre australi fu il preludio ad altre avventure. Generi oggi ridotti a sinonimi sono toccati sia a Baudin (ne ho già parlato qui) sia al comandante del Naturaliste Jacques Félix Hamelin des Essarts; ma forse quest'ultimo deve il genere Hamelinia (Asteliaceae, sinonimo di Astelia), dedicatogli nel 1832 da Achille Richard, soprattutto alle sue successive imprese militari, grazie alle quali divenne barone dell'impero; come eroe delle guerre napoleoniche, il suo nome figura sull'Arc de Triomphe, il solo di un ufficiale navale. Allo stesso modo, non fu solo la solerzia con cui trasportò in un porto francese le piante e gli animali della spedizione Baudin ad aver fatto guadagnare il genere Miliusa all'ultimo comandante del Géographe Pierre Bernard Milius (1773-1829). Egli fece infatti una notevole carriera amministrativa. Dal 1818 al 1821 fu governatore della Réunion (all'epoca ancora Ile Bourbon), dove intraprese molte iniziative come la costruzione di un canale e di strutture portuali e la fondazione del Collège Royal de Borbon e della Société philotechnique de Bourbon. Interessato alle arti e alle scienze, incoraggiò l'esplorazione botanica di Nicolas Bréon, il fondatore e primo direttore del Jardin du Roi dell'isola; in contatto epistolare con Leschenault de La Tour, che all'epoca si trovava in India, favorì e incoraggiò in ogni modo l'importazione di piante indiane a Bourbon. Al suo ritorno in Francia, portò con sé una pianta allora rara originaria del Madagascar, e ne donò tre esemplari all'orto botanico di Bordeaux, sua città natale. Si tratta dell'oggi notissima "spina di Cristo", ovvero Euphorbia milii, che lo celebra nell'epiteto (in cui il suo cognome francese è curiosamente declinato come se fosse una parola latina). Tra il 1823 e il 1825 fu governatore della Guaiana. Nel 1827, al comando del Scipion, si segnalò alla battaglia di Navarino, Il genere Miliusa gli fu dedicato a Alphonse de Candolle sulla base di un esemplare raccolto in India da Leschenault. Appartenente alla famiglia Annonaceae, comprende una sessantina di specie di alberi o arbusti eretti diffusi tra l'Asia tropicale e subtropicale e l'Australia settentrionale, con centri di diversità in India e in Tailandia. Diverse specie sono utilizzate nella medicina tradizionale: ad esempio M. balansae per le gastropatie, M. velutina come tonico e afrodisiaco, M. thorelii come analgesico. Veniamo ora ai naturalisti. A François Péron sono stati dedicati due generi Peronia, nessuno dei quali oggi accettato. Nel 1811, quindi poco dopo la sua morte, Delaroche, autore dei testi del celebre volume di Redouté Les liliacées, gli dedicò Peronia stricta, che era fiorita proprio quell'anno per la prima volta al Museum national da semi di origine ignota venuti dall'Inghilterra; la pianta fu poi identificato come Thalia dealbata. Nel 1832 volle ricordarlo anche Robert Brown, che era diventato buon amico di Péron e Leschenault durante lo scalo a Port Jackson; Peronia R.Br. è oggi sinonimo di Sarcosperma. Sono stati giustamente onorati tutti e tre i giardinieri che rimasero con Baudin, a cominciare dal capo giardiniere Anselme Riedlé (1765–1801); allievo di Thouin formato al Jardin des Plantes, aveva già preso parte alla spedizione della Belle Angélique. conquistandosi l'amicizia e la stima di Baudin. Durante la spedizione fu attivissimo, facendo raccolte sia a Tenerife sia negli scali lungo la costa occidentale dell'Australia, dove raccolse semi, esemplari d'erbario e piante vive. In questa fase, fu un maestro e un punto di riferimento non solo per i suoi due aiutanti, ma per lo stesso Leschenault che in precedenza non aveva quasi esperienza di raccolte sul campo. Purtroppo fu vittima della dissenteria che colpì la spedizione a Timor; fu sepolto con tutti gli onori nel cimitero di Kupang accanto alla tomba in cui riposava David Nelson, il botanico dello sventurato viaggio del Bounty. Baudin disegnò personalmente la sua tomba, ma non poté presenziare alle esequie, essendo a sua volta malato. Anche a lui furono dedicati due generi Riedlea oggi non riconosciuti: nel 1802 da Mirbel (sinonimo di Onoclea) e nel 1807 da Ventenat (sinonimo di Melochia). Ammalatosi anche lui a Timor come il suo capo, ben presto ne seguì la sorte l'assistente giardiniere Antoine Sautier (ca. 1771-1801); nato a Parigi, probabilmente lavorava anche lui al Museum e aveva 29 anni al momento della partenza. Decaisne, che nel 1834 gli dedicò Sautiera, oggi sinonimo di Dyscoriste, lo ricorda per "lo zelo, con il quale arricchì il Museo di un gran numero di oggetti nuovi". L'unico genere valido è toccato al solo sopravvissuto, il "garzone giardiniere" Antoine Guichenot (1783-1867). Figlio di un militare che prestava servizio alla Menagerie del Jardin des Plants e della responsabile delle sementi, era praticamente nato del giardino, ma al momento dell'ingaggio non aveva pressoché esperienza di erborizzazioni sul campo. Era quasi illetterato (le sue note d'erbario sono scritte con un'immaginifica ortografia fonetica), ma era un lavoratore instancabile e un grande osservatore, tanto che le sue note sono spesso più dettagliate di quelle dello stesso Leschenault. Va certamente a lui gran parte del merito della raccolta (per non parlare della conservazione in vita) delle piante vive del Géographe. Baudin, che ne apprezzava la dedizione e lo zelo, gli dedicò Guichenault Point, un promontorio della penisola Péron nella Shark Bay. Dopo il ritorno a Parigi, Guichenot tornò a lavorare come giardiniere al Museum; poco sappiamo sulla sua vita, eccetto alcuni aneddoti raccolti in un articolo comparso nel 1861 sul Bulletin de la Societé imperiale zoologique d'acclimatation. Dopo aver informato i lettori che all'epoca Guichenot si era stabilito a Couets nei pressi di Nantes, l'autore M. Pépin riferisce che, benché si trovasse in una situazione difficile, in seguito alla morte del padre e di due fratelli, lo scrupoloso giardiniere resistette "alle offerte più seducenti" rifiutando di vendere sottobanco i semi di una Banksia per cui un botanico inglese gli offriva 25 franchi il pezzo nonché una rara conchiglia di cui aveva raccolto numerosi esemplari. Nel 1814 fu decorato con l'ordine del giglio. Forse fu il padre dello zoologo del Museum Alphonse Antoine Guichenot, che risulta figlio di un giardiniere della stessa istituzione. E' invece infondata e dovuta alla confusione con Gaudichault, il botanico della spedizione, la notizia che abbia preso parte al viaggio dell'Uranie al comando di Freycinet. La dedica del genere Guichenotia da parte di Jacques Étienne Gay (1821) appare quanto mai azzeccata e opportuna. Si tratta infatti di un genere australiano, di cui il giovane giardiniere, insieme a Riedlé e Leschenault, raccolse la prima specie conosciuta, G. ledifolia, nel 1801 durante il primo passaggio della spedizione a Shark Bay. Oggi assegnato alla famiglia Malvaceae (in precedenza Sterculiaceae), è affine ai generi Thomasia, Lysiosepalum e Lasiopetalum, comprende 16-17 specie di arbusti endemici dell'Australia occidentali. Adattati all'estrema aridità di questa regione, hanno foglie lineari e coriacee e graziosi fiori a campanella. Quelli di G. macrantha, la specie più nota e coltivata, negli Stati Uniti sono commercializzati come Aussie Bells, "campanelle australiane".
0 Comments
Nella storia australiana, Allan Cunningham è noto soprattutto come esploratore, per aver aperto nuove vie di comunicazione e scoperto diversi valichi, tra cui quello che porta il suo nome (Cunningam's Gap); tuttavia, anche dopo essere stato coinvolto dal governatore Brisbane nell'esplorazione del territorio della colonia, egli continuò a sentirsi in primo luogo un botanico che, come scrisse a Kew, aveva trovato il modo di "mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". Finite le spedizioni marittime guidate del capitano King, tra il 1822 e il 1829 Cunningham perlustrò gran parte del Nuovo Galles del sud, per poi essere incaricato di trovare vie di collegamento con il Queensland, e prese parte a più di venti spedizioni, almeno una delle quali diretta e organizzata da lui stesso. Un viaggio lo portò anche in Nuova Zelanda. Senza però mai smettere di raccogliere piante: secondo l'amico e primo biografo Robert Heward, durante i suoi quindici anni australiani furono oltre 3000 specie. Moltissime sono quelle che lo ricordano nel nome specifico, Alania cunninghamii anche in quello generico. Senza dimenticare il genere Cunninghamia, che divide con il quasi omonimo James Cunighame.  Tra fatiche e speranza Il 25 aprile 1822, con il rientro a Sydney della Bathurst, si concludeva la prima fase delle avventure australiane di Allan Cunnigham, quella marittima (l'ho raccontata in questo post). L'infaticabile botanico del re rivolgeva ora la sua attenzione all'interno del paese. Dopo aver dedicato qualche mese a preparare i materiali da spedire a Kew (fase a cui dedicava ogni attenzione e che sempre lo preoccupava sommamente, per il lunghissimo viaggio che attendeva i suoi campioni e le fragili piante vive), già a settembre era di partenza: superate le Blue Mountains, per tutto il mese fu impegnato ad erborizzare nell'area compresa tra Bathurst e il fiume Cudgegong, spingendosi anche a oriente di quest'ultimo. I risultati di questa spedizione attirarono l'attenzione del nuovo governatore del Nuovo Galles del Sud, sir Thomas Brisbane, che lo incaricò di cercare una via di collegamento tra Bathurst e le Liverpool Plains scoperte da Oxley nel 1818. Cunningham, che da tempo coltivava la passione per l'esplorazione, accettò di buon grado e scrisse a Kew: "'Ho scoperto di poter mescolare l'esplorazione con la ricerca botanica tollerabilmente bene". L'appoggio logistico offerto dal governatore tornava per altro comodo, visto il magro salario e gli scarsi finanziamenti londinesi. Nel marzo 1823 Cunningham, accompagnato da cinque servitori e altrettanti robusti cavalli da soma, partì da Bathurst dirigendosi verso nord in direzione del Lawson's Goulburn River, poi a est fino alle sorgenti del fiume Hunter. Da qui risalì la Liverpool Range alla ricerca di un valico; dal Mount Macarthur (oggi Mount Moan) vide a est un punto in cui catena di abbassava e decise di muovere in questa direzione, ma il cammino si fece sempre più difficile, finché risultò bloccato da ogni parte da ripidi burroni. Non restava che tornare indietro fino al Mount Macarthur, per cercare un passaggio in direzione nord-ovest. L'infruttuosa deviazione era costata tre settimane e tre giorni. Dopo altri sei giorni di cammino lungo la catena, il 2 giugno Cunningham decise di salire nuovamente su una cima: guardandosi intorno, a non più di tre miglia scorse una notevole depressione, al di là della quale si intravvedevano pianure aperte. Cunningham aveva scoperto il Pandora's Pass: gli diede questo nome pensando, da una parte, alle privazioni e alle difficoltà del viaggio, dall'altra alla piccola speranza che aveva trovato alla fine, che gli facevano pensare al mito di Pandora che, quando apre il suo vaso, sparge nel mondo ogni male, ma in fondo le rimane la speranza. Raggiunto il valico il 9 giugno, ritornò infine a Bathrust il 27 giugno, dopo undici settimane di arduo cammino. Relazionò poi i due viaggi da Bathurst in A Specimen of the Indigenous Botany […] between Port Jackson and Bathurst, e in Journal of a Route from Bathurst to Liverpool Plains (1825); significativamente, il focus del primo sono le piante, del secondo l'esplorazione. Dopo questa epica spedizione, fu la volta di una serie escursioni più brevi, per lo più in distretti già esplorati, in cui la botanica tornava in primo piano: a novembre raccolse esemplari nelle Blue Mountains lungo la Bells Line; nel gennaio 1824 tornò a Bathrust a raccogliere semi maturi. Poco dopo il suo ritorno a Parramatta, attraccò a Port Jackson il battello francese Coquille, che stava circumnavigando il globo al comando di Louis Isidore Duperrey. Con grande gioia, Cunningham fece conoscenza con il naturalista ufficiale della spedizione René Primevère Lesson e il primo ufficiale e botanico Jules Dumont d'Urville e in marzo li accompagnò a erborizzare nelle contee di Camden e Argyle; visitarono i laghi George e Bathurst, le sorgenti del Murrumbidge, Brisbane Downs, la Marley Plain e Shoalhaven. Era una zona facile da percorrere e almeno in parte già battuta, che non offriva grandi novità botaniche, tranne intorno alle cave calcaree di Shoalhaven, ma fu senz'altro un splendido biglietto d'ingresso per i due naturalisti francesi, Rientrato con loro a Parramatta all'inizio di maggio, Cunningham trascorse i mesi di luglio e agosto a erborizzare a Illawarra, uno dei suoi luoghi preferiti, riportandone piante vive che piantò in piccole scatole o vasi, perché recuperassero prima di essere spedite in Inghilterra. Tra l'altro scoprì la terribile Dendrocnide excelsa (lui la chiamò Urtica gigas), un albero dalle foglie urticanti che provocano un dolore che può durare mesi, tanto inteso da resistere alla morfina. Si affrettò poi a rientrare a Parramatta, in modo da imbarcarsi sulla Amish diretta a Moreton Bay; questa spedizione, di nuovo guidata da Oxley, aveva lo scopo di esplorare il fiume Brisbane. Insieme a Oxley, Cunnigham risalì in battello il fiume finché fu navigabile; lungo le sue rive poté scoprire molte piante interessanti, tra cui Araucaria cunninghamii, e anche diverse specie di orchidee. A ottobre era di nuovo a Parramatta; per concludere l'anno, tornò nuovamente a Bathurst a fare incetta di semi. Ne riportò novità come Banksia cunninghamii, Grevillea anethifolia, Eucalyptus mannifera. Dal Nuovo Galles al Queensland Nell'inverno del 1825 (da aprile a giugno) fu la volta di una nuova spedizione verso nord, che nel prima tratto ripercorse la strada che egli stesso aveva aperto due anni prima. Passando da Richmond, Cunningham raggiunse la valle dell'Hunter, quindi superò il Pandora's Pass procedendo verso nord attraverso le Liverpool Plains, dove trovò un notevole ostacolo nella pioggia continua e nel terreno piatto e paludoso; proseguì alla ricerca di una strada più elevata, finché fu costretto a tornare indietro, trovando la piana completamente allagata. Rientrò a Parramatta il 17 giugno, avendo percorso un circuito di 700 miglia. Gli ultimi mesi dell'anno furono trascorsi ad esplorare le aree della Wellington valley e di Mudgee, alla ricerca di semi ed esemplari da inviare a Kew; il bottino più interessante furono diverse orchidee terrestri. Ma la sua salute cominciava a risentire di tante fatiche e tanti viaggi, e dovette fermarsi fino a febbraio, per poi accontentarsi di escursioni botaniche relativamente brevi lungo il Cox's River e ancora a Illawarra. Nell'agosto 1826 poté realizzare un sogno che accarezzava da molto tempo: imbarcatosi su una baleniera, raggiunse la Nuova Zelanda dove fu accolto calorosamente dai missionari della Baia delle isole. Si trattenne nell'isola del Nord per quattro mesi, visitando l'area compresa tra la Baia delle isole e Hokianga, la zona di Wangoroa e la baia di Plenty. Infine, il 29 dicembre si imbarcò sul piccolo vascello dei missionari diretto a Sydney, dove sbarcò il 20 gennaio 1827 dopo un viaggio reso lungo e penoso dai venti avversi. Risultato della breve visita fu Florae Insularum Novae Zelandiae Precursor (1837-39), considerato la prima sinossi della flora neozelandese. Lo attendeva la più impegnativa delle sue spedizioni. Essendogli giunta notizia che il governatore sir Ralph Darling desiderava si esplorassero le potenzialità economiche dell'area compresa tra la Grande Catena divisoria e Moreton Bay (l'odierna Brisbane), si offrì come capo della spedizione, per la quale propose un dettagliato itinerario. Ad accompagnarlo sarebbero stati sei uomini, parecchi cani e undici cavalli da soma con le provviste per quattordici settimane; i cavalli vennero inviati via terra fino all'alto corso del fiume Hunter, mentre Cunnigham raggiungeva in nave Newcastle; da qui risalì il fiume con le provviste fino a Dulwich, dove il gruppo si riunì. Proseguirono quindi insieme fino a Segenhoe, all'epoca la fattoria più estrema e punto di partenza della spedizione vera e propria. Gli esploratori ne partirono il 30 aprile e si diressero a nord, varcando la Liverpool Range all'altezza di Dartbrook Creek; spesso la strada era così ripida che bisognava alleggerire i cavalli, trasportando i bagagli a braccia. Quindi si diressero verso nord in direzione del fiume Peel, passando attraverso una boscaglia aperta di Eucalyptus sideroxylon. Il 21 maggio raggiunsero un vasto fiume che Cunningham chiamò Gwydir; proseguirono attraverso aride boscaglie interrotte da crinali e gole, fino a fiume Macintyre che era quasi asciutto per la siccità. Preoccupato dalla mancanza di pascolo per i cavalli e per le provviste, già consumate a metà, Cunningham decise di non proseguire verso nord come aveva progettato, ma di spostarsi più a est. Fu così che il gruppo si imbatté in un fiume largo e profondo che il botanico battezzò Dumaresq, in onore del segretario del governatore Henry Dumaresq. Dopo averlo attraversato, proseguirono per altri sei giorni; il 6 giugno Cunnigham salì sul monte Damaresq: di fronte a lui una vasta pianura feritile di ricchi pascoli. Era le terra promessa che era venuto a cercare: non a caso la battezzò Darling Downs in onore del governatore che aveva voluto quella spedizione. A una distanza di forse dieci km, vide anche un valico che prometteva di offrire un comodo passaggio verso Moreton Bay. Debilitato dall'epatite di cui soffriva periodicamente fin dai tempi dei viaggi della Mermaid, non lo esplorò personalmente, ma vi inviò due uomini che confermarono la sua supposizione. Cunningham lo chiamò Spicers Gap in onore di Peter B. Spicer, sovrintendente dei forzati. Attraverso un altro passo, che poi sarebbe stato chiamato Cunningham's Gap, il gruppo scese nei Darling Downs, seguendo per qualche giorno il corso del fiume che lo irrigava (Cunningham lo battezzò Condamine River, in onore di Thomas de la Condamine, ex aiuto di campo del governatore); quindi si accamparono in una valle ad est del fiume (Logan Valley, in onore del comandante dell'insediamento di Moreton Bay) per far recuperare uomini e cavalli. Era infatti ora di tornare indietro, cosa che fecero seguendo una via più occidentale rispetto a quella dell'andata, rientrando a Segenhoe dopo un viaggio di tredici settimane. Cunningham poté presto verificare di persona la praticabilità della via di collegamento che aveva intravvisto. Nel 1828 andò ad erborizzare a Moreton Bay con il botanico della colonia Charles Fraser; a luglio partivano in spedizione con il comandante Logan, un soldato, cinque forzati e molte provviste. Dirigendosi verso sud, raggiunsero il Logan River, scoperto dal capitano due anni prima, e il monte Barney, che Logan già aveva tentato inutilmente di scalare. Questa volta ci riuscì. Dopo aver esplorato per qualche giorno l'area intorno all'attuale Boonah, Fraser e Logan tornarono a Brisbane; Cunningham invece si addentò nelle montagne e varcò il passo che aveva scoperto nel 1827. La strada che egli percorse è oggi diventata un'autostrada, e ovviamente porta il suo nome: Cunningham Highway. Cunningham tornò a Moreton Bay ancora nel 1829, per esplorare l'alto corso del Brisbane River. Anche nel 1828 e nel 1829 non mancarono i consueti viaggi botanici a Bathurst e Illawarra. Tra maggio e settembre egli visitò anche l'isola Norfolk. Trattenuto nell'isola oltre il previsto dal cattivo tempo, poté fare un inventario molto ampio della sua flora (nel suo diario elenca 104 specie che ritiene native e 38 che considera introdotte). Visitò anche la vicina isola Phillip, dove fu derubato di gran parte dell'equipaggiamento e delle provviste da alcuni forzati. Fin nel 1828 aveva chiesto di poter tornare in Inghilterra (ricordo che l'aveva lasciata nell'ormai lontano 1814); il permesso gli fu finalmente accordato nel novembre 1830. Dopo un'ultima visita a Illawarra e alla Cox Walley e i saluti agli amici (erano tanti che richiesero non meno di una settimana), partì da Sydney il 25 febbraio e arrivò in Inghilterra a luglio. Qui si stabilì non lontano da Kew, dedicandosi alla sistemazione del suo erbario e alla stesura di vari articoli. Nel 1832 fu ammesso alla Linnean Society. Lo stesso anno morì Charles Fraser, e gli fu offerto di succedergli come botanico della colonia, ma egli rifiutò a favore del fratello minore Richard. Anche quest'ultimo era un ottimo botanico, entrato appena quindicenne a Kew. In Australia non mancò di partecipare a diverse spedizioni e visitò anche la Nuova Zelanda (dove tra l'altro scoprì l'orchidea che porta il suo nome Dendrobium cunninghamii), ma infine fu vittima di un tragico incidente. Nell'aprile 1835 si unì alla spedizione Mitchell, inviata ad esplorare il corso del fiume Darling. Nei pressi del Bogan River, si allontanò dal gruppo per erborizzare e non fece mai più ritorno. Più tardi si scoprì che, perdutosi e probabilmente in preda al delirio, si era unito ad alcuni indigeni che più tardi, terrorizzati dal suo strano comportamento notturno, lo avevano ucciso. Quando la notizia della morte di Richard giunse in Inghilterra, il posto di botanico della colonia fu nuovamente offerto a Allan Cunningham, che questa volta accettò e ritornò a Sidney nel febbraio 1837. Tra i suoi compiti, c'era anche la direzione del Giardino del governatore; Fraser aveva cominciato a trasformarlo in orto botanico (il futuro Sydney Royal Botanic Garden), ma era ancora soprattutto un parco pubblico e un orto per la coltivazione di verdure per la mensa del governatore; dopo qualche mese, Cunningham diede le dimissioni, proclamando che non "avrebbe più tollerato di essere un mero coltivatore di cavoli e rape". Nell'aprile 1838 si imbarcò sulla corvetta francese L'Héroine alla volta della Nuova Zelanda; trovò tempo pessimo e ritornò Sidney in ottobre gravemente malato. Nonostante la sua salute continuasse a peggiorare, progettava di accompagnare il capitano John Wickam della Beagle in una nuova ricognizione della costa nord-occidentale. Ormai stava così male che la nave partì senza di lui; il suo successore e amico James Anderson lo fece trasportare in un piccolo cottage situato nell'Orto botanico, dove Cunningham si spense il 27 giugno 1839. Nel 1844 in sua memoria venne eretto un obelisco commemorativo, alla cui base nel 1901 vennero traslate le sue ceneri. Si trova al centro di un piccolo stagno affiancato da boschetto di una delle tante piante da lui scoperte, la palma Archontophoenix cumminghamiana. Gli è intitolata anche la rivista scientifica dell'Orto botanico di Sydney "Cunninghamia".  Una piccola pianta per un grande raccoglitore Insieme a Robert Brown, Allan Cunningham è considerato il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento; ne esplorò le coste settentrionali, gran parte del Nuovo Galles del Sud, il Queensland meridionale, la Tasmania, nonché le isole Norfolk e Phillips e alcune aree della nuova Zelanda. Secondo il suo amico e primo biografo Robert Heward, le specie da lui raccolte ammontano a 3000. I suoi invii di semi, bulbi, piante vive a Kew furono così importanti che una serra, prima destinata alle piante africane, venne invece riservata alle sue australiane. Moltissime delle specie da lui raccolte erano ignote alla scienza, e non poche gli sono state dedicate. Ricordiamo almeno Casuarina cunninghamiana, Archotophoenix cunninghamiana, Araucaria cunninghamii, Crotalaria cunninghamii, Actinodium cunninghamii, Adenanthos cunninghamii, Alsophila cunninghamii, Angianthus cunninghamii, Banksia cunninghamii, Cassinia cunninghamii, Clematis cunninghamii, Eucalyptus cunninghamii, Nothofagus cunninghamii, Solanum cunninghamii. A una scelta di queste magnifiche piante è dedicata la gallery a fine post. Anche se i continui viaggi e la brevità del soggiorno in Inghilterra gli permisero di pubblicare solo una minima parte delle sue raccolte, gli si devono 139 denominazioni valide: 6 generi (Ackama, Alseuosmia, Corokia, Fieldia, Rabdothamnus, Hoheria), 133 specie (la più nota delle quali è probabilmente Grevillea rosmarinifolia) e una varietà. Si basano invece su raccolte di Cunningham più di 300 denominazioni di altri autori, tra cui 6 generi. A Cunningham sono stati dedicati due generi: Cunninghamia R.Br., che condivide con il quasi omonimo James Cuninghame (ne ho parlato in questo post) e Alania Endl., un genere monospecifico della famiglia Boryaceae, la cui unica rappresentante ha la ventura di ricordare il nostro protagonista sia nel nome generico sia nell'epiteto: è infatti Alania cunninghamii, un'erbacea rizomatosa del Nuovo Galles del Sud. Come ci ricorda Endlicher, Cunnigham la raccolse all'inizio del suo soggiorno australiano, nel 1818, "in campi aridi nei pressi delle Blue Mountains". E' una perenne cespitosa con foglie lineari, infiorescenze ascellari di piccoli fiori bianchi a stella con perianzio formato da sei tepali liberi, sei stami inseriti alla base con filamenti lunghi quanto i tepali. E' endemica delle Blue Mountains settentrionali; eliofila, tende a formare tappeti espandendosi con i rizomi. Qualche informazione in più nella scheda. Allan Cunningham, il secondo "raccoglitore del re per Kew", arriva in Australia alla fine dal 1816. E' l'inizio di una vera epopea che farà di lui il più prolifico cacciatore di piante australiane della prima metà dell'Ottocento, con la raccolta di non meno di 20.000 esemplari. Giovane ed entusiasta, tra il 1817 e il 1822 è il botanico di bordo delle cinque spedizioni guidate dal capitano Phillip Parker King. Per una volta, tra capitano e botanico, uniti dalla medesima sete di scoperta e dallo stesso amore per la natura, non c'è conflitto, ma collaborazione, stima, anzi amicizia. Non sono rare le occasioni in cui i due scendono insieme a terra per esplorare e fare raccolte di piante e animali. Meritatissima dunque la dedica da parte di Robert Brown del curioso genere Kingia (con il quale il botanico scozzese paga anche un debito con il padre del capitano, Philip Gidley King, governatore del Nuovo Galles del Sud all'epoca delle spedizioni Flinders). 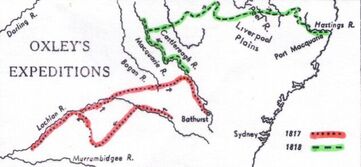 Primo contatto: una spedizione di 1200 miglia Il 20 dicembre 1816, dopo due anni trascorsi in Brasile (ne ho parlato in questo post) il raccoglitore del re Allan Cunningham (1791-1839) sbarcava finalmente nella baia di Sidney. In Brasile aveva perfezionato le tecniche di raccolta e acquisito il gusto dell'avventura, ma ora finalmente aveva raggiunto la meta per la quale si preparava da tempo. Dotato di una buona istruzione di base (la famiglia avrebbe voluto farne un avvocato), a 17 anni era entrato a Kew ed era stato assegnato all'erbario, come assistente di William T. Aiton che stava completando la seconda edizione di Hortus Kewensis; decisivo fu poi l'incontro con Robert Brown che tra il 1801 e il 1805 era stato il botanico delle spedizioni Flinders in Australia e ora era il bibliotecario di Joseph Banks. Fu Brown a iniziare Cunningham alla flora australiana e a spingerlo a proporsi per una missione sul campo nel nuovissimo continente. La sua candidatura fu caldeggiata da Aiton che ne aveva grandissima stima. Al suo arrivo a Port Jackson Cunningham aveva appena 25 anni; ne sarebbero trascorsi più di quindici prima che rivedesse la madre patria: quindici anni pieni di avventure, di spedizioni per mare e per terra, che ne avrebbero fatto il più importante esploratore della flora australiana della prima metà dell'Ottocento. Appena sbarcato, si presentò al governatore del Nuovo Galles del sud Lachlan Macquarie che lo accolse con grande gentilezza e gli suggerì di unirsi alla spedizione di John Oxley che si accingeva ad esplorare il territorio a ovest delle Blue Mountains; Cunningham accettò e, in attesa della partenza, affittò un cottage a Parramatta e iniziò a botanizzare nei dintorni. Fin dai tempi del primo viaggio di Cook, la baia di Sidney era la zona più battuta dagli europei ed egli ebbe l'impressione di essere quasi a casa, ritrovando molte piante coltivate nei giardini e nelle serre inglesi, che conosceva benissimo come assistente di Aiton e spesso non aveva difficoltà a riconoscere a colpo d'occhio. Nell'aprile 1817 Cunningham lasciò Parramatta e si unì alla spedizione Oxley il cui scopo principale era verificare se il fiume Lachlan (scoperto appena due anni prima e battezzato così in onore del governatore) si gettasse in mare o in qualche lago interno; venne così ad affiancarsi al botanico Charles Fraser, a un mineralogista e un disegnatore. Partiti da Bathurst il 28 aprile, gli esploratori seguirono il corso del fiume per circa due mesi, finché a giugno ogni ulteriore progresso fu bloccato da paludi impenetrabili. Allora si diressero a nord e raggiunsero il Macquarie River che discesero fino a Bathurst, dove rientrarono il 29 agosto. In circa 20 settimane, avevano percorso (a piedi, a cavallo, in barca) circa 1200 miglia, toccando ambienti ecologici molto diversificati; dal primo all'ultimo giorno, Cunningham non cessò mai di raccogliere piante, anche se all'inizio era un po' deluso perché "la botanica, con pochissime eccezioni, è la stessa che ho osservato in situazioni simili nei dintorni di Parramatta". Tra quelle poche eccezioni, una delle tante piante che portano il suo nome, Casuarina cunninghamiana. Alla fine, però, il bottino ammontò a circa 450 specie. L'8 settembre 1817, al tramonto, Cunningham rientrò a Parramatta con tutte le sue collezioni ben impacchettate. Il mattino dopo si presentò al governatore che lo invitò a cena e gli suggerì di unirsi a una nuova spedizione, questa volta per mare: il capitano Phillip Parker King si accingeva infatti a perlustrare le coste australiane non esplorate da Flinders. Cunningham ovviamente accettò. Scrisse a Banks e Aiton per comunicare che era rientrato sano e salvo e trascorse gli ultimi mesi dell'anno a preparare gli esemplari da inviare a Kew e a continuare l'esplorazione dei dintorni. Il 21 dicembre era a bordo del cutter Mermaid, la piccola nave scelta dall' ammiragliato per la missione di King. Costruita in India in legno di teak, era lunga 17 metri e a pieno carico aveva un pescaggio di appena tre metri, ideale per la ricognizione idrografica anche di strette insenature. Aveva dunque un carico limitato (uno degli obiettivi era anche individuare punti di rifornimento di acqua e cibo fresco) e un equipaggio di appena 19 uomini: oltre al capitano, il luogotenente Phillip Parker King, i suoi secondi Frederick Bedwell e John Septimius Roe (che poi sarebbe diventato il primo General Surveyor dell'Australia occidentale), il nostro Cunningham, 12 marinai, due mozzi e l'aborigeno Bungaree, che aveva già partecipato come guida, interprete e negoziatore con le popolazioni locali alla spedizione Flinders. 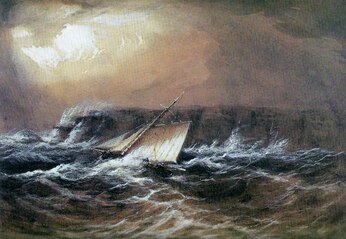 Alla scoperta della costa settentrionale dell'Australia Il compito principale di King era il rilevamento idrografico della costa settentrionale, in particolare del settore più occidentale non toccato da Flinders; l'ammiragliato sperava che egli individuasse qualche fiume che fosse possibile risalire per penetrare nell'interno. Ma la lista dei compiti che gli fu consegnata includeva anche la raccolta di informazioni sulle condizioni metereologiche, le montagne, la flora e la fauna, il legname, i minerali, le comunità locali, le loro lingue e costumi, la possibilità di commerciare con loro, nonché ogni prodotto che potesse essere esportato in Gran Bretagna. Obiettivi che per una volta mettevano d'accordo il capitano e il suo naturalista. Salpata da Port Jackson il 22 dicembre 1817, la Mermaid scese lungo la costa occidentale, per poi navigare lungo le coste meridionale e orientale fino a raggiungere il North West Cape dove sarebbe iniziato il rilevamento. Durante il tragitto, due soli scali significativi: il 26 dicembre a Twofold Bay, quando Cunningham per la prima volta scese a terra con il capitano, notando che la vegetazione poco differiva da quella di Port Jackson; il 20 gennaio 1818 a Oyster Bay, che fu perlustrata per quasi due settimane. Doppiato il North West Cape, intorno a metà febbraio venne scoperto un golfo battezzato Exmouth Gulf in onore di Lord Exmouth. Erano acque infide in cui vennero perse due delle tre ancore. Per circa due settimane la navigazione, in quasi totale assenza di vento, proseguì lenta, perlustrando il tratto di costa tra il golfo di Exmouth e Port Walcott. Cunningham ebbe parecchie opportunità di scendere a terra, spesso in compagnia del capitano che condivideva i suoi interessi naturalistici; tuttavia si era alla fine della stagione secca e il territorio appariva arido e desolato, le piante erbacee erano per lo più morte, mentre le rare specie arboree raramente portavano frutti. Finalmente l'8 marzo si levò il vento da sud e la Mermaid fece vela a nord, in direzione della Terra di Arnhem. Sospinta dal vento, dapprima carico di pioggia, non si sarebbe fermata fino al 27 marzo, quando gettò l'ancora in un'isola che poi sarebbe stata battezzata Goulburn Island; ora il paesaggio appariva del tutto diverso; così lo descrive un entusiasta capitano King: "Si era ormai al termine della stagione delle piogge, e ogni cosa aveva l'aspetto più rigoglioso; l'erba, che copriva il terreno dell'isola, era alta più di sei piedi, tanto che ci nascondeva l'un l'altro mentre camminavamo verso la sommità della collina, i cui lati erano fittamente boscosi. Ai margini della spiaggia crescevano il pandano e l'ibisco e una varietà di altri alberi e arbusti tropicali e la sabbia era variegata dai lunghi tralci del convolvolo in piena fioritura". Insomma un vero paradiso, come l'adiacente Sims Island (così nominata su richiesta di Cunningham in onore del primo curatore del Botanical Magazine John Sims) dove il nostro botanico poté fare incetta di piante, tra cui una profumatissima Asclepiadacea. Lasciata Goulburn Islands il 6 aprile, per tutto quel mese e quello successivo vennero esplorate la penisola di Cobourg, le isole Melville e Bathurst, le coste del golfo di Van Diemen fino al West Alligator River, il punto più orientale: King lo chiamò così per i coccodrilli che infestavano le sue rive paludose ed egli scambiò per alligatori. In più occasioni ci furono incontri con nativi, non sempre amichevoli nonostante la presenza mediatrice di Bungaree; il più drammatico si ebbe nella penisola di Cobourg, in un ancoraggio ribattezzato da King Knocker's Bay "Bay dei picchiatori" perché gli esploratori furono presi a sassate dai nativi mentre cercavano di disincagliare una lancia rimasta intrappolata tra le mangrovie. La stagione inoltrata e il tempo pessimo rendevano impossibile proseguire verso est; il capitano decise così di fare rotta per Timor; la breve sosta a Kupang (6-11 giugno) permise a King di rinnovare le provviste e a Cunningham di erborizzare nei dintorni della città, con l'aiuto di servo malese messogli a disposizione dall'amministrazione olandese. Il viaggio di ritorno, nuovamente lungo le coste occidentale e meridionale, fu funestato dalla dissenteria, con la morte di uno dei marinai; grazie ai venti favorevoli, fu tuttavia molto veloce: il 29 luglio 1818 la Mermaid gettava l'ancora nella baia di Sidney. Il comandante e i suoi ufficiali trascorsero la seconda metà del 1818 a riordinare le carte e a preparare la nave per la successiva spedizione; Cunningham, oltre a preparare i pacchi di semi e piante per Kew, ebbe anche il tempo di fare una breve escursione a sud di Sidney, visitando la regione di Illawarra; situata ad appena una cinquantina di miglia da Port Jackson, con il suo clima caldo-umido e una peculiare vegetazione tropicale, sarebbe divenuto uno dei suoi terreni di caccia favoriti dove sarebbe tornato molte volte negli anni successivi. Partito da Parramatta il 19 ottobre e rientrato esattamente un mese dopo, era pronto per una seconda avventura con l'amico King. La seconda spedizione della Mermaid fu però quasi un viaggio di routine: nel dicembre 1818 King salpò per la terra di van Diemen (l'odierna Tasmania) e ne perlustrò la costa fino al Macquarie Harbour; già il 14 febbraio era di ritorno nella baia di Sidney. Cunningham incrementò le sue raccolte erborizzando nei dintorni di Hobart e Launceston; la visita in Tasmania fu tuttavia abbastanza deludente per lui: erano le stesse zone già esplorate da Robert Brown e vi trovò poche novità. Il terzo viaggio della Mermaid (8 maggio 1819-12 gennaio 1820) seguì una rotta opposta rispetto al primo. Accompagnata da un altro vascello, la Lady Nelson, su cui viaggiava una nostra vecchia conoscenza, John Oxley, la Mermaid si diresse a nord, raggiungendo Port Maquaire e la foce del fiume Hastings. Dopo aver esplorato insieme quest'area, mentre la Lady Nelson e Oxley rientravano a Port Jackson, la Mermaid si inoltrava nel rischioso passaggio tra la costa del Queensland e la barriera corallina; era una navigazione lenta e difficile che moltiplicò gli scali, offrendo molteplici possibilità di raccolta a Cunnigham; sulla Fitz Roy Island poté raccogliere molti alberi tipici della foresta pluviale e addirittura due orchidee (una sarà poi dedicata al capitano come Dendrobium kingianum); all'Endeavour River, dove Cook era stato costretto a spiaggiare la sua nave gravemente danneggiata dalla barriera corallina, fu deliziato dalla raccolta di alcuni esemplari che andavano a sostituire quelli imperfetti raccolti da Banks in persona. Il 25 luglio la Mermaid doppiava Capo York ed entrava nel golfo di Carpentaria; partendo da Goulburn Island, King riprese il rilevamento della costa settentrionale, procedendo però da est a ovest; tra agosto e settembre furono esplorate le coste e le isole della Terra di Arnhem, per poi proseguire fino al Capo Londonderry e l'arcipelago Buonaparte. Si era ormai a metà ottobre. il tempo era di nuovo pessimo e molti uomini erano malati. Come due anni prima, King si diresse a Timor, per rinnovare le scorte e iniziare il viaggio di ritorno, che seguì la stessa rotta di quello precedente, concludendosi il 12 gennaio 1820. Il terzo viaggio, con i numerosi scali lungo le coste del Queensland e la lenta esplorazione della costa settentrionale fu particolarmente fruttuoso per Cunningham, che poté anche osservare (e raccogliere) in una stagione diversa varie piante che aveva già incontrato nel corso del primo viaggio; tuttavia egli si ammalò abbastanza gravemente (di itterizia, secondo King). Ciò non gli impedì di essere di nuovo della partita per la quarta spedizione della Mermaid (14 giugno-9 dicembre 1820). Nei mesi precedenti il vascello era stata carenato e bonificato (con scarso successo) degli scarafaggi e dei ratti che infestavano lo scafo. A giugno era pronto per la partenza, con gli stessi ufficiali ma un equipaggio rinnovato perché solo due marinai avevano confermato l'ingaggio; ora a bordo c'era anche un chirurgo. Fu un viaggio sfortunato fin dall'inizio. Poco dopo l'uscita dal porto, la nave incontrò un tempo così cattivo da perdere il bompresso; dovette così rientrare per essere riparata. Il viaggio riprese il 13 luglio, ma una settimana dopo, durante le manovre d'ancoraggio a Port Bowen, la nave rimase incagliata in un banco di sabbia, riportando danni gravi ma al momento non visibili, tanto che King ordinò di riprendere la navigazione. Il Capo York venne doppiato senza difficoltà e per la terza volta la Mermaid raggiunse Goulburn Island dove Roe, che si era imprudentemente allontanato da solo per cacciare, rischiò di essere catturato e ucciso dai nativi. Ma la preoccupazione maggiore era proprio la Mermaid: dall'ingresso nel golfo di Carpentaria lo scafo imbarcava sempre più acqua, tanto che King decise di portarla a terra per carenarla. Il 21 settembre fu trovato un ancoraggio adatto in una baia riparata e provvista di acqua dolce; i lavori di riparazione si protrassero fino al 30 settembre, ma non poterono che essere provvisori, in mancanza di sufficienti chiodi di rame. Non restava che intraprendere il forzato viaggio di ritorno, lungo le coste ovest e sud. Prima di rientrare a Sidney il 9 dicembre, a Botany Bay si rischiò il naufragio. Anche le raccolte di Cunningham erano state magre, a causa della stagione avanzata. All'arrivo a Port Jackson, lo attendeva una notizia dolorosa: quella della morte del suo protettore Joseph Banks, avvenuta il 20 giugno. Fu l'ultimo viaggio della Mermaid (la nave, non più adatta alla navigazione oceanica, fu destinata a usi meno logoranti), ma non l'ultimo di King, Cunningham e compagni. Il 26 maggio 1821 riprendevano il mare a bordo del brigantino Bathurst, un vascello di tonnellaggio doppio rispetto alla piccola e agile Mermaid, con un equipaggio di 33 persone. Ripercorrendo la rotta ormai consueta, ripresero l'esplorazione della costa settentrionale, completandone la ricognizione fino alla penisola Dampier e a Roebeck Bay. Tuttavia, dopo la brutta avventura della Mermaid, e tanto più con una nave con maggior pescaggio, il capitano temeva i banchi di sabbia e trascurò di esplorare la profonda insenatura che oggi porta il suo nome (King Sound). Da Roebeck Bay la nave fece rotta per Mauritius, dove Cunningham che non aveva raccolto molto durante l'ultima parte del viaggio, essendosi di nuovo ammalato, riuscì a scambiare alcune piante australiane con piante indiane, africane e malgasce. Quindi la Bathurst, nuovamente navigando lungo le coste occidentale e meridionale, rientrò a Sidney il 25 aprile 1822.  Un enigma botanico In cinque anni di viaggi e avventure comuni tra King e Cunningham si era cementata una sincera amicizia. Il capitano avrebbe descritto così il "suo" botanico: "Era un esemplare raro, direi un genere a sé: devoto alla sua scienza, la botanica; un caldo amico e un uomo onesto". Ma per i due amici era venuto il momento di separarsi. A King fu ordinato di rientrare in Inghilterra con la Bathurst; Cunningham rimase in Australia di cui continuò ad esplorare la flora per altri nove anni; e lì lo ritroveremo in un altro post. A Londra King fu accolto nella Royal Society e nel 1826 pubblicò la relazione dei suoi viaggi, che contiene anche un'appendice sulla flora della costa settentrionale dell'Australia scritta da Cunningham. Fu quindi incaricato dei rilevamenti idrografici della Terra del fuoco, missione che lo impegnò per ben cinque anni (1826-1830). Tornato in Inghilterra in cattiva salute, nel 1831 decise di lasciare il servizio attivo e di tornare in Australia, dove il padre gli aveva lasciato una vasta proprietà; vissuto fino al 1856, vi ricoprì una serie di incarichi politici; nel 1855 fu nominato retroammiraglio. Fu Robert Brown a rendere merito dei suoi servigi alla botanica dedicandogli un singolare endemismo australiano, Kingia australis; allo stesso tempo si sdebitò con il padre di lui, Philip Gidley King, governatore del Nuovo Galles del Sud ai tempi delle spedizioni Fliders. Così infatti scrive: "A questo nuovo genere ho dato il nome del mio amico il capitano King, che durante i suoi importanti rilevamenti delle coste della Nuova Olanda creò preziose collezioni in diversi campi delle scienze naturali, e in ogni occasione diede tutta l'assistenza in suo potere a Mr. Cunningham, l'infaticabile botanico che lo accompagnava. Il nome è anche inteso come segno di rispetto alla memoria del fu capitano Philip Gidley King che, come governatore del Nuovo Galles del Sud, organizzò materialmente il viaggio del Capitano Flinders; e verso la cui amicizia io e Ferdinand Bauer siamo in debito per l'assistenza che ci ha prestato finché siamo rimasti in quella colonia". Si rimanda alla sezione biografie per un profilo biografico di padre e figlio; qui basti dire che il capitano King, oltre ad essere un grande idrografo, era un naturalista più che dilettante, interessato soprattutto alla zoologia. Il suo amore per la natura traspare alla lettura di quasi ogni pagina di Narrative of a Survey of the Intertropical and Western Coasts of Australia, Performed Between the Years 1818 and 1822, dove spesso lo vediamo partecipare con entusiasmo alle raccolte di Cunningham; in Patagonia, raccolse un'importante collezione etnografica che poi donò al British museum e esemplari di uccelli, in alcuni casi inediti, che poi pubblicò sul Zoological Journal di Sidney. Era inoltre un dotato disegnatore e acquarellista. Oltre alla già ricordata orchidea, lo ricordano gli eponimi di sei rettili: Amphisbaena kingii, Chlamydosaurus kingii, Egernia kingii, Elgaria kingii, Hydrophis kingii e Liolaemus kingii. Kingia australis, l'unica specie del genere Kingia, è una pianta assai singolare. Si presenta come un tozzo pseudo tronco, formato dall'accumulo delle basi fogliari, sormontato da un ciuffo di foglie lunghe, sottili e piuttosto rigide. I fiori, minuscoli, da giallo verdastro a bruno, ma raggruppati in dense infiorescenze globose, sono portati all'apice di lunghi steli emessi tra il fogliame. Di crescita lentissima (circa 1 cm e mezzo l'anno), è però molto longeva; esemplari pluricentenari alti oltre sei metri non sono insoliti. Fin dalla sua scoperta, dovuta proprio a Robert Brown, che la raccolse nel 1801 sulla costa del King George Sound, costituisce un'enigma per i botanici. Quando non è in fioritura, ha un aspetto assai simile ad alcune specie del genere Xanthorrhoea, tanto che per molti anni si credette ne fosse la forma femminile. In realtà, i suoi fiori sono talmente diversi. Brown poté osservarla in fioritura, ma trovò solo frutti così rovinati e imperfetti che inizialmente non la pubblicò; tuttavia nel 1823 ottenne esemplari di fiori e frutti maturi raccolti da William Baxter, basandosi sui quali poté descriverla e discuterne la collocazione tassonomica in Character and description of Kingia, inizialmente pubblicato in appendice al resoconto dei viaggi di King. Con molti dubbi, egli assegnò il nuovo genere alle Liliaceae. A lungo è stato collocato nella famiglia Xanthorrhoeaceae; oggi, insieme a altri tre generi, tutti australiani, fa parte della famiglia Dasypoganaceae, stabilita nel 1998, molto più vicina alle Arecaceae (le palme) che non alle Xanthorrhoeaceae/Asparagaceae. La sua crescita lentissima è un adattamento a condizioni di estrema aridità, in terreno con pochi elementi nutritivi; la sua fioritura è evento raro, che si produce in condizioni particolarmente favorevoli, ma soprattutto dopo un incendio. Altre informazioni nella scheda. Per accattivarsi il favore di sovrani, uomini politici e potenti, da cui dipendevano finanziamenti e incarichi prestigiosi, i botanici sono stati prodighi di dediche di generi, spesso scelti tra i più vistosi. Non fa eccezione neppure Napoleone, che anzi ha collezionato ben tre dediche. Ad aprire la lista sono gli spagnoli Ruiz e Pavón che già nel 1802 intitolano all'allora primo Console Bonapartea. Niente di strano: i due non andavano tanto per il sottile con le dediche, e le elargirono generosamente ai potenti di turno, adattandosi di volta alla linea politica del momento; all'epoca, la monarchia spagnola era alleata con la Francia e si trattava di ingraziarsi, più ancora che lo stesso Napoleone, il ministro filofrancese Godoy (lui stesso dedicatario di Godoya). Nel 1804, l'anno in cui Bonaparte si autoincorona imperatore, arriva un omaggio ben più sorprendente: il botanico Palisot de Beauvois, un nobile vittima della rivoluzione, battezza pomposamente Napoleonaea imperialis un singolare alberello da lui scoperto in Africa. Il personaggio è tale che la dedica non può essere liquidata come plateale adulazione, e vale la pena di approfondire. Non stupisce (tranne che nel nome) che lo stesso anno Ventenat, che al momento era nel libro paga di S. M. l'Impératrice, abbia voluto metterci anche del suo con Calomeria. E poi, tutto sommato, i meriti di Napoleone agli occhi degli scienziati, inclusi i botanici, non erano pochi. 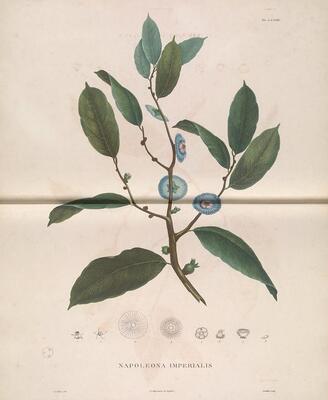 Un'adulazione smaccata? Il due dicembre 1804, con un gesto clamoroso, Napoleone Bonaparte incoronò se stesso Imperatore dei francesi. Culminava così un lungo processo, iniziato il 18 maggio, quando il Senato aveva mutato la costituzione trasformando la Repubblica in impero ereditario; immediatamente dopo la decisione era stata sancita dal plebiscito i cui risultati furono proclamati il 6 novembre: risultati ovviamente... plebiscitari, con 99,76% di voti favorevoli e solo 2569 contrari. In mezzo a queste date, il botanico Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois allestì la sua personale corona per Napoleone: una corona di petali (o almeno luio credeva così), quelli di una pianta che aveva raccolto in Africa. Dopo averla preannunciata in una seduta dell'Institut de France di ottobre, pubblicò scoperta e dedica verso la fine di dicembre, a incoronazione avvenuta, nell'opuscolo Napoléone impériale: Napoleonaea imperialis. E' una esplicita scelta di campo, dal significato eminentemente politico; il sottotitolo "Primo genere di un nuovo ordine di piante: le Napoleonée" non lascia dubbi. Napoleonaea inaugura una nuova famiglia di piante, esattamente come Napoleone inaugura un regime senza precedenti e una nuova dinastia: "Per essere un re si devono ereditare vecchie idee e genealogie. Io non voglio discendere da alcuno." Come dobbiamo leggere la plateale dedica di Palisot de Beauvois? E' la più smaccata delle adulazioni? O l'espressione di un entusiasmo reale, del resto condiviso - al netto della propaganda e della repressione - da una grande maggioranza di francesi? Certo non possiamo escludere l'interesse. All'epoca Palisot de Beauvois versava in una situazione economica molto difficile. Un tempo ricco possidente terriero, era stato rovinato dalla rivoluzione, da un amministratore incapace (o piuttosto interessato e disonesto) e da un divorzio; tornato in Francia dopo una serie di viaggi avventurosi e un lungo esilio, aveva in programma di pubblicare degnamente le sue scoperte in una serie di opere illustrate, corpose e costose: la sua Flore d'Oware et de Benin incominciò ad uscire proprio nel 1804; l'anno successivo seguì il primo volume di Insectes recueillis en Afrique et en Amérique. Cerro sperava anche che l'appoggio di Napoleone e dei suoi corifei scientifici gli garantisse l'ammissione come membro effettivo (con tanto di stipendio) dell'Institut de France (che aveva incorporato l'Accademia delle scienze), di cui era da tempo membro corrispondente. Eppure, a leggere le biografie e le testimonianze su Palisot de Beauvois, il tipo di cortigiano leccapiedi non sembra calzargli affatto (al contrario di tanti anche più famosi colleghi, a cominciare da Laplace). Nobile, durante la rivoluzione si era trovato proscritto e privato di tutti i suoi beni ed aveva potuto rientrare in Francia solo alla fine del 1798, quando il suo nome era stato cancellato dalle liste degli emigrati (un provvedimento che anticipa l'amnistia generale concessa da Napoleone primo console nel 1802). Di Napoleone certamente apprezzava la politica di conciliazione nazionale, ma anche di ritorno all'ordine dopo gli eccessi rivoluzionari. Feroce difensore dello schiavismo, che per le proprie posizioni aveva rischiato di essere messo a morte durante la rivolta di Haiti, gradiva particolarmente che egli avesse ristabilito la schiavitù nelle colonie, a suo parere follemente abolita dai rivoluzionari. Dunque, la dedica riflette probabilmente l'adesione al progetto politico di Napoleone, che rimarrà costante e sincera anche in tempi difficili, come conferma un fatto inequivocabile: nel 1815, durante i Cento giorni, il traballante Napoleone si fidava tanto della sua fedeltà che lo nominò consigliere per l'Università. 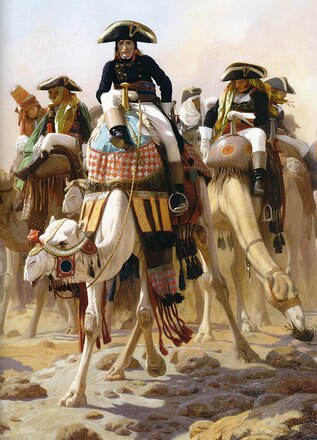 Napoleone e la scienza Oltre a considerazioni di ordine più generale, avrà pesato anche la politica culturale del nuovo imperatore che aveva fatto della scienza un importante tassello della sua propaganda e aveva valorizzato il ruolo politico e sociale degli scienziati, tanto che Eric Sartori ha definito quello napoleonico "l'impero delle scienze". Lo era, secondo lo studioso francese, da tre punti di vista: il dominio scientifico a livello europeo; la formazione e la passione scientifica dell'imperatore stesso; il ruolo politico assegnato all'élite scientifica. Quanto al dominio scientifico, la Parigi napoleonica è indubitabilmente la capitale della scienza: Laplace rivoluziona l'astronomia, i vari Berthollet, Fourcroy, Gay-Lussac portano avanti la rivoluzione della chimica inaugurata da Lavoisier, l'abate Haüy studia la struttura dei cristalli, Daubenton e Lacépède proseguono l'opera di Buffon, Fourier fa avanzare l'analisi matematica, Cuvier getta le basi della paleontologia, Lamarck e Saint-Hilaire preparano l'evoluzionismo. Parlando poi di Bonaparte, l'interesse per la scienza è una costante della sua vita, da quando ragazzo era considerato il migliore matematico della scuola militare fino all'esilio di Sant'Elena, quando riempiva le giornate leggendo la Storia naturale di Buffon, il trattato di astronomia di Delambre o il corso di chimica di Fourcroy (gli ultimi due, per altro, pubblicati grazie a lui). Veniamo al terzo punto, anche se nel breve spazio di un post dovremo limitarci a qualche cenno. Già durante la Campagna d'Italia Napoleone intraprende una vera propria opera di seduzione verso gli scienziati, chiamati a sostituire le vecchie classi dirigenti e a formare una nuova élite fondata non sul sangue e sul privilegio, ma sul talento e il sapere. A Milano, frequenta artisti, letterati e scienziati, invita alle propria tavola Volta e Spallanzani, incoraggia gli scienziati ad assumere un nuovo ruolo sociale: "A Milano gli scienziati non godono della considerazione che spetterebbe loro. Ritirati nel fondo dei loro laboratori, si ritengono fortunati se i re e i preti si limitano a non offenderli. Ma oggi non è più così: in Italia il pensiero ora è libero. Non ci sono più né Inquisizione, né intolleranza, né despoti. Invito gli studiosi a riunirsi e ad espormi le loro idee sui mezzi da adottare, o sui bisogni che emergeranno, per dare alle scienze e alle arti una nuova vita e una nuova esistenza. Tutti quelli che vorranno venire in Francia saranno accolti con distinzione dal governo. Il popolo francese valuta molto di più l'acquisizione di un matematico [...] che la conquista della città più ricca e più popolosa". Ovviamente questi proclami democratici fanno da paravento alla spogliazione del patrimonio culturale italiano; in nome della fratellanza e della libertà, a prendere la via di Parigi non sono solo quadri e statue, ma anche biblioteche intere, collezioni scientifiche, erbari e piante vive (attese con trepidazione da sua moglie Joséphine, grande appassionata di piante e giardini). Tra i "commissari governativi" che dirigono la spogliazione ci sono il grande matematico Monge (uno degli insegnanti di Napoleone alla scuola militare) e il chimico Berthollet; entrambi si legano a Bonaparte e nel 1797 ne propongono la candidatura all'Institut de France per la sezione meccanica. L'elezione del brillante generale, che non ha scritto una riga né di meccanica né di altre scienze al contrario dei candidati sconfitti, è tutta politica, primo atto della sua alleanza con l'establishment scientifico. Il secondo atto è la spedizione in Egitto (1798-1801); insieme ai soldati, ci sono 167 savants: disegnatori, architetti, ingegneri, geometri, cartografi, astronomi, chimici, mineralogisti, zoologi e botanici; divisi nelle quattro sezioni di matematica, fisica, economia politica, letteratura e arti, devono studiare e descrivere ogni aspetto dell'Egitto del passato e del presente: la geografia, la flora, la fauna, le risorse minerarie, l'arte, la società. A reclutarli a stato proprio Monge - assistito ancora da Berthollet e dal matematico Fourier - che li ha contattati e convinti in segreto (la missione era coperta dal segreto militare). In genere sono molto preparati, giovani, di salute robusta, ma una ventina di loro perirà durante la missione. Tralasciando gli altri settori, soffermiamoci sulle scienze naturali. Il compito dei naturalisti è redigere un catalogo completo della fauna e la flora del paese; per assolverlo lo zoologo Geoffroy de Saint Hilaire, affiancato dal pittore Henri-Joseph Redouté (fratello del più celebre Pierre-Joseph) e il botanico Alire Raffeneau-Delile intraprendono molte spedizioni, a volte lunghe e faticose, nell'alto e nel basso Egitto. Raffeneau-Delile descrive il loto e il papiro e crea un orto botanico al Cairo; un altro attivo raccoglitore è Ernest Coquebert de Montbret, che la ha sfortuna di morire ventunenne di peste il 7 aprile 1801, lo stesso giorno in cui la Commissione delle scienze e dell'arti si imbarca alla volta dell'Europa. Nel febbraio 1802 un decreto di Napoleone ormai primo console ordinerà la pubblicazione dei risultati a spese delle stato, ma a beneficio degli autori: è l'inizio della grandiosa Description de l'Egypte, che coinvolgerà 160 savants, 2000 artisti tra cui 400 incisori, si protrarrà per oltre vent'anni e comporterà nella prima edizione 19 volumi, 37 nella seconda. Ma abbiamo anticipato gli eventi. Come è noto, Bonaparte parte per Parigi nell'agosto del 1799 (insieme a lui, viaggia l'ormai inseparabile Monge); il 18 brumaio (ovvero il 9 novembre) con un colpo di stato rovescia il Direttorio e si impadronisce del potere. Per legittimare il quale, ha cura di circondarsi di scienziati e di chiamarli alle più alte responsabilità: diversi di loro, tra cui Lagrange, sono nominati senatori; Laplace diviene addirittura ministro dell'interno: grande matematico e fisico, ma amministratore incapace, sarà allontanato dopo appena sei settimane; Fourier è prefetto dell'Isère; Monge senatore, presidente dell'Institut d'Egypte e direttore dell'école polytechnique. Come si vede, tra questi notabili non c'è nessun botanico; cultore della matematica e delle "scienze dure", Napoleone non ha una gran considerazione della scienza della piante; in famiglia, la botanica era sua moglie Joséphine, come ci ricorda un aneddoto spesso ripetuto. Nel 1804, quando Humboldt ritornò dal suo grande viaggio in America latina, il neoimperatore lo ricevette e gli domandò, in tono quasi di disprezzo: "Dunque vi interessate di botanica? Anche mia moglie si occupa di piante". Forse nuoce ai botanici del Jardin des plantes (ora Muséum national d'histoire naturelle) anche il loro passato giacobino. E' vero che Antoine-Laurent de Jussieu ne mantiene la direzione che esercita fin dai tempi della Convenzione e nel 1804 è nominato professore di botanica alla facoltà di medicina e presidente della I sezione dell'Institut national, ma non riceverà mai gli onori che toccano ai colleghi fisici, chimici e matematici. Tra i naturalisti, l'uomo di Napoleone è Cuvier, segretario perpetuo dell'Institut e presidente della commissione che deve riformare l'università. Un merito di Bonaparte agli occhi dei botanici sarà stato se non altro aver finanziato la spedizione Baudin (1800-1803), quando era ancora primo console. Diretta verso le "coste della Nuova Olanda", ovvero l'Australia, aveva obiettivi geografici e cartografici, ma anche naturalistici, come ci ricordano i nomi delle due navi della spedizione, Géographe e Naturaliste. A bordo ci sono 24 tra artisti e scienziati, compresi molti membri dell'Institut de France, e cinque giardinieri, incaricati di occuparsi delle piante vive; tra i botanici, l'ormai anziano André Michaux, che però abbandona l'impresa per dissensi con il comandante Baudin, e Jean-Baptiste Leschenault de la Tour. Nonostante tante vicissitudini, compresa la morte del comandante, il successo scientifico della spedizione è straordinario: 200.000 esemplari di animali e piante vanno ad arricchire le collezioni del Muséum national e del Jardin des plantes. Piante e animali vivi raggiungono invece i giardini della Malmaison; e nelle sue serre fioriscono per la prima volta molte piante ora a tutti familiari, come Acacia dealbata, ovvero quella che siamo abituati a chiamare "mimosa". Per quanto tiepidamente interessato alla botanica, che delegava volentieri alla botanofila Joséphine, questi risultati avranno fatto piacere anche al quasi imperatore, cui non sfuggiva l'importanza dell'introduzione di nuove specie per il progresso dell'agricoltura, che considerava invece "l'anima, la base prima dell'Impero". Questo interesse pratico gli poteva derivare dall'esempio del padre, Carlo Bonaparte, che, convinto esponente della scuola fisiocratica, aveva iniziato a bonificare la tenuta delle Saline, dove aveva creato un vivaio con alberi da frutto e piante esotiche. Nel 1800, ancora all'epoca del consolato, Napoleone fece creare ad Ajaccio il primo orto botanico della Corsica, il Jardin d'Expériences. Inaugurato il 12 giugno 1801, si trovava nel recinto dell'ex convento di San Francesco, trasformato in ospedale militare, aveva una superficie di circa 6.000 metri quadri e godeva di un clima favorevole che permise l'acclimazione di piante esotiche, tra cui il tabacco. Nel 1807 con un decreto imperiale passò direttamente sotto l'amministrazione del Muséum di Parigi, ma solo nel 1812 fu dotato di finanziamenti e fu costruita una serra. Anche in seguito ebbe vita grama, con la morte per febbre perniciosa di almeno due giardinieri. Durante gli anni napoleonici, le società agricole, abolite ai tempi del Terrore, rifiorirono e si moltiplicarono. Prima la perdita delle colonie, poi le difficoltà dei commerci a lunga distanza causati dall'interminabile ciclo di guerre, infine il blocco continentale resero ancora più urgente l'acclimazione di piante esotiche anche nel territorio metropolitano o la ricerca di loro succedanei. L'esempio più noto è quello della coltivazione della barbabietola da zucchero; il metodo di estrazione fu messo a punto da un altro botanico, Benjamin Delassert. Nominato barone da un grato Napoleone, andò aggiungersi alla piccola schiera di scienziati di primo piano entrati a far parte della nobiltà dell'Impero (che, però, non dimentichiamolo, era formata per quasi il settanta per cento da militari). Per un alto numero di scienziati, però, c'erano incarichi pubblici ben rimunerati, posti di insegnamento nelle scuole secondarie (dove le scienze divennero materia obbligatoria) e all'università, premi in denaro, donazioni e vitalizi come quelli assegnati a Volta, la possibilità di pubblicare a spese dello stato, le sovvenzioni per le ricerche e le innovazioni tecniche, prime fra tutte quelle che potevano essere utili all'esercito, come il telegrafo ottico inventato da Claude Chappe.  Le dediche botaniche a Napoleone Palisot de Beauvois era stato anticipato di due anni dagli spagnoli Ruiz e Pavón che nel 1802 dedicarono al primo Console Bonapartea sulla base di una specie da loro raccolta in Perù. Erano abituati a offrire con disinvoltura le loro piante all'uomo politico di turno, e la dedica a Napoleone, intesa a ingraziarsi forse ancor più di lui il filofrancese Godoy, da poco ritornato al potere, è un capolavoro di servilismo e adulazione: "Genere dedicato a Napoleone Bonaparte, rifondatore della ricostituita repubblica francese, primo console, comandante sempre invitto, patrono della botanica, di tutte le scienze fruttuose e delle arti, difensore della religione, ripristinatore della pace in tutto il globo, uomo immortale, che rimarrà nella memoria degli uomini famosissimo per le sue gesta". E' quasi una consolazione sapere che il genere non è valido (è un sinonimo diTillandsia), mentre lo è il bel Lapageria, che i due botanici iberici dedicarono contestualmente "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Senza esprimersi in termini così smaccati, Palisot de Beauvois è non meno celebrativo. Per omaggiare il neoimperatore sceglie una pianta i cui vistosi fiori a coccarda ostentano un triplice giro di petali (più probabilmente staminoidi), che li fanno assomigliare a una corona. Non meno importante è il convincimento - confermato da Antoine-Laurent de Jussieu, amico di una vita - che la Napoleonaea non appartenga ad alcuna famiglia nota, anzi inauguri una famiglia propria. In effetti, la famiglia Napoleonaeaceae è stata a lungo accettata dai botanici, per essere poi assorbita nelle Lecythidaceae. Oggi al genere sono assegnate diciassette specie, tutte originarie dell'Africa tropicale occidentale e centrale intorno al golfo di Guinea; quelle più note sono N. imperialis e N. vogelii. Il primo è un alberello alto circa 6 metri, il secondo un albero di dimensioni maggiori; entrambi sono sempreverdi, con grandi foglie alternate obovate, e curiosi fiori che nascono sui rami maturi o direttamente sul tronco. Hanno una struttura molto complessa, che ha fatto parecchio discutere i botanici. Oltre che a una corona, possono essere paragonati a una coccarda, con due giri esterni di elementi simili a petali disposti orizzontalmente e un giro interno di venti stami e staminoidi eretti. Per alcuni botanici, anche recenti, si tratta di una vera corolla e gli elementi esterni sono petali; per altri è un fiore apetalo e si tratta di staminoidi, una tesi confortata dai dati molecolari e dal confronto con le strutture fiorali delle Lecythidaceae. In ogni, caso una struttura peculiare ed affascinante, nonché discussa e discutibile, come lo stesso Napoleone. Che lo stesso anno ricevette una seconda dedica vegetale dal botanico Etienne Pierre Ventanat, che in quel momento, per incarico di Joséphine, stava redigendo il catalogo delle collezioni del giardino della Mailmaison, una splendida opera in due volumi, con le illustrazioni di Pierre-Joseph Redouté. E fu proprio su richiesta della sua patrona che creò un terzo genere in onore dell'ormai imperatore, come racconta egli stesso: "Sua Maestà l'Imperatrice dei francesi, essendosi resa conto che la pianta di cui ho appena presentato la descrizione appartiene a un genere nuovo, ha voluto indicarmi il nome che dovevo dargli. I signori Ruiz e Pavón hanno già consacrato quello di Bonapartea nella Flora del Perù, e il signor Palissot-Beauvois quello di Napoleonaea in Flora d'Oware e del Benin; ho fatto così ricorso alla lingua greca, che ha fornito ai botanici un gran numero di denominazioni tanto espressive quanto armoniose, per obbedire al desiderio di Sua Maestà l'Imperatrice e dare a Sua Maestà l'Imperatore una modesta prova della riconoscenza che gli devono tutti coloro che coltivano le arti e le scienze". Come tutti i francesi, anche Ventenat è appena passato da cittadino a suddito, e si comporta di conseguenza. La pianta in questione è Calomeria amaranthoides, coltivata nei giardini della Malmaison dai semi giunti dall'Australia grazie alla spedizione Baudin. Il nome generico, come spiega lo stesso Ventenat, è formato da due parole greche, καλός (kalòs) "bello, buono" e μερίς (meris) "parte": dunque, Bonaparte. E' forse l'unica specie del piccolo genere Calomeria (Asteraceae), a cui vari repertori ne attribuiscono quattro, con una sorprendente distribuzione disgiunta: mentre C. amaranthoides è endemica degli stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud nell'Australia sud orientale, le altre tre vivono nell'Africa meridionale e orientale. Appaiono alquanto diverse dalla sorella australiana, e altri botanici le assegnano decisamente al genere Helichrysum. Parliamo dunque della sola specie certa. quella descritta e denominata da Ventenat. E' una perenne di breve vita solitamente coltivata come biennale, di grandi dimensioni (può superare i tre metri) e foglie intensamente profumate d'incenso. In estate produce grandi infiorescenze color amaranto simili a pennacchi. Ricordano tanto da vicino quelli inalberati sull'elmo dell'alta uniforme della Guardia Imperiale da far pensare che non si tratti di una semplice coincidenza. Prima di concludere, vale la pena di ricordare la damnatio memoriae che toccò a Napoleonaea imperialis. Nel 1814, appena caduto per la prima volta Napoleone, un altro botanico francese, Nicaise Augustin Desvaux, ritenne che quella ignominiosa dedica dovesse essere cancellata, e si affrettò a rinominare la pianta Belvisia caerulea, in onore dello stesso scopritore Palisot de Beauvois. Ma, grazie al repubblicano e antinapoleonico Augustin Pyramus de Candolle, in botanica vale la regola della priorità: Napoleonaea vive, Belvisia è un nome illegittimo. A scusante dei quattro botanici che si affrettarono a prostrarsi ai piedi di Napoleone, ricordiamo che non furono i soli a subirne la fascinazione. Come è noto, lo stesso Beethoven voleva dedicargli la sua terza sinfonia, finché proprio l'incoronazione gli aprì gli occhi. E le tre dediche vegetali sono tutte comprese tra il 1802 e il 1804, quando davvero Napoleone poteva ancora presentarsi nelle vesti di pacificatore, restauratore dell'ordine e al tempo stesso fautore del progresso e del rinnovamento sociale. Negli anni a cavallo tra Seicento e Settecento, la Francia del re Sole lancia una serie di spedizioni scientifiche: i viaggi di Plumier nelle Antille, il viaggio in Levante di Tournefort, la tragica spedizione di Lippi in Sudan. Di tre viaggi è protagonista padre Feuillée, frate minimo come Plumier, e provenzale come quest'ultimo e Tournefort. E' un astronomo e un cartografo e le sue spedizioni si muovono sempre sul sottile confine che separa l'esplorazione scientifica dallo spionaggio: prima è in Levante a disegnare carte e fare il punto su installazioni strategiche come porti, poi nelle Antille, infine, nel viaggio più importante, in Cile, mai esplorato da nessun studioso prima di lui. All'astronomia alterna la botanica: alle piante dedica il giorno, agli astri la notte. In appendice al suo Journal pubblica la prima rassegna della flora cilena e peruviana, con un occhio di riguardo alle specie officinali. Linneo si ricordò di lui dedicandogli il genere Fevillea, con semi ricchissimi di oli da secoli utilizzati nella farmacopea indigena e oggi forse una fonte alternativa di combustibili e preziosi grassi alimentari.  Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei? I tre viaggi di Plumier nelle Antille avevano dimostrato le grandi potenzialità botaniche di quell'area; così nel 1703, quando si offrì la possibilità di inviare in Martinica un astronomo e cartografo, Fagon, l'archiatra del re Sole e intendente del Jardin royal, insistette perché la missione avesse anche risvolti botanici. La scelta cadde su un altro frate minimo, forse allievo di Plumier: Louis Feuillée. Anche lui era provenzale e fin da ragazzo aveva dimostrato grande attitudine per la fisica e la matematica. Nel 1680, a vent’anni, prese i voti, l'unico modo per continuare gli studi per un giovane senza mezzi; nel convento di Marsiglia ebbe modo di studiare astronomia e cartografia e forse incontrò Plumier che lo avrebbe iniziato alla botanica. Tuttavia il campo in cui si fece notare fu l'astronomia: due saggi pubblicati nel 1697 e nel 1699 nelle Memorie dell’Accademia delle scienze attirarono l’attenzione dell’astronomo reale Giovanni Domenico Cassini che nel 1700 lo inviò nel Mediterraneo orientale a determinare la posizione geografica di vari porti. L’elogiativo rapporto di Cassini spinge il ministro Pontchartrain e Fagon ad affidargli la missione nelle Antille, dove dovrà fare rilievi cartografici e e osservazioni astronomiche ma anche, auspice Fagon, proseguire le ricerche botaniche di Plumier. Il 5 febbraio 1703 il frate si imbarca a Marsiglia sulla nave Grand Saint Paul diretta in Martinica con un carico di deportati. Sbarcato l’11 aprile, viene accolto nel convento dei domenicani di Saint-Pierre, ma poco dopo si ammala di febbre gialla. La sua robusta costituzione gli permette di recuperare; nei quattrodici mesi che trascorre nell’isola, come racconterà lui stesso, divide il suo tempo osservando le piante di giorno, gli astri di notte. Arrivato in Martinica su una nave di galeotti, ne riparte su un vascello corsaro. Il 4 luglio 1704 si imbarca sull’Ambitieuse, un veliero armato con sessanta cannoni, inviato nel mare dei Caraibi a insidiare le navi mercantili spagnole. Alla ricerca di prede, la nave corsara fa scalo a La Guaira in Venezuela, poi risale verso l’attuale Colombia, toccando Porto Cabello, Santa Maria (dove c’è uno scontro a fuoco con gli spagnoli), Porto Bello. Il 5 dicembre raggiunge Cartagena, dove il nostro frate sbarca salutando l’onorevole compagnia. Ha intenzione di raggiungere il Pacifico, ma il progetto si rivela irrealizzabile; dopo due mesi trascorsi ancora a fare osservazioni cartografiche e astronomiche, trova un passaggio su un piccolo vascello di filibustieri che, passando per San Domingo e Saint Thomas, lo riporta in Martinica. Vi trascorre ancora un anno, prima di poter rientrare in Francia il 21 giugno 1706. Da questo primo viaggio riporta una messe di dati astronomici, rilievi cartografici, disegni e numerose piante. Ridisegna la carta della Martinica e si guadagna il titolo di «matematico del re». Ma già Ponchartrain e Fagon progettano una nuova missione per questo frate che ha dimostrato di sapersi muovere abilmente in situazioni difficili: dovrà recarsi in Sud America per rilevare le esatte posizioni geografiche delle coste del Cile e del Perù. In piena guerra di successione spagnola, siamo a metà tra la spedizione scientifica e lo spionaggio. Infatti il buon padre Fueillée è costretto nuovamente ad accompagnarsi a corsari; ma adesso (insediatosi Filippo V a Madrid) i nemici non sono più spagnoli, ma inglesi e olandesi. Dato che molte navi nemiche incrociano nel Mediterraneo, la Saint-Jean-Baptiste su cui si è imbarcato a Marsiglia, raggiunge Tolone per unirsi a una flotta protetta dal vascello corsaro l’Heureux retours, comandato da Nicolas Lambert. Per evitare incontri pericolosi, seguono una rotta contorta e, partiti da Tolone il 14 dicembre 1707, solo il 9 maggio 1708 sono a Gibilterra. Il passaggio è sorvegliato da due fregate inglesi. Pur sapendo che l’esito è scontato, Lambert affronta la battaglia e si lascia catturare: ma con il suo sacrificio permette agli altri vascelli francesi di sfuggire e continuare il viaggio. Il primo scalo della Saint-Jean-Baptiste è Tenerife, dove sosta circa un mese. Il frate si immerge con gioia nella ricca flora canaria. L’11 luglio ripartono e 14 agosto raggiungono Buenos Aires; il comandante decide di attendere l’estate australe prima di affrontare il difficile passaggio del Capo Horn. Fueillée ne approfitta per fare i rilievi necessari a disegnare una nuova carta dell’estuario del Rio de la Plata. Ripartiti il 9 ottobre, negli ultimi giorni dell’anno superano senza troppe difficoltà Capo Horn e il 21 gennaio gettano l’ancora a Concepcion in Cile. 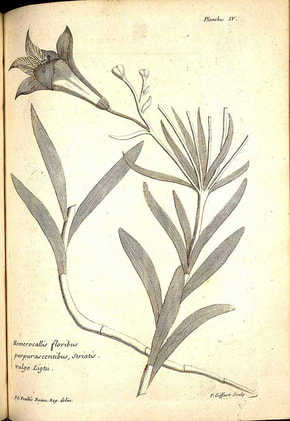 Ah, Sud America Sud America! La vera missione di padre Feuillé è solo all’inizio: rimane circa un mese a Conception, dove fa osservazioni astronomiche e raccoglie campioni di piante e animali; poi si sposta verso nord, toccando Valparaiso, Pisco, Callao e infine Lima, dove soggiorna per circa nove mesi. Nel gennaio 1710 riscende verso sud e, prima di tornare a Concepcion a cercare un imbarco, visita ancora Coquimbo e Arica. Il viaggio si protrae per un altro anno, con una lunga sosta a Conception, finché il 6 gennaio 1711 si imbarca sul Philipeaux e il 27 agosto è a Brest, dopo un’assenza di tre anni e otto mesi. Durante il lungo viaggio, come scrive uno dei suoi biografi, Paul Autran, «si dedicò a fissare la posizione e disegnare le mappe di tutti i porti, a correggere gli errori dei geografi precedenti in vari punti del suo itinerario, e raccolse un’infinità di piante, oggetti e osservazioni di storia naturale» ; fu tra l’altro uno dei primi astronomi a misurare la longitudine utilizzando segnali astronomici. Al ritorno, presentò personalmente i suoi disegni al re, che gli concesse una pensione e lo premiò con un dono graditissimo: la costruzione di un osservatorio tutto per lui nel convento dei minimi di Marsiglia, dove sarebbe vissuto quasi stabilmente fino alla morte, nel 1732. Già anziano, nel 1724, parteciperà ancora a una spedizione scientifica nelle isole Canarie, anche se dovrà rinunciare a scalare il picco del Teide insieme ai suoi più giovani accompagnatori. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Feuillé ha documentato il viaggio in Sud America nei tre volumi del suo Journal, pubblicato tra il 1712 e il 1725; in appendice al secondo e terzo volume vengono trattate le piante cilene e peruviane, sotto il titolo Histoire des plantes médicinales qui poussent sur les côtes du Chili et du Pérou. Le piante trattate sono un centinaio, molte delle quali mai descritte in precedenza. Di ciascuna viene dato un nome-descrizione in latino, seguito dal nome indigeno; seguono la descrizione in francese, solitamente molto dettagliata, indicazioni sull’habitat e gli eventuali usi terapeutici. Di eccellente qualità le tavole, ricavate da disegni e acquerelli eseguiti dal vivo dallo stesso Feuillée, che insieme alle precise descrizioni ci permettono di riconoscere facilmente, tra le altre, Alstroemeria ligtu e A. pelegrina, Lapageria rosea, Nicandra physaloides, Argylia radiata, Lobelia tupa, Mimulus luteus, Brugmansia arborea, Tropaeolum majus e T. minus. Tra le specie alimentari troviamo il pepino (Solanum muricatum), due specie di Passiflora, il lulo o naranjilla (Solanum quitoense), l’alchechengi peruviano (Physalis peruviana), la quinoa (Chenopodium quinoa), l’annona (Annona cherimolia), la caigua (Cyclanthera pedata).  Una liana dai semi oleosi L’opera botanica di Feuillé ha grande importanza storica, soprattutto per la flora cilena, mai studiata in precedenza, ed è anche di buon livello, nonostante l’autore fosse un astronomo prestato alla botanica. Ne aveva stima anche Linneo che gli rese omaggio ribattezzando Fevillea due specie alle quali Plumier aveva conservato la denominazione indigena Nhandiroba . Il genere Fevillea L. (famiglia Cucurbitaceae) comprende otto specie di liane rampicanti che vivono nelle foreste umide, dal Messico meridionale e dai Caraibi all’Argentina settentrionale. Una scelta opportuna, trattandosi di zone esplorate dal solerte frate-astronomo. La loro caratteristica più notevole sono i semi, i più grandi della famiglia (un seme secco può pesare anche 9 grammi) e i più ricchi di grassi tra le dicotiledoni. Le specie più nota e più diffusa è F. cordifolia, una liana che si aggrappa alle piante circostanti per mezzo di viticci e può allungarsi anche per 30 metri. Dioica, ha fiori maschili campanulati, piatti, con cinque lobi giallo aranciato, e fiori femminili con lobi brunastri tomentosi. L'ovario globoso si trasforma in un frutto tondeggiante, che contiene numerosi semi oleosi, da cui viene estratto un olio dal sapore simile a quello di arachide, utilizzato sia come alimento sia come combustile. Inoltre nella medicina tradizionale trova impiego come purgante, rimedio per affezioni di varia natura, emetico e antiveleno, come ricorda il nome inglese antidote vine. Un'altra specie da cui si ricava un olio alimentare è la brasiliana F. triloba. Recenti studi hanno sottolineato le potenzialità di queste piante, che potrebbero essere una buona fonte di combustibili e grassi alimentari a basso impatto ecologico. Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1978, l'astronomo russo Nikolaj Stepanovič Černych scopre un nuovo asteroide della fascia principale; decide di battezzarlo 3195 Fedchenko in onore di una eccezionale famiglia di scienziati: l'esploratore, glaciologo, zoologo e antropologo Aleksej Pavlovič Fedčenko; sua moglie, la botanica Ol'ga Aleksanderovna Fedčenko; e il figlio di entrambi, Boris Alekseevič Fedčenko, anch'egli botanico. Tutti e tre furono scienziati eminenti, anche se la figura più affascinante è probabilmente Ol'ga, coraggiosa compagna d'avventura del marito prima, tenace curatrice del suo lascito dopo l'improvvisa morte di lui, ma soprattutto grande botanica, la prima donna a studiare le piante in modo professionale nel suo paese, esperta di fama mondiale della flora del Turkestan. Esploratori della ricca flora dei monti dell'Asia centrale, madre e figlio sono ricordati anche da numerosi eponimi: fedtschenkoi o fedtschenkoanus in onore di Boris, fedtschenkoae o più spesso olgae in onore di Ol'ga, che è anche celebrata dall'unico genere valido dedicato al trio: il genere Olgaea, che raggruppa una quindicina di specie di grandi cardi asiatici.  Una coppia nella vita e nella scienza Nella Russia degli zar, l'Università era preclusa alle donne. Tuttavia Ol'ga Aleksandrovna Armfeld (1845-1925) poté giovarsi di un ambiente familiare eccezionalmente aperto e stimolante. Suo padre, Aleksandr Osipovič Armfeld, discendente da una famiglia di origine tedesca, era uno stimato professore di medicina legale all'Università di Mosca, e dal 1838 svolgeva anche il ruolo di ispettore dell'Istituto Nikolaevskij, una scuola secondaria per ragazze di buona famiglia che preparava all'insegnamento. La madre Anna Vasilievna Dmitrovskaja, che a sua volta era stata educata nel famosa scuola femminile Ekaterinskij, era l'animatrice di un frequentatissimo salotto, uno dei centri della vita artistica e culturale della città, con ospiti del calibro di Gogol', Lermontov e Lev Tolstoj. Insieme alle sorelle, Ol'ga (era la terza di una nidiata di ben nove tra figli e figlie) inizialmente venne educata in casa, ma nel 1857, a dodici anni, iniziò a frequentare l'Istituto Nikolaevskij, concentrandosi soprattutto sulle lingue straniere, la musica, il disegno e la pittura. Nel curriculum le scienze naturali, troppo "maschili", non erano previste, ma Ol'ga le scoprì e se ne innamorò durante i soggiorni estivi nella tenuta di famiglia a Možajsk. Incominciò a collezionare minerali, conchiglie, insetti e uova d'uccelli, e creò il suo primo erbario, così ben fatto che Nikolaj Kaufman lo incluse nella sua Moskovsakaja flora: un risultato notevole per una ragazzina sedicenne che stava studiando la botanica da autodidatta, traducendo le descrizioni dai grandi repertori stranieri. Nel 1864 Ol'ga si diplomò con il grado di candidat, e rimase al Nikolaevskij come insegnante di lingue. Lo stesso anno (all'epoca aveva diciannove anni) fu tra i fondatori della Società degli amanti delle scienze naturali, antropologia, etnografia (più tardi Società delle scienze naturali di Mosca), nota con la sigla OLEAE, un'associazione sorta attorno all'Università di Mosca tra i cui soci figuravano scienziati ma anche colti dilettanti. Incominciò anche a collaborare come volontaria al Museo di zoologia, aiutando a tenere in ordine le collezioni, traducendo in russo testi scientifici dal francese, dal tedesco, dall'inglese, curando la corrispondenza con studiosi europei e disegnando illustrazioni naturalistiche. Un altro dei fondatori dell'OLEAE era Aleksej Pavlovič Fedčenko (1844-1873), un giovane naturalista che si era appena laureato all'Università di Mosca. Aleksej era nato a Irkustsk, in Siberia, ma nel 1860 si era trasferito a Mosca, dove già viveva un fratello maggiore; insieme a lui, nel 1863 Aleksej fece la sua prima escursione scientifica nella regione dei laghi salati della Russia meridionale, appassionandosi di entomologia e raccogliendo una notevole collezione di imenotteri e ditteri, oggetto della sua prima pubblicazione. Dopo la laurea, entrò al Nikolaevskij come insegnante di scienze naturali. Ol'ga e Aleksej si innamorarono e divennero una coppia di scienza e di vita. Nel 1867 si sposarono. Nel frattempo, su richiesta del governatore del Turkestan Kaufman, l'OLEAE aveva varato una spedizione scientifica in quella regione recentemente annessa all'Impero russo e decise di affidarne la direzione a Aleksej Fedčenko, la persona più indicata per la vastità degli interessi che spaziavano dalla zoologia alla geologia all'antropologia. Ol'ga volle accompagnarlo, come membro ufficiale ma non pagato della spedizione. Era una decisione inaudita: non solo nessuna donna russa prima di lei aveva partecipato a una grande spedizione scientifica, ma il territorio da esplorare era particolarmente difficile e pericoloso. Largamente inesplorato, impervio, con una popolazione per lo più ostile agli occupanti russi, era anche un luogo strategico in cui si incontravano (e scontravano) le aspirazioni russe e quelle britanniche alla base del "grande gioco". I Fedčenko si prepararono seriamente alla missione visitando musei e collezioni in patria e all'estero. Il viaggio di nozze li portò in Finlandia e in Svezia. Infine, nell'ottobre del 1868 partirono per il Turkestan: Aleksej si sarebbe occupato della geografia, della zoologia, dell'antropologia; Ol'ga della botanica, delle carte e delle illustrazioni. All'epoca anche i collegamenti con quella remota regione erano difficili, e il viaggio in vettura di posta richiese più di cinquanta giorni. La spedizione vera e propria iniziò dalla valle dello Zeravshan (attuale provincia di Samarcanda nell'Uzbekistan), da pochissimo annessa alla Russia; i Fedčenko si muovevano a cavallo, accompagnati da una scorta di cosacchi. Dopo aver esplorato le aree attorno alle città di Tashkent e Samarcanda, si spostarono nel deserto del Kizilkum, il vastissimo bassopiano arido che separa i bacini dell'Amu Darya e del Syr Darya, al confine tra Kazakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. L'esplorazione continuò con i Monti Zeravshan, la fertile valle di Fergana e i Trans-Alaj, la catena dorsale che separa la valle dell'Alaj dal Pamir. I Fedčenko si muovevano tra scenari mozzafiato, con laghi, ghiacciai immensi e cime che superano i 7000 metri d'altitudine. Aleksej scoprì (e Ol'ga disegnò) la vetta maggiore del sistema, il Monte Kaufman (dal nome del governatore del Turkestan), poi Picco Lenin e oggi Picco Ibn Sina (7134 m sul livello del mare). Avrebbero voluto proseguire per il Pamir, il "tetto del mondo", che faceva sognare gli europei fin dal tempo di Humboldt. Ma dovettero tornare indietro: non aveano più provviste ("abbiamo fatto lo sciopero della fame per due giorni", annotò Aleksej). La spedizione era finita. Dopo tre anni esatti dalla partenza, nel novembre 1871 i Fedčenko erano di ritorno a Mosca con un immenso bottino; le sole piante raccolte da Ol'ga erano più di 1500, con molte specie nuove per la scienza. Iniziava il lavoro per la pubblicazione dei risultati. Nel dicembre 1871 Aleksej presentò alla Imperiale società geografica russa una relazione che destò sensazione per le informazioni inedite sul Pamir. Grande interesse fu suscitato anche dal padiglione dedicato al Turkestan, allestito dai Fedčenko nel 1872 per l'Esposizione politecnica panrussa di Mosca. Subito dopo, i coniugi partirono per un viaggio di studio in Europa occidentale. La prima tappa fu la Francia, quindi Lipsia, dove a Aleksej fu offerto un lavoro nel laboratorio dell'Università e Ol'ga seguì lezioni di botanica. Proprio a Lipsia, a dicembre, nacque l'unico figlio della coppia, Boris. Nell'estate, con il neonato si spostarono a Heidelberg e quindi in Svizzera, dove Aleksej intendeva studiare i ghiacciai per prepararsi a una nuova spedizione nel Pamir. Il 2 settembre 1873, accompagnato da due guide locali, Aleksej mosse da Chamonix per raggiungere il ghiacciaio del Gigante. Proprio mentre si trovavano sul ghiacciaio, il tempo peggiorò all'improvviso e Fedčenko ebbe un malore. Le guide, piuttosto inesperte e a loro volta esauste, decisero di lasciarlo a se stesso e scesero in cerca di soccorsi. Quando questi arrivarono, lo trovarono già morto. Ol'ga era invece convinta che fosse ancora vivo, e che se le autorità locali avessero inviato un medico, avrebbe potuto essere salvato. Al momento della morte, Aleksej Pavlovič aveva 29 anni. Fu sepolto a Chamonix e sulla sua tomba Ol'ga fece collocare una lapide con l'epigrafe "Dormi, ma le tue fatiche non saranno dimenticate".  Vedova, madre, ma soprattutto botanica! Subito dopo la mesta cerimonia, Ol'ga ritornò a Mosca con il piccolo Boris. Negli anni successivi, una serie di sventure colpì la famiglia Armfeld; la più dolorosa fu l'arresto della sorella minore Natal'ja, impegnata nel movimento populista, seguito dalla deportazione in Siberia e dalla morte. Le condizioni economiche di Ol'ga Fedčenko peggiorarono, e la donna fu costretta a mantenere se stessa e il figlio con una modesta rendita. Ancora nel 1873, pubblicò il suo primo lavoro: la traduzione di Sketch of the geography and history of the Upper Amu-Daria di Henry Yule, con le note di Aleksej. Un lavoro eccellente che le guadagnò una medaglia della Società Geografica. Molto successo godettero anche i suoi disegni e le sue vedute dei monti del Turkestan, Nonostante le difficoltà personali, Ol'ga si era data un compito sacro: assicurare la catalogazione, lo studio e la pubblicazione dei materiali raccolti durante la spedizione in Turkestan. Aleksej aveva fatto in tempo solo a scrivere Viaggio in Turkestan (che fu pubblicato nel 1875). Nella Russia di fine Ottocento, era impensabile che una donna dirigesse un lavoro così impegnativo e così costoso. Tuttavia il presidente dell'OLEAE riuscì a convincere il governatore Kaufman che la signora Fedčenko era l'unica a poter garantire il successo dell'impresa; ufficialmente, a curare la pubblicazione fu un comitato editoriale ad hoc, ma Ol'ga ne faceva parte ed era lei a coordinare tutte le attività e a corrispondere con i diversi autori coinvolti nel progetto. Solo grazie al suo impegno e alla sua perseveranza, tra il 1874 e il 1902 uscirono i venti volumi dedicati alla spedizione, con le descrizioni della geografia, della geologia, della flora e della fauna della regione. I volumi dedicati alle piante si devono a Ol'ga Fedčenko, che ormai era una botanica internazionalmente riconosciuta. In questi anni, si occupò anche dell'erbario dell'Orto botanico dei farmacisti di Mosca e pubblicò una catalogo dei muschi dell'Orto botanico di San Pietroburgo. Ma Ol'ga aveva ancora un sogno: tornare in Pamir e riprendere quel viaggio interrotto. Per tornare sul campo dovette aspettare quasi vent'anni, fino al 1891. Ora accanto a lei c'era un nuovo compagno: suo figlio Boris, che si era appena iscritto all'Università di Mosca dove studiava botanica. Il loro primo viaggio, tra il 1891 e il 1892, li portò negli Urali sudoccidentali, una regione con caratteristiche geologiche e una flora molto varia, dalle comunità delle steppe a quelle di alta montagna. L'anno dopo erano in Crimea, e quello successivo nel Caucaso. Nel 1897 (adesso Boris era assistente all'Università di Mosca) madre e figlio andarono nel Tian Shan. Ol'ga trascorse i due anni successivi a studiare le collezioni degli orti botanici e degli erbari dell'Europa occidentale, inclusi quelli di Parigi, Berlino e Londra, mentre Boris veniva assunto come botanico principale dell'Imperiale orto botanico di Pietroburgo. Finalmente, nel 1901 i Fedčenko poterono intraprendere la sognata esplorazione del Pamir. A cinquantacinque Ol'ga ritrovava i paesaggi che l'avevano affascinata quando era una giovane donna. La regione era ancora largamente inesplorata e sottoposta all'occupazione militare, ma era divenuta meno irraggiungibile, grazie alla ferrovia che ora arrivava a Tashkent. La spedizione durò cinquantadue giorni e li portò fino al confine dell'Afghanistan. Ol'ga cavalcò per intere giornate, riposandosi il minimo indispensabile, e sostentandosi con tè e pane secco. I risultati della spedizione furono pubblicati da Ol'ga Fedčenko in Flora Pamira (1903-1905) e Definizione delle piante del Pamir (1910). A quattro mani con Boris è l'imprescindibile Conspectus Florae Turkestanicae (1913), pubblicato contemporaneamente in russo e in tedesco, che copre 4145 specie. Adesso Ol'ga viveva con suo figlio a San Pietroburgo, dove dal 1905 Boris era diventato capo dell'erbario (il cui fiore all'occhiello erano proprio le collezioni dei Fedčenko), ma soggiornava spesso nella tenuta degli Armfeld a Možajsk. Qui, a partire dal 1895, madre e figlio avevano creato un eccezionale orto botanico privato, chiamato Ol'gino: era un giardino di acclimatazione, dove coltivavano e studiavano le piante raccolte durante le spedizioni; erano anche molto generosi nel distribuirne i semi ad altri orti botanici. Le piante preferite di Ol'ga erano le Iris, gli Allium e gli Eremurus. Nel 1906 Ol'ga divenne membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo: la seconda donna, e la prima naturalista, ad ottenere questo onore. Seguirono ancora due viaggi nell'amato Turkestan, sempre con Boris, uno nel 1910 e l'altro nel 1915. Alla vigilia della guerra, nel corso del suo ultimo viaggio in Europa, visitò anche l'Italia e erborizzò nei dintorni di Napoli. Nonostante la salute declinante e i rovesciamenti politici, rimase attiva fino alla morte nel 1921. Aveva appena fatto in tempo a pubblicare il suo sessantaduesimo lavoro, una monografia sull'amato genere Eremurus. Una sintesi della vita della prima botanica professionista russa nella sezione biografie. Per concludere, qualche riga su Boris Alekseevič Fedčenko, a sua volta uno dei più importanti botanici della sua generazione. Come ho già detto, nel 1902 era stato nominato curatore dell'erbario dell'Orto botanico di San Pietroburgo; gli fu affidata anche la direzione della rivista dell'Istituto, Bulletin of the Imperial Institute. Nel 1908, insieme al micologo A. A. Elenkin e al botanico A. F. Flerov, iniziò a pubblicare una rivista indipendente, Journal Russe de Botanique, che uscì fino al 1915, quando fu costretto a chiudere in seguito allo scoppio della Prima guerra mondiale. Sempre con Flerov, tra il 1908 e il 1910 pubblicò Flora Evropejskoj Rossii ("Flora della Russia europea"), che contiene 3.542 nuove specie, e una flora dell'Oka. Questi volumi furono criticati da alcuni colleghi per le descrizioni essenziali; era una scelta voluta, per mantenere loro un formato tascabile, che li rese un bestseller tra appassionati e escursionisti, Negli anni '20, Fedčenko fu impegnato in escursioni sul campo nella Russia asiatica, grazie alle quali poté completare Flora Asiatskoj Rossii "Flora della Russia asiatica" (1912-1924), ancora con Flerov. Nel 1931, quando l'Orto botanico e il Museo Botanico di Leningrado vennero fusi per creare l'Istituto Komarov, sotto la direzione dello stesso Vladimir Komarov, Fedčenko lo sostituì come editore capo della grandiosa Flora dell'Unione sovietica, di cui curò diversi volumi fino alla sua morte nel 1947.  Olgaea, un ritratto vegetale? Aleksej Pavlovič Fedčenko era soprattutto uno zoologo ed è onorato dall'epiteto fedtschenkoi (la barbara grafia si deve alla trascrizione tedesca del cirillico) di alcune specie di animali; come geografo e glaciologo, a ricordarlo è soprattutto il ghiacciaio Fedčenko, il maggiore del Pamir, anzi il più grande al di fuori dei Poli, scoperto nel 1878. Le numerose piante con nome specifico fedtschenkoi o più raramente fedtschenkoanus sono invece dedicate a suo figlio Boris. Probabilmente la più famosa è Kalanchoe fedtschenkoi, una specie malgascia che nel 1915 fu dedicata dallo scopritore Perrier de la Bâthie al "sapiente e gentile dottor Fedčenko dell'Orto imperiale di San Pietroburgo". Nel 1941 Kudrjasev gli dedicò inoltre il genere Fedtschenkiella, oggi sinonimo di Dracocephalum. Moltissimi onori sono giustamente andati a sua madre Ol'ga Armfeld Fedčenko, una grande botanica di fama europea. Il primo omaggio venne nel 1878 da Regel, il botanico tedesco che dirigeva l'orto botanico di San Pietroburgo, con Rosa fedtschenkoana, una bellissima specie nativa dalle regioni coraggiosamente esplorate da Ol'ga e Aleksej. Nel 1882 replicò con il genere Fedtschenkoa, oggi sinonimo di Strigosella. La maggior parte delle piante che la ricordano hanno però una denominazione basata sul suo nome personale: sono un centinaio le specie di trenta famiglie diverse che portano in suo onore l'eponimo olgae. Nella maggior parte dei casi, si tratta di piante delle steppe e delle montagne dell'Asia centrale, da lei scoperte nel corso dei suoi viaggi. Tra di esse, non poteva mancare Eremurus olgae, un altro omaggio di Regel. Non fanno eccezione alcune specie del genere Olgaea, omaggio postumo di M. M. Ilijn (1922). Questo piccolo genere di cardi della famiglia Asteraceae comprende infatti una quindicina di specie distribuite tra l'Asia centrale, l'Himalaya e le aree temperate dell'Asia orientale; ma il loro territorio di elezione, il centro di diversità, sono proprio le impervie montagne dell'antica regione del Turkestan, oggi divisa tra varie repubbliche. Sono erbacee perenni piuttosto imponenti, assai ramificate e piuttosto spinose, con fiori viola o blu che ricordano quelli dei carciofi, adattate a resistere all'aridità e a condizioni climatiche estreme, con inverni glaciali ed estati torride. Sono piante bellissime e austere, che credo non sarebbero spiaciute alla tenace e coraggiosa dedicataria, di cui potrebbero anche essere un occulto ritratto vegetale. Qualche approfondimento nella scheda. Nonostante la sua breve vita, la figura di William Anderson, aiuto chirurgo della Resolution nel secondo viaggio di Cook e primo chirurgo nel terzo, ha destato interesse come prototipo del tipico chirurgo della Royal Navy che univa all'abilità professionale spiccati interessi naturalistici. Benché non avesse avuto un'educazione formale come naturalista, era una sicura promessa della scienza britannica, ma anche un "giovane sensibile" ricco di acume e umanità la cui morte destò grande rimpianto tra i suoi compagni d'avventura. A ricordarlo, grazie a Robert Brown, l'Ericacea australiana Andersonia, che tuttavia presiede in condominio con due omonimi: il giardiniere William Anderson e il botanico Alexander Anderson. Soprattutto quest'ultimo è una figura di notevole interesse.  Apprendistato di un giovane uomo sensibile Il 3 o il 4 agosto 1778 sulla Resolution, la nave ammiraglia del terzo viaggio di Cook, ha luogo una mesta cerimonia: di fronte all'isola di San Lorenzo nello stretto di Bering viene sepolto in mare il chirurgo William Anderson. Non aveva ancora ventotto anni. La sua morte, preceduta da una lunga malattia, non è una sorpresa per nessuno, ma lascia tutti sgomenti. Cook, di solito freddo e riservato, scrive: "Era un giovane uomo sensibile, un compagno gradevole, molto preparato nella sua professione e aveva acquisito grande conoscenza in altre scienze; se fosse piaciuto a Dio di risparmiare la sua vita sarebbe stato molto utile nel corso del viaggio". Più toccanti e accorate le parole del comandante della Discovery, Charles Clerke (poco più di un anno dopo condividerà lo stesso destino): "La sua morte è il più sventurato colpo subito dalla nostra spedizione; la sua eminente abilità di chirurgo e la sua illimitata umanità lo rendevano il più rispettabile e il più stimato membro della nostra piccola società; la perdita della sua superiore conoscenza, soprattutto rispetto alla scienza della Storia naturale, ha lasciato un vuoto nel nostro viaggio che si farà molto rimpiangere". La grandezza della perdita è sottolineata da James King, secondo ufficiale della Resolution, che era aveva studiato astronomia ad Oxford: "Le sue conoscenze toccavano tutti gli oggetti naturali; la sua applicazione era costante e regolare, e di gran lunga eccessiva per la sua salute; la dedizione con cui studiava le diverse scienze della Storia naturale e le specie umane era tale da dare un vero piacere a ogni persona per bene e ogni uomo di scienza; era la persona più libera dalle ristrettezze di un spirito limitato che io abbia mai conosciuto". Il rimpianto dei suoi compagni d'avventura è condiviso da coloro che hanno studiato questa giovane promessa della scienza britannica. Molti riconoscono in lui il prototipo di una figura tipica della Royal Navy: il chirurgo di bordo che unisce alle capacità professionali una preparazione scientifica di buon livello e dedica qualcosa di più dei ritagli di tempo alla ricerca naturalistica. Come molti chirurghi della marina britannica, William Anderson era nato in Scozia, nel 1750, e tra i sedici e i diciotto anni aveva seguito i corsi della facoltà di medicina di Edimburgo, che includevano nozioni di botanica e scienze naturali. Forse per ragioni economiche, aveva però preferito diventare chirurgo, andando a studiare alla Surgeon Hall di Londra, dove si diplomò come aiuto chirurgo e chirurgo rispettivamente nel 1768 e nel 1770. Quindi si arruolò in marina e servì successivamente come aiuto chirurgo sulla Thunder e sulla Barfleur. Nel 1771 fu scelto come aiuto chirurgo della Resolution, la nave del secondo viaggio di Cook. Al momento dell'imbarco aveva 22 anni e l'esperienza fu sicuramente importantissima per sviluppare la sua competenza scientifica, anche se, poiché il suo diario è andato perduto, dobbiamo accontentarci di notizie indirette. Forse, almeno inizialmente, poté giovarsi in qualche modo dell'addestramento dei Forster, grazie alla mediazione del primo chirurgo James Patten, uno dei pochi che avesse rapporti accettabili con loro. Ma poi subentrò la rivalità e il sospetto. I termini in cui Georg Forster parla di lui nel suo resoconto (senza nominarlo espressamente) sono velenosi: "Uno degli aiuto chirurghi, che partecipò a questa escursione, raccolse una prodigiosa quantità di nuove e curiose conchiglie nell'isola di Ballabea, e ugualmente molte nuove specie di piante di cui non avevamo visto un singolo esemplare nei distretti che avevamo visitato; ma la più malvagia e più irragionevole invidia gli insegnò a nasconderci queste scoperte sebbene fosse del tutto incapace di usarle a profitto della scienza". L'episodio si colloca verso lo fine del viaggio, in Nuova Caledonia, in un momento in cui entrambi i Forster erano malati. Tutto dimostra che, al contrario, Anderson era invece più che capace di trarre profitto dalle sue scoperte. Compilò liste di vocaboli di diverse delle isole visitate, incluso un dizionario di 28 pagine del tahitiano che fu allegato a una delle edizioni del resoconto ufficiale. Solander, che visitò la Resolution subito dopo il ritorno in Inghilterra (ma non poté incontrare Anderson), parla delle sue collezioni in termini elogiativi. Unendo le competenze mediche con gli interessi scientifici, il giovane chirurgo studiò alcuni casi di avvelenamento causati dall'ingestione di pesci tossici e ne fece oggetto di una memoria che, sotto forma di lettera al Presidente della Royal Society John Pringle, ebbe l'onore di essere pubblicata nelle Philosophical Transactions nel 1776. 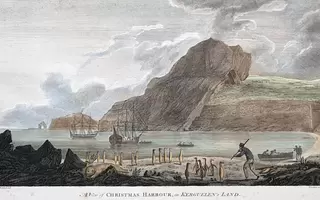 Il terzo viaggio di Cook Nel 1775 il Parlamento britannico istituì un premio di 20.000 sterline a chi avesse scoperto il mitico passaggio a Nord-ovest. E proprio questo fu l'obiettivo non dichiarato del terzo viaggio di Cook: quello ufficiale era riportare in patria Omai, un polinesiano di Raiatea che era stato condotto in Inghilterra sulla Adventure. Alla spedizione parteciparono di nuovo due vascelli: la vecchia Resolution, ancora comandata da Cook, e la piccola Discovery, al comando di Clerke (che era stato il secondo ufficiale della Resolution nel secondo viaggio). Cook la intendeva come una spedizione esclusivamente geografica, e non volle scienziati a bordo (secondo i maligni, dopo la convivenza con i Forster ne aveva avuto abbastanza) e scelse personalmente gli ufficiali tra i veterani che avevano partecipato ai suoi viaggi precedenti. C'erano però un pittore paesaggista, John Webber, e un astronomo, William Bayly. Come primo chirurgo, Cook volle il nostro William Anderson, che in tal modo divenne il naturalista ufficioso della spedizione: rispetto ai "gentiluomini naturalisti", in quanto chirurgo di bordo, presentava l'indubbio vantaggio di essere soggetto alla disciplina militare. Accanto a lui, Banks riuscì tuttavia a insinuare come aiutante uno dei giardinieri di Kew, David Nelson. Purtroppo, la sorte di Anderson era già segnata. Nel breve intervallo tra i due viaggi aveva servito sulla fregata Milfort, dove aveva contratto la tubercolosi. Anche Clerke si trovava nelle medesime condizioni: essendosi offerto come garante di un fratello insolvente, era finito in carcere per debiti, e qui era stato infettato. Al momento della partenza, tuttavia, entrambi sembravano ancora in buona salute. La Resolution partì per prima nel luglio 1776, mentre la Discovery poté salpare solo all'inizio di agosto. Nell'intervallo tra i due viaggi, la nave di Cook non era stata adeguatamente riparata e presto incominciò a imbarcare acqua soprattutto attraverso il ponte principale; con il mare grosso, le cuccette degli uomini venivano inondate, destando la preoccupazione del coscienzioso Anderson per la salute dei marinai. A Cape Town fu raggiunta dalla Discovery ; mentre entrambe le navi venivano ricalafatate, Anderson si unì a Nelson in alcune escursioni botaniche. Dopo aver lasciato il Sud Africa, navigando in direzione sud-est Cook scoprì le isole del Principe Edoardo, quindi, seguendo gli ordini dell'ammiragliato, prese possesso delle desolate isole Kerguelen con una cerimonia che Anderson (possediamo i suoi diari relativi alla prima parte della spedizione) trovava ridicola; in tutto l'emisfero, era difficile trovare un posto più sterile e meno interessante per un naturalista. Eppure, oltre a studiare i pinguini, proprio qui fece la sua più importante scoperta botanica: il cavolo delle Kerguelen, Pringlea antiscorbutica. La tappa successiva fu la Tasmania, dove l'interesse di Anderson sembra essere stato attratto soprattutto dagli indigeni, miti e accoglienti verso i forestieri; tuttavia egli osservò anche le piante, in particolare gli onnipresenti eucalipti. Il viaggio proseguì per il Queen Charlotte Sound in Nuova Zelanda, quindi toccò le isole Cook (a Atiu gli indigeni sequestrarono le piante che Anderson aveva appena raccolto, ma il chirurgo fu tutto sommato divertito dalla possibilità di osservare dal vivo l'uomo allo stato di natura) e le Tonga. Anderson descrive con ammirazione i pesci che popolano la barriera corallina, osserva con occhio clinico le malattie che affliggono gli indigeni (compresa la sifilide, importata dai viaggiatori europei), esprime qualche critica - ma sempre nel rispetto delle gerarchie - sulle punizioni a suo parere sproporzionate inflitte agli indigeni. Intanto, gli effetti della malattia avevano cominciato a manifestarsi sia per Anderson sia per Clerke. A Anderson era chiaro che proseguire il viaggio e affrontare i gelidi mari del Pacifico settentrionale sarebbe stato fatale ad entrambi. A Tahiti, dove arrivarono il 12 agosto 1777 e si fermarono fino all'inizio di dicembre, i due decisero di dare le dimissioni e di chiedere di essere lasciati a terra, affidati alle cure degli indigeni. Tuttavia, il senso del dovere, la lealtà verso i compagni, l'incertezza della reazione di Cook, li fecero esitare e rimandare la comunicazione, finché fu troppo tardi; lasciata Tahiti, dopo aver toccato le Isole della Società, nella loro rotta verso la costa americana le navi si addentrarono infatti in acque inesplorate. La salute di Anderson incominciò a declinare. Il 21 dicembre accompagnò ancora Cook in una passeggiata di discreta lunghezza a Kauai, la prima isola delle Hawaii toccata dalla spedizione. Tuttavia, il 10 gennaio, giorno in cui le navi raggiunsero l'isola di Hawaii, l'astronomo Bayly annotò sul suo diario che tutto l'equipaggio era in buona salute "eccetto il chirurgo Mr. Anderson che è molto malato in stato di consunzione". Fu solo la forza della volontà a permettergli di continuare le osservazioni linguistiche ed etnografiche e forse anche le raccolte naturalistiche (non possediamo il suo diario dopo Tahiti). Dopo aver lasciato le Hawaii all'inizio di febbraio, le navi si diressero a nord, toccando terra il 6 marzo presso Capo Foulweather nell'attuale Oregon. Proseguendo verso nord, si ancorarono nella baia di Nootka, dove trascorsero circa un mese, dal 29 marzo al 26 aprile 1778. Quindi iniziarono ad esplorare e a mappare la costa, proseguendo fino allo stretto di Bering, nella speranza di individuare il passaggio a Nord-ovest. A maggio gettarono l'ancora nell'attuale Prince William Sound in Alaska e Anderson mise piede a terra forse per l'ultima volta, arrampicandosi con Cook su una collina. Fino alla morte, avvenuta tra le 3 e le 4 del pomeriggio del 3 agosto di fronte all'isola di San Lorenzo, non abbiamo altre notizie su di lui. Se fosse vissuto, oltre ad arricchire il risultati scientifici dello sventurato terzo viaggio di Cook, sarebbe sicuramente diventato qualcosa di più di una promessa della scienza britannica; probabilmente sarebbe stato ammesso alla Royal Society e sarebbe diventato uno degli uomini di Banks, al quale legò le sue collezioni. Una sintesi della sua breve vita nella sezione biografie. Ancora qualche riga per concludere il racconto. Ovviamente, Cook non trovò il passaggio a nord-ovest (sarà conquistato solo nel 1906 dal celebre esploratore polare Roald Amundsen) e divenne sempre più esasperato e intrattabile. Quindi ritornò alle Hawaii dove, come tutti sanno, il 14 febbraio 1779 trovò la morte. Clerke, che si era apparentemente un poco ripreso, assunse il comando della Resolution, mentre sulla Discovery gli subentrava John Gore, e riprese la ricerca del passaggio a nord-ovest. Ridotto a uno scheletro dalla tubercolosi, si spense in mare il 22 agosto 1779 (era il giorno del suo trentottesimo compleanno) e fu sepolto a Petropavlovsk in Kamčatka. Dopo diverse altre vicissitudini, una delle spedizioni più disastrose della storia della Royal Navy si concluse il 4 ottobre 1780 con il rientro in patria delle due navi. La stesura del resoconto ufficiale fu affidato al canonico John Douglas che per integrare il diario di Cook utilizzò ampiamente il diario del nostro William Anderson.  Un genere per tre I materiali raccolti da Anderson rimasero inediti nella biblioteca di Banks, finché Robert Brown molti anni dopo li esaminò mentre preparava il suo importante lavoro sulla flora australiana. Oramai avevano perso ogni carattere di novità, ma Brown volle rendere omaggio allo sfortunato chirurgo dedicandogli il genere Andersonia, con una interessante nota biografica: "L'ho denominato in memoria di William Anderson, chirurgo navale, che partecipò a due spedizioni di Cook e morì durante l'ultima; si dedicò quanto più poteva all'osservazione di uomini e animali e non trascurò la botanica. Nella biblioteca di Banks e nel suo catalogo rimangono diverse sue descrizioni di piante, soprattutto dell'isola di Demen [cioè la Tasmania]; tra di essi non ho trovato alcun genere inedito, ovvero Goodenia Sm., Corraea Sm., Bauera (Ms. Ramsay) e Eucalyptum L.Hérit." Brown tuttavia approfittò dell'occasione per ricordare altri due Anderson: "Alexander Anderson, prefetto dell'orto botanico dell'isola di Saint Vincent, e William Anderson, giardiniere abilissimo, solertissimo coltivatore e acuto osservatore di piante esotiche". Al momento della dedica erano entrambi viventi e sicuramente più noti dello sfortunato chirurgo di Cook. Alexander Anderson (1748-1811) era nato ad Aberdeen e aveva studiato all'università di Edimburgo senza completare gli studi, quindi si era trasferito a Londra dove aveva lavorato per qualche tempo al Chelsea Physic Garden sotto il suo conterraneo William Forsyth. Nel 1774 si spostò a New York, dove lavorò come giardiniere e spedì a Forsyth alcuni esemplari di piante raccolte a Long Island e York Island (oggi Manhattan). Fedele all'Inghilterra, durante la guerra di Indipendenza per sottrarsi all'arruolamento si trasferì prima in Suriname poi nelle Antille britanniche. Nel 1783 si trovava all'Ospedale militare di Saint Lucia come aiutante di George Young, che gli chiese di cercare piante medicinali locali, tra cui un antimalarico che si pensava potesse sostituire la china; tuttavia la pianta, conosciuta come Cinchona sanctaeluciae, benché amara, non contiene gli alcaloidi presenti nel genere Cinchona ed è stata trasferita nel genere Exostema quindi in Solenandra, come S. sanctaeluciae. Nel 1784, quando il dottor Young poté tornare a Saint Vincent (per qualche anno occupata dai francesi), lo accompagnò, quindi gli succedette come prefetto del giardino botanico dell'isola, specializzato nella coltivazione di piante tropicali. Era anche un attivo raccoglitore, in corrispondenza con Banks, su sollecitazione del quale nel 1785 redasse un catalogo delle piante coltivate nell'orto, nel quale elenca 348 piante diverse, soprattutto medicinali o di interesse commerciale. Intorno al 1800 ne compilò una seconda edizione, che contiene circa 2000 specie, dandoci la misura del grande lavoro compiuto da Anderson per ampliare le collezioni dell'orto, sia grazie alle raccolte sul campo, sia grazie alla rete di corrispondenti. Anderson fece raccolte non solo a St Vincent, ma anche nelle piccole Antille, nell'entroterra costiero del Messico caraibico, a Trinidad e Tobago e nelle Guiane. Ricevette molte piante da capitani di marina e da numerosi corrispondenti, risiedenti nelle tredici colonie e nelle Antille francesi. Fu così che grazie a lui numerose piante caraibiche furono introdotte in Europa. Ma l'orto botanico di Saint Vincent divenne anche un centro di diffusione delle piante tropicali che, attraverso Kew, giungevano da altre parti del mondo. La più famosa è l'albero del pane Artocarous altilis, che arrivò a Saint Vincent da Tahiti nel 1793; Anderson la moltiplicò e provvide a distribuirla nelle altre isole delle Antille britanniche. Egli fu anche un prolifico autore di contributi che inviava alla Royal Society e alla Linnean Society. Progettò inoltre di scrivere una Flora dei Caraibi, di cui rimangono solo poche pagine manoscritte inviate a Banks. Purtroppo non pubblicò nessuna delle almeno 100 piante caraibiche che aveva raccolto e il suo nome è ricordato appunto solo dalla dedica collettiva di Andersonia R. Br. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Veniamo infine al secondo William Anderson (1766-1846); anche lui era scozzese e dopo aver lavorato come giardiniere in alcuni vivai nei pressi di Edimburgo, negli anni '90 si trasferì a Londra dove divenne il giardiniere capo del facoltoso mercante James Vere, che a Kengsinton Gore possedeva una notevolissima collezione di piante tropicali, in particolare succulente. Gli è stato persino dedicato il genere Veraea / Vereia, oggi sinonimo di Kalanchoe. William Anderson si fece un nome come esperto di succulente e nel 1798 fu ammesso alla Linnean Society. Nel 1814 venne nominato sovrintendente del Chelsea Physical Garden che in quegli anni aveva perso molto del passato smalto. Anderson ne seppe risollevare le sorti; contribuì anche attivamente con numerosi articoli al Gardeners Magazine e alle Transactions della Horticultural Society. Anche su di lui, una nota biografica nella sezione biografie.  Andersonia, viva la varietà! Andersonia R.Br. è un piccolo genere endemico dell'Australia sudoccidentale, della famiglia Ericaceae (precedentemente Epacridaceae). Brown lo stabilì sulla base di cinque specie che egli stesso aveva raccolto lungo il King George's Sound e di una specie raccolta a Lucky Bay. Oggi comprende una trentina di specie di arbusti che vivono soprattutto nelle boscaglie di ericacee, con alcune specie tipiche di habitat più sabbiosi o rocciosi. Anche se alcune specie sono di dimensioni maggiori, la maggior parte sono piccoli arbusti che non superano il metro, mentre le specie di ambienti rocciosi sono nane a cuscino. Una differenza legata ai diversi habitat, che vanno dalle zone con precipitazioni abbondanti a quelle semiaride. Sempreverdi, hanno foglie da piccole a minute, spesso aghiformi, alternate o disposte a spirale. I fiori possono essere solitari ma più spesso sono aggregati in infiorescenze terminali, con i fiori sotteso da una serie di brattee o bratteole. Il calice con cinque sepali o polisepalo è persistente e in genere eccede la corolla tubolare; bianco, rosa, viola o azzurro, spesso è più decorativo della corolla. Anche quest'ultima, tubolare o a urna, con lobi ricurvi o retroflessi, è piuttosto varia. Il gigante del genere è A. axillaris, un grande arbusto che può superare i tre metri. Presente solo sulle pendici superiori e sulle sommità delle cime occidentali del Stirling Range National Park, dove vive in suoli rocciosi in associazione a fitte boscaglie di ericacee, è una pianta ormai rara oggetto di progetti di reintroduzione. Tra le più piccole e più comuni, troviamo invece A. macranthera, una specie non più alta di mezzo metro che vive nelle pianure sabbiose dalla costa sud-occidentale, con minuscole foglie aghiformi e deliziosi piccoli fiori con sepali e corolla rosa-porpora. Altre specie sono ancora più decorative. A. grandiflora, una minuscola specie a cuscino presente in poche aree con suolo roccioso e sabbioso dei dintorni di Albany, ostenta sorprendenti fiori con calice bruno e corolla rosso-aranciato. Ma forse la più singolare è A. caerulea, una specie piuttosto diffusa, con portamento tappezzante o decombente; al momento della fioritura, produce fitte infiorescenze a spiga di fiori bicolori, con calice rosa-violaceo e corolla azzurra, da cui emerge un ciuffo di stami candidi. Altre informazioni nella scheda. Curioso destino, quello di Johann Reinhold Forster e di suo figlio Georg. Oggi il primo è considerato uno dei filosofi naturali più interessanti dell'ultimo Settecento, e il secondo uno dei padri dell'etnologia. Eppure, al loro tempo, l'uno e l'altro sono stati ostracizzati per motivi diversi. A rovinare la fama di Johann Reinhold è stato il suo pessimo carattere, che lo ha fatto definire da uno dei biografi di Cook un "incubo"; la reputazione di Georg è stata invece compromessa dall'entusiastica adesione alla rivoluzione francese, che gli è costata la condanna come traditore della patria, l'esilio, la morte precoce e il lungo oblio della sua opera scientifica. Entrambi parteciparono alla seconda spedizione di Cook, il padre come naturalista ufficiale, il secondo soprattutto come disegnatore e, al di là delle polemiche, si dimostrarono naturalisti solerti e capaci. A ricordarli nella terminologia botanica un genere di piante minuscole endemiche della Nuova Zelanda e della Tasmania, Forstera. A raccogliere il primo esemplare nei pressi di Cascade Cove fu Anders Sparmman che volle dedicarla al "mio compagno botanico" Georg Forster. 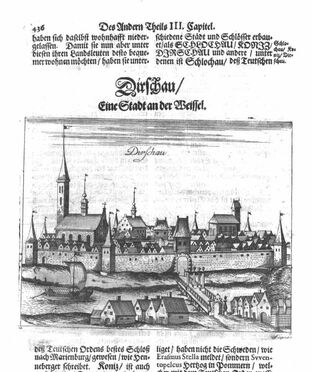 Prima del viaggio: un erudito tedesco Anche ai suoi tempi, nessuno dubitava che Johann Reinhold Forster, il naturalista ufficiale della seconda spedizione Cook, fosse un uomo coltissimo e di grande competenza scientifica. Eppure la convivenza con Cook fu così disastrosa che, dopo quell'esperienza, il navigatore decise di non volere più alcun naturalista a bordo. Il giudizio del biografo di Cook J.C. Beaglehole è senza appello: "Niente può renderlo diverso da uno dei peggiori errori dell'ammiragliato. Dall'inizio alla fine del viaggio, e anche successivamente, fu un incubo. Si esita a descriverne le caratteristiche, nel timore che il ritratto passi per una caricatura. Dogmatico, privo di umorismo, sospettoso, pretenzioso, polemico, censorio, esigente, afflitto dai reumatismi: era un problema sotto qualsiasi punto di vista". Molto diversa è l'immagine che ne dà il biografo di Forster Michael E. Hoare, che ha anche curato la monumentale edizione del suo diario del viaggio della Resolution. Secondo Hoare, egli è stato uno dei grandi geni universali dell'ultimo Settecento e l'oblio che è caduto sulla sua figura è una grande perdita per l'antropologia, la linguistica, la geografia e la zoologia del Pacifico. Le incomprensioni e lo scontro con Cook, più che al celebre cattivo carattere dello studioso tedesco, sarebbero dovuti allo incontro impossibile tra due mondi e due visioni della vita: da una parte, un marinaio e un uomo d'arme, dall'altra un filosofo, anzi un "filosofo senza tatto", come lo ha battezzato lo stesso Hoare. Proviamo dunque a raccontarlo, questo personaggio impossibile. E con lui suo figlio Georg, allievo, compagno di viaggio, ragazzo prodigio da esibire, in una relazione padre-figlio che ricorda per molti aspetti quella tra Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart. Johann Reinhold Forster, discendente da una famiglia di origine scozzese emigrata in Germania, nacque all'estrema periferia del mondo tedesco, a Dirschau, nei pressi di Danzica. Dopo aver studiato teologia, lingue classiche e orientali all'Università di Halle, divenne pastore della chiesa luterana di Nassenhuben, un altro villaggio della Pomerania prussiana. Gli aneddoti riferiscono di un pastore riluttante: aveva speso gran parte dell'eredità paterna in libri, e tutto il suo tempo era dedicato allo studio; a preparare i sermoni dedicava solo qualche minuto e durante il servizio spesso era così stanco da cadere addormentato. Intanto si era sposato con una cugina, da cui ebbe ben otto figli. Durante la Guerra dei sette anni (1756-63), quando la sua parrocchia fu ripetutamente occupata dalle truppe russe, conquistò però la stima dei suoi parrocchiani difendendo con energia i loro interessi e le loro proprietà dalla rapacità degli occupanti. Insoddisfatto della sua posizione, fece sapere al residente russo a Danzica che era disposto a trasferirsi in Russia come pastore. Fu forse in seguito a questa richiesta che nel 1764 Caterina II lo incaricò di ispezionare gli insediamenti tedeschi lungo il corso del Volga, per dissipare le voci negative sulle condizioni di vita dei coloni. Lasciando il resto della famiglia a Nassenhuben, Forster partì per la Russia con il figlio maggiore Georg, all'epoca un bambino di dieci anni. Un bambino molto speciale: così appassionato di scienze naturali che il padre, per soddisfare la sua curiosità, acquistò le opere di Linneo e incominciò a studiare zoologia e botanica insieme a lui. Forster prese molto sul serio l'incarico, e ne approfittò per studiare la meteorologia e la storia naturale della regione. La zarina contava su una relazione edulcorata, invece Johann Reinhold presentò un rapporto fortemente critico; di conseguenza gli fu negato il salario promesso. Dopo qualche mese passato a San Pietroburgo cercando inutilmente di essere pagato (Georg ne approfittò per imparare decentemente il russo), quando tornò in patria scoprì che a causa della prolungata assenza era stato privato della parrocchia. Forster decise di andare a cercare fortuna in Inghilterra, forse anche per evitare ritorsioni da parte delle autorità russe. Lasciando nuovamente il resto della famiglia in Pomerania, nell'autunno del 1766 si trasferì a Londra con il piccolo Georg. Non riuscì a trovare impiego al neonato British Museum come aveva sperato, ma nella primavera del 1767 fu assunto come insegnante di lingue moderne e scienze naturali alla Warrington Academy, una scuola non conformista con un curriculum innovativo. L'incarico durò poco: non per la scarsa qualità dell'insegnamento (Hoare, che ha studiato i materiali delle lezioni, ne sottolinea la profondità e l'alto livello) ma per il "caratteraccio" di Forster, accusato di aver inflitto "misure disciplinari violente" a uno studente; senza contare i debiti contratti con molti fornitori. Dopo aver insegnato lingue per un altro anno in una Grammar School della stessa località, Forster tornò a Londra, dove si mantenne con traduzioni sue e del figlio, specializzandosi nei racconti di viaggio: tradusse tra l'altro in inglese le relazioni degli allievi di Linneo Kalm, Loefling e Osbeck e il Viaggio intorno al mondo di Bougainville. Inoltre era redattore di una rivista specializzata in letteratura internazionale. Presentando diversi lavori su svariati soggetti alla Società degli Antiquari e alla Royal Society riuscì a farsi una solida reputazione come naturalista; inoltre era in corrispondenza con molti scienziati in Inghilterra e all'estero, incluso Linneo. Nel 1771 pubblicò A Catalogue of the Animals of North America, accreditandosi come zoologo. Lo stesso anno fu ammesso alla Royal Society. Così, quando praticamente da un giorno all'altro Banks e Solander rinunciarono a partire per il secondo viaggio di Cook, Forster sembrò indiscutibilmente il candidato ideale. Tanto più che l'avrebbe accompagnato suo figlio, un disegnatore di talento, "senz'altro molto utile in questa parte della faccenda", come scrisse il lord dell'Ammiragliato, lord Sandwich. Per tagliar corto con la burocrazia, il re autorizzò il pagamento di una discreta somma per l'acquisto delle attrezzature e in dieci giorni i Forster erano pronti a partire.  Prima del viaggio: un erudito tedesco Anche ai suoi tempi, nessuno dubitava che Johann Reinhold Forster, il naturalista ufficiale della seconda spedizione Cook, fosse un uomo coltissimo e di grande competenza scientifica. Eppure la convivenza con Cook fu così disastrosa che, dopo quell'esperienza, il navigatore decise di non volere più alcun naturalista a bordo. Il giudizio del biografo di Cook J.C. Beaglehole è senza appello: "Niente può renderlo diverso da uno dei peggiori errori dell'ammiragliato. Dall'inizio alla fine del viaggio, e anche successivamente, fu un incubo. Si esita a descriverne le caratteristiche, nel timore che il ritratto passi per una caricatura. Dogmatico, privo di umorismo, sospettoso, pretenzioso, polemico, censorio, esigente, afflitto dai reumatismi: era un problema sotto qualsiasi punto di vista". Molto diversa è l'immagine che ne dà il biografo di Forster Michael E. Hoare, che ha anche curato la monumentale edizione del suo diario del viaggio della Resolution. Secondo Hoare, egli è stato uno dei grandi geni universali dell'ultimo Settecento e l'oblio che è caduto sulla sua figura è una grande perdita per l'antropologia, la linguistica, la geografia e la zoologia del Pacifico. Le incomprensioni e lo scontro con Cook, più che al celebre cattivo carattere dello studioso tedesco, sarebbero dovuti allo incontro impossibile tra due mondi e due visioni della vita: da una parte, un marinaio e un uomo d'arme, dall'altra un filosofo, anzi un "filosofo senza tatto", come lo ha battezzato lo stesso Hoare. Proviamo dunque a raccontarlo, questo personaggio impossibile. E con lui suo figlio Georg, allievo, compagno di viaggio, ragazzo prodigio da esibire, in una relazione padre-figlio che ricorda per molti aspetti quella tra Leopold e Wolfgang Amadeus Mozart. Johann Reinhold Forster, discendente da una famiglia di origine scozzese emigrata in Germania, nacque all'estrema periferia del mondo tedesco, a Dirschau, nei pressi di Danzica. Dopo aver studiato teologia, lingue classiche e orientali all'Università di Halle, divenne pastore della chiesa luterana di Nassenhuben, un altro villaggio della Pomerania prussiana. Gli aneddoti riferiscono di un pastore riluttante: aveva speso gran parte dell'eredità paterna in libri, e tutto il suo tempo era dedicato allo studio; a preparare i sermoni dedicava solo qualche minuto e durante il servizio spesso era così stanco da cadere addormentato. Intanto si era sposato con una cugina, da cui ebbe ben otto figli. Durante la Guerra dei sette anni (1756-63), quando la sua parrocchia fu ripetutamente occupata dalle truppe russe, conquistò però la stima dei suoi parrocchiani difendendo con energia i loro interessi e le loro proprietà dalla rapacità degli occupanti. Insoddisfatto della sua posizione, fece sapere al residente russo a Danzica che era disposto a trasferirsi in Russia come pastore. Fu forse in seguito a questa richiesta che nel 1764 Caterina II lo incaricò di ispezionare gli insediamenti tedeschi lungo il corso del Volga, per dissipare le voci negative sulle condizioni di vita dei coloni. Lasciando il resto della famiglia a Nassenhuben, Forster partì per la Russia con il figlio maggiore Georg, all'epoca un bambino di dieci anni. Un bambino molto speciale: così appassionato di scienze naturali che il padre, per soddisfare la sua curiosità, acquistò le opere di Linneo e incominciò a studiare zoologia e botanica insieme a lui. Forster prese molto sul serio l'incarico, e ne approfittò per studiare la meteorologia e la storia naturale della regione. La zarina contava su una relazione edulcorata, invece Johann Reinhold presentò un rapporto fortemente critico; di conseguenza gli fu negato il salario promesso. Dopo qualche mese passato a San Pietroburgo cercando inutilmente di essere pagato (Georg ne approfittò per imparare decentemente il russo), quando tornò in patria scoprì che a causa della prolungata assenza era stato privato della parrocchia. Forster decise di andare a cercare fortuna in Inghilterra, forse anche per evitare ritorsioni da parte delle autorità russe. Lasciando nuovamente il resto della famiglia in Pomerania, nell'autunno del 1766 si trasferì a Londra con il piccolo Georg. Non riuscì a trovare impiego al neonato British Museum come aveva sperato, ma nella primavera del 1767 fu assunto come insegnante di lingue moderne e scienze naturali alla Warrington Academy, una scuola non conformista con un curriculum innovativo. L'incarico durò poco: non per la scarsa qualità dell'insegnamento (Hoare, che ha studiato i materiali delle lezioni, ne sottolinea la profondità e l'alto livello) ma per il "caratteraccio" di Forster, accusato di aver inflitto "misure disciplinari violente" a uno studente; senza contare i debiti contratti con molti fornitori. Dopo aver insegnato lingue per un altro anno in una Grammar School della stessa località, Forster tornò a Londra, dove si mantenne con traduzioni sue e del figlio, specializzandosi nei racconti di viaggio: tradusse tra l'altro in inglese le relazioni degli allievi di Linneo Kalm, Loefling e Osbeck e il Viaggio intorno al mondo di Bougainville. Inoltre era redattore di una rivista specializzata in letteratura internazionale. Presentando diversi lavori su svariati soggetti alla Società degli Antiquari e alla Royal Society riuscì a farsi una solida reputazione come naturalista; inoltre era in corrispondenza con molti scienziati in Inghilterra e all'estero, incluso Linneo. Nel 1771 pubblicò A Catalogue of the Animals of North America, accreditandosi come zoologo. Lo stesso anno fu ammesso alla Royal Society. Così, quando praticamente da un giorno all'altro Banks e Solander rinunciarono a partire per il secondo viaggio di Cook, Forster sembrò indiscutibilmente il candidato ideale. Tanto più che l'avrebbe accompagnato suo figlio, un disegnatore di talento, "senz'altro molto utile in questa parte della faccenda", come scrisse il lord dell'Ammiragliato, lord Sandwich. Per tagliar corto con la burocrazia, il re autorizzò il pagamento di una discreta somma per l'acquisto delle attrezzature e in dieci giorni i Forster erano pronti a partire.  Seconda parte: Nuova Zelanda-Spithead A giugno le due navi ripartono verso nord per esplorare il Pacifico centrale. Il 15 agosto raggiungono Tahiti, che impressiona fortemente Georg, forse influenzando le sue future idee politiche. Johann Reinhold, che è di cattivo umore per essere stato ferito durante una manovra, lamenta che ancora una volta sono arrivati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Dopo una breve sosta, il viaggio riprende attraverso le isole della Società. Qui, all'inizio di settembre, nell'isola di Raiatea, avviene la rottura tra Cook e Forster. Durante un'escursione a terra, vedendo che un indigeno cerca di impadronirsi del moschetto di suo figlio, Forster padre spara e lo ferisce. Un incidente che potrebbe costare molto caro, come ben sa il comandante, che rimprovera aspramente il naturalista; i due si scambiano male parole, finché Cook lo spinge fuori dalla sua cabina con violenza. Tre giorni dopo si rappacificano e si stringono la mano, ma qualcosa si è rotto per sempre. Da quel momento, agli occhi di Forster Cook è l'uomo egoista che non ha alcun interesse per la scienza e pensa solo alla sua gloria personale. Per il comandante, Forster è sempre più una mina vagante che, oltre a rendere irrespirabile l'atmosfera a bordo, può causare devastanti conflitti con gli indigeni. Il viaggio continua. A ottobre vistano alcune isole delle Tonga. Qui non ci sono molte nuove piante, ma in compenso ad attrarre entrambi i Foster sono i costumi degli abitanti delle isole, la loro musica, le loro lingue, che Georg studia e mette a confronto. Quindi tornano a sud; nuovamente una tempesta separa le due navi, che non si congiungeranno mai più. Il 3 novembre la Resolution è di nuovo nel Queen Charlotte Sound. Rispetto alla prima visita, ci sono molte più fioriture. Tra le piante in fiore c'è Phormium tenax (oggi forse la pianta più nota della Nuova Zelanda) e diverse orchidee, tra cui Thelymitra longifolia. In tutto le specie raccolte sono una trentina, ma Johann Reinhold è deluso perché si aspettava di trovare più animali. Dopo tre settimane di attesa, Cook si convince che l'Adventure sia naufragata durante la tempesta e decide di ripartire. In realtà, Furneaux ha raggiunto anch'esso la Nuova Zelanda in un altro punto, ma, avendo perso diversi uomini in seguito a un attacco maori e essendo a corto di provviste, ha deciso di rientrare in Inghilterra. Come l'estate precedente, anche quella del 1773-4 è dedicata all'esplorazione delle regioni antartiche. La Resolution riprende a percorrere e ripercorrere quei mari gelidi. Il 30 gennaio 1774 incontra un immenso campo di ghiaccio; Cook sospetta si estenda fino al Polo. Ci troviamo a 71° 10' di latitudine sud, il punto più meridionale mai toccato da una nave prima di allora. Forster soffre atrocemente di reumatismi, e ancora più lo angustia la sua personale ossessione: "Ci siamo affaticati per diciotto mesi, ma non abbiamo visto nulla che non sia già stato visto prima. Da parte mia credo che le poche piante e i pochi animali che abbiamo potuto incontrare durante le nostre brevi soste sono probabilmente già state osservate da Mr. Banks e dal dr. Solander". E' ora di tornare in acque più calde. La Resolution ora punta a nord e completa il periplo del Pacifico. Dopo quasi cinque mesi passati ininterrottamente in mare, il primo scalo, a marzo, è l'isola di Pasqua. Quindi si fa rotta per le Marchesi, Tahiti e nuovamente Raiatea. Durante il secondo soggiorno a Tahiti, nella speranza di trovare almeno qualche pianta che sia sfuggita a Banks e Solander, Forster padre scala le colline che coronano Matavai Bay accompagnato da un ragazzo del posto; il cammino è insidioso; sotto la pioggia cade e si procura una lussazione che lo farà zoppicare per anni. L'unica consolazione è aver trovato otto piante che molto probabilmente Banks e Solander non hanno mai visto. Cook esplora e cartografa le isole che portano il suo nome. A Niue (che di conseguenza Cook ribattezzerà isola selvaggia), Sparmann e Georg non fanno in tempo a sbarcare che vengono accolti da una sassaiola. Nelle isole Tonga, Cook proibisce ai naturalisti di scendere a terra, suscitando le prevedibili proteste di Forster. A Tanna, nelle Vanuatu, il naturalista mette le mani addosso a un indigeno che secondo lui voleva imbrogliarlo; dopo aver cercato inutilmente di fermarlo, il secondo ufficiale Charles Clerk ordina a una sentinella di sparargli se non la smette. Forster reagisce mettendo mano alla pistola. Tutti e due vanno a protestare da Cook, che sembra non credere né all'uno né all'altro. E' poi la volta di Vatoa, l'unica isola delle Fiji visitata, e delle Nuove Ebridi, sempre con soste ridotte al minimo che rendono furioso Forster: "Il denaro pubblico è andato sprecato e la mia missione, che consiste nel raccogliere nuove piante, di cui queste isole sono piene, è stata resa del tutto inutile. Che senso ha vedere due o tre isole in più? senza conoscere di quell'isola i prodotti, la natura del suolo, la disposizione degli abitanti, tutto ciò che non può essere imparato osservandola dal largo". Mai il contrasto di obiettivi tra marinai-geografi e naturalisti è stato espresso in modo più netto. Eppure le scoperte geografiche sono eccezionali: prima di tornare per la terza volta in Nuova Zelanda, Cook scopre la Nuova Caledonia e l'isola Norfolk. Il 19 ottobre, getta nuovamente l'ancora nel Queen Charlotte Sound. E' di nuovo una sosta di tre settimane, durante la quale Sparrman e i Forster raccolgono qualche pianta, ma senza entusiasmo: lo scalo è sempre quello, non c'è molto di nuovo da scoprire. L'11 novembre si riparte, questa volta per tornare a casa. Tenendosi approssimativamente a 50° di latitudine, la Resolution attraversa il Pacifico in direzione est e il 18 dicembre raggiunge il Sud America. Natale sarà festeggiato nella Terra del Fuoco. Il 21 marzo 1775 sono a Cape Town, dove Sparrman si separa dagli amici e la Resolution viene rimessa in sesto per affrontare l'ultimo tratto. Il 30 luglio 1775, poco più di tre anni dalla partenza, getta l'ancora a Spithead, in Inghilterra. Dal punto di vista geografico e oceanografico, è una delle spedizioni più importanti di tutti i tempi, con buona pace dell'inquieto Forster. Che, tuttavia, può vantare la raccolta di 260 nuove piante e circa 200 nuovi animali; l'erbario conta migliaia di esemplari di 785 diverse specie, di cui 119 della Nuova Zelanda, la zona dove sono state fatte le raccolte più cospicue. Molto notevole è anche la raccolta di oggetti e manufatti etnografici.  Dopo il viaggio: altri guai Gli scontri non sono finiti. Forse in base ad accordi orali con l'ammiragliato, Forster è convinto che gli sarà affidata la redazione del resoconto ufficiale della spedizione, un incarico che invece Cook rivendica per sé. Lord Sandwich tenta un compromesso: Cook scriverà la parte relativa alla navigazione e alle scoperte geografiche, Forster quella naturalistica; i ricavi verranno divisi a metà. Sembra funzionare: Forster prepara un capitolo di prova e lo presenta a Sandwich, che, insoddisfatto della forma linguistica, lo restituisce con molte correzioni e propone di affidare la revisione a un curatore madrelingua. Apriti cielo! Forster lo vive come un oltraggio, un tentativo mascherato di censura. Si impunta e non ascolta ragioni, finché lord Sandwich affida la redazione del resoconto al solo Cook. Forster, che sperava anche in un buon riscontro finanziario (come sempre, è pieno di debiti), cerca di batterlo sul tempo. Suo figlio Georg, che non ha alcun impegno formale con l'Ammiragliato, scriverà a tempo di record la sua versione, utilizzando i diari propri e del padre. E così nel marzo 1777 esce A voyage around the World di Georg Forster, anticipando di sei settimane lo scritto di Cook. E' uno sgarbo istituzionale: in Inghilterra molti pensano che il vero autore sia Johann Reinhold. E, oltre tutto, vende pochissimo: per tirare avanti, i Forster sono costretti a vendere parte della collezione etnografica e, quel che è peggio, i disegni di Georg. A aggiudicarseli è Banks, che sta diventando sempre più la bestia nera dei due naturalisti tedeschi. Georg incomincia a lavorare all'edizione tedesca, Reise um die Welt (1778-80), che, al contrario della controversa versione inglese, avrà un'accoglienza trionfale. Con la sua prosa non solo scientificamente accurata, ma anche vivace, coinvolgente, di facile lettura, è considerato un caposaldo della letteratura di viaggio, che ha grandemente influenzato la letteratura tedesca. Particolarmente importante la parte etnografica, che fa di Georg un precursore dell'etnografia e una delle fonti più importanti sulle lingue, le religioni, la musica, i costumi e l'economia dei popoli polinesiani. In Germania, di colpo, i Forster diventano eroi nazionali. Nel gennaio 1777 Georg, che adesso ha ventitré anni, viene ammesso alla Royal Society. Quindi va in Germania, nella speranza di trovare una sistemazione accademica per il padre; la situazione finanziaria di quest'ultimo è infatti sempre più compromessa, tanto che rischia il carcere per debiti. Con sorpresa, Georg scopre che il prestigioso Collegium Carolinum di Kassel preferisce assegnare la cattedra di storia naturale a lui anziché al padre. Allora va a Berlino a perorare la causa paterna; grazie all'interessamento dello stesso Federico II, infine Johann Reinhold viene nominato professore di storia naturale e ricerca mineraria presso la sua alma mater, l'Università di Halle. Il duca di Brunswick si offre graziosamente di estinguere i suoi debiti. Dopo tante inquietudini, la vita di Johann Reinhold sfocia in una tranquilla carriera accademica: insegnerà ad Halle per vent'anni (1779-1798), diventerà un riconosciuto membro dell'establishment universitario, verrà ammesso a molte accademie in giro per l'Europa. Ma non riuscirà a finire o a vedere pubblicate le varie opere che aveva progettato. La più importante, Descriptiones animalium, uscirà solo nel 1844, molti anni dopo la sua morte. La vita di Georg fu più movimentata e più tragica. In corrispondenza con molti intellettuali del tempo, divenne una figura di punta dell'illuminismo tedesco. Insieme a Georg Christoph Lichtenberg, che insegnava a Gottinga, fondò e pubblicò la rivista letteraria Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Litteratur. Innamoratosi di Therese Heyne, che sarebbe divenuta una delle prime scrittrici tedesche, nel 1784 per poterla sposare accettò di trasferirsi all'Università di Vilnius, sempre come professore di scienze naturali. L'anno successivo si laureò in medicina a Halle, con una tesi sulle piante del Pacifico meridionale. L'ambiente di Vilnius lo lasciava insoddisfatto, e nel 1787 ruppe il contratto, nella speranza di partecipare a una spedizione russa intorno al mondo, che tuttavia venne annullata. Si trasferì quindi a Magonza come capo bibliotecario dell'Università. Nel frattempo aveva continuato a scrivere di argomenti diversi, anche se la cronica mancanza di denaro l'aveva spesso costretto a privilegiare brevi lavori occasionali e traduzioni. Tra gli allievi di suo suocero Christian Gottlob Heyne a Gottinga c'era anche il ventenne Alexander von Humboldt che ammirava molto Reise um die Welt (anni dopo confesserà che fu proprio questa lettura a fargli scoprire la sua vocazione di naturalista-viaggiatore); il giovane strinse amicizia con Forster e nel 1790 i due viaggiarono insieme in Renania, quindi visitarono Bruxelles, L'Aia, Amsterdam, Londra, Parigi. Forster raccontò questo viaggio in Vedute del Basso Reno, Brabante e Fiandre, in tre volumi, un libro che impressionò grandemente lo stesso Goethe. Di notevole importanza la parte dedicata alla storia dell'arte, con la prima riscoperta dello stile gotico. A Parigi Forster poté seguire le vicende iniziali della rivoluzione francese, cui guardava con entusiasmo. Nel 1792, quando le truppe francesi occuparono Magonza, si unì al locale Club giacobino e partecipò attivamente alla fondazione della Repubblica di Magonza; divenne vice-presidente dell'amministrazione provvisoria, deputato alla Convenzione nazionale tedesca e redattore del Nuovo giornale di Magonza o L'amico del popolo, che anche nel titolo si ispirava alla omonima rivista di Marat. Cosciente che la neonata repubblica non sarebbe stata in grado di reggersi senza il sostegno francese, il 23 marzo 1793 la Convenzione decise di inviare a Parigi tre delegati (Georg Forster, Adam Lux e Potocki) per chiedere l'adesione alla Francia. Tuttavia poco dopo le truppe prussiane invasero la repubblica e presero Magonza dopo un lungo assedio; Forster fu proscritto come traditore della patria. Costretto a rimanere a Parigi, assisté al Terrore. Tra le vittime anche il suo collega Adam Lux, ghigliottinato per aver scritto un'apologia di Carlotta Corday. In miseria e sempre più malato, Georg Forster morì di polmonite nel gennaio 1794, prima di compiere quarant'anni. Una sintesi della vita dei due Forster nella sezione biografie. Le idee politiche condannarono Georg Forster all'ostracismo postumo. Il suo ricordo fu recuperato dalla Repubblica democratica tedesca, ma la sua importanza per la cultura tedesca ed europea ha incominciato ad essere pienamente riconosciuta solo negli anni '70 del Novecento. Come padre fondatore dell'etnologia tedesca, la Fondazione Humboldt gli ha intitolato un premio e una borsa di studio.  Minuscoli endemismi delle isole Nel 1776, Johann Reinhold Forster inviò a Linneo, di cui era grande ammiratore, dieci nuove piante raccolte durante la spedizione, con le relative descrizioni e i nomi binomiali, perché le validasse e le pubblicasse. Le descrizioni erano state redatte presumibilmente da Sparrman, ma il testo era stato organizzato da Georg e rivisto da Johann Reinhold. Linneo fece in tempo a preparare il manoscritto di Decas plantarum, ma non a pubblicarlo, a causa della malattia che lo portò alla morte. A provvedere alla pubblicazione fu nel 1780 suo figlio Carl junior. A causa di questa intricata vicenda, la paternità del genere Forstera in passato è stata attribuita a Linneo figlio, mentre oggi viene riconosciuta a Georg Forster attraverso Linneo padre. Tra quelle dieci piante c'è anche il dono d'amicizia di Sparrman; Georg, sempre devoto al padre, volle che l'omaggio fosse esteso anche a lui, sebbene questa tenera pianticella sembri più adatta a lui com'era nei suoi vent'anni che all'ipocondriaco e rancoroso Johann Reinhold. Il genere Forstera, della famiglia Stylidiaceae, comprende sette specie di erbacee perenni, sei endemiche della Nuova Zelanda e una della Tasmania; sono piante alpine o subalpine che crescono in terreni sciolti ma con umidità costante. Le specie della Nuova Zelanda hanno portamento decombente, con steli più o meno ramificati che tendono a formare densi tappeti, strisciando a livello del terreno, con foglie rivolte verso l'alto agli apici e spesso si addensano e si sovrappongono; nelle zone esposte tuttavia gli steli sono eretti e molto più brevi, non più lunghi di 2 cm. L'unica specie tasmana, F. bellidifolia, ha invece foglie basali raccolte a rosetta e steli eretti. I fiori, generalmente solitari, talvolta in gruppi di due-tre, sono portati all'apice di lunghi e sottili scapi che emergono al di sopra del fogliame; a forma di coppa, con breve tubo e sei petali, sono per lo più bianchi, talvolta con gola rosata, rossa o arancio. Un elenco delle specie e qualche approfondimento nella scheda. Completiamo il racconto della spedizione La Pérouse seguendo la Boussole e l'Astrolabe prima nei mari della Siberia, dove il comandante fa le scoperte geografiche più importanti, compreso lo stretto che porta il suo nome, e forse si riconcilia con i "diavolacci" naturalisti. Dopo una breve sosta in Kamčatka, dove sbarca l'ultimo sopravvissuto, le accompagniamo nei sognati mari del sud, dove un gruppo di isolani mette fine al mito del buon selvaggio facendo a pezzi il secondo Fleurot de Langle e il combattivo geologo Lamanon. Con i nostri naviganti provati nel corpo e nello spirito, arriviamo a Botany Bay, dove è appena avvenuto un evento di portata storica. Poi le navi ripartono e scompaiono nel nulla, inghiottite da un mistero lungo quarant'anni. Ma di misteri ce ne sono altri, tra cui: che c'entra il sudafricano genere Galopina con il comandante La Pérouse? 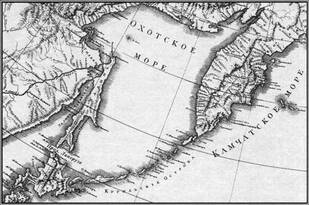 Idillio geografico-naturalistico: esplorando la Tartaria In questo post, avevamo lasciato la Boussoule e l'Astrolabe a Manila. Il dieci aprile 1787, con l'equipaggio al completo, gli scafi in stato perfetto e le stive cariche, salpano dirigendosi di nuovo a nord. L'obiettivo è la costa asiatica del Pacifico settentrionale: al contrario di quella americana (per non parlare del Pacifico meridionale, che Cook ha battuto isola per isola) è ancora poco nota ai navigatori europei e c'è molto da scoprire; è l'occasione tanto attesa da La Pérouse, che è un grande ammiratore di Cook ma è anche ossessionato dal suo fantasma. La navigazione procede rapida e senza scali fino al 23 giugno, quando, dopo aver risalito la Corea, le navi sostano nella baia di Ternej, in "Tartaria" (ovvero in Siberia). Da questo momento inizia l'esplorazione vera e propria, con la rilevazione accurata delle coste siberiane; sono finalmente appagati anche i naturalisti, Lamanon che scopre cristalli, quarzi e pietre curiose, i botanici affascinati dalla vegetazione che nell'arco di tre mesi nasce dal terreno gelato in profondità (è il permafrost), fiorisce e muore; a stupire tutti è anche la grande quantità e varietà di uccelli. Forse anche le tensioni di Macao sono acqua passata e i diavolacci sono meno diabolici: il comandante ribattezza due montagne Pic Lamanon e Pic La Martinière. Le due navi si addentrano nello stretto dei Tartari, che separa il continente da Sachalin; La Pérouse è stato informato dai pescatori locali che si tratta di un'isola e cerca un passaggio a nord, ma là dove il canale si restringe e i fondali si fanno sempre più bassi, desiste; la Boussole e l'Astrolabe invertono la rotta e tornano a sud, per doppiare l'isola passando attraverso lo stretto che separa Sachalin da Hokkaido; oggi, in onore del comandante, si chiama Stretto di La Pérouse: fino a quel momento, infatti, in occidente si pensava che si trattasse di un'isola unica. E' la seconda importante scoperta geografica di La Pérouse, dopo la baia di Lituya. Ormai è metà agosto, la stagione estiva sta per finire, e le navi fanno rotta direttamente per la Kamčatka, dove giungono all'inizio di settembre. Amichevolmente accolti dai russi, i francesi sostano qui un mese, prima nella baia di Avača poi a Petropavlovsk; Barthélemy de Lesseps presta i suoi servigi come interprete; quindi, terminato il suo compito, saluta gli amici e si accinge a traversare la Siberia per tornare in Francia via terra. Porta con sé lettere, disegni, raccolte e la seconda parte del diario di bordo. Sarà un viaggio epico della durata di un anno. Ma così Lesseps (a proposito, zio del più celebre Ferdinand, il promotore del canale di Suez) salva se stesso e molti materiali preziosi. E' il terzo, e ultimo, sopravvissuto della spedizione. 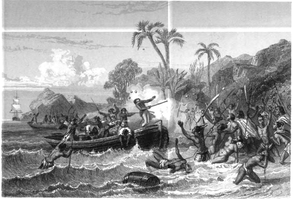 Prima tragedia: il buon selvaggio non è così buono E' ora di andare a sud, per fissare le coordinate dei punti già cartografati e eventualmente completare l'inventario delle isole "in questa vasta parte del grande Oceano disseminato di isole che sul globo terrestre sono l'equivalente della via lattea in cielo". Insomma, quello che La Pérouse avrebbe dovuto fare due anni prima, se avesse rispettato l'itinerario ufficiale. Senza alcun scalo, alla fine di novembre le navi superano la linea dell'equatore, mentre a bordo incominciano a farsi sentire i primi effetti dello scorbuto. In cerca di acqua e viveri freschi, La Pérouse punta verso le Isole dei navigatori (ovvero le Samoa), scoperte da Bougainville poco meno di vent'anni prima. Il 7 dicembre getta l'ancora al largo di Maouna (oggi Tutuila), la maggiore delle isole e la più ricca di villaggi e risorse. Nel corso di una prima spedizione di vettovagliamento alcuni segni lo allarmano, ma si lascia convincere dal suo secondo Fleuriot de Langle ad organizzare una secondo spedizione per caricare acqua di fonte, all'epoca considerata un rimedio infallibile contro lo scorbuto. La spedizione fatale ha luogo l'11 dicembre; vi prendono parte una sessantina di uomini, imbarcati su quattro scialuppe al comando dello stesso Langle; tra loro ci sono anche il geologo Lamanon, i botanici Collignon e La Martinière, il cappellano padre Receveur. Mentre i marinai caricano l'acqua, l'atmosfera si fa sempre più tesa, con forse un migliaio di indigeni che si riversano sulla spiaggia. Langle, che si rifiuta di sparare, seguendo alla lettera gli ordini del re che raccomandano di usare "dolcezza", cerca di calmare gli animi offrendo doni, con il risultato di eccitarli ancora di più. Incominciano a volare le pietre e una lo colpisce alla testa. E' il segnale del massacro: l'ufficiale viene fatto a pezzi, e con lui undici uomini, tra cui Lamanon. La Martinière si salva a nuoto: con un braccio nuota, con l'altro regge un sacco con la raccolta di piante. Anche Collignon e Receveur sono tra gli scampati, ma il cappellano è stato ferito a un occhio. La Pérouse è sconvolto per la perdita di alcuni dei suoi migliori uomini e di colui che non era solo il suo secondo, ma anche l'amico più caro; tuttavia rifiuta di vendicarsi sugli indigeni che sono a bordo, come vorrebbero i suoi marinai, perché essi sono innocenti e non si risponde alla violenza con la violenza. Ma rimpiange che il re abbia vietato l'uso delle armi e che Langle e Lamanon siano andati incontro alla morte illusi dal mito del buon selvaggio. La colpa ce l'hanno i filosofi: "Scrivono i loro libri all'angolo del focolare, e io viaggio da trent'anni; sono testimone delle ingiustizie e delle furberie di questi popoli che ci dipingono così buoni perché sono tanto vicini alla natura; ma è impossibile [...] fare società con l'uomo della natura, perché è barbaro, malvagio e furbo". 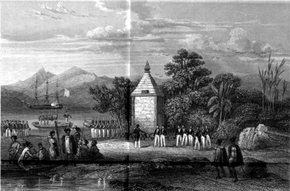 Un mistero durato quarant'anni (e oltre) Traumatizzati, comandante ed equipaggio riprendono il viaggio. Dopo le Samoa, è la volta dell'arcipelago di Tonga; qui gli abitanti sono così amichevoli da aver guadagnato a questo gruppo il soprannome di "isole degli amici". Incominciano i primi decessi per scorbuto e le condizioni di padre Receveur si aggravano. Il 13 gennaio 1788 le navi passano al largo dell'isola di Norfolk ma non possono sbarcare; non resta che fare rotta per Botany Bay, sulla costa orientale dell'Australia, che raggiungono il 26 gennaio. Sono stati preceduti di appena una settimana dalla cosiddetta First Fleet, ovvero la flotta che ha trasportato in Australia il primo convoglio di un migliaio di galeotti deportati. C'è un grande trambusto, perché il comandante, il capitano Arthur Phillip, ha ordinato di trasferire la colonia da Botany Bay a Port Jackson (oggi Sidney), dodici km più a nord. L'accoglienza dei britannici è amichevole, e offrono tutta l'assistenza possibile; non viveri, perché ne hanno meno di loro. I francesi si fermano sei settimane; all'inizio di febbraio padre Receveur muore in seguito alla ferita ricevuta a Tutuila; è il secondo europeo a morire e ad essere tumulato nell'Australia orientale (il primo è stato un marinaio di Cook) e il suo funerale è la prima cerimonia sacra ricordata negli annali australiani. La Boussole e l'Astrolabe ripartono verso metà marzo; il 10 marzo, il capitano de Clonard, che adesso comanda l'Astrolabe, si presenta a Phillip e gli affida un pacco di documenti da consegnare all'ambasciata francese a Londra: contiene dispacci, carte, relazioni, l'ultima parte del diario di bordo; nell'ultima lettera al ministro della marina, La Pérouse enuncia il suo programma; conta di completare l'esplorazione delle isole del Pacifico e di rientrare in Francia passando dalla Réunion, dove dovrebbe essere al più tardi all'inizio di dicembre. Da quel momento, le navi entrano nel mistero. A Réunion non arrivano né a dicembre né mai. Mano a mano che il tempo passa, cresce l'ansia delle famiglie, degli amici, del re, della stessa opinione pubblica che aveva seguito appassionatamente le vicende della spedizione. All'inizio del 1791, la Società di storia naturale di Parigi fa pressioni sull'assemblea legislativa perché venga organizzata una spedizione di soccorso; tra quei deputati siede anche il fratello di uno dei nostri scienziati, l'avvocato Pierre Joseph Didier de Boissieu. All'inizio di febbraio l'assemblea nazionale costituente decreta la missione di soccorso, che sarà posta sotto il comando di Antoine Bruny d'Entrecasteaux; il re promette un premio di 10.000 lire a chi porterà notizie. Come ho già raccontato in questo post, la spedizione Entrecasteux (a sua volta sventurata) non riuscirà a trovare traccia degli scomparsi. E il tempo continua a passare. Il 21 gennaio 1793 Luigi XVI sale al patibolo; sembra che ancora pochi giorni prima abbia chiesto ansioso: "Ci sono notizie di La Pérouse?" Cambiano i regimi: il terrore, il termidoro, l'impero napoleonico, la restaurazione. E arriviamo al 1826. Peter Dillon, irlandese che comanda una nave mercantile britannica, nella sua rotta verso l'India fa una deviazione per visitare alcuni amici nell'isola di Tikopia, nell'arcipelago di Santa Cruz; gli vengono mostrati un'elsa di spada e un cucchiaio d'argento con delle cifre e uno stemma, proveniente dai relitti di un naufragio avvenuto in un'altra isola, Vanikoro. Dillon, che è al corrente del premio offerto dalla monarchia francese, pensa subito alla Boussole e all'Astrolabe. Per ora non può indagare oltre, ma appena arriva a Calcutta informa il governatore della scoperta e la Compagnia delle Indie gli mette a disposizione una nave, prontamente ribattezzata The Research, per andare a cercare altre prove a Vanikoro. Qui trova altri resti, tra cui una campana di bronzo; con i suoi reperti va in Francia, li mostra a Ferdinand de Lesseps, che li riconosce senza ombra di dubbio come provenienti dalle navi scomparse. Il re di Francia (ancora per poco è Carlo X) paga sull'unghia il premio, fa Dillon cavaliere e gli concede una pensione vitalizia. Intanto, il Ministero francese della marina ha finanziato una nuova spedizione nel Pacifico, al comando del navigatore di lungo corso Jules Dumont d'Urville; tra gli obiettivi c'è anche scoprire qualcosa sul mistero delle navi perdute, tanto che la nave di d'Urville viene ribattezzata Astrolabe. Quando arriva in Nuova Zelanda, all'inizio del 1827, il francese viene a sapere delle scoperte di Dillon e si dirige immediatamente a Vanikoro, dove trova abbondanti resti del relitto di una delle due navi e ascolta le testimonianze degli indigeni sul naufragio di quasi quarant'anni prima. Buona parte del mistero è risolto, ma molti particolari rimangono oscuri: per fare totale chiarezza, bisogna aspettare il lavoro dei sommozzatori e degli archeologi, che nel 2005 permettono di trovare, sommersi in un altro punto della barriera corallina, il relitto del secondo vascello, e di identificare con sicurezza le due navi: quella che si è schiantata sulla costa dell'isola è l'Astrolabe, quella che si è arenata più in là è la Boussole, nel cui relitto viene anche trovato un scheletro intatto. Molte ipotesi sulla sua identità; tumulato a Brest con una cerimonia solenne, è noto come lo "sconosciuto di Vanikoro", e, come il milite ignoto, è diventato un po' il simbolo dei duecento e più giovani uomini scomparsi insieme alle due navi. E finalmente anche noi siamo in grado di raccontare come andò. Forse a maggio, forse a giugno, quando la regione è battuta dalle tempeste tropicali, un violento tifone scaglia le due navi contro la barriera corallina che circonda l'isola di Vanikoro. La Boussole, che è più veloce, riesce a vedere in tempo l'ostacolo e a virare, mentre l'Astrolabe lo urta violentemente e va letteralmente in mille pezzi; probabilmente ci sono ben pochi sopravvissuti. A sua volta, la Boussole si incaglia sulle rocce coralline e incomincia ad affondare. Gran parte dell'equipaggio è risparmiato e può raggiungere l'isola. Secondo le testimonianze degli isolani, gli scampati sono un centinaio; ma non trovano un'accoglienza amichevole: gli indigeni sono convinti che siano stati loro a provocare quel terribile tifone e li accolgono come gli abitanti di Tutuila avevano accolto Lange e Lamanon. I francesi (ci piace immaginare che a guidarli ci sia La Pérouse, grande marinaio e eccellente uomo d'armi) resistono con le armi in pugno; alla strage sopravvive una quarantina di marinai che si arrocca in un fortino improvvisato e incomincia a costruire una nave di fortuna usando il fasciame dei relitti e gli alberi delle foreste dell'isola. Quando l'imbarcazione è pronta, la lanciano in mare e scompaiono per la seconda volta, questa volta definitivamente (anche sul loro viaggio non mancano indizi e congetture, ma noi la finiremo qui). Sull'isola lasciano indietro due uomini, che sarebbero vissuti molti anni. Se il 17 maggio 1793 il capitano Entrecasteaux, invece di passare al largo di Vanikoro, fosse sbarcato, li avrebbe trovati ancora vivi e avrebbe ricevuto indicazioni sulla rotta degli altri. Ma la storia, anche della marineria, non è fatta con i se.  Che c'entra La Pérouse con la botanica? E Galopina con La Pérouse? Forse vi state chiedendo: che c'entra la botanica con questa storia, visto che ci siamo già congedati dai botanici della spedizione con il post precedente? Il fatto è che anche i botanici hanno voluto rendere omaggio a La Pérouse; gli sono stati dedicati vari generi, anche se le confusioni non mancano, sia per problemi ortografici, sia per la quasi omonimia con il naturalista Philippe Picot de Lapeyrouse, tanto che in alcuni casi è difficile capire chi sia il vero dedicatario. Nessuno è però oggi valido, ad eccezione del genere Galopina; la dedica si deve a Thunberg, che non spiega l'etimologia del nome, formato a partire dal cognome Galaup, trascritto a orecchio, e non a partire dal gentilizio La Pérouse. E' dunque probabile, ma non certa. Poiché risale addirittura al 1781, non ha nulla a che fare con la tragica spedizione nel Pacifico, ma si riferisce o alla lunga spedizione nei mari dell'India intrapresa da La Pérouse nel 1773 o più in generale ai suoi viaggi nell'Oceano Indiano; infatti, Thunberg inserisce questo genere in mezzo ad altri dedicati a personaggi connessi con l'esplorazione dell'India. Prima di partire per la sua ultima avventura, il navigatore francese aveva già alle spalle una lunga carriera di marinaio e soldato, che è sintetizzata nella biografia. Galopina Thun. è un piccolo genere della famiglia Rubiaceae, con quattro specie diffuse in Sud Africa e nell'Africa tropicale sud-orientale. Sono erbacee con fusti esili, foglie lanceolate e aeree infiorescenze di fiori minuscoli bianco-verdastri; assomigliano molto al loro parente europeo Galium. Ad eccezione di una specie, vivono nel sottobosco delle foreste d'altura. Sono piccole piante che non hanno nulla di eroico, tranne vivere in diverse condizioni anche sulle rocce. Qualche approfondimento nella scheda. La spedizione La Pérouse è una delle più celebri della storia della marina: non per i risultati scientifici, che pure furono importanti, ma per il mistero che ha a lungo avvolto la sua fine. In questo primo post, seguiremo le vicende della prima parte della spedizione e faremo conoscenza con i numerosi membri della variegata squadra di scienziati che avevano aderito con entusiasmo a un'impresa da cui si aspettavano grandiosi risultati e una larga fama. Le loro aspettative si scontrarono con le scelte del comandante, che considerava prioritaria la sua missione oceanografica e mal sopportava le pretese di quegli spocchiosi studiosi terricoli (in tre anni di navigazione, i periodi passati a terra furono ridotti agli scali indispensabili per i rifornimenti e il raddobbo). Con due eccezioni, anch'essi condivisero la sorte tragica e oscura dei loro compagni. A tre di loro sono dedicati altrettanto generi botanici: i sudamericani Lamanionia e Colignonia, e l'australiano Bossiaea.  La partenza: dramatis personae All'alba del primo agosto 1785, al comando di Jean-François de Galaup, conte di La Pérouse, salpano dal porto di Brest le fregate La Boussole e L'Astrolabe. A bordo circa duecentoventi uomini, tra ufficiali, marinai, scienziati. Solo tre di loro torneranno a casa. La spedizione che avrebbe dovuto essere la risposta francese alle imprese del capitano Cook si risolverà infatti nel più celebre disastro della storia della marina d'oltralpe. Eppure è stata preparata con estrema cura e nulla, apparentemente, è stato lasciato al caso; le navi sono state raddobbate per affrontare un viaggio della durata prevista di tre anni, attraverso tre oceani, mari tropicali e mari artici; la strumentazione di bordo è all'avanguardia (l'ingegnere capo è andato personalmente a Londra a procurarsi persino alcuni degli strumenti utilizzati da Cook); gli uomini sono stati scelti con cura, tra fin troppi candidati: molti avrebbero voluto partecipare a un'impresa tanto gloriosa. Tra quelli che sono stati scartati pare ci sia anche un ambizioso allievo ufficiale sedicenne, un genio in matematica, ma davvero troppo giovane: un certo Napoleone Bonaparte. La missione è stata concepita inizialmente dal ministro della marina de Castries come esclusivamente diplomatico-economica, con lo scopo principale di inserire la Francia nei traffici dell'Oceano Pacifico, soprattutto nel promettente commercio delle pellicce . Tuttavia, con il coinvolgimento di istituzioni come l'Accademia delle scienze e il Jardin des Plantes, si è allargata fino ad divenire la più ambiziosa della sua epoca, con l'obiettivo che è insieme scientifico e politico di completare l'esplorazione del Pacifico, delle sue terre, delle sue popolazioni e delle sue rotte per "costituire un catalogo ragionato delle conoscenze in tutti i campi del sapere". Ecco perché a bordo c'è un nutrito drappello di studiosi, specialisti in tutti i campi delle scienze naturali e esponenti delle più prestigiose istituzioni scientifiche del regno. Gli ufficiali, a cominciare dal comandante La Pérouse, sulla Boussole, e dal suo secondo Paul Fleuriot de Langle, sulla Astrolabe, hanno una lunga esperienza di navigazione oceanica; molti sono stati scelti personalmente da La Pérouse tra gli uomini che hanno combattuto al suo fianco nella guerra d'indipendenza americana. I marinai sono in buona parte sperimentati bretoni dal piede marino. Quanto agli scienziati, che si sono imbarcati con una interminabile lista di compiti scientifici e un voluminoso bagaglio di strumenti all'avanguardia (c'è persino una mongolfiera), hanno un'età media di trent'anni e sono membri già affermati delle più prestigiose istituzioni scientifiche del paese; hanno grandi aspettative sui loro compiti, e un'altrettanto grande considerazione di sé. I rilievi cartografici sono ovviamente affidati a ufficiali della marina, a cominciare dall'ingegnere capo Paul Monneron, coadiuvato da Sébastien Bernizet. Gli astronomi sono Joseph Lepaute Dagelet, che ha già partecipato alla spedizione nelle "terre australi" di Kerguelen, e Louis Monge (fratello del più celebre matematico Gaspard). Lo scienziato più prestigioso (e più spocchioso, a detta del comandante) è Jean Honoré Robert de Paul de Lamanon, fisico, geologo, mineralogista, paleontologo, membro dell'Accademia delle scienze di Torino e di Parigi. Il botanico ufficiale è Joseph Hugues Boissieu La Martinière del Jardin des Plantes. Anche i due elemosinieri hanno una formazione scientifica: Jean-André Mongez è un mineralogista rinomato, ma è anche ornitologo, entomologo e chimico, "uomo curioso di tutte le cose"; Louis Receveur è botanico, geologo, chimico, astronomo. Una mano la danno anche i medici di bordo Claude Rollin, Jacques Joseph Le Cor, Simon Lavaux e Jean Guillou. Con un ruolo incerto c'è il naturalista Jean-Nicolas Dufresne, che si è aggiunto come soprannumerario e, al contrario degli altri scienziati, non divide i pasti con gli ufficiali ma con i marinai. Ci sono tre pittori: il paesaggista e ritrattista Gaspard Duché de Vancy, raccomandato personalmente dalla regina; e due illustratori naturalisti, zio e nipote: Guillaume e Jean-Louis Prévost. C'è un interprete, il diciannovenne Bathélemy de Lesseps, figlio del console a San Pietroburgo. Ho volutamente lasciato per ultimo il secondo botanico, o meglio il giardiniere Jean-Nicolas Collignon; ventitrenne, è uno degli assistenti André Thouin al Jardin des Plantes. Parte con un sacco di sementi e pianticelle di alberi da frutto ben protette in speciali serre portatili in legno e vetro, da seminare e trapiantare nel corso del viaggio a beneficio degli indigeni; è il suo compito principale, ma anche lui parteciperà alla raccolta di semi, esemplari vivi o essiccati. Tuttavia Thouin raccomanda che sia indipendente e non subordinato a La Martinière. E infatti La Pérouse lo farà imbarcare sulla nave ammiraglia, mentre l'altro botanico viaggia sull'Astrolabe.  La spedizione: prima parte, da Brest a Manila (1735-1737) Seguendo la rotta puntigliosamente tracciata dall'ammiragliato (e rivista di persona dal re), le navi puntano direttamente sull'America meridionale, con solo due brevi scali a Madera e a Tenerife (29 agosto), dove c'è la prima defezione: l'astronomo Monge ha sofferto talmente il mal di mare che chiede di essere lasciato a terra. Sarà così il primo sopravvissuto. Si registra anche la prima frizione tra il comandante e gli scienziati. Lamanon e i suoi compagni decidono di scalare il Pico de Teide, per misurarne esattamente l'altezza. Sono convinti che rientri pienamente nei loro compiti scientifici e che il costo delle mule e delle guide sarà coperto dai fondi della spedizione; non così la pensa La Pérouse che informa il geologo che la notevole spesa dovrà pagarla lui. Alla gita partecipa anche Collignon, che in una lettera a Thouin racconta di un piccolo incidente: mentre scendeva dalla montagna, il suo mulo si è spaventato e si è messo a correre, di conseguenza il suo vacuolo si è aperto e tutte le piante che aveva raccolto sono andate perdute. Ripartite da Tenerife già il giorno dopo, il 9 novembre le navi gettano l'ancora nell'isola di Santa Catarina, di fronte alle coste brasiliane. Dopo i rifornimenti (gli astronomi approfittano della sosta per montare un telescopio e provare la precisione degli orologi, indispensabili per determinare la longitudine), si riparte per doppiare Capo Horn, con una navigazione insolitamente tranquilla. Il 24 febbraio 1786 la spedizione attracca al porto di cileno di Concepcion; è una vera città, sede del governatore e del vescovo. L'accoglienza è molto cortese e i francesi ricambiano offrendo un ricevimento in una tenda appositamente eretta sulla spiaggia, seguito da un ballo, da fuochi artificiali e dal lancio di una mongolfiera; La Pérouse è euforico e paga da bere a tutti i suoi uomini. Sicuramente i naturalisti avranno approfittato della sosta per le loro raccolte, ma, al contrario del diario di bordo del capitalo, i loro diari di campo sono andati perduti. Terminati i rifornimenti, a metà aprile, si riparte. L'itinerario stabilito dall'ammiragliato prevede che si dirigano a sud, per esplorare le isole del Pacifico meridionale non toccate da Cook. La Pérouse decide di invertire la rotta e di puntare direttamente verso l'America settentrionale, con due sole tappe intermedie: l'isola di Pasqua e le Hawaii. Nella prima si fermano solo un giorno e Collignon, accompagnato da Lange, ne approfitta per seminare verdure e alberi da frutto; gli indigeni vivono in condizioni miserevoli, e rubano tutto quello che possono, specialmente i cappelli e i fazzoletti dei marinai. Anche la sosta alle Hawaii è brevissima; il comandante evita l'isola di Hawaii, tristemente legata alla morte di Cook, e va a fare rifornimento a Maui, dove arriva il 18 maggio; rinnovate le scorte di acqua, maiali, banane, taro, il 1 giugno si riparte in direzione nord. Dopo tre settimane di navigazione sotto costa, spesso resa difficile dalle nebbie, si vede emergere dalle nubi la cima del Monte Sant'Elia. E' ancora estate, e, secondo gli ordini del re, devono esplorare con la massima accuratezza quest'area dove secondo i racconti dei marinai spagnoli potrebbe trovarsi l'imbocco del mitico passaggio a Nord-ovest. La Pérouse è scettico e scrive nel diario di bordo: "Bisogna ammettere una volta per tutte che si tratta di favole geografiche che sono state accettate troppo facilmente dai moderni geografi". Tuttavia, non si sottrae al compito. Il 2 luglio a 58° 52' nord scopre un'insenatura non indicata sulle carte che battezza Porto dei francesi (oggi si chiama Lituya Bay). Gli indigeni li accolgono amichevolmente e, in cambio di oggetti di ferro, offrono salmoni e pelli di lontre di mare. I francesi si fermano qui per un mese e i naturalisti sono finalmente felici di esplorare una natura che, tuttavia, li delude un po' perché fin troppo familiare. La Martinière lamenta di aver trovato al massimo tre specie sconosciute; tutte le altre avrebbe potuto raccoglierle agevolmente nei dintorni di Parigi. Il più contento è Lamanon, che si arrampica sulle scogliere e trova conchiglie a 400 metri dal livello del mare; insieme a Mongez, Receveur e Collignon va anche in cerca di minerali. Questa baia ben riparata, ricca di cacciagione e abitata da indigeni accoglienti, sembra la sede ideale di una futura base commerciale, ma il soggiorno dei francesi è funestato da una prima tragedia. L'imboccatura della baia, molto stretta, è percorsa da correnti pericolose che inghiottono due lance e le vite di 21 uomini. E' dunque con l'animo gravato dal dolore per i compagni morti che La Pérouse decide di ripartire verso sud: il passaggio a nord-ovest, decisamente, è una "pia frottola" di epoche più credulone, e ci vorrebbero anni per esplorare a dovere quelle coste intricate, immerse nelle nebbie e rese pericolose da correnti imprevedibili e dal gioco delle maree. Partite dall'Alaska il 30 luglio, la Boussole e l'Astrolabe a metà settembre attraccano a Monterey, in California, che è stata fondata appena quindici anni prima. Si fermano dieci giorni, visitano la missione francescana (non senza criticare, da veri uomini dei lumi, lo sfruttamento degli indigeni da parte dei frati). E' un'area incredibilmente fertile, e i botanici si danno da fare, anche se la stagione è poco favorevole, con le piante inaridite dalla calura estiva e i semi già caduti. Ammirano invece la ricchezza di fauna, comprese le balene che riempiono letteralmente la baia. E' ora di ripartire alla volta della Cina. Fallito il tentativo di attraccare alle Marianne, occorreranno tre mesi senza neppure uno scalo per raggiungere Macao (3 gennaio 1787). Una lunga traversata che finisce di esasperare i naturalisti, già irritati dal cambio di itinerario e dalla brevità degli scali; senza informare il capitano, guidati da Lamanon, decidono di lasciare la nave e di acquartierarsi a terra. La Pérouse risponde escludendoli dai ricevimenti offerti dai portoghesi e, alle loro proteste, li mette agli arresti per ventiquattro ore. Entrambe le parti inviano lettere di fuoco in Francia; in un dispaccio il comandante si lamenta di quei "diavolacci che mettono alla prova la mia pazienza oltre ogni limite". Ad averne abbastanza è anche Dufresne, che probabilmente non è mai riuscito ad integrarsi con gli altri scienziati più titolati. Chiede il permesso di lasciare la spedizione e di tornare in Francia, imbarcandosi su una delle tante navi che fanno la spola con l'Europa; porterà con sé la corrispondenza e il giornale di bordo della prima parte della spedizione. Prima però si incarica di vendere, con grande profitto, le pellicce acquistate in Alaska. Sarà così il secondo sopravvissuto, e uno dei cronisti della spedizione. Per uno che parte, altri che arrivano. A sostituire uno degli ufficiali morti in Alaska si imbarca sull'Astrolabe un ragazzo di appena vent'anni, Gabriel Jean du Pac de Bellegarde, che scrive a Parigi per sollecitare il suo brevetto d'ufficiale. Altri ufficiali e altri marinai si imbarcheranno a Manila, dove la Boussole e l'Astrolabe arrivano alla fine di febbraio e sostano fino a metà aprile per riparare le vele, calafatare gli scafi, completare le provviste. Quindi ripartono verso nord, per completare l'esplorazione del Pacifico settentrionale con la costa occidentale. Per ora non li seguiremo, rimandando il racconto della seconda parte dell'avventura a un altro post.  Tre generi per tre scienziati: l'energico Lamanon e Lamanonia Dobbiamo infatti occuparci di piante, ovvero dei numerosi generi che sono stati dedicati agli scienziati che hanno preso parte alla spedizione. Cominciamo dagli ottimi abati Receveur e Mongez, entrambi dedicatari di generi botanici non più accettati. A ricordarsi dei due "colleghi", morti al servizio della scienza, fu un altro sacerdote naturalista, il brasiliano José Mariano Vellozo che in Flora flumienensis dedicò loro Receveura e Mongezia, oggi rispettivamente sinonimi di Hypericum e Symplocos. Sempre a Vellozo si deve anche la dedica di Lamanonia al combattivo Robert de Lamanon, il più prestigioso scienziato della spedizione. Geologo e paleontologo in anticipo sulla sua epoca, era così appassionato delle sue ricerche da apparire "folle" a chi lo conosceva poco e mancava di diplomazia, tanto che osò polemizzare con il potentissimo Buffon; amava lo studio sul campo (aveva percorso a piedi molti paesi europei ed era un appassionato alpinista che forse scalò il Monte Bianco qualche anno prima di Saussure) e sicuramente avrà sofferto più di ogni altro la reclusione per mesi e mesi nell'angusto spazio di una nave. Era sicuramente lui il "diavolaccio" che più faceva uscire dai gangheri La Pérouse. Ma seppe mettere a frutto il suo tempo, anticipando due importanti scoperte: la marea barometrica all'equatore e la variazione dell'intensità magnetica con la latitudine. Purtroppo, anche se riuscì a inviarle a Parigi, le sue comunicazioni all'Accademia delle scienze rimasero inedite e le sue scoperte passarono quasi inosservate, non fosse per l'apprezzamento di Humboldt. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Lamanonia è un piccolo genere della famiglia Cunoniaceae che comprende sei specie di piccoli alberi o occasionalmente arbusti diffusi in Argentina settentrionale, Paraguay e Brasile, in ambienti diversi, dalla formazione vegetale del cerrado, alle foreste di araucaria e alle foreste nebulose. Hanno foglie composte palmate con margini dentati e infiorescenze a spiga di fiori privi di petali con calice a stella e numerosissimi stami, da bianco a crema. La specie più notevole è L. ternata, un albero che può superare i venti metri, con chioma arrotondata, di notevole impatto estetico soprattutto al momento della fioritura, tanto che in Brasile viene anche utilizzato nell'arredo urbano. Qualche notizia in più nella scheda.  Dalle sabbie della California alle foreste andine: Collignon e Colignonia Tutt'altra personalità deve essere stata quella di Jean-Nicolas Collignon, sempre attivo e pronto a eseguire modestamente i suoi compiti di botanico-giardiniere. Era anche uno dei più giovani della spedizione (al momento della scomparsa, aveva solo ventisei anni). Una sintesi della sua breve vita nelle biografie. Di lui ci rimangono poche lettere al suo mentore Thouin e l'onore di aver inviato in Francia la prima pianta californiana ad essere descritta dalla scienza. Nei pressi di Monterey raccolse infatti diversi semi che poi spedì a Parigi da Macao; al Jardin des Plantes tra gli altri germinarono quelli di Abronia umbellata, una piccola annuale tappezzante che si accontenta delle zone più aride e sabbiose. I discendenti di quei semi furono studiati da Lamarck che li descrisse nel 1791 (la pubblicazione però è del 1793). Ricordandosi di questo merito piccolo ma significativo, il tedesco Endlicher nel 1837 volle rendere omaggio al nostro solerte giardiniere rinominando Colignonia una specie precedentemente assegnata proprio al genere Abronia. Anche questo genere, appartenente come Abronia alla famiglia Nyctaginaceae, è sudamericano, ma è esclusivamente andino. Le sue sei specie sono erbacee perenni, suffrutici e liane, originarie delle foreste pluviali d'altura e delle foreste nebulose, talvolta anche in aree disturbate. Hanno foglie intere, opposte o verticillate, con lunghi piccioli e fiori raccolti in cime a ombrella; presentano due tipologie di fiori, con perianzio campanulato o a imbuto con tre o cinque lobi. Più che per i fiori, si fanno notare per le grandi brattee bianche. Un profilo di questo genere non molto noto nella scheda.  Una puntata in Australia: Boisseu de La Martinière e Bossiaea Veniamo infine al botanico ufficiale della spedizione, ovvero Boisseau de La Martinière. Anche lui era un protetto di André Thouin e abbastanza competente da essere nominato botanico del re a poco più di vent'anni; inoltre era un medico laureato a Montpellier. Apparteneva a una famiglia abbastanza influente e uno dei suoi fratelli fu deputato all'Assemblea legislativa e alla Convenzione (cosa che avrà qualche importanza per il seguito della nostra storia). La partecipazione di La Martinière alla spedizione fu in un certo senso una seconda scelta; il Jardin des Plantes aveva infatti indicato Louis-Augustin Bosc d'Antiq che tuttavia (per sua fortuna) rifiutò. Abbiamo anche l'impressione che Thouin nutrisse qualche riserva nei suoi confronti, visto che raccomandò che Collignon non gli fosse subordinato. Perdute le sue raccolte botaniche, il suo contributo più importante è affidato ad alcune memorie sulla biologia marina. Anche sulla sua vita una sintesi nella sezione biografie. Diversi botanici hanno voluto ricordarlo, facendo anche un po' di confusione con i suoi due nomi, scritti in vari modi. Ancora a Vellozo si deve Martinieria, oggi sinonimo di Kielmeyera; si deve invece a Guillemin Martiniera, sinonimo di Balbisia. Grazie a Ventenat, lo sfortunato botanico si è comunque aggiudicato il notevole genere australiano Bossiaea, con la seguente motivazione: "Genere consacrato alla memoria di Boisseu-Lamartinière, che accompagnò La Pérouse nel suo viaggio intorno al mondo. La relazione di questo viaggio, pubblicato l'anno V della Repubblica francese, contiene un gran numero di scoperte che testimoniano lo zelo e le conoscenze di questo sapiente naturalista". Bossiaea della famiglia Fabaceae comprende oltre settanta specie, distribuite un po' ovunque in Australia, tranne nelle zone centrali. E' un genere molto variabile, e altrettanto variabili sono anche le singole specie, in base all'habitat e soprattutto al regime delle piogge. Alcune specie hanno un areale ampio, ma molte sono endemiche di aree limitate e si distinguono tra loro soprattutto per le dimensioni, il portamento e le foglie, mentre i fiori sono relativamente omogenei. Dal punto di vista ecologico, sono l'equivalente australiano delle nostre ginestre. Sono arbusti da piccoli a medi, alcuni dei quali per adattarsi al clima arido hanno fusti e rami modificati in cladodi cilindrici o appiattiti; le foglie sono alternate od opposte, in genere piuttosto piccole, talvolta ridotte a scaglia oppure assenti; i fiori solitari o raccolti in infiorescenze poco numerose hanno corolla papilionacea gialla, aranciata o bicolore e sono sottesi da una serie brattee e da una coppia di bratteole. Il frutto è un baccello più o meno compresso. In alcune specie si apre in modo esplosivo, disperdendo i semi lontani dalla pianta madre. Nonostante la loro bellezza, sono raramente coltivate; tra tante specie, tutte interessanti, è difficile scegliere quali citare. Per esemplificare la variabilità del genere, la mia scelta è caduta su B. aquifolium, un grande arbusto o addirittura un alberello con foglie con nove o più punte che ricordano quelle dell'agrifoglio e piccoli fiori che fioriscono in massa, da arancio a giallo e da rosso a bruno; B. procumbens, di portamento prostrato e tappezzante, con minuscole foglie da ellittiche a ovate e fiori giallo oro con una macchia rossa alla gola; B. rhombifolia, un arbusto alto anche due metri, con foglie romboidali glauche e fiori bicolori gialli e aranciati; la sorprendente B. walkeri, priva di foglie e con fusti modificati in cladodi, con fiori rosso vivo. Qualche approfondimento su queste e altre specie nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|






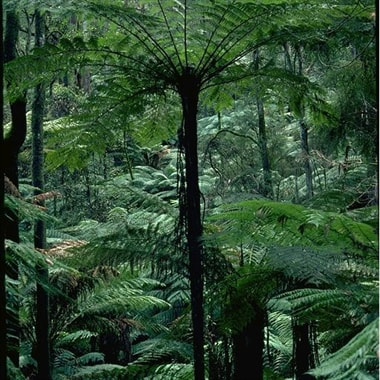



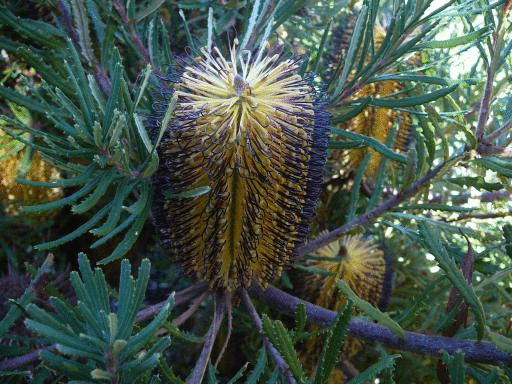




 RSS Feed
RSS Feed