|
Non è raro che generi molto noti e popolari portino il nome di personaggi altrimenti destinati all'oblio. E' senz'altro il caso del genere Deutzia (Hydrangeaceae) che annovera alcuni degli arbusti più coltivati in parchi e giardini, dedicato da Carl Peter Thunberg a Jean (o Joan) Deutz, un maggiorente di Amsterdam che aveva finanziato i suoi viaggi in Sud Africa e in Giappone. Riconoscente, il grande botanico svedese lo ricordò dando il suo nome a una delle piante da lui scoperte in Giappone, Deutzia scabra; e non dimenticò neppure gli altri due sponsor dei suoi viaggi, Jan van de Poll Pietersz. e David ten Hoven, premiati rispettivamente con i generi Pollia (Commelinaceae) e Hovenia (Rhamnaceae).  Come Thunberg ad Amsterdam trovò una cordata di finanziatori Nell'ottobre 1770, trentacinque anni dopo Linneo, un altro giovane svedese bussò alla porta di Johannes Burman; la situazione però era alquanto diversa da entrambe le parti. Burman dirigeva ancora l'orto botanico di Amsterdam, ma era ormai un professore avanti negli anni, con alle spalle una sequela di importanti pubblicazioni che ne facevano il più autorevole botanico d'Olanda. Lo svedese era Carl Peter Thunberg (1743-1828), il migliore allievo di Linneo: era già laureato a Uppsala e stava andando a Parigi per perfezionarsi in chirurgia e medicina; ma soprattutto, non arrivava a mani vuote: a garantire per lui c'era una lettera di raccomandazione del maestro, del cui verbo ora Burman era uno dei più convinti seguaci. Dunque accolse il giovane Thunberg a braccia aperte; e lo stesso fece suo figlio Nicolaas Laurens Burman (1734-1793) che, avendo studiato a Uppsala con Linneo, poteva scambiare con lui anche qualche parola in svedese. Forse anche grazie a questa calorosa accoglienza, Thunberg fu entusiasta della città sull'Amstel: dei suoi canali e delle sue eleganti case patrizie, della pulizia e dell'ordine che regnavano ovunque, dell'atmosfera di libertà e fervore intellettuale. Johannes Burman - qualcuno lo ha definito l'eminenza grigia della botanica olandese - conosceva tutti e non mancò di presentarlo agli appassionati e agli eruditi che facevano parte delle numerose società scientifiche dei Paesi Bassi. Approfittò anche della sua presenza per coinvolgerlo nella classificazione degli esemplari del suo gabinetto di curiosità: Thunberg indentificò diversi minerali, insetti e piante, in particolare Graminaceae e muschi. A Burman fu chiaro che il suo ospite era un naturalista assai preparato e mentre lo aiutava a riordinare grandi generi sudafricani come Ixia, Erica e Aspalathus, gli chiese se gli avrebbe fatto piacere che organizzasse per lui una spedizione in una delle colonie olandesi più ricche di piante: il Suriname o la colonia del Capo. Ovviamente Thunberg - e il suo maestro Linneo con lui - non sognava altro. Mentre Thunberg si trovava a Parigi, dove studiò per un anno accademico, Burman incominciò a muovere tutte le sue pedine per organizzare il viaggio promesso. In primo luogo bisognava coinvolgere la VOC, la potente Compagnia olandese delle Indie. Burman contattò i direttori della Camera di Amsterdam Egbert de Vrij Temminck e Jan van der Poll Pietersz., ottenendo un ingaggio per Thunberg come medico di bordo di una delle navi della Compagnia. Si precisò in tal modo anche la meta: il Sudafrica e, se possibile, il Giappone, la meta più entusiasmante per tutti visto che a causa della politica delle "porte chiuse" la flora giapponese era pressoché sconosciuta e dopo Kaempfer nessun naturalista preparato aveva più visitato il paese. Il viaggio fu approvato dalla VOC e Burman cercò altri sponsor disposti a finanziare le esplorazioni di Thunberg in Sudafrica e in Giappone in cambio di esemplari, semi e piante vive. Del numero facevano parte lui stesso e suo figlio Nicolaas Laurens: di condizione economica molto agiata e imparentati con famiglie ricche e influenti, erano interessati alle raccolte di Thunberg sia come studiosi sia come collezionisti. Un altro cliente era l'orto botanico di Amsterdam, di cui Burman era il praefectus e Temminck uno dei Commissari. Ma a contribuire alle spese furono anche alcuni privati che possedevano grandi giardini ed erano disposti ad allargare i cordoni della borsa in cambio di piante rare: i maggiorenti Jan van der Poll, Jean Deutz e David ten Hoven. I cinque personaggi sono citati nella dedica che apre Flora japonica: "Agli uomini generosissimi e nobilissimi, il signor Vrij Temminck, autorevolissimo console della Repubblica di Amsterdam, commissario dell'Orto botanico; al signor I. van der Poll, autorevolissimo console della Repubblica di Amsterdam; al signor Johan. Deutz, consigliere della Repubblica di Amsterdam e meritevolissimo membro di diverse accademie; al sig. David ten Hoven, consigliere e commissario della Repubblica di Amsterdam; al sig. Nicolaas Laurens Burman, dottore in medicina e professore di botanica, mecenati, sostenitori e patroni sommi!" Come si vede, il Burman ricordato come mecenate è il figlio, non il padre: nel 1784, quando uscì Flora japonica, era già morto, e il figlio gli era succeduto sia come direttore dell'orto botanico sia come professore dell'Ataeneum illustre. Come vedremo tra poco, di Thunberg non era solo un mecenate, ma anche un caro amico. Qualche contributo venne anche dalla Svezia: Thunberg era titolare di una borsa di studio, e inviò duplicati delle sue raccolte, oltre che a Linneo, a suoi amici o allievi Abraham Baeck, il presidente del reale collegio di medicina, Peter Joonas Bergius, medico di successo e fondatore di un orto botanico privato, Lars Montin, medico e membro dell'Accademia reale di Svezia. Ma i finanziamenti più costanti e cospicui vennero dagli sponsor olandesi. Dagli archivi municipali di Amsterdam risulta che l'Hortus botanicus nel novembre 1771 versò a Thunberg una prima somma per le necessità del viaggio; altri versamenti sono registrati per il 1773, il 1774 e il 1776 (quando Thunberg era già a Batavia). Sia dal Sudafrica sia da Batavia Thunberg fece regolari invii in Olanda; i pacchi erano recapitati all'orto botanico di Amsterdam, dove erano aperti alla presenza dei diversi sponsor cui poi veniva distribuito il contenuto. Come Commissario dell'orto botanico, Temminck raccomandava a Thunberg di inviare "solo piante, semi e bulbi di piante veramente rare, e nient'altro". Il resto era per i mecenati privati: "gli invii di uccelli impagliati, insetti ecc. saranno consegnati ai signori Van de Poll, ten Hoven, e ai due professor Burman". Questi ultimi scrissero a Thunberg - che al momento era in Sudafrica - per raccomandare di inviare all'orto botanico piante vive difficili da riprodurre da seme e richiesero espressamente bulbi e Pelargonium (ai quali Burman figlio stava dedicando una monografia). Neppure gli exsiccata interessavano all'Hortus, tanto che il suo erbario giapponese gli fu restituito. Invece i Commissari erano gelosissimi di semi, bulbi e piante vive, tanto che nel 1780 Nicolaas Laurens scrisse a Thunberg: "Il pacchetto con le piante giapponesi è stato consegnato quest'autunno all'Hortus; se ti rimangono dei duplicati delle piante di Ceylon, te ne sarò molto grato, perché dall'Hortus non ho avuto nulla, il che molto mi spiace". Ovviamente gli invii, soprattutto di piante vive, erano difficili, e molti esemplari non sopravvissero al viaggio. Tra quelle che furono sicuramente introdotte da Thunberg attraverso l'Hortus di Amsterdam Hydrangea macrophylla, mentre le prime gardenie fiorirono nel giardino di Deutz. Thunberg inviò piante vive anche ad André Thouin del Jardin des plantes, ma morirono tutte per il gelo nell'inverno 1789-1790.  Gli sponsor olandesi di Thunberg Dopo sette anni di viaggi, Thunberg ritornò in Olanda nell'ottobre 1778. Al suo arrivo a Texel ricevette una affettuosa lettera di benvenuto da Nicolaas Laurens Burman che lo invitò a casa sua "dove vivremo come fratelli e trascorreremo l'inverno nel modo più piacevole possibile". Tra quelle piacevoli occupazioni ci furono anche le visite agli amici e agli sponsor, nei cui giardini Thunberg fu compiaciuto di vedere in buona salute le piante da lui stesso introdotte. E' ora anche per noi di conoscerli meglio. Iniziamo da Temminck, che però tenne i rapporti con Thunberg non a titolo personale, ma come Commissario dell'Hortus botanicus. E infatti, anche se compare in prima posizione nella dedica di Flora japonica, è il solo del gruppo a non essere stato ricordato da un genere botanico. Del resto, era molto esigente e i suoi rapporti con Thunberg non furono idilliaci, come farebbe pensare una lettera in cui lamenta le note insufficienti dei suoi esemplari. Appartenente come gli altri a una famiglia magnatizia, era un uomo politico che rivestì molti incarichi importanti; era curatore dell'Athaeneum illustre e dal 1766 fu uno dei due Commissari dell'Hortus botanicus, che era gestito dalla città di Amsterdam. Morì senza figli; appartiene alla sua famiglia ma non fu un suo discendente l'importante zoologo Conraad Jacob Temminck, dedicatario del genere Temminckia de Vriese, oggi sinonimo di Scaevola L. Passiamo ora ai tre sponsor privati. Jan van de Poll Pietersz. (1726-1781) era un ricco mercante, appartenente a una famiglia attivamente impegnata nella amministrazione della città di Amsterdam. Anch'egli rivestì vari incarichi pubblici e nel 1779 divenne borgomastro. Come abbiamo visto, era uno dei direttori della Camera di Amsterdam della VOC e dal 1779 fu direttore della società del Suriname. A Velsen possedeva una tenuta di campagna chiamata Velseroog e, come Deutz, era membro della Società per l'avanzamento dell'agricoltura (De Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw). Allo stesso ambiente sociale apparteneva David ten Hoven (1724-1787), che del resto era genero di Temminck e cugino della seconda moglie di Poll, Jacoba Margaretha van Hoven. Anch'egli era un mercante e un membro del senato di Amsterdam. Mentre Poll desiderava da Thunberg soprattutto arbusti da fiore per il parco della sua tenuta, gli intenti di Hoven erano più pratici: gli servivano alberi per proteggere la sua tenuta di Woestduin dall'avanzata delle dune di Heemstede-Volenzang. Qui grazie ai semi ottenuti da Thunberg piantò molti Pinus, Abies, Cupressus, Cedrus e Juniperus. Al rientro di Thunberg in Olanda, gli versò come compenso 128 ducati d'oro. Certamente i soldi non gli mancavano: qualche anno prima aveva pagato 3050 fiorini al progettista di giardini Adriaan Snoek per il progetto di una "ciotola" nella duna, quella appunto dove sarebbero stati piantati gli alberi di Thunberg. Versò inoltre 3500 fiorini a un certo Hendrik Horsman per la fornitura di materiale vegetale e la costruzione di un viale. Dato che il tracciato di quest'ultimo sostituiva vecchi percorsi attraverso le dune, versò anche consistenti somme come compenso ai poveri dei villaggi di Vogelenzang e Overveen. Il più interessante e noto del gruppo è però Jean (anche Joan o Johannes) Deutz (1743-1784); molto più giovane dei compagni di cordata, anch'egli apparteneva a una famiglia molto influente che si era arricchita con il commercio delle spezie, del tabacco e del vino e aveva raggiunto l'apice verso la metà del XVII secolo quando si era imparentata con il Grande pensionario de Witt e aveva ottenuto il monopolio della vendita del mercurio austriaco in Europa. Il nostro Jean era un avvocato e anche lui sedeva nel consiglio di Amsterdam e fu direttore della Società del Suriname; aveva rapporti di affari e vicinato con gli altri (come quella di Poll, la sua tenuta di campagna Roos-en-Beek, si trovava a Velsen), ma i suoi interessi per la botanica erano più ampi, tanto che chiese a Thunberg di procurargli "tutti i semi e le piante essiccate possibili". Si considerava un botanico dilettante, corrispondeva con il governatore della Colonia del Capo Hendrik Swellengrebel e con Joseph Banks ed era membro di varie società scientifiche. A questo proposito va sottolineato che nel Settecento in Olanda ne esistevano molte, e i loro membri, più che professionisti, erano colti dilettanti come appunto Deutz. Come i due Burman e il botanico Maarten Houttuyn, che avrebbe pubblicato alcune delle piante inviate da Thunberg, faceva parte della Società olandese delle scienze (De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen), all'epoca un ristretto club di gentiluomini che si riuniva nell'aula municipale di Harleem per discutere di argomenti scientifici e promuovere lo studio delle scienze e delle arti. Deutz ne divenne direttore nel 1778 e nel 1781, su sua richiesta, vi venne ammesso anche Thunberg. Subito dopo nel bollettino della società venne pubblicato un suo articolo con i dati metereologici raccolti in Giappone e nel 1782, sempre su istanza di Deutz, un suo articolo sulle palme (nella traduzione olandese di Houttuyn) che contiene la prima descrizione valida di Cycas revoluta. Houttuyn si lamentò della fatica che gli era costata decifrare la minutissima grafia di Thunberg, ma ne fu ricompensato con la dedica del genere Houttuynia, di cui parleremo un'altra volta. Come abbiamo già visto parlando di Poll, Deutz era anche membro della Società per l'avanzamento dell'agricoltura, anch'essa all'epoca un club esclusivo con meno di trenta membri; sempre nel 1781 e ancora su sua proposta vi fu ammesso anche Thunberg come membro onorario.  Due dediche doverose: Pollia e Hovenia Nel suo Flora japonica, pubblicato nel 1784, oltre a porre l'opera sotto l'egida di tutti i suoi sponsor olandesi, Thunberg riservò a tre di loro anche la dedica di un genere. Abbiamo già visto per quali ragioni Temminck fu escluso; quanto ai Burman, ci aveva già pensato Linneo con il genere Burmannia. Per van der Poll, ten Hoven e Deutz il botanico svedese scelse tre piante giapponesi, all'epoca le uniche specie note dei rispettivi generi Pollia, Hovenia e Deutzia. La dedica a Poll è la più laconica, praticamente l'assolvimento di un dovere: "Ho dato il nome in onore del sommo patrono J. van der Poll, meritevolissimo console di Amsterdam". Per lui, che come sappiano era soprattutto interessato ad arbusti e piante da fiore per il suo giardino, Thunberg scelse una bella erbacea perenne nativa del Giappone (ma anche della Cina e del Sud-est asiatico), Pollia japonica. Oggi a questo genere della famiglia Commelinaceae sono attribuite una ventina di specie distribuite principalmente nelle zone tropicali del vecchio mondo, con un solo rappresentante nelle Americhe e qualche propaggine nell'Australia settentrionale. Di particolare interesse l'africana Pollia condensata, i cui frutti sono unici nel mondo vegetale: simili a biglie metallizzate blu profondo dai riflessi cangianti, nello strato esterno della buccia presentano nanocellule disposte ad elica in grado di catturare e riflettere la luce; nel buio delle foreste in cui vivono, è un richiamo irresistibile per gli animali che se ne ciberanno e ne disperderanno i semi. Appena più ampia, ma sulla stessa falsariga di quella di van der Poll, la dedica a ten Hoven: "Ho dato il nome in eterna memoria dell'ottimo mecenate David ten Hoven, Consigliere e commissario della città di Amsterdam". Coerentemente ai suoi interessi, Thunberg gli dedicò un albero Hovenia dulcis: una scelta azzeccatissima se consideriamo non solo la bellezza di questa specie, ma anche la sua grande rusticità, che forse l'avrebbe resa adatta anche al consolidamento delle dune del Mare del Nord. In Giappone egli probabilmente aveva potuto apprezzarne anche i frutti, in realtà i piccioli fiorali ingrossati, che con la loro dolcezza vengono usati nelle insalate di frutta per attenuarne l'acidità. Oggi è la più nota e diffusa delle quattro specie del genere Hovenia (famiglia Rhamnaceae), esclusivamente presente nell'Asia orientale. 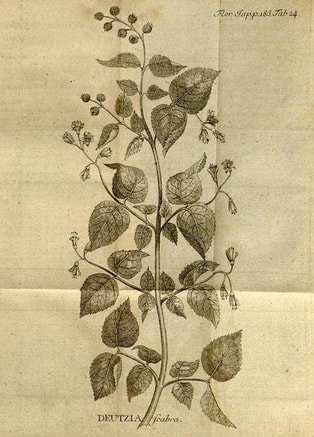 Una Deutzia per un patrono speciale Per Thunberg, ricordare con un genere botanico i suoi sponsor van der Poll e ten Hoven era un debito d'onore che in fondo sbrigò con una frase di circostanza; ma la riconoscenza che doveva a Deutz, che dopo il suo ritorno in Olanda si era dato da fare per lanciare la sua carriera scientifica, era assai maggiore. Per notarlo, basta leggere la dedica: "Questo albero vogliamo, dobbiamo consacrare al cultore di scienze naturali e massimo e benevolentissimo patrono dei suoi cultori J. Deutz, consigliere della città di Amsterdam, che a lungo è stato assai meritevole membro e degnissimo presidente di diverse società scientifiche". Vogliamo, dobbiamo: è un dovere che corrisponde al più profondo e spontaneo moto del cuore. Dunque per Deutz scelse una pianta di cui non gli sfuggiva la bellezza: Deutzia scabra, coltivata da secoli nei giardini giapponesi per le abbondanti fioriture candide e profumate. Non poteva sapere che in tal modo avrebbe eternato il nome di Deutz come patrono di un genere cui appartengono alcuni dei più diffusi arbusti da giardino. All'unica specie a lui nota, se ne sono via via aggiunte altre e oggi Deutzia (famiglia Hydrangeacae) è un grande genere con oltre settanta specie; ha distribuzione disgiunta: da una parte il Giappone e l'Asia orientale, dall'altra l'America centrale. Il loro successo come piante da giardino è relativamente recente: è stato notato che due terzi delle specie sono state scoperte solo nel Novecento. La prima ad essere nota in Europa fu proprio D. scabra; era già stata segnalata da Kaempfer e fu decritta appunto da Thunberg; nel 1812 l'ispettore della Compagnia delle India John Reeves - lo stesso che portò la prima Wisteria chinensis in Europa - inviò in Inghilterra questa specie (o più probabilmente la cinese D. crenata), che però fu coltivata in serra e non prosperò. Per la vera introduzione bisogna attendere gli anni '30 e Siebold che riportò dal Giappone D. scabra, D. crenata e D. gracilis. Verso il 1860, Robert Fortune raccolse in Cina una forma doppia di D. crenata (solitamente confusa con D. scabra, che però è endemica del Giappone). Intorno al 1880, molte nuove introduzioni dalla Cina si devono ai missionari francesi che, per integrare le magre entrate delle missioni, inviavano i loro semi alla ditta Vilmorin; il raccoglitore più prolifico fu padre Delavay che introdusse tra le altre D. purpurascens. Questi nuovi arrivi incoraggiarono gli esperimenti del grande ibridatore Lemoine, che intorno al 1891 iniziò un serrato programma di ibridazioni destinato a cambiare la storia della Deutzia: ancora oggi buona parte degli ibridi orticoli che fioriscono nei nostri giardini continuano ad essere quelli creati da lui tra il 1891 e il 1911 oppure dai suoi discendenti tra le due guerre. La moda però stava cambiando, e dopo la seconda guerra mondiale le deuzie incominciarono ad essere sentite come sorpassate e demodé; le si accusava in particolare di presentare pochi motivi di interesse terminata la fioritura. La situazione è di nuovo cambiata nel tardo Novecento, con l'introduzione di nuove specie e la selezione di cultivar più compatte e più adatte ai nostri piccoli giardini. Ne fa senz'altro parte la varietà oggi più coltivata, la nana Deutzia gracilis 'Nikko'. Per una storia più dettagliata degli ibridi e una selezione di specie si rinvia alla scheda.
0 Comments
Nel 1768, come medico della missione luterana e direttore dell'ospedale, arriva a Tranquebar, minuscola colonia danese sulla costa del Coromandel, l'allievo di Linneo Johann Gerhard König. Non lascerà l'India fino alla morte. Il suo arrivo agisce come un lievito che segna l'inizio dello studio scientifico della flora indiana; è un grande raccoglitore, ma soprattutto trasmette il suo entusiasmo ad amici e colleghi, creando forse la prima società scientifica del paese e incoraggiando le ricerche di altri naturalisti, tra cui il "padre della botanica indiana" William Roxburgh. Prima di tutto questo, il maestro Linneo lo aveva già premiato con il genere Koenigia, creato sulla base di una pianta che il suo pupillo aveva raccolto in Islanda. Un forte danese in India, là dove cantano le onde Meno noti di quelli di potenze maggiori come il Portogallo, la Francia o la Gran Bretagna, per circa duecento anni (1620-1848) in India ci furono anche alcuni insediamenti o empori danesi. Erano territori minuscoli, e dal punto di vista economico, con l'eccezione di qualche momento felice, non furono un successo. Ma sul piano culturale ebbero un ruolo sorprendente: in una di queste colonie operò la prima missione protestante della storia, nacque la prima tipografia e vennero stampati i primi libri stampati in una lingua indiana, furono create la prima scuola aperta anche alle bambine, e (forse) la prima società scientifica dell'Asia. Il luogo dove fiorirono quelle primizie è Tranquebar (oggi Tharangambadi, un nome poetico che significa "il luogo delle onde che cantano") a circa 300 km a sud di Madras sulla costa del Coromandel, nell'attuale stato indiano di Tamil Nadu, il primo e più importante avamposto danese in India. Nel 1616, l'ambizioso re di Danimarca Cristiano IV, sull'esempio della Compagnia olandese delle Indie orientali, sponsorizzò la nascita della Ostindisk Kompagni (Compagnia danese delle Indie orientali). Nella speranza di allearsi con il sovrano singalese contro i portoghesi, ottenendo in cambio una base a Ceylon, nel 1618 inviò in India una piccola flotta; tuttavia la trattativa diplomatica fallì e i danesi ripiegarono su Tranquebar, dove una delle loro navi aveva casualmente fatto naufragio. In cambio di un tributo annuo, il re di Thanjavur Raghunatha Nayak concesse loro una fascia costiera lunga otto km e profonda quattro; a partire dal 1620, i danesi vi crearono piantagioni e un emporio, protetti da un forte, Fort Daneborg, che divenne anche la sede ufficiale del governatore dell'India danese. Intanto in Europa era scoppiata la guerra dei Trent'anni, il cui esito disastroso cancellò i sogni di gloria di Cristiano IV e travolse anche la Ostindisk Kompagni. I viaggi tra India e Danimarca si interruppero, la compagnia fu sciolta e la piccola colonia rimase abbandonata a se stessa per circa trent'anni. Solo nel 1669 una fregata danese gettò di nuovo l'ancora a Tranquebar. Tornò in patria con un carico di pepe e altre spezie così promettente che venne deciso di rifondare la Compagnia, risorta dalle proprie ceneri nel 1670. Nonostante la concorrenza olandese che le impedì di allargare i suoi traffici più a est, la rinata compagnia riuscì a ritagliarsi uno spazio nel commercio dei tessuti e delle spezie indiane; la neutralità della Danimarca le permise di approfittare delle rivalità tra le potenze maggiori, traendo forti guadagni soprattutto dal nolo delle proprie navi "neutrali" ai mercanti delle potenze belligeranti. A questo effimero momento di prosperità mise fine la Grande guerra del Nord (1700-1721) che portò al fallimento anche la seconda Ostindisk Kompagni, sciolta nel 1729. Dal punto di vista religioso ed etnico, la colonia danese era un mosaico di fedi ed etnie. A inizio Settecento, quando il territorio danese si era allargato ad altri villaggi, vi vivevano circa 15.000 mila persone, musulmani, indù e cattolici indiani, convertiti dalla vigorosa attività missionaria dei gesuiti. Gli europei (soldati, funzionari, mercanti) erano una minoranza, e i danesi, circa 200 persone, una minoranza nella minoranza. La situazione preoccupava il re di Danimarca Federico IV, che decise di inviarvi missionari evangelici; non trovando nessuno disponibile in Danimarca, si rivolse all'università di Halle, uno dei centri propulsori del pietismo. Il pietismo di Halle era caratterizzato da un accentuato riformismo, che per certi aspetti lo avvicinava all'illuminismo e si traduceva in un forte impegno in campo pedagogico, sociale e culturale; l'energico caposcuola August Hermann Francke vi aveva fondato diverse scuole, un orfanatrofio, il più antico istituto biblico, una tipografia, una legatoria, una biblioteca, una farmacia e un piccolo museo di scienze naturali. La missione indiana, la prima in assoluto di una chiesa protestante, offriva ai pietisti di Halle un nuovo, inedito campo d'azione. Francke la affidò a due dei suoi migliori allievi, Bartholomäus Ziegenbalg e Heinrich Plütschau, che portarono in India la fede fervente, l'attivismo sociale, l'impegno pedagogico della scuola di Halle, destando l'ostilità non solo dei gesuiti, ma anche delle autorità locali e della Compagnia inglese delle Indie, che fece addirittura arrestare Ziegenbalg con l'accusa di tubare l'ordine pubblico. Egli approfittò della detenzione per studiare il tamil e incominciare a tradurre la Bibbia. Dopo la liberazione, oltre a due chiese e altre strutture funzionali alla missione, creò una cartiera, una tipografia (la prima dell'intero subcontinente a stampare testi in una lingua locale), una scuola aperta anche alle ragazze (anche questa una assoluta novità), un seminario per il futuro clero indiano. I missionari di Halle erano in costante contatto con la madrepatria, cui inviavano lettere, diari, contributi scientifici su vari aspetti della cultura indiana. A partire dal 1720, la tipografia della Fondazione Francke incominciò a pubblicarli in una rivista nota come Hallesche Berichte, che presto ebbe diffusione europea, influenzando a lungo l'immagine dell'India in Europa. Tra gli argomenti che più interessavano il pubblico colto c'era anche la medicina tradizionale indiana, il cui valore era stato riconosciuto dagli europei fin dai tempi di Garcia de Orta; d'altra parte, si riteneva che quell'antico patrimonio dei conoscenze fosse ormai degenerato e ridotto a un insieme di pratiche superstiziose. Urgeva inviare in India un medico con una buona preparazione in chimica e in botanica farmaceutica per studiare dal vivo le piante medicinali, tanto più che l'assistenza sanitaria a Tranquebar era inadeguata e non riusciva a far fronte alle epidemie che decimavano gli europei. Mentre gli indigeni disponevano di un certo numero di medici ayurvedici, a occuparsi della loro salute c'erano solo il chirurgo e l'aiuto chirurgo della guarnigione militare, che gestivano anche l'ospedale con l'aiuto di assistenti indiani. Nel 1732 la Fondazione Francke inviò dunque a Tranquebar Samuel Benjamin Cnoll (1705–67), un medico laureato ad Halle, che dagli anni '40 diresse anche l'ospedale; sappiamo che creò un piccolo orto botanico e scrisse un articolo sulla preparazione indiana della borace pubblicato sulla rivista danese Acta Medica Hafniensis. Alla sua morte, ne prese il posto il protagonista di questa storia, Johann Gerhard König (1728–85). Ma prima di concentrarci su di lui, due parole sulle ulteriori vicende dell'India danese. Dopo le pesanti perdite subite nella Grande guerra del Nord, la Danimarca tornò alla politica di neutralità che non avrebbe più abbandonato fino alle guerre napoleoniche. Nel 1730 venne fondata una terza compagnia, la Compagnia asiatica (Asiatisk Kompagni) che, ottenuto dal re il monopolio dei traffici asiatici per quarant'anni, aprì una nuova via commerciale con la Cina e rilanciò il commercio indiano. Anche se i maggiori profitti vennero dalla rotta cinese, ci fu una certa espansione anche nell'area indiana, con la fondazione di altri empori, il più importante dei quali fu Serampore in Bengala, fondato nel 1755. Tra il 1754 e il 1756, la compagnia cercò anche di creare un avamposto nelle isole Nicobare, che presto dovette essere abbandonato a causa della malaria e di altre malattie che decimarono i coloni. Per evangelizzare le Nicobare, la corona danese decise l'invio di una seconda missione evangelica, affidata all'Unione dei fratelli boemi, anche noti come Fratelli moravi. Il re di Danimarca assicurò la più ampia libertà religiosa e l'agguerrita congregazione lanciò immediatamente una sottoscrizione tra i propri membri per autofinanziarsi. Un primo gruppo di quattordici missionari, tutti giovani e scapoli, fu inviato Tranquebar nel 1760; ne facevano parte un pastore, due studenti di teologia e undici tra artigiani e mercanti. L'anno successivo furono raggiunti da alcune famiglie, con donne e bambini. Anche se l'evangelizzazione delle Nicobare fallì prima di cominciare, a Tranquebar i Fratelli moravi riuscirono ad affermarsi rapidamente, suscitando non poche gelosie tra i confratelli luterani. 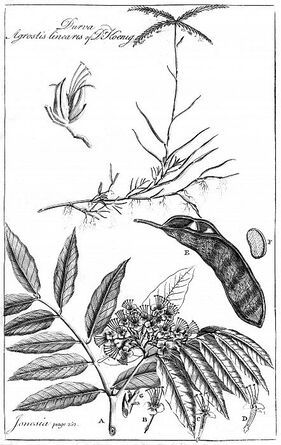 In missione per conto di Linneo A gettare un ponte tra i due gruppi missionari rivali fu proprio il nostro Johann Gerhard König. E' ora che si prenda la scena. König era un tedesco del Baltico, nato a Kreutzburg nella Livonia polacca. Incominciò la sua formazione come apprendista farmacista a Riga. Dopo aver lavorato come farmacista in diverse località danesi e svedesi, nel 1757 andò a Uppsala a studiare scienze naturali con Linneo, con il quale poi rimase in contatto. Nel 1759 si trasferì in Danimarca, dove lavorò al Frederikshospital e studiò medicina all'Università di Copenhagen con un altro discepolo di Linneo, Christen Friis Rottbøll. Come abile raccoglitore, fu ingaggiato da Oeder per Flora Danica; nel 1764 fece raccolte nell'isola di Bornholm e tra il 1766 e il 1767 in Islanda. Fu proprio la sua fedeltà a Linneo, al quale aveva inviato un certo numero di esemplari, a metterlo in urto con Oeder. Su consiglio di Rottbøll, accettò il posto di medico della missione luterana di Tranquebar, vacante per la morte di Cnoll. Non era ancora laureato, ma avrebbe potuto continuare gli studi e scrivere la sua tesi anche in India. Fu così che nel 1768 egli arrivò a Tranquebar; anche lui si sentiva un missionario, ma del verbo linneano, che fu il primo a far conoscere in India. Era un avido raccoglitore, un ottimo sistematico, e soprattutto una personalità carismatica che seppe contagiare con il suo entusiasmo amici e colleghi. Insieme ad alcuni pastori della missione luterana e qualche membro della comunità morava creò un gruppo informale il cui scopo principale era promuovere lo studio scientifico della botanica. Alcuni studiosi lo considerano la prima società scientifica indiana e gli attribuiscono anche un nome, United Brethren, "Fratelli uniti" o "Unione dei fratelli"; altri fanno notare che era la denominazione usuale della chiesa morava ed è dubbio che i "fratelli botanici" l'abbiamo mai applicata a se stessi. Ma certo il gruppo esisteva; dapprima limitato a Tranquebar, via via ne superò i confini e si allargò a medici, funzionari, naturalisti che operavano nell'India meridionale, per lo più al servizio della Compagnia inglese delle Indie. I membri del gruppo raccoglievano e scambiavano piante, le identificavano, ne discutevano "fraternamente" la classificazione; quindi cominciarono a inviare gli esemplari, identificati o meno, a botanici europei. Come allievo di Linneo che aveva studiato e lavorato in Danimarca, König era in contatto in Svezia con Retzius e in Danimarca con il maestro Rottbøll, Fabricius e Martin Vahl. Attraverso il condiscepolo Solander, incominciò a corrispondere con Banks, che a sua volta lo mise in contatto con i naturalisti al servizio della Compagnia delle Indie, il più noto dei quali, William Roxburgh, divenne un membro attivo del gruppo e suo amico personale. A loro volta, i missionari luterani coinvolti da König fecero conoscere le loro ricerche a Halle; attraverso Johann Reinhold Forster, che insegnava storia naturale in quella università, le relazioni si allargarono ad altri atenei tedeschi, con il risultato che il lavoro dei "botanici di Tranquebar" divenne ben noto in Europa e numerose piante indiane da loro segnalate per la prima volta furono pubblicate da personaggi come Retzius, Vahl, Willdenow o James Edward Smith. König lavorò a Tranquebar fino al 1773, quando ottenne la laurea in medicina in absentia all'Università di Copenhagen, sottoponendo una tesi in cui discuteva l'efficacia dei rimedi indigeni per curare le malattie endemiche della regione (De remediorum indigenorum ad morbes cuius regioni endemicos expugnandos efficacia). Insoddisfatto del magro salario che limitava di molto le sue possibilità di viaggiare, "più desideroso di fama che di fortuna", come confidò all'amico Patrick Russell, passò al servizio del nababbo di Arcot come medico personale. Poté così esplorare le colline a nord di Madras e anche visitare l'isola di Ceylon. Frequenti divennero anche i soggiorni a Madras, dove condivise le sue conoscenze con i medici inglesi, primo fra tutti William Roxburgh che all'epoca lavorava come assistente chirurgo al Madras Medical Service. Grazie agli amici inglesi nel 1778 fu assunto dalla Compagnia inglese delle Indie, di cui fu il primo naturalista ufficiale. Nel 1779 la compagnia lo inviò in Siam e negli stretti di Malacca alla ricerca di piante di interesse economico da introdurre nell'India meridionale. L'anno successivo rientrò a Madras; erborizzava spesso con Roxburgh, che all'epoca era più noto come disegnatore che come botanico, trasmettendogli i suoi metodi e rafforzando la sua vocazione botanica. Nel 1785, mentre stava recandosi a Vizagaptam per incontrare il fratello di Patrick Russell Claud, si ammalò di gastroenterite e, nonostante le cure dell'amico Roxburgh, ne morì, lasciando i suoi erbari e le sue carte in eredità a Joseph Banks. König pubblicò poco: il primo articolo scientifico sulle termiti, uscito nel 1779 su una rivista tedesca, quindi due contributi sulle piante dell'India sudorientale pubblicati da Retzius in Observationes botanicae rispettivamente nel 1783 e nel 1791. Fu invece un grande raccoglitore; suoi esemplari furono pubblicati da Linneo in Mantissa plantarum altera (1771) e dal figlio di Linneo in Supplementum plantarum (1781), fornirono le basi per la descrizione delle Cyperaceae pubblicate da Rottbøll in Descriptiones plantarum rariorum e Descriptiones et iconum rariores (1772-73) e in parte per Plants of the Coast of Coromandel di Roxburgh.  Un genere artico e montano Quando König arrivò in India, aveva già ottenuto da Linneo il "massimo riconoscimento per un botanico", ovvero la dedica di un genere. In Mantissa Plantarum Prima (1767) il suo maestro aveva creato in suo onore Koenigia (famiglia Polygonaceae), sulla base di una delle piante da lui raccolte in Islanda, K. islandica; è una minuscola erbacea, tipica delle tundre artiche e delle praterie alpine. Non solo è una delle piante da fiore più piccole del mondo (non supera i 4 cm d'altezza), ma anche una delle pochissime annuali di quelle flore in cui la bella stagione è troppo breve per garantire la maturazione dei semi. A lungo rimase l'unica specie riconosciuta, finché, rispettivamente nel 1825 e nel 1881 si aggiunsero due specie himalayane, K. nepalensis e K. pilosa. Emendato da Hedberg sulla base delle caratteristiche del polline, verso la fine del '900 il genere giunse a comprendere cinque o sei specie, tutte alpine o artiche. Finché, nel 2015, è arrivata una rivoluzione tassonomica. Sulla base dei dati molecolari, il genere è stato ridefinito, includendovi Aconogonon. Oggi dunque comprende una trentina di specie dell'emisfero boreale, con centro di diversità nell'Himalaya. Sono erbacee perenni o annuali, molto varie per dimensioni ed aspetto, con radici a fittone e piccoli fiori dai colori chiari (bianchi, crema, rosa) raccolti in cime ascellari o terminali che in alcune specie formano vistose pannocchie piramidali. Tra di esse c'è anche una bella specie abbastanza comune nei pascoli montani delle Alpi occidentali e centrali e degli Appennini settentrionali. La conosco da sempre, ma con il nome che le aveva dato Allioni, Polygonum alpinum, cui corrisponde anche il nome comune poligono alpino. Come molte piante di questa famiglia dalle vicende tassonomiche travagliate, ha cambiato nome molte volte, e adesso si chiama ufficialmente Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal. Anche se varie specie sono aggressive infestanti, alcune sono apprezzate per il loro valore ornamentale. La più coltivata è forse K. x fennica, un ibrido naturale tra K. alpina e K. weyrichii, un'imponente perenne con fioriture spettacolare. Qualche informazione in più su questa e altre specie nella scheda. A volte, per entrare nella storia - se non altro in quella della botanica - è sufficiente raccogliere un fiore in un giardino. Almeno fu quello che capitò a Clas Alströmer, rampollo di uno dei più ricchi affaristi svedesi, allievo di Linneo, alla prima tappa del suo grand tour nell'Europa mediterranea, quando la magnifica Alstroemeria, stanca di essere scambiata per un'Hemerocallis o un giglio, si fece notare proprio nel giardino del console di Svezia a Cadice. A stretto giro di posta, l'annunciò arrivò a Uppsala, seguito dai semi, guadagnando al fortunato viaggiatore una delle dediche celebrative più veloci della storia. Mentre i suoi compagni di studio affrontavano le onde e le malattie tropicali, fu semplicemente facendo un viaggio di studio in Europa che Alströmer conquistò il fiore più bello tra quelli dedicati da Linneo ai suoi apostoli. D'altra parte, i suoi meriti scientifici non sono irrilevanti: fu un importante collezionista, e soprattutto un mecenate che finanziò i viaggi di molti condiscepoli, non ultimo Carl von Linné il giovane. Grazie a lui, almeno una parte dell'erbario linneano rimase in Svezia, invece di prendere la strada per Londra. Non ultimo merito, fu il protettore di Anders Dahl, il dedicatario del genere Dahlia.  Un grand tour scientifico ricco di incontri A Uppsala, tra gli studenti che, tra il 1757 e il 1760, seguono i corsi di Linneo ce n'è uno con origini familiari molto diverse dai suoi compagni, in buona parte figli di poveri pastori di provincia, che nello studio cercano un'occasione di affermazione sociale. E' Cles Alströmer, uno dei figli minori di Jonas, pioniere della rivoluzione agraria e industriale in Svezia, promotore della diffusione della coltivazione della patata, proprietario di terreni, allevamenti e miniere, ma anche uno dei fondatori dell'Accademia delle scienze svedese. A Uppsala Cles studia agronomia, chimica e mineralogia con Wallerius, botanica con Linneo. E' compagno di studi di Solander, di cui è amico e al tempo stesso rivale. Nel 1760 parte per un grand tour che, per mete e interessi, si differenzia da quello d'obbligo per i rampolli dell'aristocrazia e della ricca borghesia europee; a richiamarlo più che l'arte sono il commercio e i progressi tecnici e scientifici. Nel corso di un triennio, nei vari paesi che visiterà, soprattutto grazie alla sua aura di allievo di Linneo, avrà libero accesso alle maggiori istituzioni scientifiche e conoscerà di persona i maggiori botanici del tempo, di cui ci ha lasciato brevi ritratti penetranti e privi di peli sulla lingua. Benché molte delle sue carte siano andate perdute in un incendio, a informarci su molti particolari del viaggio è il corposo carteggio con il maestro, cui spedì anche una cospicua collezione di piante e animali (oltre 2000 esemplari). La prima tappa fu la Spagna, dove per incarico del padre avrebbe dovuto carpire i segreti dell'allevamento delle pecore merinos, la cui lana era di gran lunga superiore a quella dei capi svedesi; Linneo a sua volta gli affidò la delicata missione di recuperare le collezioni e gli effetti personali di Löfling, morto tragicamente l'anno prima durante la spedizione nell'Orinoco. Partito in nave da Göteborg alla fine di febbraio 1760, Alströmer giunse a Cadice alla fine di aprile; qui fu ospite di Jacob Martin Bellman, il console svedese (nel porto iberico facevano tappa le navi della Compagnia svedese delle Indie orientali); nel giardino del consolato lo colpì una bellissima pianta con due fiori mai visti, nata da semi giunti dal Perù; di questa peregrina de Lima o azucena (ovvero "giglio") de Lima riuscì presto a procurarsi moltissimi semi, che inviò prontamente a Linneo. In Spagna sarebbe rimasto circa quindici mesi, alternando i soggiorni a Madrid e Cadice con puntate a Gibilterra, Siviglia, Granada e in Andalusia. Sorpreso dal maltempo mentre visitava i monti della Castiglia (forse la Sierra morena) si ammalò gravemente; più tardi egli avrebbe fatto risalire a questo incidente l'origine della grave malattia che lo colpì nella maturità. A Madrid frequentò i botanici del Real Jardin Botanico, esprimendo un giudizio molto positivo sull'ormai anziano Minuart e parecchie riserve sulla Flora española o historia de las plantas que se crían en España dell'antilinneano Quer y Martinez, uscita proprio quell'anno. A causa della malattia e poi della morte di José Ortega, fallì l'intento di recuperare gli effetti di Löfling (con una punta di malignità, Alströmer ricorda che i botanici spagnoli consideravano provvidenziale la morte precoce di quel giovane eretico, di cui si diceva si fosse convertito al cattolicesimo in articulo mortis). Ottimo fu invece il rapporto con due vecchi compagni di Löfling: l'astronomo francese Louis Godin, che aveva viaggiato con lui in Portogallo, e il medico Miguel Barnades, che lo aveva guidato alla scoperta della flora madrilena; importante fu poi l'incontro a Cadice con un giovane José Celestino Mutis, sul punto di partire per l'America. Grazie alla mediazione di Alströmer, Mutis entrò così in contatto con Linneo, di cui sarebbe divenuto uno dei principali informatori sulla flora sudamericana. Mentre si trovava in Spagna, Alstroemer ricevette la notizia della morte del padre; dopo aver pensato per un attimo di rientrare in patria, decise invece di continuare il viaggio. Alla fine del 1761 si spostò a Montepellier dove, grazie alle lettere di raccomandazione fornite dal maestro, fu ricevuto da François Boissier de La Croix de Sauvages e Antoine Gouan (che non lo impressionarono né poco né punto). Passò quasi subito in Italia (purtroppo molti dettagli ci sfuggono, a causa della perdita di molte lettere), dove sicuramente fu a Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bologna, Ferrara, Venezia, Padova, Verona, Mantova, Milano e Torino. Ovunque visitò orti botanici, gabinetti scientifici, collezioni e ambienti naturali - dalle pendici del Vesuvio dove raccolse pietre vulcaniche al monte Baldo dove sotto la guida del farmacista Giulio Cesare Moreni fece incetta di semi. Ovunque incontrò botanici a collezionisti, agli occhi dei quali divenne un vero e proprio ambasciatore di Linneo: a Firenze, dove fu ammesso alla Società botanica, Giovanni Targioni Tozzetti e Antonio Durazzini; a Pisa Giovanni Lorenzo Tilli; a Napoli Domenico Cirillo, che gli chiese l'indirizzo di Linneo; a Roma Giovanni Francesco Maratti con il quale discusse a proposito del genere Romulea; a Venezia collezionisti come il vescovo Marco Giuseppe Corner e Filippo Farsetti; a Padova Giovanni Marsili ("un botanico mediocre") e Antonio Vallisneri II ("non è come il padre"); a Milano Vandelli; a Torino Allioni. Gli toccò anche di resistere a seccatori come Saverio Manetti che ad ogni costo avrebbe voluto la dedica di un genere da parte di Linneo. All'inizio del 1763, via Ginevra, giunse a Parigi dove Bernard de Jussieu gli fece grande impressione; guardò invece con una certa perplessità al titanico tentativo di Michel Adanson di creare un sistema naturale e alle ricerche di Buffon sui mammiferi. Fu poi la volta di Londra, dove si fermò circa due mesi, divenendo un'habitué della casa di lady Monson, di cui caldeggiò, questa volta senza alcuna remora, la dedica di un genere botanico da parte del maestro, come ho raccontato in questo post. Dopo un breve passaggio ad Amsterdam, dove visitò i Burman, rientrò infine in Svezia nell'estate del 1764.  Collezionista e mecenate Da quel momento la sua vita fu quella di un importante mercante e imprenditore, in società con il fratello Patrick e poi con il suocero, Niclas Sahlgren, direttore della Compagnia delle Indie Orientali. Quest'ultimo lo coinvolse anche nelle sue attività benefiche, come la fondazione di un orfanotrofio e dell'ospedale di Göteborg (Sahlgrenska Hospital); per valorizzare le sue proprietà agricole e minerarie, fece costruire una strada che collegava la sua proprietà di Alingsås e Göteborg (ancora oggi detta strada degli Alströmer). Nel 1768 fu nobilitato, con il titolo di barone. Nel 1770 divenne presidente dell'Accademia delle scienze. Creò una biblioteca, un gabinetto scientifico e un'importante collezione naturalistica (in gran parte andata perduta, insieme ai suoi manoscritti, in un incendio che devastò la sua proprietà nel 1779). Prima a Kristinedal, la tenuta ereditata dal suocero, poi a Gåsevadholm, dove si era trasferito dopo il fallimento, creò anche un orto botanico; a curare le sue collezioni chiamò Jonas Theodor Fagraeus e, a partire dal 1776, Anders Dahl. Su suo incarico, per arricchire le collezioni quest'ultimo viaggiò sia in Svezia sia all'estero e più tardi divenne il curatore dell'erbario che Alströmer ricevette dal figlio di Linneo. Ma andiamo con ordine: insieme ai suoi fratelli, Alströmer fu un importante mecenate che finanziò i viaggi di naturalisti come Afzelius, Thunberg e Retzius. Nel 1781, tre anni dopo la morte del padre, il figlio, Carl Linnaeus il giovane, desiderava andare all'estero, in particolare a Londra, per raccogliere il materiale necessario al completamento dell'opera paterna; a finanziare il viaggio fu ancora una volta Alströmer, al quale, in cambio il giovane Carl - che era stato suo condiscepolo e amico - cedette il proprio erbario, che includeva anche i doppioni della collezione paterna. Dopo la morte precoce di Carl, la madre (come ho raccontato qui) si affrettò a vendere a James Edward Smith i materiali linneani che presero la strada di Londra; a rimanere in Svezia fu solo l'erbario acquisito da Alströmer, che ne affidò la catalogazione a Dahl. Oggi il "piccolo erbario" (herbarium parvum) è custodito presso il Museo di scienze naturali di Stoccolma. Fin dal suo rientro in Svezia, Alströmer fu afflitto da una misteriosa malattia che consisteva in una graduale paralisi dei muscoli, presumibilmente una forma di distrofia muscolare, del tutto ignota ai medici del tempo. Perse progressivamente ogni mobilità, fino ad essere costretto su una sedia a rotelle. Gli ultimi anni furono anche afflitti da problemi finanziari, in seguito alla bancarotta della società creata con il fratello. Morì nel 1794, a 58 anni. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Alstroemeria: fiori di seta alla conquista delle aiuole Quando prima le descrizioni entusiatiche di Alströmer e poi i semi del "giglio di Lima" raggiunsero Uppsala, Linneo ne fu estasiato: era sicuramente una pianta magnifica, e apparteneva a una specie ignota alla scienza, sebbene strettamente affine a due altre già descritte da padre Feuillée come Hemerocallis. Egli poté così stabilire un nuovo genere che si affrettò a battezzare Alstroemeria in onore dell'affezionato allievo che, intanto, continuava a percorrere l'Europa diffondendo il verbo linneano e rifornendo l'orto botanico di Uppsala con continui invii di semi. La pubblicazione avvenne già nel 1762 nell'opuscolo Planta Alstroemeria, che assegnato come tesi di laurea a Peter Falk, fu poi incluso in Amoenitates academicae. Linneo vi descrisse tre specie: A. peregrina, A. ligtu e A. salsilla, oggi Bomarea salsilla. E' curioso notare che A. peregrina, la pianta "scoperta" da Alströmer e subito nota come giglio del Perù, giglio degli Inca, in realtà è un endemismo cileno; tuttavia fu passando attraverso i giardini di Lima che i suoi semi pervennero in Spagna, per rallegrare il giardino del consolato svedese a Cadice. Lo spettacolare genere, un tempo assegnato alla famiglia Liliaceae, fa oggi parte di una famiglia propria, Alstroemeriaceae, insieme ai generi Bomarea, Drymophila e Luzuriaga. Comprende da cinquanta a ottanta specie distribuite in due aree discontinue dell'America meridionale: da una parte il Brasile (con zone adiacenti in Paraguay e Argentina) e dall'altra il Cile (con zone adiacenti in Perù, Bolivia, e Argentina). Sono erbacee perenni rizomatose (ad eccezione della cilena A. graminea, un'annuale del deserto di Atacama) con grandi fiori isolati o a mazzi con sei tepali che possono superare i 5 centimetri, in una vasta gamma di colori che include il rosso, il rosa, il lilla, l'arancio, il giallo, il salmone, l'albicocca, il verdastro, il bianco, con screziature e striature più scure o in colore contrastante. Le specie brasiliane hanno vegetazione estiva, quelle cilene invernale; incrociando i due gruppi gli ibridatori hanno creato ibridi praticamente sempreverdi, capaci di fiorire tutto l'anno. Se un tempo il loro uso principale erano i fuiori recisi, oggi le Alstroemeriae sono uscite dalle serre per diventare anche apprezzatissime piante da aiuola meno difficili da coltivare di quanto farebbe pensare la delicatezza dei loro fiori, simili a grandi farfalle di seta. La scelta è davvero enorme, con almeno 190 cultivar registrate. Qualche approfondimento nella scheda. Nella povera Svezia di metà Settecento, in assenza di finanziamenti statali o di fondi a disposizione dell'Università e dell'Accademia delle scienze, per Linneo fu importantissimo il sostegno del direttore della Compagnia svedese delle Indie Orientali, Magnus Lagerstroem. Grazie a questo collezionista e curioso di cose naturali, tanti dei suoi "apostoli" poterono viaggiare gratuitamente sulle navi della Compagnia e lo stesso Linneo poté giovarsi di una notevole collezione di reperti etnografici e naturalistici di provenienza asiatica. Riconoscente, dedicò all'amico e mecenate il brillante genere Lagerstroemia. 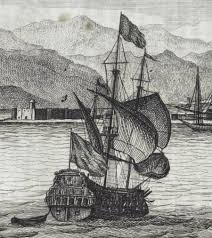 Linneo trova un mecenate La Svezia di metà Settecento sembra travolta dalla sinomania: nel 1753 nel parco del castello reale di Drottningholm viene inaugurato il padiglione cinese, al presenza dell'erede al trono (il futuro Gustavo III) vestito in abiti da mandarino; nobili e ricchi borghesi fanno a gara per ornare le loro case con porcellane e mobili cinesi; diventa di moda indossare abiti di seta di fattura cineseggiante. Porcellane, suppellettili e soprattutto il desideratissimo tè arrivano in Svezia grazie alle navi della Compagnia svedese delle Indie Orientali (SOIC), fondata nel 1731, ma che proprio tra il 1746 e il 1766 tocca l'apice del successo. E' una via di contatto con l'Oriente di cui Linneo capisce subito le potenzialità scientifiche. Attraverso il conte Tessin, cancelliere del re e presidente dell'Accademia svedese delle scienze, incomincia a premere sui vertici della Compagnia perché i viaggi commerciali assumano, in qualche modo, anche il carattere di spedizioni scientifiche. Trova immediatamente un interlocutore più che interessato in Magnus Lagerstroem, uno dei direttori della SOIC. Lagerstroem, uno svedese di origine baltica, con una notevole cultura letteraria e studioso dilettante di cose naturali, era allora all'apice della sua carriera. Con un'ottima formazione universitaria, acquisita in diversi atenei tedeschi, era un poliglotta che nella sua gioventù si era mantenuto come letterato e traduttore (fu il primo a tradurre in svedese il Tartufo di Molière e a pubblicare un manuale di lingua inglese); proprio grazie alla conoscenza delle lingue (ne scriveva e parlava almeno sei, e se la cavava con altre tre), nel 1731 era stato assunto dalla neonata SOIC come segretario. Il matrimonio con la figlia di un ricco mercante gli aveva permesso di scalare i vertici della Compagnia, fino a divenirne uno dei quattro direttori nel 1746. Proprio quell'anno si giunse a un accordo (di cui non conosciamo tutti i particolari) tra Linneo, l'Accademia delle Scienze e la SOIC: ai capitani e ai commissari di bordo delle navi che annualmente facevano la spola tra Göteborg e Canton si raccomandava di fare ogni sforzo per procurarsi oggetti di interesse etnografico e esemplari di piante e animali; nel 1747 Lagestroem emanò una circolare che stabiliva che i chirurghi e i cappellani di bordo dovevano avere una formazione scientifica, acquisita preferibilmente a Uppsala, alla scuola di Linneo. Di fatto, secondo un modello che qualche anno più tardi Joseph Banks riuscì ad imporre alla Royal Navy, queste figure assumevano un duplice volto: accanto ai loro compiti istituzionali, erano anche naturalisti a tutti gli effetti, formati secondo le istruzioni di Linneo a raccogliere e conservare reperti scientifici e a documentare le loro ricerche in accurati diari di viaggio. Fu così che iniziò l'avventura cinese degli apostoli di Linneo che abbiamo già incontrato in questo blog: Christopher Tärnström, imbarcato come pastore di bordo nel viaggio del 1746 e sfortunatamente morto prima di raggiungere la meta; Olof Torén che, sempre come pastore, tra il 1748 e il 1752 partecipò a due viaggi, prima a Giava, quindi in India e in Cina; Pehr Osbeck, cappellano della seconda nave del viaggio del 1750-1752; Carl Fredrik Adler, che tra il 1748 e il 1761 partecipò a quattro viaggi come medico di bordo; Anders Sparrman, aiuto chirurgo diciassettenne in Cina nel 1765. Grazie a questi giovani scienziati, che pagarono quasi tutti con la vita il loro amore per la scienza, giunsero in Svezia semi, piante essiccate e vive, animali, osservazioni scientifiche di ogni genere; i capitani contribuirono con rilievi cartografici e osservazioni meteorologiche. I materiali raccolti da cappellani, medici, capitani, commissari di bordo ma anche semplici marinai, andarono ad arricchire le collezioni del re, dell'Accademia delle Scienze, dell'Università di Uppsala, ma anche di facoltosi privati. Il più attivo di tutti fu proprio il nostro Magnus Lagerstroem che, approfittando della sua posizione di direttore della SOIC e investendo un notevole patrimonio, mise insieme una rilevante collezione di "cose cinesi" (ma molti reperti arrivavano da altre tappe del viaggio, dal Madagascar piuttosto che da Giava o dall'India). Quello che Lagerstroem chiamava "il mio raccolto delle Indie Orientali" comprendeva piante e animali cinesi, animali e altri reperti marini, oggetti di interesse etnografico (disegni e modellini di case e macchinari, manufatti, abiti, mappe, libri, curiosità come un corno di rinoceronte intagliato), un'intera collezione di 1000 medicinali cinesi acquistati nelle farmacie di Canton, una copia del Bencao Gangmu (o Pen-tsao Kang-mu), un grande compendio di farmacopea cinese, in 36 volumi, due dei quali di figure. Qualche anno prima della morte (avvenuta nel 1759), Lagerstroem donò le sue collezioni alla famiglia reale e a Linneo, al quale aveva anche procurato diverse piante vive per l'orto botanico dell'Università di Uppsala: tra gli altri, Arum chinense (oggi Colocasia esculenta), Artemisia chinensis (probabilmente una varietà cinese di Artemisia vulgaris, importante nella medicina cinese con il nome di moxa), Artemisia minima (oggi Centipeda minima), e, presumibilmente, quella che da lì a poco Linneo avrebbe battezzato in suo onore Lagerstroemia indica. Grazie a lui, arrivò anche una sospiratissima pianta di tè che, tuttavia, con grande delusione di Linneo, alla fioritura si rivelò una semplice camelia ornamentale. Ci è pervenuta una descrizione dei reperti naturalistici donati a Uppsala (qualche alga, qualche mammifero, ma soprattutto una cinquantina tra animali marini e uccelli) grazie alla tesi intitolata Chinensia Lagerstroemiana, scritta da Linneo nel 1754 e discussa, secondo l'abitudine del tempo, dal suo allievo Johan Lorens Odhelius. Molti di essi (tra gli altri, il famoso corno di rinoceronte) pervennero a Londra dopo l'acquisto delle collezioni linneane da parte di James Edward Smith, entrando a far parte del patrimonio della Linnean Society. Una sintesi della vita di Lagerstroem nella sezione biografie.  Lagerstroemia, dalle foreste asiatiche ai viali cittadini Poco dopo la morte del generoso mecenate, che era anche un amico personale (ci rimangono diverse sue lettere nell'epistolario linneano) Linneo volle celebrarne la memoria creando il genere Lagerstroemia. Manifestò la sua riconoscenza scegliendo una specie particolarmente bella e pregevole per le vistose fioriture, giunta a quanto pare in Svezia nel 1746 proprio attraverso Lagerstroem e i suoi fornitori di naturalia, Lagestroemia indica. Una specie indiana (oggi L. speciosa) era già stata descritta dai botanici olandesi in Hortus Malabaricus con il nome indiano di Adambea; fu forse questo a trarre in inganno Linneo - che in ogni caso dimostrò spesso una certa disinvoltura nelle sue denominazioni geografiche - inducendolo a battezzare con lo specifico indica una specie di origine cinese. Il genere Lagerstroemia appartiene alla famiglia Lythraceae, di cui costituisce il genere più cospicuo e anche il solo a comprendere veri e propri alberi. Di distribuzione essenzialmente asiatica - dall'India alla Cina e al Giappone, all'Indocina, spingendosi fino all'Australia attraverso la Malaysia - comprende una cinquantina di specie di alberi e arbusti a foglie persistenti o decidue. La più nota da noi è proprio la quasi onnipresente L. indica, che soprattutto potata a alberetto e per lo più nella varietà a fiori rosa carico, imperversa in parchi e viali cittadini, spesso usata con scarsa fantasia. Eppure ne esistono innumerevoli varietà (intorno al 2000 ne sono state recensite ben 250) e anche il mercato italiano è ben rifornito, con la presenza di vivai specializzati e di cultivar tutte italiane, come quelle selezionate dal pistoiese Antonio Grassi. Ampissima la selezione disponibile sul mercato americano, anche grazie agli ibridi tra L. indica e L. fauriei, notevoli per la rusticità e per la resistenza al mal bianco. E la scelta non si limita al solito, un po' stucchevole, rosa shocking: la gamma dei colori, oltre a tutte le sfumature del rosa e del viola, comprende anche il bianco e il rosso. Almeno un cenno al gigante del genere, l'indiana L. speciosa, un grande albero tropicale dalle vistose fioriture dal bianco al porpora che può raggiungere i 20 metri, importante per le sue implicazioni culturali; in alcune correnti del Buddismo, è considerato l'albero sotto il quale era seduto Buddah quando raggiunse l'illuminazione. Le sue foglie vengono seccate e utilizzate per un infuso simile al tè. Altri particolari su questo genere tanto diffuso quanto superficialmente noto nella scheda. Linneo è morto da quasi quindici anni e in Francia c'è la rivoluzione quando Adam Afzelius parte per l'ultimo viaggio degli apostoli. A un mondo che traballa, dove le sicurezze illuministe lasciano il posto alle rivoluzioni e al misticismo, come i discepoli di Linneo che lo hanno preceduto in giro per il mondo, oppone tenacia e dedizione alla scienza. E lascia il suo nome a un genere di splendidi alberi tropicali.  Una patria per gli schiavi liberati Sono passati quasi vent'anni dallo sfortunato viaggio di Berlin in Africa, quando Adam Afzelius parte a sua volta per la medesima meta, la Sierra Leone. Proprio su suggerimento di Henry Smeathman, il compagno di viaggio di Berlin, il paese è stato scelto dagli abolizionisti britannici per creare una colonia dove trovino una patria e un rifugio gli schiavi liberati; nel 1792, il progetto si concretizza nell'emigrazione di un migliaio di neri e nella fondazione della capitale, Freetown. Per rendere economicamente produttiva la colonia, affrancandola dal commercio degli schiavi, è necessario inventariare le risorse naturali del paese e individuarne le potenzialità economiche. E' un compito delicato, da affidare a esperti naturalisti, in primo luogo a un botanico; William Wilberforce, uno dei membri più influenti della Sierra Leone Company, che finanzia l'impresa, chiede consiglio a Joseph Banks, che propone appunto la candidatura di Afzelius, l'ennesimo allievo di Linneo approdato a Londra, in quegli anni di fine secolo ormai definitivamente la capitale della botanica mondiale. In quel momento Afzelius non è certo un giovanotto di belle speranze. Quando ha lasciato la Svezia l'anno prima, aveva già più di quarant'anni e aveva percorso lo gavetta di una modesta carriera accademica; è giunto a Londra proprio a cercare l'occasione di una spedizione scientifica che gli dia fama e rilanci la sua carriera stagnante (a Uppsala è ormai l'era di Thunberg: difficile competere con un personaggio di quel calibro). Quasi contemporaneamente, gli viene offerto di partecipare all'ambasciata in Cina di Macartney, ma Afzelius opta per la Sierra Leone: forse perché è rimasto un territorio quasi ignoto alla botanica europeo, forse perché diversi svedesi - seguaci di Swedenborg -sono membri attivi del movimento abolizionista; uno di loro è August Nordenskiöld, l'alchimista finno-svedese assunto dalla Compagnia come geologo. Lui e Afzelius faranno il viaggio d'andata insieme; ma per il compatriota non ci sarà viaggio di ritorno: morirà dopo pochi mesi. Un altro dei suoi influenti amici britannici, quel James Edward Smith che aveva acquistato le collezioni di Linneo ed era diventato presidente della Linnean Society, gli procura anche un assistente: un giovane italiano, Francesco Borone, suo servitore, che ha rivelato un sorprendente acume per la botanica. 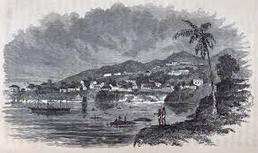 L'importante è non arrendersi Dopo i canonici due mesi di navigazione, nel maggio 1792 Afzelius e Borone sono a Freetown; trovano molte tensioni politiche, una crisi degli alloggi e molte difficoltà a preparare e soprattutto a preservare le collezioni in mancanza di carta, alcool, scatole a tenuta stagna (come dirà spiritosamente Smith, la Sierra Leone è un paese umido e "molto insettifero"); all'inizio non hanno neanche la casa promessa loro dalla compagnia. Ma soprattutto tutti e due si ammalano, presumibilmente di malaria; tanto che dopo appena un anno tornano a Londra per curarsi. A marzo dell'anno successivo Afzelius, questa volta da solo, parte di nuovo per la Sierra Leone, con attrezzature più adatte, in buona parte fornite da Banks; oltre al suo lavoro per la compagnia, in pochi mesi riesce a raccogliere, classificare, preparare, impacchettare e spedire a Banks e Smith a Londra e a Thunberg a Uppsala due importanti collezioni di piante, semi, bulbi, insetti, conchiglie, ecc. Anche se si muove poco da Freetown (compie escursioni relativamente brevi nella penisola in cui sorge la città, del resto un'area di ricca biodiversità), si avvale di una notevole rete di raccoglitori indigeni da cui acquista gli esemplari e che interroga puntigliosamente sui possibili usi. In riva al mare, nella Susan's Bay, ha una piccola casa e un giardino sperimentale dove coltiva piante utili e ornamentali e alleva i piccoli animali vivi che gli procurano i suoi raccoglitori. Ha appena messo insieme una terza collezione, ancora più imponente, quando, nel settembre 1794, una flotta francese (siamo ai tempi della prima coalizione contro la Francia rivoluzionaria) attacca Freetown. La città viene saccheggiata, devastata, incendiata; Afzelius perde la casa, tutte le sue collezioni, i libri, gli strumenti scientifici, il giardino e, quel che è peggio, il suo diario di lavoro. Non ha più nulla, tranne il vestito che ha addosso. Senza una casa, senza materiali, senza strumenti, per qualche mese vive in condizioni drammatiche. Ma non appena dall'Inghilterra gli arriva qualche aiuto, si rimette al lavoro. Mentre aspetta che una nave lo riporti in Inghilterra (non è facile, dato lo stato di guerra), nel corso del 1795 esplora non solo la costa, ma anche l'interno e ricostruisce una nuova collezione naturalistica e etnografica (particolarmente notevole la collezione di frutti); infine, nel maggio 1796 si imbarca sulla Eliza diretta a Portsmouth. In seguito a una burrasca, le piante vive che porta con sé periscono, ma si salvano i diari e tutti gli altri materiali. Altre informazioni sulla sua lunghissima vita (morirà a 86 anni, salutato come il "Nestore della botanica" e curerà anche la pubblicazione dell'autobiografia di Linneo) nella biografia.  Afzelia, legname pregiato e semi alla moda Poco dopo il suo rientro in Gran Bretagna, l'amico James Edward Smith gli dedicherà il genere Afzelia, scegliendo giustamente una delle piante raccolte dal botanico svedese in Sierra Leone, Afzelia africana. Afzelia (Fabaceae) comprende una dozzina di specie di notevoli alberi da legname, nativi delle foreste tropicali dell'Africa e dell'Asia; in Africa coprono un aerale molto vasto, che occupa la fascia forestale e le adiacenti savane, dalla Sierra Leone e dal Cameron fino alla Tanzania e al Sud Africa. Le specie asiatiche sono concentrate in Indocina, in Filippina e in Indonesia. Il legname delle specie africane è commercializzato con il nome doussié o doussie. Il più pregiato (doussie rosso) è fornito da A. africana e A. bipindensis; da A. pachyloba e A. quanzensis si ricava invece il doussie giallo o falso doussie. Per la bellezza, la durata e la stabilità, il doussie può essere annoverato tra i più pregiati legnami tropicali, paragonabile al mogano o al palissandro. Le afzelie sono alberi molto attraenti, con fiori papilionacei bianchi o rosati, spesso profumati, con un grande petalo dorsale eretto striato che può ricordare una farfalla (destinato ad attrarre le falene, i suoi insetti impollinatori). I semi bicolori di alcune specie, come A. quanzensis, vengono utilizzati come vaghi per bracciali e collane. Altre informazioni nella scheda. Andreas Berlin, uno degli ultimi apostoli di Linneo, con una borsa di studio va a Londra e entra nell'entourage di Banks. Ma anche lui sogna di partecipare a una spedizione scientifica; così non esita a partire per l'Africa per esplorare la quasi sconosciuta Sierra Leone. Ma ben presto scopre a sue spese che l'Africa può essere ben peggio della selvaggia e famigerata Lapponia di Lule.  Un coleottero, una disputa e una spedizione scientifica Nel 1766, Mr. Ogilvie, il medico di bordo del vascello britannico Renown, alla fonda alla foce del Gabon, entra in possesso di un enorme insetto, trovato a fluttuare morto nelle acque del fiume. Quelli che oggi conosciamo come "scarabei golia" sono gli insetti più grandi della Terra, possono essere lunghi fino a 15 cm e pesare un etto; subito battezzato Goliathus goliatus da Linneo (1771), il mostruoso coleottero è al centro di una curiosa disputa tra collezionisti di curiosità naturali. Il medico lo vende a William Hunter, celebre anatomista e proprietario di un notevole gabinetto di curiosità; membro della Aurelian Society, un influente circolo di entomologi, egli presta l'esemplare a un altro socio, Emanuel Mendez da Costa, che sta curando una pubblicazione. A sua volta da Costa, dopo aver fatto ritrarre l'esemplare dal celebre disegnatore naturalista Moses Harris, trovandosi in difficoltà finanziare, senza alcuna autorizzazione, vende il disegno a Dru Drury, importante entomologo e a sua volta grande collezionista, che lo pubblica come fosse proprio, senza indicare il vero proprietario, Vedendo la sua generosità così mal ripagata, Hunter va su tutte le furie. L'episodio, oltre a dimostrare quanto grande fosse nell'Inghilterra del Settecento la rivalità tra collezionisti, è all'origine di una spedizione scientifica che coinvolge uno degli ultimi apostoli di Linneo, Andreas Berlin. Nel 1771 Drury, Harris, il medico John Fothergill, l'ornitologo Marmaduke Tunstall, desiderosi di assicurare alle loro collezioni prestigiose rarità, si associano per finanziare una spedizione naturalistica in Africa occidentale, una regione poco conosciuta dagli europei e quindi particolarmente adatta "ad offrire esemplari nuovi e rari dei tre regni della natura". Coinvolgono nel progetto anche il giovane Banks, appena rientrato dal viaggio dell'Endeavour, grazie al quale ottengono il sostegno della Royal Society. La spedizione è affidata al giovane naturalista Henry Smeathman, con l'assistenza appunto di Berlin. Quest'ultimo nel 1770 si era trasferito a Londra con una borsa di studio, nella speranza di unirsi a qualche spedizione botanica. Era quindi stato assunto come segretario da Banks, che lo aveva impegnato in compiti di scarso peso scientifico, come copiare in bella copia le descrizioni delle piante; come scrive in una lettera a Linneo, tuttavia, Berlin è incerto sul suo futuro: Banks e Solander al momento sono intenzionati a partecipare al secondo viaggio di Cook e inizialmente Berlin pensa di partire con loro. Quando il progetto salta, decide di accettare la proposta di Fothergill di accompagnare Smeathman in Africa; anche se l'obiettivo principale è la raccolta di insetti, la presenza di un botanico (materia poco nota a Smeathman) è un valore aggiunto. La meta prescelta è la Guinea. Abituato al terribile clima lappone, Berlin è convinto che se la caverà benissimo in Africa: "L'Africa non può essere peggio della Lapponia di Lule". Si sbaglia di grosso. Dopo due mesi di navigazione, Berlin arriva in Africa all'inizio di aprile 1773 e raggiunge Smeathman nelle Isole delle banane, un piccolo arcipelago a sud della Sierra Leone, che sarà la base iniziale della spedizione. E' stupefatto dalla ricchezza e dalla bellezza della natura africana, tanto da paragonarsi a un cieco che ha appena ricevuto la vista. Nell'unica lettera inviata a Linneo dall'Africa, gli racconta con entusiasmo che dopo un quarto d'ora d'escursione ha già trovato tre specie sconosciute; inoltre si è accordato con Smeathman di inviare al maestro un esemplare per ogni insetto che troveranno. Ma questi progetti non si realizzeranno mai: prima ancora di lasciare le isole per la terraferma Berlin si ammala gravemente di una febbre tropicale, presumibilmente di malaria, e a giugno muore. Qualche notizia in più nella biografia.  La Berlinia e le sue sorelle La tragica vicenda di Berlin (che ha condiviso il destino di tanti altri discepoli di Linneo e in particolare del primo, quel Tärnström morto prima di raggiungere la meta) gli ha impedito di offrire particolari contributi alla scienza. Il condiscepolo Solander volle tuttavia ricordarlo dedicandogli il genere Berlinia, una leguminosa (Fabacea) africana di grande bellezza, tra i pochi esemplari vegetali che lo sfortunato naturalista era riuscito a raccogliere. Questo genere comprende una ventina di specie arboree o meno frequentemente arbustive esclusive delle foreste e delle boscaglie dell'Africa occidentale. Non è ancora ben conosciuto, tanto che recentemente - nel corso di uno studio finanziato dai Kew Gardens - ne sono state riconosciute tre nuove specie, tra cui la gigantesca B. korupensis, endemica del Parco Nazionale Korupe del Cameron, che può raggiungere i 40 metri; porta enormi baccelli che, quando sono maturi, esplodono, lanciando i semi a grande distanza. Nonostante diverse specie siano minacciate, questo alberi sono anche sfruttati per il legname, che viene commercializzato con il nome "ebiara" o (nei paesi anglofoni) Zebrawood per le evidenti venature scure. Dal genere Berlinia sono stati distaccati due generi affini: Microberlinia, che comprende due specie di alberi nativi del Cameron e del Gabon, anch'essi noti con il nome di Zebrawood; Isoberlinia, che comprende cinque specie originarie delle boscaglie aride dell'Africa tropicale, caratteristiche della formazione vegetale denominata miombo (boscaglia delle regioni aride, formata prevalentemente da alcune specie di leguminose). Le tre specie Berlinia, Isoberlinia, Microberlinia sono molto affini tra loro (le differenze sono così piccole da non essere riconoscibili quando le piante non sono in fiore e spesso sono confuse anche dalla popolazione del luogo); qualche informazione in più nelle rispettive schede. Per tutto il Settecento, nessun botanico europeo aveva potuto mettere piede in Giappone, chiuso agli stranieri dalla politica isolazionista del sakoku. L'impresa di infrangere quella cortina di ferro riuscì a uno dei formidabili apostoli di Linneo, Carl Peter Thunberg. Per riuscirci dovette farsi olandese. E mentre cambiava pelle e lingua, diede un ineguagliabile contributo alla conoscenza della flora e della fauna del Sud Africa.  Come si diventa olandesi? Nel 1636, nella baia di Nagasaki venne costruita l'isola artificiale di Dejima (o Deshima). A forma di ventaglio, lunga 120 m e profonda 75, con una circonferenza di poco più di 500 m, questo luogo minuscolo per circa 200 anni sarebbe stata l'unica finestra del Giappone sul mondo; vi aveva infatti sede l'agenzia della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC), l'unica ad essere autorizzata a commerciare con il Giappone durante il lungo periodo dell'isolazionismo, o sakoku. Qui nel 1775 giunse Carl Peter Thunberg, il più grande dei discepoli di Linneo. Per arrivarci, aveva già percorso una lunga strada e si era creato una nuova identità. Studente a Uppsala alla fine degli anni '60, nel 1770 aveva lasciato la Svezia per perfezionarsi in medicina e scienze naturali a Parigi, Leida e Amsterdam. In Olanda il suo talento fu notato da Johannes Burman (che oltre trent'anni prima aveva ospitato Linneo) e dal figlio Nicolaas, i quali progettavano di inviare in Giappone un medico-naturalista che arricchisse di nuove piante gli orti botanici olandesi; in effetti, nell'ultimo quarto del Settecento l'isolazionismo del Giappone si era fatto meno severo e, grazie all'importazione di numerosi libri scientifici in lingua olandese, vi era vivo l'interesse per le scienze occidentali, soprattutto l'erboristeria e la medicina. Un medico con una buona preparazione botanica sarebbe stato il benvenuto e avrebbe potuto ottenere piante in cambio di informazioni scientifiche. Ottimo medico e dotto naturalista della scuola linneana, Thunberg era il candidato ideale; tranne per un particolare: non era olandese. Non un ostacolo tale da impressionare né i Burman né l'avventuroso Thunberg: se non era olandese, avrebbe potuto diventarlo almeno abbastanza da apparire credibile a occhi e orecchie giapponesi. Sostenuti gli esami per essere assunto dalla VOC come chirurgo, avrebbe dovuto trasferirsi in Sud Africa, in modo da imparare la lingua e le abitudini olandesi soggiornando nella colonia del Capo. E ovviamente, mentre era sul posto, esplorare la flora e la fauna di quella ricca regione naturalistica. Linneo, sempre puntigliosamente informato dalle lettere dell'affezionato allievo, diede il suo assenso. Dunque nell'autunno del 1771 Thunberg partì per il Capo di Buona Speranza come medico di bordo della nave Schoonzigt. Il viaggio gli costò quasi la vita, per colpa di un cuoco maldestro che per errore mescolò biacca di piombo alla farina dei pancake della mensa ufficiali; ma fu anche un'occasione per dimostrare il suo acume scientifico, salvando se stesso e le altre vittime e descrivendo il decorso della malattia in una puntigliosa relazione. 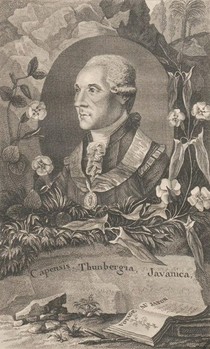 Il "padre della botanica sudafricana" Dopo la pericolosa avventura, Thunberg arrivò al Capo il 16 aprile 1772, appena una settimana dopo il condiscepolo Sparrman (come si è visto in questo post). In Sud Africa sarebbe rimasto tre anni durante i quali avrebbe esplorato sistematicamente le ricchezze naturali della regione. Il primo contatto con la flora sudafricana avvenne proprio in compagnia di Sparrman con il quale esplorò la baia del Capo, ma ben presto le strade dei due si divisero. Nonostante il nuovo governatore della Compagnia, Joachim van Plettenberg (a differenza del predecessore, Rijh Tulbagh, corrispondente di Linneo) fosse scarsamente interessato alle esplorazioni scientifiche e Thunberg fosse sempre a corto di denaro (si manteneva con il lavoro di medico della VOC e ottenne aiuto e prestiti da alcuni sponsor), egli riuscì a sfruttare al meglio la sua permanenza: ogni anno, dedicò il periodo settembre-dicembre (corrispondente alla primavera australe, la stagione delle piogge e il momento di massimo rigoglio della vegetazione) a una lunga spedizione naturalistica nell'interno; i mesi restanti erano utilizzati per raggranellare quattrini, riordinare le raccolte, scrivere le pubblicazioni scientifiche relative, compiere frequenti escursioni a breve raggio nei dintorni di Città del Capo (ad esempio, scalò la Table Mountain per almeno quindici volte). Nella prima spedizione (7 settembre 1972-2 gennaio 1773) Thunberg fu accompagnato da Johann Andreas Auge, il soprintendente dei giardini della Compagnia al Capo; dal sedicenne Daniel Ferdinand Immelmann, figlio di un ufficiale olandese; dal sergente dell'esercito Christian Hector Leonhard e da due "ottentotti" (ovvero Khoi). Dapprima si mossero verso occidente, fino alla base di Saldanha; quindi, dopo aver raggiunto le montagne, un grande giro verso est lungo l'altopiano li portò a toccare la costa a Mossel Bay. Qui si inoltrarono ancora verso est, toccando il punto più orientale al fiume Gamtoos. La spedizione si muoveva lentamente, pernottando nelle fattorie della compagnia con carri trainati dai buoi, più adatti dei cavalli ad affrontare la scarsità d'acqua. Al suo rientro a Città del Capo, Thunberg accompagnò in una breve escursione il naturalista francese Pierre Sonnerat, di passaggio in Sud Africa; ma soprattutto incontrò Francis Masson, il raccoglitore di piante inviato al Capo da Banks per conto dei Kew Gardens. I due, pur diversissimi per cultura e carattere, divennero amici e decisero di proseguire insieme l'esplorazione; in effetti, la collaborazione conveniva da entrambi: Masson aveva dalla sua una maggiore disponibilità di mezzi, Thunberg l'eccezionale competenza scientifica, oltre a una migliore conoscenza del territorio. Dopo un breve viaggio di prova, in cui insieme al capitano Gordon esplorarono le montagne intorno al Capo (13-16 maggio 1773), nel settembre 1773 i due, accompagnati da quattro khoi, partirono, per una lunga spedizione che si mosse grosso modo sulle tracce di quella precedente; tuttavia, spesso, mentre i khoi proseguivano con i carri per strade più battute e percorribili, i due naturalisti, a cavallo, affrontarono impervie scalate e passi disagevoli per esplorare la flora e la fauna delle montagne dell'altopiano. Impetuoso e talvolta imprudente, mentre guadava un torrente Thunberg rischiò di annegare nella profonda buca scavata da un ippopotamo, ma superò l'avventura con imperturbabile sangue freddo. Il punto estremo della spedizione fu questa volta il Sundays River. L'anno successivo i due amici si unirono per un'ultima spedizione (settembre-dicembre 1774) che si spinse all'interno, in direzione nord-ovest, per esplorare l'altipiano del Roggeveld, fino ad allora mai toccato dai naturalisti. Tra gli obiettivi anche la raccolta di campioni minerari. Anche se una parte delle collezioni andò perduta in seguito al ribaltamento di uno dei carri, anche in questo caso il bottino dei due amici fu ricchissimo. Durante la sua permanenza al Capo, Thunberg, raccoglitore estremamente accurato e coscienzioso, raccolse un'impressionante massa di esemplari botanici (ma anche animali, rocce, minerali, fossili): circa 3000 piante (ovvero il 30% delle specie dell'area), di cui almeno un migliaio ignote alla scienza. Insieme a numerosissime pubblicazioni più brevi dedicate a generi endemici della flora sudafricana, i suoi Prodromus plantarum capensium (1794-1800) e Flora capensis (1807-1823) furono per decenni i testi di riferimento per la conoscenza della flora sudafricana e gli guadagnarono il soprannome di "Padre della botanica sudafricana".  Il "Linneo giapponese" Ma era tempo per Thunberg di lasciare il Sud Africa per la sua vera meta. Ora parlava fluentemente l'olandese (se ne servì anche per alcuni scritti scientifici) e degli olandesi aveva assunto anche le abitudini (ma non quella del fumo, che detestava). Nel marzo del 1775 si imbarcò come medico di bordo sulla Loo, diretta a Batavia, dove riuscì a farsi assegnare il posto di medico residente dello stabilimento commerciale di Dejima. Vi arrivò ad agosto a bordo della nave Stavenisse e vi rimase per circa quindici mesi (fino al novembre 1776). Agli europei era vietato lasciare l'isola (collegata alla terraferma da un ponticello strettamente sorvegliato e chiuso da una grata); così, all'inizio l'avventura giapponese di Thunberg fu estremamente frustrante. Le uniche piante che riuscì ad osservare erano quelle utilizzate come foraggio per il bestiame che gli olandesi tenevano sull'isola. Tuttavia, grazie al suo carattere aperto e allegro, riuscì a stringere amicizia con alcuni degli interpreti giapponesi - alcuni dei quali erano medici o naturalisti - che gli procurarono esemplari in cambio di informazioni mediche e scientifiche. Grazie ai suoi contatti giapponesi nel febbraio 1776 ottenne finalmente dal governatore di Nagasaki l'autorizzazione ad esplorare i dintorni, anche se sempre accompagnato da uno stuolo di interpreti, guardie e domestici, a cui era obbligato ad offrire il tè a proprie spese in ogni punto di sosta. Ogni anno, in occasione del Capodanno giapponese, il capo dell'agenzia olandese si recava ad Edo (l'odierna Tokio) per rendere omaggio allo Shogun. Nel 1776 della delegazione fa parte anche Thunberg; durante il lungo e lento viaggio di circa 1000 km - gli ospiti europei sono trasportati in lussuose portantine - può così osservare gli usi e i costumi del paese e raccogliere numerosi esemplari botanici; unico rammarico: i contadini giapponesi sono coltivatori così solerti che difficilmente nei campi si trovano erbacce. Dopo aver toccato Osaka e Miyako (oggi Kyoto), ad aprile la delegazione arriva a Edo. Qui Thunberg è stato preceduto dalla sua fama di sapiente medico e incontra, tra gli altri, il medico personale dello Shogun, Katsuragawa Hoshu, che, insieme all'amico Nakagawa Jun-an, sta traducendo in giapponese un importante testo di anatomia; sono tre settimane di intensissimo colloqui scientifici su diversi argomenti, nel corso dei quali, tra l'altro, Thunberg avrà modo di introdurre in Giappone il mercurio per curare la sifilide. I due medici giapponesi - con i quali Thunberg rimarrà in contatto anche quando sarà rientrato in Svezia - gli procurano piante e lo informano sui loro nomi giapponesi; a sua volta, lo svedese riferisce i nomi olandesi e latini. Dopo essere stato ricevuto dallo Shogun il 18 maggio, il gruppo riparte per Nagasaki; a Osaka Thunberg trova un piccolo giardino botanico dove acquista diverse piante che poi spedirà a Amsterdam in tinozze piene di terra. Il 29 giugno è di nuovo a Deshima; durante l'estate, Thunberg, oltre a riordinare le collezioni raccolte durante il viaggio, ha modo di compiere diverse escursioni nell'area di Nagasaki. Il risultato del suo soggiorno giapponese sarà Flora japonica (1784), la prima descrizione sistematica della flora e della fauna del Giappone, un testo innovativo e influente, che gli guadagnerà il soprannome di "Linneo giapponese". Curiosamente, molte delle piante battezzate da Thunberg con il nome specifico japonica, non sono autoctone giapponesi, ma piuttosto piante orticole di origine cinese importate da secoli nel paese del Sol Levante. Altri approfondimenti su questa grande figura di naturalista nella biografia.  Thunbergia, esuberanza tropicale Onorato in vita con numerosi riconoscimenti, Thunberg ha lasciato una profonda impronta nella nomenclatura botanica. Scopritore di dozzine di nuovi generi, ha tenuto a battesimo piante oggi comuni nei giardini come Deutzia, Weigela, Aucuba, Nandina, Skimmia. Sono almeno 250 le specie vegetali (e alcune animali) che lo onorano con l'epiteto thunbergii, thunbergianus. Si deve a un altro botanico svedese, Anders Johan Retzius, la dedica del genere Thunbergia (1780), la cui specie tipo è T. capensis, una delle numerose piante raccolte da Thunberg nella regione del Capo. Questo genere della famiglia Acanthaceae comprende un centinaio di specie di erbacee, arbusti, ma soprattutto rampicanti, originarie dell'Africa meridionale, del Madagascar e dell'Asia tropicale. Vigorose, di rapida crescita e molto decorative per l'esuberante fioritura, molte sono popolari piante da giardino, soprattutto dove il clima mite ne consente la coltivazione all'aperto. La più diffusa è probabilmente T. alata, nota con il curioso nome "Susanna dagli occhi neri" per i fiori dalle corolle aranciate o gialle con un caratteristico centro dal colore scuro. Di rapida crescita, è spesso coltivata come annuale anche in climi più rigidi. Di frequente coltivazione è anche T. grandiflora, nativa dell'India tropicale, una vigorosa rampicante sempreverde con grandi fiori blu-violetto. Per approfondimenti su altre specie si rimanda alla scheda. Viaggiatore di lungo corso, Anders Sparrman a diciassette anni va in Cina, a ventiquattro in Sud Africa da dove parte per il giro del mondo con James Cook. Sopravvissuto ai ghiacci antartici e alle frecce avvelenate polinesiane, torna in Africa, diventa un'autorità nel campo dei mammiferi africani e dà un contributo determinante all'abolizione della tratta degli schiavi. A ricordarlo la bella e "sensibile" Sparrmannia. 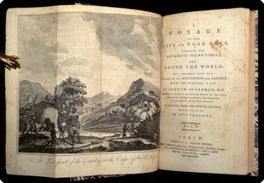 In Cina e in Sud Africa con la SOIC Di tutti gli apostoli di Linneo, Anders Sparrman è stato quello che ha viaggiato di più: ben cinque viaggi, toccando tutti e cinque i continenti (anzi tutti e sei, se contiamo anche l'Antartide). Approdato a Uppsala addirittura a otto anni, nel 1765, ad appena 17 anni, si imbarca come assistente medico su una delle navi della Compagnia svedese delle Indie Orientali (SOIC) dirette a Canton, quinto apostolo a percorrere quella rotta. Il viaggio cinese è poco più di un apprendistato sul campo per il giovane Anders, che al suo rientro ad Uppsala riprende con decisione gli studi medici e sostiene gli esami teorici nel 1770. Tuttavia non arriva alla laurea, perché all'inizio del 1772 riparte, questa volta per il Sud Africa. Il suo comandante nel viaggio in Cina, il capitano Carl Gustav Ekeberg, è riuscito a convincere le autorità olandesi a permettere a un naturalista svedese di visitare la colonia del Capo, uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del pianeta. La SOIC tuttavia si limita ad offrirgli un passaggio gratuito; al Capo per mantenersi dovrà lavorare come precettore dei numerosi figli del residente olandese Johann Friederick Kirsten, dedicando alle ricerche naturalistiche l'eventuale tempo libero. Arrivato a Cape Town nell'aprile 1772, Sparrman ha la gradita sorpresa di incontrare un altro allievo di Linneo, Carl Peter Thunberg. Ma dopo pochi giorni entusiasmanti passati a esplorare insieme quell'angolo di Paradiso, deve raggiungere il suo datore di lavoro. Mentre Thunberg, ufficialmente medico al servizio della Compagnia olandese delle Indie, esplora liberamente il paese, lui deve accontentarsi di brevi scappate rubate ai momenti di riposo. A tanto entusiasmo, subentra la delusione. In un'accorata lettera al maestro, si paragonerà a qualcuno che assiste da lontano a un ricco banchetto: gli arriva lo stuzzicante odorino delle vivande, ma a lui toccano solo le ossa. Per altro sembra proprio che la colonia del Capo si stia trasformando nel terreno di gioco preferito dei botanici, continua con amara ironia: è pieno di cercatori di piante e, ad avere i soldi per pagare, puoi procurarti tutte quelle rarità che lui non è destinato neppure a vedere. E' persino arrivato un inglese (lo conosciamo bene: è Francis Masson, il cacciatore di piante spedito da Banks)! Insomma, una situazione davvero frustrante.  Il secondo viaggio di Cook Ma prima di continuare con le avventure di Sparrman, facciamo un passo indietro e un salto in Inghilterra, dove Cook stava preparando il suo secondo viaggio. Il dubbio sull'esistenza di un continente australe, l'ipotetica Terra australis incognita, non era stato risolto dal primo pur fortunato viaggio; ecco dunque che l'ammiragliato varò immediatamente una seconda spedizione, cui avrebbero partecipato due navi: la Resolution e l'Adventure. L'équipe scientifica, dopo la defezione di Banks, fu capeggiata da un botanico tedesco, Johann Reinhold Forster, accompagnato dal figlio Georg; c'era inoltre un astronomo, William Wales, e un pittore, William Hodges. Su richiesta di Banks, fu imbarcato anche il giardiniere di Kew Francis Masson, che sarebbe sbarcato al Capo per esplorare la flora del Sud Africa. Invece di circumnavigare il globo da est a ovest, come nel primo viaggio, questa volta la rotta si sarebbe mossa in senso contrario, esplorando l'Atlantico e il Pacifico meridionale alla ricerca sistematica dello sfuggente mitico continente australe. Partito da Plymouth nel maggio 1772, Cook si diresse verso sud, toccando Madeira e le isole di Capo Verde. Il 30 ottobre giunse a Cape Town, dove venne sbarcato Masson. Durante la sosta sudafricana, Johann Reinhold Forster conobbe il nostro Anders Sparrman e gli propose di unirsi alla spedizione. Dopo una notte insonne, passata a soppesare i pro e i contro, Sparrman accettò. La Resolution e l'Adventure salpano il 22 novembre 1772 dirigendosi verso sud, nell'area dove il navigatore francese Bouvet pretendeva di aver avvistato terre emerse. Senza toccare terra per 124 giorni, le due navi esplorano l'Atlantico e il Pacifico meridionali, tra venti gelidi, nebbie antartiche e iceberg, passano per due volte il circolo polare antartico e dimostrano definitivamente che non esiste alcun continente australe sconosciuto. Balene, foche, pinguini... ma nessuna pianta per fare felici i nostri botanici. Dopo essere state separate dalla nebbia, nel maggio 1773 l'Adventure e la Resolution si ricongiungono in Nuova Zelanda. A ottobre, dopo aver esplorato Tonga, una tempesta separa di nuovo le due navi; Fourneaux, il comandante dell'Adventure, decide di rientrare in Inghilterra. Invece Cook, approfittando dell'estate australe, punta ancora una volta a sud, passa per la terza volta il circolo polare antartico, finché non viene bloccato dalla banchisa; ha comunque toccato il punto più a sud mai raggiunto (71° 10'). Anzi, secondo un aneddoto, proprio a Sparmann spetterebbe il record di essere l'uomo giunto più a sud, perché in quel momento si trovava sulla poppa della nave. Non potendo proseguire oltre, Cook ritorna a nord, esplorando palmo a palmo il Pacifico, in un grande giro che tocca Tonga, l'isola di Pasqua, l'isola Norfolk, la Nuova Caledonia, Vanuatu, quindi ancora la Nuova Zelanda. Nel novembre 1774 inizia il viaggio di ritorno; toccata la Terra del Fuoco e doppiato Capo Horn, dopo un'ulteriore puntata a sud che frutta la scoperta delle desolate Georgia del Sud e Sandwich del Sud, finalmente il 21 marzo si approda a Table Bay, la baia del Capo. Per Sparrman è ora di sbarcare. Dopo una sosta di qualche settimana, gli altri riprendono il viaggio e saranno a casa il 30 luglio. Appena sbarcato, Sparrman si affretta a scrivere a Linneo (a differenza di Solander, era un corrispondente attivo e considerava un "parricidio" trascurare le lettere al maestro). Il tono non è entusiastico, anzi... Dopo aver affrontato un viaggio durissimo (in due anni e mezzo, i periodi trascorsi a terra sommano a meno di sei mesi), il freddo polare, i rapporti ostili con gli abitanti di molte isole (sia lui sia Georg Forster hanno rischiato lo pelle), la fame e le privazioni (al loro sbarco a Cape Town sembravano un equipaggio di fantasmi), il bottino che può vantare non si può certo paragonare a quello di Solander e Banks. Quei due hanno avito la fortuna di mettere le mani sulla cassa del tesoro, hanno scoperto piante a migliaia, mentre lui ha dovuto accontentarsi di scoprirne a centinaia, in tutte quelle isole, e a ben caro prezzo: si erborizzava mentre intorno volavano pietre, lance, randelli e frecce avvelenate. Le lamentele continuano: tutti gli altri si sono laureati, grazie al nome del loro maestro stanno facendo delle belle carriere, solo lui a causa dei tanti viaggi è rimasto senza laurea e senza prospettive. Spera di rifarsi al suo ritorno, tra un anno, quando lascerà definitivamente l'Africa. 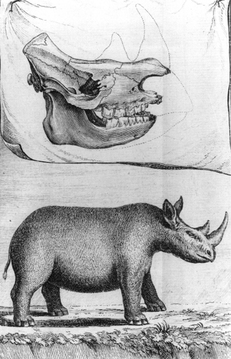 Alla scoperta della fauna africana In effetti i risultati scientifici più importanti devono ancora arrivare. D'altra parte, benché importante, il suo ruolo nella seconda spedizione di Cook era stato quello di un collaboratore - ancora oggi, è difficile distinguere i suoi contributi da quelli dei due Forster. Lavorando per quattro mesi come medico a Città del Capo e arrotondando i proventi con qualche non meglio specificata speculazione commerciale, Sparrman riesce a mettere insieme quanto basta per finanziarsi una spedizione nell'interno della colonia del Capo. Per quasi un anno (dal luglio 1775 all'aprile 1776), accompagnato da Daniel Ferdinand Immelmann (che già aveva fatto da guida a Thunberg) e da portatori khoi-khoi, esplorò l'area orientale della colonia del Capo, spingendosi fino al Great Fish River e ai confini della colonia. Importanti furono soprattutto le scoperte zoologiche: tra le molte segnalazioni, che fecero di lui un'autorità nel campo dei mammiferi africani, fu il primo a descrivere il rinoceronte africano e il bufalo del Capo. Il viaggio confermò anche il giudizio negativo di Sparrman sull'atteggiamento degli europei verso i neri e il netto rifiuto dello schiavismo, che indagò con occhio critico e spirito umanitario. Rientrò a Città del Capo appena in tempo per imbarcarsi sulla nave Stockholms Slott. Giunto a Stoccolma a luglio 1776, scoprì che la fama lo aveva preceduto, grazie ai suoi compagni di viaggio rientrati a Londra già da un anno, L'Università di Uppsala gli aveva anche attribuito, honoris causa, la tanto sospirata laurea. Per un breve periodo, in Svezia fu l'uomo del giorno. Fu ammesso all'Accademia delle Scienze, delle cui collezioni naturalistiche fu nominato curatore (incarico che mantenne per vent'anni, dal 1777 al 1798) e qualche anno più tardi ottenne una cattedra universitaria. Nel 1787 lo attendeva un ultimo viaggio: fu nominato membro della commissione che doveva esplorare il Senegal alla ricerca di un luogo adatto a una colonia svedese. La spedizione fu un fallimento, ma durante il viaggio di ritorno Sparrman e il suo compagno Wadström, di passaggio a Londra, resero un'importante testimonianza contro la tratta degli schiavi che ebbe grande influenza nell'orientare in senso antischiavista l'opinione pubblica britannica. Personalità inquieta, divisa tra l'entusiasmo illuminista per le scienze e tensioni preromantiche, nell'ultima parte della vita Sparrman, pur mantenendo un certo prestigio nell'ambiente scientifico svedese, si vide messo in secondo piano da personalità più forti, in particolare da Thunberg. Altre notizie nella biografia. Autore solerte e prolifico, egli raccontò i suoi viaggi nell'opera in tre volumi Resa till Goda Hopps-Udden, södra Polkretsen och omkring Jordklotet, samt Till Hottentott- och Caffer-Landen Åren 1772-1776 ("Viaggio dal Capo di Buona Speranza, attraverso il circolo polare Antartico e attorno al mondo, ma soprattutto nel paese degli Ottentotti e dei Caffri, dall'anno 1772 al 1776") che fu tradotto in diverse lingue europee e (nonostante qualche lungaggine) divenne un piccolo bestseller. Recentemente, lo scrittore svedese Per Wästberg gli ha dedicato un romanzo, di cui è disponibile la traduzione inglese (The Journey of Anders Sparrman, GRANTA 2010).  La sensibile Sparrmannia Benché con gli anni gli interessi di Sparrman si spostassero sempre più dalla botanica alla zoologia e dalla zoologia agli esseri umani (terminerà la sua carriera come medico dei poveri), nei suoi viaggi raccolse e classificò un importante erbario, inviò a Linneo molti esemplari e concorse alla conoscenza della flora del Capo, anche se il suo contributo è molto meno noto di quello di Thunberg. Tra le piante che contribuì a far conoscere e ad introdurre in Europa c'è anche quella che porta il suo nome, Sparrmannia africana. Sparrmannia è un piccolo genere di arbusti o piccoli alberi nativi dell'Africa tropicale, del Sud Africa e del Madagascar (famiglia Tiliaceae, ora inclusa in Malvaceae), creato dal figlio di Linneo nel 1792. La specie più nota è proprio Sparrmannia africana, un grande arbusto che cresce ai margini delle foreste, nei burroni e lungo i fiumi dal Capo occidentale a Port Elisabeth ed è comune nei distretti di George, Knysna, Uniondale e Humansdsorp (gli ultimi due comprendono alcune delle aree esplorate da Sparrman). I vistosi stami dei fiori dai petali bianchi, raccolti in ampie ombrelle, hanno una particolarità: sono sensibili al contatto. Quando un insetto tocca il fiore la massa degli stami si distende, allontanandosi dallo stigma, presumibilmente per favorire l'impollinazione. La bellezza dei fiori e delle foglie a forma di cuore, nonché la relativa facilità di coltivazione, fin dalla fine del Settecento ne hanno favorito l'introduzione prima nelle serre poi nei giardini delle zone miti. Grazie ai giardinieri inglesi nell'Ottocento la pianta ha trovato una certa diffusione nei giardini mediterranei e in altre aree non soggette al gelo, ad esempio a Madeira, ma anche in Costa Azzurra e in Riviera. Qualche notizia in più nella scheda. All'appuntamento con Venere del giugno 1769, oltre a Falk si presenta un altro apostolo di Linneo, il più famoso di tutti: Daniel Solander. L'osservazione del transito nell'esotica Tahiti è solo la prima tappa di uno dei viaggi naturalistici più famosi di tutti i tempi, il primo viaggio di Cook, con la scoperta dell'Australia e della sua natura stupefacente. Ma questa è anche la storia di un grande sodalizio intellettuale e di un'amicizia profonda, quella tra Daniel Solander e Joseph Banks.  Signori a bordo! Si parte per Tahiti Alla fine dell'agosto 1768, mentre Falk lasciava Pietroburgo per affrontare il freddo della Siberia e il sole nero della depressione, il transito di Venere metteva in movimento un altro allievo di Linneo, che per osservarlo sarebbe andato letteralmente in capo al mondo. Era Daniel Solander, il più famoso di tutti, uno dei naturalisti che a bordo dell'Endeavour fu tra i protagonisti di una delle pagine più epiche della storia della scienza: il primo viaggio di Cook e la scoperta dell'Australia. Solander era il delfino di Linneo, che contava di farne il proprio successore all'Università di Uppsala (preferendolo al figlio, il mediocre Carl il giovane) e suo genero (era fidanzato con sua figlia maggiore, Lisa Stina). Nel 1760 il maestro lo aveva spedito a Londra con il delicato incarico di diffondere il sistema sessuale linneano negli ambienti scientifici britannici che rimanevano fedeli ai sistemi di Ray e Tournefort. Il giovane Daniel assolse fin troppo bene il compito, entrando nelle grazie delle persone che contavano nella scienza londinese; ma soprattutto scoprì un ambiente molto più fertile e libero della grigia, luterana e assolutistica Svezia. Mentre Linneo preparava per lui un carriera di professore universitario, cercandogli un ingaggio (guarda caso!) all'Accademia di Pietroburgo, Solander faceva orecchie da mercante e con l'aiuto degli amici inglesi cercò un incarico che gli permettesse di rimanere a Londra. Lo trovò al British Museum che gli chiese di catalogare le farraginose collezioni di storia naturale. In questo compito Solander si dimostrò brillantissimo, divenendo un pioniere della museologia; inventò persino un particolare tipo di scatola da archivio, che in inglese porta ancora il suo nome, Solander box. Fu proprio al British Museum che incontrò un giovane ricchissimo, appassionato di storia naturale, destinato a diventare il suo migliore amico, il suo compagno di avventura e il suo protettore: Joseph Banks. Nel febbraio del 1768, la Royal Society (la più importante istituzione scientifica europea) chiede al re Giorgio III di finanziare una spedizione scientifica nell'Oceano Pacifico allo scopo di osservare nelle migliori condizioni il transito di Venere; il re accetta e la Royal Navy ne approfitta per unire allo scopo scientifico un secondo obiettivo, tenuto segreto: esplorare il Pacifico meridionale alla caccia della Terra australis incognita, l'ipotetico continente che avrebbe dovuto riequilibrare la distribuzione delle masse terrestri. Gli scopi dell'Ammiragliato britannico, com'è ovvio, sono più strategici e militari che scientifici; quindi, esattamente come nella contemporanea spedizione dell'Accademia russa, ricerca scientifica, prestigio internazionale e interessi imperialistici vanno di pari passo. Ma il fatto che a prendere l'iniziativa questa volta siano gli scienziati (e non un monarca più o meno illuminato) la dice lunga sulla distanza che separa la monarchia parlamentare inglese e la stratificata società britannica dagli altri stati europei, ancora immersi nell'ancien régime. Eccoli dunque, sul ponte della HMS Endevour, i protagonisti della grande avventura: il comandante James Cook, appena promosso tenente di vascello; settantatré marinai; dodici fanti di marina; l'astronomo Charles Green; lo scienziato dilettante Joseph Banks, nominato botanico ufficiale senza stipendio (a lui interessa la gloria, personale e della nazione), assistito da una piccola équipe di sette persone pagata di tasca propria composta da Daniel Solander, dal segretario finlandese Herman Spöring, dai disegnatori Sydney Parkinson e Alexander Buchan e da quattro servitori. Non mancano due levrieri, caso mai nelle pause ci fosse l'occasione di praticare lo sport della caccia! Quando salpano da Plymouth, è il 26 agosto 1768; quando getteranno nuovamente l'ancora in acque inglesi, dopo aver circumnavigato il globo e aver scoperto un nuovo continente, saranno trascorsi quasi esattamente tre anni (12 luglio 1771).  Alla scoperta della flora del quinto continente La prima tappa del viaggio è Madeira: Banks, Solander e la loro squadra ne approfittano per esplorare l'isola; in sei giorni di permanenza raccolgono circa 700 esemplari. Il viaggio prosegue alla volta del Brasile; a Rio, mentre la nave viene caricata di acqua e provviste, il viceré rifiuta lo sbarco ai botanici, sospettandoli di spionaggio. Ma gli scienziati non si arrendono: oltre a corrompere i fornitori perché insinuino qualche bella pianta tra gli ortaggi, di notte lasciano più volte la nave alla chetichella per andare ad erborizzare. Da Rio si prosegue lungo la costa americana, raggiungendo il Pacifico dopo aver doppiato il tempestoso Capo Horn. Nonostante qualche perplessità, Cook si fa convincere dai "gentiluomini passeggeri" a sbarcare nella Terra del fuoco per un'escursione botanica; quella che all'inizio si presenta come una piacevole gita, a causa del mutevole clima patagonico si trasforma in una tragedia: Solander rischia di morire di ipotermia e due servitori di Banks perdono la vita. Ma è ora fare vela per Tahiti (scoperta giusto un anno prima da un altro navigatore inglese, Samuel Wallis), il luogo scelto per le osservazioni astronomiche del transito di Venere. Dopo una lunga navigazione senza mai avvistare terra, la meta è raggiunta a metà aprile 1769. Nell'attesa dell'evento, i naturalisti esplorano estensivamente la natura dell'isola e, nelle pause, si rilassano con le amichevoli ragazze tahitiane. Venere si presenta all'appuntamento il 3 giugno, in una giornata serena che permette a Green, Cook, Solander di fare osservazioni e misurazioni indipendenti. L'unico neo del felice soggiorno tahitiano è la morte di Buchan, in seguito ad un attacco epilettico. Terminato il compito ufficiale, Cook apre finalmente il plico sigillato che contiene le indicazioni segrete dell'Ammiragliato: cercare l'ipotetico continente australe. Con a bordo un tahitiano di nome Tapua che funge da guida, l'Endeavour tocca le isole della Società (Cook le chiamò così non tanto in onore della Royal Society quanto perché sono molto vicine le une alle altre), quindi la Nuova Zelanda. Dopo aver circumnavigato l'isola (il bottino botanico è modesto perché poche sono le occasioni di sbarcare), Cook intende dirigersi a sud per cercare di ritrovare la Tasmania (toccata più di un secolo prima dall'olandese Tasman), ma a causa delle correnti è costretto a tenere una rotta più settentrionale. E' così che il 20 aprile 1770 viene avvistata per la prima volta la costa occidentale dell'Australia. L'Endeavour prosegue verso nord lungo la costa, finché trova un'insenatura adatta all'ormeggio. Banks, Solander, Spöring e i disegnatori possono sbarcare e iniziare l'esplorazione. L'episodio è notissimo: una flora e una fauna ricchissime e sconosciute si offrono agli stupefatti botanici, favoriti anche dalla stagione (è l'autunno australe, dopo la stagione delle piogge). I risultati sono così straordinari che Cook decide di ribattezzare il luogo dell'approdo (che inizialmente aveva battezzato Singray Harbour, baia delle razze) Botany Bay, baia della botanica. Per otto giorni Solander e Banks esplorano liberamente la zona, dalla riva paludosa alla foresta di eucalipti dell'interno, mettendo insieme un bottino così ricco che lo stesso Banks dispera di riuscire mai a classificare tutti quegli esemplari mai visti. Con la nave stipata di collezioni, i fortunati esploratori riprendono il viaggio, sempre facendo rotta verso nord, mantenendosi in vista della costa. Senza saperlo, si infilano nel labirinto (l'espressione è di Cook, che lo definisce "Insane labyrinth") della Grande Barriera Corallina e il'11 giugno sfiorano il disastro: la nave rimane gravemente danneggiata dall'impatto con le rocce coralline. Dopo una giornata di passione, riescono a raggiungere terra; i danni sono così gravi che sarà necessaria una sosta di due mesi per effettuare le riparazioni. Ma non tutto il male viene per nuocere: per i naturalisti è un'altra grande occasione per incrementare le raccolte. Riparata la nave, con una lenta navigazione tra gli isolotti e gli scogli della Grande Barriera, raggiungono il punto estremo, Capo York, dal quale fanno vela per l'isola di Giava. Dopo una sosta nell'isola di Savu (dove Cook sequestra libri, giornali e diari di bordo e fa giurare a tutti di mantenere segreta l'impresa), il 10 ottobre raggiungono Batavia, la capitale delle Indie Olandesi, dove la nave potrà essere messa in condizioni di affrontare il viaggio di ritorno. Cook è orgoglioso di non aver perso neppure un uomo a causa dello scorbuto che nei lunghi viaggi per mare spesso dimezzava l'equipaggio: anche se la causa del morbo, ovvero la carenza di vitamina C, non era ancora nota, è riuscito a prevenirlo imponendo ai suoi uomini e ai passeggeri una dieta variata con agrumi, crauti e verdure crude. Tuttavia proprio la sosta a Batavia è fatale: le condizioni igieniche sono pessime e molti uomini si ammalano di dissenteria e malaria. Muore un terzo dell'equipaggio, tra gli altri - alcuni a Batavia, altri durante il viaggio verso il Capo di Buona Speranza -Spöring, l'astronomo Green, il disegnatore Parkinson, il secondo ufficiale Hicks. Anche Solander e Banks sono in punto di morte, tanto che quando raggiungono il Capo non potranno approfittare più di tanto dei tesori naturali di quel secondo paradiso dei botanici. Ma il viaggio volge al termine: toccata sant'Elena, il 10 luglio 1771 avvistano le sospirate coste inglesi. Cook e Banks, ma anche il nostro Solander, sono gli eroi del giorno; per limitarci alla botanica le loro collezioni comprendono 30.300 esemplari di 3.607 specie, di cui 1.400 sconosciute, 110 nuovi generi. Si aggiungano uccelli, mammiferi, molluschi, pesci e altri animali marini.  All'ombra di Banks Solander non tornerà mai più in Svezia. Dopo la fortunata impresa e la ventilata partecipazione al secondo viaggio di Cook (vedremo nel prossimo post, dedicato a Banks, le ragioni per le quali i due rimasero a terra), rimane legato all'amico e protettore. Nell'estate del 1772 va con lui nelle Ebridi e in Islanda (quasi una gita, per chi aveva appena circumnavigato il mondo). In seguito, pur mantenendo l'incarico al British Museum, in qualità di bibliotecario di Banks si occupa essenzialmente di ordinare e catalogare l'immensa collezione raccolta durante il grande viaggio. In particolare sono di sua mano i testi che, accompagnando 743 incisioni tratte dai disegni di Parkinson, dovrebbero formare il grande Banks Florilegium. Purtroppo, l'opera non vedrà mai la luce: nel 1782, a 49 anni, Solander è improvvisamente stroncato da un'emorragia celebrale. Banks, preso da mille incarichi, nonostante il rimpianto per l'amico, non provvederà alla pubblicazione. Ciò nuocerà alla fama postuma di Solander che, soprattutto in Inghilterra, è stato a volte descritto come uno scienziato brillante, ma pigro, che si era fatto affascinare dalla dolce vita londinese fino a trascurare i suoi doveri scientifici. Hooker si spinse a definirlo un parassita che viveva alle spalle di Banks. Il lavoro di catalogazione per il British Museum e molti privati, la mole dei manoscritti, la stessa influenza scientifica sull'amico (che, forse, se non lo avesse mai incontrato, non sarebbe diventato il grande patron della botanica britannica) smentiscono questa interpretazione. Qualche approfondimento nella biografia. A celebrare Solander non mancano comunque i riconoscimenti postumi: il capo Solander (la punta più meridionale di Botany Bay), l'arcipelago delle Solander a sud della Nuova Zelanda, il parco Solander nella città natale Piteå (che ospita istituti scientifici e aziende a energia pulita); molte piante e animali con nome specifico solandri, solandranus, e ovviamente un genere Solandra. Anche qui c'è una piccola storia da raccontare. Il nome è stato assegnato ben tre volte. Non sono validi i nomi attribuiti da Linneo (Solandra capensis, attualmente Centella capensis) e Murray (Solandra lobata, oggi Hibiscus lobatus): in entrambi i casi, si tratta di specie di generi già noti, non di nuovi generi; ecco perché ad essere accettata è l'attribuzione di Swartz, che nel 1787 descrisse Solandra grandiflora. Anche Olaf Schwartz era svedese; nel 1787, al ritorno da una spedizione in Nord America e nelle Antille, soggiornò a Londra, dove conobbe Banks ed ebbe modo di consultare le collezioni di Banks e i manoscritti di Solander. La dedica di una delle piante da lui raccolte in America a Solander fu sia un atto d'omaggio alla sapienza botanica del suo conterraneo scomparso, sia un ringraziamento per la gentilezza e la generosità di Banks.  Le pericolose trombe d'oro del dio del vento Il mio primo incontro con la spettacolare Solandra maxima è avvenuto nelle Canarie, dove è stata introdotta nei parchi e nei giardini con tanto successo da naturalizzarsi in alcuni siti favorevoli. Mi piace pensare che le sgargianti trombe gialle di questa esuberante sarmentosa siano un omaggio fatto su misura per Solander; uomo amato da tutti, modesto e cordiale, vivace e pieno di spirito, definito dai contemporanei conversatore filosofo per la capacità di parlare in modo brillante di ogni argomento, dal più profondo al più frivolo, aveva una piccola debolezza: la passione per i panciotti un po' vistosi. Questa pianta, che probabilmente non ha mai visto, sicuramente gli sarebbe piaciuta. Il genere Solandra, appartenente alla famiglia Solanaceae, comprende una decina di specie di arbustive e sarmentose rampicanti originarie delle zone tropicali dell'America. Solandra maxima, nativa del Messico, era ben nota ai popoli precolombiani che con il nome di kieri o kieli la veneravano come pianta magica, utilizzata come potente droga per indurre viaggi sciamanici, grazie ai suoi effetti allucinogeni. Secondo gli indios huicholes era l'incarnazione del dio del vento; chi dorme accanto ai suoi fiori, sarà trasportato dalla sua fragranza in un regno di illuminazione mistica. In effetti, stretta parente di Brugmansia e Datura, contiene diversi alcaloidi, che la rendono un allucinogeno potente ma alquanto pericoloso. Meno rischioso dunque, là dove il clima lo permette, coltivare questa pianta per i suoi fiori spettacolari, grandi trombe dorate con strisce porpora che possono raggiungere il diametro di venti centimetri; con le lucide foglie lussureggianti, trasformerà qualsiasi pergola in un angolo dei Tropici. Altri approfondimenti nella scheda. La grande Caterina, per dare lustro alla scienza russa e conoscere le risorse dell'immenso territorio che governa, finanzia generosamente una grande spedizione, guidata dallo zoologo tedesco Pallas; tra i capi della spedizione, anche il depresso apostolo di Linneo Johan Peter Falk. Anche se il suo maestro pensava che il moto e l'amore per la natura fossero il miglior rimedio per il più nero degli umori neri, la ricetta con Falk non funziona. E lo studioso si rivelerà il peggior nemico di se stesso, più pericoloso del freddo siberiano e dei ribelli di Pugačev. 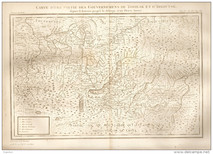 Il transito di Venere e la Spedizione dell'Accademia Nel 1761 e nel 1769, in occasione dei due "transiti" ravvicinati di Venere (ovvero dell'interposizione del pianeta tra la Terra e il Sole) le grandi monarchie europee organizzarono importanti spedizioni scientifiche. Fu anche uno dei primi casi di collaborazione scientifica internazionale, con il coinvolgimento di astronomi e scienziati di molti paesi. L'imperatrice di tutte le Russie Caterina II volle dare prestigio alla nascente scienza russa partecipando in grande stile all'impresa. Se nel 1761 nell'impero russo le osservazioni erano state deludenti a causa delle avverse condizioni atmosferiche, nel 1769 Caterina (che si era impadronita del potere nel 1762) non si fece cogliere impreparata: con un anticipo di alcuni anni, vennero predisposte le attrezzature e organizzate non una, ma una serie di spedizioni, in punti diversi del paese. Cinque furono concentrate nella durata e negli obiettivi, essenzialmente astronomici e geografici, ma la sesta (nata inizialmente come impresa collaterale) assunse proporzioni grandiose: gli scienziati avrebbero dovuto esplorare estensivamente la Russia orientale e meridionale, il Caucaso e la Siberia; oltre ad individuare i luoghi più favorevoli per l'osservazione del transito di Venere, avevano il compito di raccogliere quante più informazioni possibili sulle potenzialità economiche, gli usi e i costumi, le piante, gli animali e le ricchezze naturali dell'immenso impero russo. La grande spedizione venne organizzata dell'Accademia delle scienza russe, di cui coinvolse molti membri; a capeggiare l'impresa venne chiamato un brillante zoologo tedesco, Peter Simon Pallas, donde i due nomi con cui è nota: "spedizione dell'Accademia" e "spedizione di Pallas". Giunto a Pietroburgo all'inizio dell'estate 1767, Pallas impiegò un anno a pianificare accuratamente gli itinerari, la logistica e gli obiettivi scientifici, partendo tra l'altro dallo studio approfondito delle spedizioni precedenti, la più importante delle quali è la cosiddetta Grande spedizione del Nord degli anni 1733-1743. Venne deciso di suddividere l'esplorazione tra cinque corpi di spedizione indipendenti, tre dei quali avrebbero avuto come fulcro la regione di Orenburg (avamposto della colonizzazione della Siberia, sul fiume Ural) , la più promettente anche dal punto di vista economico; due la regione di Astrachan' (sul fiume Volga, da cui muoveva invece l'espansione verso il Caspio e il Caucaso). A capo di ciascun gruppo furono nominati prestigiosi scienziati, tutti stranieri con una sola eccezione; i tre gruppi di Orenburg furono guidati rispettivamente dallo stesso Pallas (che aveva anche il coordinamento generale della spedizione); da Ivan Ivanovič Lepëchin, russo ma formatosi all'Università di Strasburgo; da Johan Peter Falk, svedese e allievo di Linneo. I corpi di spedizione di Astrachan' furono capeggiati dal tedesco Samuel Gottilieb Gmelin e dal lettone Johann Anton Güldenstädt (suddito russo di lingua e cultura tedesca). Oltre a un numero variabile di servitori, cuochi, cacciatori, guide, li accompagnavano studenti e assistenti russi: il tal modo la spedizione fu anche un'eccezionale esperienza di formazione sul campo, da cui uscì un'intera generazione di scienziati. In corso d'opera, gli obiettivi si fecero più ambiziosi; dagli iniziali quattro anni, si passò a sette anni (1768-1774), con un ampliamento dell'area esplorata che si estese dal Mare del Nord al Caucaso, dal Volga alla Siberia orientale. Con una spedizione ottimamente pianificata da Pallas e finanziata da Caterina II senza badare a spese, i viaggiatori (almeno rispetto alle vicissitudine di tanti esploratori contemporanei) poterono far fronte con relativo successo alle indubbie difficoltà ambientali: il caldo torrido d'estate, il fango dopo il disgelo e dopo le piogge autunnali, ma soprattutto il proverbiale freddo siberiano; il termometro di Pallas gelò, mentre un assistente di Güldenstädt perse le dita dei piedi per assideramento. I pericoli vennero piuttosto dai fattori umani. Georg Moritz Lowitz, uno degli astronomi impegnati nell'osservazione del transito di Venere, incappò nella rivolta di Pugačev e fu impiccato dai ribelli; Gmelin fu catturato da un signorotto locale nella zona di Derbent (Dagestan) e morì in prigionia, mentre attendeva il pagamento del riscatto. Anche il destino di Falk, il dodicesimo apostolo di Linneo, si concluse in modo tragico.  Il difficile viaggio di Johan Peter Falk Quando venne decisa la spedizione, Falk si trovava in Russia da qualche anno in veste di dimostratore dell'orto botanico di Pietroburgo. Inizialmente non si pensò a lui: aveva già più quarant'anni e, soprattutto, praticamente da sempre soffriva di ipocondria e depressione. Soltanto alla fine dell'estate 1768, quando gli altri gruppi erano già partiti da mesi, si decise di aggregare Falk alla spedizione, probabilmente per la sua competenza botanica e in quanto allievo di Linneo; per classificare le specie vegetali si decise infatti di applicare il sistema sessuale linneano. Dopo aver trascorso l'inverno a Mosca, nel maggio 1769 Falk raggiunse Pallas a Samara e per due settimane viaggiarono insieme. Quindi Falk si mosse verso sud, lungo il Volga, toccando Syzran, Saratov, Carycin (Volgograd), dove svernò. Nella primavera, fu ricevuto dal khan dei calmucchi, stanziati a occidente di Astrachan'. Già a Samara aveva dato segni di depressione, risentendo negativamente della responsabilità di dover dirigere una spedizione scientifica, tanto che l'accademia delle Scienze decise di affiancargli un giovane chimico tedesco, Johann Gottlieb Georgi, che lo raggiunse nel giugno 1770 a Uralsk. Insieme i due si recarono ad Orenburg dove rimasero fino alla fine dell'anno. A quanto sembra, Georgi non poté fare molto per alleviare i problemi di Falk, tanto più che i loro rapporti erano abbastanza tesi (lo svedese sospettava il giovane collega di volersi impadronire dei suoi risultati scientifici). All'inizio del 1771, si separarono: Falk si mosse a est lungo la linea fortificata che proteggeva Orenburg dalle incursioni dei nomadi, mentre Georgi esplorò la Baschiria e gli Urali meridionali. I due si ricongiunsero a Čeljabinsk nella Siberia meridionale, dove Georgi trovò Falk ammalato. Quando si fu rimesso, insieme, sempre spostandosi verso est, raggiunsero Omsk. Da qui attraverso la steppa di Barabinsk si mossero verso gli Altai settentrionali, esplorando la zona mineraria di Barnaul. Quindi si diressero verso nord, raggiungendo Tomsk, dove intendevano trascorrere l'inverno. Le condizioni di Falk erano però sempre più compromesse; a Tomsk, Georgi ricette l'ordine di raggiungere la spedizione di Pallas che affidò al suo assistente Anton Valter il compito di accompagnare Falk a Pietroburgo. Da questo momento la spedizione-Falk venne sciolta e i suoi membri si aggregarono al gruppo di Pallas. Nella primavera del 1772, Falk iniziò il suo viaggio di ritorno, muovendosi con lentezza; a ottobre raggiunse Kazan, dove trascorse l'inverno; prima di proseguire per Pietroburgo, chiese e ottenne di potersi curare alle terme di Kizljar, apparentemente con buoni risultati. Tuttavia quando alla fine dell'anno rientrò a Kazan, le sue condizioni precipitarono: per settimane, fu costretto a letto, nutrendosi solo di tè e di pane svedese (avete presente quel pane croccante che vendono all'Ikea?), soffrendo di mal di testa, insonnia, crampi e dolori di varia natura che cercò di alleviare con l'oppio (l'uso del laudano, tintura alcolica di oppio, era a quei tempi abituale, veniva addirittura prescritto ai lattanti che soffrivano per la dentizione). Nel gennaio del 1774, quando lo ritrovò a Kazan, Georgi si trovò di fronte uno scheletro, con lo sguardo selvaggio, che quasi non parlava. Tuttavia, Falk sembrò riprendersi e quella che doveva essere la sua ultima giornata trascorse abbastanza calma, tanto che alla sera Georgi e un servitore, su sua richiesta, lo lasciarono solo. Ma al mattino li aspettava un macabro spettacolo: il cadavere di Falk ricoperto di sangue e sfigurato. Durante la notte si era tagliato la gola con un rasoio, quindi si era sparato alla testa. Nonostante i tormenti della depressione e le continue malattie, reali o immaginarie del povero naturalista svedese, sul piano scientifico la spedizione di Falk ottenne risultati rilevanti. Raccolse materiali etnografici sulla vita quotidiana dei Russi meridionali e sui popoli tatari, baskiri, kalmucchi e cosacchi. Si distinse nell'esplorazione delle risorse minerarie e nello studio delle acque, di cui diede anche una prima classificazione (che sarà perfezionata proprio da Georgi). Quanto alla botanica, mise insieme una notevole collezione della flora della steppa delle rive del Volga, degli Urali, della Siberia occidentale e dei dintorni di Kazan. Georgi, oltre a spedire a Pietroburgo i materiali raccolti da Falk, curò anche la pubblicazione dei suoi diari di viaggio (Beiträge zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs). Qualche notizia in più sull'infelice allievo di Linneo nella biografia.  Falkia, una tappezzante antidepressiva La pianta che onora la memoria di Falk non arriva dalla Siberia o dalle steppe russe, ma dal Sudafrica. Ancora una volta fu Thunberg a dedicare al condiscepolo da poco perito tragicamente uno dei tanti nuovi generi che veniva scoprendo in quel paradiso dei botanici. Egli raccolse la pianta nel 1774 e la pubblicò nel 1781 in Nova genera plantarum (con la grafia Falckia); l'anno successivo fu pubblicata anche dal figlio di Linneo, a cui il genere è stato a lungo attribuito. Il genere Falkia, della famiglia Convolvulaceae, comprende tre specie, tutte africane. La più nota è Falkia repens, una tappezzante dalla graziosa fioritura che nei climi miti può essere utilizzata in alternativa al tappeto erboso, particolarmente apprezzabile in tempi di siccità e riscaldamento globale. Simile alla più nota Dichondra, meriterebbe di essere più conosciuta e coltivata: è adattabile a diversi tipi di suolo; cresce all'ombra come al sole; forma un denso tappeto verde, con graziose foglioline tondeggianti che assomigliano a orecchie (il nome afrikaans è infatti oortjies, "piccole orecchie"); può essere utilizzata anche come ricadente. E soprattutto, regala una pregevole fioritura di un delicato bianco-rosato. Se si considera che, al contrario del tappeto erboso, non occorre neppure falciarla, nessuna depressione a coltivare la Falkia! Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed