|
Intrepidi scienziati pronti ad ogni avventura, ricercatori entusiasti e instancabili raccoglitori di piante e animali. Così ci sono apparsi molti apostoli di Linneo; molti, ma non tutti. Göran Rothman, medico partito per il nord Africa in modo forse un po' improvvisato, non ha saputo (o potuto?) ricavare molto dal suo viaggio, a parte la rovina economica e una salute compromessa. Grazie a un caro amico, ha però lasciato il suo nome a una pianta bella tra le belle, la Rothmannia.  Un inconcludente viaggio in Nord Africa Göran (o Georg) Rothman, l'undicesimo apostolo, è quello di cui probabilmente sappiamo meno. Era figlio d'arte: suo padre Johan Stensson Rothman, medico e botanico, era stato insegnante di Linneo a Växjö ed era rimasto in ottimi rapporti con lui. Göran, dopo aver studiato scienze naturali e medicina ad Uppsala, era diventato un medico molto stimato. Quando nel 1773 l'inviato di Tripoli a Stoccolma Hagi Abdrahman chiese l'invio di uno scienziato svedese per condurre ricerche naturalistiche in Libia, egli propose la propria candidatura. Linneo era perplesso; avrebbe preferito qualcuno con maggiore esperienza di ricerca naturalistica sul campo e magari bravo a disegnare (in particolare, pensava ad Osbeck). Nonostante ciò, la candidatura di Rothman fu accettata; l'Accademia svedese delle Scienze avrebbe pagato una parte dei costi della spedizione, mentre al resto avrebbe provveduto Abdrahman. Accompagnato da quest'ultimo, Rothman lasciò Stoccolma nell'agosto del 1773 per un viaggio che doveva durare quasi esattamente tre anni. Mal progettata e improvvisata, tuttavia, la spedizione fu un fallimento. Gli aiuti finanziari e logistici promessi da Abdrahman non si materializzarono; Rothman arrivò a Tripoli in piena stagione delle piogge. Secondo quanto egli stesso scrisse a Wargentin, segretario dell'Accademia svedese delle scienze, quando finalmente iniziò le esplorazioni dei dintorni, fu deluso dalla sterilità di un territorio che poco aveva da offrire a un botanico (non posso non pensare: a meno che si chiamasse Forsskål!); il calore intenso, la paura dei beduini e l'indifferenza delle autorità gli impedirono escursioni a più ampio raggio. Solo dopo un anno gli si offrì la possibilità di accompagnare un fratello del Pascià in direzione dell'Atlante; non sappiamo nulla di questo viaggio, ma in una lettera Linneo depreca che Rothman non abbia potuto raggiungere le montagne. Nel 1775 intraprese una breve spedizione costiera. Intanto la situazione finanziaria si faceva sempre più insostenibile - anche se Rothman collaborava con il consolato svedese a Tripoli - tanto che scrisse all'Accademia delle scienze per ottenere un ulteriore finanziamento. Rientrò quindi a Stoccolma nel luglio del 1776. I risultati scientifici del viaggio furono modesti e lasciarono insoddisfatti tanto l'Accademia delle scienze - che riteneva non valessero la spesa sostenuta - quanto Linneo, che in una lettera scrive che tutte le piante raccolte da Rothman erano già note. Anche in patria la situazione finanziaria di Rothman rimase precaria; nel 1776 fu nominato assessore del Collegium medicum, un incarico che non prevedeva stipendio. Per mantenersi, mise a frutto le sue notevoli competenze linguistiche e un indubbio talento letterario, come traduttore di opere liriche, poesie e romanzi (ma anche, anonimamente, di materiali giornalistici). Tra le sue traduzioni più notevoli, il romanzo di Voltaire Zadig, il carme di Pope Lettere di Eloisa ad Abelardo, il libretto dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, scritto da Calzabigi. Il soggiorno in Tripolitania aveva per altro minato la sua salute; morì nel 1778, a soli 39 anni. Il suo diario di viaggio, rimasto inedito per oltre duecento anni, è stato recentemente pubblicato nell'abito del progetto dell'IK foundation sugli apostoli linneani. Qualche notizia in più nella biografia.  Rothmannia, ovvero "Chi trova un amico trova un tesoro" Non i modesti meriti scientifici, ma l'amicizia ha guadagnato a Rothman l'onore di essere ricordato da una pianta. Nel 1774, mentre egli si trovava in Tripolitania, il suo vecchio amico e compagno di studi Carl Peter Thunberg esplorava - lui sì, con enorme successo! - il Sud Africa; a maggio inviò all'Accademia delle scienze la descrizione di una bellissima pianta che propose di chiamare Rothmannia, "in onore di Göran Rothman, un mio vecchio amico, che, ho sentito dire, sta per partire per la Turchia" (insomma, un onore per meriti futuri, e pure sulla base di informazioni errate, anche se è vero che sulla carta la Libia apparteneva all'impero ottomano). Linneo abbozzò e nel 1776 Thunberg ufficializzò la denominazione nell'articolo Rothmannia, ett nytt orte-genus, "Rothmannia, un nuovo genere". Cosa ci sarà stato in comune tra la spettacolare Rothmannia capensis e il caro vecchio amico? Non lo sappiamo, ma così va il mondo, anche dalle parti della botanica: al dolce e geniale Löfling una minuscola Caryophyllacea dai fiori invisibili, al titanico Forsskål un'ortica e all'inetto Rothman la splendida Rothmannia! Rothmannia è un genere di una quarantina di specie della famiglia delle Rubiaceae, che comprende alberi fioriferi di distribuzione tropicale (Africa meridionale, Oceano indiano occidentale, Cina meridionale, Indocina e Nuova Guinea). La specie più nota è proprio quella descritta e battezzata da Thunberg, R. capensis; diversamente da molte Rubiaceae (pensiamo al nostro Galium) in cui le infiorescenze sono formate da fiori piccoli e numerosissimi, porta grandi fiori solitari che ricordano quelli della Gardenia. In effetti i due generi appartengono alla stessa famiglia e sono molto affini, tanto da aver posto a lungo problemi di classificazione; il figlio di Linneo ricollocò la Rothmannia nel genere Gardenia e fino alla metà del Novecento non è stata riconosciuta come genere separato (ecco perché in molti siti R. capensis è ancora designata con il vecchio sinonimo Gardenia rothmannia). Meno frequentemente coltivate della Gardenia, le diverse specie di Rothmannia sono tuttavia piante di grande bellezza, fortemente profumate e attraenti anche per il lucido fogliame sempreverde. Altre informazioni nella scheda.
0 Comments
Un filosofo illuminista radicale; un uomo ostinato che ha quasi sempre ragione ma è incapace di compromessi; un viaggiatore avventuroso; un pioniere dell'ittiologia; un cacciatore di piante instancabile; un linguista capace di imparare in poche settimane i dialetti della penisola arabica; il coprotagonista di un capolavoro della letteratura danese. Tutto questo è stato Peter Forsskål, il più scontroso ma forse il più affascinante apostolo di Linneo, che ha scritto nel suo diario di viaggio: "Per le scienze naturali, bisogna essere pronti anche a dare la vita". Lui la sua l'ha data, a trentun anni, e in cambio il suo maestro gli ha dedicato la pungente Forsskaolea. 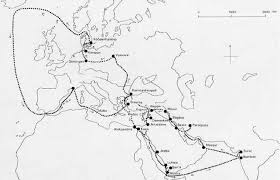 Dalla battaglia per la libertà di parola all'Arabia felice "Quanto più un uomo può vivere secondo le proprie inclinazioni, tanto più egli è libero. Per questa ragione, insieme alla vita stessa, non vi è nient’altro che sia più caro all’uomo quanto la sua libertà. Nessun essere dotato di ragione rinuncia ad essa o la limita a se stesso, a meno che non vi sia costretto dalla violenza o dal timore di un male maggiore." A scrivere queste parole non è Hume o Rousseau, ma un altro figlio dell'illuminismo, il finno-svedese Peter Forsskål, il decimo apostolo di Linneo. Naturalista, filosofo, ma soprattutto uomo libero, anch'egli morì giovanissimo nel corso di una spedizione naturalistica, ma ebbe la ventura di essere salvato dall'oblio da un grandissimo scrittore, il danese Thorkild Hansen. Nel 1962 Hansen, sulla base di molti documenti e in particolare delle lettere e dei diari dei suoi membri, scrisse Arabia felix, una ricostruzione romanzata ma non troppo delle vicende della sventurata spedizione danese in Yemen del 1761-67 che vide la morte di tutti i partecipanti, con una sola eccezione. Sebbene l'autore non nutra particolare simpatia per Forsskål sa fare emergere le ombre (l'ostinazione e l'arroganza) e le luci (l'amore per la giustizia e la verità, l'acuta intelligenza, l'instancabilità, la tenacia, la capacità organizzativa) dello scienziato svedese, ricostruendo un affascinante personaggio a tutto tondo. Una traduzione italiana di Arabia felix è stato pubblicata dalla benemerita casa editrice Iperborea. Dopo il deludente (almeno dal punto di vista di Linneo) viaggio di Rolander in Suriname, fino all'inizio degli anni '60 nessun "apostolo" fu coinvolto in una spedizione di rilievo. A dire il vero, nel 1758 quello che è considerato l'ottavo apostolo, l'estone Anton Rolandson Martin si era imbarcato su una nave baleniera ed aveva brevemente visitato le isole Svalabard; a sua volta Carl Fredrik Adler tra il 1748 e il 1761 in qualità di medico di bordo della Compagnia Svedese delle Indie orientali aveva toccato per quattro volte Canton (morendo nel corso dell'ultimo viaggio). Tuttavia nessuno dei due è ricordato da un genere di piante. Al contrario, il pugnace Forsskål fu tra i protagonisti di una grande spedizione che coinvolgeva tre università (Copenhagen, Uppsala e Gottinga) e, almeno sulla carta, avrebbe dovuto dare gloria alla Danimarca e al suo re, Federico V. Forsskål era probabilmente il più dotato tra i dotatissimi allievi di Linneo, e di certo il più versatile. I suoi interessi non si limitavano alle scienze naturali, ma includevano le lingue, la politica, la filosofia, l'economia. Dopo gli studi teologici e naturalistici a Uppsala, aveva studiato filosofia e filologia orientale a Gottinga; qui aveva trovato un'atmosfera ben più libera e stimolante di quella svedese. Nel 1759, al suo ritorno in patria, presentò una tesi di filosofia dal titolo De libertate civili in cui attaccava i privilegi e difendeva la libertà di pensiero e di stampa. Di fronte al rifiuto della facoltà, decise di pubblicarla a sue spese, in lingua svedese con il titolo Tankar om Borgerliga Friheten, "Pensieri sulla libertà civile". Nell'arco di ventiquattr'ore, la censura impose il ritiro e la distruzione dell'opuscolo; a eseguire l'ordine doveva essere il rettore della facoltà, cioè il nostro Linneo. Il previdente Forsskål, tuttavia, aveva già ritirato tutte le copie e le aveva distribuite ai suoi amici; Linneo - forse non troppo solerte - riuscì a recuperarne solo 79 su 500. L'atmosfera si era però fatta pesante per l'intrepido Forsskål - che d'altra parte non intendeva arretrare di un millimetro sulle sue posizioni - spingendolo ad accettare la proposta del suo professore di Gottinga, Michaelis, che aveva avanzato la sua candidatura come naturalista della spedizione danese in Yemen. Inizialmente riluttante (anche per la contrarietà del padre, che aveva già perso due figli), accettò a tre condizioni: il titolo di professore; una sostanziosa pensione vitalizia di cui usufruire in un paese a sua scelta; l'uguaglianza tra tutti i membri della spedizione (forse dettata, più che da amore per la democrazia, dal rifiuto di qualsiasi limite alla sua libertà). La corte danese sottoscrisse tutte le richieste e nel settembre del 1760 Forsskål raggiunse Copenhagen. Immediatamente il suo carattere impetuoso e alieno dai compromessi lo trascinò in un'ulteriore controversia; come medico della spedizione, venne nominato il neolaureato Christian Karl Kramer. Considerandolo del tutto inadeguato, Forsskål cercò di farlo sostituire da un altro allievo di Linneo, Johann Peter Falk, a suo parere molto più preparato di lui. Tuttavia si mosse con scarsa diplomazia e suscitò le ire del maestro di Kramer, il professor Kratzenstein (proprio quello che aveva aiutato il transfuga Rolander; la rivalità tra Uppsala e Copenhagen, a questo punto, è più che un sospetto!). Alla fine, i membri della spedizione furono sei, mal assortiti fin dall'inizio; due danesi, il professor Frederich Christian von Haven, in qualità di filologo, e Christian Karl Kramer, in qualità di medico; due tedeschi, il geografo e matematico Carsten Niebuhr e Georg Wilhelm Baurenfeind, in qualità di pittore; due svedesi, Peter Forsskål e il servitore Lars Berggren. I rapporti tra i due professori, von Haven e Forsskål, furono pessimi fin dall'inizio: uniti solo dall'alta opinione di sé, erano opposti per origine geografica e sociale, formazione culturale e carattere: un danese e uno svedese, un nobile e un borghese, un umanista e uno scienziato, un indolente e un iperattivo. Quali incidenti e quali scontri l'incompatibilità tra i due possano aver provocato in una convivenza forzata di quasi due anni e mezzo lo potete leggere nel libro di Hansen. Qui mi limito a sintetizzare l'itinerario: dopo aver raggiunto con una nave danese Costantinopoli (con brevi soste nei pressi di Marsilia e a Malta), il gruppo si imbarcò per l'Egitto, dove rimase circa un anno (prima ad Alessandria, poi al Cairo, infine nel Sinai); attraverso il Mar Rosso, si recò infine in Yemen, la meta principale della spedizione. Qui, a pochi giorni di distanza, i due professori morirono di malaria: il 25 maggio 1762 von Haven, l'11 luglio Forsskål; i superstiti si imbarcarono per Bombay, ma durante il viaggio in mare perirono anche Baurenfeind e Berggren; poco dopo lo sbarco in India, morì pure Kramer. Rimasto solo Niebuhr ritornò in Danimarca solo nel novembre del 1767 dopo un avventurosissimo viaggio a piedi attraverso la penisola arabica, la Persia e l'impero ottomano. Anche se l'obiettivo iniziale era soprattutto letterario-filologico, l'indolenza di von Haven e l'attivismo di Forsskål e Niebuhr spostarono ben presto il baricentro della spedizione sul versante geografico e naturalistico. Oltre alle importantissime rilevazioni astronomiche e cartografiche del matematico tedesco, anche le ricerche naturalistiche di Forsskål furono di grande rilievo: nell'arco di due anni e mezzo, raccolse oltre 2000 piante (di cui 693 nello Yemen); esplorò sistematicamente la fauna e la flora del Mar Rosso (fu tra l'altro tra i primi a cogliere la natura animale dei coralli); raccolse una massa di informazioni economiche e etnologiche (tra cui un'importante farmacopea cairota); descrisse per la prima volta piante oggi ben note come l'Adenium obesum. Il suo atteggiamento verso la cultura farmaceutica e naturalistica locale fu innovativo e rispettoso: quando individuava nuovi generi o nuove specie manteneva il nome locale, appena latinizzato per adattarlo alle convenzioni della nomenclatura binomiale: ad esempio, battezzò il qāt, un arbusto le cui foglie vengono masticate come stimolante, Catha edulis. Affidò le sue osservazioni al diario di viaggio ma anche a diverse opere scientifiche che furono preservate e pubblicate dopo la sua morte da Carsten Niebuhr (anche se purtroppo errori e refusi ne diminuirono il valore scientifico). I suoi studi sono considerai pionieristici nei campi della biologia marina, della migrazione degli uccelli, della distribuzione geografica delle piante e dell'iterazione tra piante e territorio. 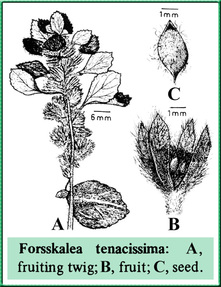 L'unico ricordo è un'ortica? Dopo la morte dell'allievo, Linneo ne onorò la memoria con la dedica di una delle piante che egli aveva scoperto. Me scelse una nata nell'orto botanico di Uppsala da semi che Forsskål gli aveva spedito dal Cairo e la chiamò Forsskaolea tenacissima, per ricordare la determinazione e la tenacia che il giovane allievo aveva dimostrato anche nelle situazioni più difficili. Ma forse la dedica non è così innocente; lasciamo la parola a Thorkild Hansen: "Linneo la battezza Forsskaolea e aggiunge le indicazioni descrittive tenacissima, hispida, adherens, uncinata. Quando Carsten Niebuhr sente di questa scelta, monta su tutte le furie [...]. Ma, anche se la scelta di Linneo non è causale, non è detto che quelle caratteristiche debbano essere ritenute così insultati come pensava Niebuhr. Linneo merita di essere elogiato piuttosto che scagionato. Non c'è niente da perdonargli. Non ha fatto che dire la verità. Conosceva Forsskål. Sapeva che non era tipo cui rendere omaggio con rose o orchidee. Né crescevano fiori ricercati sulla solitaria tomba nei pressi di Yerim. La memoria di Forsskål non poteva essere legata a un profumo, a bellezza; ma a qualcosa che corrode, che brucia. I quattro famigerati aggettivi - tenacissima, hispida, adherens e uncinata - significano tenacissimo, selvatico, caparbio e spigoloso. L'unico ricordo che sopravvive di Peter Forsskål, morto a Yerim nell'Araba Felice, la pianta Forsskaolea, è un'ortica". La conclusione di Hansen (come si conviene alla sua amara visione della vita) è forse troppo pessimistica. Intanto, i risultati scientifici di Forsskål sono oggi rivalutati e appaiono più incisivi ed importanti di quanto non sembrasse sessant'anni fa. Negli anni '70, il suo diario di viaggio è stato utilizzato come punto di partenza del ricercatore inglese John Wood che ha potuto ritrovare piante che non erano più state descritte da duecento anni. Buona parte della tassonomia dei pesci del Mar Rosso si basa ancora sui suoi studi. Anche la sua battaglia per la libertà non fu né donchiosciottesca né inutile se pochi anni dopo la sua morte la Svezia - primo tra i paesi europei - approvò una legge sulla libertà di stampa. In occasione del 250 anniversario della pubblicazione dell'opuscolo sulla libertà civile, l'Università di Gottinga ha voluto onorare Forsskål con una targa; gli sono stati dedicati convegni in Svezia, in Finlandia, in Danimarca e in Germania; è nato un sito dove potete trovare molto materiale su di lui e soprattutto il testo di Pensieri sulla libertà civile in molte lingue, tra cui anche l'italiano. Come sempre altre notizie nella sezione biografie. Quanto alla Forsskaolea, è davvero una cugina della nostra ortica, un piccolo genere delle famiglia Urticaceae di sole sei-sette specie, presenti in un'area che va dalle isole Canarie all'India occidentale attraverso il Nord Africa e il Vicino Oriente. F. tenacissima si è adattata a vivere dove ben poche altre specie sopravviverebbero: suoli aridi, sassosi, fessure tra le rocce. F. angustifolia è invece una specie endemica delle Canarie, dal portamento arbustivo, che non è difficile vedere visitando l'arcipelago. Altre informazioni sul genere Forsskaolea nella scheda. Forsskål è inoltre ricordato dal nome specifico di diverse piante (e animali) da lui descritti per la prima volta; tra le più notevoli Salvia forsskaolei, una salvia azzurra della penisola balcanica che Forsskål raccolse in Turchia. Dato che il suo cognome può essere scritto in vari modi, accanto all'epiteto specifico forsskaolei, si trovano anche forskalianus (come Sansevieria forskaliana) o forskohlii (come Coleus forkohlii, oggi Plectrantus barbatus, che a sua volta ha dato il suo nome alla forskolina, un integratore alimentare di moda). Per Linneo, i suoi apostoli erano davvero investiti di una missione sacra; attendeva con ansia le loro lettere, i semi, le piante, gli esemplari che gli avrebbero permesso di collocare al proprio posto un altro mattoncino del grande edificio del Systema naturae. Ma il settimo apostolo, Daniel Rolander, non gli permise di dare neppure un'occhiata al ricco bottino che aveva raccolto in Suriname. Da allora, per gli esegeti di Linneo, è un fallito, reso folle dal sole tropicale, un codardo irriconoscente; per dirla con Linneo, ingratus disciplus Rolander "l'ingrato allievo Rolander". 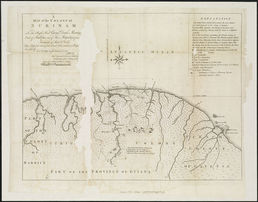 Il viaggio in Suriname Tra gli apostoli di Linneo, se Loefling, l'allievo prediletto, è Giovanni, allora Rolander è Giuda. I capi d'accusa contro di lui sono pesanti: infingardaggine, vigliaccheria, ingratitudine, follia, ubriachezza... Tuttavia nel 2008 la pubblicazione del suo Diarium Surinamense (rimasto manoscritto per oltre 250 anni) ha rimescolato le carte, tanto che viene di chiedersi se egli non sia stato piuttosto la vittima di una riuscitissima operazione di mobbing. Giudichiamo dai fatti. Nel 1754 alla corte di Svezia si presenta Carl Gustav Dahlberg, un ex militare che ha fatto fortuna in Suriname (Guyana Olandese), con una considerevole raccolta di esemplari botanici e zoologici che dona al re. Il personaggio entra in contatto con l'ambiente scientifico svedese, incluso Linneo. Quando fa girare la voce che intende assumere un giovane da portare con sé in Suriname come precettore delle figlie, Linneo propone il suo allievo Daniel Rolander: dato che di questo paese gli interessa soprattutto la fauna, in particolare gli insetti (tra cui la cocciniglia), Rolander, "entomologo fin dalla nascita", è la persona giusta. Dopo qualche titubanza l'affare va in porto; anzi Dahlberg, a sua volta appassionato naturalista dilettante, fa capire che - pur di lasciare il suo nome alla storia - il lavoro sarà una sinecura: Rolander potrà dedicarsi alle ricerche praticamente a tempo pieno. Linneo si dà da fare per raccogliere i soldi per il viaggio; tra i finanziatori, oltre a lui stesso, il celebre entomologo Charles de Geer. Nell'ottobre del 1754, Dahlberg e Rolander partono per l'Olanda, da dove si imbarcheranno per il Suriname. Tuttavia la partenza è ritardata da una malattia di Rolander; salpano solo nell'aprile del 1755 e giungono a Paramaribo in Suriname a giugno. Il loro arrivo coincide con una rivolta di schiavi neri; per circa un mese si fermano in città, per poi trasferirsi nella piantagione di Wajamo, di proprietà di Dahlberg. Veniamo al primo capo di accusa: secondo la vulgata linneana, in Suriname Rolander avrebbe combinato poco o nulla. In realtà, lavorò molto e con metodo: nel primo mese esplorò Paramaribo e i dintorni, poi per cinque mesi l'area della pianura, risalendo in barca fiumi come il Commevije e i suoi tributari e facendo tappa in diverse piantagioni. Infine, nel mese di gennaio 1756 tornò a Paramaribo, nelle cui vicinanze esplorò varie piantagioni. Si impose una ferrea routine: la giornata era dedicata alle ricerche, la sera alla preparazione degli esemplari e alla stesura degli appunti. I risultati furono imponenti per quantità e qualità, non solo nel campo dell'entomologia, ma anche della botanica; fu attento osservatore delle pratiche mediche dei neri e spettatore critico dello schiavismo. Mise insieme un erbario (raccoglieva molti esemplari per ciascuna pianta) che secondo un contemporaneo avrebbe potuto soddisfare tutti i botanici d'Europa. Fu tra i primi studiosi a comprendere il ruolo degli insetti nell'impollinazione delle piante. Quindi, l'idea di un Rolander instupidito dal clima tropicale che tralascia i suoi doveri è totalmente infondata. La seconda accusa è quella di codardia: Rolander sarebbe stato terrorizzato dai rumori, dai colori, dalla confusione e dalla violenza della natura tropicale; inoltre il timore di ammalarsi si sarebbe trasformato in un'ipocondria patologica. Qualcosa di vero c'è. In effetti, Rolander si era ammalato gravemente durante l'inverno trascorso ad Amsterdam; detestava il clima tropicale ed era molto critico sulle abitudini alimentari dei piantatori, in particolare quella di bere forte. La sua salute era malferma; un medico locale gli consigliò di cambiare mestiere; inoltre la paura di soccombere per una malattia tropicale non era così infondata, a giudicare dalla sorte degli altri apostoli. Se esplorò quasi esclusivamente le piantagioni, non fu per un terrore patologico degli animali della foresta, ma per la sollevazione degli schiavi fuggiti (maroon) che impediva di addentrarsi nel paese. Quando, dopo sette mesi, decise di rompere l'accordo con Dahlberg e di tornare a casa, la sua non fu quindi la fuga di un vile o di un folle ipocondriaco. In tono molto pacato, Dahlberg ne parla in una lettera a Linneo: "Quando gli ho chiesto di rimanere, prospettandogli la possibilità di esplorare le montagne, Rolander ha declinato accampando la cattiva salute, il clima ostile, la stanchezza per tanto lavoro, aggiungendo che ormai aveva visto tutto; forse pensa che il Suriname non sia così interessante come si crede". 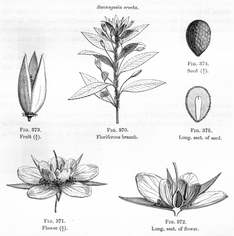 La rottura con Linneo e l'ostracismo Il viaggio di ritorno di Rolander fu complicato. Partito nel gennaio del 1757 da Paramaribo, il naturalista dovette fermarsi una decina di giorni nell'isola di St. Eustatius nelle Antille olandesi in attesa di condizioni favorevoli; sfruttò la sosta per integrare le sue raccolte con animali e piante dell'isola. Ad aprile era ad Amsterdam, ma sulla via di casa rimase bloccato per mesi ad Amburgo, ammalato e senza soldi. Solo ad ottobre riuscì a rientrare in Svezia, grazie al soccorso dell'Accademia delle Scienze svedese. Arriviamo così alla scena madre del dramma, e alla duplice accusa di ingratitudine e follia. Rolander e Linneo si incontrarono a Stoccolma; il maestro si offrì di ospitarlo a casa sua, ma l'allievo respinse l'offerta e gli negò l'accesso alle sue collezioni, promettendogli solamente il dono di un esemplare di Sauvagesia. Linneo, folle di rabbia, qualche giorno dopo si introdusse nell'abitazione di Rolander e sottrasse l'esemplare promesso. Ne seguì una rottura irrimediabile. Nelle biografie di Linneo, la colpa del fattaccio ricade sulle spalle di Rolander: la sua salute mentale, già vacillante in Suriname, sarebbe peggiorata, aggiungendo all'ipocondria la paranoia che lo induceva a sospettare di tutti, in particolare di Linneo (che, da questo momento in avanti, lo definirà "l'ingrato allievo Rolander"). Ma possiamo trovare motivazioni più razionali: probabilmente covava rancore verso il maestro che per mesi lo aveva abbandonato malato e senza mezzi ad Amburgo, mentre avrebbe potuto facilmente aiutarlo attraverso la sua potente rete di corrispondenti. Inoltre per Rolander, privo di mezzi e di appoggi familiari, l'unica risorsa erano le sue collezioni e il suo diario di viaggio: non era disposto a cederli per nulla, con il rischio che Linneo pubblicasse a proprio nome le scoperte che gli erano costate la salute e la giovinezza; in cambio voleva una cattedra universitaria o almeno risorse certe. D'altra parte Linneo considerava un suo diritto l'accesso alle collezioni dell'allievo che aveva formato, ospitato in casa sua e il cui viaggio aveva almeno in parte pagato di tasca propria. Dopo la rottura con Linneo, Rolander poté ancora contare su qualche appoggio. Inviò una cassa di insetti al barone de Geer e grazie a Abraham Bäck, medico, amico e corrispondente di Linneo, fu assunto come curatore del giardino dei semplici dell'ospedale Seraphim di Stoccolma. L'incarico avrebbe dovuto includere lezioni di medicina, ma Linneo avvertì Bäck che Rolander non ne aveva requisiti. Dopo qualche anno, vedendo che l'ostilità di Linneo impediva ogni carriera in Svezia, l'allievo ostracizzato si trasferì a Copenhagen. Neanche qui fu molto fortunato; dopo varie vicissitudini, grazie alla protezione di un professore tedesco, Christian Gottlieb Kratzenstein, riuscì a redigere il diario di viaggio (Diarium Surinamicum, quod sub itinere exotico conscripsit Daniel Rolander), ma non a farlo pubblicare. Alla fine per mantenersi fu costretto a cedere il diario a Kratzenstein e una parte dell'erbario a Rottboel, un altro botanico danese. Dopo il definitivo rientro in Svezia precipitò in una tragica spirale di indigenza e malattia, forse anche nell'alcolismo di cui lo accusa Linneo in una lettera del 1774. Qualche notizia in più nella biografia.  Una pianta e una cimice La condanna postuma (i latini la chiamavano damnatio memoriae) ha continuato a perseguitare Rolander per più di due secoli; solo la pubblicazione nel 2008 di una traduzione inglese del Diarium Surinamicum nell'ambito del progetto dell'IK sugli apostoli ne ha riabilitato la memoria, permettendo la lettura diretta di questo notevole lavoro. I risultati delle sue ricerche sono rimasti fuori della storia della scienza, anche se per fortuna solo in parte: grazie alla cassa di insetti spediti a de Geer, Linneo poté studiare e includere nella decima edizione del Systema naturae un'ottantina di insetti del Suriname. Il diario e gli erbari furono utilizzati da Rottboel per diversi lavori; in Descriptiones rariorum plantarum (1777) egli pubblicò 12 specie raccolte da Rolander in Suriname, e gli dedicò il genere Rolandra, della famiglia delle Asteraceae. Invece il rancoroso Linneo, non contento di aver impedito a quello che considerava un giuda qualsiasi carriera accademica, si vendicò ulteriormente dando il suo nome a una cimice, Aphanus rolandri (dal greco aphantos, "oscuro, ignobile"); insomma, non un nome onorifico, ma un insulto. La ricompensa floreale toccata al travagliato allievo maledetto è un modesto contributo alla sua memoria; è una pianta che egli stesso aveva raccolto in Suriname, Rolandra fruticosa, unica specie del genere, nativa delle Antille e dell'America centrale e meridionale, dall'Honduras al Brasile. E' un'erbacea o un suffrutice dotato di proprietà medicinali, sfruttate nella medicina tradizionale. Altre notizie nella scheda. Pehr Loefling, inviato in Spagna da Linneo su richiesta del segretario di stato spagnolo, sfrutta il suo incarico per esplorare a fondo la natura della penisola iberica. Il potente ministro lo sceglie per guidare e formare una piccola équipe di naturalisti che accompagnerà la grande spedizione che deve stabilire i confini ispano-portoghesi nell'area dell'Orinoco. Anche questa seconda avventura sarà ricca di risultati naturalistici, ma porterà Loefling a una morte precoce. La minuscola Loeflingia non è forse così inadeguata a ricordarlo. 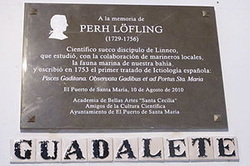 Alla scoperta della flora iberica Sesto apostolo di Linneo e terzo Pehr della serie, Loefling è non meno formidabile dei suoi omonimi Kalm e Osbeck. Ma ben più sfortunato di loro, bruciò la sua breve vita nel volgere di poche stagioni. Ragazzo prodigio, arriva all'Università di Uppsala a 15 anni e a 20 si laurea in medicina. Linneo ne fa il precettore di suo figlio, il poco dotato Carl junior, il proprio segretario, l'allievo prediletto; quando si presenta l'occasione di inviare un apostolo alla corte di Madrid, la scelta cade senza esitazioni su di lui. Il maestro gli fa un master accelerato di botanica e zoologia, gli amici si quotano per procurargli un microscopio e la necessaria attrezzatura, la Compagnia Svedese delle Indie Occidentali gli offre un passaggio gratuito per Oporto. Partito dalla Svezia nel marzo del 1751, il ventiduenne Pehr Loefling a maggio arriva in Portogallo; a Lisbona incontra l'ambasciatore spagnolo per prendere accordi sul suo incarico; in effetti, è il primo discepolo di Linneo ad essere assunto ufficialmente come scienziato stipendiato (gli spettano anche vitto e alloggio gratuiti). Quindi si mette in cammino; sulla strada per Madrid approfitta per erborizzare in varie località dell'Estremadura. A Madrid arriva ad ottobre; istruito anche in questo da Linneo, si reca quanto prima all'Escorial, per incontrare il potente ministro Carvajal, dal cui favore dipende la sua carriera in Spagna. Come si è visto in questo post, all'inizio l'ambiente madrileno gli è ostile; ma la competenza, l'amore per la scienza e la simpatia naturale gli conquistano il rispetto e spesso l'amicizia dei botanici madrileni. Oltre ai quattro che abbiamo già conosciuto, va aggiunto Miguel Barnades, un medico e influente botanico con il quale stringe amicizia e che lo accompagna nelle sue esplorazioni della flora spagnola. Nei due anni in cui soggiornerà nella capitale iberica, con l'aiuto dei colleghi spagnoli, che lo accompagnano, scambiano piante con lui, gli indicano i luoghi più promettenti, Loefling riesce a raccogliere circa 1300 esemplari (un dato imponente, se si pensa che l'intera flora spagnola comprende circa 6000 specie). Impara rapidamente lo spagnolo, tanto che scrive in questa lingua articoli scientifici che firma con il nome di Pedro; su richiesta di Carvajal traduce anche testi dallo svedese, tra cui un estratto del viaggio di Kalm sulle piante utili del Nord America. Lettere e frequenti invii di semi e piante secche mantengono il cordone ombelicale con Uppsala e il maestro. 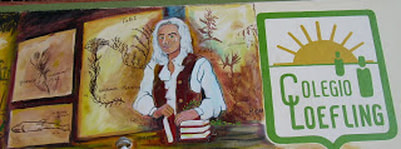 La expedicion de limites de Orinoco Nel frattempo, in seguito al trattato ispano-portoghese del 1750, Carvajal sta organizzando la spedizione che deve stabilire i confini sudamericani tra le due potenze (Expedition de limites de Orinoco, "Spedizione dei confini dell'Orinoco"); si tratta di un'impresa imponente, al comando del capitano di marina José de Iturriaga, che coinvolge soldati, geografi, cartografi, missionari; in una Spagna che sta scoprendo l'Illuminismo, non può mancare anche una componente scientifica. Il ministro pensa dunque a Loefling per capeggiare e istruire la piccola equipe di naturalisti che affiancherà a la spedizione. Lo svedese accetta e nell'agosto 1753, è ricevuto all'Escorial insieme ai suoi due assistenti, i medici neolaureati Benito Paltor e Antonio Condal, e ai due disegnatori Bruno Salvador Carmona e Juan de Dios Castel. Al conferimento dell'incarico, vengono elencati gli scopi scientifici della missione, che include la raccolta di esemplari di piante e di animali e la ricerca di piante utili, tra cui un possibile surrogato americano della cannella. Nel novembre, la piccola equipe botanica arriva a Cadice; Loefling approfitta della attesa, che si prolunga per motivi organizzativi e burocratici, per esplorare la flora e la fauna dell'area gaditana; particolarmente importanti le ricerche sui pesci, per le quali si avvale dell'aiuto e dell'esperienza dei pescatori locali. Finalmente, il 24 febbraio 1724, a bordo delle fregata Immaculada Concepcion e del vascello Santa Ana la spedizione parte per il Venezuela. Dal porto di Cumaná dovrebbero risalire il corso dell'Orinoco, attraversare l'area non navigabile dei raudales di Atures e Maipures, risalire il Caño Casiquiare, quindi raggiungere il rio Negro dove è previsto il ricongiungimento con la spedizione portoghese. Si tratta in gran parte di aree inesplorate e dense di pericoli. Dal punto di vista scientifico, è la prima delle numerose spedizioni che la Corona spagnola organizzerà nell'ultima metà del XVIII secolo; è anche la prima volta che, dopo avventurieri e missionari, uno scienziato esplora e descrive la flora e la fauna del Venezuela. Fin dall'arrivo a Cumaná, Loefling inizia a raccogliere i primi esemplari e a studiare gli animali della fascia costiera; in una lettera a Linneo, esprime il suo entusiasmo per l'esuberanza e i colori della natura tropicale. Per circa un anno, soggiorna in diverse località della costa (Barcelona, Piritu, San Bernardino, Tocuyo). In quest'ultima conosce il padre Antonio Caulin che lo aiuta nelle esplorazioni e lo assiste quando si ammala per la prima volta. Nel maggio 1755, mentre il resto della spedizione raggiunge in nave Guayana (base di partenza per risalire l'Orinoco), l'équipe dei naturalisti compie il viaggio via terra, attraversando la regione dei Llanos, allo scopo di raccogliere il maggior numero possibile di piante e animali; è un viaggio avventuroso e difficile, parte a piedi, parte in piroga, che li porta ad attraversare zone malsane. Molti di loro si ammalano. Inizia un periodo estremamente difficile per Loefling, che contrae la malaria con attacchi ripetuti di febbri, vomito, dolori addominali che spesso lo costringono a letto. Il 22 febbraio del 1756 (ha compiuto ventisette anni da pochi giorni) muore alla missione di San Antonio del Caroní, dove sarà sepolto ai piedi di un arancio. Con lui finisce anche la spedizione naturalistica: i suoi aiutanti disertano - come non capirli: a quel punto, oltre a Loefling, erano già morti metà dei membri della spedizione! - e i disegnatori si convertono in cartografi. Altre notizie sulla vita dello sfortunato naturalista nelle sezione biografie. Durante i due anni in Venezuela, Loefling raccolse una imponente collezione naturalistica e un erbario; scrisse note e inviò, quando era possibile, lettere al suo maestro. Alla sua morte, i materiali superstiti vennero spediti in Spagna; l'erbario, purtroppo, è perduto; arrivarono invece a Uppsala gli appunti. Integrandoli con le lettere da lui ricevute, Linneo redasse Iter hispanicum (pubblicato nel 1758), che raccoglie, oltre a una biografia dell'allievo, il diario dei suoi viaggi e diversi scritti di Loefling sulla flora e la fauna spagnole e venezuelane; inoltre si avvalse del materiale raccolto dall'allievo per le piante iberiche e venezuelane descritte in Species Plantarum e Systema naturae. Al Real Jardin Botanico di Madrid sono conservati altri manoscritti di Loefling e circa duecento disegni della spedizione dell'Orinoco, alcuni dei quali di mano sua. Chi volesse seguire più da vicino le tappe dei suoi viaggi, può curiosare nel blog bilingue (in spagnolo e svedese) Ruta Loefling, che comprende anche dettagliate Google Maps.  Della Loeflingia e di altre piante Per il Venezuela, l'ardimentoso allievo di Linneo è un piccolo eroe nazionale; a Ciudad Guayana gli sono stati dedicati un parco (vi invito a un tour virtuale grazie a Google maps: è un luogo meraviglioso che rievoca le sensazioni provate da Loefling alla scoperta del mondo tropicale), una delle vie principali e un collegio privato dove ogni anno viene celebrata una "Settimana Loefling", con attività naturalistiche e ecologiche. Ovviamente Linneo gli dedicò un genere Loeflingia (Species Plantarum, 1753) ma la scelta cadde su una piccola, rara Caryophyllacea della penisola iberica che può sembrare molto modesta per quello che era pur sempre il suo allievo prediletto e uno dei migliori naturalisti della sua generazione. In realtà la dedica va inquadrata nella strategia messa in atto da Linneo e Loefling stesso per vincere le resistenze nell'ambiente botanico spagnolo: essa affiancò la parallela creazione dei quattro generi di cui si è parlato in questo post a sottolineare l'appartenenza a un'unica comunità scientifica; a Loefling, come più giovane di tutti, toccava ovviamente la pianta meno appariscente. D'altra parte, la giustizia poetica della botanica ha creato inattesi legami tra Loefling e la sua pianta. Molti anni dopo la morte di Linneo, negli Stati Uniti fu individuata una terza specie, L. squarrosa, che si aggiungeva alle iberiche L. hispanica e L. baetica; così, come la carriera botanica del suo dedicatario, Loeflingia si distribuisce tra penisola iberica e America (anche se non più a sud del Messico). Inoltre la breve vita della pianta, un'annuale delle dune sabbiose che germoglia alle prime piogge di primavera e si dissecca nell'arco di poche settimane sembra una metafora della vita del dedicatario. Qualche approfondimento nella scheda. Tra le tante piante scoperte o descritte per la prima volta da Loefling, diverse, distribuite giustamente nelle due aree che esplorò, lo ricordano nel nome specifico: Plantago loeflingii, Bonellia loeflingii, Janipha loeflingii, Campanula loeflingii, Combretum loeflingii, Manihot loeflingii, Corynostylis loeflingii; naturalista completo, molto versato in ittiologia e entomologia, ha dato il suo nome anche alla falena Aleimma loeflingiana.  Un po' di gloria postuma: Condalia D'altra parte, Loefling non è stato l'unico membro della Spedizione dei confini dell'Orinoco a entrare nella nomenclatura botanica. Per i botanici spagnoli di fine Settecento, desiderosi di dimostrare la raggiunta parità scientifica della loro patria, come prima spedizione organizzata dalla monarchia iberica, essa assumeva un ruolo tutto particolare. Dunque i partecipanti spagnoli dovevano essere celebrati e ricordati, anche se, come abbiamo visto, dopo la morte di Loefling avevano abbandonato l'impresa e anche dopo non si erano segnalati in alcun modo. Fu così che nel loro Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus (1794) Ruiz e Pavón andarono a ripescare i due giovani medici, o più probabilmente studenti di medicina, che avevano accompagnato lo svedese come allievi e assistenti, entrambi catalani: Benedict Paltor (morto nel 1782) e Antoni Condal (1745-1804), dedicando loro rispettivamente Paltoria e Condalia. Qualche anno dopo, l'abate Cavanilles rincarò la dose, celebrando anche i due pittori Bruno Salvádor Carmona e Juan de Dios Castel, dedicatari di Carmona e Castelia. E per buon peso, aggiunse anche un secondo genere Condalia (suscitando per altro le ire dei due colleghi). Con una sola (e importante) eccezione, si tratta di generi oggi non accettati: Paltoria è sinonimo di Ilex, Carmona di Ehretia, Castelia di Pitrea. Condalia Ruiz & Pav. di Coccocypselum. L'unico genere attualmente accettato è dunque Codalia Cav, E per un oscuro medico catalano della cui vita dopo aver lasciato la spedizione - all'epoca avrò avuto circa ventidue anni - non sappiamo nulla, non è un omaggio da poco. Con una ventina di specie distribuite dagli Stati Uniti meridionali alla Patagonia, il genere Condalia, della famiglia Rhamnaceae, comprende arbusti spinosi nativi dei deserti e delle boscaglie xerofile dell'America subtropicale e tropicale. Di aspetto piuttosto vario, variano anche enormemente per diffusione: da una parte, abbiamo gli endemismi confinati in piccole aree, come la colombiana C. thomasiana, che vive solo in un'énclave arida della valle del Checua, nella regione andina di Cundinamarca; dall'altra, specie di vasta diffusione come C. buxifolia, che preferisce i suoli più umidi, e vive in habitat diversi in Bolivia, Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1751, l'arrivo a Madrid di Pehr Loefling, discepolo prediletto di Linneo, scuote lo stagnante ambiente della botanica spagnola. Finalmente nella capitale nasce un orto botanico, destinato a diventare la più importante istituzione botanica del paese; con tatto e consumata abilità diplomatica, Loefing riesce ad appianare le ostilità iniziali. Della sua strategia di avvicinamento fa anche parte la dedica da parte del maestro di quattro nuovi generi ad altrettanti botanici spagnoli. Ed ecco nate Queria (ma - ed è appena giusto - il nome non è più valido), Minuartia, Ortegia e Velezia.  In difesa dell'onore botanico della Spagna Nel Settecento, il progresso delle nazioni passa anche attraverso la botanica. Per la valorizzazione economica del territorio, è indispensabile la rilevazione delle risorse naturali, in primo luogo botaniche, tanto per un'agricoltura più produttiva e razionale quanto per una pratica medica e farmaceutica più efficace. Anche la nuova dinastia dei Borboni, installatasi in Spagna proprio all'inizio del secolo e riconosciuta dalle potenze europee nel 1714 con la pace di Utrecht, è coinvolta in questo processo. Sebbene il paese iberico nel Rinascimento fosse stato all'avanguardia nel campo della botanica, da almeno un secolo gli studi naturalistici sono stagnanti. Non mancano certamente né studiosi né investigatori sul campo, ma sono legati a modelli del passato: contrariamente a quanto è avvenuto almeno da un cinquantennio in Inghilterra come in Francia, in Olanda come in Svezia, la botanica in Spagna non è ancora una scienza autonoma, rimane un'ancella della medicina e anche più della farmacia (tutti i personaggi che incontreremo in questa storia sono farmacisti-raccoglitori, più che botanici). A metà del secolo, anche il modello teorico dominante, che è quello di Pitton de Tournefort, è decisamente superato. Ecco perché José de Carvajal, segretario di stato di Ferdinando VI, decidendo di aggregare una squadra di scienziati alla spedizione che doveva fissare i confini tra Spagna e Portogallo in America meridionale (Expedition de Limites de Orinoco) pensò di chiedere l'aiuto dell'astro delle scienze naturali europee, Carlo Linneo. Fu così che Pehr Loefling, giovanissimo e brillante allievo del luminare svedese, fu catapultato in Spagna, con il duplice compito di capeggiare l'équipe dell'Orinoco e di convertire i botanici spagnoli al metodo del maestro. Questo post è dedicato al secondo aspetto; un secondo sarà dedicato a Loefling e al suo contributo alla conoscenza della natura in Spagna e Venezuela. Il compito, per così dire diplomatico, del giovane naturalista svedese non era semplice: l'ambiente dei botanici spagnoli gli era decisamente ostile, e non senza responsabilità di Linneo stesso. Con il suo solito tono tronfio, nel 1736 in Bibliotheca botanica aveva dichiarato che la flora spagnola era tanto ricca quanto misconosciuta a causa dell'enorme "barbarie botanica" che imperversava nel paese. Ce n'era abbastanza per pungere l'orgoglio nazionale dei botanici spagnoli, in particolare del loro decano, José Quer y Martinez (1695-1764), che si affrettò a rispondere con un'apologia della scienza spagnola intitolata Discurso analítico sobre los métodos botánicos e rincarò la dose con il Catálogo de los autores españoles, que han escrito de Historia Natural in cui esaltò il contributo degli scienziati iberici alla conoscenza della flora e della fauna del nuovo mondo. Di fronte ai posteri, Quer ha pagato cara la sua ostilità a Linneo: medico e farmacista, era un ottimo raccoglitore e conoscitore di piante (il suo erbario, oggi conservato a Ginevra, comprende circa 2000 esemplari); tuttavia, mancava di metodo e si ostinò fino alla fine a non utilizzare la denominazione binomiale nella sua Flora española, che nacque già obsoleta. Di conseguenza, un po' ingiustamente è passato alla storia come il medico e botanico pasticcione e passatista che si è opposto a grande Linneo.  La nascita del Real Jardin botanico de Madrid Diversamente dal collega, un atteggiamento non pregiudizialmente ostile verso Loefling e Linneo assunse il secondo uomo della botanica iberica, il farmacista Joan Minuart (Quer e Minuart saranno rispettivamente primo e secondo professore di botanica al Real jardin botanico); in effetti, la botanica catalana era la più avanzata del paese, grazie soprattutto alla famiglia Salvador che aveva collaborato con Tournefort e i Jussieu e manteneva contatti con gli ambienti scientifici d'oltralpe. Anche Minuart, allievo di Jaime Salvador, si era formato nel credo tournefortiano, ma era un uomo di animo buono e aperto che fece un'ottima impressione su Loefling; ammise che il metodo di Linneo era molto interessante, ma non faceva per lui: era troppo vecchio per cambiare, e la sua vista ormai indebolita gli impediva di mettersi a contare cose così piccole come stami e pistilli. Altre notizie su di lui nella biografia. Erano ovviamente i più giovani a vedere nell'arrivo di Loefling, giunto a Madrid nel 1751, un'opportunità per svecchiare la botanica del paese. La favorevole circostanza spinse il farmacista reale Josè Ortega a proporre al ministro Carvajal la trasformazione in Hortus Regius del piccolo giardino botanico privato creato nel 1744 dal duca di Atrisco, a partire da semi raccolti nei suoi viaggi in Spagna, Italia, Francia. "Un orto botanico o una scuola reale di botanica - scrisse nell'esposto - introdurranno la deliziosa scienza nel paese e, di conseguenza, da una parte lavorerà il gruppo madrileno, mentre dall'altra lo svedese potrà far mostra delle grandi cose che offre". E' il primo passo per la fondazione del Real jardin botanico inaugurato nel 1755, a Migas Calientes, alla periferia di Madrid. José Ortega aveva una buona conoscenza dell'Europa perché il re Ferdinando VII lo aveva inviato in varie capitali europee per raccogliere informazioni al fine di creare una Reale Accademia delle Scienze. Accolse Loefling calorosamente e si mostrò assai aperto al metodo linneano: "il più affamato di tutti", lo definisce Loefling. Una vera amicizia nacque poi con Cristobal Velez, un quarantenne farmacista madrileno che aprì allo svedese la sua casa e la sua biblioteca; purtroppo morì precocemente nel 1753. Bisogna attendere però la generazione successiva per la definita affermazione del metodo linneano in Spagna, soprattutto grazie a Casimiro Gomez Ortega, nipote di José Ortega e figura eminente della botanica spagnola di fine secolo. Qualche notizia in più su Ortega e Velez nella sezione biografie. 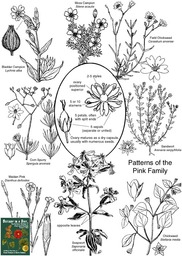 Minuscole piante spagnole Per vincere la resistenza degli spagnoli, oltre alla simpatia personale, alla pazienza e alla dimostrazione quotidiana della competenza come naturalista, che ne faceva un esempio vivente della validità del metodo del maestro, Loefling seppe anche sfruttare la vanità umana. Ormai la parola di Linneo negli ambienti scientifici europei aveva la pregnanza di un oracolo e ottenere la dedica di una pianta in Species plantarum (a cui stava giusto lavorando e che uscirà nel 1753) era la più o meno confessata aspirazione di tutti i botanici europei. In una lettera di quell'anno al medico e naturalista tedesco Ludwig, Linneo espresse grande entusiasmo per alcune "minutissimae plantae Hispanicae" (minuscole piante spagnole) che gli erano state inviate dall'allievo; e su suo suggerimento, le incluse nell'opera, creando i quattro generi Queria, Minuatia, Ortegia e Velezia. Oggi sono tutti annoverati nella famiglia Caryophyllaceae/Dianthaceae. Con una certa giustizia poetica, Queria è un nome non valido (le sue specie sono ora incluse Minuartia); Ortegia è un genere monospecifico con la specie O. hispanica; Velezia è un piccolo genere di due specie, V. rigida e V. quadridentata. Quindi, alla fine, l'omaggio maggiore è toccato al buon Minuart, con il genere Minuartia, uno dei più vasti della famiglia, ben conosciuto dagli amanti della flora alpina per i suoi cuscinetti di fitte foglioline che ricordano il muschio, trapuntati dalle minute stelline bianche dei fiori. Per maggiori informazioni sui tre generi, si rimanda alle rispettiva schede. L'aspetto del mondo dipende anche dagli occhi che lo guardano. Due allievi di Linneo, Olof Torén e Pehr Osbeck, si trovano nello stesso momento in Cina e percorrono la stessa rotta nel viaggio di ritorno, ma uno ne ricava (oltre alla malattia mortale di cui sarà vittima) qualche curiosità etnografica e ben poche osservazioni naturalistiche, l'altro riempie la sua cassa da marinaio con decine di esemplari e dà un contributo fondamentale alla conoscenza delle piante cinesi, di cui diventa la principale fonte per Species Plantarum di Linneo. Torna a casa con le tasche vuote, ma si guadagna il diritto di essere ricordato dall'Osbeckia, una pianta bella e misconosciuta quasi come il suo dedicatario.  Mentre gli altri giocavano, io esaminavo le erbe Pochi mesi dopo Olof Torén, iniziava il suo viaggio verso la Cina Pehr Osbeck, il quinto apostolo di Linneo. Infatti nel 1750 la SOIC (Compagnia Svedese dell'Indie Orientali) aveva deciso di raddoppiare la posta, inviando due navi alla volta della Cina: oltre alla Götha Leijon, partita in primavera per sperimentare la nuova rotta con scalo a Surat, in inverno salpò la Prins Carl che seguì la consueta rotta diretta. Il suo cappellano era un altro allievo di Linneo, appunto Pehr Osbeck. Nell'estate e nell'autunno del 1751 entrambi i vascelli erano a Canton e fecero insieme il viaggio di ritorno. Al contrario di Torén, che raccolse pochi esemplari e lasciò come testimonianza solo alcune lettere al maestro, Osbeck seppe sfruttare quella che lui stesso probabilmente considerava la grande avventura della sua vita, mettendo insieme una collezione naturalistica stupefacente per grandezza e qualità: oltre 500 piante (tra cui 26 specie e due generi descritti per la prima volta) oltre a centinaia di uccelli, pesci, insetti, minerali. Il documentatissimo Dagbok öfwer en ostindisk Resa åren 1750, 1751, 1752 ("Diario del viaggio nelle Indie Orientali", pubblicato nel 1757), steso sulla base del diario di viaggio poco dopo il ritorno a casa, riesce ad unire la precisione delle descrizioni naturalistiche al fascino dell'avventura, conditi da un pizzico di ironia. Tra l'altro è una delle prime opere in cui vengono utilizzate le denominazioni binomiali, riprese dalla recentissima prima edizione del Systema Naturae (1753). Lo stesso Linneo sarà stupefatto dei risultati del viaggio dell'instancabile Pehr, tanto da chiedersi come avesse fatto a raccogliere così tanti esemplari in così poco tempo. La spiegazione sta nella curiosità e nell'attivismo di Osbeck. In effetti, dice lui stesso nella prefazione, in un viaggio così lungo, terminate le incombenze ordinarie ("leggere le preghiere della mattina e della sera, confessare, somministrare la cena del signore, catechizzare, visitare gli infermi, officiare i funerali, predicare la domenica e i giorni di festa") gli rimane molto tempo per lo studio. Durante i lunghi mesi di navigazione ci sono pesci, uccelli, alghe; un'eclissi di luna all'andata e una di sole al ritorno; i crostacei rimasti attaccati all'ancora, l'acqua di mare fosforescente e persino i parassiti che guastano l'acqua e i viveri di bordo sono ottimi oggetti di studio. Lo dirà in alcuni versi tracciati nel registro della parrocchia dove servirà al ritorno in patria: "Gli altri bevevano, io rimanevo sobrio; gli altri dormivano, io vegliavo; gli altri giocavano, io esaminavo le erbe; quando gli altri sono morti, ho pensato alla morte, ma ora non mi fa paura". Appassionato di ogni ramo delle scienze naturali, ma soprattutto botanico, quando è a terra Osbeck sa approfittare al massimo delle soste, brevi o lunghe che siano. A parte la Cina, nel corso del viaggio il vascello attracca solo quattro volte, due all'andata e due al ritorno. Il primo lungo scalo è a Cadice, dove gli svedesi si fermano per dieci settimane. Appena può, indossati abiti spagnoli per non dare nell'occhio, un paio di forbici in tasca (l'uso dei coltelli era vietato dalle autorità), una scatola per gli insetti e fogli di carta per le piante sotto un braccio, il nostro animoso Pehr parte in esplorazione. E' incantato dai patios dove le passiflore crescono fino al secondo piano, dalle terrazze ornate di vasi di garofanini e violaciocche, dal profumo dei fiori degli agrumi "che farebbero resuscitare un morto", dai boschetti di Chamaerops humilis e dalle siepi di Agave americana, ma anche dalla più umile delle erbacce. Percorre la campagna esplorando i bordi delle strade, i giardini, le vigne, i terreni coltivati o gli incolti; un giorno, mentre sta tornando da Puerto de Santa Maria (una località a una decina di km da Cadice che ama esplorare, perché molto più ricca di acqua e di vegetazione dell'arido capoluogo) viene sorpreso da una pioggia torrenziale; nonostante la strada allagata, continua a osservare e a raccogliere piante. E' così che si imbatte in un'erba che non è mai stato descritto prima di lui: una rara solanacea oggi conosciuta con il nome di Triguera osbeckii. Quando arriva alla locanda, è bagnato fino alle ossa; giusto il tempo di cambiarsi ed è di nuovo in strada, insieme ad alcuni amici che vanno ad acquistare limoni. Il secondo scalo è a Giava, dove la nave, sia all'andata sia al ritorno, fa provviste d'acqua e viveri freschi. La vista delle rive fiorite dell'isola per Pehr è un supplizio di Tantalo: "fui costretto a languire come una persona affamata che vede il cibo solo da lontano". Quando la nave finalmente si ancora al largo, Osbeck si precipita a terra sulla lancia che va a caricare i rifornimenti, assicurando il comandante che ritornerà appena avrà bisogno di lui. La sosta è brevissima, ma Pehr potrà in parte rifarsi nel viaggio di ritorno, quando al seguito del carpentiere di bordo si addentra affascinato e turbato insieme nella foresta pluviale e studia attentamente le piante epifite che vivono sull'albero abbattuto: tra gli altri, un Asplenium nidus (è il primo a descriverlo) e l'orchidea Phalenopsis amabilis. Sulla spiaggia invece raccoglie bulbi di Crinum asiaticum, che trapianta nella sabbia e riesce a far arrivare vivi in Svezia. Persino la breve sosta alla brulla isola di Ascension (secondo scalo del viaggio di ritorno), giudicata da Osbeck il luogo più sgradevole che avesse mai visto, gli frutta la scoperta di un'ignota graminacea, Aristida adscensionis, oltre a una bella descrizione della riproduzione delle testuggini. Il mare dei Sargassi poi gli darà occasione di importanti osservazioni scientifiche.  Erborizzando a Wampoa Ma è ora di parlare del soggiorno in Cina. Alla fine di agosto 1751, la Prins Carl attracca all'isola di Wampoa, a una ventina di km da Canton (per i grandi velieri, il Fiume delle perle non era navigabile oltre quel punto). Qui venivano ancorate le navi europee e vivevano i marinai durante le lunghe e complesse operazioni di carico e scarico delle merci; gli ufficiali e gli agenti della SOIC soggiornavano invece a Canton, nella factory svedese situata nell'enclave europea. Qualche giorno dopo, arriva anche la Götha Leijon, proveniente da Surat. Il soggiorno in Cina di Osbeck dura poco più di quattro mesi, alternando periodi nella factory e sulla nave. In base alle regole della compagnia, quando due navi si trovavano insieme in Cina, un pastore rimaneva a officiare a Wampoa, mentre l'altro stava a Canton. Questo spiega perché Osbeck e Torén non abbiamo mai erborizzato insieme. D'altra parte, le personalità dei due non potevano essere più diverse. Se l'uno mette insieme ben pochi esemplari (di cui non documenta neppure la provenienza), l'altro nonostante le difficile condizioni in cui opera un cappellano svedese in Cina riesce a raccogliere ben 244 specie di piante cinesi (nonché animali e altre curiosità naturali), di cui 11 mai descritte prima di lui. Spinto dal suo attivismo, ancora una volta approfitta di ogni occasione. Quando è a Canton, visita mercati, giardini e farmacie - anche se le barriere linguistiche e la diffidenza dei cinesi gli impediscono quasi del tutto di raccogliere informazioni sulla farmacopea cinese. Quanto ai sobborghi della città e alla campagna fuori delle mura, è una missione quasi impossibile: sebbene formalmente non fosse ancora vietato agli europei allontanarsi dalla factory (il divieto verrà introdotto pochi anni dopo, nel 1757), farlo era già praticamente impossibile per i "diavoli stranieri". Osbeck ci prova più di una volta, ma appena fuori dall'area frequentata dagli europei è circondato da torme di bambini che urlano e chiedono soldi; un'altra volta si salva da un invasato che gli mette le mani addosso grazie a due ambigui personaggi, forse agenti di polizia; un'altra ancora, non avendo pagato la mancia pretesa, viene preso a sassate. Per altro non si arrende; approfitta persino del funerale di un alto funzionario olandese (gli unici a non essere seppelliti nei pressi di Wampoa) per osservare la flora del cimitero mentre si attende l'arrivo della salma. Molto più proficui sono i soggiorni sull'isola di Wampoa, dove gli stranieri potevano muoversi senza rischi; organizza anche brevi puntate nelle vicine isole dove attraccano le navi francesi e danesi. E' da qui che arriva la maggior parte degli esemplari raccolti; altri sono stati acquistati, come una Camellia japonica dagli splendidi fiori bianchi e rossi comprata da un venditore ambulante cieco che, a guardarla meglio, si rivela un imbroglio: i fiori sono stati presi da un'altra pianta e accuratamente fissati alle corolle con chiodi di bambù. Osbeck conclude filosoficamente che in Cina bisogna stare molto attenti e comunque è facile prendersi delle fregature... E quando tornerà in Svezia, non gli sarà rimasto un soldo: la già scarsa paga (Pehr ha scoperto che i suoi omologhi danesi sono pagati il triplo!) è stata investita in onore della scienza. La grande cassa acquistata in Cina - oggi è parte di una collezione privata - si riempie sempre più di preziosi esemplari secchi, di scatole di insetti, di animali conservati nel brandy spagnolo. Per la conoscenza in Occidente della flora cinese, il viaggio di Osbeck è una tappa fondamentale. Prima di lui, solo i missionari gesuiti - che per altro godevano di ben altre possibilità di muoversi nel paese, di cui parlavano la lingua e conoscevano profondamente la cultura - avevano fatto conoscere agli europei tante piante del Celeste impero. Gli esemplari forniti dall'industrioso allievo arrivano a Linneo appena in tempo per essere inclusi - sebbene solo in parte - in Systema plantarum: su un centinaio di piante asiatiche, almeno una settantina si devono presumibilmente a lui (anche se Linneo non sempre lo cita esplicitamente). In una sola cosa Osbeck delude il suo maestro: neanche lui riesce a portargli la tanto sospirata pianticella di tè. In realtà, il diligente allievo se ne era procurata una, ma andò perduta in modo tragicomico. Quando la Prins Carl finalmente salpa, il 4 gennaio 1752, tutti sono euforici e saltano sul ponte, mentre vengono sparati i rituali colpi di cannone; com'è come non è, il vaso di Camellia sinensis dal ponte scivola in mare prima che Osbeck se ne accorga e possa salvarlo. Sebbene avesse deciso di non fare altri viaggi, la vita di Osbeck dopo il ritorno in Svezia fu ancora lunga e attiva; altre informazioni nella biografia.  L'Osbeckia, questa sconosciuta Proprio in occasione della gita in cui Osbeck e i suoi compagni vengono soccorsi dai due poliziotti, scendendo da una collina dove hanno visitato una pagoda Pehr osserva un cespuglio dai bei fiori rossi che rimangono aperti di notte, che Linneo chiamerà Melastoma octandrum. Lì vicino trova un'altra pianta, simile alla prima per i fiori, ma diversa da ogni altro genere per l'aspetto generale. Linneo "ritenendo che le mie fatiche fossero meritevoli di qualche ricordo ha pensato di chiamare questa pianta Osbeckia chinensis". Entrambe le specie appartengono alla famiglia delle Melastomaceae, anzi oggi Melastoma octandrum L. è considerato sinonimo di Osbeckia octandra DC. Il genere Osbeckia comprende erbacee, suffrutici ed arbusti di una fascia tropicale che va d'India al Sud est asiatico, con qualche presenza in Australia. Alcune specie hanno proprietà medicinali. Sebbene si tratti di piante assai attraenti, sia per le foglie ovali profondamente venate sia i per i vistosi fiori con quattro o cinque petali dai colori vivaci (bianco, rosa carico, rosso) le Osbeckia sono poco note al di fuori dei paesi d'origine e raramente coltivate. Dunque, almeno per la fama postuma, lo sventurato e depresso Torén ha avuto più fortuna dell'attivo e vincente Osbeck. Ma forse è la pianta giusta per lui: intelligente, industrioso, ironico, di bella presenza, dopo il ritorno in patria visse una vita sempre attiva e proficua, ma lontana dalle luci della ribalta. Altre informazioni su Osbeckia nella scheda. Non come naturalista, ma come cappellano di bordo Olof Torén, il quarto apostolo di Linneo, si imbarca per l'India e per la Cina. Al servizio della Compagnia Svedese delle Indie Orientali, compie due viaggi con destinazione Canton, il secondo attraverso lo scalo indiano di Surat. Rientrato in patria gravemente ammalato, scrive sette lettere-relazione al suo maestro, ricche di notazioni etnografiche, religiose ed economiche più che naturalistiche. In suo onore Linneo battezza Torenia asiatica una piantina che gli ha portato dalla Cina.  Le rotte asiatiche della SOIC Nell'agosto 1749, proprio nei giorni in cui Peter Kalm toccava la sua meta in Canada, il terzo apostolo di Linneo Fredric Hasselquist partiva dalla Svezia alla volta dell'impero ottomano. Come abbiamo già visto in questo post, il suo viaggio era destinato a concludersi tragicamente. Il quarto apostolo, Olof Torén, era appena tornato dalla Cina e si apprestava a un secondo viaggio, che avrebbe pagato con la vita. Le piante cinesi continuavano ad esercitare il loro richiamo su Linneo - che sognava addirittura di acclimatare il tè in Svezia - e sull'Accademia svedese delle Scienze. Impensabile una vera spedizione scientifica come quelle di Kalm in America o di Hasselquist in Medio Oriente: i cinesi limitavano l'accesso agli europei alla piccolissima enclave della stazione commerciale di Guangzhou (meglio nota in occidente con il nome di Canton). L'unica via praticabile era aggregare un naturalista, come medico o cappellano di bordo, al viaggio annuale di una delle navi della Compagnia Svedese delle Indie Orientali che facevano la spola tra Gothenborg e Canton. La Compagnia Svedese delle Indie Orientali (SOIC, Svenska Ostindiska Companiet) era stata fondata nel 1731 a Gothenburg, ultima tra le grandi compagnie commerciali europee. Anche in Svezia bere il tè o possedere porcellane e lacche cinesi era diventato un irrinunciabile status symbol; l'importazione di questi prodotti, che raggiungevano la Svezia attraverso i commercianti inglesi o olandesi, pesava negativamente sulla già misera bilancia dei pagamenti del paese, grandemente impoverito da un secolo di guerre. Gli Svedesi cercarono così di inserirsi nel commercio verso la Cina (e in misura minore l'India) in modo da importare senza intermediari questi prodotti tanto desiderati. La SOIC nei sui 82 anni di vita (dal 1731 al 1813) organizzò 131 viaggi, con 37 vascelli. Ogni anno nell'arsenale della Compagnia a Gothenborg una o più navi erano addobbate per il viaggio. Si salpava intorno a gennaio o febbraio, con un carico di ferro e rame; la prima tappa era solitamente Cadice, dove questi metalli e altre merci erano scambiati con argento spagnolo che sarebbe servito per acquistare i prodotti cinesi: infatti i Cinesi non erano interessati alle merci europee, mentre le leggi svedesi vietavano l'esportazione d'argento. Dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, si arrivava allo stretto di Giava verso luglio o agosto; con il monsone favorevole, il viaggio verso la Cina richiedeva un altro mese. La meta finale era Guangzhou dove si trovava lo stabilimento (o factory) della Compagnia. Dopo una sosta di non più di quattro mesi, verso Natale si era pronti per il viaggio di ritorno, con le stive cariche di tè (da solo costituiva il 90% del carico), porcellane, spezie, sete e suppellettili (mobili, oggetti di lacca, tappezzerie). Facendo a ritroso la stessa strada, se non c'erano imprevisti, dopo 7-8 mesi, verso luglio o agosto, si era di nuovo a casa. In tutto 17-18 mesi; ma bastava qualche contrattempo per essere costretti a sostare per lunghi mesi in attesa del monsone favorevole ; e allora il viaggio poteva durare anche due anni e mezzo (un ritardo che si poteva pagare con la vita, come successe a Tärnström e a molti suoi compagni di viaggio). In queste condizioni, le possibilità di esplorazione per un scienziato, imbarcato come medico o cappellano di bordo, non erano molte. Senza contare gli impegni dovuti al suo incarico, il tempo passato a terra era in realtà ridotto a poche settimane. Per quanto riguarda la Cina, inoltre, gli occidentali erano rigorosamente confinati nelle factory ed era vietato viaggiare nell'interno del paese; per questa ragione, le prime piante cinesi conosciute in Europa furono essenzialmente specie coltivate che gli europei acquistavano attraverso i loro comprador (cioè i mediatori cinesi) nei grandi vivai che sorgevano nei pressi di Canton. 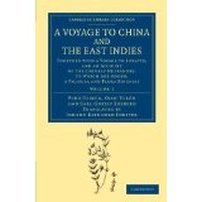 Le lettere-testamento di Torén Ma torniamo a Olof Torén e ai suoi due viaggi. Come Tärnström era stato ordinato pastore e fu assunto dalla SOIC come cappellano di bordo. Il primo viaggio, sulla nave Hoppet, durò dal gennaio 1748 al luglio 1749 ed ebbe come destinazione Canton; dovette svolgersi senza particolari intoppi, seguendo la rotta descritta sopra, ma Torén non ne ha lasciato alcuna documentazione. Siamo invece ben documentati sul secondo viaggio, perché Torén stesso ne riferì in sette lettere a Linneo, scritte poco dopo il ritorno in patria e pubblicate dopo la sua morte in appendice al giornale di viaggio di Pehr Osbeck. La rotta seguita fu in parte diversa; poiché i guadagni sembravano in calo, la Compagnia cercò di inserirsi nel commercio indiano, prevedendo uno scalo a Surat. Partita a febbraio 1750 da Gothenborg, la nave Götha Leijon si diresse alla volta di Madeira, dove fece brevemente scalo per approvvigionarsi di acqua e viveri; dopo aver circumnavigato l'Africa e aver toccato il Madagascar, raggiunse Surat, dove sostò cinque mesi. Quindi proseguì lunga la rotta consueta e raggiunse Canton, dove rimase sei mesi. Il viaggio di ritorno avvenne attraverso lo stretto di Giava e il Capo di Buona Speranza, con un breve rifornimento nell'isola di Ascension e rientro a Gothenborg nel luglio del 1752. Proprio nel corso del viaggio di ritorno Torén si ammalò, forse di tubercolosi, e morì dopo circa un anno. Qualche notizia in più nella biografia. Le lettere a Linneo furono scritte durante l'anno di malattia (l'ultima due mesi prima della morte) e forse questo spiega il loro tono rassegnato, malinconico. Le notizie di carattere economico, etnografico e religioso dominano, mentre le notazioni naturalistiche sono sorprendentemente scarse; niente escursioni in mezzo alla natura come quelle di Kalm! Gli animali e le piante di cui sui parla sono quelli che si possono vedere nei giardini, negli orti, nelle piazze cittadine, al massimo sui bordi degli abitati. D'altra parte, per la maggior parte del tempo, Torén è dovuto rimanere a bordo. A Surat, si lamenta, su cinque mesi di permanenza, ha trascorso a terra 23 giorni in tutto. Le uniche piante indiane citate sono il baniano (Ficus benghalensis) e un ibisco (Hibiscus surattensis) che cresceva nel giardino della factory svedese. Qualche pianta in più vede a Queda, nello stretto di Malacca: cita tamarindo, papaya e mangrovie. La parte dedicata alla Cina (e scritta quando la malattia era già molto avanzata) contiene soprattutto notazioni etnografiche ed economiche, con alcune pagine sulla coltivazione del riso e sui sistemi di irrigazione. Eppure in Cina Torén ha sicuramente raccolto qualche esemplare e si è procurato una pianta di tè (che tuttavia non è sopravvissuta al viaggio). 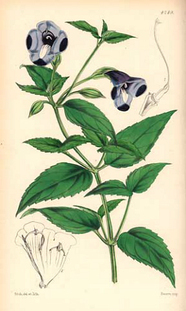 Le allegre fioriture estive della Torenia Almeno una pianta cinese raccolta da Torén è conservata nell'erbario di Linneo; arriva da Canton e, poiché era sconosciuta, lo studioso svedese (in Species Plantarum 1753) la battezzò in suo onore Torenia asiatica. Molte specie di questo genere sono originarie della Cina e del Sud est asiatico e vivono in terreni disturbati, vicino agli abitati; in base alla testimonianza di Osbeck, un altro allievo di Linneo che era in Cina contemporaneamente a Torén, la si trovava sia alla periferia di Canton sia a Wampoa, dove erano ormeggiate le navi svedesi. In ogni caso, ora il ricordo dello sfortunato quarto apostolo è preservato da una delle più graziose ed esuberanti regine dei balconi estivi. Il genere Torenia (un tempo famiglia Scrofulariaceae, ora Linderniaceae) comprende una cinquantina di erbacee di una fascia tropicale che va dal Madagascar al Sud Est asiatico - area in cui vivono i due terzi delle specie; la più comune in coltivazione è T. fournerii, una perenne sensibile al freddo coltivata come annuale. Con il suo portamento compatto, tendenzialmente ricadente, le foglie lucide e soprattutto le lunghissime fioriture è la pianta ideale per balconette e cestini appesi; negli ultimi trent'anni, grazie allo sforzo di grandi produttori di sementi statunitensi e giapponesi e agli ibridi creati quasi a getto continuo, la Torenia è diventata un'alternativa sempre più popolare a annuali più consuete. Come sempre, approfondimenti nella scheda. Verso la metà del Settecento, l'Accademia svedese delle Scienze decide di inviare un botanico esperto alla ricerca di piante da naturalizzare per il rilancio dell'economia del paese. La scelta cade su Pehr Kalm, botanico finnico preparato e di forte fibra; la meta, scelta con la consulenza di Linneo, sarà il Canada settentrionale. Per due anni Kalm erborizza da New York al Canada, scoprendo che il clima americano è più freddo di quello europeo alla stessa latitudine; raccoglie moltissime nuove piante e, finalmente placato il suo irascibile maestro, diventa il dedicatario del più ambito degli arbusti americani da fiore: la Kalmia.  Nuove piante per rilanciare l'agricoltura svedese Nel Settecento, la dottrina economica dominante è la fisiocrazia che vede nella produzione agricola la fonte della prosperità della nazione. In Svezia se ne fa portavoce il nobile Sten Carl Bielke che è convinto che il paese uscirà dalla sua cronica povertà se potrà raggiungere l'autosufficienza alimentare grazie a un'agricoltura più produttiva; l'introduzione di nuove specie di piante potrebbe essere la carta vincente. Se ne convince soprattutto dopo un viaggio in Russia, compiuto insieme a un promettente giovane botanico di origini finlandesi, Pehr Kalm, del quale ha finanziato gli studi. Membro dell'Accademia delle Scienze svedese, propone all'Istituzione di inviare Kalm in Siberia alla ricerca di piante adatte al clima scandinavo. A questo punto viene consultato Linneo che è entusiasta dell'idea, ma propone un'altra meta: l'America settentrionale. Le specie che stanno arrivando grazie agli importatori britannici sembrano molto promettenti, e, oltretutto, il viaggio costerebbe molto meno, tanto più che i contatti già ci sono e lungo il fiume Delaware c'è addirittura una piccola colonia svedese. E' d'accordo con Bielke che la persona ideale sia Pehr Kalm (suo allievo a Uppsala): gode di buona salute, è stato allevato in povertà e non ha grilli per la testa, sa adattarsi a tutto ed è un naturalista completo ed entusiasta. La decisione è presa, ma prima della partenza passano ancora mesi. Niente viene lasciato al caso: Kalm è nominato professore di "oeconomie" (cioè economia agraria) all'Università di Abo/Turku che coprirà una parte delle spese; Bielke gli procura un servitore, il giardiniere Lars Jungström; Linneo mobilita la sua rete di contatti in Inghilterra e America; l'ambasciatore svedese a Parigi si assicura la benevolenza del ministro della Marina francese. L'itinerario predisposto dall'accademia, insieme a dettagliate istruzioni, prevede come meta principale la baia di Hudson, alla stessa latitudine della Svezia e della Finlandia centrale. Kalm dovrà cercare soprattutto piante utili in agricoltura e in medicina: querce, sassofrasso, aceri, l'ambito Morus rubra (si sogna un'industria della seta svedese), il riso selvaggio da acclimatare nei laghi finlandesi; dovrà anche raccogliere da indigeni e immigrati europei notizie sugli usi di queste e altre piante utili. 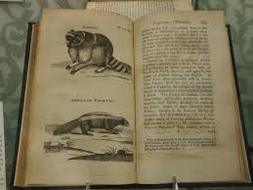 Da Goterborg a Filadelfia Così nell'ottobre del 1747 comincia il viaggio del secondo apostolo di Linneo. La prima tappa è Londra, dove Kalm deve incontrare i corrispondenti britannici del maestro che gli procureranno a loro volta lettere per i loro contatti in America. La sosta londinese si prolunga più del previsto: Kalm rimane a Londra sei mesi, che impiega a studiare inglese e a visitare le personalità più in vista della botanica e del giardinaggio britannici. Il contatto più importante è Collinson, botanico e mercante di piante, che durante il viaggio di Kalm farà da raccordo tra Uppsala e Filadelfia grazie alla sua rete di corrispondenti americani, primi fra tutti Benjamin Franklin e John Bartram. Finalmente nel settembre del 1748 Kalm arriva a Filadelfia; sarebbe sua intenzione partire immediatamente per il Canada, ma i suoi nuovi conoscenti locali lo informano che sarebbe inutile perché a Nord la vegetazione è giù dormiente. Fine osservatore, capisce che hanno ragione, tanto più che si rende conto che le piante tanto desiderate da Linneo sono abbondantissime in Pennsylvania; dotato di una notevole competenza meteorologica, comprende che la costa atlantica americana è molto più fredda di quella europea; propone addirittura di cambiare l'itinerario previsto: in primavera partirà in esplorazione, ma non si spingerà più a nord del New England, perché è in questa zona che si trovano le piante adatte al clima svedese. Inutile dire che Linneo va su tutte le furie: gli scrive delle lettere così sgradevoli che Kalm, con tutto il rispetto, gli chiede di evitare di svergognarlo così (le lettere, prima di arrivare a lui, passavano dalle mani di Collinson a Londra e di Bartram a Filadefia). Ma, come Garibaldi, ubbidisce. 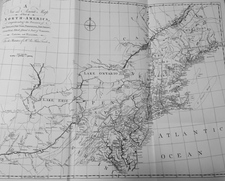 Le spedizioni botaniche Dopo aver trascorso l'inverno a Raccoon, una comunità svedese del New Jersey, Kalm e il servitore Lars nella primavera del 1749 partono alla volta del Canada. Da New York si dirigono a nord lungo il corso dell'Hudson fino ad Albany; toccano il territorio canadese al forte St. Frédéric. Con gioia, Kalm scopre che il lavorio diplomatico ha dato i suoi frutti: sono attesi e il governatore La Galissonière ha dato ordine che siano aiutati in ogni modo; il viaggio sarà a carico della corona francese; saranno accompagnati da guide locali, saranno a loro disposizione imbarcazioni e poi una carrozza; un piccolo esercito viene addirittura mobilitato per raccogliere semi e esemplari. Sempre spostandosi verso nord, Kalm esplora le rive del lago Champlain e del fiume Richelieu; ad agosto giunge a Québec, dove incontra più volte La Gallissonière, nipote di Bégon e come lo zio appassionato botanofilo. Per ordine del governatore, ora è accompagnato dal miglior botanico della colonia, il francese Jean François Gaultier, con il quale erborizza fino alla fine di settembre. Si rende però sempre più conto che il clima canadese è più freddo di quello svedese e incomincia a dubitare che le piante raccolte possano acclimatarsi in patria. Vorrebbe ancora visitare la zona dell'Ontario e sulla via del ritorno le cascate del Niagara: il permesso gli viene negato dal nuovo governatore generale La Jonquière (il disponibile La Galissonière è stato richiamato in Francia a metà agosto), a causa delle tensioni di frontiera tra francesi e britannici. Rientra quindi a Filadelfia per la stessa strada seguita all'andata. Anche il secondo inverno trascorre a Raccoon ed è allietato da una parentesi rosa: giusto a Capodanno del 1750 Kalm si sposa con Anna Margareta Sjöman, vedova del pastore della comunità. Approfitta della sosta per riordinare gli appunti e per spedire le prime raccolte di semi ed esemplari al collerico Linneo, che nel frattempo ha avuto modo di accusarlo di essere infingardo e parolaio. Nell'estate dello stesso anno riesce ad ottenere il sospirato permesso di visitare le cascate; ne trarrà un resoconto che sarà immediatamente pubblicato da Benjamin Franklin, suo ottimo amico. Ma è giunto il momento di tornare a casa; lasciata l'America nel febbraio 1751, dopo un viaggio tempestoso e un breve soggiorno a Londra, la giovane coppia rientra a Stoccolma alla fine di maggio, accolta a braccia aperte da Linneo. Ben a ragione: i risultati sono imponenti: dozzine di specie descritte per la prima volta (sono una novantina quelle che ricordano Kalm nel nome specifico), semi da acclimatare in Svezia e Finlandia, accurate descrizioni scientifiche di una zona nota agli europei ma mai prima esplorata con tanta competenza. Il diario di viaggio di Kalm En Resa til Norra America ("Un viaggio attraverso il Nord America"), presto tradotto in francese, olandese, tedesco e inglese, è importantissimo non solo per la storia naturale, ma anche come documento etnografico e storico; allo sguardo preciso dello scienziato, Kalm sa unire freschi tocchi poetici; innamorato della natura, è anche uno dei primi a cogliere l'impatto negativo della colonizzazione.  Da Kalm alla Kalmia: un onore reciproco Kalm sognava di scrivere una flora del Canada; a causa degli impegni universitari (se ne parla nella biografia) rinunciò al progetto, ma i suoi appunti fornirono a Linneo una fonte di grande qualità per le piante americane pubblicate nella prima edizione di Species Plantarum (1753). In questa opera il collerico scienziato dedicò a quello che a questo punto considerava il suo allievo prediletto un genere magnifico, Kalmia (Ericaceae), che comprende spettacolari arbusti da fiori nativi dell'America settentrionale tanto accuratamente esplorata dal suo dedicatario. Kalmia latifolia era già nota (ovviamente con altri nomi) in Europa; era tra le piante più richieste dalla ricca clientela di Bartram e Collinson e la dedica a Kalm suscitò qualche malumore. Linneo veniva accusato di distribuire nomi celebrativi tra amici e allievi secondo le sue personali simpatie. In questo caso, però, le polemiche sono davvero fuori luogo. Quella di Kalm è la prima descrizione scientifica della pianta, accompagnata da accurate notazioni etnografiche sui suoi usi pressi i nativi e esatte notazioni sulla tossicità delle foglie; ma è anche un inno alla bellezza della natura: quando è in fiore "la sua bellezza rivaleggia con quella degli alberi più belli", i suoi fiori rosa che sbiadiscono in bianco "assomigliano a coppe antiche". Egli considerava un particolare gesto di amicizia e gentilezza da parte di Linneo avergli dedicato una pianta così bella. Concordo con Diana Wells: "Si potrebbe pensare che è stata la pianta ad essere onorata da una così bella persona. Peter Kalm era una persona eccezionale e bella proprio come l'arbusto che lo celebra". Kalmia latifolia - approfondimenti sul genere Kalmia nella scheda - è stata scelta come simbolo vegetale del Connecticut e della Pennsylvania. Nel 2011 la Finlandia ha coniato una moneta commemorativa del viaggio di Kalm, che reca sul recto l'immagine della pianta e sul verso le cascate del Niagara. Indirettamente Kalm ha dato il nome anche un'altra Ericacea, Kalmiopsis ("simile alla Kalmia"), nonché agli ibridi intergenerici x Kalmiodendron (ibridi tra Kalma e Rododendron) e x Kalmiothamnus (ibridi tra Kalmiopsis e Rhodotamnus). Approfondimenti sul genere Kalmiopsis nella scheda. Da Uppsala, gli allievi di Linneo partono per esplorare il mondo; perfettamente addestrati dal loro maestro, sono in grado di studiare, descrivere, raccogliere, preparare e conservare gli esemplari di piante e animali che contribuiranno all'opera del loro mentore. Ma tra la metà e la fine del Settecento le esplorazioni scientifiche sono avventure pericolose: pochi di loro ritorneranno a casa. In un'isoletta del Vietnam finirà tragicamente il viaggio del primo di loro, Christoper Tärnström, che aveva sognato di raggiungere la Cina. Tardivamente, il figlio di Linneo lo compenserà con la dedica della Ternstroemia, una cugina della pianta del tè che lo sfortunato botanico avrebbe dovuto riportare dalla Cina.  Gli apostoli di Linneo Nel bel racconto "L'allievo inglese" (in Specie rare, Dedalo 2013) la scrittrice americana Andrea Barrett immagina un Linneo sulla soglia della morte nella cui mente offuscata realtà e visione, passato e presente si confondono. E, compagni per l'ultimo viaggio, gli appaiono i suoi apostoli morti, allegri, chiacchieroni, senza rancore per le loro giovani vite stroncate. E ognuno di loro reca in mano una pianta, quella che gli è stata dedicata e lo ricorderà per sempre. Con il nome mezzo serio mezzo faceto di "apostoli" Linneo aveva l'abitudine di chiamare i suoi migliori studenti che inviò nelle capitali europee a diffondere il verbo linneano e nei cinque continenti in spedizioni scientifiche alla ricerca di animali e piante. Prima di partire, lo scienziato svedese - ottimo insegnante - li sottoponeva a un training che faceva di loro perfetti naturalisti raccoglitori, anche attraverso brevi spedizioni propedeutiche; aveva predisposto un codice di comportamento a cui attenersi: dovevano evitare di ubriacarsi, giocare d'azzardo, parlare di politica e offendere i governanti stranieri; ogni sera dovevano tenere un diario delle loro osservazioni scientifiche; raccogliere, disegnare e descrivere le piante; predisporre un erbario; raccogliere, preparare e conservare gli animali; studiare i costumi locali, facendo tesoro di tutte le conoscenze mediche, farmaceutiche, agronomiche che potessero essere utili alla Svezia. E, last but not least, durante il viaggio se possibile, e sicuramente al loro ritorno, inviare gli esemplari raccolti a Uppsala, al caro maestro. Naturalmente non tutti gli allievi di Linneo diventarono apostoli; molti, la maggioranza di loro, dopo gli studi a Uppsala divennero medici, insegnanti e preti di villaggio; solo i più dotati, i più devoti alla scienza, ma anche i più tenaci entrarono nel novero degli eletti. Sui loro nomi e sul loro stesso numero le fonti sono divise: chi dice dodici (tratto in inganno dal riferimento evangelico), chi ventidue, chi di più ancora. La fonte più autorevole, l'IK Foundation, che ha curato la pubblicazione in una splendida veste editoriale dei loro diari di viaggio, ne individua diciassette. Nel sito dedicato www.linnaeus.org si trovano mappe interattive dei viaggi e dettagliate schede bio-bibliografiche di questi splendidi e coraggiosi scienziati. 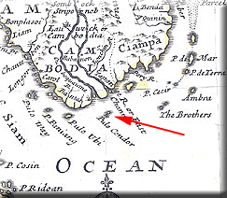 Il viaggio del primo apostolo Diversi per età, origini sociali, provenienza geografica, temperamento, avevano in comune un metodo di lavoro e una passione inesauribile per le scienze naturali che li sostenne nelle terribili prove che molti di loro dovettero affrontare nel corso di viaggi che li portarono dalla Svezia alla Cina, all'Australia, alle Americhe, dalle terre artiche ai deserti dell'Arabia. Su diciassette, sette morirono prima di poter ritornare in Svezia, due poco dopo il loro ritorno, uno perse la ragione. Il primo fu anche uno dei più sfortunati. Christopher Tärnström (1711-1746) era un pastore luterano appassionato di scienze naturali. Già trentenne, era tornato a Uppsala appositamente per studiare con Linneo (di cui era più giovane di solo quattro anni) benché fosse sposato e avesse tre bambine. Il suo desiderio più grande era partecipare a un viaggio naturalistico; il suo maestro era perplesso: sia perché lo considerava troppo vecchio sia perché era padre di famiglia. Ma cedendo alle sue insistenze lo aiutò a trovare un imbarco come cappellano della nave Calmar, appartenente alla Compagnia svedese delle Indie orientali, che il 13 febbraio 1746 partì alla volta del porto di Canton in Cina. Linneo affidò a Tärnström una lista di quattordici desiderata, che comprendeva dei ciprini dorati per la regina Ulrika Eleonora e una pianticella (o almeno dei semi) di Camellia sinensis per sé; oltre a raccogliere animali e piante, gli chiese anche di effettuare precise misure della temperatura. Ma il povero Christopher in Cina non arrivò mai: infatti, dopo un viaggio abbastanza agevole, in ottobre la nave dovette fermarsi ad attendere il monsone favorevole nell'isola di Pulo Condor (Con Son), sulla costa dell'attuale Vietnam. Tärnström ne approfittò per erborizzare, ma a novembre si ammalò di febbri tropicali; quando la nave finalmente salpò, era così grave che non poté partire e morì il 4 dicembre. Fu sepolto nell'isola con altri svedesi colpiti dalla stessa malattia. Notizie più dettagliate nella biografia. La morte del suo primo apostolo fu un duro colpo per Linneo e comportò uno strascico assai sgradevole. Infatti la vedova, Brita Tärnström, lo accusò violentemente di averla resa vedova e di aver lasciato le sue figlie orfane e senza sostegno. Per stornare queste accuse, in parte ingiustificate visto che Tärnström era partito di sua volontà, Linneo si sentì obbligato ad assistere finanziariamente la donna e le bambine; ma, per evitare simili complicazioni in futuro, da qual momento inserì la regola che per le spedizioni scientifiche sarebbero stati scelti solo giovani scapoli senza famiglia.  Ternostroemia, una cugina della pianta del tè Le ombre degli apostoli morti nel racconto di cui ho parlato all'inizio ostentano la pianta che è stata loro dedicata. In effetti, quasi tutti sono celebrati del nome di un genere; fanno eccezione solo Anton Rolandsson Martin, Fredrik Hasselquist e Carl Fredrick Adler. Il primo non ha lasciato contributi alla storia della botanica, perché il suo viaggio del 1758 aveva avuto per meta le gelide Spitsbergen. Federick Hasselquist tra il 1753 e il 1756 esplorò la Terrasanta alla ricerca delle specie citate nella Bibbia; morì durante il viaggio di ritorno, nei pressi di Smirne in Turchia. I materiali raccolti raggiunsero la Svezia e Linneo ebbe il doloroso compito di pubblicarli; gli dedicò il genere Hasselquistia, non riconosciuto (è sinonimo di Tordylium, un'Apiacea mediterranea). E' ricordato dalla specie Tordylium hasselquisti. Carl Fredrik Adler, uno degli apostoli più giovani, servì come medico sulle navi della Compagnia svedese delle Indie orientali e fece ben quattro missioni fino al porto di Canton; morì a Giava nel 1761, di ritorno dall'ultimo viaggio. Non gli è stata dedicata una pianta, ma una vespa delle galle (Adleria). Ma torniamo a Tärnström, il primo a partire e il primo a morire. Oltre a provvedere alla sua famiglia, il minimo che poteva fare Linneo sarebbe stato dedicargli una pianta. Ma non lo fece, forse per rancore nei confronti della combattiva vedova; a provvedere fu suo figlio Carl Jr. (Supplementa Acta Plantarum, 1791) sulla base di esemplari ricevuti da Celestino Mutis, capo della Real Expedicion Botanica del Nuovo Reino de Granada. Così il primo apostolo di Linneo, che avrebbe dovuto raggiungere la Cina per portare al suo maestro una piantina di tè, è celebrato dalla Ternstroemia, un albero o arbusto tropicale che, se non altro, fino a qualche anno fa era annoverato nella famiglia Theaceae (oggi è inserito in una famiglia specifica, Pentaphylacaceae, che ne è stata recentemente distaccata). E' un vasto genere diffuso in ampie aree tropicali e subtropicali di Asia, Africa e America; di grande valore ornamentale, le Ternstroemia sono coltivate per la bellezza sia delle grandi foglie coriacee sia dei fiori spesso raccolti in piccoli racemi. La specie più comune è Ternstroemia gymnanthera, originaria delle foreste dell'Asia orientale; questa ed altre specie sono presenti anche in Vietnam. Mi chiedo se Tärnström possa averne incontrata qualcuna mentre erborizzava nell'isola di Pulo Condor, che con il nome di Con Son sarebbe diventata tristemente famosa per aver ospitato un carcere ai tempi del colonialismo francese, poi della guerra del Vietnam. Oggi l'arcipelago di Con Dao, di cui Con Son è l'isola maggiore, è un sito riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità, sia per i fondali marini ricchi di specie rare sia per le foreste con 300 specie di alberi, tra cui 44 endemismi. Altri approfondimenti su Ternstroemia nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|
 RSS Feed
RSS Feed