|
Del medico veneziano Lionardo Sesler (o Leonardo, ma lui preferiva firmarsi nel primo modo) oggi ci rimangono un ritratto, un manoscritto copiato di sua mano, una lettera pubblicata nell'opera di un amico con la dedica di un nuovo genere - ormai ridotto a sinonimo - e poche notizie non sempre affidabili. Eppure intorno alla metà del Settecento il suo nome era noto anche al di fuori dei confini della Serenissima, e anche di più lo era l'orto botanico privato che aveva creato nell'isola di Sant'Elena, nel sestiere Castello. Fu il ricordo indelebile di quel giardino a spingere Scopoli a dedicargli il genere Sesleria, di casa nei prati aridi anche di casa nostra, divenuto così il suo ricordo più importante e concreto. 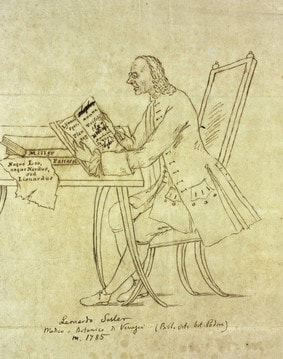 Un medico veneziano appassionato di piante Intorno al 1745 un giovanissimo Giovanni Antonio Scopoli giunse a Venezia, deciso ad approfondire lo studio della medicina e della botanica, alla quale aveva incominciato ad appassionarsi esplorando le sue montagne. Tra i luoghi che frequentava si può dire quotidianamente spicca il giardino che il medico veneziano Lionardo ( o Leonardo) Sesler aveva creato nell'isola di Sant'Elena, all'estremità orientale della città, così evocato dallo stesso Scopoli nella prima edizione di Flora carniolica (1760): "Nella nostra memoria rimane indelebile il giardino, di sovente visitato, bellissimo e ricchissimo di piante rare, creato a Sant'Elena dal dottor Leonardo Sesler, uomo sommamente curioso delle scienze naturali". In quegli anni a Venezia Sesler era senza dubbio una riconosciuta autorità per "l'osservazione e la coltivazione delle piante" (anche queste sono parole di Scopoli), ma le informazioni che ci rimangono su di lui sono poche e sfuggenti. Stando a Saccardo, la sua famiglia era di origini tedesche, ma nacque a Venezia, in quale anno non sappiamo. Mosé Giuseppe Levi nel 1835, dunque una sessantina di anni dopo la sua morte, riferisce che morì nel 1785 all'età di ben 102 anni; sarebbe nato dunque nel 1683, una data davvero improbabile. La data di morte è invece confermata tra l'altro da un suo ritratto a penna conservato nella biblioteca dell'orto botanico padovano, in cui lo vediamo intento a leggere un manoscritto con molte correzioni; sul tavolo di fronte a lui, due volumi, uno forse un testo medico di Falloppio, l'altro indubbiamente il dizionario di Miller, e un cartiglio che recita: "Neque Leo, neque Nardus, sed Lionardus" (Non sono né leone, né nardo [un animale e una pianta] ma Leonardo). Alto e segaligno, con gli occhiali, non è certo un ottuagenario; purtroppo però il ritratto non è datato e anche il Garden's Dictionary, con le sue 8 edizioni, non ci aiuta. Sempre secondo Levi fu medico molto stimato, specializzato in ostetricia (a questo potrebbe alludere il volume di Falloppio); presumibilmente si laureò a Padova e certamente fu legato a Giulio Pontedera, prefetto dell'orto padovano dal 1719 al 1757, visto che sempre nella biblioteca dell'istituzione patavina è conservato un manoscritto di mano di Sesler che consiste in una copia della prima parte del primo volume della storia dell'Orto Botanico di Padova dello stesso Pontedera. Se la data di nascita riferita da Levi fosse affidabile, i due sarebbero stati quasi coetanei (anzi il minore d'età risulterebbe Pontedera, nato nel 1688). C'è da dubitarne, se consideriamo che una seconda amicizia padovana ci porta a tutt'altra data: si tratta di Vitaliano Donati, con il quale Sesler potrebbe aver erborizzato in Veneto, Friuli e Istria negli anni '40. E proprio in appendice all'edizione olandese (1757) della Storia naturale dell'Adriatico di Donati compare l'unica opera edita di Sesler: la lettera nella quale egli istituisce in onore dell'amico il genere Vitaliana, sulla base di una pianticella da lui raccolta sul monte Pellegrino sopra Cividale (oggi Androsace vitaliana); la lettera testimonia anche la sua grande ammirazione sia per il giovane amico e la sua sensazionale scoperta della natura animale dei coralli, sia per Linneo, definito omnium naturalium rerum lumen fulgentissimum. Come si è visto, agli anni '40 ci riporta anche la testimonianza di Scopoli. Molte delle piante rare che egli notò nel giardino di Sant'Elena dovevano essere il frutto delle erborizzazioni di Sesler nei territori della Serenissima; la sua fama dovette però superarne i confini, tanto da essere citato anche da von Haller. Secondo Levi, quando Sesler fu nominato chirurgo dell'ospedale di San Pietro e Paolo, sempre nel sestiere Castello, vi trasferì il giardino, ma colui che gli successe nell'anno della sua morte "quasi cignale ne ha lo interamente guastato, poiché meglio gli piacque vedervi sorgere piante di frutta saporite". Difficile credere che Sesler mantenesse il "grave suo ufficio" (così lo definisce Levi) a 102 anni! Forse se gliene togliamo venti o trenta, i conti tornano di più... Sempre a Padova e agli anni '40 ci riporta infine una terza documentata frequentazione di Sesler: quella con l'abate Filippo Vicenzo Farsetti: il ricchissimo nobiluomo nel 1744 affidò all'architetto Paolo Posi il compito di trasformare la sua villa di Santa Maria della Sala presso Padova in una residenza degna di Versailles; il parco, progettato dal francese Charles-Louis Clérisseau, si arricchì di templi, laghetti, labirinti, parterres, boschetti. Ma Farsetti volle anche un orto botanico ricco di piante rare; Lionardo Sesler, stimatissimo "fiorista" (cioè esperto di piante anche ornamentali) fu il suo principale consulente; secondo alcune fonti ne fu addirittura il direttore o curatore, ma è difficile pensarlo, visto che continuava a risiedere a Venezia e ad esercitarvi molto attivamente la medicina.  Là dove fioriscono i prati di Sesleria Fu tuttavia il giardino di Sant'Elena tanto ammirato da Scopoli a fare entrare il medico veneziano nella lista dei dedicatari di generi botanici; il grato botanico trentino volle infatti dedicargli Sesleria, stabilito sulla base di una graminacea che cresceva copiosa nei luoghi sassosi nei pressi di Idrija (attuale Slovenia); Scopoli non le assegnò un nome specifico, ma potrebbe trattarsi di S. caerulea. Oggi al genere sono assegnate da 30 a 40 specie, una delle quali in Nord Africa, le altre diffuse dall'Europa all'Iran, con centro di diversità nei Balcani, dove ne vive circa l'80%. Ne è ben fornita anche la flora italiana, con una dozzina di specie, cinque delle quali endemiche: S. calabrica (Massiccio del Pollino e Catena dell'Orsomarso a cavallo tra Lucania e Calabria); S. italica (Appennini centrali e settentrionali, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria Marche e Lazio); S. nitida (Appennini centrali e meridionali, Sicilia); S. pichiana (Appennini settentrionali, con stazioni sparse dal Piemonte e dalla Liguria all'Emilia); S. x tuzsonii (endemismo del Monte Procinto nelle Alpi Apuane, possibilmente sinonimo di S. autumnalis). Specie pioniere dei prati aridi e rocciosi, soprattutto nelle aree montane, le Sesleriae sono le erbe dominanti dei seslerieti, talvolta insieme ai carici. Nelle Alpi, il seslerieto da Sesleria caerulea colonizza pendii aridi, scoscesi e assolati su substrati calcarei della fascia montana e prealpina ed è ricco di fioriture, con specie come Aster alpinus, la stella alpina Leontopodium alpinum, Potentilla aurea, Anemone alpina, Viola calcarata e l'orchidea Gymnadenia nigra (sin. Nigritella nigra). Insieme a Carex sempervirens costituisce il seslerieto-sempervireto. Negli Appennini, dove è presente dal piano montano a quello alpino in pendii fortemente aridi e lungo le creste esposte al vento, il seslerieto è dominato da S. juncifolia o da S. appenina, anch'esse con un ricco corteggio di compagne tra cui spiccano Pedicularis elegans subsp. elegans, Carex kitaibeliana, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Androsace villosa, Astrantia tenorei, Leontopodium nivale, Gentiana dinarica, Pulsatilla alpina subsp. millefoliata, Linum alpinum. Oltre a costituire la base dei tappeti di fiori multicolori che ammantano le montagne, le Sesleriae stanno entrando anche in giardino, per la robustezza, le scarse esigenze, e l'indubbio valore decorativo; quelle più facilmente disponibili nei vivai sono S. caerulea, apprezzata per i ciuffi sempreverdi di foglie glauche, e S. autumnalis, interessante anche per le spighette argentee prodotte a partire da settembre. Da Sesleria intorno alla metà del secolo scorso è stato separato il molto affine genere Sesleriella, con una o due specie di minuscole erbe rupicole delle Alpi orientali (Italia, Svizzera, Austria e Slovenia): si tratta di S. sphaerocephala, e forse da S, leucocephala, oggi per lo più considerata una variante cromatica della precedente. Altre notizie nelle rispettive schede di Sesleria e Sesleriella.
0 Comments
Per gli uomini del Rinascimento nati al di là delle Alpi, adottare uno pseudonimo classico era quasi un obbligo, soprattutto se il loro nome suonava barbaro a orecchie latine: così Philipp Schwarzerdt divenne Filippo Melantone, e, tra i botanici, Hieronimus Bock divenne Tragus e Jakob Dietrich di Bergzabern si trasformò in Tabaernemontanus. Giunto a Firenze negli ultimi anni del regno di Cosimo I, anche il "simplicista" (ovvero esperto di piante medicinali) Jodocus de Goethuysen adottò un nome più pronunciabile da bocche italiane, facendosi chiamare Giuseppe Casabona o Benincasa. Grande raccoglitore di piante, è noto soprattutto per un viaggio che nel 1590 lo portò a Creta, dove fece importanti raccolte. Al suo ritorno divenne prefetto dell'orto dei semplici di Pisa. E fu appunto uno dei suoi successori, il botanico fiorentino Gustavo Savi, a celebrarlo con la dedica del genere Benincasa (Curcubitaceae). 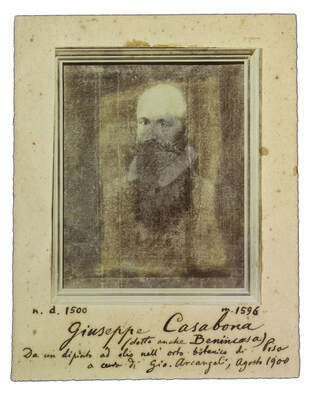 Un simplicista viaggiatore, dall'Italia a Creta Per i naturalisti del Cinquecento, l'Italia era la meta più ambita: era qui che i medici umanisti avevano riscoperto gli antichi, era qui che erano nati i primi orti botanici, era qui che una natura generosa elargiva tesori botanici a non finire, senza dimenticare che la penisola era anche il punto d'arrivo delle piante del Mediterraneo orientale, alcune delle quali vi si erano da lungo tempo naturalizzate. I collezionisti fiamminghi e tedeschi vi inviavano i loro emissari a cercare piante per arricchire i loro giardini; molti giovani medici venivano a perfezionarsi a Padova, o almeno a visitare i nuovi orti botanici, o magari ad erborizzare in luoghi presto celebri in tutta Europa come il Monte Baldo. Qualche "oltremontano", qualsiasi fosse il motivo che l'aveva portato in questa terra promessa della botanica, vi trovava lavoro e vi piantava radici. E' il caso del prussiano Melchiorre Guilandino, il secondo prefetto dell'orto patavino, e - con un percorso diverso - del fiammingo Jodocus Goedenhuyse (o Goethuysen), quinto prefetto di quello di Pisa. Non ne conosciamo la data di nascita e non sappiamo come e quando sia arrivato in Italia, forse adolescente. Al contrario di Guilandino, non era medico, anzi non possedeva una formazione né umanistica né universitaria: era un "pratico", un giardiniere e simplicista, ovvero erborista ed esperto di piante medicinali. Probabilmente intorno al 1570 (forse quindicenne) entra al servizio del nobile fiorentino Niccolò Gaddi, amico e consulente di Cosimo I per le sue collezioni d'arte, che possedeva un rinomato giardino noto come "paradiso dei Gaddi" per la ricchezza di piante e la raffinatezza degli ornamenti. Qui Goedenhuyse fa il suo apprendistato e incomincia a farsi chiamare con un nome meno ostico per bocche e orecchie italiane, Giuseppe Casabona, o anche Benincasa. Per incarico di Gaddi intraprende le prime escursioni botaniche che lo portano sul monte Pisano, nel Livornese e a Barga. Intorno al 1578, passa al servizio del granduca Francesco I, appassionato di chimica e arti sperimentali, lavorando dapprima nel giardino del Casino poi in quello detto "delle Stalle", ovvero nel giardino dei semplici fondato da Luca Ghini per Cosimo I. Ormai è un simplicista rinomato e per arricchire le collezioni ducali intraprende una serie di spedizioni sempre più a largo raggio: nell'estate-autunno del 1578 visita le Alpi Apuane, risalendo fino ai confini con la Liguria e il Piemonte; tra maggio e giugno 1579 è la volta di Grossetano, Argentario, Piombino e isola d'Elba, quindi nuovamente delle Apuane; nella primavera 1581 visita il Veneto (Padova, Bassano, Vicenza) spingendosi fino al Trentino; nell'estate 1583 un lungo giro lo vede in Garfagnana, nelle montagne del Parmense, sui colli Euganei, sul monte Summano, quindi a Padova e Venezia. Secondo Olmi, viene probabilmente anche coinvolto nelle "attività distillatorie" delle fonderie medicee, dove si producevano sostanze medicamentose sia per l'uso della famiglia granducale, sia come prestigiosi doni ai potentati d'Europa. Come abilissimo raccoglitore e scopritore di piante rare, che scambia all'occasione con altri studiosi (anche se sembra con una certa riluttanza) incomincia a corrispondere con naturalisti del calibro di Aldrovandi e Pinelli in Italia, Camerarius il giovane e Clusius al di là delle Alpi. Gli ultimi due lo mettono in contatto con il loro protettore Guglielmo IV di Assia-Kassel: forse non gli spiacerebbe passare al suo servizio, visto il misero stipendio e il crescente disinteresse per gli orti botanici da parte di Francesco I. Con l'ascesa al trono granducale di Ferdinando I, la sua situazione però migliora: il nuovo granduca fa costruire una comoda casa per il suo simplicista e la sua famiglia (sposato con una fiorentina, Casabona ne ha diversi figli) e il giardiniere-erborista fiammingo riprende a viaggiare, anche per rifornire i nuovi giardini di Villa Medici a Firenze: nell'estate del 1588 torna in Veneto per esplorare i monti dei territori della Repubblica, incluso il monte Baldo; tra i suoi accompagnatori, Girolamo Cappello, fratello della defunta granduchessa di Toscana Bianca, che gli fornirà l'occasione del viaggio a Creta. Nell'aprile 1590, lo troviamo all'orto botanico di Pisa, allora diretto da Lorenzo Mazzanga, forse impegnato in lavori che preludono al trasferimento nella nuova sede; nell'estate di quell'anno visita la Liguria, Monaco e Nizza, quindi si sposta a Venezia per affrontare il suo viaggio più importante: quello a Creta, ordinatogli dal granduca per "cercare le piante più eleganti e finora sconosciute in Europa e portarle a Firenze". Di passaggio a Padova, cerca di convincere il nipote di Camerarius, Joachim Jungermann, ad accompagnarlo. Ma il giovane tedesco (purtroppo per lui, visto che è destinato a morire mentre si reca a Costantinopoli) rifiuta. Casabona salpa da Venezia il 17 settembre 1590, imbarcandosi sulla nave che porta a Candia il nuovo governatore, appunto Girolamo Cappello. Durante il viaggio, esplora varie località costiere di Istria, Dalmazia e Albania, e il 22 novembre sbarca a Candia. Da quel momento, per quasi un anno, batterà l'isola in lungo e in largo, andando "per boschi et monti et circando simplici". Ne raccoglie più che può e alcuni li fa disegnare da Georg Dyckman, un mercenario tedesco al servizio della Serenissima che aveva qualche abilità artistica (ne rimangono 35 nel codice 464 conservato presso l'orto botanico di Pisa). Anche se l'erbario cretese non ci è giunto, siamo relativamente informati sulle sue attività grazie alle lettere inviate al granduca, a funzionari medicei, a diversi nobili personaggi di cui cerca i favori, ma soprattutto agli amici naturalisti Clusius, Camerarius e Aldrovandi. Di nuovo in Italia nel novembre 1591, l'anno successivo è nominato prefetto dell'orto di Pisa, anche se non è né medico né laureato: segno della grande stima in cui lo tiene il granduca, che gli affida il trasferimento delle piante nella nuova sede, quella attuale di via Santa Maria. Un lavoro spossante che si conclude nel 1595. Ne è testimonianza ancora il codice 464 che contiene 69 disegni a penna di attrezzi di giardinaggio e progetti di aiuole e labirinti. Casabona muore alla fine di quell'anno, dopo un ultimo viaggio autunnale in Corsica.  Zucche d'Oriente Fu il botanico fiorentino Gaetano Savi, prefetto dell'orto di Pisa a partire dal 1814, a voler ricordare il suo antico predecessore con la dedica del genere Benincasa (una forma alternativa del cognome italianizzato del nostro, molto meno usata di Casabona). Questo piccolo genere della famiglia Cucurbitaceae comprende solo due specie di zucche, diverse per dimensioni e caratteristiche ma entrambe coltivate e consumate in Asia. B. fistulosa (sin. Praecitrullus fistulosus), nota con il nome indiano tinda, ma anche come zucca indiana, zucca o melone tondo indiano, zucca mela, nativa dell'India e della Tailandia, è una liana annuale con foglie profondamente dentate e molto pelose che produce piccole zucche quasi tonde dal diametro di 4-8 cm, molto popolari in India e Pakistan come ingredienti di curry e altri piatti salati; se ne consumano anche i semi. Più importante nella cucina orientale è B. hispida, nota come zucca cerosa o zucca invernale, forse originaria di Malaysia, Nuova Guinea, Australia orientale e delle isole del Pacifico, ma introdotta in Asia orientale già in epoca preistorica; è particolarmente popolare in Cina. Come le altre zucche, anch'essa è una liana annuale a rapida crescita, che può raggiungere i 6 metri, con grandi foglie intere con cinque lobi poco accentuati, grandi fiori gialli maschili e femminili, questi ultimi seguiti da grandi frutti ovoidali, allungati o cilindrici lunghi anche 80 cm. Sono ricoperti di peli ispidi e urticanti, che una volta eliminati lasciano il posto a una superfice lucida e cerosa. La polpa è bianca, croccante, ma quasi insapore. Si conserva per molti mesi, da cui il nome zucca invernale. E' l'ingrediente di innumerevoli piatti nelle cucine orientali, sia salati come zuppe e stufati, sia dolci; in Cina i canditi di B. hispida sono consumati nelle festività del Capodanno e costituiscono il ripieno tradizionale dei mooncake. Tra gli scienziati venuti in Brasile al seguito dell'arciduchessa Leopoldina c'era anche un botanico italiano, il fiorentino Giuseppe Raddi. Giunto con gli ultimi e partito con i primi, la sua partecipazione fu breve, ma straordinariamente fruttuosa per quantità e qualità. Grazie alle raccolte brasiliane e agli studi che ne ricavò, Raddi divenne una figura assai riconosciuta a livello europeo, come testimoniano i vari generi che gli furono dedicati. I due che oggi sono ancora validi ci fanno conoscere alcuni inattesi bambù, compreso quello che è considerato il più piccolo del mondo. 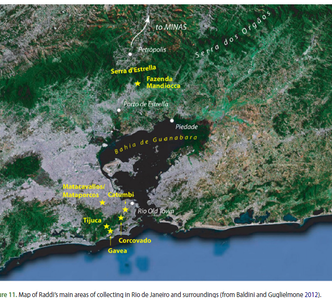 Dalle crittogame toscane alle piante del Brasile Gli Asburgo-Lorena erano assai legati alla Toscana. L'imperatore Leopoldo II, figlio cadetto di Maria Teresa d'Austria e Francesco Stefano di Lorena, per venticinque anni era stato granduca di Toscana (con il nome Pietro Leopoldo) e in Toscana erano nati ed erano stati educati i suoi figli, compreso l'imperatore Francesco II. Così fu del tutto naturale che nel suo viaggio nuziale alla volta del Brasile l'arciduchessa Leopoldina facesse tappa nella seconda patria della sua famiglia, dove fu accolta da suo zio, il granduca Ferdinando III. E fu proprio quest'ultimo a pensare che la partecipazione alla grande spedizione scientifica brasiliana avrebbe dato lustro al suo piccolo Stato. Tanto più che, per una volta, c'era la persona giusta al posto giusto. Nel 1817, Giuseppe Raddi aveva quasi cinquant'anni ed era uno studioso riconosciuto soprattutto come esperto di crittogame e funghi. Di modesta origine, si era avvicinato alla botanica grazie a Ottaviano Targioni Tozzetti, che aveva preso sotto la sua ala protettrice lui e l'amico d'infanzia Gaetano Savi. Nel 1785, a quindici anni, aveva incominciato a lavorare come assistente di Zuccagni al Giardino dei semplici di Firenze; dopo dieci anni di gavetta, era stato nominato custode del Museo di Storia naturale di Firenze. Assunto questo incarico, Raddi studiò il latino e le principali lingue europee e approfondì gli studi di botanica, dedicandosi soprattutto alle crittogame e ai funghi, un campo peculiare della botanica toscana nel quale si erano già distinti Pier Antonio Micheli (1679–1737), Giovanni Targioni Tozzetti (1712–1783) e il figlio di quest'ultimo Ottaviano. Le sue prime pubblicazioni, a partire dal 1806, sono appunto dedicate a nuove specie di crittogame e funghi scoperte nei dintorni da Firenze. Erano anni politicamente difficili. Nel 1799 l'esercito francese aveva occupato il Granducato, costringendo Ferdinando III all'esilio. Gli intellettuali si divisero tra filofrancesi e legittimisti; tra questi ultimi Raddi che nel 1808, con l'annessione della Toscana al Regno d'Italia e la soppressione del Museo, perse il lavoro. Nonostante le difficoltà economiche, continuò le sue ricerche e si mantenne in corrispondenza con importanti studiosi europei, compreso de Candolle, nonostante le opposte opinioni politiche. Il purgatorio di Raddi durò fino al 1814 quando Ferdinando III recuperò il trono e il botanico venne reintegrato nell'incarico di curatore delle collezioni scientifiche del Museo di storia naturale. In una situazione più tranquilla, poté così completare la sua prima importante monografia Jungermanniografia Etrusca (1817), dedicata alle crittogame toscane: un lavoro così importante che Nees von Esenbeck salutò Raddi "padre dell'epaticologia". L'opera fu presentata nel giugno 1817, poco prima dell'arrivo in Toscana di Leopoldina e del suo seguito; fu certamente essa ad attirare l'attenzione del granduca, che invitò Raddi ad unirsi alla spedizione in Brasile. Con strumenti, libri, mappe geografiche, ma senza alcun assistente, il botanico toscano si imbarcò sul San Sebastiano, uno dei vascelli portoghesi che dovevano condurre la principessa a Rio de Janeiro; salpata da Livorno il 13 agosto 1817, la piccola flotta austro-portoghese si fermò per pochi giorni a Madeira (11-13 settembre), dando modo a Raddi di raccogliere 150 specie di vegetali, compresa una nuova epatica; dopo 82 giorni di navigazione, giunse a Rio il 5 novembre. Subito dopo l'arrivo, il botanico toscano, oltre ai colleghi imbarcati sull'Austria, che si trovavano a Rio già da vari mesi, conobbe il console russo Georg von Langsdorff, che lo invitò a visitarlo nella sua fazenda Mandioca. Un altro incontro importante fu quello con il carmelitano Leandro do Santíssimo Sacramento, professore di botanica alla Real Academia de Medicina. Contrariamente ai colleghi austriaci e tedeschi, Raddi disponeva di un budget estremamente limitato. Il costo della vita nella colonia, anche a causa dell'arrivo della comitiva nuziale, era proibitivo. Non avendo abbastanza denaro per assumere aiutanti sul posto, egli dovette muoversi da solo, approfittando dell'ospitalità di amici brasiliani e soprattutto di Langsdorff. I suoi viaggi ebbero dunque un raggio limitato, tanto nei dintorni della città, quanto nell'area di Mandioca. Le località di raccolta più citate nel suo diario di campo sono, in ordine alfabetico, Catumby, un villaggio a ovest di Enseada da Glória; il monte Corcovado; la Serra de Estrela, un gruppo di montagne a nord della Baia di Guanabara; il monte Gavia, a sud di Rio de Janeiro; Mandioca, la valle a ovest di Rio da Janeiro dove si trovava la fazenda di Langsdorff; le piste di Matacavallos e Mataporcos nella foresta pluviale a nord della capitale; Nossa Senhora da Piedade Inhumirin, a nord del porto di Estrella; la foresta di Tijuca, che circondava il palazzo reale; si aggiungano alcune località tra Rio e Petropolis, inclusa la Serra dos Órgãos. Nonostante tutte le difficoltà, le raccolte di Raddi nei sette mesi che trascorse in Brasile furono imponenti: 4000 piante, 2230 insetti, 49 rettili, 65 minerali, manufatti, frutti; raccolse anche i semi di circa 340 specie, con l'intenzione di propagarli una volta tornato in Toscana. Nell'orto botanico di Firenze sono ancora oggi coltivate alcune specie di Begonia, compresa la popolarissima B. maculata Raddi, e un esemplare di Psidium guineense, discendenti da piante nate da semi portati da Raddi dal Brasile. Dopo aver inutilmente sollecitato nuovi finanziamenti, il 1 giugno 1818 Raddi dovette rassegnarsi a tornare in Europa insieme a Mikan, ai pittori e all'ambasciatore d'Austria von Eltz. Il 19 agosto sbarcò a Genova con diverse casse di esemplari e tre barili di cachaça usati per conservare pesci e anfibi.  Un importante contributo scientifico Le sue vicissitudini non erano finite. Di origini sociali modeste, autodidatta, era guardato con sufficienza dai colleghi più titolati, che invidiavano la sua fama crescente al di fuori del provinciale ambiente fiorentino, Al suo ritorno in città, Raddi scoprì che il custode del Museo, il paleontologo Filippo Nesti, non aveva trattato con la dovuta cura i materiali spediti dal Brasile; nonostante ciò, la catalogazione delle collezioni venne affidata, invece che al raccoglitore, allo stesso Nesti, che per altro non aveva competenze né in botanica né in zoologia. Raddi si vide retrocesso al rango di impiegato amministrativo con un modestissimo stipendio. Soltanto a partire dal 1820, quando venne abolito l'incarico di custode del Museo, pur mantenendo lo stesso stipendio, gli venne riconosciuto il ruolo di "fisico", ovvero di ricercatore, con l'incarico di studiare le proprie raccolte brasiliane. Lasciato il lavoro al Museo, si trasferì al Canto di Candeli in Borgo Pinti per dedicarsi interamente a questo compito. A una prima monografia sulle felci brasiliane, Synopsis Filicum Brasiliensium, uscita già nel 1819, seguì l'importante Agrostografia Brasiliensis sive enumeratio plantarum ad familias naturales graminum et ciperiodarum spectantium quas in Brasilia collegit et descripsit (1823), il primo studio sulle erbe neotropicali, che comprende 65 Poaceae (tra cui 5 nuovi generi) e 26 Cyperaceae. Infine nel 1825 uscì Plantarum Brasilensium Nova Genera et Species Novae, vel minus cognitae che Raddi concepiva come prima parte di un lavoro più ampio. A questi lavori maggiori si affianca una notevole produzione di articoli e memorie, pubblicati negli atti di società scientifiche come la Società Italiana delle Scienze di Modena. Raddi vi approfondì lo studio di numerose altre famiglie di piante, con un approccio innovativo che dava grande importanza alla sistematica attraverso l'analisi e l'interpretazione di vasti gruppi. Il botanico fiorentino si inserì così autorevolmente nel dibattito europeo sulla classificazione naturale. Notevole fu anche il suo contributo alla zoologia, con la descrizione di diverse nuove specie di rettili. La precisione delle descrizioni e la profondità delle interpretazioni diedero risonanza europea a Raddi, che fu in corrispondenza con molti colleghi di primo piano; egli fu anche ammesso a numerose società scientifiche in Italia e all'estero. Non doveva però essere totalmente appagato, oppure non si era spento il suo desiderio di avventura, se nel 1828, quando aveva già quasi sessant'anni, accettò di affrontare una nuova sfida. Nel 1827, due egittologi, il toscano Ippolito Rosellini e il francese Jean François Champollion, il decifratore della stele di Rosetta, proposero ai rispettivi governi una spedizione in Egitto. Ne nacque così la Missione archeologica franco-toscana che per 15 mesi (18 agosto 1828-27 novembre 1829) esplorò la valle del Nilo toccando tutti i più celebri siti noti all'epoca. Con Rosellini e Champollion c'era un vasto gruppo di archeologi, architetti, disegnatori, naturalisti. Uno di loro era il nostro Giuseppe Raddi, che della spedizione era il botanico ufficiale. Anche in Egitto, Raddi si dimostrò un raccoglitore instancabile, raccogliendo nell'arco di otto mesi circa 450 specie di piante. Dapprima esplorò i dintorni di Alessandria e di Rosetta, quindi con i suoi compagni risalì il Nilo fino alla prima cataratta. Qui abbandonò la spedizione per tornare in Basso Egitto, dove la vegetazione era più abbondante. Il 29 giugno 1829 partì da Rosetta per raggiungere il Wadi el-Natrun ma durante il viaggio fu colto da una violenta infezione intestinale. Costretto a rientrare al Cairo, continuò ad aggravarsi, tanto da decidere di tornare in Italia. Il 23 agosto si imbarcò a Alessandria ma durante il viaggio di ritorno morì a Rodi il 6 settembre. Qualche anno dopo, un gruppo di amici volle porre una lapide in suo ricordo a Santa Croce, che lo saluta come "ornamento d'Italia". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Bambù piccoli e lillipuziani Della grande stima internazionale goduta da Raddi testimoniano anche le numerose dediche di generi che gli furono tributate. Era una stima che andava non solo allo scienziato, ma anche alla persona, lodata per la modestia, la coerenza e la nobiltà d'animo. Contava anche la riconoscenza per la generosità di Raddi, che per quanto poté - il regolamento del Museo di storia naturale poneva gravi limiti - condivise con larghezza i suoi esemplari con i colleghi. Tra i beneficiati Antonio Bertoloni, amico personale di Raddi e Savi, cui il botanico fiorentino inviò più di 200 esemplari per la sua Flora italica, molti dei quali appartenenti a specie mai descritte, in particolare crittogame. La stima reciproca è testimoniata da uno scambio di dediche: nel 1812 Bertoloni dedicò al collega Raddia, famiglia Poaceae (ne riparliamo tra poco); l'anno dopo Raddi ricambiò con Bertolonia, famiglia Melostomataceae. Il secondo omaggio giuse dal franco-statunitense Rafinesque, che nel 1814 dedicò al botanico fiorentino Radiana (Aizoacaeae), oggi sinonimo di Sesuvium L. Anche la terza dedica si deve a un collega che ebbe rapporti personali con Raddi, quel frate Leandro do Santíssimo Sacramento che lo aveva guidato alla scoperta della flora brasiliana. E ancora una volta, si tratta di uno scambio di cortesie: nel 1820 Raddi pagò il suo debito di riconoscenza con Leandro dedicandogli Leandra, un'altra Melastomatacea; l'anno successivo il brasiliano si sdebitò con Raddisia (Celastraceae), oggi sinonimo di Salacia L. Il genere di Leandro fu ripreso da de Candolle (come abbiamo visto, assiduo corrispondente e estimatore dell'attività scientifica di Raddi) che lo corresse in Raddia. Nel 1822 il francese Achille Richard aggiunse Radia (Amaryllidaceae), oggi sinonimo di Vellozia Vand. Di tutti questi generi l'unico oggi valido è Raddia Bertoloni. E' una dedica particolarmente opportuna per il primo studioso delle graminacee sudamericane. A questo genere appartengono infatti una dozzina di specie di bambù, diffusi tra Venezuela, Guyana e Brasile. Anche se siamo abituati ad associare i bambù all'estremo oriente, anche l'America tropicale è particolarmente ricca di specie di questi vasto gruppo di Poaceae. Sono americani (e dell'Oceania) i cosiddetti bambù erbacei, appartenenti alla tribù Olyreae, con una ventina di generi, uno dei quali è appunto Raddia. Anche se alcune specie crescono a Trinidad e Tobago, in Guyana, in Venezuela e nell'Amazzonia brasiliana, il centro di diversità di questo genere è la costa atlantica orientale del Brasile, in particolare tra gli Stati di Bahia e Espìrito Santo. Sono bambù erbacei, alti non più di un metro, cespugliosi, con colmi eretti, che crescono in piccoli gruppi, soprattutto nelle foreste stagionalmente aride. La specie più diffusa è probabilmente R. brasiliensis, una specie molto polimorfa assai diffusa nelle foreste costiere da Cearà a Rio de Janeiro, con qualche popolazione sparsa nel Brasile occidentale. Qualche approfondimento nella scheda. La tribù Olyreae ha una tassonomia piuttosto complicata, ed è stata sottoposta a continue revisioni. Nell'ambito di una di esse, nel 1948 Jason Richard Swallen creò il genere Raddiella, in cui nome allude alla somiglianza con Raddia, ma in miniatura. Insieme a Mniochloa questo genere comprende infatti i bambù più piccoli del mondo. Il più piccolo in assoluto è R. vanessiae, una specie della Guyana francese che a maturità non supera i due cm. A distribuzione più settentrionale rispetto alla cugina maggiore (si fa per dire), sono native dell'America centrale e del Sud America settentrionale, fino a Trinidad. In genere comprende una quindicina di specie da piccole a minuscole; solitamente sono perenni cespugliose che formano colmi, per lo più striscianti; R. vanessiae, oltre ad essere il più piccolo bambù nel mondo, è anche l'unico sicuramente annuale. Altre informazioni nella scheda. La loro è davvero una strana coppia. Lei è una star internazionale, nata in Africa ma oggi di casa in tutto il mondo, una bellezza statuaria richiestissima in matrimoni e altre cerimonie, soggetto seducente e sensuale di grandi artisti, al centro di un giro d'affari miliardario; lui è un medico condotto di provincia, appagato dal suo piccolo mondo, che divide le giornate tra la cura dei pazienti, lo studio e le passeggiate in montagna. A unirli, è stata la tassonomia botanica. Sono il genere Zantedeschia (che i profani chiamano sbrigativamente calla) e il suo patrono, il dottor Giovanni Zantedeschi, botanico italiano del primo Ottocento.  Una schiva vita in provincia La vera calla, Calla palustris L., è una rusticissima pianta palustre presente in tutta la fascia temperata boreale, dall'Europa al Giappone all'America settentrionale. Linneo vi accostò una specie sudafricana descritta da Caspar Commelin nel catalogo del Giardino botanico di Amsterdam, che egli forse aveva vista nel giardino del suo protettore Clifford. La chiamò dunque Calla aethiopica (l'epiteto significa genericamente "africana"). Commelin l'aveva ricevuta da un suo corrispondente nel 1687, ma era già stata ritratta nel 1664 per il Jardin du Roi di Parigi. A separarla da Calla e ad attribuirla a un nuovo genere fu il botanico tedesco Curd Sprengel, sulla base di varie differenze, in particolare la forma della spata, piatta nella specie europea, avvolta su sé stessa ("cucullata") in quella africana. Nell'assegnarle un nome, decise di onorare un medico e botanico italiano, Giovanni Zantedeschi. Era nato il genere Zantedeschia, anche se il danno ormai era fatto: tutti (o quasi) continuano imperterriti a chiamarle calle. L'accoppiata Zantedeschi / Zantedeschia, del resto, è davvero singolare. Da una parte, lo vedremo meglio tra poco, c'è un medico di provincia, innamorato dei piccoli tesori botanici dei suoi monti; dall'altra un fiore statuario dalla bellezza sontuosa e innegabilmente sensuale, fonte di ispirazione per gli artisti, senza dimenticare l'importanza economica della sua coltivazione, con un giro d'affari miliardario. Giovanni Zantedeschi era nato nel 1773 a Molina, una frazione di Fumane nel Veronese, ai piedi dei Monti Lessini ; questo luogo di grande bellezza, nei cui pressi oggi sorge un parco con numerose cascate, nutrì il suo amore per la natura, per la montagna e i suo fiori. Laureatosi in medicina a Padova, dove strinse amicizia con il giovane botanico Ciro Pollini (1782-1833), divenne medico condotto prima a Tremosine sul lago di Garda, poi a Bovegno nella alta Val Trompia; questo villaggio già alpestre, circondato da monti dolomitici e posto alla convergenza di una serie di valli minori, all'epoca ancora semi isolato (vi arrivò nel 1804, quattro anni prima che fosse costruita la carrozzabile per Brescia) sembrava fatto su misura per lui. Non lo avrebbe più lasciato fino alla morte, quarant'anni dopo. Si sposò con una ragazza del posto e, oltre che come medico condotto, esercitò la professione come anatomo-patologo presso l'ospedale locale. I suoi variegati interessi scientifici (che spaziavano dall'anatomia alla micologia, dalla meteorologia all'analisi delle proprietà fisico-chimiche e terapeutiche delle acque locali) gli crearono tra i valligiani la fama di "duturù" (dottorone, gran dottore). Ma la passione dominante era la botanica, cui dedicò una decina di saggi, per lo più presentati ai soci dell'Ateneo bresciano e spesso rimasti manoscritti; si occupò di botanica applicata, studiando le piante tossiche e progettando una Flora medico-economica, ma fu soprattutto un attivo esploratore della flora delle montagne della sua piccola provincia. Cedo la tastiera all'alata prosa del suo primo biografo, Antonio Schivardi: "a tutto ardore portavasi sugli erti monti, nelle selve, in orridi dirupi e burroni ad osservare, dal rovere gigante che con l'annoso capo saluta le nubi al muschio pigmeo che tutto al suolo aderisce, per sorprendere al loro nascere, alla loro germinazione e per isvellere dal tuo regno, o natura, i misteri". Percorrendo e ripercorrendo quelle montagne (ci rimangono i racconti di due ardue escursioni nelle Alpi bresciane e bergamasche, rispettivamente nel 1825 e nel 1836) incontrò molte piante rare e non pochi endemismi, che poi inviava perché fossero conosciuti e descritti ai suoi corrispondenti: all'amico Ciro Pollini, a Giuseppe Moretti prefetto dell'Orto di Pavia, a Antonio Bertoloni, autore della celebre Flora italica. A una sola ebbe in sorte di dare il nome, Laserpitium nitidum Zant., il laserpizio insubrico; ma fu anche il primo - o tra i primi - a segnalare Ranunculus bilobus Bertol., Campanula elatinoides Moretti, Moehringia glaucovirens Bertol., Silene elisabethae Jan, Saxifraga arachnoidea Sternb., Arabis pumila Jacq, (primo rinvenimento in Italia), Campanula raineri Perpenti, Physoplexis comosa (L.) Schur (primo rinvenimento in questo settore delle Alpi). Tutte specie rare, per lo più rupicole, molte delle quali bellissime, che potete ammirare nella gallery. Rimase manoscritta la progettata Flora bresciana. Dopo una lunga vita trascorsa attivamente nel borgo montano che era divenuto la sua patria d'elezione, Zantedeschi si spense dopo breve malattia nel 1846. Lascio nuovamente la parola a Schivardi, che lo ritrae come un ottocentesco filosofo stoico: "Beato nella solitudine di Bovegno, superiore alle lusinghe e all'ira dell'instabile diva [ovvero la fortuna], straniero ad ogni pubblico e privato avvenimento, lontano dal rammaricarsi per le male opere degl'invidi, degli scioperati e dei detrattori dell'altrui fama; d'indole franca, confidente, pacifica; d'umor gioviale, di tratto cortese, dignitoso, libero, percorse la sua lunga carriera nel costante uso delle sociali virtù, nelle utili discipline, tutto raccolto nella scienza, che per dieci lustri professò ed onorò". Molina di Fumane, il suo paese natale, ho voluto onorarlo con il Museo Botanico della Lessinia, che espone circa 300 specie della Lessinia e della Valpolicella.  Una star internazionale Più del suo contributo alla conoscenza della flora di un lembo della catena alpina, a immortalare il dottor Zantedeschi è il notissimo genere che gli è stato dedicato. Non sappiamo perché Sprengel (che non ha lasciato alcuna nota in proposito) abbia scelto proprio lui; diverse fonti sostengono che fosse tra i suoi corrispondenti, ma non sono riuscita a verificare questa informazione. In ogni caso le sue scoperte dovettero dargli una modesta fama tra i botanici del tempo. Fu così che lo schivo dottore diede il nome a piante lontanissime, sotto ogni aspetto, dalle sue adorate specie rupicole. Il genere Zantedeschia Spreng, appartenente alla famiglia Araceae, comprende otto specie di erbacee con radici rizomatose provenienti soprattutto dal Sud Africa, con una sola specie che si spinge più a nord fino alla Tanzania e all'Angola; sono caratterizzate da una vistosa spata, ovvero una brattea che simula un petalo, che avvolge lo spadice, la vera infiorescenza. Molto a lungo in Europa si è conosciuta una sola specie, Z. aethiopica, che come ho anticipato arrivò negli ultimi decenni del Seicento. Piuttosto rustica, adattabile e di non difficile coltivazione, divenne presto popolare, tanto che il Dizionario di Miller (1768) la definisce "un vecchio abitante dei giardini inglesi". Dall'Europa giungerà poi nelle Americhe, in Asia e in Australia, tanto che oggi risulta naturalizzata in molti paesi a clima mite o subtropicale, divenendo in alcuni casi anche un'attiva infestante. Coltivata soprattutto per la produzione di fiori recisi, nella seconda metà dell'Ottocento diventa anche uno dei soggetti preferiti della pittura: la dipingono Henri Matisse, Emil Nolde, Diego Rivera (che la ritrae molte volte), Tamara de Lempicka e tanti altri. Il liberty ne fa un motivo ricorrente e si ispira alle sue forme avvolgenti per gioielli, vasi, lampadari. Il successo delle altre specie, che hanno rivoluzionato anche il mercato floricolo, è molto più recente. Al contrario di Z. aethiopica, che se trova le condizioni giuste è sempreverde, esse si comportano come bulbose stagionali e vanno in riposo dopo la fioritura. Molto meno rustiche, di dimensioni più contenute, portano però in regalo agli ibridatori i loro colori: non solo il bianco candido della sorella più nota, ma anche il giallo, il rosa, il rosso, il viola profondo. Grazie al lavoro assiduo degli ibridatori di Stati Uniti (che coprono circa il 50% del mercato), Paesi Bassi e Nuova Zelanda (che si contendono il 45%, lasciando a tutti gli altri le briciole), negli ultimi trent'anni sono state create centinaia di nuove varietà, vendute sempre più, oltre che come fiori recisi, come piante da interno e da aiuole. Qualche approfondimento nella scheda. Se il professor Moris poté completare la ricognizione della flora sarda nonostante i crescenti impegni accademici e politici lo trattenessero a Torino, gran parte del merito va al giardiniere Domenico Lisa, che lo sostituì nel lavoro sul campo. Non minore fu il contributo di Maddalena Lisa Mussino, moglie di Domenico, che disegnò e dipinse la maggior parte delle illustrazioni di Flora sardoa. Questa grande artista fu l'ultima esponente dello straordinario gruppo di disegnatori che tra il 1753 e 1868 realizzò un'opera che ha pochi uguali nella storia dell'illustrazione botanica, Iconographia taurinensis. A Domenico - ma io credo un po' anche a Maddalena - è stato dedicato il genere Lisaea. 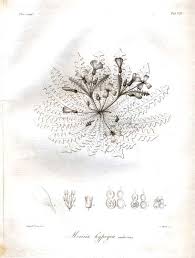 Le raccolte di Domenico... Nella primavera del 1828, il professor Moris, ammalato, lasciò la Sardegna per andare a curarsi in Piemonte. A continuare le ricerche rimase però Domenico Lisa, che già era stato suo compagno nelle spedizioni dei due anni precedenti. Nell'estate di quell'anno Lisa visitò il nord dell'isola, un'area che era rimasta fuori dalle escursioni di Moris, rientrando poi a Cagliari attraverso l'altopiano centrale. Tra le località toccate nel suo ampio giro, Porto Torres, Alghero, Nurra, Porto Conte, Asinara, Sassari, l'isola della Maddalena, Vignola, Tempio, Luogosanto, il monte Limbara, Olbia, Tavolara, il Monte Albo di Siniscola, Orosei, Galtellì, Nuoro, il Monte d’Oliena, Tonara, Monti di Sadali e Maracalagonis, Serrenti. Negli anni successivi, Lisa tornò almeno altre tre volte in Sardegna. Nel 1837 visitò le isole di Maddalena, Budelli, Barrentini. Nel 1840, partendo questa volta da Porto Torres anziché da Cagliari, tornò a percorrere la Sardegna settentrionale e centro-settentrionale, dedicando però maggiore attenzione alla costa (zona malsana per la malaria) e alle isole minori. Le località citate nel suo itinerario sono Porto Torres, Sassari, Scala di Giocca, Torralba, Tempio, Aggius, Limbara, La Maddalena, l'isola dei Cappuccini, Olbia, Capo Figari, le isole di Figarolo e Tavolara, S. Teodoro, Siniscola, il Monte Albo, Orosei, Galtellì, Nuoro, il Monte d’Oliena, Orgosolo, Urzulei, con rientro a Porto Torres attraverso Aggius, Limbara, Tempio, Torralba, Sassari. Nel 1852 Moris lo inviò un'ultima volta in Sardegna, per completare le ricerche in vista del terzo volume di Flora sardoa. Le zone citate per questa spedizione sono Bonorva, Silanus, Nuoro, Galtellì, Onifai, Orosei, Dorgali e le sue montagne, Flumineddu di Dorgali, il Monte d’Oliena, Orgosolo, Urzulei, i monti di Nuraminis. Indubbiamente il contributo di Lisa fu importante, e Moris lo riconobbe esplicitamente sia citandolo con elogio nella prefazione di Flora sardoa sia dedicandogli Oenanthe lisae, un endemismo sardo noto come finocchio acquatico. Ma non fu il solo merito del giardiniere torinese, che continuava degnamente la tradizione dei colti erbolai dell'orto del Valentino. Entrato in servizio nel 1821, oltre che all'esplorazione della Sardegna partecipò anche alla ricognizione floristica delle valli piemontesi. Nel 1852 divenne custode e giardiniere capo, carica che mantenne fino alla morte nel 1862. Curò con competenza le collezioni di fanerogame del giardino e l'allestimento degli esemplari dell'erbario. Come botanico, si interessò a un gruppo di piante allora ancora poco studiato, i muschi, dedicando loro una monografia (Elenco dei muschi raccolti nei dintorni di Torino, 1837). Allestì anche un erbario personale ricco di circa 2000 esemplari che alla sua morte volle legare all'istituzione dove aveva servito per quarant'anni. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. 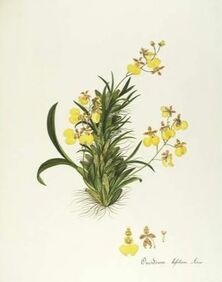 ... e gli acquarelli di Maddalena Ma è ora di parlare di un altro membro della famiglia Lisa il cui contributo a Flora Sardoa non fu meno importante. Mi riferisco a Maddalena Lisa Mussino (1805-1869), moglie di Domenico e autrice della maggior parte delle tavole che illustrano l'opera. Grazie a lei, facciamo un breve excursus sugli illustratori botanici che operarono nell'arco di un secolo e mezzo presso l'orto torinese, creando quella splendida opera collettiva che va sotto il nome di Iconographia taurinensis. Si tratta di 7470 tavole disegnate e acquarellate, raccolte in 64 volumi, che illustrano le piante coltivate nel giardino botanico torinese oppure le specie di nuova scoperta. L'idea di far ritrarre le piante del Regio orto botanico fu del primo direttore, Bartolomeo Caccia, che fece venire da Milano il pittore botanico Giovanni Battista Morandi, il quale realizzò circa quattrocento tavole acquarellate. Tuttavia, Iconographia taurinensis esordì ufficialmente solo nel 1752, grazie a Vitaliano Donati, che affidò la realizzazione delle tavole a Francesco Peyroleri (1710?-1783). Come ho già raccontato in questo post, Peyroleri era un vero fils du jardin; entrato al servizio dell'istituzione torinese da ragazzo come garzone, aveva sviluppato un notevole talento per il disegno, tanto che proprio per lui fu creata la nuova figura professionale di "disegnatore delle cose botaniche" o "olitore botanico". Fu attivo almeno fino al 1773, operando al fianco prima di Donati e poi di Allioni, per il quale disegno anche le tavole di Flora pedemontana. Con Peyroleri, Iconographia taurinensis (cui contribuì con diverse migliaia di tavole) divenne un affare di famiglia; Francesco fu affiancato dal figlio, che dipinse alcune tavole ma poi si specializzò nell'incisione, e dal nipote Giovanni Battista Bottione. Istruito dallo zio, Bottione gli succedette nel 1783 e fu attivo fino a fine secolo. A sua volta egli insegnò il mestiere alla figlia Angela Maria (che preferiva firmarsi Angelica), sposata Rossi, cui l'incarico fu affidato ufficialmente nel 1807. E finalmente entra in scena la nostra Maddalena Mussino; nata nel 1805, arrivò al giardino botanico poco più che bambina nel 1816 come apprendista della cugina Angela. Le prime tavole che possiamo attribuire a lei con una certa sicurezza risalgono al 1825. Da quel momento per un decennio affiancò la maestra (sono opera comune i volumi XLIX-LIV), fino al 1838 quando le subentrò come disegnatrice. Il suo contratto prevedeva l'esecuzione di quaranta disegni ogni anno, ritraendo dal vero in particolare le specie esotiche che fiorivano nelle serre del Giardino. Si devono integralmente alla sua mano i volumi LV-LXIV, per un totale di oltre 1200 tavole. Alla sua morte, nel 1868, il ruolo di disegnatore fu soppresso, e con esso ebbe termine anche Iconographia taurinensis. La collaborazione di Maddalena con Moris per quella che sarà Flora sardoa inizia nel 1827. Sulla base di alcune lettere di Moris, risulta che la giovane donna raggiunse il marito a Cagliari nella primavera di quell'anno e si trattenne nell'isola almeno fino a settembre; con grande soddisfazione del professore, ritrasse dal vero con grande esattezza una cinquantina di specie nuove o non presenti nell'iconografia. Quando poi Moris allestì Flora sardoa, Maddalena contribuì con 81 delle 111 tavole. I suoi disegni si distinguono per la finezza e la precisione del tratto, non disgiunte da una certa freschezza. Va anche sottolineato che fu la prima artista del gruppo torinese ad affiancare ai tradizionali pigmenti naturali alcuni pigmenti artificiali, come possiamo anche rilevare dai colori luminosi e brillanti dei suoi acquarelli.  Una dedica ambigua Nel 1844 Pierre Edmond Boissier, un botanico svizzero allievo di de Candolle, dedicò a Domenico Lisa il genere Lisaea. Al solo Domenico? La motivazione desta qualche perplessità: "Dedicato all'illustre Lisa benemerito per i suoi studi sui muschi italiani, illustratore della flora piemontese e sarda". Come andrà inteso il latino illustrator? in senso reale o metaforico? Viene il sospetto che Boissier abbia confuso marito e moglie; è strano, visto che era di casa in Italia ed era passato anche da Torino. In ogni caso, il dedicatario ufficiale è Domenico, e a questo mi attengo, anche se vorrei difendere la causa di Maddalena. Il genere Lisaea, della famiglia Apiaceae, poco noto e non molto studiato, comprende tre specie di annuali erbacee diffuse tra il Mediterraneo orientale e l'area irano-caucasica, in ambienti aridi anche d'altura. Hanno foglie pinnate, fiori solitamente bianchi e caratteristici frutti spinosi che li distinguono dai generi affini come Turgenia. Qualche informazione in più nella scheda. Grazie alla grande variabilità morfologica e geologica del territorio, la flora sarda è particolarmente varia; inoltre, come avviene spesso nelle isole, è ricca di endemismi (circa 340 su un totale di 2410 entità, ovvero il 15% del totale). La Sardegna è dunque di grande interesse per i botanici anche oggi; tanto più lo era all'inizio dell'Ottocento quando era un territorio pressoché inesplorato per la scienza. Niente da stupirsi dunque se il giovane medico Giuseppe Giacinto Moris, appassionato botanico formatosi all'Orto di Torino, quando il governo piemontese lo spedì a Cagliari ad insegnare chirurgia, fece di tutto per non farsi sfuggire l'occasione di essere il primo a scrivere una Flora Sardoa. Fu l'impresa della sua vita: prima sette anni di ricerca sul campo in cui visitò quasi ogni angolo dell'isola, poi la pubblicazione di tre volumi (un quarto rimase inedito) protrattasi per oltre un ventennio. Capace e intraprendente direttore dell'Orto botanico di Torino per quasi quarant'anni, Moris fu anche senatore del Regno. A ricordarlo, oltre ai nomi specifici di diverse delle piante, la rara Morisia monanthos, endemica di Corsica e Sardegna. 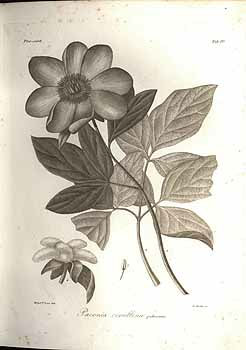 Un territorio tutto da scoprire Nei primi decenni dell'Ottocento, per un botanico entusiasta c'era ancora molto da scoprire anche nella vecchia Europa. Una delle aree pressoché inesplorate era la Sardegna che, al contrario delle regioni continentali degli stati sabaudi, era stata toccata solo marginalmente dalla grande ricognizione botanica promossa da Allioni e dai suoi allievi. Unica eccezione, le ricerche del medico Michele Antonio Plazza (1720-1791), titolare della prima cattedra di Chirurgia all'Università di Cagliari, che erborizzò nel Cagliaritano e nel sud dell'isola e fu in corrispondenza con Allioni; quest'ultimo, sulla base delle sue raccolte, nel 1759 pubblicò Fasciculus stirpium Sardiniae in Diocesi Calaris lectarum, il primo vero studio sulla flora sarda, in cui esaminò 136 specie (tutte abbastanza comuni). Plazza probabilmente intendeva scrivere egli stesso una flora sarda, ma il suo manoscritto, in cui le specie descritte sono 818, rimase inedito fino all'inizio del Novecento. Agli inizi degli anni '80, nel corso del suo viaggio mediterraneo, anche il celebre botanico norvegese Martin Vahl toccò rapidamente l'isola, dove scoprì una nuova specie di sparto o ginestra, di cui inviò un campione a L'Héritier de Brutelle (si tratta di Genista ephedroides DC, un endemismo sardo). Dunque, nel 1822, quando arrivò a Cagliari per assumere la cattedra di clinica medica, il ventiseienne medico Giuseppe Giacinto Moris, aveva un'intera flora da esplorare e da scoprire. Allievo prima di Balbis, che aveva acceso in lui l'entusiasmo per la botanica, poi di Capelli (direttore dell'orto torinese dal 1817 al 1831) probabilmente iniziò i suoi viaggi botanici fin da subito, e sicuramente dal 1823. Non era un compito facile: quasi non esistevano strade (la costruzione della Carlo Felice, che per la prima volta collegò il nord e il sud dell'isola era appena iniziata, e sarebbe stata terminata solo nel 1830), non c'erano alberghi, imperversavano il tifo e la malaria, non mancavano banditi e briganti. Bisognava dunque muoversi a cavallo, dormire all'aperto o chiedere ospitalità ai maggiorenti locali. Nelle sue prime spedizioni, Moris ebbe il sostegno di alcuni membri della Reale Società Agraria Economica di Cagliari, in particolare il canonico Murcas, Preside del Collegio dei Nobili e l'Intendente generale Greyffier, entrambi appassionati di botanica. Ma soprattutto trovò un compagno e un amico in Alberto La Marmora (1779-1863). Militare di carriera, quest'ultimo, sospettato di aver preso parte ai moti del 1821, era stato costretto alle dimissioni e esiliato in Sardegna, di cui cominciò a studiare la geologia, l'archeologia, la storia e a tracciare nuove carte, divenendo in breve il fondatore degli studi sardi in tutti questi campi. 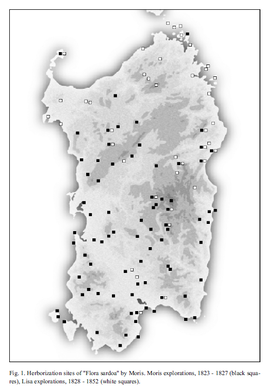 Un'esplorazione in profondità e un'opera fondamentale La prima spedizione documentata di Moris è del maggio 1823, quando insieme a Greyffier e La Marmora, muovendo da Cagliari visitò Aritzo e il Gennargentu. A giugno, ancora con La Marmora, era la volta di Domusnovas e del Sulcis. L'anno successivo, come riferisce in una lettera a Capelli, fu nelle zone più insalubri dell'isola (non sappiamo esattamente dove), forse in compagnia di Philippe Thomas, membro di una famiglia di botanici svizzeri, che in quel periodo viveva a Cagliari. Fino a quel momento, Moris, che era in Sardegna a insegnare chirurgia, non aveva alcun incarico ufficiale come botanico. Deciso a continuare le sue ricerche con l'obiettivo di scrivere una flora della Sardegna, attraverso Capelli incominciò a fare pressioni sul governo di Torino per essere esonerato dall'insegnamento e essere ufficialmente incaricato di esplorare la flora sarda; chiedeva anche finanziamenti, testi scientifici aggiornati e personale di supporto. La dispensa dall'insegnamento giunse nell'agosto del 1824 e all'inizio del 1825 da Torino arrivò Carlo Giuseppe Bertero, però non nelle vesti di aiutante, come credeva Moris, ma come direttore della missione; sebbene i rapporti personali tra i due fossero eccellenti e basati sulla stima reciproca, si generò una situazione equivoca cui mise fine lo stesso Bertero che preferì rientrare a Torino dopo pochi mesi. In ogni caso i due botanici piemontesi, sempre in compagnia di La Marmora, tra maggio e giugno avevano visitato il Sulcis e Iglesias. Partito Bertero, Moris continuò l'esplorazione con La Marmora, visitando Ogliastra, Fonni e nuovamente il Gennargentu. Fu durante una di queste escursioni che capitò un gustoso incidente riferito da La Marmora: Moris aveva raccolto numerose Malvaceae e le aveva disposte con cura in mezzo a fogli di carta in una cartella che portava sul dorso; avendo visto una pianta interessante, scese da cavallo, e, passandosi una briglia sotto il braccio per evitare che l'animale si allontanasse, si inginocchiò per raccogliere l'esemplare; nello sforzo, la cartella si aprì e venne a trovarsi proprio sotto il muso del cavallo che ne approfittò per farsi una bella scorpacciata. Il materiale raccolto incominciava ad essere ingente e, nonostante l'aiuto di Thomas, Moris si trovò in difficoltà. Fortunatamente, da Torino giunse l'incarico ufficiale e anche il sospirato assistente, nella persona di Domenico Lisa, giardiniere dell'Orto torinese, che sarebbe stato suo compagno nelle campagne del 1826-1827. Quella del 1826, con Lisa e La Marmora, fu un lungo giro di due mesi (maggio-luglio) nella Sardegna centrale, toccando tra le altre località Carloforte, Monte Arcuentu, Capo Frasca, Uras, Morgongiori, Flumentorgiu, Laconi, Gennargentu, Aritzo, Tonara, Desulo. Ancora più ampia fu la spedizione del 1827. Partiti da Cagliari l'ultima settimana di aprile, i tre compagni attraversarono l'intera isola, visitando Arbus, Ales, Santu Lussurgiu, Planargia, Bosa, Sindia, Bonorva, Monte Santo, Ozieri, Monte Rasu. Qui Moris e Lisa si separarono da La Marmora, continuando verso nord con un itinerario che non conosciamo con precisione. Del resto, oltre a quelle citate negli itinerari, molte altre località furono visitate da Moris, come risulta dalle note dell'erbario (nella cartina, sono indicate con un quadretto scuro). Malato, nella primavera del 1828 Moris rientrò a Torino, affidando a Lisa la continuazione del lavoro sul campo. Ancora a Cagliari, nell'aprile 1827 aveva in parte anticipato i risultati delle sue ricerche, pubblicando in contemporanea nella capitale sarda e a Torino Stirpium sardoarum elenchus, che contiene la descrizione di 1246 piante vascolari e la diagnosi di 26 specie nuove, seguito a giugno da un'Addenda e a dicembre da una seconda serie, con ulteriori 157 specie e la diagnosi di 17 specie nuove. A Torino nel 1829 diede poi alle stampe una terza serie, con altre 76 specie vascolari e un'ampia lista di crittogame. In tutto le specie descritte sono 1482. Moris non sarebbe più tornato in Sardegna, anche se le ricerche nelle zone che aveva dovuto tralasciare continuarono grazie a Lisa (ne parlerò in un altro post) e al sardo Simone Masala, che negli anni '60 raccolse molti esemplari nel Sarcidano e nell'area di Cagliari. Nel 1829 Moris fu nominato professore di medicina presso l'Università di Torino e nel 1831 succedette a Capelli come direttore dell'orto botanico torinese. Membro di molte istituzioni, senatore del Regno dal 1848, fu sempre più coinvolto in impegni accademici e amministrativi che rallentarono quella che riteneva la vera missione della sua vita: la stesura della Flora sardoa. Uscita nell'arco di un ventennio (nel 1837 il primo volume, tra il 1840 e il 1843 il secondo, tra il 1858 e il 1859 il terzo) è un'opera imponente, estremamente accurata nelle descrizioni e nelle determinazioni (a tal fine, Moris visitò importanti erbari a Parigi e Ginevra) e di grande pregio estetico, grazie alle 111 tavole che la illustrano, preparate sotto la sua stretta supervisione. La maggior parte è dovuta a Maria Maddalena Lisa Mussino, disegnatrice dell'orto torinese e moglie di Domenico Lisa. L'autore delle altre è John C. Heyland, disegnatore botanico che collaborò con celebri botanici dell'epoca, tra cui de Candolle. In tutto le specie descritte sono 1141, Benché incompleta (si limita alle fanerogame), Flora sardoa è un'opera fondamentale che divenne un punto di riferimento per tutti gli studi successivi, avendo anche il merito di stimolare l'interesse per la peculiare flora dell'isola e i suoi numerosi endemismi.  Morisia, la pianta che si semina da sé Nelle opere maggiori e nei numerosi contributi usciti in diverse riviste, Moris pubblicò circa un centinaio di nuove specie. Sono numerose quelle che lo ricordano nel nome specifico, tra cui la bellissima Paeonia morisii Cesca, Bernardo & N.G. Passal. (anche se questa denominazione non è universalmente riconosciuta) e la rara Genista morisii Colla, limitata alla Sardegna sud-occidentale. Tra le specie più rare della nostra flora, inserite nella lista rossa, si fregiano del suo nome Borago morisiana e Dianthus morisianus. Nel 1832 lo svizzero Jacques Etienne Gay gli dedicò un nuovo genere endemico dell'area sardo-corsa, Morisia, famiglia Brassicaceae, anticipando di due anni l'omonimo Morisia, famiglia Cyperaceae, creato da Nees von Esembeck. A essere valido è dunque il primo, anche se nel 1838 de Candolle propose di cambiarlo in Morisea o Morisina per evitare confusioni con Morysia (genere oggi disusato, dedicato al collezionista francese Charles de Saint Morys). Morisia è un genere monospecifico rappresentato unicamente da M. monanthos, una specie endemica della Sardegna e della Corsica, che cresce in luoghi preferibilmente umidi e freschi, formando localmente colonie anche estese. E' un'erbacea perenne bassa, con rosette di foglie pennate con foglioline più o meno triangolari e fiori eretti a quattro petali giallo oro. La sua particolarità sta nel metodo di disseminazione; dopo la fioritura, i peduncoli si ripiegano verso il basso spingendo i frutti nel suolo, dove avverrà la maturazione e quindi la germinazione dei semi. E' considerata un paleo endemismo di origine nordafricana. Altre informazioni nella scheda. Per vent'anni esatti, dal 1781 al 1801, a reggere l'Orto botanico di Torino fu il medico Giovanni Pietro Maria Dana, allievo e successore di Allioni. La sua attività si colloca nel solco di quella del maestro, anche se, paragonato a lui e al suo successore, Giovanni Battista Balbis, appare una figura decisamente minore. A percorrere il catalogo delle sue opere, numerosissime ma sempre contenute negli argomenti e nelle dimensioni, si ha l'impressione che la sua attività scientifica sia stata presieduta dal dio delle piccole cose: da una parte, è un medico e uno scienziato sperimentatore che studia le piante del territorio soprattutto per le loro applicazioni pratiche, terapeutiche o industriali; dall'altra, lo colpisce ciò che è strano, mostruoso (come dimostrano i diversi studi dedicati a feti deformi). Non va imputato a sua colpa se, quando Balbis ne rilevò l'incarico, trovò il giardino in uno stato miserevole: pesò certamente la malattia progressiva che segnò gli ultimi anni di vita di Dana, ma più ancora le guerre napoleoniche, che dal 1796 ebbero per teatro anche il Piemonte. A ricordarci che egli godette anche di un certo prestigio internazionale è il genere Danaea, dedicatogli da James Edward Smith, che comprende bellissime felci neotropicali.  Medicina e botanica applicata Nel 1781, Carlo Allioni chiese di essere dispensato dall'insegnamento e dalle cure gestionali dell'orto botanico torinese - di cui comunque mantenne la responsabilità scientifica - per dedicare tutte le sue forze alla pubblicazione di Flora pedemontana. A sostituirlo fu uno dei suoi migliori allievi, Giovanni Pietro Maria Dana, che dal 1770 era già primo professore associato presso la facoltà di medicina. Come il quasi coetaneo Bellardi, Dana era venuto a Torino dalla provincia - era nato a Barge, nel Cuneese - per studiare medicina e si era innamorato della botanica grazie alle lezioni di Allioni. Anch'egli fece parte del gruppo di entusiasti raccoglitori che sotto la sua guida percorsero ogni angolo del Piemonte per esplorarne la flora. Oltre alle valli del cuneese, egli perlustrò i dintorni di Pinerolo, il Monferrato, la provincia astigiana e i monti liguri. Alla ricerca botanica sul campo, affiancò la professione medica e una copiosa produzione di saggi e memorie che gli valsero appunto la nomina a professore associato poi, come ho anticipato, a titolare della cattedra di botanica e direttore dell'orto botanico. Ai primi lavori medici, dedicati a argomenti come i calcoli renali e la secrezione urinaria, affiancò saggi sulla generazione delle piante e sulla scilla officinale (ovvero la tossica Drimia maritima, all'epoca usata soprattutto per le sue proprietà cardiotoniche). In due memorie pubblicate nel 1766, all'analisi patologica e alle indicazioni terapeutiche si unisce l'osservazione naturalistica; nella prima Dana studia una nuova specie di vermi della classe degli irudinei, che denomina Hirudo alpina (oggi Crenobia alpina Dana), vivente in acque stagnanti, la cui ingestione accidentale, se non trattata opportunamente, poteva risultare fatale; attento alla cultura locale, Dana ne riporta anche il nome dialettale, sioure o soûre; nella seconda si occupa delle dermatiti causate dal contatto con idrozoi urticanti, che chiama armenistari. Anche i suoi studi botanici sembrano orientati alle applicazioni pratiche. Nel 1770 dedica un saggio a un fungo (agaricus seu boletus pelliceus) la cui polvere era usata come emostatico; nel 1774 a una pianta coltivata nell'Orto botanico di Torino, Solanum melanocerasum (oggi S. scabrum), forse di origine africana, che era usata sia in farmacia sia nell'industria tintoria, per ricavare coloranti chiamati con gli affascinanti nomi color d'Isabella chiaro, lilla violante, gris de prince, color di frejdolina chiaro. Altri argomenti dei suoi saggi sono i rimedi contro i danni da grandine, le acque termali e le fumigazioni; non manca un certo interesse per il curioso, il difforme, con alcune memorie dedicati a feti deformi o a un gatto mostruoso. Come si vede, soggetti molto specifici e di portata limitata, che tuttavia, insieme al ruolo di curatore dell'orto botanico tornese, gli procurarono una certa rinomanza internazionale, visto che fu ammesso a varie società scientifiche estere, come la Società fisico-botanica di Firenze, la Società linneana di Londra, la Società fisica e di storia naturale di Losanna e la Società reale di Montpellier. Già membro dell'Accademia delle Scienze e della Società agraria di Torino, dal 1784 fu nominato consigliere e presidente dell'amministrazione del protomedicato di Torino. Negli ultimi anni di attività tornò a interessarsi di piante tintorie, fondando addirittura un laboratorio apposito ("Regio laboratorio di tintura") dove conduceva osservazioni e esperimenti; nel 1790 fu consultato dal ministro Graneri circa l'opportunità di coltivare Carthamus tinctorius come colorante in sostituzione dello zafferano; l'anno successivo, in risposta al concorso bandito dall'Accademia delle scienze di Torino per trovare una sostanza tintoria che sostituisse l'indaco, Dana propose l'autoctona Isatis sylvestris vel angustifolia, probabilmente una forma selvatica di Isatis tinctoria, da lui trovata in val d'Aosta, nella contea di Nizza e nel Monferrato. E' l'ultimo dei suoi "piccoli lavori". Gli ultimi anni di Dana furono segnati infatti dal lento progresso di una "malattia cerebrale" che finì per renderlo del tutto inabile e lo portò alla morte nel 1801. Le conseguenze si fecero sentire anche nell'Orto botanico di Torino, che, quando Balbis gli subentrò, versava in uno stato deplorevole, certamente anche per la mancanza di denaro e gli effetti della guerra, che coinvolse il Piemonte a partire dal 1796. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Danaea, una felce venuta da lontano Diversi furono i generi dedicati a Dana. Nel 1785, in riconoscimento del suo contributo all'esplorazione della flora piemontese, Allioni gli dedica Danaa, oggi sinonimo di Physospermum, famiglia Apiaceae; nel 1835 Colla battezza Danaa yegua (sinonimo di Acrisione denticulata, famiglia Asteraceae) una delle piante cilene raccolte da Bertero. La dedica valida arriva nel 1793 con Danaea, famiglia Marattiaceae, da parte di James Edward Smith, il presidente della Linnean Society di cui, come abbiamo già visto, Dana era membro. Smith era stato a Torino, era a sua volta membro dell'Accademia delle scienze della città piemontese (nelle cui Memorie comparve infatti l'articolo che istituisce il nuovo genere), e intratteneva regolari rapporti epistolari con botanici torinesi, soprattutto Bellardi. Forse la dedica va dunque intesa, più che un omaggio alla persona di Dana, un riconoscimento del suo ruolo di curatore di un'istituzione di peso europeo. E' un omaggio indubbiamente sontuoso: il genere Danaea comprende infatti una cinquantina di specie di felci delle foreste pluviali delle Antille, del centro e del sud America, dall'aspetto insieme esotico e primordiale. Appartengono infatti a una linea evolutiva antichissima, con rappresentati fossili fin dal Paleocene. La loro caratteristica distintiva più evidente è il dimorfismo delle foglie, in genere pennate, ma con foglie fertili contratte e sporangi disposti in file lineari che coprono interamente la pagina inferiore della lamina fogliare. Sono piante elusive per l'habitat e con caratteristiche distintive che rendono difficile il riconoscimento a partire da esemplari essiccati, il che spiega perché negli ultimi anni ne sono state individuate diverse nuove specie. Per il suo nome curioso vorrei almeno ricordare Danaea kalevala, una grande e spettacolare felce delle Piccole Antille, che è stata riconosciuta come specie solo nel 2006 dal botanico olandese M.J.M. Christenhusz, che in ricordo degli anni di dottorato trascorsi presso l'Università di Turku, si è ispirato al celebre ciclo epico finlandese. Qualche approfondimento su questo genere affascinante nella scheda. Esponente di spicco della scuola botanica di Allioni, di cui fu il principale allievo e collaboratore, Lodovico Bellardi in decine di escursioni botaniche percorse ogni angolo dello stato sabaudo, dalla pianura alle contrade più remote delle Alpi, dando un contributo inestimabile alla conoscenza della flora pedemontana. Celebre tra i botanici del suo tempo - di molti dei quali fu stimato corrispondente - per la profonda conoscenza delle piante, grande raccoglitore di piante locali, scrisse poco e non uscì quasi dai confini dello stato dove era nato. Viaggiatore immobile nello spazio, lo è anche nel tempo: al contrario di quanto accadde ad altri botanici subalpini, attraversò senza esserne toccato le tempeste della storia nel periodo che va dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione. Lo ricordano due piccoli generi, presenti anche nel nostro paese: Bellardia (Orobanchaceae) e Bellardiochloa (Poaceae). Per una volta, entrambe le dediche si riferiscono a specie che il dedicatario raccolse e contribuì a fare conoscere. 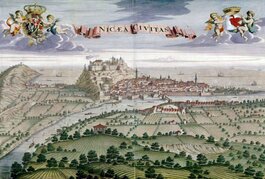 Tra piane, montagnose e alpestri regioni Nella prefazione alla Flora pedemontana (1785), la sua grande opera dedicata alla flora del Piemonte, Carlo Ludovico Allioni sottolinea l'importanza del contributo dell'allievo Lodovico Bellardi, che, spinto da ardente amore per la scienza, percorse ed esplorò in modo accuratissimo molte contrade dello Stato sabaudo alla ricerca di piante. I luoghi citati da Allioni ci danno la misura dell'ampiezza di questi viaggi: la pianura vercellese; le colline, le montagne, i laghi del Canavese; la Valle d'Aosta e le sue montagne; buona parte della Savoia; la contea di Nizza, senza tralasciare le cime più aspre e le valli più remote. Allioni ricorda poi l'estrema generosità del solerte allievo che, invece di pubblicare le sue scoperte in un'opera propria, come inizialmente aveva progettato, le mise a disposizione del maestro che le pubblicò appunto in Flora pedemontana. Per capire il peso di questo contributo, basti pensare che su 2813 specie qui descritte, per circa 250 Bellardi è citato come raccoglitore; tra di esse almeno una ventina erano inedite. Allievo prima di Donati, poi di Allioni, Bellardi era venuto a Torino a studiare medicina dalla nativa Cigliano, nel Vercellese, e grazie ai suoi maestri si era innamorato della botanica. Benché avesse scelto la professione di medico e non avesse alcun incarico ufficiale né all'Università né all'orto botanico, divenne il principale collaboratore di Allioni grazie ai suoi viaggi e alle sue ricerche. Tra il 1759 (appena diciottenne) e il 1790 percorse in lungo e in largo il Piemonte in tutte le "piane, montagnose e alpestri regioni", per citare il suo primo biografo, G. Carena. Il viaggio che conosciamo meglio, essendocene pervenuto il diario, è quello che nell'estate del 1784 lo portò a percorrere Valle d’Aosta, Vallese, Alta Savoia e Savoia in compagnia di Francesco Peyrolery, giardiniere e disegnatore dell'orto botanico di Torino. Partiti da Torino all'inizio di luglio, i due raggiunsero l'imbocco della Valle d'Aosta, quindi risalirono la Valle di Gressoney, per poi tornare nella Valle centrale a Saint-Vincent e dirigersi ad Aosta. Attraverso il Valico del Gran S. Bernardo raggiunsero Martigny e da qui Roche nel Vaud, dove incontrarono il celebre scienziato Albrecht von Haller; ritornati a Martigny raggiunsero Chamonix attraverso il Col de la Forclaz. Passando per Mégéve e Ugine, toccarono l'attuale Albertville, proseguendo nella Vanoise fino a Termignon (dove il diario si interrompe), da dove forse rientrarono a Torino attraverso il valico del Moncenisio. Questa escursione, della durata di poco più di un mese, fruttò la raccolta di circa 430 piante. Come ho già detto, non si tratta che di uno dei tanti viaggi che nell'arco di 30 anni portarono Bellardi a percorrere ed esplorare gran parte degli stati sabaudi (esclusa la Sardegna). Oltre a offrire un eccezionale contributo alla conoscenza della flora del Piemonte e delle zone limitrofe, le sue ricerche arricchirono anche l'orto botanico di Torino di numerose specie, che egli coltivava pure in suo piccolo orto sperimentale, che aveva potuto creare grazie al sostegno dell'ambasciatore portoghese a Torino, Roderigo Countinho de Souza. Qui Bellardi sperimentava anche la coltivazione di piante officinali adatte al clima subalpino, in sostituzione dei costosi semplici importati: così coltivò due specie di rabarbaro (Rheum compactum L. e R. undulatum L.) e una Cassia diversa dalla senna descritta da Linneo, che però ne aveva le stesse proprietà medicinali, tanto che avrebbe potuto perfettamente sostituirla; la chiamò perciò Cassia succedana (nome ancora oggi valido). Dopo il 1790, i viaggi si diradarono, ma nel frattempo Bellardi era riuscito a creare una rete di allievi, amici e corrispondenti che, da ogni angolo del Piemonte, raccoglievano per lui le piante locali nei diversi momenti della loro vita vegetativa. Tra di essi il frate certosino Cumino, Biroli, de Suffren, Viale. Intratteneva anche una fitta corrispondenza con molti eminenti botanici europei, presso i quali godeva di una fama quasi leggendaria di enciclopedia vivente delle piante subalpine. Così Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, ebbe a definirlo viro de re botanica celeberrimo, cuius laudatum nomen rei herbariae cultoribus est notissimum, "uomo celeberrimo per la botanica, il cui nome lodato è notissimo ai cultori della botanica". Tra i suoi corrispondenti più assidui, James Edward Smith, presidente della Linnean Society, una delle numerose istituzioni scientifiche straniere che lo accolsero tra i loro membri (oltre alle torinesi Reale Società Agraria e Reale Accademia delle Scienze, di cui fu anche Tesoriere dal 1804 al 1825). Rispetto all'imponente attività di raccoglitore, limitati furono invece i contributi scritti: Osservazioni botaniche con un saggio d'appendice alla Flora Pedemontana (1788), in cui polemizzò con il maldestro autore di una flora di Chambery, chiarendo il concetto di pianta autoctona; Appendix ad Floram Pedemontanam, (1792) e Stirpes novae vel minus notae Pedemontii descriptae et iconibus illustratae (1803), che costituiscono un'integrazione della Flora di Allioni con nuove specie o correzioni tassonomiche. In totale, si ritiene siano circa una sessantina le nuove specie da lui raccolte e segnalate. Di notevole importanza anche l'erbario, con oltre 5000 essiccati (che egli chiamava "scheletri"), notevole anche per la precisione delle note che lo corredano, oggi conservato presso l'orto botanico di Torino. Una sintesi della sua lunga, serena e produttiva vita nella sezione biografie.  Poa o Festuca? no, Bellardiochloa Contrariamente a quello che siamo portati a pensare, è abbastanza raro che un botanico sia celebrato dal nome di una pianta che raccolse, studiò o denominò. Bellardi è l'eccezione che conferma la regola: gli sono stati dedicati ben due generi validi e in entrambi i casi la specie tipo fu raccolta e descritta da lui. L'interesse per le piante di questo grande raccoglitore della flora alpina era a 360 gradi; circa metà delle piante nuove da lui segnalate sono crittogame; si interessò anche ai licheni e ai funghi; tra le angiosperme, studiò piante solitamente trascurate, vere e proprie "erbacce", tra cui numerose Poaceae. Così in Flora Pedemontana, Allioni segnalò una nuova specie di Poa raccolta da Bellardi nel suo paese natale, in onore del quale la denominò Poa cilianensis All.; oggi è passata a un'altro genere, ma mantiene il nome specifico voluto dai due botanici piemontesi: Eragrostis cilianensis (All.) Janch. Un'altra specie di Poa, che Bellardi raccolse presso Limone Piemonte, fu da lui pubblicata nell'appendice alla Flora pedemontana (1792) sotto il nome di Poa violacea. Questa denominazione fu trascurata dai botanici successivi, che in genere attribuirono la pianta (variamente denominata) al genere Festuca, finché nel 1874, sulla base di alcune caratteristiche della cariosside, Balansa lo restituì al genere Poa ripristinando la denominazione di Bellardi. Nel 1929 il botanico di origini piemontesi Emilio Chiovenda, in un saggio pubblicato in un volume miscellaneo celebrativo del bicentenario dell'orto botanico torinese, rilevò che questa specie presenta caratteristiche intermedie tra Poa e Festuca, tanto da farla attribuire a un genere proprio, che chiamò Bellardiochloa, cioè "erba di Bellardi", "in omaggio allo scopritore della specie, che fu tanto benemerito della flora piemontese". Nei decenni successivi, a dire il vero, il genere creato da Chiovenda non godette certo del consenso generale, venendo per lo più attribuito a Poa. Solo in anni recenti, ulteriori studi hanno dimostrato che Bellardiochloa è un genere a sé, ben differenziato tanto da Poa quanto da Festuca dal punto di vista sia morfologico sia molecolare. Oggi gli sono assegnate cinque specie di erbe dei pascoli e delle rocce delle aree subalpine, soprattutto su suoli silicei. Una specie, B. variegata (sinonimo B. violacea, ovvero proprio la specie descritta da Bellardi) ha un ampio areale che comprende le montagne dell'Europa meridionale, dai Pirenei ai Balcani passando per le Alpi; in Italia, dove è nota con il nome comune di fienarola violacea, è presente in tutte le regioni eccetto Campania e Puglia. In Sicilia sono presenti due rare sottospecie, B. v. subsp. nebrodensis e B. v. subsp. aetnensis. Il centro di diversità del genere è considerato la Turchia, dove sono presenti quattro delle cinque specie, tre delle quali endemiche. Qualche approfondimento nella scheda.  Un genere quasi parassita Anche l'altro genere che celebra Bellardi, ovvero Bellardia (Orobanchaceae) ha una storia travagliata. Oltre ad avere riconosciuto i meriti dell'allievo prediletto nella prefazione, in Flora Pedemontana Allioni volle anche onorarlo dedicandogli una delle piante da lui raccolte, Bellardia trixago, "in segno di riconoscenza e stima". Non validi sono ovviamente i generi Bellardia creati più tardi, rispettivamente nel 1791 da Schreber e nel 1835 da Colla. Bellardi raccolse questa pianta nei pressi del faro di Nizza. In precedenza, era già stata studiata da altri botanici, che l'aveano assegnata ad altri generi, in particolare Bartsia. Successivamente, il genere stabilito da Allioni ebbe vita controversa, ora riconosciuto come indipendente, ora incluso appunto in Bartsia. E' molto recente (2016) una revisione filogenetica di quest'ultimo genere che ha dimostrato l'indipendenza di Bellardia, cui ha attribuito due specie, B. trixago e B. viscosa (prima Parentucellia viscosa). Entrambe sono mediterranee e presenti nel nostro paese, in pascoli e incolti. Nota con il nome di perlina minore, B. trixago è un'erbacea annuale emiparassita, diffusa nell'Italia centro meridionale, con un'infiorescenza eretta e piramidale dai vistosi fiori bianchi o violacei che emergono da file di brattee. Nota come perlina maggiore, B. viscosa ha dimensioni maggiori, ma fiori più piccoli gialli e presenta ghiandole che la rendono vischiosa al tatto. La sua appartenenza al genere Bellardia è comunque controversa; POWO considera nome valido Parentucellia viscosa, B. viscosa sinonimo. Qualche informazione in più nella scheda. Giacobino come Balbis, anche l'avvocato Luigi Colla fu uno dei membri del filo francese governo provvisorio della Repubblica piemontese; come l'amico, deluso da Napoleone, lasciò la politica, affiancando all'attività forense la passione sempre più travolgente per la botanica. A Rivoli, nella cintura torinese, trasformò così un podere in un notevole giardino botanico privato, ricco di specie esotiche, grazie soprattutto agli invii dell'avventuroso Bertero. Fu anche autore di contributi di notevole interesse, tra cui spicca la monografia sulle piante cilene raccolte appunto dall'amico scomparso. Di notevole importanza storica sono sia il suo carteggio con eminenti personalità botaniche del tempo (tra cui, primi fra tutti, Balbis e Bertero) sia l'erbario. Tra i suoi corrispondenti non poteva mancare de Candolle che nel 1825 gli dedicò il genere Collaea. Collaboratrice del padre, del quale illustrò le opere con numerose tavole botaniche, fu la figlia maggiore Tecofila, che Bertero volle onorare con il bellissimo e delicato genere cileno Tecophilaea.  Botanico per diletto Nato in una famiglia di giuristi, il torinese Luigi Colla fu avviato alla carriera forense, anche se la sua inclinazione lo avrebbe portato verso le scienze naturali, in particolare la più gentile, la botanica. Laureatosi con una tesi sul diritto naturale ispirata a Beccaria, cominciò a esercitare con successo la professione di avvocato; tuttavia, gli eventi della rivoluzione francese lo spinsero ad entrare nei circoli giacobini, dove probabilmente iniziò la sua amicizia con Giovanni Battista Balbis. Come lui, nel 1798 fu uno dei membri del governo provvisorio filofrancese; nella breve stagione della Repubblica piemontese, fu anzi molto attivo sia nell'azione a favore dell'adesione alla Francia sia nella repressione dei moti legittimisti. Al momento dell'occupazione austro-russa fu arrestato e rimase in carcere fino al ritorno dei francesi, grazie alla vittoria napoleonica di Marengo. Come gli altri repubblicani piemontesi, fu tuttavia deluso dalla politica di Napoleone, allontanandosi progressivamente dalla vita politica. Era tempo di riempire questo vuoto con una passione fino ad allora sopita: quella per le piante. Intorno al 1810, l'avvocato acquistò a Rivoli, a circa quindici chilometri da Torino, uno vasto podere con l'intenzione di trasformarlo in un orto botanico privato. Sembra che gli amici botanici Balbis e Bellardi, cui si rivolse per consigli, all'inizio avessero accolto la conversione di Colla alla "scienza dei vegetabili" con un certo scetticismo; tuttavia, stando a un aneddoto forse apocrifo, quando nel 1813 Balbis visitò il giardino, rimase ammirato dalle ordinate aiuole con le piante disposte secondo le classi di Linneo. Il giardino aveva impostazione paesaggistica, secondo il gusto all'inglese, e conteneva anche alcune serre per la coltivazione delle numerosissime specie esotiche. La realizzazione del giardino fu accompagnata da uno studio assiduo delle basi teoriche della botanica e delle pratiche agronomiche che Colla volle condividere nella sua prima opera dedicata al mondo vegetale, l'Antolegista botanico (1813-1814, in sei volumi), intesa a divulgare la scienza botanica tra coloro che non leggevano il latino; contiene anche un'appendice con consigli pratici sulla creazione di orti e giardini. Sempre alla ricerca di novità per il suo giardino, Colla incominciò a corrispondere con orti botanici e studiosi, con i quali scambiava semi ed esperienze, diventando una figura via via sempre più nota e riconosciuta a livello internazionale, tanto da essere ammesso a numerose prestigiose società scientifiche estere (dall'Academy of natural sciences di Filadelfia all'Académie Royale di Lione, dalla Accademia dei Georgofili di Firenze alla Medical and Botanical Society di Londra, ma l'elenco potrebbe continuare). La caduta di Napoleone e il ritorno dei Savoia - al contrario di quanto accade a Balbis, costretto all'esilio - non incisero sulla vita di Colla, che continuò ad affiancare una brillante carriera di avvocato alla cura del giardino e alle sempre più numerose pubblicazioni botaniche. Di notevole interesse, nel 1820, Memoria sul genere Musa e monografia del medesimo in cui descrisse alcune specie di banane che sono all'origine delle moderne varietà coltivate, in particolare Musa acuminata e M. balbisiana Colla. Nel 1824 seguì Hortus ripulensis, il catalogo del suo giardino, che per la rarità delle specie descritte e l'accuratezza delle descrizioni lo consacrò come uno dei più colti e raffinati proprietari di giardini privati d'Europa. Nella maturità e nella vecchiaia l'attività di Colla sembra ancora intensificarsi. Per il vecchio avvocato, l'unico rimasto a Torino degli amici dispersi (dall'esilio, dai viaggi avventurosi, dalla morte), è anche un modo per riscattarne e preservarne la memoria. Ciò vale in particolare per Plantae rariores in regionibus chilensis a clarissimo M. D. Bertero nuper detectae (1834-36) in cui Colla pubblicò le piante ricevute dal Cile dallo scomparso Bertero. Di notevole importanza per le numerose piante inedite o poco note è pure il poderoso Herbarium pedemontanum, in otto volumi (1833-37); quest'opera, in un certo senso, può essere considerato la realizzazione del vecchio progetto concepito con Balbis di aggiornare e completare la Flora Pedemontana di Allioni; Colla vi si dimostra anche attivo esploratore delle campagne e delle montagne piemontesi. D'altro canto è notevole anche per la pubblicazioni di specie inedite inviategli da Bertero dalle Antille e dal Cile, da Colla coltivate nel suo giardino di Rivoli. Nel 1840, in occasione del Secondo Congresso degli Scienziati italiani, che si tenne a Torino, ebbe il piacere di ospitare a Villa Colla l'intera sezione botanica in visita al suo giardino. Un po' tardivi, arrivarono anche i riconoscimenti ufficiali di Casa Savoia: nel 1844 fu nominato Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e nel 1848, poco prima della morte, Senatore del Regno. Qualche approfondimento sulla sua vita nella sezione biografie. Il suo erbario, donato dagli eredi, è ora custodito presso l'Orto botanico di Torino, mentre numerose sue carte sono conservate presso la Biblioteca storica della Provincia di Torino. Di notevole rilevanza il carteggio con insigni botanici dell'epoca, primi fra tutti ovviamente gli amici Balbis e Bertero. 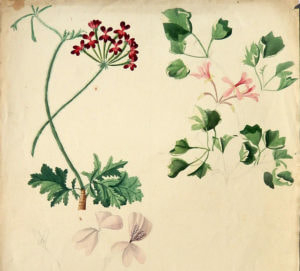 Una raffinata e precisa artista botanica Accanto a Colla, sua collaboratrice preziosa e indispensabile, fu la figlia Tecofila. All'epoca era uso che le signorine di buona famiglia ricevessero lezioni di musica e disegno, ma la nostra Teofila Giacinta Rosalia Anna Maria detta Tecofila in entrambi i campi era ben più di una dilettante. Come il padre, era ottima pianista e cantava con voce di contralto. A soli diciassette anni si sposò con l'avvocato Giuseppe Billotti, che nel 1814 insieme allo stesso Colla aveva fondato l'Accademia filarmonica di Torino, di cui nel 1819 divenne presidente. Gli accademici si riunivano per fare musica insieme, organizzando anche concerti con professionisti. Dal 1838 istituirono anche una scuola gratuita di musica vocale e strumentale, in cui insegnò pure Tecofila, che dell'Accademia era l'unica socia di sesso femminile. Ma veniamo all'altra arte coltivata dalla giovane signora. Reputata artista botanica, tanto da essere ammessa alla Societé Linéenne, si distingueva per la precisione del disegno e per la raffinatezza dell'acquarellatura. A partire dal 1820 (l'anno stesso in cui si sposò) collaborò con il padre disegnando alcune delle tavole delle sue opere: per Memoria sul genere Musa, disegnò dal vero le tre tavole che documentano le fasi della fruttificazione; per Hortus Ripulensis creò 29 su 40 tavole; è poi sua la maggior parte delle 71 tavole di Plantae rariores e delle 97 di Herbarium Pedemontanum. Memoria circa una nuova specie di Calonyction, che Colla lesse durante il citato secondo Congresso degli scienziati italiani facendola stampare come omaggio ai congressisti, contiene una tavola disegnata da Tecofila seguendo in tempo reale la successiva apertura dei fiori. Oltre che con il padre, la valente illustratrice collaborò occasionalmente con G. Gallesio (per il quale disegnò la tavola della Freisa di Pomona italiana) e G.G. Moris, direttore dell'orto torinese dal 1831. Nella sezione biografie una rassegna delle (scarse) notizie biografiche che ho potuto raccogliere su di lei.  Il genere Collaea La rinomanza internazionale di Colla e del suo giardino è testimoniata dalle numerose dediche di generi con cui fu onorato: Collaea de Candolle (1825), Sprengel (1826), Bertero (1835); Collania Schlutes (1830) e Herbert (1837). L'unico oggi valido è Collea DC, della famiglia Fabaceae, stabilito da de Candolle in Mémoires sur la famille des légumineuses. E' un genere esclusivamente sudamericano, con sei o sette specie, distribuite tra Perù, Bolivia, Paraguay, Argentina centrale e settentrionale e Brasile, che è il centro di diversità con quattro specie. Sono arbusti di notevole impatto estetico, con foglie digitato-trifoliate e fiori molto vistosi raccolti in infiorescenze terminali, in colori brillanti (rosso, viola, azzurro, bianco). La più spettacolare è forse C. cipoensis R. H. Fortunato, un endemismo esclusivo della Serra do Cipó, nello stato brasiliano di Minas Gerais, con corolle rosso fuoco impollinate da due specie di colibrì. Diffusa invece ampiamente in tutto l'areale è C. argentina Griseb., un suffrutice o perenne con corolle papilionacee rosa fucsia. Qualche informazione in più nella scheda.  Il genere Tecophilaea Colla era estremamente legato alla figlia Tecofila che, imitando Cicerone nei confronti della sua Tulliola, definiva "deliciae suae", la sua delizia. In Hortus ripulensis (1824) pensò di ripagare le sue fatiche creando in suo onore il genere Billottia (Myrtaceae). A fare il guastafeste intervenne però de Candolle, che fece notare che il nome non era valido perché si trattava di un sinonimo di Calothamnus, creato da La Billardière nel 1806. Pensò però di cancellare l'affronto creando un nuovo genere Billottia (1830, famiglia Rubiaceae). Anche Robert Brown ebbe la stessa idea, creando Bilotia (con una t sola), pubblicato da Don nel 1832. Nessuno di questi generi è oggi valido. Lo è invece il meraviglioso genere Tecophilaea stabilito da Bertero sulla base di una specie raccolta in Cile; morto precocemente lo sfortunato botanico, a pubblicarlo fu proprio Colla, in Herbarium pedemontanum (1836). Questo piccolo genere, di una famiglia propria (Tecophilaeaceae), comprende due specie di bulbose native delle montagne costiere del Cile centrale; la più nota e spettacolare è T. cyanocrocus, le cui corolle blu cobalto hanno quasi rischiato di farla estinguere. Scoperta nel 1862 dal botanico tedesco F. Leybold, proprio questo colore così raro scatenò la cupidigia dei collezionisti che facevano a gara per procurarsene un esemplare. Fu soprattutto il collezionista e ibridatore tedesco Max Leichtlin a lanciarla sul mercato, scatenando una raccolta indiscriminata che in pochi anni, unita ai danni della pastorizia, fece pensare che la pianta fosse ormai estinta in natura. Tuttavia nel 2001 la fondazione cilena Fundaciòn R.A. Philippi ne scoprì una popolazione selvatica la cui ubicazione venne tenuta segreta per permetterne l'adeguata protezione. Altre notizie nella scheda. Tra gli avventurosi cacciatori di piante di inizio Ottocento c'è anche un botanico piemontese, Carlo Giuseppe Bertero. Formatosi alla scuola di Balbis, di fronte all'onda nera della Restaurazione decise di lasciare l'Europa e di dedicare la sua vita all'esplorazione della flora di paesi lontani, possibilmente poco battuti. Il primo viaggio, tra il 1816 e il 1821, lo portò nelle Antille e in Colombia; dopo un breve rientro in patria, nel 1827 ripartì nuovamente per le Americhe, scegliendo una meta quasi vergine per la scienza: il Cile. Fu poi la volta delle Juan Fernandez, uno straordinario arcipelago oceanico che per qualche aspetto anticipa le darwiniane Galapagos, quindi di Tahiti; ma era l'ultimo viaggio: mentre faceva ritorno in Cile, la nave su cui era imbarcato si inabissò nell'Oceano Pacifico. Privo di sostegno da parte di sovrani o altre istituzioni pubbliche, finanziò le sue ricerche mantenendosi con la sua professione di medico. Anche se non pubblicò quasi nulla, il suo contributo alla conoscenza della flora del Nuovo mondo fu inestimabile. De Candolle, che gli fu amico e mentore, già al suo ritorno dalle Antille aveva voluto dedicargli Berteroa, un piccolo genere di Brassicaceae affine ad Alyssum che non ha nulla di esotico, essendo diffuso soprattutto nel Mediterraneo e nell'Asia occidentale.  Primo viaggio: Antille Fu forse l'indignazione per un gesto politico che calpestava un uomo che considerava un secondo padre e con lui le ragioni della scienza a spingere Carlo Giuseppe Bertero a trasformarsi in un cacciatore di piante. Nato a Santa Vittoria d'Alba nel fatidico 1789, era venuto a studiare medicina a Torino ed era divenuto uno dei più brillanti allievi di Giovanni Battista Balbis, cui lo legava un affetto quasi filiale. Nel 1814, quando il suo maestro fu cacciato dall'università e l'intera facolta di medicina fu epurata degli "infranciosati" (con il licenziamento di otto docenti su nove), Bertero decise di dare le dimissioni da segretario del Grand Jury (l'organismo che faceva le veci del Tribunale di Protomedicato) e di non continuare gli studi nel collegio medico dell'Università. Anche la monotona e soffocante provincia albese non sembrava offrirgli alcuna prospettiva. Tornato a casa, come l'eroe stendhaliano Fabrizio del Dongo, si trovò immerso in atmosfera stagnante, senza alcuna prospettiva. A soddisfare la sua sete di conoscenza non bastavano le escursioni botaniche sulle Alpi e nelle campagne di casa. Era ora di lasciare l'Italia per cercare altrove fama e conoscenza. Unico cordone ombelicale con una patria matrigna, la corrispondenza con gli amici, primi tra tutti il maestro Balbis e il colto botanico dilettante Luigi Colla che, come vedremo, furono poi i principali destinatari anche dei suoi invii di piante e semi. La prima tappa, quasi ovviamente, fu Parigi, dove poté sfruttare le relazioni di Balbis con i maggior botanici francesi per avere accesso al Jardin des Plantes e a erbari ricchi di piante esotiche; importante fu l'incontro con C.H. Persoon, grazie al quale trovò un imbarco per le Antille come medico di bordo. Si era preparato al viaggio con scrupolo, non solo studiando negli erbari la flora di quell'area, ma anche l'inglese e lo spagnolo. Imbarcatosi nell'agosto 1816 a Le Havre, a fine anno giunse in Guadalupa, salutato quasi come un eroe per aver salvato se stesso e molti compagni di viaggio da un'epidemia di febbre gialla scoppiata a bordo. Nell'isola esercitò con successo la professione medica e divenne una figura nota e riconosciuta, tanto che il governatore gli offrì la direzione dell'orto botanico e di un laboratorio di storia naturale. Nonostante la proposta fosse allettante anche sul piano economico, Bertero rifiutò per non legarsi a un singolo luogo e estendere la sua esplorazione ad altre isole dell'arcipelago. Privo di ogni sostegno ufficiale a causa della cecità dei Savoia, egli dovette dunque dividere il suo tempo tra la professione medica, che amava e esercitava con il tipico spirito umanitario della tradizione illuminista-giacobina, e le ricerche sul campo; altra difficoltà, la mancanza di testi di consultazione (all'epoca, non erano ancora state pubblicate i grandi repertori di de Candolle e Sprengel, che per le piante americane in modo diverso tanto dovettero proprio alle ricerche del nostro). Così, la sua avventura americana fu costellata di progetti e ripensamenti: in una lettera a Colla, annuncia che intende visitare sistematicamente tutto l'arco delle Piccole Antille (Marie-Galante, Dominica, Martinica, St. Lucia, St. Vincent, Barbados, Grenada, Tobago, Trinidad), per poi raggiungere il delta dell'Orinoco. Il percorso reale fu tutt'altro: lasciata Guadalupe nel luglio 1818, visitò due isole all'epoca sotto dominio danese, St. Thomas e St. Croix; passò poi a Porto Rico, lussureggiante per la flora, ma deludente per il dispotismo e l'arretratezza civile. Tra 1819 e 1820 visitò le due parti di Hispaniola, quella orientale ancora colonia spagnola, e quella occidentale, divenuta nel 1804 repubblica indipendente con il nome di Haiti. Da qui, tra 1820 e 1821, si spostò verso le coste dell’attuale Colombia. La guerra civile che imperversava nel paese lo spinse a lasciare quell'area di per sé promettente; dopo aver toccato ancora la Giamaica, a ottobre era di nuovo in Europa.  Il viaggio continua: Cile, Juan Fernandez, Tahiti Desiderava soprattutto incontrare Balbis (che ormai si era trasferito stabilmente a Lione) e riordinare le proprie collezioni. Probabilmente, pur non manifestando apertamente la sua delusione per rispetto del maestro, non fu soddisfatto nello scoprire che Balbis, invece di tenere riuniti gli esemplari che egli gli aveva inviato tra tante difficoltà, li aveva distribuiti, generosamente ma altrettanto sconsideratamente, agli studiosi interessati, disperdendo una collezione che solo chi l'aveva raccolta avrebbe potuto ordinare e catalogare in modo completo. Rientrato ad Alba alla fine dell'anno, erborizzò ancora intensamente in Piemonte, ma crescevano la frustrazione e il desiderio di ripartire. Nel 1825 collaborò con Moris che stava esplorando la flora sarda, ma pasticci burocratici trasformarono anche questa opportunità in un fallimento, nonostante gli ottimi rapporti personali con il collega. Quando, all'inizio del 1827, la morte della amata madre sciolse l'ultimo legame con il Piemonte, capì che era ora di mettersi di nuovo in viaggio. Cercava una meta poco battuta dai botanici, e su suggerimento di de Candolle, che incontrò a Parigi, scelse il Cile. In effetti quell'angolo del Sud America, se si escludono il viaggio di Feuillé all'inizio del Settecento e il capitolo sulla vegetazione nel Saggio sulla storia naturale del Cile dell'abate Molina, era quasi sfuggito ai botanici. Ancora una volta, Bertero dovette muoversi in modo individuale; è vero che a Parigi molti colleghi lo avevano blandito e corteggiato, ma egli dovette amaramente constatare che in realtà speravano di sfruttarlo per ottenere l'invio di qualche pianta rara; lo stesso de Candolle gli offrì del denaro per raccogliere piante per lui, proposta che egli respinse con sdegno, nonostante l'amicizia personale che lo legava allo svizzero. Accettò invece che pubblicasse le sue specie e le sue descrizione nel Prodromus, come male minore, prima che lo facesse qualcun altro. Strinse anche un accordo con il barone Delessert: dal Cile avrebbe inviato i suoi esemplari a lui, che avrebbe custodito le collezioni fino al ritorno di Bertero, distribuendo una copia ciascuno a Balbis, Colla, de Candolle e trattenendone una per sé. Tuttavia il pur ricco barone non finanziò il viaggio, che Bertero ancora una volta si pagò con la sua attività di medico. Anche in questo caso si imbarcò come medico di bordo; partito da Le Havre nella seconda metà di ottobre 1827, sbarcò a Valparaiso nel febbraio dell'anno successivo. Anche in Cile alternò all'attività di ricerca la professione medica, in condizioni tuttavia ben più difficili di quelle già complesse che aveva incontrato nelle Antille. Nel paese era difficile spostarsi per l'assenza di strade, il territorio battuto da banditi, la resistenza endemica degli indios mapuche; il livello culturale era basso (da un medico ci si aspettava che ti guarisse subito, altrimenti meglio gli intrugli tradizionali) e la natura ostile, con piogge incessanti e frequenti terremoti. In quegli anni, il territorio del Cile, ancora oggi un lungo petalo stretto tra le Ande e l'Oceano Pacifico, come ebbe a definirlo Neruda, aveva un territorio di circa un terzo di quello attuale, che rispetto alla capotale si estendeva per circa 500 km a Nord (fino a La Serena, ultima città prima del deserto di Atacama) e altrettanti a Sud (fino a Concepción, sulla foce del fiume Bío-Bío). Di fatto, i viaggi di Bertero dovettero limitarsi alla valle centrale; dopo essere vissuto per qualche tempo nei villaggi di Rancagua e San Fernando, si stabilì essenzialmente tra la capitale Santiago e il porto di Valparaiso, da dove partivano i suoi periodici invii di piante essiccate e semi per l'Europa. Per qualche tempo, a quanto pare, insegnò anche disegno naturalistico all'Instituto National e tra il 1828 e il 1829 pubblicò sulla rivista Mercurio cileno la sua unica opera edita, Lista de las plantas que han sido observadas en Chile por el Dr. Bertero en 1828, in cui passa in rassegna le piante da lui osservate nel paese, indicate con il nome latino e quello locale (prive di descrizione, non sono tuttavia valide ai fini dell'attribuzione del nome botanico). Tra le escursioni più ricche di scoperte quella che lo portò a risalire la valle andina del fiume Aconcagua, fino a Quillota. Nel 1829 o nel 1830 Bertero conobbe il viaggiatore inglese Alexander Caldcleugh, appassionato di mineralogia e di botanica. Costui, di ritorno da un viaggio in Brasile e Argentina, aveva visitato brevemente Más a Tierra, l’isola principale dell'arcipelago Juan Fernández, oltre 600 km al largo di fronte a Valparaiso. Nacque così l'idea di recarsi in quel luogo remoto e singolare, che insieme al nuovo amico il piemontese esplorò dal marzo al maggio 1830. Era la prima spedizione di un botanico professionista in una terra ricca di endemismi, dove egli raccolse 330 specie, di fatto quasi l'intero catalogo della flora dell'isola. Ma sulle Juan Fernández, oggi riserva della biosfera, vorrei tornare in un altro post, visto che non mancano le storie da raccontare. Si trattava di un'impresa di grande valore che forse avrebbe potuto aprire a Bertero le porte di un incarico prestigioso, come la direzione del Museo nazionale cileno. Tuttavia, proprio mentre il piemontese era a Más a Tierra, il governo liberale con il quale probabilmente aveva avuto contatti, come dimostrerebbe la sua collaborazione al Mercurio cileno, venne rovesciato e si impose un regime autoritario. Furono forse queste circostanze a spingere Bertero, privo di appoggi e credenziali internazionali, a partire per una meta ancora più remota: Tahiti. A proporglielo fu il belga Jacques Antoine Morenhout, che aveva stabilito un proficuo commercio di madreperla, legname, olio di cocco tra Cile e isole del Pacifico, con centro a Tahiti, dove aveva una casa. Poco sappiamo del soggiorno di Bertero a Tahiti, che dovette durare sei mesi; nell'aprile 1831, essendo venuto a sapere (con dieci mesi di ritardo) della rivoluzione di luglio in Francia, si imbarcò alla volta di Valparaiso, dove aveva lasciato i suoi materiali e da dove intendeva tornare in Europa. Ma la nave su cui si era imbarcato, appartenente a Morenhout, non arrivò mai in porto. Il belga ne concluse che doveva aver fatto naufragio dopo aver lasciato Raiatea, un'isola a 290 km a nord-ovest di Tahiti, da dove Bertero gli aveva inviato la sua ultima lettera il 15 aprile 1831. In ricordo, battezzò Bertero Reef, scogliera di Bertero, un gruppo di isolotti e scogli corallini della Polinesia francese dove verosimilmente potrebbe essere avvenuto il naufragio. Una sintesi della vita avventurosa del botanico piemontese nella sezione biografie. 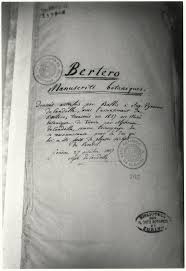 La dispersione delle collezioni Vicende altrettanto sfortunate ebbero le sue collezioni. Come ho già accennato, molti degli invii ricevuti dalle Antille da Balbis, furono da quest'ultimp dispersi tra numerosi colleghi; inoltre Balbis consegnò (prestò?) a de Candolle il diario di campo del viaggio che Bertero gli aveva donato, perché se ne servisse per la stesura del Prodromus (lo svizzero vi attinse a piene mani, talvolta anche riproducendo le descrizioni di Bertero parola per parola). Per fortuna, nel 1857, grazie a suo figlio Alphonse il prezioso manoscritto tornò a Torino; si tratta di 14 quaderni di campo, per un totale di oltre 1000 pagine, dove Bertero annotò 1746 raccolte, con una descrizione minuziosa, habitat, luogo di raccolta, nomi comuni, usi officiali locali, accompagnati talvolta da una discussione sistematica e tassonomica e da precisi disegni di dettagli morfologici. Le piante essiccate raccolte nelle Antille sono in parte confluite negli erbari di Colla e Balbis, ora presso l'Orto botanico di Torino, in parte disperse in dozzine di erbari sparsi per l'Europa. Non possediamo purtroppo i diari di campo relativi a Cile, Juan Fernandez e Tahiti. Dopo la morte del congiunto, gli eredi di Bertero misero all'asta i materiali conservati presso il barone Delessert (circa 15000 esemplari) e, benché i botanici torinesi fossero riusciti a raccogliere la somma necessaria tramite una sottoscrizione, ad aggiudicarseli fu una ditta tedesca che a sua volta li vendette tanto a istituzioni scientifiche quanto a collezionisti privati, disperdendo anche questa collezione. Un piccolo erbario di circa 400 esemplari rimase in Cile, dove costituisce la collezione più antica dell'erbario del Museo Nacional de Historia Natural di Santiago. A questo punto, il più importante depositario della memoria di Bertero rimase Colla, che sulla base degli invii dell'amico ne aveva pubblicato un parziale catalogo già nel 1829 in Plantae rariores ex regionibus chilensibus a clarissimo C. G. Bertero nuper detectae et ab. L. Colla in lucem editae. Ma anche su Colla tornerò in un altro post.  La modesta Berteroa Benché queste sfortunate vicende abbiano privato Bertero della gloria che sognava e ben meritava, il valore del suo lavoro non sfuggì ai botanici contemporanei, come dimostrano le varie dediche che ricevette in vita e dopo la morte. Intanto l'imponente numero di piante contrassegnate dagli specifici bereteroi, berteroanus (oltre 300) sta a dimostrare l'importanza del suo contributo alla conoscenza della flora delle Americhe. Tre sono i nomi specifici che gli sono stati dedicati (cui si aggiunge il fungo Berteromyces Ciferri). Il più antico (e unico oggi valido) è Berteroa, creato da de Candolle nel 1821, separando B. incana dal linneano Alyssum. Seguì nel 1854 E. G. von Steudel che, anagrammando la denominazione, creò Terobera (oggi sinonimo di Machaerina Vahl); infine nel 1919 O.E. Schulz assegnò una Brassicacea affine a Berteroa al nuovo genere Berteroella (oggi sinonimo di Stevenia). Il genere Berteroa, della famiglia Brassicaceae, comprende cinque specie di erbacee annuali, biennali o perenni di breve vita distribuite tra Mediterraneo e Asia occidentale, dall'Italia alla Turchia, con massima concentrazione nella penisola balcanica. La più nota è B. incana, un'erbacea abbastanza invasiva che si è infatti diffusa al di fuori dell'area originaria, per altro difficile da determinare, ed ora è presente dall'Europa occidentale fino alla Siberia; si è anche ampiamente naturalizzata negli Stati Uniti dove è considerata un'infestante. In Italia sono presenti tre specie, appunto B. incana (Italia settentrionale e forse centro-settentrionale, Basilicata), B. mutabilis (solo in Calabria), B. obliqua (Italia centro meridionale, a partire dal Lazio). Tendono a crescere in ambienti disturbati caldi e aridi; i fiori generalmente bianchi, portati su lunghi racemi, hanno quattro petali profondamente divisi e sono seguiti da silique ovoidali. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|









 RSS Feed
RSS Feed