|
Nella primavera del 2019, al termine di un lavoro di ricerca e restauro che ha coinvolto storici e botanici, nei giardini di Fulham Palace, la millenaria residenza dei vescovi londinesi, sono state aperte al pubblico "The Bishop Compton Beds", un gruppo di aiuole piantate con alcune specie che crescevano qui tra fine Seicento e inizio Settecento, ai tempi del vescovo Henry Compton. Figura politica di una certa influenza, Compton fu soprattutto un grande appassionato di piante esotiche, responsabile della prima introduzione di molte specie principalmente dalle colonie del Nord America. A ricordarlo, Comptonia peregrina, unica specie vivente di questo genere della famiglia Myricaceae.  Intrighi politici e piante esotiche Nel giugno 1688 al re d'Inghilterra, l'impopolare Giacomo II, nacque il sospirato erede maschio, che avrebbe ricevuto un'educazione cattolica. Si profilava l'incubo di una dinastia cattolica (e assolutista) sul trono inglese. Subito incominciarono a circolare voci secondo le quali il bimbo, nato morto, era stato sostituito con un altro neonato. Il 30 giugno 1688 sette uomini politici inglesi, poi passati alla storia come i Sette immortali, scrissero al principe Guglielmo d'Orange, nipote del re e marito di sua figlia Maria, fino a quel momento erede al trono, per sollecitarlo ad intervenire militarmente per sostenere i diritti della consorte. E' l'atto d'inizio della Gloriosa rivoluzione che portò alla cacciata di Giacomo II, alla salita al trono di Guglielmo III e Maria II e all'instaurazione di una monarchia parlamentare sancita dalla Dichiarazione dei Diritti del 1689. I sette altolocati nobiluomini erano tutti laici, ad eccezione di uno: Henry Compton (1632-1713), il vescovo anglicano di Londra. Niente da stupirsi, se consideriamo le sue fiere posizioni protestanti e il suo legame personale con William e Mary, di cui nel 1677 aveva anche officiato il matrimonio. Henry era il sesto e ultimo figlio di Spencer Compton, secondo conte di Northampton, che morì in battaglia durante la guerra civile, quando il ragazzo aveva solo undici anni. Più tardi egli viaggiò a lungo all'estero e rientrò in Inghilterra solo con la Restaurazione, quando per un breve periodo militò come cornetta in un reggimento di cavalleria. Dopo pochi mesi però decise di entrare al servizio della Chiesa e, dopo essersi laureato a Cambridge, nel 1661 prese gli ordini. Dopo tutta una serie di incarichi minori, nel 1674 fu nominato vescovo di Oxford; ma già l'anno successivo divenne decano della Cappella reale e dal dicembre 1675 vescovo di Londra. Questa rapida promozione è in genere attribuita, oltre alle sue origini altolocate, alla protezione di un altro dei futuri "immortali", il conte di Danby, di cui condivideva la difesa delle prerogative della Chiesa d'Inghilterra e le posizioni anticattoliche. Fu così che la vita del vescovo Compton incominciò a intrecciarsi con quella della principessa Mary e della sorella minore Anne. Il re Carlo II gli affidò infatti l'educazione religiosa delle nipoti, che Compton educò nella fede protestante (e forse anche nella passione dei fiori). Come vescovo, aveva posizioni molto liberali verso i dissidenti religiosi e sostenne anche economicamente i protestanti perseguitati che trovavano rifugio in Inghilterra; era invece ferocemente avverso ai cattolici. Ciò lo portò a scontrarsi con l'erede al trono, il duca di York (ovvero il futuro Giacomo II) che si oppose alla suo nomina ad arcivescovo di Canterbury e nel 1785, alla sua salita al trono, lo allontanò dalla Cappella reale e dal Consiglio privato; nel 1686, quando rifiutò di sospendere John Sharp, rettore di St Gile's-in-the-Fields, per i suoi scritti antipapisti, fu egli stesso sospeso. Aveva dunque più di una ragione per sostenere la causa di William e Mary, anche se nel maggio 1688 era stato reintegrato nell'ambito di una serie di provvedimenti con cui Giacomo aveva cercato di recuperare il consenso della Chiesa d'Inghilterra. Entrambe le principesse gli erano assai affezionate, in particolare lo era la più giovane, Anne. E fu proprio da lui che ella si rifugiò nel novembre 1688, pochi giorni dopo lo sbarco di Guglielmo in Inghilterra, per sottrarsi al padre e chiedere aiuto per raggiungere il marito, il principe danese Georg che si trovava ad Oxford (anche il loro matrimonio era stato officiato da Compton). Forse memore dei suoi trascorsi militari, il vescovo la scortò fino ad Osford, insieme al fido capo giardiniere George London e a un nutrito gruppi di armati. Nell'aprile 1689, essendosi rifiutato di farlo l'arcivescovo di Canterbury William Sancroft, fu ancora lui a incoronare William e Mary nella chiesa di Westminster. Sperava indubbiamente di essere ricompensato con la nomina a primate d'Inghilterra, ma quando nel 1690 Sancroft fu dichiarato decaduto proprio per quel rifiuto, la scelta dei sovrani cadde su John Tillotson; Compton ne fu così deluso da lasciare ogni attività politica. Nel 1792, quando Anne diventò regina, rientrò nel consiglio privato, fu nominato lord elemosiniere e membro della commissione per l'unione tra Inghilterra e Scozia, incarico che però non gli fu confermato; né, nel 1694, alla morte di Tillotson, la sua antica allieva gli concesse il sospirato arcivescovato di Canterbury. Ne fu così deluso da lasciare il partito whig per quello tory, ma soprattutto trovò consolazione nella passione per la botanica e il giardinaggio, che l'aveva accompagnato almeno dalla sua nomina a vescovo di Londra, quando aveva deciso di trasformare i giardini della residenza di Fulham, creandovi una ricchissima collezione di esotiche. Il giardino risaliva almeno al XVI secolo, cosa che ne fa il secondo giardino botanico per antichità della capitale inglese. Si dice che il vescovo Grindal (1519-1583) vi abbia introdotto le tamerici (Tamarix gallica) dalla Francia; di certo vi faceva coltivare dell'uva di cui faceva omaggio alla regina Elisabetta. Ma a renderlo famoso fu proprio Compton. Forse perché coinvolto nella ricostruzione di Londra dopo l'incendio del 1666 (come vescovo, si occupò della riedificazione della cattedrale di St Paul), Compton era particolarmente interessato all'introduzione di alberi da legname che potessero reintegrare il patrimonio forestale britannico. Fu così che nei terreni che si allungavano lungo il Tamigi (un appezzamento molto più vasto degli attuali 13 acri) creò uno dei primi arboreti a noi noti. A popolarlo erano soprattutto alberi rustici nordamericani; infatti, come vescovo di Londra, Compton era il responsabile dell'organizzazione della Chiesa nelle colonie americane; manteneva i contatti con i pastori, che sceglieva il più possibili tra persone interessate alle scienze naturali, e li incoraggiava a spedirgli piante utili o semplicemente curiose. Il più produttivo di questi collaboratori fu il pastore John Banister che aveva già una formazione botanica, avendola studiato a Oxford; tra 1683 e il 1688, grazie a lui fecero il loro arrivo a Londra i primi esemplari di Cornus amomum, Lindera benzoin, Liquidambar styraciflua, Acer negundo e soprattutto Magnolia virginiana, la prima magnolia a raggiungere l'Europa. Compton era amico e corrispondente di molti botanici e assiduo frequentatore, insieme al suo capo giardiniere, del Temple Coffee House Botany Club, un club informale di appassionati e naturalisti che forse a partire dal 1689 prese l’abitudine di riunirsi ogni venerdì presso un caffè londinese per discutere di botanica e mettere a confronto le proprie collezioni. Corrispondeva regolarmente con Jacob Bobart il giovane, il curatore dell'orto botanico di Oxford; apriva volentieri il suo giardino a botanici come Leonard Plukenet, che sicuramente descrisse alcune delle sue piante in Phytographia, John Ray, che incluse in Historia plantarum quindici novità, per lo più introdotte da Banister, e il farmacista James Petiver, che a sua volta faceva incetta di piante grazie a una vasta rete di capitani e chirurghi di marina. Fu sicuramente attraverso Petiver che Compton ottenne Rhus chinensis, inviato dalla Cina da James Cunningham. Altri alberi che dovette far piantare sono citati dai visitatori che li videro nei decenni successivi. Willam Watson, che nel 1755 ispezionò il giardino, notò grandi esemplari di Acer saccharinum, Gleditsia triacanthos, Juglans nigra, tutti americani, e il mediterraneo Pinus pinea. Nel 1766 il botanico scozzese John Hope visitò a sua volta il giardino e misurò alcuni alberi: una quercia da sughero di 40 piedi, un noce nero di 65 piedi e un acero rosso (Acer rubrum) di quasi 30 piedi. Egli cita anche vari alberi che quell'anno erano stati abbattuti per fare spazio a nuove costruzioni: Lindera benzoin, Acer negundo, Juniperus virginiana, nonché un cedro del Libano piantato nel 1683. Altre testimonianze citano Liridodendron tulipifera, Diospyros virginiana e. tra gli arbusti e i piccoli alberi, Rhododendron viscosum, Rhus typhina, Sassafras albidum, Crataegus crus-galli, tutti probabilmente giunti a Londra grazie a Banister. C'erano anche altre mediterranee, come Celtis australis, Cercis siliquastrum, Phillyrea latifolia, Più difficile sapere che cosa il vescovo facesse coltivare nelle aiuole e nella magnifica serra, di cui non conosciamo né l'ubicazione né le dimensioni, benché i contemporanei ne parlino con ammirazione. Le collezioni dovevano comprendere almeno un migliaio di specie, ma andarono disperse subito dopo la morte di Compton (avvenuta nel 1713); le rarità da serra furono da lui lasciate in eredità all'orto botanico di Oxford, ma nessuna è sopravvissuta e non ne conosciamo nemmeno la lista. Qualche indizio ce lo forniscono diverse testimonianze più o meno dirette. Tra il 1675 e la morte nel 1682, visse a Fulham il pittore Alexander Marshal, famoso per i suoi dipinti di fiori e piccoli animali; tra gli altri dipinse tulipani, garofani e Primula auricola in forme variegate e doppie che potrebbero aver fatto parte della collezione di Compton. Petiver cita una pianta di goji (Lycium barbarum), arrivata evidentemente dalla Cina, mentre l'architetto John Evelyn, che visitò la serra nel 1681, vi poté ammirare un Sedum arboreum in fiore (oggi Aeonium arboreum) giunto da Madera. C'era anche una Passiflora caerulea e Clematis hederacea (oggi identificata come Campsis radicans). La maggior parte delle esotiche da serra dovevano però essere passate attraverso l'Olanda, con la quale, come sostenitore di William e Mary, Compton dovette avere intense relazioni. Nel 1691 si recò ad Amsterdam insieme a Guglielmo III e gli fu donato un florilegio, noto come Compton Codex e oggi custodito al British Museum, con una quarantina di disegni di piante sudafricane raccolte durante la spedizione in Namaqualand del 1685-86; a sua volta egli donò all'orto botanico di Amsterdam varie specie americane che allungano la lista di alberi e arbusti di oltre oceano: Aralia spinosa, Euonymus americanus, Physocarpus opulifolius, Taxodium distichum, Yucca aloifolia f. draconis. Il vescovo dovette invece riportare con sé dall'Olanda una notevole collezione di Pelargonium (tra quelli identificati, P. triste e P. capitatum) e alcune delle novità recentemente portate da Hermann dalla colonia del Capo, come Hermannia althaeifolia e la calla Zantedeschia aethiopica. Arrivava sicuramente dalle serre dell'orto botanico di Amsterdam l'allora ancora rarissima pianta di caffè, e probabilmente anche un ammirato Cereus che apriva i suoi fiori di notte. I vescovi di Londra hanno abitato a Fulham per oltre 1000 anni, dall'VIII secolo al 1975, quando il palazzo e i giardini sono stati ceduti alla municipalità di Hammersmith. All'inizio del secolo è iniziato un vasto programmi di restauri che ha coinvolto sia il palazzo sia i giardini, finanziato con i proventi della Lotteria Nazionale. Nel 2019 sono state aperte al pubblico aiuole (The Bishop Campton Beds) piantate con alcune specie coltivate ai tempi del vescovo Compton; tra gli alberi - quasi tutti a limitato sviluppo per non ombreggiare eccessivamente le altre specie - Diospyros virginiana, Celtis australis, Cercis siliquastrum e, ovviamente, Magnolia virginiana; tra gli arbusti, Rhododendron viscosum, Rhus typhina, Crataegus crus-gallii; ai loro piedi, tra le altre, Zantedeschia aetiopica, Asarum canadense, Adiantum pedatum, Dicentra cucullaria, Trillium sessile, Mertensia virginica. A giudicare dalle fotografie, per ora le aiuole appaiono ancora piuttosto spoglie, ma sono appunto recentissime.  Un fossile vivente Anche se, come abbiamo visto, le collezioni di Compton furono disperse subito dopo la sua morte, il lascito del vescovo al giardinaggio inglese è imponente. Sandra Morris, che, basandosi sulle citazioni di Ray e Plukenet, l'erbario di Petiver confluito in quello di Sloane e le testimonianze di Watson e Hope, tra il 1991 e il 1993 ha pubblicato su "Garden History" due articoli, dedicati rispettivamente a alberi e arbusti il primo, alle piante erbacee il secondo, è riuscita a identificare 89 alberi o arbusti e 61 erbacee. Per diverse specie, la loro presenza a Fulham, retrodata l'introduzione in Inghilterra di parecchi decenni. Il vescovo meritava dunque l'omaggio di un genere botanico. A pensarci fu L'Héritier de Brutelle; ma dato che il nuovo genere avrebbe dovuto essere pubblicato nel secondo fascicolo di Stirpes novae che non uscì mai, a pubblicarlo per primo in Hortus kewensis (1789) fu Aiton, che precisa anche che la pianta in questione, Comptonia asplenifolia, fu introdotta in Inghilterra nel 1714, l'anno dopo la morte del vescovo, da un'altra grande collezionista, la contessa di Beaufort, una degli acquirenti della collezione di Compton. Oggi la pianta si chiama Comptonia peregrina ed è l'unico rappresentante vivente del genere Comptonia, famiglia Myricaceae. I paleontologi ne hanno identificato dozzine di specie fossili, distribuite in tutto l'emisfero settentrionale, la più antica delle quali risale al Cretaceo, 65 milioni di anni fa. Si tratta dunque di un vero fossile vivente, oggi confinato al Nord America orientale (dalla Nuova Scozia e al Manitoba a nord alla Georgia settentrionale a sud). E' un arbusto alto da un metro a un metro e mezzo, che si espande attraverso rizomi, con foglie dai margini dentati che ricordano singolarmente quelli delle felci, da cui il nome comune sweet fern, "felce dolce". L'aggettivo si riferisce al soave profumo delle foglie, percepibile anche a una certa distanza, dovuto alla presenza di oli essenziali. Per lo più monoica, porta in genere fiori femminili e maschili su piante diverse; i primi sono dei piccoli gattici arrotondati con brattee rossastre, mentre i secondi, più vistosi, sono gattici allungati giallo-verdastro. Dove trova le condizioni adatte, può formare dense colonie. Pianta adattata al freddo, è più comune nel settore più settentrionale dell'areale, dove cresce soprattutto in foreste aperte di conifere con suolo povero e acido, mentre più a sud ha una distribuzione sparsa, su suolo sabbioso, in praterie, savane e boscaglie, talvolta in querceti e pinete aperte, anche periodicamente allagati. Come adattamento agli incendi, produce semi che rimangono dormienti per decenni e germinano solo quando un incendio offre condizioni ottimali, riducendo la competizione degli alberi e degli arbusti più alti. Come adattamento a suoli poveri, è invece in grado di fissare i nitrati grazie a noduli delle foglie che non ospitano micorrize ma batteri. Qualche informazione in più nella scheda.
0 Comments
Il missionario William Carey è una personalità molto nota della storia indiana. Prodigioso poliglotta, tradusse e pubblicò il Vangelo e la Bibbia in molte lingue del subcontinente, creò una tipografia, una rete di scuole, la prima università indiana. Forse è meno noto che era un appassionato botanico e un agronomo sperimentatore, e come tale fu tra i soci fondatori della Società agricola indiana, di cui dettò gli obiettivi. Il suo giardino botanico privato era il più ricco dell'India, secondo solo a quello della Compagnia delle Indie diretto dal suo amico William Roxburgh, a cui Carey donò per altro molte piante. Roxburgh ricambiò con la dedica di Careya, ma Carey lo contraccambio con un inestimabile servizio postumo: la pubblicazione di Flora indica. Una missione rivoluzionaria Nel 1755, la Compagnia danese delle Indie Orientali, in cambio di cinquemila rupie e vari doni, ottenne dal Nawab del Bengala il permesso di commerciare e di stabilire un emporio e un porto. Poté così installarsi a Serampore sulla riva dell'Hoogly, uno dei bracci del delta del Gange, un piccolo centro circondato da villaggi agricoli che già da secoli ospitava un mercato frequentato da portoghesi, olandesi e francesi. Con l'impegno di versare una tassa annuale e di far rispettare la legge e l'ordine, vi creò una minuscola stazione commerciale battezzata Frederiksnagore in onore del re di Danimarca Federico V (anche se è per lo più nota come Serampore). Rispetto a altre città dell'area controllate dalle compagnie francesi e inglesi, era insignificante ma i danesi furono abili a sviluppare attività artigianali e mercantili, attraendo mercanti europei e migliaia di indiani, impiegati soprattutto come tessitori. Nel 1777 l'amministrazione di Serampore passò alla corona danese. Grazie all'abile governatore Ole Bie (1776-1805) la cittadina conobbe un eccezionale sviluppo urbanistico, tanto da essere descritta dai contemporanei come la città più elegante e meglio amministrata dell'India europea. Gli affari andavano a gonfie vele, la presenza danese favoriva lo sviluppo dell'artigianato tessile e incise anche sull'agricoltura: i contadini vennero infatti incoraggiati ad affiancare alla traduzionale coltivazione del riso, quella l'indaco (Indigofera tinctoria), utilizzato nella tintura delle stoffe. Nel 1799 Ole Bie permise a un gruppo di missionari battisti britannici di stabilirsi a Serampore. I primi missionari battisti, John Thomas e William Carey, era arrivati a Calcutta nel 1793, ma avevano dovuto scontrarsi con l'ostilità della Compagnia inglese delle Indie che temeva che la loro attività di proselitismo causasse insanabili attriti con gli indiani; inoltre, come non conformisti con idee sociali avanzate, erano visti come pericolosi sovversivi. Il governatore Bie invece contava su di loro per creare una scuola aperta ai ragazzi tanto indiani quanto europei; per i missionari sarebbe stato un asilo dove iniziare finalmente la sospirata attività di proselitismo. A fondare la missione furono tre energici personaggi, noti come il "trio di Serampore": il maestro Joshua Marsham, il tipografo William Ward e il più famoso di tutti, il reverendo William Carey (1761-1834), una figura così eccezionale che il filantropo William Wilberforce lo definì "una delle principali glorie della nazione britannica", mentre Rabindranath Tagore lo salutò "padre del Bengala moderno". Figlio di un tessitore, nacque in un piccolo villaggio del Northamptonshire dove non esistevano scuole, finché, quando aveva sei anni, suo padre venne assunto dalla parrocchia come funzionario e maestro. Da lui ricevette una sommaria istruzione, rivelando un precoce talento per le lingue (imparò il latino da autodidatta) e un grande interesse per la natura, specialmente per gli insetti e le piante. A quattrodici anni fu collocato come apprendista presso un calzolaio e uno dei suoi compagni lo avvicinò all'ambiente dei dissidenti religiosi. Passò quindi a lavorare per un calzolaio battista; ne abbracciò la fede e ne sposò la cognata, una giovane donna analfabeta. Alla morte del padrone, ne rilevò la bottega; sempre più coinvolto nelle attività della congregazione battista, studiò i testi sacri e imparò da autodidatta altre lingue: il greco, l'ebraico, l'italiano, l'olandese e il francese, sempre con un libro sotto mano mentre fabbricava scarpe. Nel 1785, come mastro si trasferì in un villaggio più grande dove venne invitato a servire come pastore; lo diverrà a pieno tempo nel 1789. Intanto aveva incominciato a interessarsi sempre più alle attività missionarie. Nel 1792 grazie al finanziamento di un amico e correligionario pubblicò An Enquiry into the Obligations of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens, un vero e proprio manifesto in cui sostenne che ogni cristiano deve farsi apostolo del messaggio di Cristo. Lo stesso anno fu tra i fondatori della Società battista per la propagazione del Vangelo (poi nota come Baptist Missionary Society) e nel 1793, con la moglie e i figli, partì per l'India insieme al medico John Thomas. Pensava di mantenersi come agricoltore e portò con sé bulbi e semi di piante orticole e alimentari; anche in questo campo era un colto autodidatta: conosceva la classificazione linneana, e aveva una certa esperienza di raccolta sul campo. Giunto in India nel novembre 1793, venne a sapere che in seguito alla morte del colonnello Kyd il posto di intendente del giardino della Compagnia delle Indie era vacante. Si precipitò a Calcutta per presentare la sua candidatura, ma scoprì che era già stato designato William Roxburgh. La cosa non lo amareggiò, anzi andò a fargli visita: fu l'inizio di una grande amicizia. Carey scoprì ben presto che, a causa dell'ostilità della Compagnia delle Indie, gli era impossibile predicare; anche Thomas abbandonò l'impresa. Grazie a un amico, fu assunto come sovrintendente di una piantagione di indaco a Madnabati, dove visse per sei anni. Fu così testimone della miserevole condizione dei contadini indiani e si convinse che fosse compito degli inglesi risollevarla introducendo strumenti migliori e nuove coltivazioni. Vi creò un orto botanico e come l'amico Roxburgh, fece molti esperimenti agricoli. Scriveva agli amici in Inghilterra per ottenere pianticelle di piante da frutto e semi di ortaggi; da Roxburgh ebbe alberi di cannella, noce moscata, teak; a sua volta gli inviava esemplari che raccoglieva in natura. Tra di essi l'albero di sal, che nel 1798 Roxburgh pensò di dedicargli con il nome di Careya saulea. Carey respinse l'omaggio, sia per modestia sia nella convinzione che le piante debbano conservare i nomi indigeni; in effetti, le sue proteste furono accolte e la pianta fu rinominata Shorea robusta (dal nome sanscrito sarja). Furono anni durissimi che gli costarono la perdita di un figlio di cinque anni e l'alienazione mentale della prima moglie. Non aveva certo dimenticato lo scopo per cui era venuto in India; si preparò alla missione imparando il sanscrito e il bengali e tradusse in quest'ultima lingua il nuovo testamento. Dall'Inghilterra giunsero altri confratelli, in particolare Marsham e Ward che nel 1799 lo precedettero a Serampore; acquistarono una grande casa che doveva ospitare sia le loro famiglie sia i locali della scuola. Carey con la moglie e i figli superstiti li raggiunse all'inizio del 1800 portando con sé una macchina da stampa procuratagli dal proprietario della piantagione di Madnabati. Ad occuparsi della scuola furono soprattutto Joshua Marsham e sua moglie Hannah: era aperta a tutti, senza badare alla religione o alla casta: fu l'inizio di una vasta rete di scuole in lingua bengali che nel 1818 ne contava 92 frequentate da 10.000 alunni. Intanto anche la Compagnia delle Indie incominciava a convincersi che i missionari di Serampore non costituivano un pericolo, anzi potevano tornare utili per dare una patina di credibilità alla sua immagine offuscata. Nel 1801 il governatore Wellesley lo chiamò a insegnare bengali al Fort William College, una scuola dove i funzionari della Compagnia studiavano le lingue, le culture, le tradizioni e la storia dell'India. Continuò a dedicarsi con zelo allo studio del maggior numero possibile di lingue indiane e alle traduzioni e insieme a Ward creò una casa editrice, che iniziò la sua attività con la stampa del Nuovo testamento in bengali da lui tradotto; seguirono il Nuovo testamento in sanscrito, in marathi, in panjabi, e l'intera Bibbia in bengalese. Entro il 1835, l'anno successivo alla morte di Carey, la Bibbia era stata tradotta e stampata in non meno di 42 lingue e dialetti. Ma non si pubblicavano solo testi religiosi: nello stesso arco di tempo, la casa editrice giunse a stampare oltre 200.000 volumi: c'erano classici della tradizione indiana come il Mahabaratha e il Ramayana, grammatiche, lessici e dizionari per l'uso del Fort William College, ma anche - come vedremo meglio tra poco - testi scientifici. A partire dal 1818 venne anche pubblicato un quotidiano bilingue, in inglese e bengali. Anche se nel 1812 un devastante incendio distrusse manoscritti, carta, set di caratteri tipografici, le macchine da stampa si salvarono; la tipografia rimase ufficialmente attiva fino al 1837, ma anche dopo questa data uscì ancora occasionalmente qualche volume. Nel 1818 Carey, Marsham e Ward fondarono il Serampore College, destinato sia ai futuri pastori, sia a studenti di "ogni casta, colore o paese". Posto inizialmente sotto la giurisdizione danese, quindi passato sotto controllo britannico dal 1845, è considerato la prima università indiana, di cui ha costituito un duraturo modello. 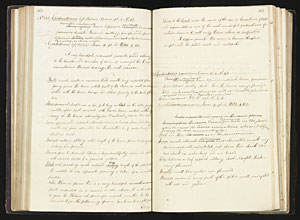 Carey e Roxburgh: una collaborazione fraterna Per Carey, la coltivazione di un giardino era una passione, un svago salutare per la mente e il corpo, ma lo studio delle scienze naturali aveva anche un risvolto religioso: la lettura del libro della natura avvicina a Dio quanto quella della Bibbia. Al suo arrivo a Serampore, portò con sé le piante che coltivava a Madnabati e creò un orto botanico privato; più tardi, quando in seguito a dissidi con la casa madre in Inghilterra lasciò la Baptist Missionary Society e si trasferì nel College, vi spostò anche il giardino. Misurava cinque acri, vantava una collezione di migliaia di piante (seconda solo a quella del giardino di Calcutta della Compagnia delle Indie), quattro vasche per le piante acquatiche, voliere per gli uccelli. Dopo la sua morte (1834), divenuto giardino del Serampore College, fu posto sotto la direzione di Joachim Otto Voigt, che ne scrisse il catalogo, insieme a quello dell'orto botanico di Calcutta (Hortus suburbanus Calcuttensis, 1845). Alcune piante erano state raccolte dallo stesso Carey, molte le aveva ottenute dai suoi corrispondenti, molto numerosi tanto in India quanto all'estero, grazie alla rete delle missioni e ai suoi contatti con studiosi, proprietari terrieri e filantropi indiani. Collezionava anche acquarelli di piante e insetti dipinti da artisti indiani, di alcuni dei quali fece dono alla Linnean Society di Londra di cui divenne membro nel 1823. Fin dai tempi di Madnabati, era molto interessato ai risvolti pratici della botanica e all'agricoltura; per sostenere la missione, progettò una piantagione di alberi da legname, cui dovette rinunciare perché la Compagnia delle Indie non concesse i terreni. Nel settembre 1820, su sollecitazione di lady Hastings, la moglie del governatore generale dell'India, insieme a Joshua Marsham e altri due europei fondò l'Agricultural and horticultural society of India, che entro un mese, posta sotto il patronato di lord e lady Hastings, che concessero anche un terreno sperimentale a Barrackpore, contava già cinquanta soci, metà europei e metà indiani. Gli obiettivi della società, fissati dallo stesso Carey, includevano il miglioramento dei terreni, tramite metodi di coltivazione più avanzati, incluse le più efficienti tecniche di rotazione delle culture; l'introduzione di nuove piante utili; il miglioramento delle attrezzature; il miglioramento degli animali agricoli; la bonifica e la coltivazione dei terreni abbandonati. Fin da quando si conobbero nel 1793, la collaborazione tra Carey e William Roxburgh fu strettissima. Il missionario considerava il suo stesso giardino quasi una succursale dell'orto botanico di Calcutta cui donò non meno di ottanta esemplari. Tra di essi, forse il più notevole è l'himalayana Rosa clinophylla (che Roxburgh chiamava R. involucrata) da lui spedita al giardino di Calcutta nel 1797; negli anni venti, ne inviò un esemplare anche a Hooker, all'epoca direttore dell'orto botanico di Glasgow. Nel 1813, quando Roxburgh, lasciò l'India nella speranza di recuperare la salute (sarebbe purtroppo morto poco più di un anno dopo) gli affidò due manoscritti: il catalogo dell'orto botanico di Calcutta Hortus Bengalensis e la sua monumentale Flora indica. Il primo fu pubblicato dalla tipografia di Serampore già nel 1814, con una prefazione dello stesso Carey. Durante il suo servizio in India (dal 1773 al 1813, interrotti solo da due brevi soggiorni in patria) Roxburgh descrisse circa 2600 specie, e di circa 2500 fece preparare i disegni. Nel 1795, quando da poco si era trasferito a Calcutta, una selezione di cento piante da lui raccolte in Cormandel fu pubblicata a spese della Compagnia delle Indie nel primo volume di Plants of the Coast of Coromandel, sotto la direzione di Joseph Banks e con la prefazione di Patrick Russell. Seguirono, a lunghi intervalli di tempo, altri due volumi, in tutto trecento piante; l'ultimo uscì nel 1819, dopo la morte di Roxburgh. Negli anni di Calcutta, quest'ultimo aveva continuato a lavorare alla sua Flora indica, un grosso manoscritto con 2542 descrizioni botaniche di cui preparò due copie. Per prudenza, tornando in patria una la portò con sé, con l'intenzione di completarla e prepararla per la stampa, l'altra la affidò a Carey. Durante il viaggio, aggiunse ancora alcune descrizioni, e inviò copia anche di queste a Carey. Le gravi condizioni di salute e la morte però gli impedirono di attuare il suo proposito. Non trovandosi in Inghilterra nessuno disposto a pubblicarlo (Plants of the Coast of Coromandel, tre volumi in folio con illustrazioni a piena pagina, si era rivelato costosissimo), Carey decise di stamparlo nella tipografia di Serampore. Con l'aiuto di Nathaniel Wallich (assistente di Roxburgh e suo successore alla testa dell'orto botanico di Calcutta dal 1817) che aggiunse le sue note, ne pubblicò una parte in due volumi, usciti rispettivamente nel 1820 e nel 1824. Nel 1832, su richiesta dei figli di Roxburgh, visto che ancora mancava un'edizione inglese, pubblicò l'intera opera in tre volumi, questa volta senza le note di Wallich. Tanto la prima edizione parziale, quanto la seconda edizione integrale per ragioni di costi furono stampate senza illustrazioni. Anche così, è un'opera fondamentale, fondativa della botanica indiana, di cui Roxburgh è considerato il padre.  Un albero dai molti usi Se Carey aveva rifiutato la dedica dell'albero di sal, dovette accettare un secondo omaggio di Roxburgh che nel 1811 nel secondo volume di Plants of the Coast of Coromandel gli intitolò il genere Careya sulla base di un esemplare di C. erbacea, raccolto dal missionario in Bengala e da lui inviato all'orto botanico di Calcutta; Roxburgh ricorda queste circostanze e aggiunge "nominata per il suo scopritore, un buono botanico, e un promotore della storia naturale in generale". Se avesse dovuto far propria la propensione di Carey per le denominazioni indigene, avrebbe dovuto chiamarla Kumbhaadu-lataa. Il genere Careya (famiglia Lecythidaceae) comprende tre specie, distribuite tra Afghanistan, isole Andamane, subcontinente indiano, Indocina e Malaysia. C. herbacea è un'erbacea perenne diffusa dalle pendici himalayane al Bengala; C. valida, un albero endemico delle isole Andamane. La specie più nota è però C. arborea, anch'essa descritta da Roxburgh. E' un bell'albero da medio a grande, deciduo, con le foglie che diventano rosse prime della caduta. Produce vistosi fiori a coppa crema o bianco verdastro con lunghissimi stami e filamenti sterili, porpora o soffusi di rosso alla base. All'epoca del Raj, la sua corteccia fibrosa veniva usata per gli stoppini dei fucili. Nella medicina tradizionale indiana, la corteccia e i fiori, ricchi di mucillaggini, trovano impiego per le loro proprietà astringenti. In Myanmar le grandi foglie vengono usate per fabbricare i tradizionali sigari detti cheroot, ma fermentate entrano in alcune specialità culinarie. In Tailandia invece le foglie giovani e i boccioli si consumano freschi in insalata. Il frutto è edule (tanto che l'albero è noto come guaiava selvatica) ma si ritiene che i semi siano lievemente tossici. Per accattivarsi il favore di sovrani, uomini politici e potenti, da cui dipendevano finanziamenti e incarichi prestigiosi, i botanici sono stati prodighi di dediche di generi, spesso scelti tra i più vistosi. Non fa eccezione neppure Napoleone, che anzi ha collezionato ben tre dediche. Ad aprire la lista sono gli spagnoli Ruiz e Pavón che già nel 1802 intitolano all'allora primo Console Bonapartea. Niente di strano: i due non andavano tanto per il sottile con le dediche, e le elargirono generosamente ai potenti di turno, adattandosi di volta alla linea politica del momento; all'epoca, la monarchia spagnola era alleata con la Francia e si trattava di ingraziarsi, più ancora che lo stesso Napoleone, il ministro filofrancese Godoy (lui stesso dedicatario di Godoya). Nel 1804, l'anno in cui Bonaparte si autoincorona imperatore, arriva un omaggio ben più sorprendente: il botanico Palisot de Beauvois, un nobile vittima della rivoluzione, battezza pomposamente Napoleonaea imperialis un singolare alberello da lui scoperto in Africa. Il personaggio è tale che la dedica non può essere liquidata come plateale adulazione, e vale la pena di approfondire. Non stupisce (tranne che nel nome) che lo stesso anno Ventenat, che al momento era nel libro paga di S. M. l'Impératrice, abbia voluto metterci anche del suo con Calomeria. E poi, tutto sommato, i meriti di Napoleone agli occhi degli scienziati, inclusi i botanici, non erano pochi. 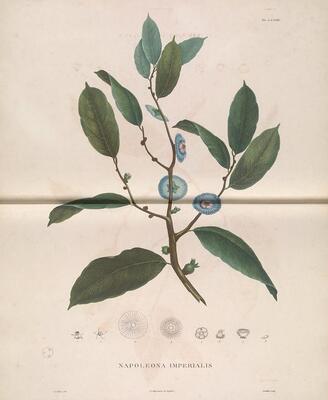 Un'adulazione smaccata? Il due dicembre 1804, con un gesto clamoroso, Napoleone Bonaparte incoronò se stesso Imperatore dei francesi. Culminava così un lungo processo, iniziato il 18 maggio, quando il Senato aveva mutato la costituzione trasformando la Repubblica in impero ereditario; immediatamente dopo la decisione era stata sancita dal plebiscito i cui risultati furono proclamati il 6 novembre: risultati ovviamente... plebiscitari, con 99,76% di voti favorevoli e solo 2569 contrari. In mezzo a queste date, il botanico Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois allestì la sua personale corona per Napoleone: una corona di petali (o almeno luio credeva così), quelli di una pianta che aveva raccolto in Africa. Dopo averla preannunciata in una seduta dell'Institut de France di ottobre, pubblicò scoperta e dedica verso la fine di dicembre, a incoronazione avvenuta, nell'opuscolo Napoléone impériale: Napoleonaea imperialis. E' una esplicita scelta di campo, dal significato eminentemente politico; il sottotitolo "Primo genere di un nuovo ordine di piante: le Napoleonée" non lascia dubbi. Napoleonaea inaugura una nuova famiglia di piante, esattamente come Napoleone inaugura un regime senza precedenti e una nuova dinastia: "Per essere un re si devono ereditare vecchie idee e genealogie. Io non voglio discendere da alcuno." Come dobbiamo leggere la plateale dedica di Palisot de Beauvois? E' la più smaccata delle adulazioni? O l'espressione di un entusiasmo reale, del resto condiviso - al netto della propaganda e della repressione - da una grande maggioranza di francesi? Certo non possiamo escludere l'interesse. All'epoca Palisot de Beauvois versava in una situazione economica molto difficile. Un tempo ricco possidente terriero, era stato rovinato dalla rivoluzione, da un amministratore incapace (o piuttosto interessato e disonesto) e da un divorzio; tornato in Francia dopo una serie di viaggi avventurosi e un lungo esilio, aveva in programma di pubblicare degnamente le sue scoperte in una serie di opere illustrate, corpose e costose: la sua Flore d'Oware et de Benin incominciò ad uscire proprio nel 1804; l'anno successivo seguì il primo volume di Insectes recueillis en Afrique et en Amérique. Cerro sperava anche che l'appoggio di Napoleone e dei suoi corifei scientifici gli garantisse l'ammissione come membro effettivo (con tanto di stipendio) dell'Institut de France (che aveva incorporato l'Accademia delle scienze), di cui era da tempo membro corrispondente. Eppure, a leggere le biografie e le testimonianze su Palisot de Beauvois, il tipo di cortigiano leccapiedi non sembra calzargli affatto (al contrario di tanti anche più famosi colleghi, a cominciare da Laplace). Nobile, durante la rivoluzione si era trovato proscritto e privato di tutti i suoi beni ed aveva potuto rientrare in Francia solo alla fine del 1798, quando il suo nome era stato cancellato dalle liste degli emigrati (un provvedimento che anticipa l'amnistia generale concessa da Napoleone primo console nel 1802). Di Napoleone certamente apprezzava la politica di conciliazione nazionale, ma anche di ritorno all'ordine dopo gli eccessi rivoluzionari. Feroce difensore dello schiavismo, che per le proprie posizioni aveva rischiato di essere messo a morte durante la rivolta di Haiti, gradiva particolarmente che egli avesse ristabilito la schiavitù nelle colonie, a suo parere follemente abolita dai rivoluzionari. Dunque, la dedica riflette probabilmente l'adesione al progetto politico di Napoleone, che rimarrà costante e sincera anche in tempi difficili, come conferma un fatto inequivocabile: nel 1815, durante i Cento giorni, il traballante Napoleone si fidava tanto della sua fedeltà che lo nominò consigliere per l'Università. 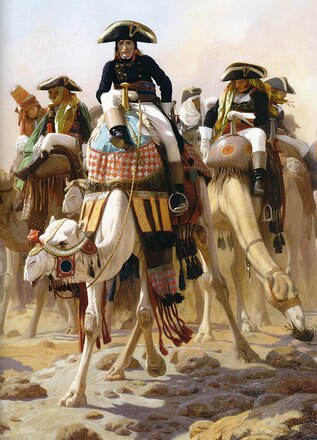 Napoleone e la scienza Oltre a considerazioni di ordine più generale, avrà pesato anche la politica culturale del nuovo imperatore che aveva fatto della scienza un importante tassello della sua propaganda e aveva valorizzato il ruolo politico e sociale degli scienziati, tanto che Eric Sartori ha definito quello napoleonico "l'impero delle scienze". Lo era, secondo lo studioso francese, da tre punti di vista: il dominio scientifico a livello europeo; la formazione e la passione scientifica dell'imperatore stesso; il ruolo politico assegnato all'élite scientifica. Quanto al dominio scientifico, la Parigi napoleonica è indubitabilmente la capitale della scienza: Laplace rivoluziona l'astronomia, i vari Berthollet, Fourcroy, Gay-Lussac portano avanti la rivoluzione della chimica inaugurata da Lavoisier, l'abate Haüy studia la struttura dei cristalli, Daubenton e Lacépède proseguono l'opera di Buffon, Fourier fa avanzare l'analisi matematica, Cuvier getta le basi della paleontologia, Lamarck e Saint-Hilaire preparano l'evoluzionismo. Parlando poi di Bonaparte, l'interesse per la scienza è una costante della sua vita, da quando ragazzo era considerato il migliore matematico della scuola militare fino all'esilio di Sant'Elena, quando riempiva le giornate leggendo la Storia naturale di Buffon, il trattato di astronomia di Delambre o il corso di chimica di Fourcroy (gli ultimi due, per altro, pubblicati grazie a lui). Veniamo al terzo punto, anche se nel breve spazio di un post dovremo limitarci a qualche cenno. Già durante la Campagna d'Italia Napoleone intraprende una vera propria opera di seduzione verso gli scienziati, chiamati a sostituire le vecchie classi dirigenti e a formare una nuova élite fondata non sul sangue e sul privilegio, ma sul talento e il sapere. A Milano, frequenta artisti, letterati e scienziati, invita alle propria tavola Volta e Spallanzani, incoraggia gli scienziati ad assumere un nuovo ruolo sociale: "A Milano gli scienziati non godono della considerazione che spetterebbe loro. Ritirati nel fondo dei loro laboratori, si ritengono fortunati se i re e i preti si limitano a non offenderli. Ma oggi non è più così: in Italia il pensiero ora è libero. Non ci sono più né Inquisizione, né intolleranza, né despoti. Invito gli studiosi a riunirsi e ad espormi le loro idee sui mezzi da adottare, o sui bisogni che emergeranno, per dare alle scienze e alle arti una nuova vita e una nuova esistenza. Tutti quelli che vorranno venire in Francia saranno accolti con distinzione dal governo. Il popolo francese valuta molto di più l'acquisizione di un matematico [...] che la conquista della città più ricca e più popolosa". Ovviamente questi proclami democratici fanno da paravento alla spogliazione del patrimonio culturale italiano; in nome della fratellanza e della libertà, a prendere la via di Parigi non sono solo quadri e statue, ma anche biblioteche intere, collezioni scientifiche, erbari e piante vive (attese con trepidazione da sua moglie Joséphine, grande appassionata di piante e giardini). Tra i "commissari governativi" che dirigono la spogliazione ci sono il grande matematico Monge (uno degli insegnanti di Napoleone alla scuola militare) e il chimico Berthollet; entrambi si legano a Bonaparte e nel 1797 ne propongono la candidatura all'Institut de France per la sezione meccanica. L'elezione del brillante generale, che non ha scritto una riga né di meccanica né di altre scienze al contrario dei candidati sconfitti, è tutta politica, primo atto della sua alleanza con l'establishment scientifico. Il secondo atto è la spedizione in Egitto (1798-1801); insieme ai soldati, ci sono 167 savants: disegnatori, architetti, ingegneri, geometri, cartografi, astronomi, chimici, mineralogisti, zoologi e botanici; divisi nelle quattro sezioni di matematica, fisica, economia politica, letteratura e arti, devono studiare e descrivere ogni aspetto dell'Egitto del passato e del presente: la geografia, la flora, la fauna, le risorse minerarie, l'arte, la società. A reclutarli a stato proprio Monge - assistito ancora da Berthollet e dal matematico Fourier - che li ha contattati e convinti in segreto (la missione era coperta dal segreto militare). In genere sono molto preparati, giovani, di salute robusta, ma una ventina di loro perirà durante la missione. Tralasciando gli altri settori, soffermiamoci sulle scienze naturali. Il compito dei naturalisti è redigere un catalogo completo della fauna e la flora del paese; per assolverlo lo zoologo Geoffroy de Saint Hilaire, affiancato dal pittore Henri-Joseph Redouté (fratello del più celebre Pierre-Joseph) e il botanico Alire Raffeneau-Delile intraprendono molte spedizioni, a volte lunghe e faticose, nell'alto e nel basso Egitto. Raffeneau-Delile descrive il loto e il papiro e crea un orto botanico al Cairo; un altro attivo raccoglitore è Ernest Coquebert de Montbret, che la ha sfortuna di morire ventunenne di peste il 7 aprile 1801, lo stesso giorno in cui la Commissione delle scienze e dell'arti si imbarca alla volta dell'Europa. Nel febbraio 1802 un decreto di Napoleone ormai primo console ordinerà la pubblicazione dei risultati a spese delle stato, ma a beneficio degli autori: è l'inizio della grandiosa Description de l'Egypte, che coinvolgerà 160 savants, 2000 artisti tra cui 400 incisori, si protrarrà per oltre vent'anni e comporterà nella prima edizione 19 volumi, 37 nella seconda. Ma abbiamo anticipato gli eventi. Come è noto, Bonaparte parte per Parigi nell'agosto del 1799 (insieme a lui, viaggia l'ormai inseparabile Monge); il 18 brumaio (ovvero il 9 novembre) con un colpo di stato rovescia il Direttorio e si impadronisce del potere. Per legittimare il quale, ha cura di circondarsi di scienziati e di chiamarli alle più alte responsabilità: diversi di loro, tra cui Lagrange, sono nominati senatori; Laplace diviene addirittura ministro dell'interno: grande matematico e fisico, ma amministratore incapace, sarà allontanato dopo appena sei settimane; Fourier è prefetto dell'Isère; Monge senatore, presidente dell'Institut d'Egypte e direttore dell'école polytechnique. Come si vede, tra questi notabili non c'è nessun botanico; cultore della matematica e delle "scienze dure", Napoleone non ha una gran considerazione della scienza della piante; in famiglia, la botanica era sua moglie Joséphine, come ci ricorda un aneddoto spesso ripetuto. Nel 1804, quando Humboldt ritornò dal suo grande viaggio in America latina, il neoimperatore lo ricevette e gli domandò, in tono quasi di disprezzo: "Dunque vi interessate di botanica? Anche mia moglie si occupa di piante". Forse nuoce ai botanici del Jardin des plantes (ora Muséum national d'histoire naturelle) anche il loro passato giacobino. E' vero che Antoine-Laurent de Jussieu ne mantiene la direzione che esercita fin dai tempi della Convenzione e nel 1804 è nominato professore di botanica alla facoltà di medicina e presidente della I sezione dell'Institut national, ma non riceverà mai gli onori che toccano ai colleghi fisici, chimici e matematici. Tra i naturalisti, l'uomo di Napoleone è Cuvier, segretario perpetuo dell'Institut e presidente della commissione che deve riformare l'università. Un merito di Bonaparte agli occhi dei botanici sarà stato se non altro aver finanziato la spedizione Baudin (1800-1803), quando era ancora primo console. Diretta verso le "coste della Nuova Olanda", ovvero l'Australia, aveva obiettivi geografici e cartografici, ma anche naturalistici, come ci ricordano i nomi delle due navi della spedizione, Géographe e Naturaliste. A bordo ci sono 24 tra artisti e scienziati, compresi molti membri dell'Institut de France, e cinque giardinieri, incaricati di occuparsi delle piante vive; tra i botanici, l'ormai anziano André Michaux, che però abbandona l'impresa per dissensi con il comandante Baudin, e Jean-Baptiste Leschenault de la Tour. Nonostante tante vicissitudini, compresa la morte del comandante, il successo scientifico della spedizione è straordinario: 200.000 esemplari di animali e piante vanno ad arricchire le collezioni del Muséum national e del Jardin des plantes. Piante e animali vivi raggiungono invece i giardini della Malmaison; e nelle sue serre fioriscono per la prima volta molte piante ora a tutti familiari, come Acacia dealbata, ovvero quella che siamo abituati a chiamare "mimosa". Per quanto tiepidamente interessato alla botanica, che delegava volentieri alla botanofila Joséphine, questi risultati avranno fatto piacere anche al quasi imperatore, cui non sfuggiva l'importanza dell'introduzione di nuove specie per il progresso dell'agricoltura, che considerava invece "l'anima, la base prima dell'Impero". Questo interesse pratico gli poteva derivare dall'esempio del padre, Carlo Bonaparte, che, convinto esponente della scuola fisiocratica, aveva iniziato a bonificare la tenuta delle Saline, dove aveva creato un vivaio con alberi da frutto e piante esotiche. Nel 1800, ancora all'epoca del consolato, Napoleone fece creare ad Ajaccio il primo orto botanico della Corsica, il Jardin d'Expériences. Inaugurato il 12 giugno 1801, si trovava nel recinto dell'ex convento di San Francesco, trasformato in ospedale militare, aveva una superficie di circa 6.000 metri quadri e godeva di un clima favorevole che permise l'acclimazione di piante esotiche, tra cui il tabacco. Nel 1807 con un decreto imperiale passò direttamente sotto l'amministrazione del Muséum di Parigi, ma solo nel 1812 fu dotato di finanziamenti e fu costruita una serra. Anche in seguito ebbe vita grama, con la morte per febbre perniciosa di almeno due giardinieri. Durante gli anni napoleonici, le società agricole, abolite ai tempi del Terrore, rifiorirono e si moltiplicarono. Prima la perdita delle colonie, poi le difficoltà dei commerci a lunga distanza causati dall'interminabile ciclo di guerre, infine il blocco continentale resero ancora più urgente l'acclimazione di piante esotiche anche nel territorio metropolitano o la ricerca di loro succedanei. L'esempio più noto è quello della coltivazione della barbabietola da zucchero; il metodo di estrazione fu messo a punto da un altro botanico, Benjamin Delassert. Nominato barone da un grato Napoleone, andò aggiungersi alla piccola schiera di scienziati di primo piano entrati a far parte della nobiltà dell'Impero (che, però, non dimentichiamolo, era formata per quasi il settanta per cento da militari). Per un alto numero di scienziati, però, c'erano incarichi pubblici ben rimunerati, posti di insegnamento nelle scuole secondarie (dove le scienze divennero materia obbligatoria) e all'università, premi in denaro, donazioni e vitalizi come quelli assegnati a Volta, la possibilità di pubblicare a spese dello stato, le sovvenzioni per le ricerche e le innovazioni tecniche, prime fra tutte quelle che potevano essere utili all'esercito, come il telegrafo ottico inventato da Claude Chappe.  Le dediche botaniche a Napoleone Palisot de Beauvois era stato anticipato di due anni dagli spagnoli Ruiz e Pavón che nel 1802 dedicarono al primo Console Bonapartea sulla base di una specie da loro raccolta in Perù. Erano abituati a offrire con disinvoltura le loro piante all'uomo politico di turno, e la dedica a Napoleone, intesa a ingraziarsi forse ancor più di lui il filofrancese Godoy, da poco ritornato al potere, è un capolavoro di servilismo e adulazione: "Genere dedicato a Napoleone Bonaparte, rifondatore della ricostituita repubblica francese, primo console, comandante sempre invitto, patrono della botanica, di tutte le scienze fruttuose e delle arti, difensore della religione, ripristinatore della pace in tutto il globo, uomo immortale, che rimarrà nella memoria degli uomini famosissimo per le sue gesta". E' quasi una consolazione sapere che il genere non è valido (è un sinonimo diTillandsia), mentre lo è il bel Lapageria, che i due botanici iberici dedicarono contestualmente "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Senza esprimersi in termini così smaccati, Palisot de Beauvois è non meno celebrativo. Per omaggiare il neoimperatore sceglie una pianta i cui vistosi fiori a coccarda ostentano un triplice giro di petali (più probabilmente staminoidi), che li fanno assomigliare a una corona. Non meno importante è il convincimento - confermato da Antoine-Laurent de Jussieu, amico di una vita - che la Napoleonaea non appartenga ad alcuna famiglia nota, anzi inauguri una famiglia propria. In effetti, la famiglia Napoleonaeaceae è stata a lungo accettata dai botanici, per essere poi assorbita nelle Lecythidaceae. Oggi al genere sono assegnate diciassette specie, tutte originarie dell'Africa tropicale occidentale e centrale intorno al golfo di Guinea; quelle più note sono N. imperialis e N. vogelii. Il primo è un alberello alto circa 6 metri, il secondo un albero di dimensioni maggiori; entrambi sono sempreverdi, con grandi foglie alternate obovate, e curiosi fiori che nascono sui rami maturi o direttamente sul tronco. Hanno una struttura molto complessa, che ha fatto parecchio discutere i botanici. Oltre che a una corona, possono essere paragonati a una coccarda, con due giri esterni di elementi simili a petali disposti orizzontalmente e un giro interno di venti stami e staminoidi eretti. Per alcuni botanici, anche recenti, si tratta di una vera corolla e gli elementi esterni sono petali; per altri è un fiore apetalo e si tratta di staminoidi, una tesi confortata dai dati molecolari e dal confronto con le strutture fiorali delle Lecythidaceae. In ogni, caso una struttura peculiare ed affascinante, nonché discussa e discutibile, come lo stesso Napoleone. Che lo stesso anno ricevette una seconda dedica vegetale dal botanico Etienne Pierre Ventanat, che in quel momento, per incarico di Joséphine, stava redigendo il catalogo delle collezioni del giardino della Mailmaison, una splendida opera in due volumi, con le illustrazioni di Pierre-Joseph Redouté. E fu proprio su richiesta della sua patrona che creò un terzo genere in onore dell'ormai imperatore, come racconta egli stesso: "Sua Maestà l'Imperatrice dei francesi, essendosi resa conto che la pianta di cui ho appena presentato la descrizione appartiene a un genere nuovo, ha voluto indicarmi il nome che dovevo dargli. I signori Ruiz e Pavón hanno già consacrato quello di Bonapartea nella Flora del Perù, e il signor Palissot-Beauvois quello di Napoleonaea in Flora d'Oware e del Benin; ho fatto così ricorso alla lingua greca, che ha fornito ai botanici un gran numero di denominazioni tanto espressive quanto armoniose, per obbedire al desiderio di Sua Maestà l'Imperatrice e dare a Sua Maestà l'Imperatore una modesta prova della riconoscenza che gli devono tutti coloro che coltivano le arti e le scienze". Come tutti i francesi, anche Ventenat è appena passato da cittadino a suddito, e si comporta di conseguenza. La pianta in questione è Calomeria amaranthoides, coltivata nei giardini della Malmaison dai semi giunti dall'Australia grazie alla spedizione Baudin. Il nome generico, come spiega lo stesso Ventenat, è formato da due parole greche, καλός (kalòs) "bello, buono" e μερίς (meris) "parte": dunque, Bonaparte. E' forse l'unica specie del piccolo genere Calomeria (Asteraceae), a cui vari repertori ne attribuiscono quattro, con una sorprendente distribuzione disgiunta: mentre C. amaranthoides è endemica degli stati di Victoria e del Nuovo Galles del Sud nell'Australia sud orientale, le altre tre vivono nell'Africa meridionale e orientale. Appaiono alquanto diverse dalla sorella australiana, e altri botanici le assegnano decisamente al genere Helichrysum. Parliamo dunque della sola specie certa. quella descritta e denominata da Ventenat. E' una perenne di breve vita solitamente coltivata come biennale, di grandi dimensioni (può superare i tre metri) e foglie intensamente profumate d'incenso. In estate produce grandi infiorescenze color amaranto simili a pennacchi. Ricordano tanto da vicino quelli inalberati sull'elmo dell'alta uniforme della Guardia Imperiale da far pensare che non si tratti di una semplice coincidenza. Prima di concludere, vale la pena di ricordare la damnatio memoriae che toccò a Napoleonaea imperialis. Nel 1814, appena caduto per la prima volta Napoleone, un altro botanico francese, Nicaise Augustin Desvaux, ritenne che quella ignominiosa dedica dovesse essere cancellata, e si affrettò a rinominare la pianta Belvisia caerulea, in onore dello stesso scopritore Palisot de Beauvois. Ma, grazie al repubblicano e antinapoleonico Augustin Pyramus de Candolle, in botanica vale la regola della priorità: Napoleonaea vive, Belvisia è un nome illegittimo. A scusante dei quattro botanici che si affrettarono a prostrarsi ai piedi di Napoleone, ricordiamo che non furono i soli a subirne la fascinazione. Come è noto, lo stesso Beethoven voleva dedicargli la sua terza sinfonia, finché proprio l'incoronazione gli aprì gli occhi. E le tre dediche vegetali sono tutte comprese tra il 1802 e il 1804, quando davvero Napoleone poteva ancora presentarsi nelle vesti di pacificatore, restauratore dell'ordine e al tempo stesso fautore del progresso e del rinnovamento sociale. Non è raro che generi molto noti e popolari portino il nome di personaggi altrimenti destinati all'oblio. E' senz'altro il caso del genere Deutzia (Hydrangeaceae) che annovera alcuni degli arbusti più coltivati in parchi e giardini, dedicato da Carl Peter Thunberg a Jean (o Joan) Deutz, un maggiorente di Amsterdam che aveva finanziato i suoi viaggi in Sud Africa e in Giappone. Riconoscente, il grande botanico svedese lo ricordò dando il suo nome a una delle piante da lui scoperte in Giappone, Deutzia scabra; e non dimenticò neppure gli altri due sponsor dei suoi viaggi, Jan van de Poll Pietersz. e David ten Hoven, premiati rispettivamente con i generi Pollia (Commelinaceae) e Hovenia (Rhamnaceae).  Come Thunberg ad Amsterdam trovò una cordata di finanziatori Nell'ottobre 1770, trentacinque anni dopo Linneo, un altro giovane svedese bussò alla porta di Johannes Burman; la situazione però era alquanto diversa da entrambe le parti. Burman dirigeva ancora l'orto botanico di Amsterdam, ma era ormai un professore avanti negli anni, con alle spalle una sequela di importanti pubblicazioni che ne facevano il più autorevole botanico d'Olanda. Lo svedese era Carl Peter Thunberg (1743-1828), il migliore allievo di Linneo: era già laureato a Uppsala e stava andando a Parigi per perfezionarsi in chirurgia e medicina; ma soprattutto, non arrivava a mani vuote: a garantire per lui c'era una lettera di raccomandazione del maestro, del cui verbo ora Burman era uno dei più convinti seguaci. Dunque accolse il giovane Thunberg a braccia aperte; e lo stesso fece suo figlio Nicolaas Laurens Burman (1734-1793) che, avendo studiato a Uppsala con Linneo, poteva scambiare con lui anche qualche parola in svedese. Forse anche grazie a questa calorosa accoglienza, Thunberg fu entusiasta della città sull'Amstel: dei suoi canali e delle sue eleganti case patrizie, della pulizia e dell'ordine che regnavano ovunque, dell'atmosfera di libertà e fervore intellettuale. Johannes Burman - qualcuno lo ha definito l'eminenza grigia della botanica olandese - conosceva tutti e non mancò di presentarlo agli appassionati e agli eruditi che facevano parte delle numerose società scientifiche dei Paesi Bassi. Approfittò anche della sua presenza per coinvolgerlo nella classificazione degli esemplari del suo gabinetto di curiosità: Thunberg indentificò diversi minerali, insetti e piante, in particolare Graminaceae e muschi. A Burman fu chiaro che il suo ospite era un naturalista assai preparato e mentre lo aiutava a riordinare grandi generi sudafricani come Ixia, Erica e Aspalathus, gli chiese se gli avrebbe fatto piacere che organizzasse per lui una spedizione in una delle colonie olandesi più ricche di piante: il Suriname o la colonia del Capo. Ovviamente Thunberg - e il suo maestro Linneo con lui - non sognava altro. Mentre Thunberg si trovava a Parigi, dove studiò per un anno accademico, Burman incominciò a muovere tutte le sue pedine per organizzare il viaggio promesso. In primo luogo bisognava coinvolgere la VOC, la potente Compagnia olandese delle Indie. Burman contattò i direttori della Camera di Amsterdam Egbert de Vrij Temminck e Jan van der Poll Pietersz., ottenendo un ingaggio per Thunberg come medico di bordo di una delle navi della Compagnia. Si precisò in tal modo anche la meta: il Sudafrica e, se possibile, il Giappone, la meta più entusiasmante per tutti visto che a causa della politica delle "porte chiuse" la flora giapponese era pressoché sconosciuta e dopo Kaempfer nessun naturalista preparato aveva più visitato il paese. Il viaggio fu approvato dalla VOC e Burman cercò altri sponsor disposti a finanziare le esplorazioni di Thunberg in Sudafrica e in Giappone in cambio di esemplari, semi e piante vive. Del numero facevano parte lui stesso e suo figlio Nicolaas Laurens: di condizione economica molto agiata e imparentati con famiglie ricche e influenti, erano interessati alle raccolte di Thunberg sia come studiosi sia come collezionisti. Un altro cliente era l'orto botanico di Amsterdam, di cui Burman era il praefectus e Temminck uno dei Commissari. Ma a contribuire alle spese furono anche alcuni privati che possedevano grandi giardini ed erano disposti ad allargare i cordoni della borsa in cambio di piante rare: i maggiorenti Jan van der Poll, Jean Deutz e David ten Hoven. I cinque personaggi sono citati nella dedica che apre Flora japonica: "Agli uomini generosissimi e nobilissimi, il signor Vrij Temminck, autorevolissimo console della Repubblica di Amsterdam, commissario dell'Orto botanico; al signor I. van der Poll, autorevolissimo console della Repubblica di Amsterdam; al signor Johan. Deutz, consigliere della Repubblica di Amsterdam e meritevolissimo membro di diverse accademie; al sig. David ten Hoven, consigliere e commissario della Repubblica di Amsterdam; al sig. Nicolaas Laurens Burman, dottore in medicina e professore di botanica, mecenati, sostenitori e patroni sommi!" Come si vede, il Burman ricordato come mecenate è il figlio, non il padre: nel 1784, quando uscì Flora japonica, era già morto, e il figlio gli era succeduto sia come direttore dell'orto botanico sia come professore dell'Ataeneum illustre. Come vedremo tra poco, di Thunberg non era solo un mecenate, ma anche un caro amico. Qualche contributo venne anche dalla Svezia: Thunberg era titolare di una borsa di studio, e inviò duplicati delle sue raccolte, oltre che a Linneo, a suoi amici o allievi Abraham Baeck, il presidente del reale collegio di medicina, Peter Joonas Bergius, medico di successo e fondatore di un orto botanico privato, Lars Montin, medico e membro dell'Accademia reale di Svezia. Ma i finanziamenti più costanti e cospicui vennero dagli sponsor olandesi. Dagli archivi municipali di Amsterdam risulta che l'Hortus botanicus nel novembre 1771 versò a Thunberg una prima somma per le necessità del viaggio; altri versamenti sono registrati per il 1773, il 1774 e il 1776 (quando Thunberg era già a Batavia). Sia dal Sudafrica sia da Batavia Thunberg fece regolari invii in Olanda; i pacchi erano recapitati all'orto botanico di Amsterdam, dove erano aperti alla presenza dei diversi sponsor cui poi veniva distribuito il contenuto. Come Commissario dell'orto botanico, Temminck raccomandava a Thunberg di inviare "solo piante, semi e bulbi di piante veramente rare, e nient'altro". Il resto era per i mecenati privati: "gli invii di uccelli impagliati, insetti ecc. saranno consegnati ai signori Van de Poll, ten Hoven, e ai due professor Burman". Questi ultimi scrissero a Thunberg - che al momento era in Sudafrica - per raccomandare di inviare all'orto botanico piante vive difficili da riprodurre da seme e richiesero espressamente bulbi e Pelargonium (ai quali Burman figlio stava dedicando una monografia). Neppure gli exsiccata interessavano all'Hortus, tanto che il suo erbario giapponese gli fu restituito. Invece i Commissari erano gelosissimi di semi, bulbi e piante vive, tanto che nel 1780 Nicolaas Laurens scrisse a Thunberg: "Il pacchetto con le piante giapponesi è stato consegnato quest'autunno all'Hortus; se ti rimangono dei duplicati delle piante di Ceylon, te ne sarò molto grato, perché dall'Hortus non ho avuto nulla, il che molto mi spiace". Ovviamente gli invii, soprattutto di piante vive, erano difficili, e molti esemplari non sopravvissero al viaggio. Tra quelle che furono sicuramente introdotte da Thunberg attraverso l'Hortus di Amsterdam Hydrangea macrophylla, mentre le prime gardenie fiorirono nel giardino di Deutz. Thunberg inviò piante vive anche ad André Thouin del Jardin des plantes, ma morirono tutte per il gelo nell'inverno 1789-1790.  Gli sponsor olandesi di Thunberg Dopo sette anni di viaggi, Thunberg ritornò in Olanda nell'ottobre 1778. Al suo arrivo a Texel ricevette una affettuosa lettera di benvenuto da Nicolaas Laurens Burman che lo invitò a casa sua "dove vivremo come fratelli e trascorreremo l'inverno nel modo più piacevole possibile". Tra quelle piacevoli occupazioni ci furono anche le visite agli amici e agli sponsor, nei cui giardini Thunberg fu compiaciuto di vedere in buona salute le piante da lui stesso introdotte. E' ora anche per noi di conoscerli meglio. Iniziamo da Temminck, che però tenne i rapporti con Thunberg non a titolo personale, ma come Commissario dell'Hortus botanicus. E infatti, anche se compare in prima posizione nella dedica di Flora japonica, è il solo del gruppo a non essere stato ricordato da un genere botanico. Del resto, era molto esigente e i suoi rapporti con Thunberg non furono idilliaci, come farebbe pensare una lettera in cui lamenta le note insufficienti dei suoi esemplari. Appartenente come gli altri a una famiglia magnatizia, era un uomo politico che rivestì molti incarichi importanti; era curatore dell'Athaeneum illustre e dal 1766 fu uno dei due Commissari dell'Hortus botanicus, che era gestito dalla città di Amsterdam. Morì senza figli; appartiene alla sua famiglia ma non fu un suo discendente l'importante zoologo Conraad Jacob Temminck, dedicatario del genere Temminckia de Vriese, oggi sinonimo di Scaevola L. Passiamo ora ai tre sponsor privati. Jan van de Poll Pietersz. (1726-1781) era un ricco mercante, appartenente a una famiglia attivamente impegnata nella amministrazione della città di Amsterdam. Anch'egli rivestì vari incarichi pubblici e nel 1779 divenne borgomastro. Come abbiamo visto, era uno dei direttori della Camera di Amsterdam della VOC e dal 1779 fu direttore della società del Suriname. A Velsen possedeva una tenuta di campagna chiamata Velseroog e, come Deutz, era membro della Società per l'avanzamento dell'agricoltura (De Maatschappij ter Bevordering van de Landbouw). Allo stesso ambiente sociale apparteneva David ten Hoven (1724-1787), che del resto era genero di Temminck e cugino della seconda moglie di Poll, Jacoba Margaretha van Hoven. Anch'egli era un mercante e un membro del senato di Amsterdam. Mentre Poll desiderava da Thunberg soprattutto arbusti da fiore per il parco della sua tenuta, gli intenti di Hoven erano più pratici: gli servivano alberi per proteggere la sua tenuta di Woestduin dall'avanzata delle dune di Heemstede-Volenzang. Qui grazie ai semi ottenuti da Thunberg piantò molti Pinus, Abies, Cupressus, Cedrus e Juniperus. Al rientro di Thunberg in Olanda, gli versò come compenso 128 ducati d'oro. Certamente i soldi non gli mancavano: qualche anno prima aveva pagato 3050 fiorini al progettista di giardini Adriaan Snoek per il progetto di una "ciotola" nella duna, quella appunto dove sarebbero stati piantati gli alberi di Thunberg. Versò inoltre 3500 fiorini a un certo Hendrik Horsman per la fornitura di materiale vegetale e la costruzione di un viale. Dato che il tracciato di quest'ultimo sostituiva vecchi percorsi attraverso le dune, versò anche consistenti somme come compenso ai poveri dei villaggi di Vogelenzang e Overveen. Il più interessante e noto del gruppo è però Jean (anche Joan o Johannes) Deutz (1743-1784); molto più giovane dei compagni di cordata, anch'egli apparteneva a una famiglia molto influente che si era arricchita con il commercio delle spezie, del tabacco e del vino e aveva raggiunto l'apice verso la metà del XVII secolo quando si era imparentata con il Grande pensionario de Witt e aveva ottenuto il monopolio della vendita del mercurio austriaco in Europa. Il nostro Jean era un avvocato e anche lui sedeva nel consiglio di Amsterdam e fu direttore della Società del Suriname; aveva rapporti di affari e vicinato con gli altri (come quella di Poll, la sua tenuta di campagna Roos-en-Beek, si trovava a Velsen), ma i suoi interessi per la botanica erano più ampi, tanto che chiese a Thunberg di procurargli "tutti i semi e le piante essiccate possibili". Si considerava un botanico dilettante, corrispondeva con il governatore della Colonia del Capo Hendrik Swellengrebel e con Joseph Banks ed era membro di varie società scientifiche. A questo proposito va sottolineato che nel Settecento in Olanda ne esistevano molte, e i loro membri, più che professionisti, erano colti dilettanti come appunto Deutz. Come i due Burman e il botanico Maarten Houttuyn, che avrebbe pubblicato alcune delle piante inviate da Thunberg, faceva parte della Società olandese delle scienze (De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen), all'epoca un ristretto club di gentiluomini che si riuniva nell'aula municipale di Harleem per discutere di argomenti scientifici e promuovere lo studio delle scienze e delle arti. Deutz ne divenne direttore nel 1778 e nel 1781, su sua richiesta, vi venne ammesso anche Thunberg. Subito dopo nel bollettino della società venne pubblicato un suo articolo con i dati metereologici raccolti in Giappone e nel 1782, sempre su istanza di Deutz, un suo articolo sulle palme (nella traduzione olandese di Houttuyn) che contiene la prima descrizione valida di Cycas revoluta. Houttuyn si lamentò della fatica che gli era costata decifrare la minutissima grafia di Thunberg, ma ne fu ricompensato con la dedica del genere Houttuynia, di cui parleremo un'altra volta. Come abbiamo già visto parlando di Poll, Deutz era anche membro della Società per l'avanzamento dell'agricoltura, anch'essa all'epoca un club esclusivo con meno di trenta membri; sempre nel 1781 e ancora su sua proposta vi fu ammesso anche Thunberg come membro onorario.  Due dediche doverose: Pollia e Hovenia Nel suo Flora japonica, pubblicato nel 1784, oltre a porre l'opera sotto l'egida di tutti i suoi sponsor olandesi, Thunberg riservò a tre di loro anche la dedica di un genere. Abbiamo già visto per quali ragioni Temminck fu escluso; quanto ai Burman, ci aveva già pensato Linneo con il genere Burmannia. Per van der Poll, ten Hoven e Deutz il botanico svedese scelse tre piante giapponesi, all'epoca le uniche specie note dei rispettivi generi Pollia, Hovenia e Deutzia. La dedica a Poll è la più laconica, praticamente l'assolvimento di un dovere: "Ho dato il nome in onore del sommo patrono J. van der Poll, meritevolissimo console di Amsterdam". Per lui, che come sappiano era soprattutto interessato ad arbusti e piante da fiore per il suo giardino, Thunberg scelse una bella erbacea perenne nativa del Giappone (ma anche della Cina e del Sud-est asiatico), Pollia japonica. Oggi a questo genere della famiglia Commelinaceae sono attribuite una ventina di specie distribuite principalmente nelle zone tropicali del vecchio mondo, con un solo rappresentante nelle Americhe e qualche propaggine nell'Australia settentrionale. Di particolare interesse l'africana Pollia condensata, i cui frutti sono unici nel mondo vegetale: simili a biglie metallizzate blu profondo dai riflessi cangianti, nello strato esterno della buccia presentano nanocellule disposte ad elica in grado di catturare e riflettere la luce; nel buio delle foreste in cui vivono, è un richiamo irresistibile per gli animali che se ne ciberanno e ne disperderanno i semi. Appena più ampia, ma sulla stessa falsariga di quella di van der Poll, la dedica a ten Hoven: "Ho dato il nome in eterna memoria dell'ottimo mecenate David ten Hoven, Consigliere e commissario della città di Amsterdam". Coerentemente ai suoi interessi, Thunberg gli dedicò un albero Hovenia dulcis: una scelta azzeccatissima se consideriamo non solo la bellezza di questa specie, ma anche la sua grande rusticità, che forse l'avrebbe resa adatta anche al consolidamento delle dune del Mare del Nord. In Giappone egli probabilmente aveva potuto apprezzarne anche i frutti, in realtà i piccioli fiorali ingrossati, che con la loro dolcezza vengono usati nelle insalate di frutta per attenuarne l'acidità. Oggi è la più nota e diffusa delle quattro specie del genere Hovenia (famiglia Rhamnaceae), esclusivamente presente nell'Asia orientale. 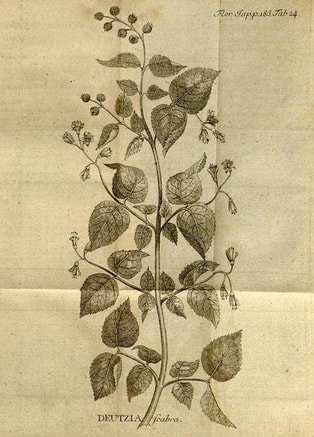 Una Deutzia per un patrono speciale Per Thunberg, ricordare con un genere botanico i suoi sponsor van der Poll e ten Hoven era un debito d'onore che in fondo sbrigò con una frase di circostanza; ma la riconoscenza che doveva a Deutz, che dopo il suo ritorno in Olanda si era dato da fare per lanciare la sua carriera scientifica, era assai maggiore. Per notarlo, basta leggere la dedica: "Questo albero vogliamo, dobbiamo consacrare al cultore di scienze naturali e massimo e benevolentissimo patrono dei suoi cultori J. Deutz, consigliere della città di Amsterdam, che a lungo è stato assai meritevole membro e degnissimo presidente di diverse società scientifiche". Vogliamo, dobbiamo: è un dovere che corrisponde al più profondo e spontaneo moto del cuore. Dunque per Deutz scelse una pianta di cui non gli sfuggiva la bellezza: Deutzia scabra, coltivata da secoli nei giardini giapponesi per le abbondanti fioriture candide e profumate. Non poteva sapere che in tal modo avrebbe eternato il nome di Deutz come patrono di un genere cui appartengono alcuni dei più diffusi arbusti da giardino. All'unica specie a lui nota, se ne sono via via aggiunte altre e oggi Deutzia (famiglia Hydrangeacae) è un grande genere con oltre settanta specie; ha distribuzione disgiunta: da una parte il Giappone e l'Asia orientale, dall'altra l'America centrale. Il loro successo come piante da giardino è relativamente recente: è stato notato che due terzi delle specie sono state scoperte solo nel Novecento. La prima ad essere nota in Europa fu proprio D. scabra; era già stata segnalata da Kaempfer e fu decritta appunto da Thunberg; nel 1812 l'ispettore della Compagnia delle India John Reeves - lo stesso che portò la prima Wisteria chinensis in Europa - inviò in Inghilterra questa specie (o più probabilmente la cinese D. crenata), che però fu coltivata in serra e non prosperò. Per la vera introduzione bisogna attendere gli anni '30 e Siebold che riportò dal Giappone D. scabra, D. crenata e D. gracilis. Verso il 1860, Robert Fortune raccolse in Cina una forma doppia di D. crenata (solitamente confusa con D. scabra, che però è endemica del Giappone). Intorno al 1880, molte nuove introduzioni dalla Cina si devono ai missionari francesi che, per integrare le magre entrate delle missioni, inviavano i loro semi alla ditta Vilmorin; il raccoglitore più prolifico fu padre Delavay che introdusse tra le altre D. purpurascens. Questi nuovi arrivi incoraggiarono gli esperimenti del grande ibridatore Lemoine, che intorno al 1891 iniziò un serrato programma di ibridazioni destinato a cambiare la storia della Deutzia: ancora oggi buona parte degli ibridi orticoli che fioriscono nei nostri giardini continuano ad essere quelli creati da lui tra il 1891 e il 1911 oppure dai suoi discendenti tra le due guerre. La moda però stava cambiando, e dopo la seconda guerra mondiale le deuzie incominciarono ad essere sentite come sorpassate e demodé; le si accusava in particolare di presentare pochi motivi di interesse terminata la fioritura. La situazione è di nuovo cambiata nel tardo Novecento, con l'introduzione di nuove specie e la selezione di cultivar più compatte e più adatte ai nostri piccoli giardini. Ne fa senz'altro parte la varietà oggi più coltivata, la nana Deutzia gracilis 'Nikko'. Per una storia più dettagliata degli ibridi e una selezione di specie si rinvia alla scheda. Nel corso della seconda spedizione nell'America settentrionale, David Douglas scopre un curioso arbusto con lunghi gattici biancastri e decide di battezzarlo Garrya elliptica in onore di uno dei dirigenti della Hudson's Bay Company, che tanto gli era stata d'aiuto in questa e nella precedente spedizione: Nicholas Garry, un personaggio che sarebbe del tutto dimenticato senza questa dedica e il ruolo che giocò nella storia della HBC, ancora oggi una delle maggiori aziende canadesi. Seguiamolo nel difficile viaggio tra laghi e fiumi canadesi durante il quale gli toccò, con tatto e diplomazia, di mettere pace tra trapper rivali che fino a pochi mesi prima si scambiavano fucilate. Una difficile missione tra i cacciatori di pellicce Tra fine Settecento e inizio Ottocento, la caccia e il traffico delle pellicce in Canada erano controllati da due compagnie rivali, la Compagnia della Baia di Hudson (Hudson's Bay Company, HBC) e la Compagnia del Nord Ovest (North West Company, NWC). Intorno al 1810, la diminuzione dei profitti, causata dalla rarefazione degli animali da pelliccia, dalle tensioni di frontiera con gli Stati Uniti e dall'insediamento di coloni che sottraevano spazio alle foreste, sfociò in una guerra aperta, con sabotaggi reciproci, assassini e addirittura scontri armati. Era una situazione insostenibile che preoccupava tanto le autorità politiche quanto gli azionisti delle Compagnie. Per riportare l'ordine, il segretario di stato per la guerra e le colonie, lord Bathurst, ritenne che l'unica soluzione fosse costringere le due rivali a fondersi in un'unica compagnia, che avrebbe mantenuto il nome della più antica, l'HBC, e avrebbe avuto il monopolio dei traffici su un territorio immenso, da costa a costa. Per spiegare la situazione agli agenti locali, ridefinire la struttura organizzativa e riorganizzare la rete delle stazioni commerciali fu deciso l'invio in Canada di un rappresentante per ciascuna delle vecchie compagnie. Il direttivo della HBC scelse il suo membro più giovane, e l'unico scapolo, Nicholas Garry, un mercante che in precedenza aveva commerciato con la Russia. La missione infatti si presentava difficile e impegnativa anche sul piano fisico. I due incaricati dovevano visitare le principali stazioni commerciali e mettere fine a anni di ostilità convincendone i capi che l'accordo conveniva a tutte le parti. Garry si rivelò una scelta felicissima e seppe dimostrare pazienza, equanimità, diplomazia. Di grande valore storico la testimonianza del suo Diary of Nicholas Garry, deputy-governor of the Hudson’s Bay Company from 1822–1835: a detailed narrative of his travels in the northwest territories of British North America in 1821. Garry partì da Londra alla fine del marzo 1821 e viaggiò fino a New York insieme ai due delegati della NWC che avevano partecipato alle trattative per la fusione, Angus Bethune e John McLoughlin. Alla fine di maggio era a Montreal, il quartier generale della NWC, dove fu raggiunto dal suo corrispettivo della compagnia rivale, Simon McGillawry. Come nota ironicamente nel suo diario, fino a pochi mesi prima costui era "il più attivo e strenuo oppositore degli interessi della Compagnia che sono incaricato di rappresentare". Due settimane dopo si imbarcava con McGillawry e suo fratello maggiore William su una canoa di scorza di betulla manovrata da dodici rematori franco-canadesi. La meta era Fort William (oggi Thunder Bay), sul Lago superiore, il principale deposito della NWC, dove ebbe luogo l'incontro con gli agenti della vecchia compagnia. All'inizio fu alquanto tempestoso, ma più il maggiore dei McGillevry spiegò con franchezza i termini dell'accordo e convinse i suoi compagni dei vantaggi. Seguirono estenuanti trattative sulla distribuzione dei posti. Garry annotò sinteticamente nel diario: "Da giovedì 10 luglio a sabato 14 luglio. Discussioni senza fine". Poi verificò gli inventari e i conti e inviò il suo rapporto a Londra; quindi partì con McGillawry per York Factory, la stazione commerciale della HBC situata all'estremità occidentale della baia di Hudson, punto di arrivo della pista che collegava la baia con Fort Vancouver e il Pacifico. Era un viaggio lungo e impegnativo che durò un mese e mezzo. I due commissari viaggiavano su due diverse canoe, ciascuna con otto rematori, che all'inizio trasformarono il viaggio in una sorta di gara. Sul Rainy Lake incontrarono un consiglio di indiani, ai quali Garry assicurò che non avevano nulla da temere dalla fusione delle due compagnie, anzi al contrario ne avrebbero tratto beneficio. La navigazione proseguì tra un dedalo di laghi e fiumi attraverso il Lago dei boschi e il fiume Winnipeg fino alla colonia di Red River; era stata proprio la fondazione di questo insediamento di coloni scozzesi, voluto da lord Selkirk, a scatenare le peggiori ostilità tra le due compagnie, che erano sfociate addirittura in una battaglia, con il coinvolgimento dei Métis, il gruppo indigeno nato dai matrimoni misti tra nativi, franco-canadesi e altri europei. Selkirk aveva risposto occupando Fort William e facendone arrestare i capi, tra cui McLoughlin e William McGillawray. La morte del lord nel 1820 aveva riportato un po' di pace, ma Garry notò che la situazione era ancora esplosiva e che sarebbero state necessarie misure forti. A Norway House sul lago Winnipeg ci fu un secondo incontro con gli agenti, che confermò gli accordi di Fort William, in particolare l'abbandono della via commerciale della NWC tra Fort William e Montreal a favore di quella più diretta della HBC attraverso York Factory e la baia di Hudson. Quindi navigando lungo il Nelson River, alla fine di agosto i due delegati raggiunsero York River, dove furono accolti dal governatore della HBC William Williams. A causa della sua azione non di rado arbitraria durante le ostilità, quest'ultimo era particolarmente inviso agli uomini della NWC e McGillawry ne pretese la rimozione. Garry riuscì a trovare una soluzione diplomatica: Williams lasciò il posto di governatore del dipartimento settentrionale a George Simpson e fu trasferito al dipartimento meridionale; mantenne tuttavia il titolo di governatore senior. Garry scoprì con sollievo che la soluzione non spiaceva a Williams, che, destinato a una sede meno redditizia ma anche meno periferica, avrebbe potuto finalmente far venire la famiglia dall'Inghilterra. Risolte con successo tutte le questioni, Garry poté così lasciare York Factory e imbarcarsi a metà settembre per l'Inghilterra. In apprezzamento del suo operato, la Compagnia lo promosse vice governatore. In Canada lasciò il ricordo di un uomo umano, pieno di tatto e sopra le parti. In suo onore il nuovo forte costruito dalla HBC nel 1822 sul Red River fu battezzato Fort Garry.  Garrya, la "maggiore curiosità della collezione" Non sappiamo molto del ruolo di Garry negli uffici della Compagnia a Londra nei dodici anni in cui fu vicegovernatore (1822-1835). E' probabile che tra l'altro si occupasse del Museo della Compagnia, dove erano custoditi oggetti di varia natura provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti nord-orientali. O almeno, è in questa veste che lo conobbe l'esploratore e cacciatore di piante David Douglas. Tra il 1824 e il 1827 per incarico della Royal Horticultural Society egli aveva visitato il nord America nord-occidentale ed era stato grandemente aiutato dalla HBC: non solo aveva viaggiato sia all'andata sia al ritorno a bordo di navi della compagnia, ma muovendosi lungo la pista che collegava Fort Vancouver a York Factory aveva utilizzato come campo base le sue stazioni commerciali, aveva viaggiato con i suoi agenti ed era stato da loro aiutato in ogni modo. Al suo ritorno a Londra, visitò il Museo della Compagnia per verificare alcuni esemplari e conobbe Garry, con il quale strinse amicizia. Il vicedirettore lo aiutò ad organizzare il suo secondo viaggio, iniziato, di nuovo a bordo di una nave della HBC, nell'ottobre 1829. Così, quando sulla costa dell'Oregon si imbatté in un notevole arbusto mai descritto in precedenza, decise di battezzarlo Garrya elliptica, in onore del nostro Nicholas Garry, al quale dedicò anche Quercus garryana, una quercia endemica della costa settentrionale del Pacifico. Garry seguiva le avventure dell'amico e ci rimane una sua preoccupatissima lettera a Hooker in cui lo informa sulle voci (purtroppo fondate) circa la morte di Douglas alle Hawaii. Di lui sappiamo solo che nel 1835 diede segni di squilibrio mentale tanto che fu costretto a lasciare il lavoro e morì nel 1856 senza aver mai recuperato il senno. Oggi sarebbe del tutto dimenticato senza l'omaggio di Douglas. Garrya Douglas ex. Lindl., appartenente a una famiglia propria (Garryaceae, che oggi include anche Aucuba japonica) è un piccolo genere di una quindicina di specie di arbusti distribuite lungo la costa pacifica dall'Oregon a Panama, con qualche rappresentante nelle Antille. Sono piante dioiche a fecondazione anemofila caratterizzate da fiori raggruppati in lunghi amenti penduli che iniziano a spuntare alla fine dell'estate e raggiungono la maturazione alla fine dell'inverno, quando il vento disperde il polline dei fiori maschili. La specie più nota, coltivata anche nei nostri giardini, è proprio Garrya elliptica, endemica della costa dell'Oregon e della California settentrionale, dove cresce in formazioni vegetali aride. E' un arbusto molto ramificato che tende ad assumere un'ordinata forma sferica, con foglie coriacee dai margini ondulati, densamente tomentose nella pagina inferiore. Solitamente vengono coltivati esemplari maschili, i cui gattici sono molto più lunghi di quelli femminili; fioriscono tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, ma le brattee persistenti rimangono fino all'estate. G. fremointii e G. flavescens sono simili, ma con margini delle foglie lisci anziché ondulati. G. congdonii, molto comune nella Catena costiera della California, è alquanto simile, ma vive in habitat più montani al di sopra dei 200 metri. Lindley, che pubblicò le piante raccolte da Douglas, giudicò che Garrya fosse meno attraente di altri generi introdotti da questo formidabile cacciatore di piante, ma che fosse "la maggiore curiosità botanica della sua collezione". E' un giudizio forse un po' ingeneroso, se pensiamo alla bella e prolungata fioritura invernale di G. elliptica. Qualche approfondimento nella scheda. Trasportati dalle correnti dell'Oceano Indiano, i giganteschi semi del cocco di mare, o coco de mer, una rara palma endemica delle Seychelles, approdano talvolta su rive lontane, dove le loro curiose forme anatomiche, del tutto simili a un bacino femminile, insieme all'origine misteriosa, non hanno mancato di alimentare leggende. Rari ed ambiti, divennero anche un ricercatissimo oggetto di collezione. Il mistero della loro provenienza fu svelato solo nella seconda metà del Settecento quando i francesi esplorarono e colonizzarono l'arcipelago. Commerson, che poté studiare alcuni semi portati a Mauritius, fu il primo ad assegnarla ad un genere proprio, Lodoicea, cui accoppiò l'inconsueto epiteto callypige, "dalle belle natiche". Tuttavia i più pudibondi botanici ottocenteschi lo abbandonarono, preferendo, per una serie di circostanze, una denominazione geografica derivata non dal luogo dove cresce, ma da uno dei tanti approdi dei suoi semi, le Maldive. La palma delle Seychelles porta dunque il nome fallace Lodoicea maldivica. Resta da chiarire l'etimologia del generico Lodoicea; in mancanza delle note di Commerson, andate perdute, non resta che affidarsi alle ipotesi. La più probabile è che si tratti di una dedica al re Luigi XV che di Commerson, in quanto botanico del re, era anche il datore di lavoro. Sarebbe la più banale delle dediche encomiastiche, se non fosse proprio quell'epiteto imbarazzante. Che, però, vista la scandalosa vita privata del sovrano, forse non è per nulla fuori posto.  Una pianta leggendaria Lodoicea maldivica è una rara palma endemica delle Seychelles, nota come cocco di mare, o anche coco de mer, una denominazione che riflette antiche credenze sulla sua origine. Quando i frutti delle piante che crescono sulla riva del mare cadono in acqua, molto pesanti e densi (pesano tra i 15 e i 20 kg) affondano e si adagiano sul fondale; dopo parecchio tempo, il guscio cade e l'enorme seme (il più grande del regno vegetale) incomincia a decomporsi producendo gas che lo fanno affiorare. Ora può galleggiare e, trasportato dalle correnti dell'Oceano indiano, approda a rive lontanissime dal suo luogo di nascita. A differenza del seme della noce di cocco, non è più vitale e la sua presenza in luoghi dove non c'è nessun albero che lo produca ha alimentato miti e leggende. In Malesia si credeva che fosse il frutto di un albero sottomarino, detto Pausengi, sulle cui fronde faceva il nido il mitico uccello Garuda, metà uomo e metà aquila, il cui equivalente nei paesi islamici è il colossale Roc. Consideriamo poi che questo seme è molto speciale non solo per le dimensioni: bivalve, ha una forma che evoca sorprendentemente la parte inferiore del corpo femminile: visto di fronte, il ventre e il bacino; di dietro, le natiche, come ci ricorda un'altra denominazione francese, coco-fesses, "cocco natiche". Gli strani semi si trovavano talora lungo le spiagge di India, Sri Lanka e Maldive. In India erano venduti per cifre altissime e contesi tra i potentati. Nelle Maldive erano considerati di proprietà del re e chi se ne fosse appropriato era passibile di pena di morte: i sovrani dell'arcipelago ne fecero oggetto di un lucroso commercio, vendendole in Indonesia, in Giappone e in Cina, dove si attribuivano loro proprietà mediche come antiveleno e afrodisiaco. Al loro arrivo nell'Oceano Indiano, anche gli europei ne furono colpiti. La prima testimonianza europea è quella di Garcia de Orta che nel 1563 in Colóquios dos Simples e Drogas he Cousas Medicinais da Índia [...] li descrive come coco das Maldivas. Anche Camoes li menziona nei Lusiadi. Pochi anni dopo l'imperatore Rodolfo II riuscì a procurarsene un esemplare per la sua Wunderkammer sborsando 4000 fiorini d'oro. Nel 1602 il sultano di Banten, per sdebitarsi con l'ammiraglio olandese Wolfert Hermanssen, che lo aveva aiutato contro i portoghesi, gli fece dono di una noce, ma prima ordinò che fosse privata della parte superiore, per non offendere la sua modestia. Nella seconda metà del Seicento, la storia dell'albero sottomarino venne riportata con il dovuto scetticismo nell'Herbarium amboinicum di Georg Everhard Rumphius, che battezzò la pianta Cocus maldivicus: ecco l'origine dell'epiteto che porta ancora, nonostante non cresca nelle Maldive. Come ho anticipato, la sua patria sono infatti le Seychelles. Oggi è presente soltanto a Praslin, la seconda isola per grandezza dell'arcipelago, e nel vicino isolotto di Cousin; in passato, la sua distribuzione era lievemente più ampia, ma non si è mai spinta oltre questo angolo delle Seychelles. Fino a quando non venne colonizzato dai francesi nella seconda metà del Settecento, l'arcipelago, situato a metà strada tra il Madagascar e le Mascarene, era disabitato, salvo offrire punti di sosta e rifugio temporaneo a mercanti e pirati. L'isola dove cresce la nostra palma nel 1744 fu cartografata dall'esploratore francese Lazare Picault che la battezzò appunto "isola delle palme", vedendo che era quasi interamente ricoperta da fitti palmeti; nel 1768 fu esplorata da Marion Dufresne che la rinominò Praslin, in onore del ministro della marina, César Gabriel de Choiseul-Chevigny, duca di Praslin (cugino del duca di Choiseul, il segretario di stato di Luigi XV). L'agrimensore della spedizione, un certo Barre, raccolse una trentina di noci e le portò con sé all'Ile de France; almeno alcune finirono nel gabinetto di curiosità di Poivre, dove le vide e le studiò Philibert Commerson. L'anno successivo, un altro membro della spedizione, Jean Duchemin, tornò nell'isola e raccolse una grande quantità di noci, che andò a vendere in India, determinando un crollo del loro valore. Le leggende, comunque, non erano finite: come molte palme, il cocco di mare è una pianta dioica. Il fiore degli alberi maschili è un lunghissimo spadice della forma fallica. Fu così che nacque la diceria che, nelle notti di tempesta, essi si sradicassero per raggiungere le femmine e accoppiarsi con loro. Ma guai a chi avesse assistito alla scena: sarebbe morto o avrebbe perso la vista. Non è finita: nel 1881 il generale inglese Charles George Gordon visitò le Seychelles e fu talmente colpito dall'esuberante vegetazione della Vallée de Mai nell'isola Praslin da concludere che questa era la vera sede del Paradiso terrestre. E la mela offerta da Eva ad Adamo era una noce di coco de mer. Dal che si conclude che Eva era molto forzuta, visto il peso di quel frutto (per altro privo di ogni pregio alimentare).  Un eponimo che porta fuori strada Forse nel 1771 o nel 1772 Sonnerat visitò le Seychelles, ed ebbe modo di osservare, disegnare e descrivere il "grande palmizio dell'isola Praslin volgarmente detto cocco di mare". Egli era convinto appartenesse al genere Borassus e lo battezzò B. macrocarpus. Da parte sua, Commerson riteneva appartenesse a un genere proprio, e creò una denominazione molto originale, che commenterò più avanti: Lodoicea callypyge. Nel 1791 Georg Friedrich Gmelin pubblicò la pianta come Cocos maldivica, riprendendo la denominazione di Rumphius. Purtroppo la descrizione di Sonnerat non rispetta le regole e quella di Commerson è andata perduta; la sua denominazione fu pubblicata solo molti anni dopo, nel 1805, da Saint-Hilaire. Due anni dopo, La Billardière tentò di correggere il tiro rinominando la specie Lodoicea sechellarum, L. delle Seychelles. Purtroppo il danno era fatto: il primo eponimo valido era quello di Gmelin e in base alla legge della priorità nel 1887 Peerson ufficializzò il nome "sbagliato" che porta ancora, Lodoicea maldivica, L. delle Maldive. Spiegato l'eponimo, è ora di occuparci del nome generico. Come abbiamo visto, Commerson lo accoppiò a un nome specifico inconsueto: callypige, dal gr. calli- "bello" e pigé "natica", attributo di Venere dalle belle natiche. Basta osservare il famoso seme del coco de mer per capire perché. Del resto un aneddoto, non so quanto fondato, vuole che Bougainville, visitando il gabinetto di curiosità di Poivre a Parigi, abbia proposto di chiamarlo Cucul la Prasline. Da dove viene invece Lodoicea? Perdute le note di Commerson e senza altre testimonianze (contrariamente a ciò che scrivono alcuni, né Saint Hilaire né La Billardière si pronunciano in merito), dobbiamo affidarci alle ipotesi. La prima vuole che si tratti di un nome mitologico: evocherebbe Laodice, tirata in ballo come la "più bella delle figlie di Priamo". E' vero che Commerson non rifuggiva dai nomi derivati dal mito (è suo, ad esempio, Hebe), ma non si capisce come un ottimo latinista come lui abbia potuto stravolgere le leggi della fonetica e derivare da Laodice Lodoicea anziché *Laodicea; senza contare che in nessun testo antico si parla del lato B della bella principessa troiana.  Un omaggio o uno sberleffo? Regolarissima è invece la derivazione di Lodoicea da Lodoicus, una delle forme latine di Luigi / Lodovico, in concorrenza con il più comune Ludovicus. Chi potrebbe essere questo Luigi se non il re cristianissimo, sua maestà Louis XV, ovvero il datore di lavoro di Commeson, botaniste du roi? Ovviamente le perplessità sono molte: intanto in medaglie e iscrizioni il sovrano ha sempre usato la forma Ludovicus; inoltre sembra oltraggioso, o per lo meno maldestro, accostare al regio nome un epiteto così scandaloso. Ricordiamoci però della personalità di Commerson: era un noto gaffeur, non aveva peli sulla lingua ed era uno spirito anticonformista. D'altra parte, la noce di coco de mer è stato per secoli un ambitissimo dono regale; le palme, poi, sono simbolo di vittoria e sono spesso associate ai sovrani, e da questo punto di vista Ladoicea maldivica, con la sua altezza che può superare i 30 metri e foglie lunghe più di dieci, certo non sfigura. Luigi XV non ha mai usato il nome Lodoicus, ma lo hanno fatto molti re di Francia prima di lui: è una forma un po' arcaica, ma perfettamente documentata, che potrebbe persino essere considerata un omaggio, la rievocazione di un passato glorioso. Potrebbe però anche essere uno sberleffo, se consideriamo alcuni aspetti della personalità del possibile dedicatario. E' noto che Luigi XV era poco interessato agli affari di stato, e combatteva la noia collezionando favorite ed amanti. La sua condotta sessuale era oggetto di pettegolezzi e pasquinate e a corte tutti sapevano che il modo migliore per fare carriera era contribuire alle regali distrazioni. Sicuramente era un intenditore di bellezze femminili, incluse le belle natiche. Nel 1752, il pittore François Boucher dipinse un nudo femminile, conosciuto come La jeune fille allongée ("La ragazza sdraiata") o L'odalisque blonde ("L'odalisca bionda") che ritrae un'adolescente formosa e indubbiamente callipigia. Si tratta di un ritratto della quindicenne Louise O'Murphy, che secondo la testimonianza di un ispettore di polizia che indagò sulla famiglia della ragazza, fu commissionato dal marchese di Marigny, il fratello minore di Mme de Pompadour. Quando il re vide il dipinto, chiese di conoscere l'originale, che trovò anche più bello del quadro. Per due anni, dal 1753 al 1755, Louise fu una delle sue petites maitresses, come venivano chiamate le amanti non ufficiali che non venivano presentate a corte e alloggiavano discretamente in una delle case del Parc-aux-Cerfs a Versailles. Questa storia Commerson doveva conoscerla meglio di noi: a riferirgliela, di prima mano, sarà stato proprio il marchese, che per un ventennio fu sovrintendente degli edifici e dei giardini reali; il botanico lo frequentò nei suoi anni parigini e gli dedicò il genere Marignia, oggi sinonimo di Protium. Naturalmente non è una prova, ma almeno un indizio. D'altra parte, Luigi XV tutto sommato un genere botanico se lo merita. Per quanto annoiato, frivolo e superficiale, era interessato alle scienze e finanziò, oltre al viaggio di Bougainville, altre spedizioni scientifiche, la più importante delle quali è sicuramente la Missione geodetica franco-spagnola. Inoltre, volle al Trianon un orto botanico che in pochi anni divenne uno dei più importanti del mondo. Anche questa è una storia interessante. Intorno al 1750, avendo saputo che uno dei suoi cortigiani preferiti, il duca di Noialles, aveva messo a disposizione del medico Louis Guillaume Le Monnier e del giardiniere Antoine Richard una parte del suo parco di Saint Germain en Laye perché sperimentassero nuove tecniche di coltivazione e creassero un orto botanico all'avanguardia, il re volle visitarlo. Ne fu ammirato e chiese di conoscere Le Monnier; senza nessun preavviso, il dottore fu convocato e quando si trovò di fronte al sovrano, svenne per l'emozione. Luigi XV lo nominò suo medico personale e, insieme a Richard, lo incaricò di creare un orto botanico al Trianon. Certo non disprezzava il Jardin des Plantes, creato dai suoi antenati; ma viveva a Versailles e da Parigi si teneva il più lontano possibile. Quest'uomo incostante e annoiato per una volta si appassionò: le serre si moltiplicarono e da tutto il mondo arrivarono piante rare che fecero crescere rapidamente il giardino, che arrivò ad accogliere 4000 specie, organizzate secondo il sistema linneano. Di Linneo, infatti, Luigi XV era un fervente ammiratore. Nel 1771, quando il principe ereditario di Svezia, il futuro re Gustavo III, gli fece visita, si congratulò con lui per avere un suddito tanto eminente e gli affidò i semi delle piante più rare (alcune fonti dicono che le raccolse di sua mano) da consegnare al grande botanico. Purtroppo quel giardino bellissimo ebbe vita breve. Alla morte del vecchio sovrano, il nipote Luigi XVI donò questa area del parco alla moglie Maria Antonietta, che fece spianare l'orto botanico per sostituirlo con un giardino all'inglese, a cornice del suo universo privato di finta pastorella. Come avrebbe reagito Luigi XV se fosse stato informato dell'insolita dedica (morì di vaiolo circa un anno dopo Commerson)? ne sarebbe stato indignato? o al contrario lusingato o addirittura divertito? E' inutile chiederselo: era un uomo impenetrabile e imprevedibile, oltre che pieno di contraddizioni. La storia l'ha condannato per aver disonorato la monarchia con la sua condotta scandalosa, per aver perso le colonie in guerre disastrose, per aver lasciato il potere in mano a cortigiani corrotti, per aver lasciato incancrenire i problemi sociali e finanziari del paese. Ma, almeno per la botanica, è un benemerito. Un suo breve profilo nella sezione biografie.  Una palma patrimonio dell'Umanità Per concludere, ancora due parole su Lodoicea maldivica, unica specie del genere Lodoicea, famiglia Arecaceae. E' indubbiamente la pianta dei record: il suo frutto e il suo seme sono i più pesanti dal mondo (per lo meno, allo stato selvatico); il suo fiore femminile è il più grande tra le palme, mentre quello maschile è uno spadice di oltre un metro in grado di produrre polline per dieci anni di seguito. Da record anche il cotiledone germinato, che può allungarsi fino a quattro metri. Produrre frutti e semi così grandi comporta un enorme dispendio energetico; ciascuna pianta in media non ne porta più di sette alla volta, e circa una centinaio in tutta la sua vita. Come abbiamo visto anche la sua altezza e la lunghezza delle fronde sono ragguardevoli: lunghe 10 metri e oltre, possono coprire un'area di dieci metri quadrati. Un'altra caratteristica di questa palma è la sua lentezza, e, correlata ad essa, la sua longevità. Prima di arrivare a maturità e fiorire, passano da 25 a 50 anni; ciascun frutto, per maturare, richiede da sei a dieci anni. Quando poi cade a terra, ci metterà almeno due anni a germinare. In compenso, a meno di essere distrutte dall'uomo o da eventi avversi, queste palme possono vivere e produrre fiori e frutti per 800 anni. Prima dell'arrivo degli europei, Lodoicea maldivica costituiva la specie dominante delle isole Praslin e Cousin e di altri isolotti circostanti, ed era presente in una varietà di habitat dalla costa fino alle zone più alte. Deforestazione, incendi, attività umane l'hanno fatta sparire nelle isole minori e ne hanno ridotta la presenza a una sola stazione a Cousin e a due a Praslin. La più importante, e la sola dove i palmizi formano ancora una foresta densa e continua, è la Vallée de Mai di Praslin, dove Gordon collocò l'Eden. Oggi è una riserva naturale, che a partire dal 1983 fa parte dei Patrimoni dell'Umanità Unesco. Qui Lodoicea maldivica cresce in formazioni miste con altre quattro palme endemiche (Deckenia nobilis, Phoenicophorium borsigianum, Nephrosperma vanhoutteanum e Verschaffeltia splendida) e alberi dicotiledoni endemici (Paragenipa wrightii, Canthium bibracteatum, Syzygium wrightii e Erythroxylum sechellarum). E' l'habitat di felci, briofite e licheni e di una sorprendente serie di endemismi animali: il pappagallo nero delle Seychelles Coracopsis nigra barklyi, cinque gechi dei generi Phelsuma e Ailuronyx, i due camaleonti Calumma tigris e C. seychellensis, la chiocciola Pachnodus praslinus. La salvaguardia della Vallée de mai riveste anche una grande importanza economica: è stato calcolato che il 40% dei turisti che visitano le Seychelles acquistano il biglietto d'ingresso alla riserva. Anche la vendita delle noci (oggi fortunatamente regolamentata, dopo che questo commercio aveva dato un ulteriore colpo alla sopravvivenza della specie) comporta un notevole giro d'affari. Il prezzo, ovviamente, è molto variabile in base alle dimensioni e alla qualità, e non è affatto economico, anche se non è paragonabile a quello che toccava prima della colonizzazione delle Seychelles, quando una sola noce poteva costare quanto una casa. La deliziosa Legousia speculum-veneris, lo specchio di Venere, deve il nome generico alla gratitudine di un botanico nei confronti del suo benefattore (per fortuna, un caso non isolato): il magistrato Bénigne Le Gouz de Gerland che finanziò la fondazione dell'orto botanico di Digione, dove volle che fossero tenuti corsi di botanica aperti e gratuiti. Grato, il primo professore a tenere quella cattedra, il medico e botanico Jean François Durande, nella sua Flore de Bourgogne istituì in suo onore il genere Legousia separandolo dal linneano Campanula. Oggi, dopo una storia tassonomica travagliata, le ricerche molecolari gli danno ragione e confermano l'indipendenza del genere che celebra quel generoso mecenate.  Il mecenate che fu sepolto tre volte Il 30 pratile dell'anno VIII (ovvero il 19 giugno 1800), cinque giorni dopo la vittoria napoleonica di Marengo, le vie della città di Digione sono percorse da uno solenne corteo. Precedute da un gruppo di tamburini, da un picchetto di soldati, da tre drappelli della guardia nazionale, accompagnate da tutte le autorità civili e militari, dai bambini e dai ragazzi delle scuole e dai loro insegnanti, su un carro transitano le ceneri del "buon cittadino Legouze"; a chiudere il corteo, i membri della Società delle scienze, dei tribunali, del municipio e della prefettura, e altri tre drappelli di veterani della guardia nazionale. Il protagonista involontario non è un eroe della rivoluzione o della guerra d'Italia, ma un nobile e un magistrato morto nel 1774, ai tempi dell'Ancien Regime, quando il suo nome era Bénigne Le Gouz de Gerlande, signore di Magny-sur-Tulle, Gerland e Jancigny, con tanto di titoli e particella nobiliare. Per circa vent'anni, ha riposato nella sua tomba nella chiesa della Madeleine, finché la Convenzione ha decretato la chiusura delle chiese e poi la vendita dell'edificio come bene nazionale; l'Accademia delle Scienze di Digione, che adesso sia chiama Società delle Scienze, ha ottenuto che i suoi resti fossero preservati e ha chiesto la loro traslazione nell'orto botanico, di cui Le Gouz era stato il fondatore. Le autorità dipartimentali e il sindaco hanno aderito con entusiasmo: sia perché il ricordo di quel generoso benefattore non è sopito, sia perché l'occasione è ottima per prendere le distanze dagli eccessi del Terrore e della scristianizzazione, celebrare la ritrovata concordia nazionale (in uno dei discorsi tenuti durante la cerimonia si ricorda la pacificazione della Vandea) e valori laici come il progresso scientifico e il mecenatismo. Non a caso, un cartiglio posto sul carro funebre ammonisce: "Onorate le ceneri del fondatore dell'orto botanico. Imitiamo le virtù del benefattore delle scienze e delle arti". Bénigne Le Gouz de Gerlande, nato sul finire del Seicento, membro di una famiglia eminente della nobiltà di toga, era stato un importante magistrato (per vari anni fu grand bailli d'epée du Dijonnais, ovvero il magistrato che esercitava il potere signorile e giudiziario a nome del re). Quando studiava al collegio dei gesuiti di Parigi (dove fu condiscepolo di Voltaire) si appassionò di letteratura, scienze, arti, coltivando interessi diversi con notevole eclettismo: la poesia, la musica, la storia e l'antiquaria, il disegno, le scienze naturali. Membro dell'Accademia delle Scienze di Digione, intervenne assiduamente alle sedute con memorie sugli argomenti più vari: i primi re di Borgogna e l'origine dei borgognoni, le cause fisiche del diluvio universale, la vita di Pompeo, l'elettricità, ecc. Era anche un collezionista, sia d'arte sia di naturalia, e sicuramente faceva coltivare piante rare nei giardini del suo castello di Gouville (chiamato così con un gioco di parole basato sul suo nome, Gouz-ville). A distinguerlo da tanti collezionisti e eruditi più o meno dilettanti, furono però il mecenatismo e la generosità con cui dotò la città natale di importanti istituzioni. Non sposato e privo di eredi, nella vecchiaia fu infatti generoso di lasciti e doni. Nel 1764, donò le sue collezioni naturalistiche all'Accademia delle scienze di Digione, in modo che fossero messe a disposizione di tutti a giovamento del progresso scientifico; il nucleo più importante era costituito da pesci e altri reperti marini raccolti nel frequenti soggiorni nelle isole Hyères. L'anno successivo incoraggiò il pittore François Devosge ad aprire una scuola gratuita e pubblica di disegno, che nel 1767 fu ufficialmente riconosciuta dagli Stati generali di Borgogna. Le Gouz finanziò anche un premio destinato ai migliori pittori e assegnato dall'Accademia delle scienze. La scuola divenne rapidamente così importante che gli Stati generali di Borgogna decisero di farsi carico della scuola e dei premi: è il primo nucleo della prestigiosa École nationale supérieure d'art de Dijon, nonché del Museo di belle arti, concepito inizialmente come raccolta di modelli da copiare e imitare. La generosità di Le Gouz dovette cercare un nuovo sbocco; il segretario dell'Accademia lo persuase a finanziare la creazione di un orto botanico. In città non esisteva nulla di simile, se non forse un giardino dei semplici appartenente all'ordine dei farmacisti; inoltre, all'Università, dove l'unica facoltà prevista era quella di diritto, non si insegnava botanica. Fu così che il vecchio magistrato (all'epoca aveva circa settantacinque anni) acquistò un terreno in Allées de la Retraite (attualmente boulevard Voltaire) e vi fece allestire un orto botanico, destinato alla "dimostrazione" delle piante, con annesso un salone dove sarebbero state tenute lezioni aperte e gratuite di botanica; come insegnante, Le Gouz, che era in contatto con il bel mondo parigino, aveva pensato niente meno che a Rousseau, ma al rifiuto del filosofo ripiegò su un medico locale, Jean-François Durande. Il nuovo orto botanico fu ufficialmente inaugurato il 20 giugno 1773, con un discorso del donatore e una prolusione di Durande sui benefici dello studio della botanica. Le Gouz sarebbe morto circa un anno dopo (per una sintesi della sua vita, si rimanda alla sezione biografie). Negli anni rivoluzionari, l'orto botanico, che il fondatore aveva donato all'Accademia delle scienze, passò sotto la giurisdizione del Comune che nel 1833, visto che la sede originaria era ormai troppo angusta e difficile da irrigare per la scarsità di acqua, decise di trasferire le piante in un vasto terreno precedentemente destinato alle esercitazione della compagnia degli archibugieri che già nel secolo precedente era stato trasformato in un parco paesaggistico all'inglese e dall'inizio del secolo era di proprietà municipale. Fu così che il piccolo orto botanico di Le Gouz si trasformò nel Jardin botanique de l'Arquebuse, oggi uno dei più importanti della Francia. I resti del fondatore non seguirono le sue sorti: esumati una seconda volta, furono trasferiti nella tomba di famiglia. A ricordarlo, nel Jardin de l'Arquebuse fu tuttavia posto un busto in bronzo di pregevole fattura.  Legousia, uno specchio per la dea Da molti anni, il suo nome era stato perpetrato anche in altro modo. Nel 1782 il dottor Durande pubblica Flore de Bourgogne, in cui descrive 1300 specie, classificate seguendo il sistema naturale di Jussieu (è uno dei primi esempi) e coglie l'occasione per ripagare il suo benefattore ribattezzando Legousia arvensis la linneana Campanula speculum-veneris. E' una pianta che cresce comunemente nei coltivi, e piace pensare che Le Gouz, che scrisse anche una memoria sulla fertilità del suolo, la conoscesse, l'amasse e ne avesse parlato con Durande. Il genere Legousia, della famiglia Campanulaceae, comprende erbacee annuali del Vecchio mondo, diffuse da ovest a est tra la Macaronesia e l'Asia centrale e da sud a nord tra il nord Africa e l'Europa centrale, dove vivono in campi aperti (anche come infestanti dei coltivi), foreste sparse, praterie e terreni ruderali. In passato è stata attribuita al genere Specularia o ad altri generi, ma oggi la sua indipendenza è confermata dagli studi filogenetici. Solitamente gli sono attribuite sei specie che differiscono tra loro per particolati del calice e la disposizione dell'infiorescenza. Uno studio recente (2019) riduce le specie a quattro. La più nota è lo specchio di Venere, Legousia speculum-veneris, con fiori viola profondo dai lobi arrotondati raccolti in pannocchie ramificate, che assomiglierebbero a uno specchietto (da cui il nome comune). Un tempo, come papaveri e fiordalisi, era molto comune come infestante dei campi di grano, mentre oggi è diventata più rara a causa dell'impiego di diserbanti. Nel nostro territorio sono presenti anche L. hybrida, con infiorescenza a corimbo, denti del calice più lunghi che larghi e corolla lunga circa la metà del calice, e L. falcata con infiorescenza a spiga, lungo tubo calicino con denti acuminati lunghi il triplo della corolla. Qualche approfondimento nella scheda. Curioso destino, quello del dottor John Boswell, ultimo allievo scozzese di Boerhaave, stimato medico di Edimburgo, collezionista e studioso di cose naturali: per tutti è solo lo zio di suo nipote, lo scrittore James Boswell (che a sua volta vive di gloria riflessa come biografo del dottor Johnson). Eppure, grazie a un atto di generosità, è anche il dedicatario di un genere botanico di enorme importanza culturale: Boswellia, ovvero le piante da cui si ricava l'incenso.  Sacri granelli misteriosi Il sacro profuma d'incenso. Un aroma che aleggia non solo nelle chiese cattoliche, ma nei templi buddisti o indù, nelle moschee e nelle sinagoghe, e che arriva da lontano. La più antica attestazione del suo uso cerimoniale ci porta addirittura nelle tombe dell'antico Egitto 3500 anni fa. Nel suo significato generale, il termine incenso, dal latino incendere "bruciare", può indicare una varietà di sostanze vegetali (resine, foglie, radici, legno, bacche) che quando vengono bruciate emanano un fumo aromatico. Molte sostanze possono rientrare in questa categoria, ma nel significato più specifico il termine designa un gruppo di oleoresine ricavate da diverse specie del genere Boswellia, note come franchincenso, ovvero "incenso vero". Nell'antichità, come è esistita una via della seta, c'era anche una via dell'incenso. Fin dal II millennio a.C., le carovane cariche dei preziosi grani di resina profumata, partite dallo Yemen meridionale, il mitico regno di Saba, la percorrevano per raggiungere l'Egitto, le coste mediterranee, la Mezzaluna fertile, la Persia, mentre le navi, cariche di questa e altre merci preziose, salpavano per l'India. I migliori clienti divennero però i Romani, che importavano da quella che chiamavano Arabia Felice enormi quantità di thus o olibanum (adattamento del gr. libanon, a sua volta da una parola semitica che significa "bianco", il colore dei granelli di resina essiccati). Tuttavia, in seguito a una serie di circostanze politiche, il flusso incominciò ad inaridirsi a partire dal III secolo d.C. e nella tarda antichità la via dell'incenso cessò d'esistere. Solo dopo il Mille, e ancor più con le crociate, le chiese europee tornarono a profumare d'incenso. Ma, visto che la preziosa sostanza arrivava in Europa sotto forma di granuli, nessuno sapeva con precisione da quale pianta si ricavasse. Nei libri degli antichi gli studiosi del Rinascimento trovavano informazioni contraddittorie: secondo Teofrasto era un arbusto di modeste dimensioni, molto ramificato, con foglie simili a quelle del pero, con corteccia sottile come quella del lauro; ma ne conosceva anche un'altra varietà, simile al lentisco. Una veniva dall'Arabia, l'altra dall'India. Secondo Diodoro Siculo, si trattava di un'acacia con foglie allungate come quelle del salice. Anche della terra d'origine si discuteva; era opinione comune che arrivasse dall'Arabia, ma qual era la "libanophora regio"? Secondo Plinio, Augusto per scoprirne l'esatta ubicazione aveva inviato in Arabia una spedizione che aveva dovuto tornare indietro sconfitta dal deserto; e concludeva sconsolato che nessun autore latino aveva la minima idea di quale e come fosse la pianta da cui era ricavato. In tanta confusione, gli studiosi più prudenti, come Clusius e Ray, evitavano di avanzare ipotesi; Thevet sosteneva fosse la resina di un pino, ma l'opinione prevalente era che derivasse dalla resina di un ginepro, Juniperus thurifera (ipotesi inconsistente, trattandosi di una specie del Mediterraneo occidentale). Linneo notò la contraddizione e propose Juniperus lycia, oggi Juniperus phoenicea, che se non altro è presente in tutto il bacino del Mediterraneo, compreso il Libano e la Palestina, ma anche lungo le coste del Mar Rosso e nella penisola arabica. Uno degli obiettivi principali dalla spedizione del suo allievo Pehr Forsskål nell'Arabia Felice era proprio scoprire qualcosa di più sulla misterioso pianta; egli identificò quella da cui si ricava un'altra resina, opobalsamum o balsamo di Gilead, ovvero Commiphora gileadensis, ma sull'incenso non riuscì a sapere nulla. La risposta sarebbe arrivata non dalla penisola arabica, ma dall'India, e non da un linneano, ma da un medico scozzese al servizio della compagnia delle Indie.  Il mistero è stato svelato? Si tratta di William Roxburgh (1751-1815), il "padre della botanica indiana": anche lui un "botanico senza Nobel", visto che purtroppo il genere Roxburghia che gli fu dedicato da W. Jones non è valido. Come sappiamo oggi, il genere Boswellia è relativamente vasto, e comprende una ventina di specie, diffuse in un'ampia area che va dall'Africa tropicale all'India passando per la penisola arabica e il Madagascar. Le specie presenti nel subcontinente indiano sono due, B. ovalifoliata e B. serrata. Quest'ultima, oggi nota come incenso indiano o franchincenso indiano, è una pianta medicinale, un grande albero chiamato salai, ben noto alla medicina ayrvedica, così come la sua resina odorifera che nei trattati medici indiani è nota con il nome sanscrito kunduru. Da tempi immemorabili, anche in India (che tra l'altro oggi detiene il primato mondiale della produzione di bastoncini di incenso) il fumo (e l'aroma) dell'incenso accompagna le cerimonie sacre, le preghiere e molte occasioni della vita quotidiana; è bruciato in varie forme, ma la più tipica sono dei bastoncini di bambù intinti in miscele infiammabili e profumate, a base di vari ingredienti; uno dei più apprezzati sono proprio i granuli di resina di B. serrata, che in lingua bengali si chiama luban, un nome che richiama immediatamente il misterioso olibanum. A segnalare a Roxburgh la resina e a suggerire la sua identificazione con l'olibanum sembra sia stato il chirurgo della residenza di Naipur, D. Turnbull. Il botanico scozzese esaminò la pianta e ne scrisse la descrizione, anche se non la pubblicò direttamente; come faceva spesso, affidò i suoi appunti a un amico, l'orientalista H.T. Colebrooke, che la inserì in un articolo comparso nel 1807 su Asiatic Researches in cui sosteneva che la pianta dell'incenso andava identificata con questo albero indiano; Roxburgh l'aveva denominata Boswellia serrata, ovvero B. con foglie seghettate; da parte sua Colebrooke era così sicuro dell'identificazione che suggeriva di chiamarla Lebanus thuriferus, ovvero Lebanus produttore di incenso. In realtà non era proprio così, ma prima di raccontare questa parte della storia, è ora di fare conoscenza con l'uomo che ha dato il nome al genere Boswellia, il dottor John Boswell di Edimburgo. Come si è guadagnato la dedica è presto detto: negli anni in cui studiava all'Università di Edimburgo, il giovane Roxburgh, uno studente brillante ma privo di mezzi, era stato ospitato nella casa del dottor Boswell; la famiglia Boswell, piuttosto nota e influente, doveva anche aver messo una buona parola per farlo assumere come chirurgo di bordo dalla Compagnia delle Indie. Insomma, il botanico aveva un debito di riconoscenza con il suo vecchio benefattore, con cui strinse anche legami familiari, visto che la sua terza moglie, Mary Boswell, non era altri che la nipote del nostro dottore.  Un medico colto, affabile ed eccentrico Per me, e forse per tutti, John Boswell è soprattutto lo zio di Boswell, ovvero del celebre scrittore James Boswell (1740-1795), il biografo del dottor Johnson. Conosciamo il suo volto da un ritratto a olio, dipinto da C. R. Parker e conservato nelle collezioni del Royal College of Physician of Edinburgh, e il suo carattere da alcune righe di chi lo conobbe all'inizio e alla fine del suo percorso esistenziale. Nelle collezioni del Royal College è conservata anche la sua cassa da dottore, donata da un bisnipote di Roxburgh. A farci conoscere il giovane John Boswell, all'epoca venticinquenne, è un altro medico scozzese, Isaac Lawson, amico e corrispondente di Linneo; nella sua lettera del 2 novembre 1736, egli lo descrive come un giovanotto molto colto e dotato, ben noto negli ambienti colti di Edinburgo. Ha molto gradito la copia di Musa Cliffortiana datagli da Lawson e in cambio sarebbe felice di donare a Linneo una copia della sua tesi di laurea, De ambra, che ha discusso il giorno prima ed è stata appena stampata. Fratello minore di Alexander Boswell, il padre del biografo, John Boswell, come tanti studenti di medicina scozzesi, era dunque venuto a Leida per seguire le lezioni di Boerhaave, anzi è considerato l'ultimo degli "uomini di Boerhave". Tornato a Edimburgo, divenne un ottimo professionista e uno stimato membro dell'establishment medico cittadino; nel 1748 fu ammesso al Collegio dei medici, di cui fu tesoriere dal dicembre 1748 al 1756 e di nuovo dall'agosto 1758 al dicembre 1763; ne fu poi presidente dal dicembre 1770 al 1772. Abitava in una confortevole casa a sud della collina del castello, nota come Boswell's Court, proprio quella dove ospitò Roxburgh, che doveva essere amico di uno dei suoi otto figli, Bruce. Sappiamo che era massone (una tradizione di famiglia) e che tra il 1753 e il 1754 fu Primo grande guardiano della Grande loggia di Scozia; secondo F.A. Pottle, curatore dei carteggi del nipote, era un "medico abile, ma decisamente eccentrico". Un'eccentricità che si manifestava soprattutto nelle sue scelte religiose: abbandonò la chiesa ufficiale per aderire alla setta dei Galassiti, ma ne fu cacciato e scomunicato per la sua abitudine di frequentare le case chiuse. Era anche un uomo generoso: oltre ad ospitare Roxburgh e ad aiutare la sua carriera, protesse il poeta Allan Ramsay che gli dedicò alcuni versi. Il nostro migliore informatore su John Boswell è però il famoso nipote. L'eccentrico zio era indubbiamente il più caro dei suoi parenti, e anche se non si frequentavano spesso ogni incontro era una festa per entrambi. Una di queste visite, quella del 26 ottobre 1726, suggerì a James questo sintetico ritratto: "E' un uomo degnamente affettuoso, un buon medico, un compagno gradevole e un grande virtuoso" (espressione che all'epoca indicava uno studioso dilettante e un collezionista). Il sogno di James era sicuramente far incontrare i suoi due idoli: il caro zio e il dottor Johnson. E l'incontro avvenne nel novembre 1773, come ricorda lo scrittore nel suo Diario delle Ebridi: il dottor Johnson "ha trascorso una mattinata con mio zio il dottor Boswell che gli ha mostrato il suo museo di curiosità; e, dato che è uno studioso elegante e un medico allevato alla scuola di Boerhaave, il dottor Johnson ha gradito la sua compagnia". Settantenne, il simpatico dottore morì il 15 maggio 1780 dopo una lunga malattia che lo aveva lasciato mezzo morto per un anno, come ci informa ancora il nipote James. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Boswelliae d'India, d'Arabia e d'Africa Adesso che sappiamo tutto del dottor Boswell, torniamo a Boswellia. L'identificazione di Roxburgh e Colebrooke fu accettata dagli ambienti colti britannici, tanto più che la Compagnia delle Indie ne approfittò per importare in Inghilterra l'incenso indiano pubblicizzato come il "vero" incenso. Tuttavia non è lo è; è sicuramente di ottima qualità, ma è più balsamico, con maggiori sentori legnosi. Per risolvere davvero il mistero, fu necessario attendere quasi un altro quarantennio. Nel 1846 il dottor H.J. Carter, chirurgo della nave H.M.S. Palynurus, in ricognizione lungo le coste dell'Arabia meridionale, in Oman e nello Yemen meridionale vide e studiò alcuni esemplari che dapprima attribuì alla stessa specie di Roxburgh, ma che più tardi venne identificata come il vero franchincenso, B. sacra. In suo onore una specie somala è stata denominata B. carteri. Come ho anticipato, il genere Boswellia, della famiglia Burseraceae, comprende una ventina di specie; il centro di diversità è lo Yemen, compresa l'isola di Socotra particolarmente ricca di specie endemiche. Da tutte si ricava incenso, ma per la maggior parte delle specie si tratta di piccole produzioni, destinate al consumo locale. Le specie importanti per l'esportazione sono quattro: B. sacra, B. frereana, B. papyrifera e la già citata B. serrata. B. sacra è presente in Yemen, Oman e Somalia settentrionale; è dunque la specie che alimentava la via dell'incenso, il mitico olibanum dell'Arabia felice che già Augusto aveva tentato inutilmente di ritrovare. E' un alberello alto fino a 8 metri, solitamente molto ramificato, con corteccia che si sfoglia, resinoso in tutte le sue parti. Per produrre l'incenso, i raccoglitori praticano delle incisioni nei rami più bassi e robusti; la resina ne fuoriesce in forma di gocce che cristallizzano in superficie, ma continuano ad ingrossarsi finché dopo una decina di giorni sono sufficientemente grandi per essere raccolte. Anche se i granuli potrebbero essere pronti per la vendita dopo una ventina di giorni, in Oman, dove si produce l'incenso di migliore qualità, si usa immagazzinarli in grotte per qualche mese, una pratica che ne migliora la conservazione. B. frereana è originaria della Somalia. E' nota come incenso copto poiché la sua resina è tradizionalmente usata dalla chiesa copta in Egitto; l'80% della produzione è però esportato in Arabia saudita dove viene utilizzato nelle cerimonie legate all'annuale pellegrinaggio alla Mecca. Anche l'incenso copto è di ottima qualità, tanto che è detto anche "incenso dei re". B. papyrfera è la più importante e diffusa specie africana, presente in una vasta area dell'Africa centrale e nord-orientale ( Etiopia, Nigeria, Camerun, Repubblica centro africana, Chad, Sudan, Uganda e Eritrea); è un albero di medie dimensioni alto fino a 10 metri; estremamente resistente alla siccità, è considerato una delle piante più utili e polivalenti di questa regione: oltre alla resina, di eccellente qualità, se ne usa il legname, le foglie come foraggio, diverse parti come medicinali; i fiori sono una importante fonte di nettare e polline per le api. Oggi è minacciata per l'eccessivo sfruttamento e la restrizione del suo habitat, le foreste tropicali aride. Meritano almeno un cenno le specie di Socotra, un'isola che si trova proprio al centro dell'area di diffusione di Boswellia, essendo quasi equidistante dalle coste dello Yemen e della Somalia. In un territorio di appena 3800 km quadrati ne vivono ben sette specie: B. ameero, B. bullata, B. dioscoridis, B. elongata, B. nana, B. popoviana, B. socotrana. B. bullata e B. dioscoridis sono state scoperte e pubblicate solo nel 2001 dal botanico svedese Mats Thulin. Altri approfondimenti nella scheda. Per finire, un'ultima curiosità. Come ho detto all'inizio, in senso generale il termine incenso può essere utilizzato per qualsiasi sostanza vegetale che produce fumo aromatico. E infatti in rete sono presenti moltissimi produttori di "incenso", "incenso religioso", "incenso liturgico", con nomi evocativi come "incenso dei re Magi", "incenso cattedrale", "Bethlem", "Caspar", ecc. Quasi mai è possibile scoprirne la composizione, ma è evidente che sotto l'etichetta incenso può esserci di tutto: franchincenso etiope, yemenita o africano, benzoino, mirra, legno di sandalo, ma anche lavanda, Syderitis, Artemisia, vetiver, e così via. Del resto, diverse piante che nulla hanno a che fare con l'incenso (a bruciare le loro foglie si otterrebbe soltanto fumo... senza arrosto, ovvero senza profumo) vengono chiamate impropriamente "incenso". La più nota probabilmente è Plechtrantus glabratus (sin. P. coleoides). Linneo arriva in Olanda nel giungo 1735, con due propositi: laurearsi in medicina, come esige il futuro suocero per concedergli la mano della promessa sposa Sara Lisa Moraea, e far conoscere al mondo scientifico europeo le sue idee innovative. Nei bagagli ha molti manoscritti. Quello a cui tiene di più è il suo schema per classificare i tre regni della natura: animale, vegetale, minerale. Quando lo mostra al botanico di Leida Jan Frederik Gronovius, quest'ultimo ne è entusiasta e proclama che deve essere immediatamente stampato. Dato che Linneo non ha un soldo, a pagare le spese sarà lui, con il concorso di un altro amico, il "coltissimo scozzese" Isaac Lawson. E' grazie a questo atto d'amicizia che esce la prima edizione dell'opera seminale della moderna sistematica: Systema naturae. Linneo pagherà il suo debito di riconoscenza dedicando ai due finanziatori un genere di piante; a Lawson toccherà Lawsonia, cui appartiene un'unica specie, L. inermis, dalle cui foglie si ricava l'henné. 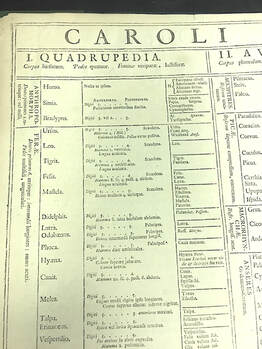 In Olanda alla ricerca di una laurea... e di uno sponsor Linneo arrivò in Olanda il 2 giugno 1735. Aveva 28 anni, era privo di mezzi, e doveva laurearsi al più presto in medicina: era questa la condizione ultimativa postagli dal dottor Johan Moraeus per concedergli la mano di sua figlia Sara Elizabeth, detta Sara Lisa. Al giovane svedese non mancava la fiducia in se stesso, o se preferite la faccia tosta. Appena sbarcato ad Amsterdam (dove si fermò solo tre giorni) chiese udienza a Johannes Burman, che aveva solo un anno più di lui, ma era già professore universitario e direttore dell'orto botanico. Burman, un uomo pieno di impegni, accettò di incontralo, ma non ne fu minimamente impressionato. La tappa successiva di Linneo fu Harderwijk, una piccola università che richiedeva solo un breve soggiorno per concedere la laurea. Bastarono pochi giorni per sbrigare le formalità, e nell'arco di una settimana egli fu in grado di discutere la tesi che aveva già scritto in Svezia. Il 23 giugno venne proclamato Dottore in medicina. La condizione imposta dal futuro suocero era soddisfatta, ma Linneo era venuto in Olanda con un altro obiettivo: far conoscere (e accettare) le sue teorie innovative al mondo scientifico europeo. Per riuscirci, gli serviva un patrono. Il tentativo con Burman era fallito sul nascere, ma Linneo non si scoraggiò. Appena laureato, si spostò a Leida, il maggior centro accademico olandese, nonché sede del più antico ed illustre orto botanico. E questa volta fece centro. Si presentò a Jan Frederik Gronovius, che non aveva alcuna posizione accademica ma era già un botanico noto per i suoi studi sulla flora americana, e gli mostrò il manoscritto di Systema naturae. Gronovius ne fu entusiasta: non solo scrisse lettere di presentazione per Burman e il celebre medico Herman Boerhaave, ma decretò che l'opera andava stampata immediatamente. E dato che Linneo non aveva soldi, a finanziare la stampa sarebbe stato lui, con il concorso del "coltissimo scozzese" Isaac Lawson (così Linneo stesso lo presenta nella prefazione di Systema naturae).  Una vita attraverso le lettere Isaac Lawson si trovava in Olanda per la stessa ragione di Linneo: anche lui era deciso a laurearsi in medicina, ma anziché conseguire una laurea lampo nel diplomificio di Hardweijk, stava seguendo regolari corsi presso l'università di Leida, la più prestigiosa del paese. Era una tradizione di lunga data per i medici scozzesi studiare a Leida; ad attirarli era soprattutto la fama di Boerhaave, che insegnò qui dal 1701 al 1731 e educò diverse generazioni di medici scozzesi, noti come gli "uomini di Boerhaave". Non conosciamo nulla né dell'origine familiare né della giovinezza di Lawson; maggiore di Linneo di tre anni, quando si conobbero aveva 31 anni. Visto che, oltre a concorrere alle spese di stampa di Systema naturae, soccorse finanziariamente il nuovo amico in più occasioni, doveva appartenere a una famiglia facoltosa. Per altro, sappiamo abbastanza poco di lui. La nostra fonte principale sono le undici lettere che egli scrisse a Linneo tra il 1735 e il 1744 (non possediamo le risposte), le prime indirizzate formalmente al "doctissimo ac celeberrimo doctore Carlo Linnaeo", le ultime confidenzialmente all' "amico suo praestantissimo". Molte informazioni ci arrivano poi da altri corrispondenti di Linneo, in particolare Gronovius per il periodo olandese e Collinson per quello inglese. A presentare Lawson a Linneo sarà stato probabilmente proprio Gronovius che considerava lo svedese il suo protetto e la sua scoperta. Sicuramente lo scozzese era uno dei membri più assidui dell'accademia informale che si riuniva attorno a Gronovius, dove Linneo estasiava i presenti raccontando le sue avventure in Lapponia (in puro stile barone di Munchhausen) e si esibiva suonando il tamburo vestito con un improbabile costume lappone. L'aiuto di Gronovius e Lawson per Systema naturae non si fermò al finanziamento. L'esilissimo opuscolo di appena dodici pagine richiese ben cinque mesi tra la revisione del manoscritto e la correzione delle bozze; iniziato il 30 giugno, il lavoro finì a dicembre. In tutte questi mesi, i due amici furono a fianco di Linneo come consulenti e editor (per usare un termine moderno) e da settembre, quando lo svedese si trasferì a Hartekamp a lavorare per Clifford, si sobbarcarono totalmente i rapporti con il tipografo e la correzione delle bozze. Negli anni successivi, svolsero lo stesso ruolo di editor per le altre opere linneane stampate in Olanda, in particolare la prima edizione di Genera plantarum e Critica botanica (entrambe uscite a Leida nel 1737). Una trionfante lettera di Gronovius, datata la vigilia di Natale del 1736, informa Linneo che ha appena letto le ultime pagine di Genera plantarum e che è pronto a portarle all'editore; en passant, nelle ultime righe aggiunge che Lawson ha appena ottenuto il titolo di "candidato in medicina", ma non ne va troppo fiero. Possediamo poco meno di una decina delle lettere che Lawson scrisse a Linneo mentre quest'ultimo si trovava a Hartekamp, tra il 1736 e il 1737; riguardano soprattutto la soluzione di problemi editoriali, ma qua e là aprono uno spiraglio sulla vita intellettuale dei due amici: ad esempio, nel settembre 1737, Lawson propone a Linneo di andare a visitare il Museo di storia naturale di Haarlem insieme a un amico comune, il tedesco Johann Bartsch. In un'altra lettera, ringrazia per l'invio di un campione di zinco. Il suo interesse principale era infatti la mineralogia. Secondo gli atti dell'Università di Leida, Lawson ottenne il titolo di dottore in medicina il 28 dicembre 1737 con una tesi sull'ossido di zinco; ma prima di tornare a casa, si concesse un lungo giro in Germania, per visitare le miniere della famosa regione mineraria dello Harz e alcune importanti città. Siamo minutamente informati del viaggio grazie a due lettere a Linneo, la prima inviata da Goslar il 10 aprile 1738, la seconda da Londra il 27 maggio 1739. Il viaggio si protrasse dalla primavera all'autunno del 1738; Lawson visitò le miniere di Zellerfeld e Clausthal, quindi si spostò a Sankt Andreasberg e a Züdlinburg, raccogliendo campioni di minerali per la propria collezione o da inviare ad altri studiosi, tra cui Gronovius. Visitò quindi Berlino, Halle, Lipsia, Dresda e i distretti minerari della Sassonia. Quando arrivò nella celebre città termale di Carlsbad, si rese conto che i suoi piani di proseguire per Praga, Vienna e Ungheria non erano realistici (avrà finito i soldi o la sua famiglia si sarà spazientita?) e tornò in Inghilterra, con una sosta di appena qualche giorno in Olanda per salutare gli amici. Durante il viaggio in Germania, Lawson incontrò molti studiosi. L'incontro forse più importante per la diffusione del metodo linneano nel mondo tedesco fu quello con Johann Joachim Lange ad Halle; Lawson gli mostrò Systema naturae e Lange (che era un teologo, e come naturalista un autodidatta) ne fu così entusiasta che decise di pubblicarne un'edizione tedesca. Questa edizione bilingue (in latino e in tedesco) uscì nel 1740. Nel 1739 Lawson si stabilì a Londra, dove esercitava la medicina. Continuò a corrispondere attivamente con Gronovius e con Linneo (anche se di questo periodo ci sono rimaste due sole lettere); come aveva fatto in Germania, continuò a diffondere il verbo linneano, stringendo amicizia con personaggi come Peter Collison, che insieme al pettegolo Gronovius è la nostra principale fonte per questo periodo. Sono notizie sparse e discontinue, che non formano una biografia ma ci danno un'idea del personaggio. Nel marzo 1739 Lawson prese parte alla seduta della Royal Society in cui fu presentata una copia di Hortus Cliffortianus. Nel 1740 fece pubblicare una lista delle regole a cui dovrebbe attenersi il naturalista per raccogliere e preservare correttamente gli esemplari; Gronovius la tradusse in latino e la inviò a Linneo, suggerendogli di pubblicare a sua volta qualcosa di simile. Nel 1742, quando il Presidente della Reale accademia delle Scienze Abraham Bäck (un altro amico di Linneo) visitò Londra, soggiornò nella stessa casa di Lawson. Sappiamo inoltre (anche se la corrispondenza tra di loro è andata perduta) che il medico fu in contatto con lord Bute, un altro scozzese che aveva studiato a Leida, e fu proprio lui, nel 1741, a proporre a Linneo di dedicare al nobile conterraneo il genere Stewardia. Dell'influenza di Lawson sui linneani ci informa una lettera di Pehr Kalm del giugno 1748, in cui leggiamo che a Londra c'è un nutrito gruppo di seguaci di Linneo: studiano accanitamente le sue opere, ne sanno recitare interi brani a memoria, e "Isaac Lawson è il loro maestro". La notizia è quanto meno curiosa: nel giugno 1748, come vedremo tra poco, Lawson era già morto. La frase di Kalm andrà dunque interpretata in senso metaforico. Quello che sappiamo con certezza è che nel 1747 Lawson divenne medico capo delle truppe britanniche inviate in Olanda a respingere l'invasione francese durante la guerra di successione austriaca, e morì nel corso di questa campagna. Forse fu una delle vittime della battaglia di Lauffeldt del 2 luglio 1747. Una breve profilo biografico nella sezione biografia.  Capelli rossi e tatuaggi rituali Proprio come aveva fatto con Gronovius, dedicandogli Gronovia, Linneo pagò il suo debito di riconoscenza con Isaac Lawson dedicandogli il genere Lawsonia. Lo scienziato svedese amava trovare qualche affinità tra i dedicatari e le piante e spesso nascondeva dietro le sue dediche un ritratto vegetale. Sicuramente lo fece per Gronovius, ma è difficile capire quale relazione vedesse tra Lawsonia inermis, ovvero l'esotica pianta da cui si ricava l'henné, e il generoso medico scozzese. Si tratta dell'unica specie del genere Lawsonia (famiglia Lythraceae). Nonostante il nome specifico (che significo "senza spine") è un grande arbusto spinoso con piccole foglie ellittiche e fiori profumati da bianchi a rosati seguiti da piccole capsule brunastre. La pianta è nota fin dall'antichità per le sue proprietà tintorie: la polvere di henné, ricavata dalle foglie essiccate, fornisce una tintura temporanea; unita a un fissatore, può essere impiegata per tingere stoffe e cuoio, ma il suo uso principale è nella cosmesi e nei tatuaggi. La pianta è coltivata da talmente tanto tempo che ne ignoriamo l'origine precisa; nel corso dei secoli è stata diffusa in un'area vastissima, dal Nord Africa fino al Sud Est asiatico; in alcuni di questi paesi i coloranti a base di henné costituiscono anche un importante prodotto di esportazione. In molte culture l'henné ha assunto un rilevante significato simbolico, religioso, rituale, associato alle feste principali dell'anno e ai momenti di passaggio della vita, in particolare la nascita e il matrimonio. Già gli antichi Egizi lo usavano per colorare le unghie, i capelli, le mani e i piedi delle mummie. In buona parte del mondo islamico e in India i matrimoni sono preceduti da speciali cerimonie durante le quali le mani e i piedi della sposa sono decorati con elaboratissimi tatuaggi tracciati con l'henné, un rito purificatore e apotropaico che dovrebbe allontanare il malocchio e propiziare la fertilità e la felicità del matrimonio. I disegni e lo stesso calore dei tatuaggi variano da una regione all'altra. In India i tatuaggi temporanei creati con l'henné sono anche una forma d'arte. In molte medicine tradizionali, l'henné è anche utilizzato per curare affezioni diverse, tanto da essere considerato una vera panacea. Sembra che in Europa l'uso dell'henné per tingere i capelli, oltre ad essere legato alla moda dell'orientalismo, sia stato diffuso dai preraffaelliti, a partire da Elizabeth Sidall, la moglie e musa di Gabriel Dante Rossetti, che esaltava il biondo-rosso naturale dei suoi capelli con impacchi di henné. Passò poi agli Impressionisti, e lunghi capelli rossi tinti con l'henné divennero quasi un marchio di fabbrica delle ragazze della bohème. La moda sarebbe stata poi rinnovata a partire dagli anni '60 del Novecento dal movimento hippie e dalle tendenze new age, che esaltavano il ritorno alla natura e il recupero dei saperi tradizionali. Altre informazioni nella scheda. Due simboli iconici si incontrano in questa storia: da una parte il saguaro, il cactus gigante dei deserti americani, reso familiare dall'immaginario cinematografico; dall'altra, Andrew Carnegie, incarnazione del sogno americano, multimiliardario che ha ispirato la figura di zio Paperone, a suo tempo considerato l'uomo più ricco del mondo, ma anche celebre benefattore e filantropo. Il punto d'incontro tra i due è una collina nei pressi di Tucson, dove i saguaro sono di casa e dove, finanziato da Carnegie, nacque il Desert Laboratory. Qui li studiarono i botanici Britton e Rose, scoprendo che appartenevano a un genere tutto loro; e in onore del finanziatore, il saguaro divenne Carnegiea gigantea.  Prologo: cactus giganti e film western Chiudete gli occhi e provate a immaginare la scena madre di un tipico film western. Siamo alla resa dei conti: l'eroe, pistola in pugno, sta per affrontare il cattivo. A fare da sfondo, il deserto: terra rossastra, in lontananza le sagome della Monument Valley. La vegetazione è ridotta a pochi cespugli spinosi ma qua e là si stagliano le maestose sagome del cactus a candelabro. Lo state vedendo? E' lui, il nostro primo protagonista, il saguaro, ovvero Carnegiea gigantea, simbolo iconico dei film western; eppure, nella Monument Valley, i saguari non ci sono; e neppure nelle tante location in Utah, Colorado, New Mexico, Texas dove la fantasia di registri e scenografi li ha sparsi a piene mani. In realtà, il saguaro vive solo nel deserto di Sonora, anzi in alcune parti della porzione orientale di questo deserto, in Messico e in Arizona meridionale e occasionalmente nella California sudorientale; il cuore del suo regno è il Parco nazionale dei saguaro, nell'Arizona meridionale, con due sezioni rispettivamente nelle Tucson Mountains e nelle Rincon Mountains. Non lontano dalle Tucson Mountains e dal parco, nel 1939 la Columbia Pictures allestì il set dove fu girato Arizona, diretto da Wesley Ruggles. Al termine delle riprese, la casa di produzione decise di trasformarlo in uno studio cinematografico permanente, dove da quel momento sarebbero stati girati tutti i suoi western. Da allora sono stati oltre 300 tra film e telefilm, tra cui un monumento della cinematografia come Sfida all'OK Corral (1957). E' stato così che i saguaro hanno incominciato ad essere associati ai film western e diventarne un immancabile accessorio di scena, andando a popolare il nostro immaginario e paesaggi dove non esistono in natura.  Primo atto: il miliardario filantropo Altrettanto iconico è anche il secondo protagonista di questa storia, il miliardario Andrew Carnegie, incarnazione del sogno americano "dall'ago al milione" e prototipo della figura di zio Paperone. Come da copione, il nostro nasce in Scozia, arriva in America poverissimo e fa i più diversi mestieri: a tredici anni è un bobbin boy, uno dei ragazzi addetti al cambio e alla raccolta delle spolette in una manifattura di cotone, per dodici ore al giorno, sei giorni su sette, per una paga di un dollaro la settimana; lavora poi in una fabbrica di spolette, quindi passa ad una compagnia locale di telegrafi, prima come fattorino, poi come operatore. A 18 anni (adesso il suo salario è di 4 dollari la settimana) diventa operatore telegrafista della compagnia ferroviaria Pennsylvania Railroad Company e poi segretario di uno dei dirigenti; è un avido lettore, che nel tempo libero legge più che può e studia da autodidatta. A 24 anni diventa sovrintendente della Western Division. Siamo nel 1859 e le ferrovie sono un settore in grande espansione; Carnegie conosce le persone giuste e grazie ai loro consigli fa i suoi primi investimenti proprio nelle ferrovie, prendendo in prestito 500 dollari con un'ipoteca sulla casa di sua madre. Conosce per caso T. T. Woodruff, l'inventore del vagone letto, e insieme a lui fonda una piccola società per sfruttare l'invenzione. Il primo affare importante arriva con la guerra di successione; con la sua esperienza sia nei telegrafi sia nelle ferrovie, Carnegie è incaricato dal governo dell'Unione di ristabilire le linee ferroviarie e telegrafiche tagliate dai sudisti. Il trasporto di truppe e di materiali al fronte fornisce altre opportunità di guadagno. Dopo la guerra, Carnegie lascia le ferrovie, e si lancia nel siderurgico. La prima fabbrica, Cyclops Iron Company, fondata nel 1864 insieme al fratello, assorbe via via alcune fucine della zona e diventa la Union Mill. Produce ferro, un prodotto che il mercato chiede sempre meno, ormai soppiantato dall'acciaio. Durante un viaggio in Inghilterra, Carnegie conosce un nuovo metodo di produzione dell'acciaio, il processo Bessemer, e lo introduce nella sua acciaieria, fondata nel 1872. Da quel momento, sarà un successo travolgente. Combinando innovazione tecnologica, organizzazione efficiente e bassi salari, riesce via via ad assorbire i concorrenti, come la rivale Homestead Steel Works acquisita nel 1883, e diventa l'imperatore dell'acciaio; Pittsburgh è la capitale mondiale di quell'impero. Alla fine degli anni '80 la Carnegie Steel è la più grande produttrice di ghisa, rotaie ferroviarie e coke del mondo. Con i suoi associati, controlla l'integrazione verticale di tutte le fasi produttive, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione del prodotto finito. Nel 1892 nasce ufficialmente la Carnegie Steel Company, che dà una struttura formale a una ragnatela di interessi ed attività, che include la costruzione di locomotive, ferrovie, ponti, porti, edifici e la proprietà di 18 giornali. Lo stesso anno, mentre Carnegie si trova in vacanza in Italia, le sue acciaierie sono al centro di uno scontro sindacale (Homestead Strike), risolto da suoi associati con l'uso della forza. Carnegie è lontano, ma approva pienamente l'operato dei suoi uomini, compreso l'uso di milizie private e l'uccisione di diversi scioperanti. La sua reputazione ne esce compromessa. E' forse anche per questo che nel 1901, all'età di 66 anni, decide di ritirarsi. Trasforma l'azienda in una società per azioni e vende le sue attività industriali al banchiere John Morgan per la cifra record di 480 milioni di dollari. Le cronache del tempo lo considerano l'uomo più ricco del mondo (gli studiosi lo ritengono il quarto uomo più ricco di tutti i tempi). Da questo momento in avanti, non sarà più un industriale, ma un filantropo; anche se le sue attività filantropiche erano già iniziate da qualche anno, ora saranno la sua occupazione esclusiva. Autodidatta, crede nel valore dell'istruzione, e si impegna nella creazione di biblioteche: per suo impulso ne nasceranno oltre 2500, non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i paesi anglofoni. Per gli amanti della musica, il suo nome è perpetrato dalla Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto del mondo, costruita a New York per sua volontà nel 1890; per quelli delle arti, dal Carnegie Museum of Pittsburgh.  Secondo atto: un laboratorio nel deserto I musei, le fondazioni, le università, gli istituti di ricerca finanziati da Carnegie sono innumerevoli; sono una ventina le fondazioni che portano il suo nome, impegnate nei campi più diversi. Soffermiamoci su una soltanto, Carnegie Institution for Science di Washington. Molto interessato al progresso scientifico, subito dopo il ritiro, il miliardario-filantropo pensò di fondare una università nazionale a Washington, simile ai grandi centri di ricerca europei; temendo però lo scontento delle università già esistenti, vi rinunciò, puntando su un istituto di ricerca indipendente impegnato ad accrescere le conoscenze scientifiche di base. Comunicò al presidente Theodore Roosvelt che era pronto a dotare la nuova istituzione di 10 milioni di dollari; nel 1907 ne aggiunse 2, e altri 10 nel 1911. Inizialmente, l'istituzione finanziò soprattutto ricerche individuali, ma creò anche alcuni laboratori di ricerca. E finalmente stiamo per scoprire qual è il legame tra Andrew Carnegie e il saguaro. Nel 1891 Frederick V. Coville, botanico capo del Dipartimento federale di Agricoltura, aveva esplorato la Death Valley in California ed era rimasto affascinato dalla varietà di forme di vita in un ambiente così estremo. Poco dopo la sua fondazione, egli propose alla Carnegie Institution for Science di finanziare un laboratorio dove studiare le condizioni di vita delle piante dei deserti; l'istituto approvò la proposta e concesse un finanziamento di 8000 dollari. Restava da trovare un sito appropriato: insieme a Daniel T. MacDougal, direttore assistente del New York Botanical Garden, Coville visitò varie aree promettenti in California, New Mexico, Chihuaha, Sonora e Arizona; alla fine la scelta cadde su Tumamoc Hill, un'area collinare ricca di vegetazione ma facilmente accessibile nei pressi di Tucson. Nasceva così il Desert Botanical Laboratory, inaugurato il 7 ottobre 1903. Diretto inizialmente da MacDougal, che mantenne l'incarico fino al pensionamento nel 1928, divenne la base del Carnegie Department of Botanical Research, dotandosi via via di edifici per ospitare lo staff, di una serra, di aiuole sperimentali, di una rivista. Nella primavera del 1906, Volney Spalding, professore in pensione dell'Università del Michigan, che si era trasferito a Tucson in cerca di un clima più mite, propose di delimitare 19 quadrati di 10 metri x 10, e monitorare le piante perenni, identificando, mappando e fotografando tutti gli individui. Era un metodo innovativo che faceva i suoi esordi proprio in quegli anni. Lo stesso anno vennero acquisiti ulteriori terreni e l'intera area fu circondata da una palizzata per tenere lontano il bestiame. Primo laboratorio al mondo dedicato alla flora dei deserti, il Desert Laboratory in pochi anni divenne un'istituzione di punta e uno stimolo per la nascita dell'ecologia negli Stati Uniti; nel 1915, tra i 30 fondatori della Ecological Society of America, sette erano ricercatori del Desert laboratory. Nel 1938, in seguito a problemi economici, la Carnegie Institution for Science decise prima di tagliare drasticamente i finanziamenti, riducendo all'osso il personale, poi di liberarsi del laboratorio, vendendolo simbolicamente per un dollaro. Propose l'acquisto all'Università dell'Arizona, che rifiutò; ad accettare fu invece il dipartimento federale delle foreste, che fino al 1956 lo usò come stazione sperimentale. Fu un periodo di sostanziale decadenza, con poche ricerche condotte soprattutto dall'Università dell'Arizona. La quale, nel 1956 si decise ad acquistare il laboratorio: ma invece di pagarlo un dollaro, dovette sborsarne 100.000. Il laboratorio rinacque. Nel 1964, venne realizzato un censimento dei saguaro, da confrontare con la mappa disegnata da Spanding nel 1907; il censimento fu ripetuto nel 1970, nel 1993 e tra il 2011 e il 2012. Nel 1982, furono creati nuovi quadrati per studiare le piante annuali. Nove di quelli creati da Spanding per le piante perenni esistono ancora: è la più lunga serie di dati fornita da quadrati ecologici al mondo. Oggi, con il nome di Desert Laboratory on Tumamoc Hill, è allo stesso tempo un'area protetta che preserva un ambiente unico, un laboratorio di studi ambientali, un'istituzione educativa collegata con l'Università dell'Arizona. Molte informazioni nel sito, inclusi coinvolgenti filmati.  Epilogo: come il cactus gigante divenne Carnegiea Tra i primi progetti del Desert Laboratory, figura la collaborazione con Britton e Rose per la grande ricerca sulle Cactaceae che sfocerà nei magnifici volumi su questa famiglia pubblicati tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution. Fu MacDougal a suggerire a Nathaniel Britton, all'epoca direttore dell'orto botanico di New York, di ampliare la sua ricerca sulle cactacee americane e di chiedere il finanziamento del Carnegie Institution per un progetto molto più ambizioso. Le trattative richiesero tempo, ma alla fine l'istituzione accettò di finanziare le ricerche e la pubblicazione e nel 1912 tanto Britton quanto Rose furono nominati ricercatori associati alla Carnegie. Il progetto si configurò fin da subito come una collaborazione tra l'orto botanico di New York, lo Smithsonian (dove a lungo aveva lavorato Rose) e il Desert Laboratory, che fu anche una delle sue basi logistiche. Tra le piante più caratteristiche di Tumamoc Hill ci sono proprio i saguaro; fu qui che li studiarono Britton e Rose, capendo che dovevano essere assegnati a un genere proprio (all'epoca erano ancora attribuiti al genere Cereus con il nome C. giganteus); era un'ottima occasione per ingraziarsi lo sperato finanziatore, ovvero Mr. Carnegie. Fu così che nel 1908 i due botanici crearono in suo onore il genere Carnegiea, con questa motivazione: "Questo genere è dedicato a Mr. Carnegie. Il Desert Laboratory della Carnegie Institution di Washington, a Tucson, Arizona, è circondato da esemplari tipici di questa pianta unica". Qualche maligno ha osservato che la dedicata era azzeccata non solo per la bellezza e l'unicità di questa specie, ma anche per le sue micidiali spine, evocative del carattere spinoso del dedicatario. Spinosità dimostrata anche in occasione della presentazione della nuova denominazione: inizialmente, Carnegie fu molto lusingato, ma quando scoprì che non si trattava di una nuova specie, ma solo di un cambio di nome, perse ogni interesse. Per inciso, egli morì nel 1919, pochi mesi dopo l'uscita del primo fascicolo di Cactaceae di Britton e Rose. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Sia come sia, da allora il saguaro è Carnegiea gigantea Britton & Rose, unica specie del suo genere. E' un cactus colonnare, con un tronco imponente, che mediamente raggiunge i dieci metri. Il più grande esemplare conosciuto è alto 13 metri e ha una circonferenza di 3 metri. I fusti colonnari hanno in genere 11-15 coste, lungo le quali si trovano areole ben separate, distanziate di circa 2-3 cm tra loro, ciascuna delle quali porta da 15 a 30 spine, lunghe da 5 a 11 cm, che provocano ferite dolorose e facili ad infettarsi. Sono piante a lentissima crescita. Quando nascono, sono minuscole, e a due anni non misurano ancora un cm. Una pianta di 15 anni è alta intorno ai 30 cm, mentre una pianta di un metro ha tra 20 e 50 anni di età. Intorno a 30 anni, incomincia a produrre i primi fiori e i primi frutti, ma la vera maturità arriva tra i 50 e i 75 anni, quando incomincia a sviluppare rami laterali; gli esemplari più vecchi e imponenti ne hanno molti (il record è di 49 rami, o braccia, su una singola pianta): lo sviluppo di molteplici rami è importante per la riproduzione, dal momento che la fioritura avviene soprattutto agli apici di fusti. Molti esemplari, tuttavia, non li sviluppano mai. I rami laterali sono piuttosto diversi dal fusto principale: hanno costolature molto più numerose, poco profonde, con spine più ravvicinate ma molto più brevi e meno acuminate, in modo da permettere l'accesso degli ospiti che impollinano i fiori e si cibano dei frutti. I bellissimi fiori bianchi, di consistenza cerosa, ricchissimi di polline, si aprono nel tardo pomeriggio e durano meno di una giornata; sono impollinati da numerosi animali, tanto diurni quanto notturni: api da miele, pipistrelli e molte specie di uccelli, tra cui colombe dalle ali bianche e diversi colibrì. I fiori sono seguiti da frutti che ricordano i fichi d'India, appetiti dagli uccelli. Ognuno contiene circa 2000 semi; in effetti, anche se hanno un'alta germinabilità, l'aridità e la predazione comportano molte perdite, tanto che si stima che solo l'1% produca una pianticella. Appena nata è minuscola, e ha bisogno di essere protetta per sopravvivere e crescere; a provvedere sono alberi e cespugli, come le leguminose Olneya tesota o Parkinsonia florida, che forniscono ombra e trattengono l'umidità. Negli ambienti più aridi, tuttavia, queste piante sono assenti e i saguaro iniziano la loro vita in mezzo a ciuffi d'erba o cespugli di Ambrosia dumosa o ancora accanto ad altre Cactaceae come Opuntia kunzei. Il saguaro è una specie chiave nel suo ambiente, che provvede cibo, riparo e protezione a molti animali. L'abbondantissimo polline è una fonte di cibo importante per i suoi impollinatori, come lo sono i frutti per le formiche e vari uccelli, in particolare le colombe dalle ali bianche. I picchi Melanerpes uropygialis e Colaptes chrysoides scavano i loro nidi nei tronchi; in genere, li usano per una sola stagione, rinnovandoli ogni anno. I loro nidi abbandonati, attorno al quale la pianta ha prodotto un callo legnoso, si trasformano in case "chiavi in mano" per molte altre specie di uccelli. Anche i nativi hanno sfruttato i saguaro per secoli in vari modi: le costole lignificate degli esemplari morti venivano usate per palizzate e gli antichi nidi dei picchi come cestini; con i frutti si preparavano marmellate, sciroppi e bevande fermentate per le cerimonie religiose. Qualche approfondimento nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|

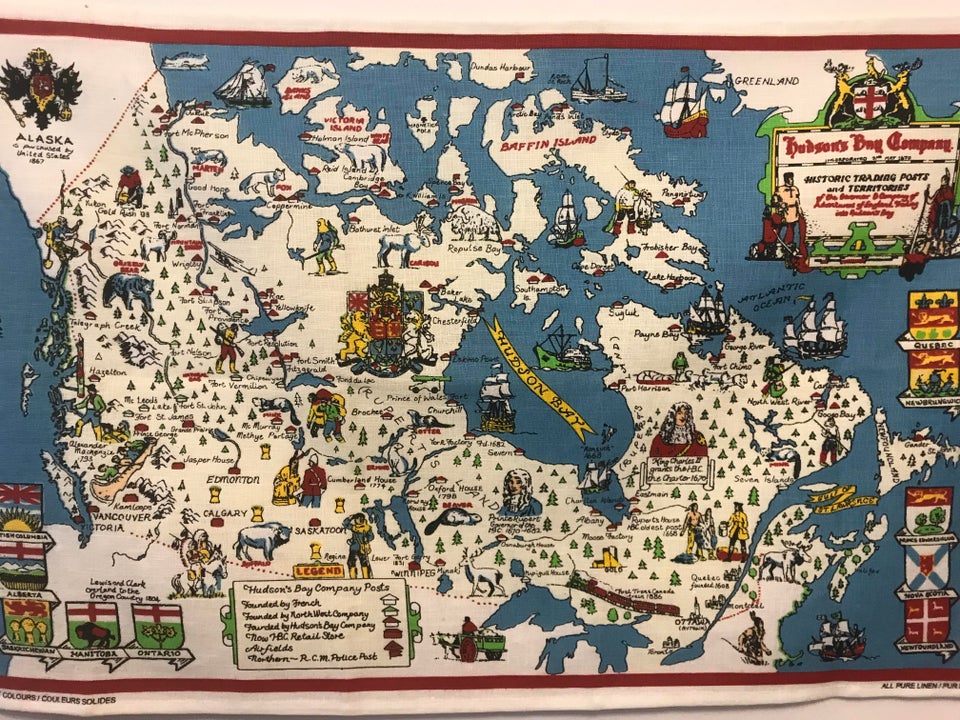
 RSS Feed
RSS Feed