|
Curioso destino, quello di William Forsyth: reputato dai contemporanei un'autorità indiscussa soprattutto nel campo delle piante da frutto, scrisse un best seller che resistette per decenni, stampato e ristampato; un successo professionale che raggiunse il suo apice con la creazione del Forsyth's plaister, che inizialmente gli procurò fama, onori e denaro, ma poi finì per rovinare i suoi ultimi anni (e la sua reputazione presso i posteri). Ora è ricordato soprattutto grazie alla solare forsizia, che con le sue esplosive fioriture annuncia l'arrivo della primavera.  Un prototipo di giardino roccioso... Abbiamo incontrato William Forsyth tra i sette padri fondatori della (futura) Royal Horticultural Society: a lui si rivolse Wedgwood per chiedergli di coinvolgere Banks, e sicuramente fu lui il principale organizzatore della fatidica riunione del 7 marzo 1804. Del resto, in quel momento era un'autorità: curatore dei giardini reali di Kensington e Saint James, autore di un volume di successo sull'arboricoltura, godeva del sostegno di membri del parlamento e dell'ammiragliato. Ma andiamo con ordine. Nato nel 1737 a Old Medrum, nei pressi di Aberdeen, Forsyth era uno dei numerosissimi giardinieri scozzesi che a partire dalla seconda metà del Settecento per circa un secolo quasi monopolizzarono l'orticultura inglese. Come molti conterranei, venne a cercare fortuna a Londra. Dopo aver perfezionato la sua formazione con Philip Miller al Chelsea Physic Garden, nel 1763 fu nominato capogiardiniere di Syon House, il grande parco londinese di proprietà del duca di Northumberland che proprio in quegli anni veniva riplasmato come giardino paesaggistico da Capability Brown. Nel 1771, quando l'ottuagenario Miller fu costretto al pensionamento dal Comitato dei farmacisti, gli subentrò come giardiniere capo a Chelsea; la sua assunzione fu subordinata all'accettazione di regole ferree imposte dal Comitato, che mal aveva sopportato l'indipendenza e il caratteraccio di Miller; il Comitato si riservava di decidere ogni particolare della sistemazione del giardino, e Forsyth doveva chiederne l'autorizzazione per ogni più piccolo spostamento, oltre che per scambiare piante e semi con altre istituzioni. Nonostante questo (e le condizioni finanziarie poco brillanti, con una paga annua di 50 sterline), si trattava di un incarico prestigioso: all'epoca - Kew era ai suoi esordi - Chelsea era il più importante orto botanico del paese. Forsyth lo curò per 13 anni. Durante la sua gestione, il giardino si arricchì di nuove specie, soprattutto tropicali, grazie ai buoni rapporti con vivaisti (come Gordon e Lee), collezionisti come lo stesso duca di Northumberland e Fothergill, e lo staff di Kew (il capo giardiniere Aiton e, ovviamente, lo stesso Banks). Forsyth stimolò anche l'attività di cacciatori di piante, come John Fraser. Tra le piante esotiche che giunsero in quegli anni a Chelsea, Caesalpinia pulcherrima, il pimento (Pimenta dioica), l'anatto (Bixa orellana), il mogano (Swietenia mahagoni), Guaiacum officinale, Senna alata. Sull'esempio del suo predecessore, Forsyth mantenne inoltre fitte relazioni e scambi con altre istituzioni botaniche e singoli studiosi nel resto d'Europa. Due furono le imprese più impegnative in cui si trovò coinvolto: in primo luogo, la ricollocazione delle piante che a partire dal 1773 ricevettero una collocazione sistematica basata sul sistema di Linneo; in secondo luogo, la creazione di quello che è considerato il più antico giardino roccioso europeo. Nel 1771 la Società dei Farmacisti decise infatti di creare un'area adatta alla coltivazione di piante che richiedono un substrato roccioso. Il progetto probabilmente si deve non Forsyth - che ebbe un ruolo di esecutore - ma a Stanesby Alchorne, il prefetto dell'orto, e a Uriah Bristow, membro del Comitato e più tardi Maestro della Società. Poiché i farmacisti non avevano fondi, per la costruzione si ripiegò inizialmente su materiali di recupero, in particolare pietre provenienti dalla Torre di Londra (che Alchorne pagò di tasca sua). Venne poi in soccorso Joseph Banks, che nel 1772 donò un carico di pietra lavica trasportato dall'Islanda. Con questi materiali Forsyth creò un monticello ovale di pietra dal diametro di appena 40 passi, che venne decorato con un assortimento di oggetti bizzarri: minerali insoliti; madrepore e coralli; una conchiglia gigante portata da Cook dai mari del Sud (che esiste tuttora); un busto dello stesso Banks. Chiamato semplicemente The Rock e costruito nel corso dell'estate del 1773, fu la prima struttura del genere in Europa. Sfortunatamente, non ci sono rimaste né informazioni su quali piante vi crescessero né illustrazioni d'epoca (la più antica è del 1890). Sotto l'opprimente tutela del Comitato e con una paga sempre più insoddisfacente mano a mano che la sua famiglia cresceva insieme alla sua reputazione di eccellente giardiniere, Forsyth si trovò a combattere con difficoltà economiche e organizzative: nel 1774 riuscì a strappare all'avaro Comitato il permesso di vendere le piante eccedenti e di coltivare una parte dell'orto a proprie spese e per il proprio uso; nel 1775, mentre continuavano i grandi lavori di trapianto richiesti dalla ricollocazione sistematica, ottenne l'assunzione di un terzo aiuto giardiniere, ma solo da marzo a ottobre. Nel 1777 rimase senza esito la sua richiesta di un aumento salariale, rimasto invariato da anni nonostante il rincaro del costo della vita.  Un mastice miracoloso? A sollevarlo da queste difficoltà giunse nel 1784 la nomina a Sovrintendente dei giardini reali di Kensington e St. James; in questa nuova veste, Forsyth dovette occuparsi della coltivazione di verdure e della cura delle piante da frutto. Molte erano vecchie, in cattive condizioni, affette da cancri e altre malattie del legno. Per riportarle in salute, oltre a rimuovere accuratamente le parti malate, Forsyth mise a punto la ricetta di un particolare mastice che, a suo dire, non solo chiudeva i fori e consolidava l'albero, ma consentiva la ricrescita di legno nuovo e sano. Il ritrovato (Forsyth ne manteneva segreta la composizione) suscitò l'immediato interesse delle alte sfere: disporre di alberi sani, in particolare querce, era essenziale per la marina inglese, civile e miliare, specie dopo la perdita delle colonie americane, che si aggiungeva alla costante diminuzione delle foreste britanniche. Nel luglio del 1789 (una decina di giorni dopo la presa della Bastiglia) i due rami del parlamento incaricarono un comitato di vagliare l'efficacia del mastice (noto come Forsyth's plaister) e di riferirne al Tesoro; visto il parere favorevole, nel maggio 1791 quest'ultimo dispose il pagamento a Forsyth di un premio di 1500 sterline in cambio della ricetta miracolosa. Eccola: uno staio di letame fresco, mezzo staio di calce, mezzo staio di cenere di legna, una sedicesima parte di sabbia di fiume, cui potevano aggiungersi, per rendere la miscela più fluida, urina e sapone. Per quanto possa apparirci bizzarra, non è molto dissimile dalle ricette in uso all'epoca (e da certi mastici e paste per tronchi ancora oggi usati, tra l'altro, nell'agricoltura biodinamica). L'opinione pubblica si divise: ad alcuni pareva uno spreco di denaro pubblico, per non dire una soperchieria o un caso di manifesta corruzione, che si fosse pagata una cifra enorme - vi ricordate la paga di Forsyth a Chelsea? - per un prodotto ben poco dissimile da quelli usuali. Altri - come capita anche oggi - furono invece sedotti proprio dalla semplicità della procedura e dal basso costo degli ingredienti di un prodotto che si voleva miracoloso, tanto più che a metterlo a disposizione di tutti aveva pensato lo stesso Forsyth, rivelandone pubblicamente la formula in appendice a Observation on the diseases, defects, and injuries in all kinds of Fruit and Forest Trees ("Osservazioni sulle malattie, i difetti, le lesioni di ogni tipo degli alberi da frutto e forestali"), uscito sempre nel 1791. A difendere a spada tratta il ritrovato di Forsyth (oltre a uomini politici, membri dell'ammiragliato e uomini della strada) fu soprattutto l'agronomo James Anderson nel suo Recreation in agricolture (1799). Sul versante opposto, il critico più reciso fu Thomas Andrew Knigth che nel 1801, nella seconda edizione di A Treatise on the Culture of Apple and Pear ("Trattato sulla coltivazione delle mele e delle pere"), avanzò alcuni dubbi, ribaditi più estesamente l'anno successivo in Some doubts relative to the efficacy of Mr. Forsyth's plaister in filling up the holes in trees ("Alcuni dubbi sull'efficacia del mastice di Forsyth nel riempire i buchi degli alberi"). Grande esperto di alberi da frutto (è considerato il padre della pomologia britannica), studioso della fisiologia vegetale che per alcuni aspetti anticipò Mendel, prove sperimentali alla mano, Knight dimostrò che il preteso mastice miracoloso non era certo in grado di far rinascere il legno morto; era solo una pasta che riempiva i buchi in modo tale che "era impossibile distinguere il legno nuovo dal vecchio". La risposta di Forsyth non si fece attendere; in appendice alla sua fortunata opera A Treatise on the culture and management of Fruit-Trees ("Trattato sulla coltivazione e la gestione degli alberi da frutto"), uscito anch'esso nel 1792, attaccò, senza nominarlo esplicitamente, il "libello" di Knight e allegò le testimonianze dell'efficacia del suo mastice, che gli giungevano da ogni dove, da San Pietroburgo a Madras. Knight, a sua volta, rincarò la dose, giungendo a insinuare che Anderson fosse in combutta con Forsyth. La polemica si trascinò per anni, sempre più violenta. Intanto, il trattato di arboricoltura di Forsyth conosceva uno strepitoso successo: senz'altro il più letto e più influente manuale sull'argomento di primo Ottocento, fu ristampato per almeno un trentennio, ne fu pubblicata un'epitome negli Stati Uniti e traduzioni in altri paesi. Anche se oggi molte delle pratiche che vi sono consigliate (prima tra tutte il trattamento delle lesioni del legno) sono superate, ne emerge chiaramente la profonda padronanza del soggetto da parte dell'autore. Il quale, probabilmente, non era dunque né un ciarlatano né un imbroglione: credeva in buona fede che il suo mastice fosse in grado di rigenerare il legno, senza rendersi conto che le piante non traevano giovamento dal plaister in quanto tale, ma dall'accurata rimozione delle parti malate. Quanto a Knight, Forsyth se ne vendicò come poté: come organizzatore della riunione che portò alla nascita dell'Horticultural Society, usò tutta la sua influenza per escluderne l'arcinemico, benché fosse uno scienziato rinomato e un protetto di Banks. Del resto, una vendetta di breve durata; Forsyth mori pochi mesi dopo (una sintesi della sua vita nella sezione biografie) e Knight non solo entrò a fare parte della Society, ma a partire dal 1811 ne divenne presidente (incarico che mantenne per 27 anni).  Alla scoperta delle solari forsizie In una simile atmosfera polemica, è improbabile che un botanico britannico avrebbe dedicato un genere a Forsyth; a commemorarlo tuttavia pensò il danese Martin Vahl che nel stesso anno della sua morte gli dedicò Forsythia, riconoscendo come appartenente a un nuovo genere Syringa suspensa, un arbusto giapponese descritto per la prima volta da C. P. Thunberg nel 1784. Il genere Forsythia, della famiglia Oleaceae, comprende una decina di specie di arbusti di origine soprattutto orientale (Cina, Corea, Giappone), con l'eccezione di F. europaea, nativa della penisola balcanica. Oggi è difficile immaginare un giardino o un parco senza le immancabili forsizie, che con le loro prorompenti fioriture color oro sono un vero e proprio araldo della primavera. Eppure sono arrivate da noi da meno di 150 anni. Dopo la segnalazione di Thunberg, bisogna aspettare un altro grande divulgatore della flora giapponese, Franz von Siebold, perché la prima Forsythia asiatica raggiunga l'Europa: è ancora F. suspensa, importata in Olanda intorno al 1830 e approdata in Inghilterra, nei famosi vivai Veitch, nel 1855. Nel 1864, il cacciatore di piante Robert Fortune introduce la varietà eretta (F. suspensa var. fortunei). Lo stesso Fortune, nel suo primo viaggio in Cina (1844-45) in un vivaio cinese si era imbattuto nella seconda specie decisiva per i moderni ibridi, F. viridissima. F. suspensa e F. viridissima sono infatti i genitori di F. x intermedia, nata da un incrocio casuale nell'orto botanico di Gottinga in Germania nel 1878. Nei decenni seguenti, numerosi altri ibridi x intermedia vengono attenuti dai vivaisti tedeschi; il più fiorifero e vigoroso di tutti è probabilmente 'Spectabilis', creato nel 1908 dal vivaio tedesco Spath, ancora oggi molto diffuso. Dopo la prima guerra mondiale, sono invece gli ibridatori statunitensi a dominare il campo; tra le cultivar più note, 'Lynwood' (nata da uno sport di 'Spectabilis' in Irlanda, ma resa popolare da vivaisti americani) e 'Arnold Giant', creata nell'Arnold Arboretum nel 1946. Ancora più tardiva è la conoscenza e la diffusione delle altre specie. F. europaea fu scoperta nel 1897 in Albania; la scoperta di F. giraldiana, un'altra specie cinese, si deve invece al missionario italiano Giuseppe Giraldi, che la raccolse nello Shanxi nel 1897. Solo nel Novecento di aggiungeranno la giapponese F. japonica, descritta nel 1914 da Tomitaro Makino, lettore di botanica all'Università di Tokio, e la coreana F. ovata, raccolta nel 1917 da Takenoshi Nakai sulla Montagna di Diamante nella Corea centrale. Altri approfondimenti nella scheda.
0 Comments
La sera del 7 marzo 1804 in una libreria del quartiere londinese di Piccadilly si incontrano sette uomini, diversi per età e condizione sociale. A unirli, la passione per il giardinaggio e l'orticoltura. Da quell'incontro nascerà la Horticultural Society, oggi Royal Horticultural Society, la più prestigiosa associazione di orticultura del mondo, con oltre 350.000 iscritti. Più di uno di quei sette uomini verdi è ricordato da un genere di piante. Per cominciare, facciamo conoscenza con il più altolocato, l'onorevole Charles Francis Greville, dedicatario della Grevillea. 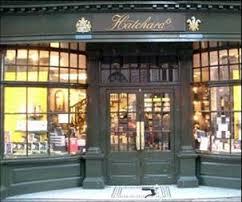 Una fruttifera riunione in libreria Nell'Inghilterra di inizio Ottocento, in cui il possesso di un parco con essenze esotiche è uno status symbol e l'hobby del giardinaggio unisce titolati e ricchi borghesi, mentre le conseguenze della interminabile guerra con la Francia rendono sempre più urgente incrementare le rese agricole e valorizzare gli alberi di frutto e da legname, l'idea di creare un'associazione che si proponga di promuovere lo sviluppo dell'orticultura in tutte le sue forme è nell'aria. Il primo a lanciarla è John Wedgwood, figlio di Josiah, fondatore della celeberrima fabbrica di ceramiche, che nel giugno 1801 scrive una lettera a William Forsyth, soprintendente dei giardini reali di Kensington e Saint James, chiedendogli di contattare sir Joseph Banks, presidente della Royal Society e grande patron degli studi botanici, per proporgli di creare una Società dedicata alla promozione dell'orticoltura. La risposta di Banks, prontamente coinvolto da Forsyth, è entusiastica, ma ci vogliono quasi tre anni per giungere alla fatidica sera del 7 marzo 1804 quando finalmente, presso la libreria Hatchards di Piccadilly, avviene l'incontro tra i sette soci fondatori da cui nasce ufficialmente la Horticultural Society (qualche anno dopo divenuta Horticultural Society of London e dal 1864, ottenuto il patrocinio reale, Royal Horticultural Society). I sette personaggi sono un piccolo spaccato della dinamica e aperta società inglese, in cui troviamo fianco a fianco nobiluomini, ricchi dilettanti, uomini di scienza e orticultori con le mani sporche di terra. Il primo è ovviamente John Wedgwood, che in quanto promotore presiede l'incontro. E' un ricco borghese appassionato di giardinaggio, ma è anche l'esponente di una famiglia in ascesa che unisce la ricchezza (derivata da una grande azienda di successo) agli interessi scientifici. Il padre Josiah, protagonista della prima rivoluzione industriale, si interessò di scienza applicata, inventò il pirometro - uno strumento per misurare le alte temperature necessarie per la cottura delle ceramiche - e fu accolto nella Royal Society. Il fratello Richard proseguì gli studi del padre sulla temperatura, ma soprattutto fu tra gli antesignani della fotografia. La sorella Susannah sposò Robert Darwin, figlio del filosofo Erasmus, divulgatore del sistema linneano con un poema all'epoca famoso, Gli amori delle piante. Dalla coppia nascerà il grande naturalista Charles Darwin. A rappresentare la nobiltà è l'honourable Charles Francis Greville, figlio cadetto di un lord, collezionista d'arte e appassionato dilettante di giardinaggio. La scienza è invece rappresentata da tre botanici: sir Joseph Banks, amico personale del re Giorgio III, sovrintendente ufficioso e artefice dei Royal Kew Gardens, presidente della Royal Society, e onnipotente patrono della botanica britannica, che già tante volte abbiamo incontrato in questo blog; Richard Anthony Salisbury, un personaggio dal passato (e dal futuro) alquanto chiacchierato; James Dickson, autore di un'importante opera sulle alghe e i funghi britannici, ma anche vivaista e come tale esponente anche dell'ultimo gruppo, quello dei "pratici". A formarlo insieme a lui sono i sovrintendenti dei giardini reali: William Forsyth, che dirige i parchi di Kensington e St. James dopo una lunga gavetta iniziata come aiuto giardiniere; William Townsend Aiton, capo giardiniere di Kew, carica ereditata dal padre, il grande William Aiton.  Nomi botanici, imbrogli e scandali Per quella che non è affatto una coincidenza, ben quattro di questi sette personaggi sono onorati da generi celebrativi tuttora validi, e un quinto da un sinonimo che gli assicura comunque un posto nella storia della nomeclatura botanica. A essere rimasti a bocca asciutta sono soltanto Josiah Wedgwood e W. T. Aiton, che tuttavia vive di gloria riflessa, dal momento che il suo nome di famiglia è ricordato dal genere Aitonia, dedicato al padre (oggi però ridotto a sinonimo). A sfiorare il podio è stato Richard Anthony Salisbury, nato Richard Markham; quando partecipò alla fatidica riunione, aveva alle spalle un passato burrascoso che lo aveva portato in carcere per debiti, ma godeva di una solida reputazione scientifica; nel 1797 James Edward Smith gli aveva dedicato il genere Salisburia (non valido: Salisburia adiantifolia Smith è un sinonimo di Ginkgo biloba L., pubblicato da Linneo nel 1771); nel 1809 fu nominato segretario ad honorem propria della neonata Horticultural Society. Ma quello stesso anno fu protagonista di uno scandalo che gli costò l'ostracismo dall'establishment scientifico britannico; dopo aver assistito presso la Linnean Society ad una conferenza di Robert Brown in cui lo botanico scozzese presentava la sua revisione tassonomica delle Proteaceae, ne memorizzò i nomi e li pubblicò come propri, sotto il nome di un amico, Joseph Knight, anticipando di qualche mese la pubblicazione di Brown. Da quel momento, nonostante la sua innegabile competenza, le sue opere furono boicottate e rimasero manoscritte; inoltre il suo successore alla carica di tesoriere della Horticultural Society, Joseph Sabine, ne rilevò e denunciò le irregolarità finanziarie. I quattro generi tuttora validi sono toccati rispettivamente a sir Joseph Banks con Banksia L.f. 1782 (se ne è già parlato in questo post); William Forsyth con Forsythia Vahl 1804; James Dickson con Dicksonia L'Héritier 1789; Charles Francis Greville con Grevillea R. Brown ex Knight 1809. Riservando a Forsyth e Dickson i prossimi post, approfondiamo ora la conoscenza con Greville.  Fiorirà la vaniglia Charles Francis Greville era il secondo figlio del primo conte di Warwick, proprietario tra l'altro di un grande parco progettato da Capability Brown. Come molti cadetti del suo ceto, godeva di un patrimonio personale molto limitato. Nonostante questo, investendolo con proverbiale oculatezza - i detrattori la definivano avarizia - riuscì a creare una notevole collezione di antichità e di pittura italiana, anche grazie ai contatti dello zio materno, sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli. Nelle cronache rosa, è noto per la sua lunga relazione con Emily Hart detta Emma. Ormai stanco di lei e desiderando sposarsi con una ricca ereditiera - l'unico modo per rimpinguare le sue magre finanze - senza tenere conto della volontà di lei, la spedì a Napoli dallo zio, da cui contava di ereditare, perché ne facesse la sua amante, nel duplice intento di liberarsi di una relazione scomoda e di evitare un secondo matrimonio del facoltoso parente. I suoi progetti però fallirono completamente: il ricco matrimonio andò in fumo, sir William si innamorò di Emma e la sposò; con il nome di lady Hamilton, la bellissima donna entrò nella storia come confidente della regina Carolina di Napoli e come amante di Horace Nelson. Alla morte del padre, Greville ereditò dal fratello maggiore un seggio alla Camera dei comuni e percorse una carriera politica che lo portò a rivestire diverse cariche di una certa rilevanza (fu Tesoriere della Real casa e membro del Consiglio privato della corona). Gli furono spesso affidati incarichi finanziari, dove poté esplicare il suo notevole spirito imprenditoriale. I suoi interessi scientifici furono variegati; come collezionista, incominciò a interessarsi di pietre preziose e minerali, divenendo amico di James Smithson, dedicatario dello Smithsonian di Washington; le sue collezioni furono poi acquisite dal British Museum. Membro di diverse società scientifiche (incluse la Royal Society, la Linnean Society e la Society of Antiquarians of London), come membro della Società dei dilettanti divenne intimo amico di Joseph Banks, che lo avvicinò alla passione per i giardini. Per molti anni visse in una casa affacciata sul Paddington Green, alla periferia di Londra, dove creò un giardino estremamente raffinato, dotato di serre in cui coltivava le piante tropicali che gli giungevano grazie ai contatti di Banks. Nell'inverno 1806-1807 ottenne il suo maggior successo, riuscendo a far fiorire per la prima volta in serra l'orchidea da cui si ricava la vaniglia, Vanilla planiflora. Pubblicata nel 1807 da Salisbury nel suo Paradisus londinensis (un catalogo delle piante più significative dei giardini di Londra), proprio perché se ne conoscevano i fiori solo da illustrazioni, fu ritenuta erroneamente una nuova specie e battezzata Vanilla fragrans. Greville fornì anche diversi esemplari di piante rare a James Edward Smith per il suo erbario, oggi conservato presso la Linnean Society. Qualche informazione in più sulla sua vita nella sezione biografie.  Il fascino esotico della Grevillea A questo appassionato di giardini e protettore della botanica, Robert Brown volle dedicare uno dei nuovi generi di Proteaceae australiane, Grevillea, stabilito nel 1810 in Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen. Come si accennato, però, i suoi risultati furono plagiati da Salisbury, che nel 1809 ne anticipò la pubblicazione in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae, sotto il nome di Knight. Ecco perché, per la regola della precedenza, la denominazione completa del genere è Grevillea Brown ex Knight. Con le sue circa 300 specie, Grevillea è uno dei più vasti generi della famiglia Proteaceae. Multiforme per portamento (si va dagli arbusti sempreverdi prostrati alti non più di mezzo metro ai grandi alberi che superano i trenta), si è adattato agli habitat più vari: dagli ambienti montani innevati alle foreste pluviali, dalle aree aride semidesertiche dell'interno australiano alle zone costiere sabbiose. La maggior parte delle specie è endemica dell'Australia, ma il suo areale si estende a nord all'Indonesia e alla Nuova Guinea e a est alla Nuova Caledonia. Molto caratteristiche sono le infiorescenze dai colori brillanti, talvolta unilaterali, talvolta cilindriche, che possono ricordare uno spazzolino, formato da numerosissimi fiori privi di petali con un calice tubolare che si divide in quattro brevi lobi da cui si protende un lunghissimo stilo. Ricchi di nettare, attirano insetti e uccelli, che ne sono i principali impollinatori; alcune specie sono però impollinate da farfalle, falene, coleotteri, imenotteri, formiche e persino da piccoli marsupiali. Le foglie alternate variano invece molto da una specie all'altra (aghiformi, pennatosette, pennate, profondamente dentate). Per i loro fiori inconsueti e vistosi, dal fascino decisamente esotico, alcune sono apprezzate piante da giardino; in Australia sono tra le più frequentemente coltivate nei parchi e nei giardini pubblici e privati; introdotte nei paesi tropicali e subtropicali, alcune specie sono abbastanza diffuse anche da noi in aree non soggette a gelate. Tra le più note G. banksii, un piccolo albero o arbusto espanso originario del Queensland, con vistosi racemi cilindrici rosso brillante; relativamente frequente da noi anche l'arbustiva e rustica G. rosmarinifolia, orginaria dell'Australia Sud orientale, con lunghe foglie lineari e fiori da rosa vivo e rosso riuniti in racemi allargati, da alcuni paragonati a ragni. G. robusta, nativa del Queensland e del South New Wales, è invece un vero e proprio albero, di crescita veloce, con fiori da arancione a giallo oro, riuniti in racemi orizzontali unilaterali. Moltissimi sono poi le cultivar e gli ibridi orticoli, selezionati soprattutto in Australia. Qualche approfondimento nella scheda. Situato all'estrema periferia occidentale dell'Impero russo, l'orto botanico di Tartu, in Estonia, nell'Ottocento giocò un sorprendente ruolo di primo piano nella conoscenza della flora russa e asiatica. Il merito di aver fondato quella importante scuola botanica fu di un baltico di lingua tedesca, Carl Friedrich von Ledebour. A celebrarne il ricordo, il genere africano Ledebouria. 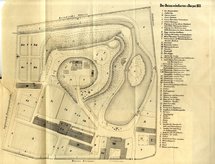 Rinasce un'Università, nasce un Giardino botanico Tartu, all'epoca meglio nota con il nome tedesco Dorpat, vantava una prestigiosa università di lingua tedesca e confessione luterana, fondata nel 1632 dal re di Svezia Gustavo Adolfo come baluardo conto il controriformismo polacco. Dopo diverse vicissitudini, già prima del passaggio dell'Estonia sotto il dominio russo, nel 1721, aveva cessato di esistere. Sotto l'impulso degli intellettuali baltici di lingua tedesca venne rifondata nel 1798 e consolidata nel 1802; dal punto di vista amministrativo e finanziario, dipendeva dalla corona russa, ma sul piano culturale era un'istituzione tedesca; in tedesco venivano impartite le lezioni e tedeschi, spesso balto-tedeschi, erano gli insegnanti. Nel 1803, ad affiancare l'insegnamento della medicina, delle scienze naturali e della farmacia, venne creato un orto botanico, inizialmente collocato in via Vanemuise, sotto la direzione di Gottfried Albrecht Germann; nel 1806 lo stesso Germann, con l'aiuto del capo giardiniere J. A. Weinmann, curò il trasferimento in una sede più idonea, sull'antico bastione di via Lai (dove il giardino si trova tuttora). Il duplice legame - da una parte con la Russia, protagonista in quegli anni di molte spedizioni scientifiche, con il suo immenso territorio in gran parte ancora inesplorato, dall'altra con la Germania e più un generale con la rete degli studiosi, degli orti botanici e delle università europee - fece dell'Università di Tartu/Dorpat un importante luogo di interscambio culturale e permise all'orto di crescere rapidamente. Un primo catalogo indica un patrimonio di 4300 specie. Germann era uno studioso polivalente, interessato soprattutto alla botanica e all'ornitologia. All'Università di Dorpat insegnava storia naturale, botanica, zoologia, mineralogia, entomologia e ornitologia. Come strumento didattico, creò anche un gabinetto di storia naturale, con collezioni di insetti, minerali e un erbario. Anche Weinmann era un personaggio notevole: prima di arrivare a Tartu aveva lavorato a Würzburg e Vienna, dopo Tartu lavorerà a San Pietroburgo e sarà ammesso all'Accademia delle scienze.  Dalle rive del Baltico ai monti dell'Asia centrale Ma la vera svolta fu impressa dal secondo curatore dell'orto ( e secondo professore di botanica dell'Università). Morto Germann nel 1809, per qualche tempo i due incarichi rimasero vacanti, finché venne nominato a sostituirlo il giovane e dinamico Carl Friedrich Ledebour; nato a Stralsund, da parte di madre era anche lui un tedesco del Baltico, ma da parte di padre era svedese. E in Svezia era entrato in contatto con la scuola linneana nella persona di Carl Peter Thunberg. Arrivato a Tartu nel 1811, in piene guerre napoleoniche, dopo un avventuroso viaggio da Berlino, dimostrò subito la sua intraprendenza, riuscendo a ottenere dalle autorità russe la costruzione di una nuova serra, un notevole aumento dei fondi e l'ampliamento del giardino, che sotto la sua gestione raggiunse le dimensioni attuali di circa tre ettari. Ottimo didatta, riuscì a creare intorno a sé una prestigiosa scuola botanica, introducendo di fatto in Russia l'insegnamento della botanica sistematica; tra gli esponenti più noti, Johann Friedrich von Eschscholtz, che ritroveremo in questo blog come naturalista della spedizione Kotzebue; e i suoi stretti collaboratori Carl Anton von Meyer e Alexander Bunge. Era un eccellente tassonomista, ma non disdegnava la ricerca sul campo. Nel 1815 avrebbe desiderato partecipare come naturalista alla spedizione di Kotzebue nel mar Glaciale Artico e nel Pacifico, insieme al suo allievo Eschscholtz, ma dovette rinunciare per motivi di salute. Nel 1818 visitò brevemente la Crimea insieme a un altro allievo, Carl Anton von Meyer. Ma la grande avventura di Ledebour iniziò nel 1826, quando diresse una grande spedizione nei monti Altai e nelle steppe del Kirghizistan, questa volta con Meyer e Bunge. Per due anni, muovendosi separatamente, i tre botanici esplorarono a fondo una regione ancora poco nota, raccogliendo oltre 1600 specie di fanerogame; se la botanica costituiva il loro interesse principale, non mancarono raccolte di minerali e animali. Ledebour riservò a se stesso la parte orientale della catena; visitò Ridder, Zyryanovsk, esplorò la valle dell'Irtysh e raggiunse e sorgenti dei fiumi Uby, Charysh e Yeni. Quindi visitò Katun e si spinse fino ai confini con la Cina. Una relazione del viaggio è contenuta in Reise durch die Altaigebirghe und die Soongorische Kirgisen-Steppe ("Viaggio nei monti Altai e nella steppa del Kirgizistan), pubbicato in tedesco a Berlino tra il 1829 e il 1830. Al loro rientro a Tartu, i tre naturalisti scrissero insieme l'importante Flora Altaica, in quattro volumi, uscita tra il 1829 e il 1833, considerata la prima flora regionale del secolo. Tra le specie descritte per la prima volta Malus sieversii (con il nome di Pyrus sieversii) e Larix sibirica. Dei risultati della spedizione usufruì anche l'orto di Dorpat, che si arricchì di molte specie di piante siberiane e centro-asiatiche, divenendo anche il principale tramite per la loro conoscenza e diffusione in Europa, grazie agli scambi con la rete europea degli orti botanici. In tal modo furono gettate le besi della particolare vocazione dei botanici dell'Università di Dorpat, che in un certo senso si specializzarono nello studio della flora della Russia orientale e dell'Asia. Insieme ai due collaboratori e ad altri allievi, Ledebour iniziò quindi a studiare i materiali botanici raccolti da Chamisso, Wormskjold e Eschscholtz durante le spedizioni di Kotzebue (1815–1818 e 1823–1826), nonché i materiali raccolti nella Russia meridionale da Carl Eduard Eichwald (1825–1826) e da von Nordmanne e Th. Döllinger nel 1836. Su questa base, Ledebour iniziò a scrivere un'opera complessiva sulla flora russa: un' impresa impegnativa, che lo spinse nel 1836 a lasciare l'incarico universitario (lo sostituì Bunge) per dedicarsi ad essa a tempo pieno. Il risultato fu Flora Rossica, in quattro volumi, uscita tra il 1841 e 1853, la prima che copre l'intero territorio dell'Impero russo (Russia europea, Asia, Caucaso, Alaska), per un totale di circa 6500 specie; nonostante sia priva di immagini, questa prima descrizione completa della flora russa rimase per decenni un'opera di riferimento. Pur avvalendosi ancora una volta della collaborazione di diversi altri studiosi, Ledebour realizzò il grosso del lavoro, che completò letteralmente pochi giorni prima della morte. Qualche approfondimento sulla sua vita nella sezione biografie.  Ledebouria, minuscoli gigli tigrati A ricordare Ledebour sono in primo luogo numerose piante da lui descritte per la prima volta (Lilium ledebourii, Trollius ledebourii, Lonicera ledebouri, Rhododendron ledebourii, Artemisia ledebouriana, ecc). Ma soprattutto, a questo grande esperto della flora siberiana e asiatica, è toccato di essere celebrato da un genere soprattutto africano. Fu Albrecht Wilhelm Roth nel 1821 (quando Ledebour era un apprezzato studioso dell'Università di Dorpat, ma non aveva ancora affrontato né la grande spedizione negli Altai né scritto le sue due opere principali) a dedicargli il genere Ledebouria, descrivendo la specie tipo, l'indiana L. hyacinthina. Il genere Ledebouria, della famiglia Asparagaceae, sottofamiglia Scilloideae (un tempo Hyacinthaceae) ha avuto una storia tassonomica complessa, venendo assegnata da botanici diversi successivamente ad altri generi affini (Hyacinthus, Lachenalia, Drimia, Scilla); nel 1970 è stato ristabilito da Jessop. Ancora incerto rimane il numero di specie assegnate (da circa 40 a 60); sono bulbose soprattutto sudafricane (almeno una trentina di specie), con qualche rappresentante anche in Madagascar e in India. Di dimensioni molto variabili, da minuscole a relativamente grandi, sono spesso caratterizzate da foglie più o meno carnose vistosamente macchiettate. Probabilmente la specie più nota da noi, spesso offerta da Garden center e specialisti di succulente, è la graziosa L. socialis (spesso commercializzata con il vecchio nome di Scilla socialis o S. violacea), originaria di aree sabbiose ma ricche di humus della zona di transizione tra il Capo orientale il Capo Occidentale in Sud Africa. E' caratterizzata da bulbi che crescono sopra il livello del suolo, protetti da tuniche di consistenza cartacea, da cui spuntano ciuffi di foglie oblunghe da verde a argentee, spesso densamente macchiettate, che le hanno guadagnato il nome inglese di Tiger lily, "Giglio tigre". Un'altra specie abbastanza diffusa in coltivazione è L. cooperi, con foglie lineari, lucide, erette, rigate, e graziose spighe di fiori rosa brillante. Per qualche informazione in più su qualche altra specie meno nota si rimanda alla scheda. Nel Cinquecento la creazione dei primi orti botanici imprime una svolta allo studio delle piante. Accanto a quelli pubblici, nati in ambito universitario, come quelli di Pisa e Padova, anche giardini privati ebbero talvolta un ruolo nella (ri)nascita dell'interesse per la botanica. Ne è un esempio il giardino della Montagnola, creato a Napoli da Gian Vincenzo Pinelli intorno alla metà del XVI secolo, grazie al quale si formò un vivace circolo di studiosi e appassionati.  Un giardino e una corrispondenza internazionale Il nome di Gian Vincenzo Pinelli è noto agli studiosi di Galileo e ai bibliofili. Trasferitosi a Padova dal 1558, attratto da quella celebre università, vi creò una immensa biblioteca che, almeno in parte, venne acquistata dal cardinal Borromeo andando a costituire uno dei fondi più importanti della Biblioteca ambrosiana; raccolse attorno a sé un importante circolo di intellettuali, fu il primo ospite di Galileo che poté avvalersi della sua notevole collezione di volumi di ottica; fu in corrispondenza con il fior fiore degli intellettuali europei. Ma prima di tutto questo, nella sua giovinezza napoletana, Pinelli fu veramente un "giovane meraviglioso". Di salute cagionevole, aggravata da un grave incidente a un occhio, fin da bambino si dedicò attivamente allo studio, acquisendo una cultura vastissima e poliedrica. Le cospicue risorse economiche della famiglia (il padre era un mercante genovese trasferitosi a Napoli per meglio curare i propri interessi commerciali) gli permisero di avere i migliori maestri: il filosofo e letterato napoletano Gian Paolo Vernaglione per la cultura classica e le lingue latina e greca; il celebre compositore fiammingo Filippo de Monte per la musica. I suoi interessi includevano anche le scienze: i problemi di vista lo spinsero a studiare ottica; le piante medicinali esotiche che affluivano al porto di Napoli, uno dei principali del Mediterraneo, lo avvicinarono alla medicina e botanica. Fu così che intorno alla metà del secolo il giovanissimo Pinelli fece impiantare in una proprietà della famiglia fuori delle mura della città, sulla collina dei Miracoli in località Montagnola, un giardino botanico privato, sul modello di quello che pochi anni prima Ghini aveva creato a Pisa. Secondo le testimonianze dell'epoca, comprendeva specie sia medicinali sia ornamentali, ed era ricco di essenze rare ed esotiche. Forse grazie a Ghini, Gian Vincenzo entrò in contatto con il suo allievo prediletto, Bartolomeo Maranta, che rientrato a Napoli da Pisa intorno al 1555, divenne il suo maestro di medicina e botanica, nonché il curatore del giardino. In realtà, fu un arricchimento reciproco: se Pinelli si giovò della grande competenza di Maranta, quest'ultimo fu stimolato dalle intelligenti conversazioni con il dotatissimo allievo. La frequentazione quotidiana del giardino della Montagnola permise al botanico di mettere alla prova le conoscenze apprese alla scuola di Ghini e di creare un vero e proprio metodo per il riconoscimento dei semplici, esposto in Methodi cognoscendorum simplicum libri tres (1559), che volle dedicare a Pinelli (al tempo ventitreenne). Maranta non era il solo frequentatore di quel favoloso giardino; un altro abituè fu il farmacista Ferrante Imperato che ne ottenne esemplari per la sua collezione e rese omaggio a Pinelli nella prefazione della sua Historia naturale, dove lo celebra come fondatore della scuola naturalistica napoletana. Tuttavia nel 1558 Gian Vincenzo riuscì finalmente a convincere il padre a lasciarlo partire per Padova. Non sappiamo quale sorte avesse il giardino dopo la sua partenza; pare che per qualche tempo fosse affidato alla cura di Maranta che tuttavia a sua volta lasciò Napoli a più riprese (e per un certo periodo, nel 1562, subì anche il carcere dell'Inquisizione). Probabilmente, lontani il proprietario e il curatore, il giardino languì e fu abbandonato. Non di meno, anche a Padova Pinelli continuò a interessarsi di scienze naturali; oltre alla ricchissima biblioteca, considerata la maggiore del tempo, creò anche una collezione di antichità e di storia naturale; anche la casa padovana aveva un giardino ricco di piante rare. Soprattutto, fu l'animatore di una rete di studiosi europei, che consentì di collegare gli esponenti dell'umanesimo e della ricerca scientifica italiana con gli studiosi d'oltralpe. La sua stessa casa - meta irrinunciabile degli intellettuali stranieri in visita in Italia - divenne in un vero centro di smistamento da cui transitavano lettere, libri, pacchi di reperti. Ad esempio, Imperato si rivolse a lui per far pervenire un pacco (che conteneva tra altri esemplari una collezione di semplici essiccati) al botanico tedesco Camerarius; e a Pinelli fece spesso ricorso per procurasi reperti rari per il suo museo. Fu sempre Pinelli a mettere in contatto Clusius con Imperato e Aldrovandi. Anche Gessner e i fratelli Bahuin furono tra i suoi contatti. Dopo aver fondato in giovinezza un giardino, nella maturità Pinelli fu dunque uno dei principali tramiti tra la botanica italiana e quella europea. Questi i suoi meriti botanici; qualche informazione in più sulla vita del poliedrico erudito, che fu cultore di molte materie ma non scrisse neppure un libro, nella sezione biografie.  Pinellia, un drago verde dalla Cina Al fervore di studi della Napoli rinascimentale, seguì una lunga pausa. Bisognò attendere il Settecento perché rifiorissero gli studi di botanica e addirittura il 1807 perché Napoli avesse il suo orto botanico. Per una singolare coincidenza, sorse proprio in località Montagnola, dove 250 anni prima Pinelli faceva coltivare il suo orto dei semplici. Se ne ricordò Michele Tenore, primo prefetto dell'orto napoletano, nell'agosto del 1839, quando creò un nuovo genere, staccandolo da Arum. Nella comunicazione all'Accademia reale delle scienze si dichiara deciso a imitare l'esempio dei botanici di tutte le nazioni che quasi ogni giorno creano nomi in onore dei "più distinti cultori della scienza delle piante". Quindi aggiunge: "Di simili omaggi noi scrittori della Penisola mostrar ci dobbiamo più teneri, come quelli che meno frequenti occasioni avendo di tributarli, una schiera non meno numerosa d'illustri nomi negli annali della scienza registrati troviamo, che ne attendono tuttora il meritato favore". La sua scelta cadde dunque su Pinelli, di cui Tenore ricorda i meriti come fondatore del giardino della Montagnola, prima istituzione di questo tipo in Napoli. Nacque così il genere Pinellia della famiglia Araceae. Pinellia è un piccolo genere endemico dell'Asia orientale (Cina, Corea, Giappone) che comprende nove specie, con centro di biodiversità in Cina. Alcune di esse sono relativamente conosciute anche da noi come piante ornamentali, prima fra tutte la famigerata P. ternata. Famigerata perché questa erbacea, per quanto bella e gradevole, si dimostra fin troppo espansiva e volonterosa, tanto da essere ormai considerata una pericolosa infestante. Così, l'anno scorso l'orto botanico di Torino ha chiamato a raccolta amici, studenti, volontari per eradicarla dalle sue aiuole. Eppure in Cina è una specie di notevole importanza etnobotanica, utilizzata nella medicina tradizionale nel trattamento di svariate malattie. Più controllabili e (a mio parere) più attraenti altre specie: in particolare la giapponese P. tripartita, con foglie trifogliate con venature molto evidenti e uno spadice lunghissimo, verde acido, che le ha guadagnato il nome di Green Dragon. Notevole anche il fogliame di P. pedatisecta, che forma una grande ventaglio di lunghe foglioline lanceolate, di aspetto molto esotico. Un po' meno diffusa è la piccola P. cordata, che in alcune varietà ha foglie a freccia o cuoriformi piacevolmente marmorizzate. Qualche approfondimento nella scheda. La prima immagine a stampa (1599) di una Wunderkammer, una camera delle meraviglie, immortala il Museo di Ferrante Imperato, farmacista napoletano, collezionista, studioso di scienze naturali con particolari interessi per la geologia, creatore di un immenso, misterioso e sfortunato erbario. A fine Settecento, l'ancor più sventurato botanico napoletano Domenico Cirillo gli dedicherà il genere Imperata. 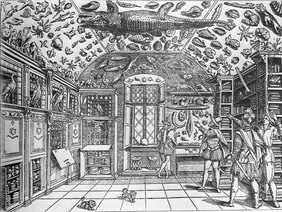 Un grande museo napoletano Nel Cinquecento, con la rinascita degli studi naturalistici, inizia anche il collezionismo dei naturalia, oggetti più o meno rari e curiosi tratti dai tre mondi della natura (minerali, animali, piante). Le prime collezioni private, note come "Teatri della natura", furono create da scienziati, medici e farmacisti. Nate a scopo di studio, furono comunque segnate dal gusto del meraviglioso, dell'esotico e dello stravagante. Quale aspetto potessero avere lo vediamo dall'illustrazione che apre l'Historia naturale di Ferrante Imperato, creatore di un celebrato museo presso la sua abitazione napoletana (che si trovava in piazza santa Chiara, nei pressi di palazzo Gravina, e non nello stesso palazzo, come si dice in molti siti). L'immagine ci mostra tre pareti della sua "camera delle meraviglie"; su quella di sinistra, e in parte su quella di fondo, illuminata da una grande finestra, una elegante scaffalatura in legno custodisce scatole, sacchetti e boccette; sulla parete di fronte, una libreria con imponenti volumi in folio; nella parte alta delle scaffalature, uccelli impagliati; la parete di fondo e il soffitto sono letteralmente tappezzati di animali, soprattutto marini, tra tutti spicca un coccodrillo. In primo piano, sulla destra un giovane (probabilmente Francesco, figlio di Ferrante Imperato) mostra la collezione a due visitatori, elegantemente vestiti alla spagnola. Sul fondo, un po' in disparte, un quarto personaggio, che potrebbe essere un terzo visitatore o lo stesso Ferrante Imperato (è vestito con la stessa pomposa eleganza dei "turisti", ma non porta la spada, privilegio dei nobili). Insieme a quelli allestiti da Ulisse Aldrovandi a Bologna e da Francesco Calzolari a Verona, il museo napoletano di Imperato era noto in tutta Europa ed era meta di numerosi visitatori. Secondo le testimonianze dell'epoca, comprendeva dodicimila reperti tratti dai tre regni della natura (minerali, fossili, pietre preziose e gemme, terre, coloranti, conchiglie, animali imbalsamati, pesci e animali marini essiccati, oli, inchiostri, profumi, balsami e resine, erbe secche e semi) e alcuni artificialia, oggetti curiosi creati dall'uomo, che Imperato parte aveva raccolto personalmente nei suoi viaggi nel sud d'Italia, parte aveva acquistato alla fiera di Francoforte - che a quanto pare frequentò assiduamente -, parte aveva ottenuto come dono o in scambio da altri membri della grande rete che raccoglieva i naturalisti europei. Fondato probabilmente intorno al 1566 - come si deduce dal contratto con gli stipettai che realizzarono i mobili - nacque dapprima dalla stessa professione di farmacista. Lo speziale-farmacista, un professionista che non aveva formazione universitaria ma un vasto sapere pratico, acquisito dopo un lungo apprendistato regolato dagli statuti della propria corporazione, preparava le medicine prescritte dai medici, partendo dai semplici: non solo erbe, spezie e altri prodotti di origine vegetale come resine e balsami, ma anche minerali e persino alcuni animali (la carne di serpente era un ingrediente indispensabile della celebre teriaca). La sua bottega includeva perciò un vero e proprio laboratorio, con mortai, alambicchi e altre attrezzature per pestare, impastare, distillare i preparati "galenici". Non si vendevano solo droghe medicamentose, erbe medicinali e preparati farmaceutici, ma anche quei prodotti che in futuro spetteranno al droghiere: spezie alimentari; candele, cera, miele, zuccheri e conserve; carta, inchiostro e colori per la pittura; insetticidi e veleni per i topi; profumi, acque distillate e belletti... Non stupisce dunque che due farmacisti di successo come Imperato e Calzolari abbiano trasformato le loro botteghe in veri e propri musei. Le due istituzioni erano piuttosto simili: entrambe si trovavano al primo piano, sopra il negozio, comprendevano una galleria di ritratti di scienziati illustri e la vera e propria camera delle meraviglie; quello di Imperato comprendeva anche un terrazzo con un piccolo giardino botanico pensile. Sia Calzolari sia Imperato erano inseriti nel circuito dei naturalisti europei e italiani, da cui ricevettero molti materiali per le loro collezioni, e godevano di un notevole prestigio personale. Ma mentre il veronese si accontentò di essere un farmacista, Imperato nutriva maggiori ambizioni; la sua bottega era un vero e proprio laboratorio, in cui lui stesso e altri studiosi potevano condurre ricerche e esperimenti. Celebre la sua collaborazione con Bartolomeo Maranta, il cui frutto fu Della theriaca et del mithridato libri due, firmato dal solo Maranta ma nato dal sodalizio scientifico tra i due. Come naturalista, l'interesse principale di Imperato andava ai minerali e alla geologia: osservatore attento del territorio campano, studiò gli affioramenti geologici, descrisse con esattezza le serie stratigrafiche osservate nelle cave di pozzolana, comprese e spiegò correttamente la natura dei fossili, il ruolo delle acque nel modellamento nel terreno, l'origine della salinità marina. Espose le sue ricerche in un vasto trattato, Dell'Historia naturale, pubblicato nel 1599 a cura del figlio Francesco, in cui studiò terre, acque, aria, minerali, metalli, erbe e animali soprattutto dal punto di vista della loro utilità per l'uomo. Alle citazioni degli autori del passato vi affianca i risultati delle sue osservazioni, spesso in dissenso con le idee ricevute e ricche di intuizioni corrette. 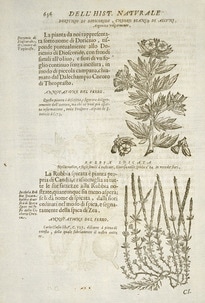 Un erbario leggendario e sfortunato A fare la parte del leone nel trattato sono le terre, i minerali, i metalli. A animali e piante, forse per non entrare in competizione con ammirati studiosi come Mattioli, Imperato dedicò solo gli ultimi due libri; vi compiono una manciata di piante per lo più officinali, nuove, di identificazione discussa o poco note. Ad esempio, vi troviamo una delle prime segnalazioni della melanzana rossa (Solanum aethiopicum). Eppure la botanica rientrava tra gli interessi principali del poliedrico studioso e il suo erbario costituiva uno dei punti di forza del Museo. Ci sono giunte informazioni contrastanti sulla sua consistenza: le piante, sistemate su fogli di carta di formato in folio con un particolare trattamento che conservava i colori naturali, erano raccolti in grandi volumi, dieci secondo alcune testimonianze, 80 secondo altre. Dopo la morte di Imperato (avvenuta dopo il 1615), il figlio Francesco ne custodì l'eredità, incrementando addirittura le raccolte. Le generazioni successive tralasciarono invece il museo: le collezioni furono abbandonate e disperse, probabilmente anche in seguito all'epidemia di peste che devastò Napoli nel 1656. Nel Settecento i 9 volumi superstiti del grande erbario pervennero a Sante Cirillo, medico, botanico, membro della Royal Society, che li trasmise al nipote, il grande botanico Domenico Cirillo. Costui partecipò attivamente alle vicende della Repubblica partenopea; dopo il crollo della repubblica e il rientro dei Borbone, fu arrestato, processato e condannato a morte. Il giorno stesso della sua esecuzione, il governo borbonico permise a una folla di fanatici sanfedisti di saccheggiarne la casa, distruggendo molti scritti e materiali scientifici di inestimabile valore, incluso l'erbario di Imperato. Fortunosamente, si salvò un solo volume, che pervenne a uno storico locale, Camillo Minieri Riccio, e nella prima metà dell'Ottocento fu venduto alla Biblioteca nazionale di Napoli, dove è oggi custodito. Il volume superstite, di 536 pagine, comprende 442 esemplari. Supponendo vera l'informazione secondo la quale l'erbario originariamente fosse composto da 80 volumi, e ipotizzando che ciascun volume fosse di dimensioni analoghe, si arriverebbe alla favolosa cifra di 35.000 esemplari secchi. Per capirne l'enormità basti pensare che il coevo erbario di Cesalpino (del 1563) contiene 768 esemplari e quello di Caspar Bauhin (il più grande dell'epoca) ne raccoglieva circa 4000. Anche se la cifra fosse fantasiosa, e fosse da accettare l'ipotesi più prudente di 10 volumi, l'erbario rimarrebbe comunque il più imponente del suo tempo. Testimonianze dell'epoca ci dicono che era ricco di piante esotiche, ottenute da altri studiosi o acquistate a grande prezzo; Imperato avrebbe addirittura finanziato un viaggio in India per procurarsene alcune. Per maggiori informazioni sulla vita di Imperato, si rimanda alla biografia.  Imperata, una bella invasiva Parti dell'erbario di Cirillo sfuggirono alla devastazione sanfedista e passarono al botanico Vincenzo Petagna (1730–1810). Mescolati ad essi, si trovano circa 170 esemplari di provenienza sconosciuta, che in base a recenti analisi potrebbero aver fatto parte dell'erbario di Imperato. Alcuni di essi sono storicamente importanti, perché costituiscono i tipi su cui si basò Cirillo per stabilire denominazioni binomiali, alcune delle quali ancora accettate. Fu proprio su uno di questi esemplari (da lui denominato Imperata arundinacea, oggi I. cylindrica) che Cirillo stabilì il genere Imperata, dedicato all'illustre predecessore, pubblicato nel secondo volume di Plantarum rariorum regni neapolitani (1788-1792). Imperata è un piccolo, ma diffuso genere di erbe tropicali e subtropicali (famiglia Poaceae). Sono erbe perenni rizomatose, con steli solidi, eretti e infiorescenze setose, cui si deve il nome comune inglese satintail "coda di raso". Oggi le si attribuiscono undici specie, diffuse nelle Americhe, in Asia,in Africa, in Micronesia e in Papuasia, dopo il distacco di altre specie, assegnate a generi affini (Miscanthus, Saccharum, Lagurus, Cinna). La specie più nota, I. cylindrica, è ubiquitaria: originaria dell'Asia, del Sud Africa e delle isole del Pacifico, è stato introdotta nell'Europa meridionale e in America, dove spesso si è naturalizzata, diventando a volte invasiva. Nei paesi originari è invece una specie di estrema utilità: è estesamente utilizzata per consolidare aree litoranee sabbiose e altri terreni franosi; gli steli secchi sono utilizzati per ricoprire i tetti, intrecciare tappeti e borse, fare la carta. Alcune cultivar sono coltivate per il valore ornamentale; la più diffusa nei giardini è la giapponese I. cylindrica 'Red Baron', con foglie rosse. Qualche informazione in più nella scheda. Imperato è anche ricordato da una specie di zafferano, Crocus imperati, endemismo presente esclusivamente nell'Italia centrale e meridionale. Il 19 ottobre 1593 giunge a Leida un viaggiatore partito da Francoforte. E' lì per creare l'orto botanico di quella recentissima Università (fondata appena 18 anni prima). Con lui viaggiano molte piante rare, tra cui una collezione di preziosi bulbi. Quel viaggiatore è Carolus Clusius, uno dei botanici più importanti del Rinascimento. E da quei bulbi nascerà, letteralmente, l'industria olandese dei tulipani.  Clusius chierico vagante della botanica Già anziano, almeno secondo gli standard dell'epoca, quando si trasferì in Olanda Clusius aveva alle spalle una vita alquanto movimentata. Fiammingo francofono, in gioventù aveva abbracciato il protestantesimo e, dopo aver abbandonato gli studi giuridici su consiglio di Melantone, era andato a studiare medicina prima a Montpellier, poi a Parigi. A segnarlo furono soprattutto i tre anni (1551-1554) trascorsi a Montpellier, dove divenne segretario di Rondelet, che aiutò nella redazione dell'Histoire naturelle des poissons. Clusius partecipò a entusiasmanti esplorazioni botaniche in Linguadoca e in Provenza, apprese le tecniche per tenere un erbario, affinò le sue capacità di osservare, distinguere e descrivere le particolarità di ciascuna specie. Non conseguì la laurea e non divenne medico: fu un naturalista, che studiava piante (e animali) non per le loro proprietà medicinali, ma di per se stesse. Nel decennio successivo visse prevalentemente nelle Fiandre; grazie all'esperienza editoriale acquisita come collaboratore di Rondelet e alla grande predisposizione per le lingue - giunse a padroneggiarne otto o nove - incominciò a collaborare con lo stampatore Christophe Plantin; il suo primo lavoro fu una traduzione dell'erbario (Cruydeboeck) di Rembert Dodoens dal fiammingo in francese (Histoire des plantes, 1557). Nel 1564-1565, come precettore di Jacobus Fugger, figlio del celebre finanziere Anton, visitò la Spagna e il Portogallo, ne esplorò la flora e strinse duraturi contatti con eminenti studiosi iberici. Visitando Lisbona e Siviglia, le porte d'ingresso delle piante provenienti dalle colonie, Clusius incontrò l'oggetto privilegiato dei suoi studi: la flora esotica. Frutto di quel viaggio furono tre traduzioni dei lavori di Garcia de Orta, Nicolas Monardes e Cristobal de Acosta sulle piante medicinali e aromatiche americane e asiatiche; e la sua prima opera originale, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum ("Su alcune piante rare osservate in Spagna", 1476), in cui descrisse circa 200 nuove specie, sia iberiche sia esotiche. L'opera, oltre che per essere la prima dedicata alla flora spagnola, si segnala per la precisione e la completezza delle descrizioni (che guadagnarono all'autore l'appellativo di "principe dei descrittori") e l'accuratezza delle illustrazioni xilografiche.  Tulipani, amore a prima vista In appendice a quell'opera compare anche la descrizione di una pianta che non ha nulla a che fare con la flora iberica: un tulipano. L'incontro fatale avvenne a Malines (o Mechelen), la città fiamminga dove Clusius visse più o meno stabilmente tra il 1567 e il 1573. Nel 1562 un mercante di Anversa, di cui non ci è stato tramandato il nome, insieme a un carico di tessuti ricevette da un fornitore turco un dono inatteso; un pacco di bulbi. Pensando fossero un tipo di cipolle, ne mangiò una parte, e piantò il resto nell'orto (o, secondo una versione più romantica, li buttò nella compostiera). La primavera successiva produssero insoliti fiori gialli e rossi; il mercante li mostrò a Joris Rye, un mercante di Malines, che possedeva un giardino pieno di piante rare e corrispondeva con molti botanici. Neppure Rye li conosceva, ma, con il permesso dell'amico, trapiantò i bulbi nel suo giardino e ne scrisse ai suoi corrispondenti, tra cui anche il nostro Clusius. Il quale, a meno che ne avesse già visti in Spagna - cosa non documentata, ma non impossibile - deve aver visto in fioritura quella che sarebbe diventata la "sua" pianta nella primavera del 1567, nel giardino di Rye a Malines. Fu amore a prima vista: incominciò a ricercarne i bulbi e i semi, a coltivarli, a moltiplicarli, a studiarli. Nel maggio 1573, una nuova svolta: la fama che Clusius si era acquistato con le sue pubblicazioni e con la torrenziale corrispondenza con i botanici e i botanofili di mezza Europa (nel corso della sua vita, creò un'immensa rete di corrispondenti, circa 300 persone, cui si calcola abbia scritto non meno di 4000 lettere; ce ne sono rimaste circa 1300) convinse l'imperatore Massimiliano II a chiamarlo a Vienna per creare un orto botanico sul modello di quelli italiani. Dopo una vita di gavetta, in cui a malincuore aveva dovuto barcamenarsi tra lavori editoriali, impieghi occasionali e il soccorso degli amici, era anche una promozione sociale, con una posizione a corte e un generoso compenso di 500 fiorini all'anno. All'epoca Vienna era il crocevia tra l'Europa e l'Impero ottomano, un nemico minaccioso ma anche un partner commerciale con il quale la corte imperiale intratteneva costanti rapporti diplomatici; i turchi erano celebri per i loro giardini (e i tulipani erano i fiori che apprezzavano più di ogni altro). Uno dei principali fornitori di Clusius divenne l'ambasciatore imperiale a Istanbul, da cui ricevette regolari invii di piante e di bulbi. Inoltre il botanico si legò di amicizia con Ogier Ghislain de Busbecq, il quale, prima di lasciare Vienna, gli donò la sua collezione di piante rare, tra cui una grande quantità di semi e bulbi di tulipano.  Da Vienna a Leida Ma le vicissitudini del nostro botanico viaggiatore non erano finite. Nel 1576 l'imperatore Massimiliano II morì all'improvviso; il suo successore, il fervente cattolico Rodolfo II, fece trasformare il giardino di Clusius in un maneggio, trasferì la corte a Praga e incominciò ad allontanare i protestanti da ogni incarico. Nonostante ciò, Clusius si trattenne a Vienna per un decennio, realizzando molte spedizioni botaniche nella Bassa Austria, nelle Alpi austriache, nel Burgerland e in Pannonia, grazie al sostegno del principe ungherese Boldizsàr Batthyàni. Il frutto di queste spedizioni furono due libri: Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam provincias observatarum historia (1583) e Stirpium Nomenclator Pannonicum (1584), di nuovo opere pionieristiche che descrivevano per la prima volta la flora austriaca e ungherese. Nel 1588, preoccupato per il clima di ostilità contro i protestanti e amareggiato dai ripetuti furti di piante rare dal suo giardino privato (commissionati da nobili personaggi, contro i quali Clusius era del tutto impotente), si trasferì a Francoforte, dove poteva godere della protezione di un nuovo mecenate, Guglielmo IV di Assia. Naturalmente, portò con sé le amate piante, e gli amatissimi bulbi. I quali, ovviamente, viaggiarono con lui fino a Leida, quando nel 1593, a sessantasei anni, Clusius si trasferì ancora una volta, pronto a iniziare una nuova vita. Nel giro di pochi anni, anche grazie alla collaborazione di Dirk Cluyt, giardiniere e farmacista, la competenza di Clusius e la sua estesa rete di corrispondenti permisero di creare un giardino piccolo (un rettangolo di 35 per 40 metri), ma ricco di più di 1000 specie; non era solo un orto dei semplici, ma anche un giardino di acclimatazione delle piante esotiche. Dopo la penisola iberica, le Fiandre e la corte viennese, ancora una volta Clusius si trovava nel posto giusto per alimentare la sua passione di studioso, collezionista e coltivatore di queste piante: oltre alle centinaia di corrispondenti sparsi per l'Europa, a fornire nuovi esemplari per le aiuole dell'Hortus erano ora anche i capitani delle navi della VOC (la Compagnia Olandese delle Indie Orientali). E ogni primavera, le magnifiche fioriture di tulipani (Clusius giunse a coltivarne, descriverne e catalogarne 34 varietà) attiravano folle di visitatori; molti gli chiedevano bulbi dei più belli, dei più strani (quelli con screziature o fiamme). Ma per il vecchio botanico erano oggetti di studio e, per cavarsi d'impiccio, chiedeva in cambio somme astronomiche; non si trattava di avarizia: si era sempre dimostrato generoso delle sue piante con corrispondenti e amici (secondo alcuni calcoli, avrebbe inviato loro non meno di un migliaio di bulbi di tulipani, contribuendo più di ogni altro a diffonderli in Europa). Con le sue ricerche, cercava tra l'altro la soluzione a un mistero: perché un bulbo che un anno aveva petali monocromi, l'anno successivo presentava fiamme o rotture in un altro colore? Egli fu il primo a capire che dietro a quelle "rotture" che tanto appassionavano i collezionisti c'era qualcosa che non andava; notò che i bulbi delle piante affette dal "mal della striscia" erano più piccoli e decisamente più deboli di quelli sani. Solo intorno al 1930 si sarebbe dimostrato che si tratta effettivamente di una malattia, provocata dal cosiddetto virus del mosaico del tulipano. Esattamente come era successo a Vienna, per aggirare la riluttanza di Clusius a separarsi dai suoi bulbi, gli appassionati si rivolsero ai ladri. Due volte nell'estate del 1596 e di nuovo nella primavera del 1598, essi penetrarono nel suo giardino privato e portarono via ingenti quantità di bulbi (almeno cento nel corso di una sola incursione). Amareggiato, Clusius decise di rinunciare a coltivarli e di distribuire quanto rimaneva tra i suoi amici. Inoltre si facevano sentire l'età e le numerose infermità, che negli ultimi anni della sua vita lo costrinsero a una quasi totale immobilità. Rimaneva vivace e attiva la sua mente, che gli permise di aggiungere due capolavori alla sua opera: Rariorum plantarum historia (1601) e Exoticorum libri decem (1605), ancora una volta dedicate alle piante esotiche e rare che aveva ricercato, coltivato e studiato per tutta la vita, di cui si troverà una sintesi nella sezione biografie. Intanto, per serendipity, i furti ebbero un risultato positivo: i preziosi bulbi sottratti a Clusius si diffusero in tutto il paese e, incrociandosi con varietà meno pregiate, divennero i progenitori delle varietà e degli ibridi che hanno fatto dell'Olanda il paese dei tulipani.  Clusia, un abbraccio soffocante Diverse piante rendono omaggio a questo grandissimo botanico. In primo luogo, com'è giusto, Tulipa clusiana, una bella specie di tulipano che egli per primo descrisse e contribuì a diffondere. Ma anche Primula clusiana e Gentiana clusii che ci ricordano che Clusius fu un pioniere dell'esplorazione botanica delle Alpi e fu tra i primi a coltivare piante alpine nel giardino di Vienna. E naturalmente, il genere Clusia, che gli fu inizialmente dedicato da Charles Plumier, per essere poi confermato da Linneo. Questo genere, che dà il nome alla famiglia Clusiaceae (nota anche come Guttifereae) sarebbe sicuramente piaciuto al destinatario per la sua singolarità. In primo luogo è caratterizzato da una grande varietà di forme e di habitat: neotropicale, ovvero presente solamente nella fascia calda dell'America centrale e meridionale, comprende alberi, arbusti e liane, che possono vivere in pianura come in montagna, nelle aree costiere sabbiose o rocciose, nelle savane, nelle foreste a galleria. Alcune sono semiepifite: iniziano la loro vita come epifite, germogliando su alberi o su altre epifite a molti metri dal suolo, quindi sviluppano lunghe radici che giungono fino a terra; a questo punto si trasformano in grandi arbusti che possono anche strangolare e uccidere l'albero ospite. Alcune Clusiae sono tra i pochi alberi ad aver sviluppato una fotosintesi CAM (metabolismo acido delle crassulacee), di solito presente in specie succulente erbacee: tipiche di zone molto aride, di giorno chiudono gli stomi delle foglie per evitare un'eccessiva traspirazione; di notte, li aprono per permettere la fissazione del carbonio. Sebbene si tratti in genere di specie di grandi dimensioni, alcune Clusiae sono coltivate anche nelle nostre case come piante d'appartamento. La più comune è C. major (più nota come C. rosea), che in vaso si presenta come un attraente alberello con foglie ovoidali lucide e coriacee e i vistosi fiori semidoppi che possono ricordare quelli delle camelie. Altre informazioni sulle straordinarie caratteristiche ecologiche di questo genere nella scheda.  C'e anche Clusiella Nel 1860 Planchon e Triana pubblicano un'epifita da poco scoperta nelle foreste d'altura di Grenada; le foglie e l'aspetto generale assomigliano al mirto o a certe Apocynaceae, ma diverse caratteristiche dei fiori femminili (né i fiori maschili né i frutti erano noti) spingono i due botanici a collocarla tra le Clusiaceae, e a denominarla Clusiella elegans: assomiglia infatti a una Clusia in miniatura. Nacque così un secondo genere dedicato a Clusio. Per circa un secolo C. elegans rimase l'unica specie del genere, finché intorno al 1950 vi furono incluse una specie prima assegnata a Astrotheca, quindi a Clusia, e cinque nuove specie. Al momento Clusiella è un genere di 8 specie, e non appartiene più alle Clusiaceae, ma alle Calophyllaceae (precedentemente tribù Calophylleae delle Clusiaceae). Sono perenni semi epifite che vivono nelle foreste tropicali di montagna dell'America centrale e del Sud America settentrionale, dal Costa Rica al Brasile settentrionale. Poiché vivono sulla sommità degli alberi, sono difficili da raccogliere e da studiare. Sono arbusti rampicanti o ricadenti, dioci, che secernono un lattice di colore chiaro. Specie nella pagina inferiore, le foglie presentano pori resiniferi e anche i fiori, con cinque piccoli sepali imbricati e cinque petali convessi di dimensioni maggiori, producono resine. C. elegans è abbastanza diffusa nella Cordigliera occidentale della Columbia; con tralci lunghi fino a due metri, si arrampica sulle chiome di alberi o si mescola ad altri arbusti, talvolta con portamento ricadente. Ha delicati fiori bianchi, talvolta delicatamente soffusi di rosa. Qualche approfondimento nella scheda. Il nome di Aldrovandi è di quelli che tutti hanno sentito nominare, ma pochi conoscono in modo diretto. L'immensa opera di colui che per quarant'anni a Bologna tenne la prima cattedra di storia naturale, più che nelle pochissime opere a stampa, in cui l'erudizione e le notizie più diverse soffocano i pochi risultati scientifici originali, trovò espressione essenzialmente nel "Teatro della natura", il più antico museo di storia naturale. Ma se la sua Syntaxis plantarum fosse stata pubblicata, forse la storia della botanica sarebbe in parte diversa. A ricordarlo una carnivora acquatica, diffusa in tutto il mondo, ma a rischio di estinzione.  Il grande "Teatro" di un naturalista enciclopedico Bologna, 1549. Un gruppo di cittadini bolognesi incappa in un'accusa di eresia; tra di loro il nobile e colto Ulisse Aldrovandi, che si affretta ad abiurare. Ciò nonostante, è inviato a Roma dove è costretto a trattenersi in attesa del processo. Per passare il tempo, incomincia a interessarsi di archeologia ma soprattutto fa amicizia con un medico francese, Guillaume Rondelet, che si trova a Roma al seguito del cardinale di Tournon. Rondolet, padre fondatore dell'ittiologia, trascina il nuovo amico nelle sue scorribande nel mercato ittico; travolto dal suo entusiasmo, Aldrovandi (che fino ad allora aveva studiato diritto, matematica, logica, filosofia, ma anche medicina) incomincia ad appassionarsi di scienze naturali. Liberato da ogni sospetto d'eresia, quando finalmente rientra a Bologna, decide di completare gli studi medici e di approfondire la zoologia, la mineralogia, la botanica. Una decisione che sarà rafforzata l'anno successivo da un secondo incontro: quello con il grande Luca Ghini che nell'estate del 1551 trascorreva le vacanze a Bologna. Nasce così la vocazione di scienziato universale di Ulisse Aldrovandi, uno dei più illustri studiosi della natura del Cinquecento italiano. Presso l'ateneo bolognese fu lettore di logica dal 1554, insegnante di botanica medica dal 1556, e dal 1561, per quasi quarant'anni (fino al 1600) titolare della prima cattedra di scienze naturali (lectura philosophiae naturalis ordinaria de fossilibus, plantis et animalibus). Si noti che, diversamente da quanto avveniva in quegli anni negli altri atenei, non era una cattedra di "materia medica", cioè di botanica applicata alla medicina, ma proprio l'insegnamento a tutto tondo delle scienze naturali. Un'altra novità si aggiunse almeno dal 1567, quando Aldrovandi prese a far seguire le lezioni accademiche da esercitazioni pratiche, basate sull'osservazione diretta di esemplari naturalistici ("mostrando realmente le cose, doppo il legger che haveva trattato nella lettione"). Nacque così il più antico museo di storia naturale: nel corso di un cinquantennio, Aldrovandi raccolse nella sua stessa casa un'imponente collezione di naturalia; proprio per il focus sul mondo naturale e gli intenti didattici, era ben diversa dai gabinetti principeschi e delle Wunderkammer che nascevano proprio in quegli anni. Con orgoglio, Aldrovandi ci informa che nel 1595 la sua collezione comprendeva 18.000 esemplari, tra cui 7000 piante essiccate "agglutinate" (cioè incollate) in quindici volumi, animali, minerali, pietre, 66 cassettiere con 4500 cassetti contenenti semi, frutti, gomme, fossili, oggetti esotici. Nella coscienza dell'importanza didattica dell'immagine, ma anche per colmare i "buchi" della collezione (un microcosmo che mirava a riprodurre, nel modo più completo possibile, il macrocosmo), Aldrovandi volle aggiungere 3000 splendidi acquarelli, raccolti in 17 volumi, e 5000 matrici xilografiche conservate in 14 armadi. Le matrici, realizzate con estrema accuratezza da artisti dotati, avrebbero dovuto andare a illustrare un'immensa Historia naturalis, che lo studioso bolognese continuò a scrivere per tutta la vita ma che, come vedremo meglio, pubblicò in ben piccola parte. Tutto questo, insieme ai volumi della ricca biblioteca e i suoi stessi manoscritti, andava a formare un mirabile "Teatro della natura" che divenne ben presto, oltre che uno strumento didattico, un'attrazione che richiamavano visitatori da tutta Europa: nel corso della vita dello scienziato, come risulta dal registro dei visitatori, furono più di 1500, sempre accolti con disponibilità e calore, secondo la testimonianza dell'olandese Hugo Blotius, bibliotecario imperiale, che la visitò ammirato nel 1572. Frutto di cinquant'anni di fatiche e di grandi spese (in una lettera al fratello, il naturalista dichiara di avervi investito tutto il proprio patrimonio), il "Teatro della natura" venne realizzato in primo luogo con una mirata attività di raccolta diretta. Fin dagli anni degli studi, Aldrovandi organizzò numerose spedizioni naturalistiche; le più celebri sono l'escursione dell'estate 1554, che, insieme a Calzolari e Anguillara, lo portò sulle pendici del monte Baldo, ancora oggi noto come "giardino d'Europa" per la grande varietà di vegetazione; e la grande spedizione del 1557, quando insieme ai suoi allievi percorse un ampio giro che, a partire dalle valli ravennati, lo portò fino ai monti Sibillini, quindi sulla via del ritorno lungo l'appennino marchigiano e romagnolo. Secondo Anna Pavord, questo viaggio segnò una tappa nella storia della botanica, perché fu la prima escursione naturalistica appositamente organizzata allo scopo di esplorare sistematicamente la flora di un'area specifica. Altri esemplari furono donati da sponsor e corrispondenti, in particolare i membri di quella stupefacente rete di studiosi che nel Rinascimento collegava tra loro i naturalisti europei e, nonostante le guerre e le infinite difficoltà di viaggi che avvenivano ancora a cavallo, in carrozza, ma spessissimo a piedi, produceva un incessante scambio di libri, semi, piante essiccate, minerali e... idee. Diverse piante esotiche erano coltivate nell'Orto botanico della stessa università di Bologna, che venne creato dal senato bolognese nel 1568 (quarto dopo Pisa, Padova e Firenze) su istanza di Aldrovandi che ne fu il curatore fino alla morte. Altre notizie sulla vita del grande studioso nella sezione biografie.  L'eredità botanica di Aldrovandi In questo blog abbiamo incontrato già molti esempi di opere importanti e innovative che, mai pubblicate, rimasero manoscritte a coprirsi di polvere negli scaffali di una biblioteca. La sorte delle opere di Aldrovandi fu, forse, ancora peggiore. Nella sua vita scrisse moltissimo; le sue opere manoscritte ammontano a più di 300, per un totale di oltre 160 volumi. Solo 14 furono pubblicate. Genio universale e enciclopedico, Aldrovandi scrisse di molti argomenti, anche non attinenti alle scienze naturali (la sua prima opera a stampa, dedicata alla statuaria romana, è uno dei primi esempi della rinascita dell'interesse per l'archeologia); molte opere sono compilazioni antiquarie, che lasciano largo spazio alle favole e al gusto del meraviglioso; moltissimi sono cataloghi di vario tipo. Si tratta per lo più di lavori preparatori alla progettata Storia naturale, che avrebbe dovuto toccare tutti gli aspetti della natura. Come possiamo evincere dalle tre parti direttamente pubblicate dall'autore o dalla sua vedova (i volumi sugli uccelli, gli insetti e gli altri animali "senza sangue"), similmente alla quasi contemporanea Historia animalium di Gessner (che fu tra i corrispondenti del bolognese), essa si collocava a cavallo tra passato e futuro; da una parte c'è l'enciclopedismo, il tributo alla cultura antica, il gusto antiquario, che li infarciscono di citazioni e informazioni tratte in modo apparentemente acritico dagli autori del passato; dall'altra la ricerca diretta sulla natura che si traduce in preziose osservazioni sull'anatomia e la fisiologia di ciascun animale. Fu questa commistione di naturalismo e gusto antiquario che fece giudicare severamente Aldrovandi da Buffon, secondo il quale, sfrondandola di tutte le informazioni inutili e estranee, la sua opera si sarebbe potuta utilmente ridurre a un decimo. In effetti vi si riconosce una concezione della conoscenza diversa da quella del Settecento illuminista o dei nostri giorni: l'opera di un Aldrovandi o di un Gessner è espressione dell'ideale rinascimentale della copia, parola latina che indica l'abbondanza, la ricchezza, espressa iconograficamente dall'immagine della cornucopia. L'obiettivo dello studioso rinascimentale è quello di presentare, nel modo più esaustivo possibile, ogni possibile informazione sul proprio soggetto, quindi tutto ciò che è stato scritto, tutto ciò che si crede comunemente, oltre a tutto ciò che si è osservato con i propri occhi. Ecco perché ai dati naturalistici direttamente osservati e osservabili si affiancano in modo così massiccio informazioni culturali di ogni genere, comprese le favole e il meraviglioso. Già segnata da questa concezione, che sarebbe stata ben presto superata da Galileo e dalla sua scuola, la fama futura di Aldrovandi fu ancor più danneggiata dalla pubblicazione postuma di alcune opere in forma largamente alterata. E' il caso dell'unico lavoro edito dedicato al mondo vegetale, Dendrologia, pubblicato nel 1667 da Ovidio Montalbani, uno scrittore particolarmente incline al fantastico. E' a un'opera come questa (e alla celebre Monstruorum historia, pubblicata nel 1642) se allo scienziato bolognese è toccato di passare alla storia, oltre che come un pedante collezionista di citazioni antiquarie, come un credulone acriticamente convinto della reale esistenza di draghi, basilischi, sciapodi, cinocefali e sirene. Inedita rimase invece la maggiore opera botanica di Aldrovandi (che, consapevole del suo valore, ne raccomandò inutilmente la pubblicazione nel testamento), la Syntaxis plantarum. E' un manoscritto in due volumi, per un totale di più di 1000 carte, collocabile tra il 1561 e il 1600, che consiste in una raccolta di 1700 tavole sinottiche, in cui le piante vengono descritte, catalogate e confrontate tra loro in tabelle collegate a disegni. Ciascuna tavola è strutturata in base a un criterio di classificazione o "chiave" in ordine gerarchico, stabilendo classi, generi e specie, allo scopo di individuare categorie comuni alle "diciotto mila specie diverse" osservate da Aldrovandi. Molte tavole sono dedicate agli organi principali delle piante, per esempio i frutti, i semi, le radici, il fusto; quelle più complesse riguardano i fiori, con chiavi come il numero, il colore, le differenze esterne degli stami e delle antere. Altre si basano su caratteristiche fisiologiche, come il tempo della fioritura, sulla base del quale viene anche compilato un calendario mensile; le tavole in cui le piante vengono divise in base alla stazione in cui vivono e alla distribuzione geografica fanno di Aldrovandi un antesignano della fitogeografia. Come Cesalpino, un altro discepolo di Ghini, Aldrovandi giunge così a proporre un proprio sistema di classificazione. Egli divide le piante in "perfette" e "imperfette" e individua 17 gruppi, a partire dagli alberi per giungere agli "imperfecti" (piante senza semi, cioè in gran parte funghi), usando sei chiavi principali: natali loco, vivendo conditione, partium habitu, quantitate, discriminibus, naturae dotis, ovvero l'habitat, la forma biologica, l'aspetto delle parti, la quantità delle parti stesse, i caratteri distintivi, le doti di natura. Per singole categorie, egli porta esempi concrete di species. Alcuni studiosi lo ritengono l'antesignano anche del sistema binomiale: in effetti, nel suo erbario e nelle tavole acquarellate molte piante sono contrassegnate da un nome basato su genere e specie; del resto, Gaspard Bauhin, che per primo doveva divulgare questa innovazione, era stato uno dei suoi allievi. Infatti, anche se non furono mai pubblicate, le tavole sinottiche di Aldrovandi nacquero come strumento didattico utilizzato nelle sue seguitissime lezioni; per questa via hanno influenzato il successivo progresso della botanica grazie ai numerosi allievi che furono educati a quel metodo. Accanto a questo lascito immateriale, alla sua morte Aldrovadi lasciò quello concretissimo del suo Teatro; legò infatti per testamento il suo intero patrimonio scientifico, ovvero i manoscritti, la biblioteca e il museo, al Senato bolognese, a condizione che fosse conservato integro; che gli inediti fossero pubblicati; che l'accesso fosse libero a tutti. Il grande museo divenne così di proprietà della città e dell'Università e per tutto il Settecento continuò ad esserne una delle principali attrazioni. Nell'Ottocento varie collezioni furono smembrate tra diversi istituti universitari, finché nel 1907 l'insieme fu almeno in parte ricostruito in una sala di Palazzo Poggi. Perduti molti reperti più deperibili, rimangono scheletri, animali impagliati, fossili, minerali. Il preziosissimo erbario (ne sono rimasti quasi 5000 fogli), uno dei più antichi che ci sia pervenuto, è invece costodito presso l'Orto botanico: benché le piante non siano disposte secondo un criterio riconoscibile e le note si limitino al solo nome, senza indicazione del raccoglitore e del luogo di raccolta, è ragguardevole per l'antichità (fu iniziato probabilmente nel 1551), la vastità, la cura del montaggio. Sono invece custodite presso la Biblioteca Universitaria le tavole acquarellate; quanto alle matrici xilografiche, poche ci sono giunte: molte di esse andarono a alimentare le stufe durante la Seconda guerra mondiale. Grazie a un grande progetto dell'Università di Bologna, l'intero erbario (consultabile qui), tutte le opere a stampa e gli acquarelli sono stati digitalizzati e sono raggiungibili attraverso questo bellissimo sito, davvero un mirabile "Teatro della natura" virtuale.  Androvanda, una pianta in pericolo Nel 1734, Gaetano Lorenzo Monti, botanico bolognese, presentò una memoria in cui, richiamandosi all'abitudine introdotta da Linneo di onorare gli studiosi più illustri con il nome di una pianta, deplorava che egli avesse dimenticato il grande Aldrovandi. Propose così di nominare Aldrovandia una pianta palustre (la pubblicazione avverrà solo qualche anno dopo in De Aldrovandia novo herbae palustris genere, 1747). Questa specie era già nota ed era stata descritta nel 1696 dal botanico inglese Plukenet, con il nome di Lenticula palustris. Linneo tenne conto dell'appunto di Monti e nel 1753 ne ufficializzò la denominazione, ribattezzando la pianta Aldrovanda vesiculosa (commise forse un piccolo errore ortografico). A. vesiculosa è l'unico rappresentante del suo genere (anche se altre specie forse sono esistite in passato); è un membro della famiglia Droseraceae, da cui differisce in quanto acquatica, ma come le cugine è carnivora; per diversi aspetti ricorda la più nota Dionaea, tanto che Darwin la definì "una Dionaea d'acqua in miniatura". E' un'erbacea priva di radici, che fluttua sulla superficie dell'acqua; le foglie, distribuite regolarmente lungo il fusto in piccoli verticilli a forma di ruota idraulica (da cui il nome inglese water wheel) e sorrette da piccioli con sacche d'aria che aiutano il galleggiamento, hanno lamina reniforme, che si chiude in due valve, dentellate sui bordi. Quando una preda si avvicina, si chiudono rapidamente, intrappolandola. La loro velocità di reazione (10-20 millisecondi) è considerata la maggiore del regno vegetale. La pianta vive in tutti i continenti, escluse le Americhe, ma è diventata sempre più rara a causa della restrizione dell'ambiente naturale e dell'inquinamento delle acque stagnanti ma pulite che predilige, ricche di anidride carbonica e povere di fosforo e di azoto. Se all'inizio del '900 era presente in 379 stazioni naturali note, nel corso del secolo queste si sono drammaticamente ridotte a sole 50, due terzi delle quali concentrate in un'area tra Polonia e Ucraina. In Italia un tempo doveva essere diffusa in un vasto areale; ne sono state recensite 17 stazioni, ma tutte si sono estinte nel corso dell'ultimo secolo: l'ultimo avvistamento, relativo al lago di Sibolla presso Lucca, risale al 1985. In vari paesi, sono in atto azioni per la tutela e la reintroduzione di questa rara specie; in Italia un progetto pilota ha preso avvio nelle regioni Piemonte e Lombardia; esemplari, provenienti dalla Svizzera, sono attualmente coltivati in due orti botanici: il Giardino botanico Rea di Trana, in provincia di Torino, e l'Orto botanico dell'Università di Pavia. Qualche approfondimento nella scheda. Perché un botanico olandese ha dedicato una specie sudafricana a un botanico tedesco che lavorava in Russia? Un mistero mai risolto; ma la storia di Traugott Gerber, attivo e sfortunato pioniere delle ricerche botaniche in Russia, vale la pena di essere raccontata. E con i suoi fiori solari, la Gerbera, regina dei fiori recisi, continua a perpetuarne il nome, tanto che un grande coltivatore e collezionista di gerbere ha voluto dedicargli un piccolo museo.  Un giardino dei semplici e tre spedizioni botaniche Il più antico orto botanico russo nacque nel 1706 per volontà dello zar Pietro il grande che, secondo la tradizione, sarebbe stato coinvolto di persona nell'impianto, mettendo a dimora tre alberi tra cui un Larix sibirica che ancora sopravvive. Sorgeva alla periferia settentrionale della città, presso la torre Suchareva, e fortunatamente, sebbene profondamente alterato, si è conservato fino ad oggi, come parte dell'Orto botanico dell'Università di Mosca. Come dice chiaramente il nome Moskovskij apotekarskij ogorod, "Orto moscovita dei farmacisti" , inizialmente apparteneva all'ordine dei farmacisti ed era destinato alla coltivazione dei semplici da utilizzare per la preparazione dei medicinali. Per alcuni anni, il giardino non ebbe una direzione scientifica, finché nel 1735, sotto la zarina Anna Ivanovna, venne assunto un giovane medico e botanico tedesco, Traugott Gerber, con l'incarico di dirigere e ampliare il giardino, trasformandolo in un'istituzione educativa. In quanto dimostratore dell'orto, Gerber doveva infatti illustrare le piante e le loro proprietà medicinali ai futuri medici e farmacisti. Egli ampliò notevolmente le collezioni, aggiungendo alla coltivazione dei semplici quella di piante locali e esotiche, sia nelle parcelle esterne sia nelle serre. Molti semi e piante gli giunsero attraverso contatti e scambi con botanici francesi, tedeschi e olandesi. Altre specie furono raccolte nelle spedizioni botaniche capeggiate dalle stesso Gerber, finalizzate alla ricerca di piante utili e medicinali. Il lavoro sul campo iniziò con l'esplorazione dei dintorni di Mosca; il frutto fu Flora Mosquensis, un manoscritto che descrive circa 200 piante. Nel 1739 guidò una spedizione lungo il bacino del Volga, seguendo l'itinerario Mosca–Murom–Nizny Novgorod– Kazan’–Samara– Saratov–Tsaritsyn (oggi Volgograd)– Voronez–Tambov–Ryazan’– Mosca; ne diede conto in Flora Wogensis, che include 225 specie. Infine nel 1741 organizzò una spedizione nel bacino del Don e in Ucraina, che fruttò 280 specie, descritte in Flora Tanaicensis (tutte queste opere non furono mai pubblicate e rimasero allo stadio di manoscritto). L'anno successivo, in seguito alla morte della zarina e alle complicate vicende della sua successione, il posto di curatore del giardino dei farmacisti fu soppresso (sarà ripristinato solo nel 1786). Gerber divenne medico militare e si trasferì a Vyborg nella Carelia russa, a nord di Pietroburgo, dove morì l'anno successivo all'età di soli 33 anni. Dopo la sua morte, il suo grande erbario (circa 2400 taxa) andò disperso. Una sintesi della sua vita breve ma intensa nella sezione biografie. Per iniziativa del vivaista, ibridatore e ricercatore tedesco Peter Ambrosius (che ha probabilmente creato la più vasta collezione di Gerberae del mondo), a Zodel, il villaggio della Slesia tedesca al confine con la Polonia dove Gerber nacque nel 1710, nel 2002 è stato fondato il Trautgott Gerber Museum, che raccoglie testimonianze sulla sua vita e sul suo tempo e comprende anche un piccolo giardino di erbe.  Perché la Gerbera? Per un curioso scherzo del destino, il nome di questo botanico nato in Slesia, vissuto nella fredda Russia e morto nella glaciale Carelia, è oggi legato a un fiore che arrivò in Europa dal Sud Africa, la solare Gerbera. A dedicargliela fu, nel 1737, il botanico olandese J.F. Gronovius; il perché è un rebus per gli studiosi. E' assai probabile che i due si scambiassero piante (dall'Olanda arrivarono a Gerber piante per l'orto moscovita, e Gronovius era un accanito collezionista con una enorme rete di corrispondenti); secondo il sito ZAfrica, la dedica avrebbe coinvolto anche un fratello di Gerber (di cui si conoscono solo le iniziali, Fr.), a sua volta raccoglitore di piante nelle Antille; anche questa notizia è plausibile: Gronovius aveva molti corrispondenti che operavano in centro e nord America; ma non ne ho trovato conferma in altre fonti. Le prime ad essere descritte (non da Gronovius, ma dal suo amico Burman, in Rariorum africanarum plantarum decades) furono due specie sudafricane (oggi note come Gerbera linnaei e G. crocea). Linneo riprese e validò il genere nel 1758, ma più tardi cambiò idea e lo unì al panboreale Arnica. Il genere Gerbera fu ripristinato soltanto nel 1817 da H. Cassini, in uno dei primi studi complessivi sulla famiglia Asteraceae. Benché le specie più note (e quelle da cui sono nati gli ibridi oggi in commercio) siano sudafricane, il genere Gerbera, che comprende una trentina di specie, è presente anche in altre aree: l'Africa subsahariana tropicale, il Madagascar, la regione sino-hymalaiana, mentre l'attribuzione dell'unica specie sudamericana è discussa. L'area sudafricana è tuttavia quella di maggiore biodiversità, con 14 specie. Quelle che troviamo dai fiorai e che alimentano il mercato dei fiori recisi (è la quinta specie più venduta) sono per lo più gerbere ibride; la prima fu ottenuta nel 1890 da R. I. Lynch del Giardino botanico di Cambridge incrociando G. jamesonii con G. viridifolia. Da allora sono state prodotte e selezionate centinaia e centinaia di cultivar, variabili per dimensioni, forma (singole, semidoppie, doppie), colore del disco centrale e dei "petali" radiali (in realtà, come nelle altre Asteraceae, entrambi sono flosculi) in infinite sfumature di bianco, crema, giallo, rosa, violetto, rosso, arancio. Praticamente l'intero arcobaleno, eccetto il blu. Approfondimenti sulle altre specie e sulla storia degli ibridi nella scheda. Per un ventennio, il medico tedesco Oeder è l'attivissimo factotum della botanica danese; è lui, tra l'altro, a ideare e a varare la magnifica Flora Danica, uno dei testi più imponenti e belli della storia della botanica. Ma il suo zelo riformatore gli costò molto caro. Grazie a Linneo, gli rimase se non altro la dedica della poco nota Oedera.  Un botanico molto impegnato Nel Settecento, con la nascita della dottrina fisiocratica, che lega all'agricoltura la prosperità della nazione, cresce l'interesse per lo sfruttamento economico delle piante. E' in questa atmosfera che nel 1752 J. H. E. Bernstorff, ministro degli esteri danesi, chiama un giovane medico e botanico bavarese, Georg Christian Oeder, a rivestire la neonata cattedra di "Economia sociale" all'Università di Copenhagen; la levata di scudi dell'ambiente accademico danese, ostile alla nomina di uno studioso straniero, fa fallire il progetto. Tuttavia, con l'appoggio del re Federico V e del primo ministro Moltke, Bernstorff rilancia: nasce l'Istituzione Botanica Reale, modellata sul Jardin des Plantes di Parigi, del tutto autonoma dall'università, finanziata dalla Corona, con lo scopo di istituire un giardino botanico e una biblioteca. Oeder diventa così curatore del Giardino botanico e lettore di botanica applicata, con il titolo di Professor botanices regius. Oltre alle lezioni, attivissimo, Oeder si impegna su tre fronti. Il primo luogo, l'allestimento del Giardino Botanico. Fin dal Seicento l'Università di Copenhagen si era dotata di un orto dei semplici ma l'istituzione, priva di fondi, aveva finito per declinare. Il nuovo giardino, fondato nel 1752, era situato a nord dell'Ospedale Frederik, diviso in due parti da Amaliegade: la parte occidentale, con una serra, fu aperta al pubblico nel 1763; la parte orientale non venne mai realizzata. In effetti, già nel 1778 il giardino fu trasferito nei pressi di Charlottenborg, dove si trova ancora oggi. Il secondo impegno fu la realizzazione di una biblioteca specializzata, con particolare attenzione alla botanica applicata. Grazie ai fondi messi a disposizione dal sovrano e ai contatti esteri, nel 1754 venne acquistata l'intera biblioteca del medico britannico Richard Mead, con oltre 1300 volumi; altri testi inglesi e americani furono procurati da Philip Miller, direttore del Chelsea Physic Garden. Il terzo progetto fu il più ambizioso. Nel 1753 Oeder propose di studiare e documentare la flora del regno di Danimarca-Norvegia e dei possedimenti della corona (Schleswing-Holstein, Oldenburg-Dalmenhorst, Islanda, isole Faroe e Groenlandia), pubblicando i risultati in una serie di volumi in folio con descrizione e usi di ciascuna specie, corredate da grandi tavole realizzate in calcografia. Lo scopo era duplice: individuare piante utili in medicina, orticultura, agricoltura e giardinaggio; diffondere la conoscenza della botanica e delle proprietà economicamente utili delle piante. Nasce così Flora Danica, un monumento della botanica e un capolavoro dell'illustrazione botanica, destinato a impegnare Oeder per quasi vent'anni e tre o quattro generazioni di botanici danesi per oltre un secolo: il primo volume uscirà infatti nel 1761, l'ultimo 123 anni dopo, nel 1883. Per raccogliere le piante, Oeder si impegna in diversi viaggi, in particolare tra il 1758 e il 1760 visita le montagne della Norvegia, dove rinnova la conoscenza con Gunnerus, vescovo di Trondheim, che sarà suo corrispondente negli anni successivi. A partire dal 1761, riesce a pubblicare un fascicolo all'anno (per un totale di 10 fascicoli, con 600 tavole). All'inizio degli anni '70, tuttavia, l'energico e abile botanico, come economista, si trovò coinvolto in una delle pagine più discusse della storia danese. Dal settembre 1770, per circa sedici mesi, in seguito alla grave malattia mentale del re Cristiano VII, il potere fu di fatto nelle mani del medico personale del re, il tedesco Johann Friedrich Struensee, convinto illuminista, che varò a ritmo febbrile una serie di riforme invise alla corte e alla nobiltà danese: tra le altre, l'emancipazione dei servi, l'abolizione della tortura, la cancellazione del carcere per debiti. Oeder, a sua volta un riformatore illuminista, convinto sostenitore della necessità di una riforma agraria e dell'emancipazione dei contadini, sui quali gravavano ancora vincoli feudali, diventò uno dei suoi più ascoltati consiglieri ed entrò a far parte di molte commissioni. Quando venne varato un catasto, base indispensabile per una tassazione più equa, fu Oeder a predisporre i dati delle parrocchie di varie aree del paese. Fece parte anche della commissione che doveva elaborare la riforma universitaria. Tuttavia nel gennaio 1772, una congiura di corte portò alla caduta di Struensee che venne arrestato, processato per alto tradimento - con l'accusa, fondata, di essere l'amante della regina - e condannato a morte. Seguì una reazione feroce, che portò alla cancellazione di tutte le riforme e al siluramento dei collaboratori di Struensee. Tra loro, anche Oeder che perse il posto di professore (quindi anche gli incarichi di curatore dell'orto botanico, della biblioteca e di Flora danica). Da quel momento, visse una vita oscura di piccolo funzionario a Oldenburg, località presto ceduta a un duca tedesco - di fatto un esilio mascherato; solo due anni prima della morte (avvenuta nel 1791) venne nobilitato da un altro convinto riformatore, l'imperatore Giuseppe II. Quale informazione in più nella biografia.  Dalla botanica alla mensa reale Ma torniamo a Flora Danica. Il progetto varato da Oeder si rivelò ambiziosissimo ed è improbabile che, anche se non fosse stato silurato, egli sarebbe riuscito a realizzarlo. Tanto che, in corso d'opera, l'impresa cambiò natura: poiché i testi che avrebbero dovuto accompagnare le tavole (le descrizioni delle piante e le indicazioni dei loro usi economici e medici) non furono mai scritti, si trasformò in uno spettacolare album illustrato. Oeder riuscì unicamente a scrivere un'introduzione alla botanica e una lista parziale delle piante (relativo alle sole crittogame). Il licenziamento gli impedì di scrivere altri testi e i suoi successori vi rinunciarono definitivamente. Flora Danica si presenta dunque come una raccolta di splendide tavole calcografiche in folio (ben 3240), il catalogo completo della flora spontanea danese; in via di principio, le piante, ritratte dal vero, sono a grandezza naturale (tranne le piante grandi, riprodotte in scala con particolari a grandezza naturale) e occupano una tavola ciascuna - ad eccezione di alcuni muschi. I particolari che permettono di distinguere una specie dall'altra sono disegnati a parte; per le piante più piccole e i particolari minuti, venne utilizzata una lente d'ingrandimento. Gli artisti di cui si servì Oeder erano anch'essi tedeschi, padre e figlio: Michael Rössler (1705-77), il padre, era l'incisore e Martin Rössler (1727-82), il figlio, il pittore. Come si è detto, l'opera aveva anche un fine divulgativo. Per questo, ne vennero predisposte due versioni: una di base, con le tavole stampate in bianco e nero, una di lusso con le tavole colorate a mano; grazie al sostegno del re, vennero vendute a un prezzo "politico": ciascun fascicolo di 60 tavole costava 4 rix-dollari nella versione economica, 6 in quella di lusso. Inoltre per la diffusione si coinvolse la chiesa: copie dell'edizione base vennero inviate ai vescovi che avrebbero provveduto a distribuirle ai pastori, alle scuole parrocchiali e alle persone colte; in effetti, nella Danimarca del Settecento, non esistevano scuole pubbliche laiche, l'istruzione passava totalmente attraverso la chiesa luterana, che d'altra parte, in quanto chiesa di stato, dipendeva dal re. Dopo il siluramento di Oeder, l'opera rischiò di essere a sua volta abbandonata. Tuttavia, dopo qualche anno di interruzione, fu affidata a Otto Friedrich Müller, uno zoologo di chiara fama, scarsamente interessato alla botanica, tanto che in otto anni (1775-1782) pubblicò soltanto cinque fascicoli. Con il terzo curatore l'opera tornò nelle mani di un botanico, il grande Martin Vahl (1787-1799) e proseguì, tra interruzioni e riprese, fin quasi alla fine del XIX secolo, con J. W. Hornemann (1806-1840), S. Drejer, J. F. Schouw e Jens Vahl (1843), F. Liebmann (1845-1853), J. Steenstrup e Johan Lange (1858), Johan Lange da solo (1861- 1883), che concluse l'opera e ne scrisse gli indici. Giunta alla fine, l'enorme pubblicazione era costituita da 51 parti e 3 supplementi. Grazie alla biblioteca nazionale danese, è possibile non solo conoscerne meglio la storia, ma sfogliare la spettacolare opera, che è stata integralmente digitalizzata nel sito Flora danica on-line. Non perdetevi una visita: la bellezza artistica e la precisione scientifica hanno qui raggiunto uno dei loro vertici. Ma nel frattempo Flora Danica conosceva una nuova incarnazione, quella che probabilmente l'ha resa più nota. Nel 1790 il principe ereditario Federico ordinò alle manifattura di Copenhagen un servizio da tavola decorato con disegni tratti dalle tavole di Flora Danica, che avrebbe dovuto essere donato alla zarina Caterina II; in finissima ceramica, completamente dipinto a mano, a realizzarlo fu chiamato Johan Christoph Bayer, uno dei pittori botanici che aveva lavorato per i volumi sotto la supervisione di Martin Vahl. Lo splendido servizio, che comprendeva 1802 pezzi, però non giunse mai in Russia; rimase in possesso della corona danese, che ancora oggi se ne serve in occasione di ricevimenti di stato. Diventato uno dei più prestigiosi servizi di porcellana di ogni tempo, è tuttora in produzione alla Royal Copenhagen (dipinto rigorosamente a mano, scegliendo tra oltre 3000 motivi decorativi tratti dalle illustrazioni di Flora Danica).  Oedera, un'asteracea sudafricana Quanto a Oeder, poco prima di essere silurato fece in tempo a ricevere l'omaggio di Linneo che nel 1771 (Mantissa Plantarum altera) gli dedicò il genere sudafricano Oedera separandolo dall'europeo Buphthalmum. Oedera, della famiglia Asteraceae, è un genere endemico del Sud Africa, con circa 18 specie delle Province del Capo orientale e del Capo orientale. Si tratta di piccoli arbusti eretti, di portamento che può ricordare quello dell'erica, con foglioline spesso strette, aghiformi, adatte a sopportare l'aridità, e capolini gialli, singoli in alcune specie, raccolti in dense infiorescenze in altre. Una dozzina di specie è caratteristica di un ambiente molto particolare, il fynbos, la vegetazione arbustiva che riveste una piccola striscia costiera del Capo Occidentale, soprannominato Cape Floral Kingdom per l'abbondanza di piante (almeno 8000 specie) e la ricchezza di endemismi (circa 4000 specie). Similmente alla macchia mediterranea, che ne è l'equivalente nelle nostre latitudini, è una formazione vegetale xerofita dominata da arbusti. Tra i gruppi più importanti, si annoverano anche numerose Asteraceae, appartenenti a generi affini tra loro, Relhania, Rosenia, Nestlera, Leysera, e appunto Oedera, che si distingue dagli altri per alcune caratteristiche, ad esempio per le foglie prive di tomento. Alcune di esse, come O. genistifolia e O. squarrosa possono talvolta assumere il ruolo di specie dominanti. Qualche informazione in più nella scheda. Ardono gli ultimi fuochi delle guerre di religione quando un giovane medico, Pierre Richer de Belleval, propone a Enrico IV di dotare l'Università di Montpellier di un orto dei semplici degno della sua fama. E' così che nasce, tra gelosie di colleghi e cronica mancanza di fondi, il primo Orto botanico di Francia, creato da un cattolico in una cittadella del protestantesimo, destinato ad essere distrutto dal fuoco amico del cardinale di Richelieu e a risorgere dal nulla, sempre per merito del pertinace Belleval. Che si guadagnerà ben due generi: Richeria e Bellevalia. 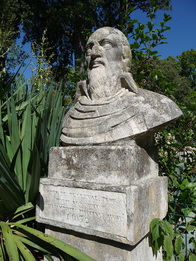 La modesta proposta di Richer de Belleval Dicembre 1593. Il governatore della Linguadoca, duca di Montmorency, presenta un giovane medico a un Enrico IV ancora in assetto di guerra (da quattro è nominalmente re di Francia, si è già convertito al cattolicesimo, ma ancora Parigi rifiuta di aprirgli le porte). Il dottore si chiama Pierre Richer de Belleval e espone al sovrano il suo sogno: dotare l'Università di Montpellier di un giardino dei semplici che rivaleggi con quello di Padova. Il re, già proiettato verso la pace e la ricostruzione del paese, è entusiasta. Ed è così, che con decreto reale nasce il Jardin du Roy, il giardino del re, ovvero l'Orto botanico di Montpellier; poiché nessuna delle cattedre di medicina dell'Università di Montpellier è vacante, con un secondo provvedimento ad hoc viene istituita per Belleval una quinta cattedra (il primo insegnamento di botanica in terra francese): d'inverno dovrà insegnare anatomia, in primavera e d'estate raccogliere e "dimostrare" i semplici. Nonostante le "lettere patenti" reali, c'è ancora qualche ostacolo: manca la ratifica del Parlamento di Linguadoca (arriverà solo nel 1596) e Belleval deve completare gli studi: ha conseguito il titolo medico a Avignone, gli manca il dottorato che solo Montpellier, appunto, gli può conferire. Ottenuto il titolo e giunta l'approvazione del Parlamento e i primi finanziamenti, Belleval si mette all'opera: acquista una serie di appezzamenti al di fuori delle mure cittadine, nel quartiere di Saint Jacques, altri ne requisisce. Si getta anima e corpo nell'impresa, anticipando anche di tasca sua il denaro necessario per gli uomini, i cavalli, i materiali, le piante (si è da poco sposato con una ricca ereditiera, di cui sta rapidamente esaurendo la dote). Estraneo all'ambiente di Montpellier (la sua famiglia è originaria della Champagne), "papista" in una città protestante (ha compiuto gli studi nella cattolicissima Avignone, che fa parte del territorio pontificio), con la sua fortunata carriera Belleval non può che suscitare invidie e rancori nella città che, nel frattempo, con l'editto di Nantes, è diventata anche ufficialmente una roccaforte ugonotta. I più zelanti fanno arrivare a André Dulaurens, primo medico del re, denunce e proteste: la più grave è che Richer de Belleval ha lasciato all'abbandono l'insegnamento dell'anatomia. Accusa fondata: sempre in giro ad erborizzare nelle campagne della Linguadoca, quando non all'estero, per fare visita ai colleghi di Padova, Bologna, Vienna, Londra, Leida (entrando il quella rete di relazioni e scambi che abbiamo già incontrato parlando dell'Orto padovano), in effetti Belleval ha occhi e tempo solo per il Giardino. E alla fine, trovata una soluzione di compromesso (l'insegnamento di anatomia sarà affidato a un sostituto), l'appassionato botanico può finalmente concentrarsi nell'opera della sua vita. 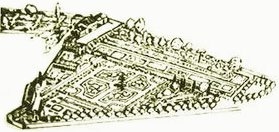 Un giardino per i semplici e per le piante La concezione del Jardin royal di Montpellier è per molti aspetti innovativa: non sarà solo un giardino dei semplici, destinato alle piante medicinali la cui conoscenza è richiesta nel curriculum dei futuri medici, ma un giardino botanico dove le piante esotiche e le piante del territorio potranno essere coltivate rispettando le loro esigenze di suolo e esposizione. L'idea più innovativa è il monticulus, il "monticello", un rialzo artificiale alto circa due metri, con orientamento est-ovest, formato da cinque terrazze sovrapposte; lo scopo è duplice: riparare dal vento le piante medicinali coltivate nelle parcelle destinate ai semplici; offrire alle piante "selvagge" l'esposizione più adeguata. Nelle cinque terrazze esposte a sud vengono trapiantate le piante della garrigue, amanti del sole; nelle cinque terrazze esposte a nord le piante amanti dell'ombra. Di concezione ugualmente innovativa il labirinto, uno spazio protetto da muri con una struttura a spirale che trattiene l'umidità e fornisce ombra alle piante. Per le esotiche c'è un giardino recintato e sono previste aree specifiche per le piante acquatiche, quelle delle sabbie e quelle delle rocce. E' la prima volta che in un giardino si cerca di ricreare le condizioni naturali adatte a ciascuna pianta. Più tradizionale la parte propriamente didattica, il giardino dei semplici vero e proprio, destinato alla formazione degli studenti di medicina dell'Università, collocato a sud del monticulus; comprendeva due gruppi di tre aiuole rialzate parallele, dotate di canaletti di irrigazione, dove le piante erano sistemate in ordine alfabetico (esattamente come negli erbari del tempo) e contraddistinte da numeri incisi sulla pietra che permettevano l'identificazione (lo stesso Richer de Belleval provvide a scrivere il catalogo, in cui le piante erano contrassegnate con quegli stessi numeri). All'ingresso, un'iscrizione latina ammoniva i visitatori: Hic Argus sit et non Briareus, "Qui bisogna comportarsi come Argo dai cento occhi, non come Briareo dalle cento mani" (insomma, "guardare e non toccare"). Nel 1622, il Giardino aveva ormai raggiunto la maturità, conteneva almeno 1300 specie, era il fiore all'occhiello dell'Università di Montpellier e attirava studenti e visitatori da tutta Europa; Parigi, che ancora non aveva un suo orto botanico, guardava a quel modello per dotarsi di un'istituzione di pari livello. Quell'anno il Cardinale di Richelieu, nella sua controffensiva contro gli ugonotti, inviò le sue truppe ad assediare la città, che, come si è visto, era una delle piazzeforti protestanti previste dall'editto di Nantes. Il cavaliere d'Argencourt, ingegnere della città, per rafforzare le difese in vista dell'assedio, cacciò i giardinieri e trasformò il giardino in un bastione; Richer de Belleval riuscì solo a salvare le piante più preziose, trasferendole in quello che era stato il piccolo orto di Rondelet. Due anni dopo, quando venne firmata la pace, del giardino non era rimasto nulla. Bisognò ricominciare tutto da capo; nel 1629 Richelieu visitò la città e promise aiuti finanziari che tardavano ad arrivare (forse perché, nel frattempo, stava per sorgere il Jardin des plantes di Parigi, che stava molto più a cuore al re e al cardinale). Belleval, negli otto anni che gli sarebbero rimasti da vivere, ricostruì e ingrandì la sua creatura, lasciando in eredità il difficile compito a un nipote (come molte cariche della Francia dell'Ancien Régime, anche quella di curatore del Jardin royal di Montpellier era ereditaria). Fondatore del più antico orto botanico francese, titolare della prima cattedra di botanica, pioniere dell'ecologia botanica, Belleval fu anche uno botanico sul campo che esplorò a fondo la flora della Linguadoca, ma anche dei Pirenei e delle Alpi. Fu anche un antesignano della nomenclatura binomiale, anche se la sua idea oggi appare francamente bizzarra: denominare le piante con un nome più generale (il genere) in caratteri latini, un nome più specifico (la specie) in caratteri greci. Qualche notizia in più nella biografia. Tra alti e bassi, nei secoli successi il Jardin des Plantes de Montpellier, il più antico orto botanico francese, secondo in ordine di importanza solo a quello parigino (fondato nel 1626), manterrà il suo prestigio e sarà diretto da importantissimi botanici, come Augustin Pyramus de Candolle; oggi è uno dei pochi a trovarsi ancora nella collocazione voluta dal suo fondatore, e al centro è ancora visibile il monticulus, la "Montaigne di Richer", all'estremità della quale da quasi quattro secoli continua a fiorire l'albero di Giuda (Cercis siliquastrum) da lui piantato.  Due nomi, due generi: Richeria e Bellevalia Diversi botanici onorarono Richer de Belleval con la dedica di un genere. Oggi due sono quelli considerati validi: Richeria Vahl e Bellevalia Lapeyr. Forse è giusto, considerando che il nostro aveva due nomi e due volte ha creato il giardino. Richeria Vahl. è un piccolo genere della famiglia Phyllantaceae (un tempo sottofamiglia delle Euphorbiaceae) che comprende alcune specie di alberi originari del centro e sud America e delle Antille. E' stato dedicato a Richer de Belleval nel 1797 dal botanico danese Martin Vahl. La specie più nota è Richeria grandis, un grande albero sempreverde comune nelle foreste dei Caraibi e del Sud America. Alla sua scorza, nota con il nome di bois bandé, sono attribuite proprietà afrodisiache. Torniamo nel vecchio mondo con Bellevalia Lapeyr., un genere della famiglia Asparagaceae (una delle diverse famiglie staccate dalle Liliaceae), abbastanza affine a Muscari o Hyacinthus. E' stato stabilito nel 1808 da un naturalista francese dal nome chilometrico: Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse, grande studioso della fauna, della flora e dei minerali dei Pirenei. Comprende una sessantina di specie, diffuse dal Mediterraneo all'Asia centrale. Sono bulbose con infiorescenze a spiga molto simili a quelle dei giacinti (e infatti al genere Hyacinthus in passato sono state assegnate diverse specie). Sei specie e due sottospecie sono presenti anche in Italia; la più diffusa è B. romana, nota come giacinto romano, una bulbosa con fiori bianco-verdastri con stami viola, raccolti in racemi laschi portati su caratteristici fusti violacei. Per altre informazioni sui generi Richeria e Bellevalia si rimanda alle rispettive schede. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed