|
Nell'epoca vittoriana, la passione per le piante esotiche ha ormai contagiato l'intera società britannica; e all'introduzione di nuove specie da studiare, moltiplicare e coltivare non contribuiscono solo botanici e cacciatori di piante al servizio di orti botanici e vivai, ma anche singoli viaggiatori, commercianti, soldati, funzionari. E diplomatici, come il protagonista di questa storia, John Henry Mandeville. Furono numerose le piante interessanti che inviò a Londra dalla sua sede di Buenos Aires, secondo la testimonianza di John Lindley, che gli dedicò la più bella, la profumatissima Mandevilla suaveolens. A lungo piante di nicchia coltivate solo da chi poteva permettersi una serra, le Mandevillae sono oggi protagoniste di una vera rivoluzione, che le ha trasformate nelle rampicanti da fiore più apprezzate e vendute (persino nei supermercati), anche se, per una serie di complesse vicende, spesso sono commercializzate con il sinonimo Dipladenia. 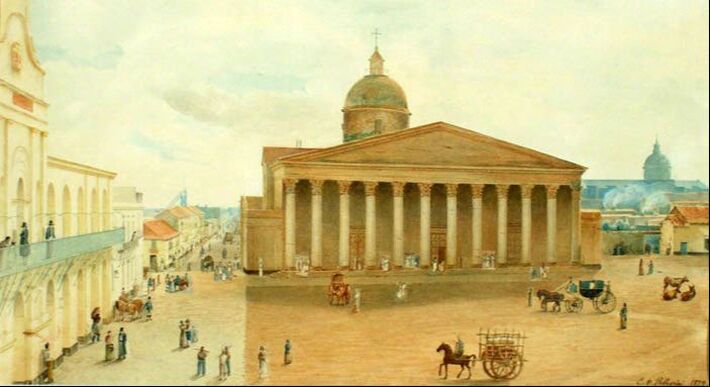 Successi e umiliazioni di un diplomatico Dopo un trentennio di gavetta, la carriera diplomatica di John Henry Mandeville (1773-1861) raggiunse il suo culmine con la nomina a ministro plenipotenziario britannico a Buenos Aires. Secondo Raymond Jones, studioso della diplomazia del Regno Unito, era un ottimo diplomatico, un "cavallo da tiro", stimato dai superiori per la capacità di iniziativa, l'intelligenza, l'affidabilità. Tuttavia gli mancavano gli amici potenti che gli avrebbero garantito incarichi più prestigiosi; dovette così accontentarsi di questa sede diplomatica che il Foreign office considerava secondaria. Diplomatico di lunga esperienza, uomo di mondo e conversatore facondo e affabile, Mandeville sembrava la persona giusta per barcamenarsi in una situazione tutt'altro che facile. Gli interessi britannici nel paese sudamericano, che aveva raggiunto l'indipendenza nel 1823 e si era affrettato a sottoscrivere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione con il Regno Unito, erano importanti: la Gran Bretagna era il maggior partner commerciale e il primo investitore, e il trattato garantiva molti privilegi ai suoi sudditi. Tuttavia l'ascesa al potere del generale Rosas sembrava mettere in forse la stretta alleanza tra i due paesi, come faceva temere l'allontanamento del predecessore di Mandeville, Hamilton Charles Hamilton. La scelta del Foreign Office si rivelò lungimirante: giunto nella sua nuova sede nel 1835, Mandeville riuscì a conquistare la fiducia di Rosas e a convincerlo a sottoscrivere un accordo che metteva al bando la compravendita di schiavi. Il suo rapporto con il tirannico, sospettoso e grossolano generale non fu però esente da ombre: se da una parte quest'ultimo ne apprezzava la conversazione e lo invitava volentieri alla casa Rosada, incoraggiandolo addirittura a corteggiare sua figlia Manuela, dall'altra diffuse pettegolezzi su di lui e arrivò a farlo pedinare dalla polizia e a intercettarne la corrispondenza. D'altra parte, anche l'atteggiamento di Mandeville verso il dittatore argentino era ambivalente, come la politica del suo paese. Se mai si permise una critica aperta, non mancò di informare puntualmente il suo governo delle nefandezze del regime rosista ai danni degli oppositori; in ogni caso, sia lui, sia lord Palmerston erano convinti che in un paese selvaggio come l'Argentina un personaggio come Rosas fosse un male necessario (non diverso sarà il giudizio di Churchill su Mussolini). A partire dal 1838, Mandeville si trovò a gestire la difficile crisi internazionale provocata dalla Francia che impose il blocco navale del Rio della Plata per vedersi riconosciuto lo status di "potenza più favorita" di cui già godeva la Gran Bretagna; la Francia puntava direttamente alla caduta di Rosas, allenandosi con i suoi oppositori interni e con l'Uruguay. Dietro a tutto questo c'era evidentemente la rivalità politica ed economica tra la stessa Francia e la Gran Bretagna; tuttavia quest'ultima andò sempre più allontanandosi da Rosas, perché la situazione politica globale (si pensi in particolare alla Guerra dell'oppio) spingeva a un'intesa con Parigi. La guerra tra Argentina e Uruguay, il feroce nazionalismo di Rosas, il deciso interventismo francese spinsero così Palmerston a capovolgere la propria politica, alleandosi con la Francia contro Rosas (con la partecipazione al blocco anglo-francese del Rio de la Plata, 1845-1850). Il logoramento della relazioni anglo-argentine mise Mandeville in una posizione molto difficile, che raggiunse l'apice nel 1844, alla vigilia del suo congedo: il quotidiano "El Nacional" di Montevideo pubblicò undici sue lettere che contenevano giudizi molto duri sulla politica di Rosas, suscitando l'indignazione generale dell'opinione pubblica argentina; Rosas pensò che il diplomatico inglese non avrebbe più osato presentarsi al suo cospetto. Invece, con sangue freddo, Mandeville si recò alla sua residenza a Palermo. Rosas lo ricevette, ma dopo mezz'ora di conversazioni apparentemente senza importanza, diede libero sfogo in sua presenza a una necessità corporale. Alle proteste indignate dell'inglese, obiettò che era ben nota a tutti l'abitudine di Mandeville di grattarsi ovunque le natiche; lui non lo aveva mai ripreso per questo, perché riteneva che non potesse farne a meno, se gli prudeva. Dopo un simile affronto pubblico, al malcapitato ministro plenipotenziario britannico non restava che lasciare il paese; tornato in Gran Bretagna nel 1845, andò in pensione (aveva già superato i settant'anni), e visse ancora a lungo, forse coltivando la passione per il giardinaggio che l'aveva spinto, durante il mandato decennale, ad inviare in patria numerose piante rare. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Mandevilla o Dipladenia? Riconoscente per i numerosi interessanti invii, nel 1840 John Lindley volle dedicargli la specie più bella tra quelle da lui introdotte, una rampicante dai profumatissimi fiori bianchi, che in Argentina era nota come "gelsomino del Cile"; la battezzò Mandevilla suaveolens, ma poiché era già stata pubblicata nel 1799 da Ruiz e Pavon come Echites laxus, oggi il suo nome accettato è Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson. Nel corso dell'Ottocento altre specie di questo genere della famiglia Apocynaceae arrivarono occasionalmente nelle serre europee, ma nessuna divenne veramente popolare; diverso fu invece la sorte di una altro gruppo di specie affini. Nel 1844 Alphonse de Candolle pubblicò in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis una revisione delle Apocynaceae in cui, tra l'altro, creò il nuovo genere Dipladenia (il nome significa "con due ghiandole", in riferimento alla coppia di ghiandole del nettario), in cui riunì una ventina di specie staccate da Echites. Al contrario delle sorelle Mandevillae, queste rampicanti dai fiori spettacolari incontrarono il favore degli intenditori e nel corso del secolo diverse specie vennero introdotte nelle serre europee. Una delle prime fu D. rosacampestris (oggi Mandevilla illustris), raccolta in Brasile nel 1839 dai francesi Guillemin e Hullet; la stessa specie nel 1847 fu portata a Gand da de Vos, raccoglitore per i vivai Verschaffelt, con il nome D. nobilis. Nel 1841 William Lobb, cacciatore di piante dei vivai Veitch, raccolse nella Serra dos Órgãos in Brasile D. splendens e D. urophylla. A suscitare grande sensazione, quando venne presentata in una mostra floricola a Londra, fu soprattutto la prima, lodata da Hooker per l'esotica bellezza. Più o meno nello stesso periodo a nord di Rio de Janeiro fu scoperta D. sanderi, che però venne importata in Inghilterra solo nel 1896, appunto dal vivaio F. Sander and Co. Si deve a un altro cacciatore dei Veitch, Richard Pierce, l'introduzione di D. boliviensis; raccolta nel suo viaggio in Sud America tra il 1859 e il 1861, fiorì per la prima volta nelle serre dei Veitch nel 1868. Lo stesso anno venne presentato su The Gardener's cronicle un ibrido destinato a segnare la storia del genere, D. x amabilis (anche noto come D. amoena): l'aveva ottenuto nel 1862 Henry Tuke, giardiniere di un certo R. Nicolls a Bramley presso Leeds, incrociando D. splendens con D. crassinoda. Erano piante magnifiche e imponenti, che troviamo spesso illustrate nelle riviste di giardinaggio dell'epoca; ma non erano per tutte le tasche; costose ed esigenti, necessitavano di cure professionali e dell'atmosfera protetta di una serra tropicale. Fu così che nel Novecento furono un po' dimenticate, anche se nel 1930 in Francia si ebbe un apporto particolarmente apprezzabile, D. x amabilis "Alice du Pont", una statuaria bellezza dai fiori rosa chiaro. Vi state chiedendo come mai questa lunga storia di Dipladenia in un post dedicato a Mandevilla? Semplice: nel 1933 R.E. Woodson propose una ridefinizione di Mandevilla, che venne allargato a 107 specie, con la confluenza di otto generi incluso Dipladenia. Nel 1949 Pichon propose una nuova riclassificazione, che includeva in Mandevilla anche il piccolo genere Macrosiphonia, mantenuto indipendente da Woodson. I recenti studi tassonomici basati sul DNA hanno confermato queste conclusioni. Oggi, Mandevilla è il più numeroso genere neotropicale delle Apocynaceae, con oltre 150 specie, mentre per i botanici il genere Dipladenia non esiste più (o meglio è un sinonimo "storico" di Mandevilla). Ma le cose stanno diversamente in campo orticolo. Qui, evidentemente, il nome Dipladenia aveva fatto in tempo a entrare nella memoria e nel cuore di coltivatori e appassionati, cui era ben più familiare di Mandevilla. Ed è dunque con il duplice nome Mandevilla / Dipladenia che le nostre spettacolari rampicanti tropicali nell'ultimo ventennio sono diventate protagoniste di una delle più eclatanti rivoluzioni del mercato floricolo. Si è detto che il primo Novecento le trascurò; a riscoprirle furono nella seconda metà degli anni '50 gli orticultori danesi, che reintrodussero nel mercato "Alice du Pont" e diverse cultivar di Mandevilla sanderi (da questo momento, uso i nomi attuali!). Ma la vera rivoluzione inizia nel 1991: nei vivai della giapponese Suntory vengono seminati i semi di un incrocio tra M. x amabilis 'Rose Giant' (madre) e M. boliviensis (padre). Dei 35 semenzali solo uno sarà selezionato: è nata Sunmandeho, ovvero la capostipite della fortunata serie Sundaville, commercializzata a partire dal 2000 in Europa come 'Sundaville Cosmos White' e in America come 'Sun Parasol Giant White'. Nel 2005 seguirà la più famosa di tutte, la rossa Sunmadecrim, ibrido tra M. atroviolacea e M. sundaville 'Cosmos White'. Sarà commercializzata come Dipladenia sundaville 'Red'. La Suntory decide infatti di usare i due nomi per differenziare la sua produzione: Mandevilla per le rampicanti vigorose con grandi foglie dalla venatura evidente, Dipladenia per le forme più compatte, cespugliose e foglie piccole. Una distinzione inconsistente dal punto di vista botanico, ma che ha fatto scuola, tanto che oggi (almeno da noi) il nome commerciale prevalente sembra proprio essere Dipladenia (del resto, le forme compatte, nei nostri terrazzi e nei nostri piccoli giardini, hanno la preferenza su quelle a grande sviluppo). Sotto l'uno o l'altro nome, oggi sono le rampicanti da fiore più vendute sul mercato, tanto che è facile trovarle in vendita persino sugli scaffali dei supermercati, a prezzi così competitivi che molti le coltivano come annuali, proprio come si fa con le petunie. Le grandi ditte che dominano questo mercato miliardario si sfidano a colpi di novità: accanto al bianco, al rosa e al rosso, arrivano il giallo e l'albicocca; Suntory moltiplica le serie, introducendo le Mini e le Up con fiore stellato; la francese Lannes risponde con le piccole deliziose Diamantina; Syngenta punta sulle fioriture precoci, il portamento ordinato e compatto, la versatilità, la resistenza e la facilità di coltivazione della sua serie Rio (è probabile che se acquistate una "Dipladenia" rossa senza nome in un supermercato, sia una 'Rio Red', la più venduta di tutte). Dopo aver sopportato l'ignobile oltraggio di Rosas, il buon Mandeville saprà farsi una ragione se la "sua" pianta imperversa in ogni dove sotto le mentite spoglie di Dipladenia. Qualche notizia sulle specie più importanti per la creazione degli ibridi nella scheda.
0 Comments
Gli spagnoli li chiamavano semplicemente amapola, "papavero" o copa de oro. Ogni anno, a milioni rivestono di un tappeto d'oro le praterie della California che li ha scelti come proprio simbolo floreale. A questi fiori così semplici, così campagnoli, è stato assegnato uno dei nomi botanici dalla grafia più terroristica, Eschscholzia californica. Eppure a ideare questa mostruosità è stato un poeta. La colpa, più che sua, è di una duplice trascrizione: dal tedesco al russo, quindi dal russo al latino della botanica. A farne le spese anche il buon dottor Eschscholtz (nato altrove, si sarebbe chiamato Escholz): lo abbiamo incontrato come membro della prima spedizione Kotzebue insieme all'amico Adelbert von Chamisso (il poeta in questione); ora ci farà da guida nella seconda. Scopriremo poi che Eschscholzia californica ha tante sorelle, bellissime e ardimentose foglie dei deserti.  Un fiore semplice dal nome terroristico Nell'ottobre 1816, quando i russi gettarono l'ancora nella baia di San Francisco, Adelbert von Chamisso fu piuttosto deluso; in quella stagione ormai autunnale le fioriture erano ben poche e la maggior parte delle piante apparivano disseccate dal sole estivo; gli sembrava di vedere solo cadaveri vegetali, tanto che parlò di "botanica forense". A rallegrare lui e l'amico Eschscholtz, lo zoologo e medico di bordo della Rjurik, le ultime tardive fioriture di una papaveracea dai fiori d'oro, che Chamisso avrebbe poi battezzato Eschscholzia californica. Esuberanti e generose, in primavera fioriscono a milioni, ma le fioriture possono prolungarsi sporadicamente fino all'autunno. Fu così che a questo fiore dalla bellezza semplice fu associato un nome dalla grafia terroristica. Scopriamo perché. Johann Friedrich Gustav von Eschscholtz era un tedesco baltico, nato a Dorpat (oggi Tartu), di lingua tedesca ma suddito russo. La grafia originaria del suo cognome era Escholtz (o anche Escholz), che nella trascrizione in cirillico diventa Эшшольц, ripetendo due volte il carattere corrispondente al trigramma tedesco sch. Ritraducendo in alfabeto latino, il tutto produce appunto Eschscholtz, la forma adottata in tutte le sue opere a stampa dal nostro dottore. Chamisso si adeguò, denominando il genere che celebra l'amico Eschscholzia (se non altro, risparmiò una t). Eschscholtz aveva studiato medicina e chirurgia all'Università di Dorpat, divenendo il più promettente allievo e l'assistente di von Ledebour. Quando fu scelto come medico di bordo e zoologo della Rjurik aveva appena ventidue anni. Era un naturalista entusiasta, appassionato soprattutto di insetti, ma pronto a estendere le sue osservazioni a tutti i campi della natura. Tra l'altro, fu il primo a segnalare il fenomeno del ghiaccio fossile (o permafrost), che poté studiate nella penisola di Seward in Alaska. Come quelle di Chamisso, le sue collezioni botaniche furono pubblicate in diverse riviste e in appendice alla relazione di viaggio di Kotzebue, A voyage of discovery into the South Sea and Beering's Straits … undertaken in the years 1815-1818 … under the command of the Lieutenant … Otto von Kotzebue (1821). Al suo rientro a Dorpat, si sposò con la sorella del maestro e iniziò una promettente carriera accademica; nel 1819 fu nominato aggiunto di anatomia e nel 1822 direttore del gabinetto zoologico. Pubblicò anche le sue scoperte entomologiche in Entomographien (1822). Intanto in Russia si andava preparando una terza circumnavigazione del globo. Nuovamente affidata al comando di Kotzebue (che nel frattempo era stato promosso capitano), avrebbe dovuto riprendere gli obiettivi di quella precedente, ma con mezzi maggiori, a partire dalla nave, la Predpriatie, una fregata con un equipaggio di 145 persone (la Rjurik ne ospitava 32). A bordo ci sarebbe stata anche un'équipe scientifica, interamente formata da giovani studiosi dell'Università di Dorpat; a capeggiarla fu chiamato proprio il nostro Eschscholtz, che era anche il medico di bordo. Gli altri erano l'astronomo Ernst Wilhelm Preuss, il geologo Ernst Hoffmann e il chimico e fisico Emil Lenz. Come si vede, nessun botanico; evidentemente, l'ammiragliato condivideva il punto di vista di Kotzebue e di tanti capitani, a cominciare da Cook: in una spedizione oceanografica, i botanici non servivano a niente e creavano solo guai. La Predpriatie avrebbe anche dovuto scortare una flotta di rifornimenti per l'America russa. Ma all'ultimo momento gli obiettivi furono cambiati; vista la sempre più agguerrita concorrenza di cacciatori di pellicce di altre nazioni, avrebbe dovuto soprattutto proteggere gli interessi russi, scoraggiando la penetrazione altrui lungo la costa nordoccidentale dell'Alaska. 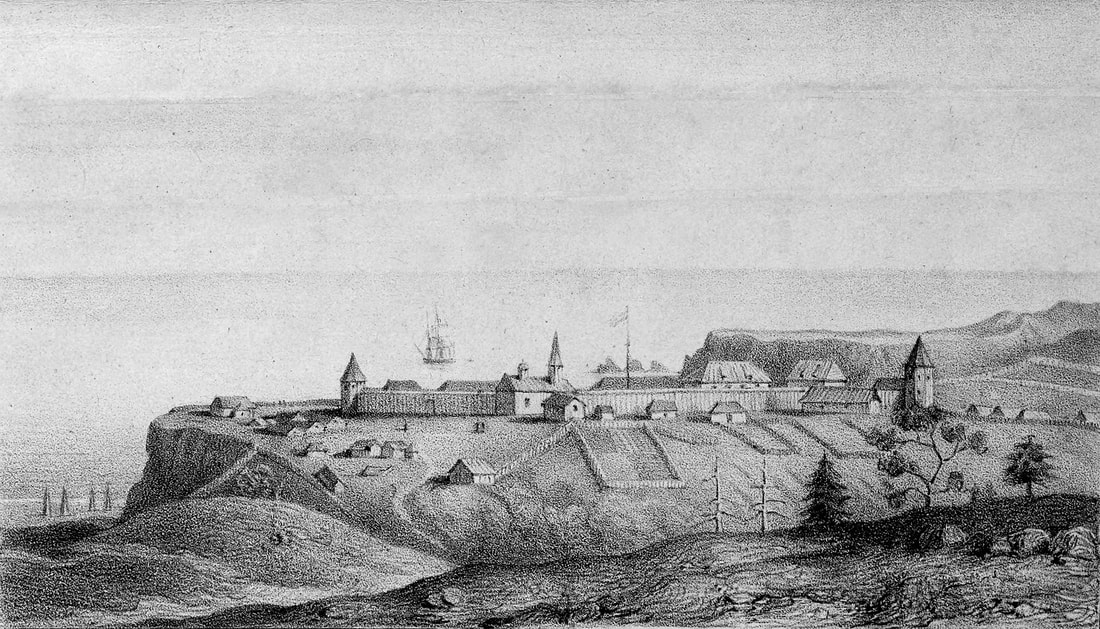 La seconda spedizione Kotzebue La Predpriatie salpò da Kronstadt il 28 luglio 1823 e seguendo la rotta ormai consueta il 23 dicembre doppiava Capo Horn; dopo una breve sosta a Talcahuano in Cile, si diresse a Tahiti, passando per l'arcipelago delle Tuamotu, dove toccò diverse isole scoperte in spedizioni precedenti e ne scoprì una nuova, battezzata appunto Predpriatie. Kotzebue giunse a Tahiti il 14 marzo 1824 e, dopo aver incontrato diversi membri della London Missionary Society, ne ripartì il 24. Proseguendo verso nord, incontrò varie isole degli arcipelaghi della Società e delle Sottovento, scoprendo l'atollo di Motu Onu (ribattezzato Bellingshausen in onore del celebre esploratore russo). La rotta proseguì attraverso le Samoa, dove furono scambiati maiali e altre provviste con gli indigeni, la catena Radak e le Marshall, già toccate durante il primo viaggio. Dopo una breve sosta a Petropavlovsk in Kamčatka, i russi raggiunsero le Aleutine e l'avamposto di Novoarchangelsk (Sitka) in Alaska, dove trascorsero i mesi estivi, impegnati in operazioni di pattugliamento. Scendendo a sud per svernare, il 27 settembre gettavano l'ancora nella Baia di San Francisco; rispetto alla visita della Rjurik, la situazione politica era totalmente mutata. Ora sul forte sventolava la bandiera messicana (nel 1822 l'Alta California si era infatti resa indipendente dalla Spagna). Il soggiorno si protrasse fino alla fine di novembre; grazie all'ospitale comandante della piazza, Eschscholtz ebbe l'opportunità di viaggiare in battello fino a Santa Clara e soprattutto di visitare l'avamposto russo di Fort Ross, nei pressi di Sonora, che era stato creato nel 1812 dalla compagnia russo-americana. Fu un viaggio avventuroso nel corso del quale poté incrementare le sue raccolte di insetti e osservare molte specie di uccelli; emozionante il viaggio di ritorno con una flottiglia di baidarke, i kayak degli Aleutini al servizio della compagnia. A novembre, insieme al comandante (con cui cui si intendeva molto di più di Chamisso) risalì il fiume Sacramento in una piacevole gita di più giorni; osservarono molti animali selvatici e fecero una scorpacciata degli acini, piccoli ma dolcissimi, delle viti selvatiche che si arrampicavano sugli alberi lungo le rive, predicendo un sicuro futuro vinicolo alla California. Con molto sangue freddo, Eschscholz rese inoffensivo e catturò un piccolo serpente a sonagli; conseguenze più sgradevoli ebbe l'incontro con una puzzola. Il secondo soggiorno californiano di Eschscholtz fu molto più produttivo del primo: circa duecento specie di insetti, tutti ignoti alla scienza tranne uno; una vasta collezione di molluschi; numerosi uccelli e anfibi; una quarantina di specie di uccelli; in tutto, registrò circa 2400 animali. Raccolse anche qualche nuovo esemplare di pianta, anche se queste collezioni sono difficili da distinguere da quelle del 1816; le pubblicò infatti insieme in Descriptiones plantarum novae Californiae, adjectis florum exoticorum analysibus (1826) che è anche la prima pubblicazione scientifica nel cui titolo si menziona la California. Lasciata la quale, il 12 dicembre Kotzebue era di nuovo a Honolulu, dove fece omaggio al ministro Kalaimoku di una copia calcografica del ritratto del re Kamehameha dipinto da Choris. Alla fine di gennaio, lasciate le Hawaii, si tornò a nord, puntando direttamente sull'Alaska; i mesi da marzo a agosto 1825 vennero di nuovo trascorsi a Novoarchangelsk. Con la fine dell'estate, giunse il momento del ritorno; di nuovo a Honululu il 13 settembre, dopo una sosta di appena sei giorni, la Predpriatie, attraverso le Marshall e le Marianne, si diresse a Manila per le riparazioni necessarie ad affrontare l'Oceano aperto. Ne ripartì il 10 gennaio 1826 e, dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, era di ritorno a Kronstadt il 10 luglio. Rispetto alla spedizione della Rjurik, quella della Predpriatie, che si mosse in gran parte lungo rotte già percorse e si trattenne per molti mesi in Alaska, fu molto meno ricca di scoperte geografiche, limitate ad alcuni atolli nelle Tuamotu, nelle isole della Società e nelle Marshall; uno fu dedicato proprio al nostro Eschscholtz, ma noi siamo abituati a chiamarlo con il nome locale Bikini. Rilevanti furono invece i risultati oceanografici, in particolare le misure delle temperature delle acque oceaniche profonde condotte da Emil Lenz (destinato a diventare un importantissimo scienziato). Di grande importanza per la storia della zoologia anche il lavoro di Eschscholtz, che, oltre che in California, fece raccolte significative di insetti anche in Alaska e nelle Hawaii. Nel 1825 nelle Marshall scoprì il primo esemplare di Balanoglossus. Di ritorno a Dorpat, fu nominato professore di zoologia e contribuì per le parti naturalistiche alla relazione di Kotzebue, nell'edizione inglese A new voyage round the world in the years 1823, 24, 25, and 26. Cominciò a lavorare a un grande atlante illustrato delle specie da lui scoperte; per identificare e classificare le numerose specie nuove di insetti (soprattutto coleotteri e lepidotteri), andò a Parigi a consultare l'esperto di coleotteri Pierre François Dejean. Purtroppo, morì improvvisamente ad appena 37 anni e il suo Zoologischer Atlas (1829-1833) uscì parzialmente postumo. Molte delle specie da lui raccolte furono descritte da altri, tra cui lo stesso Dejean, lo svedese Carl Gustaf Mannerheim e il tedesco naturalizzato russo Gotthelf Fischer von Waldheim. Una sintesi della vita troppo breve di questo grande zoologo nella sezione biografie.  Eschscholzia, sognando California Il genere Eschscholzia, creato da Chamisso nel 1820, è strettamente legato alla California. Eccetto due, tutte le sue quattordici specie vi sono presenti; le spettacolari fioriture di Eschscholzia californica, la specie di nota e diffusa, in primavera trasformano le praterie della penisola in tappeti d'oro. La distesa più impressionante è la riserva dell'Antelope Valley nel deserto del Mojave, dove i "papaveri della California" coprono 1.745 acri; altre fioriture notevoli si possono godere nella Bear Valley, nel Carrizo Plain e a Point Buchon. Niente da stupirsi che siano stati scelti come simbolo floreale dello Stato di California. Piante adattabili, sono presenti in diversi habitat, dal livello del mare fino a 2000 metri, lungo la costa come nei deserti interni; prediligono le praterie aperte, ma crescono anche lungo le strade e in luoghi sassosi e sabbiosi. La fioritura è lunghissima, con un periodo che varia di anno in anno in base al regime delle piogge; può iniziare a febbraio e protrarsi fino a settembre (o oltre: come abbiamo visto, Chamisso e Eschscholtz la raccolsero a ottobre). E' anche piuttosto variabile, con varietà annuali e perenni; varia anche il colore dei petali: oltre al giallo aranciato prevalente, ci sono varietà giallo più o meno chiaro, bianche, rosate o rossastre. Ne hanno approfittato i vivaisti per creare numerose cultivar, alcune delle quali a fiori doppi. Diffusa nelle aree temperate di tutto il mondo come pianta da giardino, è arrivata anche dove non avrebbe dovuto. Si dice che quando finì la corsa all'oro, i minatori che andarono a cercare fortuna in Cile, in Nuova Zelanda e in Australia portarono con sé involontariamente i semi di E. californica mescolati alla sabbia della California usata come zavorra delle navi. Sia come sia, oggi in Cile i papaveri della California formano distese ancora più grandi e vigorosi di quelle della loro terra natale, a scapito delle piante native. Ma non c'è solo E. californica. C'è almeno una dozzina di altre specie, molte delle quali sono annuali degli ambienti desertici della California e degli stati adiacenti. Per conoscerle più da vicino, leggete la scheda, dove troverete anche informazioni sulle più interessanti cultivar di E. californica. Da qualche anno incontra un crescente successo anche nei nostri giardini Muhlenbergia capillaris, una graminacea a fioritura tardiva, abbastanza insignificante fino a fine stagione, quando esplode in una sorprendente nuvola di aerei fiori rosa. Potrebbe essere un involontario ritratto vegetale del reverendo Henry Muhlenberg, placido pastore luterano e pioniere della botanica americana, che scelse la via del modesto raccoglitore della flora locale (mettendo insieme un catalogo di oltre mille specie, tutte rigorosamente raccolte nel raggio di tre miglia da casa) e propugnò il progetto di una flora nazionale, nata dalla collaborazione e dal confronto tra i botanici. Solo in tarda età, quando vide che a prevalere erano invece l'ambizione e le rivalità personali, si decise a pubblicare un lavoro che considerava poco più di un indice di quella flora cooperativa. Addirittura postuma uscì la sua opera più importante, dedicata alle sue piante preferite: carici e graminacee. E' dunque giusto che a celebrarlo siano le graminacee del genere Muhlenbergia, i cui numerosi rappresentanti negli Stati Uniti sono chiamati affettuosamente muhly. 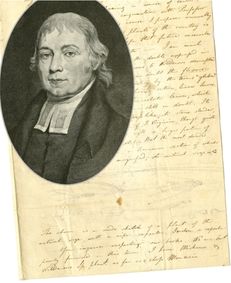 Conflitti tra vocazioni Dopo le turbolente vicende di Frederick Pursh, parlare di Henry Muhlenberg è come contemplare un placido lago dopo aver affrontato le rapide di un torrente. Anche lui vantava un doppio nome ed era di origine tedesca, ma le analogie finiscono qui. Il suo nome ufficiale era Gotthilf Heinrich Ernst, ma preferiva il più colloquiale Henry. Apparteneva a una delle famiglie più influenti della importante comunità tedesca e olandese della Pennsylvania; il padre Henry Melchior (nato Heinrich Melchior Mühlenberg, 1711-87) era il fondatore e il patriarca della Chiesa luterana negli Stati Uniti; i due fratelli maggiori, John Peter Gabriel e Frederick August, furono importanti uomini politici; il primo, generale dell'Armata continentale, era un eroe nazionale, la cui popolarità presso gli "olandesi" di Pennsylvania era seconda solo a quella di Washington. Anche nelle generazioni successive, fino ai nostri giorni, questa famiglia ha continuato ad essere illustrata da uomini di Chiesa e politici, scienziati, architetti e filantropi (se vi incuriosisce, qui trovate l'albero genealogico). Quando aveva solo nove anni, Henry fu mandata a studiare in Germania, a Halle, insieme ai fratelli maggiori, per ricevere un'adeguata istruzione che li avrebbe preparati alla carriera ecclesiastica cui li destinava il padre. Qui rimase dieci anni e studiò lingue antiche, filosofia, teologia; anche se la città vantava un prestigioso orto botanico e una secolare tradizione medica, non sembra che al momento il ragazzo se ne interessasse. Rientrò in patria nel 1770 e fu immediatamente ordinato sacerdote (aveva solo 17 anni), divenendo prima assistente del padre poi pastore a Filadelfia. Nel settembre del 1777 la città fu occupata dalle truppe britanniche; temendo rappresaglie per l'impegno patriottico dei fratelli maggiori, Henry preferì rifugiarsi nella casa paterna a Trappe, dove trascorse un anno di esilio forzato durante il quale incominciò a interessarsi delle piante locali. Uomo prudente e metodico, prese ad annotare le sue osservazioni in un diario di campo (scritto in grafia minutissima in un misto di tedesco colloquiale, inglese e latino, ha messo a dura prova gli studiosi) e a confrontarle con quanto poteva leggere nella letteratura sulla flora americana. Questo studio da autodidatta continuò quando venne nominato pastore a Lancaster, una località a circa 100 km da Filadelfia, dove servì fino alla morte per ben trentacinque anni. Inizialmente il suo interesse andava soprattutto alle piante medicinali, di cui sperimentava le virtù su se stesso, la sua numerosa famiglia (ebbe otto figli) e la comunità. Esplorava le campagne dei dintorni, raccogliendo semi che poi seminava nel giardino di casa, sempre annotando scrupolosamente le sue osservazioni. Si attirò così anche i rimproveri del padre, che avrebbe preferito si occupasse meno delle piante e più dei parrocchiani. La botanica era vista come un hobby, una passione un po' frivola, che non doveva distoglierlo dai compiti pastorali e didattici (nel 1789 divenne il primo presidente del Franklin College). Per almeno un decennio, Muhlenberg continuò ad osservare e analizzare la flora locale, sempre più consapevole del rischio di errori di identificazione vista la carenza di testi di riferimento. Infatti a quel tempo erano disponibili ben poche opere sulla flora delle colonie americane, nessuna delle quali si occupava specificamente della Pennsylvania: Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands di Mark Catesby (1729-31), Flora virginica (1739-1743) di Gronovius, cui nel 1788 aveva fatto seguito Flora Caroliniana (1788) di Thomas Walter. Il pastore-botanico giunse così a compilare un Calendario delle fioriture delle piante locali e una lista di circa 1100 piante spontanee e coltivate che crescevano nel raggio di 3 miglia da Lancaster, presentata nel 1791 alla American Philosophical Society. Molte potevano essere specie nuove, ma per saperlo con certezza era necessario entrare in contatto con gli studiosi europei che, avendo accesso ai grandi erbari, avrebbero potuto aiutarlo a identificare e denominare correttamente i suoi esemplari. Determinante in questa decisione fu l'incontro con Johann David Schoeppf; questi, medico militare delle truppe dell'Assia stanziate presso New York durante la guerra d'indipendenza, dopo la fine del conflitto aveva ottenuto il permesso di rimanere nel paese e nel corso di vari viaggi esplorò la flora da New York alla Florida. Incontrò anche Muhlenberg, che lo accompagnò in alcune escursioni e condivise con lui le sue osservazioni sulle piante medicinali. Tornato in patria, Schoeppf pubblicò Materia medica americana (1787), senza neppure ringraziarlo. Tuttavia lo mise in contatto con il celebre naturalista Johan Christian Schreber, più tardi presidente dell'Accademia Leopoldina (cui anche Muhlenberg fu ammesso poco dopo), il quale a sua volta lo inserì nella rete dei grandi naturalisti europei, con i quali Muhlenberg scambiava piante, semi, esemplari e osservazioni naturalistiche. 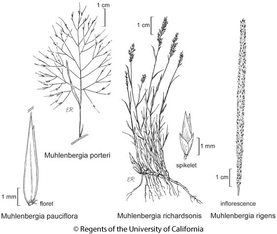 Un progetto di flora cooperativa A suscitare l'interesse dei corrispondenti europei erano soprattutto le nuove specie di briofite, caricacee e graminacee scoperte dal nostro pastore. I suoi invii furono determinanti ad esempio per gli studi sulle felci di Olaf Schwartz. A capire pienamente il valore delle sue ricerche fu però soprattutto Willdenow, il direttore dell'Orto botanico di Berlino, che nel 1801 pubblicò negli annali della Società di scienze naturali una serie di osservazioni di Muhlenberg sui generi Juglans, Fraxinus e Quercus, accompagnati dalle proprie descrizioni e note in latino: in tal modo, queste denominazioni di Muhlenberg, a differenza di quelle della lista del 1791, prive di descrizioni, risultano pienamente valide e sono entrate nella tassonomia botanica. Nel 1803 seguì un altro saggio sui salici. Numerose sono poi le specie segnalate da Muhlenberg pubblicate da Willdenow nella sesta edizione di Species plantarum (1798-1826) , tra cui numerosi carici. La fama e il prestigio di Muhlenberg in Europa è testimoniata anche dalla visita che gli fecero Humboldt e Bompland nel 1804, al ritorno dal loro viaggio in Sud America. Se nella prima parte della sua vita, la rete di corrispondenti di Muhlenberg includeva soprattutto studiosi europei, dopo l'indipendenza divennero sempre più numerosi gli americani, nell'ambito di un grande progetto che egli riuscì solo in parte a realizzare. In un discorso letto nel febbraio 1791 alla American Philosophical Society propugnò una Flora della nuova nazione che avrebbe dovuto nascere non dal lavoro di un singolo, geniale, studioso, ma dalla collaborazione di molti raccoglitori e uomini di scienza: "Ripeto il desidero che ho già espresso: alcuni connazionali istruiti dovrebbero unirsi nelle ricerche botaniche, e spedire alla nostra Società le loro Flore per essere esaminate e eventualmente pubblicate; in tal modo, dall'unione delle Flore di ciascun stato, potremmo avere una Flora degli Stati Uniti, basata su osservazioni valide e certe". Raccolse qualche adesione: tra le più entusiastiche, quelle di un altro pastore, Manasseh Cutler, che contribuì con le sue ricerche in varie aree del New England; William Baldwin, con raccolte in Georgia e Florida; Stephen Elliott, che contribuì per la Virginia occidentale. Ma, in generale, l'intuizione precorritrice di Muhlenberg cadde nel vuoto, mentre si moltiplicavano le flore scritte da botanici stranieri come Michaux, Pursh e Nuttall, in uno spirito di accesa competizione e di ricerca di gloria personale totalmente opposto al sogno "cooperativo" di Muhlenberg. Fu questa situazione, infine, a deciderlo a uscire dal riserbo e a pubblicare egli stesso Catalogus Plantarum Americae Septentrionalis or A catalogue of hitherto known native and naturalizes plants of North America, che include 3780 specie, raccolte grazie al contributo di 28 corrispondenti (scrupolosamente elencati nella prefazione). Nella speranza che mani più forti e abili delle sue, come ebbe a scrivere a Baldwin, completassero il lavoro, si tratta ancora una volta di una lista molto succinta, in cui utilizzò solo in parte il tesoro delle sue annotazioni botaniche, rimaste manoscritte. Unica eccezione, la parte dedicata alle amate graminacee e caricacee, pubblicata postuma dal figlio Frederick August in Descriptio Uberior Graminum et Plantarum Calamariarum Americae Septentrionalis Indiginarum et Cicurum (1817), un'opera di grande importanza storica perché numerose piante native vi vengono descritte per la prima volta. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Le nuvole rosa di Muhlenbergia Dipinto dai suoi contemporanei come un uomo amabile, ospitale, generoso, pieno di humor e calda simpatia (tratti evidenti anche ai nostri occhi grazie alle sue numerosissime lettere), benché abbia pubblicato così poco Muhlenberg fu riconosciuto già dai contemporanei come il vero padre della botanica americana, salutata da Baldwin come "il Linneo del nostro paese". Non mancarono dunque i riconoscimenti: numerosi botanici, tra cui Elliott, Gray, Torrey, Grisebach e Schwarz, gli dedicarono almeno una specie e Schreber, il suo primo corrispondente tedesco, battezzò in suo onore Muhlenbergia un genere di Poaceae (1789), omaggio adattissimo a questo grande esperto di erbe. Questo grande genere di graminacee comprende circa 150 specie di erbe diffuse in Asia e nel continente americano, soprattutto nel Stati Uniti sudoccidentali e in Messico. Molte delle numerose specie nordamericane hanno grande importanza ecologica come specie dominanti di praterie e pascoli montani. Native per lo più di ambienti desertici e semidesertici, sono piante poco esigenti che si adattano a suoli poveri e alla siccità, caratteristiche che, unite al notevole impatto estetico durante la fioritura, le stanno rendendo sempre più popolari nei giardini. Da noi la specie più nota è sicuramente la vistosa M. capillaris, caratterizzata da aeree infiorescenze che a fine estate e a inizio d'autunno la trasformano in una nuvola rosa, purtroppo non del tutto rustica; altre acquisizioni più recenti che stanno raggiungendo anche i nostri giardini sono M. reverchonii, più piccola e meno vistosa della precedente, ma anche più rustica; M. lindheimeri con fogliame verde azzurro e una fontana di spighe verde-argento, decorativa anche in inverno per i semi persistenti; M. dumosa con fusti eretti e finemente ramificati che la fanno assomigliare a un bambù, tanto che in America è detta Bamboo muhly. Muhly è infatti l'affettuoso nomignolo con cui le specie di questo genere sono note negli Stati Uniti. Altre specie sono presentate nella scheda. Alla fine, le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark non furono pubblicate né da B.S. Barton né da nessun altro botanico americano, ma in Inghilterra dal tedesco Frederick Pursh (nato Friedrich Pursch). Uno smacco per l'orgoglio nazionale degli Stati Uniti, appena usciti malconci dalla guerra del 1812 contro la perfida Albione. Insieme alla rivalità con altri botanici, primo fra tutti Thomas Nuttal, sta forse qui l'origine della leggenda nera che ha dipinto Pursh come mentitore seriale, plagiario, tassonomista mediocre e temerario, barbaro dalle fattezze tartare e, soprattutto, ubriacone senza speranza. Sicuramente la sua fu una vita inquieta e errabonda, conclusa precocemente nella miseria e nell'alcolismo. Rimangono a ricordarlo Flora Americae Septentrionalis, la prima flora del Nord America a comprendere specie continentali, raddoppiando il numero delle piante nordamericane fino ad allora pubblicate, e il genere Purshia, coraggioso e splendido ornamento dei monti e dei deserti del Nord America occidentale, il cui primo esemplare, ancora una volta, fu raccolto durante la spedizione di Lewis e Clark. Può essere ironico che, a celebrare un uomo accusato di essere troppo dedito alla birra, siano piante che non temono gli ambienti più aridi.  Un inquieto botanico di talento Le vicende americane di Fredrick Pursh si intrecciano continuamente con quelle dei diversi personaggi che, in vario modo, ebbero a che fare con le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark: Thomas Hamilton, Bernard McMahon, il professor Barton, lo stesso Lewis. E alla fine fu proprio lui a pubblicarle per primo, nei due volumi di Flora Americae Septentrionalis, usciti a Londra tra la fine del 1813 e l'inizio del 1814. Tedesco, era nato a Großenhain in Sassonia nel 1774 con il nome di Friedrich Trauttgott Pursch; si era poi trasferito a Dresda, come apprendista giardiniere del Reale orto botanico, dove aveva ricevuto ottime basi teoriche da Johann Heinrich Seidel. La collaborazione a una flora dei dintorni della città gli permise di acquisire anche qualche esperienza editoriale. Spirito inquieto e avventuroso, nel 1799 lasciò la Germania per gli Stati Uniti, dove servì successivamente come giardiniere presso diversi privati tra Baltimora e Filadelfia. Nel 1803 Thomas Hamilton lo assunse come giardiniere capo di Woodlands, in sostituzione di John Lyon. Poté così conoscere i numerosi naturalisti e botanici che frequentavano la casa, tra cui Henry Muhlenberg, William Bartram e Benjamin Smith Barton; desideroso di liberarsi del lavoro nelle aiuole per dedicarsi completamente all'esplorazione e allo studio delle piante, nel 1805 lasciò anche Hamilton per passare al servizio di Barton, come curatore dell'erbario e raccoglitore. Per suo conto, intraprese infatti alcune spedizioni, in cui si mosse a piedi, con la sola compagnia di un cane, la prima delle quali, tra aprile e novembre 1806, lo portò in Virginia e sulle montagne tra le Caroline e la Georgia. Nel frattempo, a Filadelfia incominciavano ad arrivare le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark, gli essiccata affidati per volontà del presidente Jefferson alla American Philosophical Society in vista della pubblicazione da parte di Barton, e i semi a Hamilton e McMahon. Ma il lavoro di Barton, secondo la sua abitudine di molto progettare e poco concludere, non faceva alcun progresso. Fu così che, probabilmente dietro suggerimento di McMahon, nell'aprile 1807 Lewis incontrò Pursh e, impressionato dalla sua competenza, gli chiese di illustrare le "sue" piante, dietro il compenso di 60 dollari. Poco dopo, Pursh partì per la sua seconda escursione botanica, che lo portò sulle montagne tra Pennsylvania e Vermont in direzione dei grandi laghi. Di ritorno a Filadelfia a ottobre, si stabilì a casa di McMahon e lavorò tutto l'inverno ai disegni, e presumibilmente anche alle descrizioni, visto che da parte del professor Barton, che avrebbe dovuto occuparsene, non si registrava alcun progresso. Lo scontento di Pursh verso il dilatorio professore cresceva. Nel 1809, probabilmente anche in questo caso grazie alla raccomandazione di McMahon, fu assunto come curatore dell'Elgin Botanical Garden di New York, appena fondato da David Hosack. Lasciando Filadelfia, portò con sé i disegni, le descrizioni e i doppioni dell'erbario della spedizione (compreso qualche esemplare che aveva "sezionato" per avere un proprio campione), forse già con l'intenzione di pubblicare le piante in proprio, decisione probabilmente rafforzata dalla tragica morte di Lewis, avvenuta nell'ottobre 1809. Neppure a New York il nostro inquieto botanico si trattenne a lungo; nel 1810 visitò le Indie Occidentali, anche per ragioni di salute, e nel 1811, viste anche le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Gran Bretagna, che sarebbero sfociate nella guerra del 1812, partì per Londra. A spingerlo a questo passo, oltre alla speranza di trovare uno sponsor e un editore, la possibilità di consultare le biblioteche e gli erbari di numerosi botanici che avevano esplorato la flora nordamericana prima di lui. Nella capitale inglese Pursh trovò il protettore che cercava nella persona di Aylmer Bourke Lambert, vicepresidente della Linnean Society, grande collezionista di erbari e esperto di conifere (il suo nome è ricordato da Pinus lambertina). Dunque, con grande smacco dei botanici americani, le piante della grande spedizione "nazionale" di Lewis e Clark furono finalmente pubblicate a Londra da un tedesco. Prima di esaminare meglio Flora Americae Septentrionalis, un cenno alle successive vicende di Pursh. L'opera gli procurò una certa fama almeno in Inghilterra, se subito dopo gli venne affidata la cura dei cataloghi di alcuni giardini botanici; ma egli non era tipo da accontentarsi di un tranquillo lavoro editoriale. Desiderava ripartire e riprendere la ricerca sul campo. Nel 1814 respinse l'invito a dirigere il neo istituito orto botanico dell'Università di Yale; nel 1816 accettò invece quello di lord Selkirk di aggregarsi come botanico al nuovo insediamento del Red River in Canada. Partito dall'Inghilterra nel febbraio di quell'anno, si trovava già in Canada quando il progetto fallì in seguito all'assassinio del capo della spedizione, Robert Semple. Nei quattro anni che gli restavano da vivere, povero, senza alcun sostegno ufficiale e afflitto da problemi crescenti di alcoolismo, Pursh fece diverse escursioni botaniche nel paese, in particolare nel bacino del San Lorenzo e nell'isola di Anticosti, con l'intenzione di scrivere una flora del Canada. Aveva già raccolto circa 1000 esemplari, quando tutta la sua collezione fu distrutta in un incendio. Era l'ultimo colpo alle sue speranze. Morì a Montreal, ad appena 46 anni. Una sintesi di questa vita inquieta nella sezione biografie.  Un'opera importante e molte polemiche Arrivato a Londra presumibilmente nel novembre 1811, ospite di Lambert, Pursh si mise immediatamente al lavoro. Già nel febbraio 1812 scrisse a James Edward Smith, proponendogli di pubblicare sulle Transactions della Linnean Society una relazione sulle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Con l'incoraggiamento di Lambert, che gli fece aprire le porte delle biblioteche e delle collezioni di Banks e Smith, il progetto si ampliò a una flora dell'America settentrionale. Con una certa disinvoltura, senza il permesso dei raccoglitori, Pursh incominciò ad includervi non solo le specie di Lewis e Clark e quelle raccolte da lui stesso nel corso delle escursioni fatte al servizio di Barton e Hosack, ma anche le piante di cui era venuto a conoscenza grazie alla liberalità di Muhlenberg e di altri amici con i quali aveva erborizzato (senza né citarli né ringraziarli). Una disinvoltura che spiacque allo stesso Smith, il quale, a quanto pare, quando seppe in che modo Pursh era venuto in possesso degli esemplari raccolti da Lewis e Clark, non solo rifiutò di pubblicarli, ma evitò di venire a trovarsi nella stessa stanza con lui. Nella primavera del 1812, Pursh incontrò Nuttall, suo successore come raccoglitore di Barton, che gli mostrò le sue collezioni. Inoltre, in seguito a complesse circostanze, erano pervenuti a Lambert i duplicati delle collezioni dell'inglese John Bradbury, che nel 1811 aveva raccolto insieme a Nuttall lungo il fiume Missouri e poi da solo oltre Fort Mandan. Senza il permesso dell'autore (intrappolato dalla guerra negli Stati Uniti), Pursh decise di includere nella sua opera un'appendice con quaranta piante inedite raccolte da Bradbury. Anche Nuttall si lamentò in tal senso; tuttavia, poiché egli aveva ripercorso parte dell'itinerario di Lewis e Clark, raccogliendo le stesse piante, questa accusa è forse infondata. Tramontata la possibilità di pubblicare il suo lavoro sulle Transactions, Pursh si rivolse al Botanical Magazine, un mensile con il quale collaboravano sia lui sia Nuttall, in quella che divenne quasi una gara per la primogenitura. I due volumi di Flora Americae Septentrionalis uscirono ufficialmente il 10 gennaio 1814, ma poiché la stampa era stata completata qualche settimana prima, già a dicembre alcune copie vennero distribuite a personaggi influenti in vista della presentazione nella riunione mensile della Linnean Society. L'opera contiene la descrizione di 470 generi e 3076 specie, cui va aggiunto il supplemento con le 40 specie di Bradbury; tra di esse, quelle raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark sono 132; solo 24 sono illustrate da disegni eseguiti dallo stesso Pursh a Filadelfia. Benché preceduta di pochi anni da Flora Boreali-Americana di André Michaux (1803) e seguita quasi immediatamente da The Genera of North American Plants di Thomas Nuttall (1818), l'opera di Pursh riveste una notevole importanza storica. Rispetto alla flora del francese, che rendeva conto delle piante degli Stati atlantici, allarga il campo a molte specie continentali, sia delle Montagne rocciose sia della costa pacifica; inoltre la precedenza cronologica rispetto a Nuttall ha imposto molte delle sue denominazioni. Tra i generi da lui creati, vorrei ricordare Calochortus e soprattutto Lewisia e Clarkia, in onore dei due capi della celebre spedizione; tra le specie, Gaillardia aristata, Arbutus menziesii, Gaultheria shallon, Euphorbia marginata, Ribes sanguineum, Philadelphus lewisii, Linum lewisii. Inutile dire che i botanici americani non la presero affatto bene. Tra i più drastici, Constatine Samuel Rafinesque che nella sua recensione del 1819 segnalò 43 errori macroscopici e così si espresse: "L'ignoranza presiede tutta l'opera. Gli errori, gli spropositi, le denominazioni improprie che la costellano sono innumerevoli. Cambiare un nome buono con uno cattivo è un'assurda temerarietà. Eppure a tale temerarietà inclina Mr. Pursh; vorrei però avvisare tanto lui quanto chi volesse seguire la sua autorità, che sarebbe meglio tornasse a scuola, e imparasse l'abc della botanica, come fanno i bambini quando imparano l'alfabeto". Non mancarono dicerie sulla persona stessa di Pursh; già Barton aveva diffuso la fama della sua propensione all'alcool. John Francis, un amico di Hosack che soggiornò a Londra negli anni in cui vi viveva Pursh, disse di lui: "E' il peggiore nemico di sé stesso: è ubriaco al mattino, a mezzogiorno e alla sera". Un aneddoto, probabilmente falso, vuole che, per vedere Flora Americae septentrionalis finita, Lambert fosse costretto a chiuderlo a chiave nell'attico che gli aveva messo a disposizione con gli esemplari, libri, carta, inchiostro, cibo e birra. Un altro contemporaneo che lo incontrò a Montreal lo descrisse come un uomo brillante, sicuramente entusiasta della botanica, ma incolto, tagliato con l'accetta, con fattezze tartare, un barbaro nativo della Russia (una diceria che dovette essere diffusa, se si pensa che nei necrologi usciti in Canada è definito "il celebre botanico Frederick Pursh, nato in Russia").  Purshia, rose dei deserti Tra le piante della spedizione di Lewis e Clark, Pursh descrisse un arbusto raccolto lungo il Columbia River come Tigarea tridentata. Nel 1816, de Candolle riconobbe la sua appartenenza a un genere proprio, che battezzò Purshia in onore del nostro discusso botanico, la cui opera, al di là dei metodi disinvolti e degli innegabili errori, fu comunque una pietra miliare nella storia della botanica americana. Lo dimostrano anche le successive dediche di un genere Purshia da parte di due botanici tedeschi, Sprengel (1817) e Dennstedt (1818). A essere valido, per la regola della priorità, è quello di de Candolle. Purshia DC. della famiglia Rosaceae comprende 5-8 specie di arbusti endemici dell'America nordoccidentale, dal British Columbia in Canada al Messico settentrionale. Crescono in ambienti aridi sia di montagna sia delle steppe desertiche temperate. Sono arbusti o anche piccoli alberi con foglie piccole, profondamente lobate, e fiori molto decorativi con cinque petali più o meno separati bianchi, gialli o rosa e vistosi stami gialli. I frutti sono acheni piumati, che vengono facilmente dispersi dal vento. Molto resistenti alla siccità e adattabili ai suoli poveri grazie ai noduli sulle radici che ospitano i batteri azoto-fissatori Frankia, sono piante pioniere, spesso con un ruolo di specie dominante. Il genere oggi comprende anche le specie meridionali un tempo incluse in Cowania. La specie a più ampia diffusione è quella descritta da Pursh, Purshia tridentata, una specie montana con delicati fiori giallo pallido che può diventare un alberello alto fino a cinque metri. Il nome inglese antelope bush, antelope bitterbush sottolinea la sua importanza nell'alimentazione di Antilocapra americana e altri ungulati. Le radici amare erano usate dai nativi come medicinale, mentre dai semi veniva ricavata una tintura violacea. Di notevole importanza ecologica anche Purshia stansburyana, nativa dell'Ariziona e del Messico settentrionale, le cui fronde forniscono un'eccellente pastura a molti ungulati selvatici, inclusi alce, cervo mulo e bighorn del deserto. I suoi fiori bianchi dai grandi petali la fanno assomigliare a una rosellina; poiché il suo habitat preferito sono le rocce, su cui si abbarbica grazie alle profonde radici, è infatti detta cliffrose. Stansbury's cliffrose. Ulteriori informazioni sulle altre specie nella scheda. Subito dopo l'indipendenza, il più bel giardino d'America era Woodlands, alla periferia di Filadelfia, creato dal ricco proprietario terriero e collezionista d'arte William Hamilton che, a quanto pare, vi faceva coltivare circa 10.000 specie tra native ed esotiche. Jefferson, che ammirava Woodlands e lo considerava il solo giardino al di qua dell'Oceano a poter competere con quelli britannici, volle che nelle sue aiuole e nelle sue serre venisse coltivata e moltiplicata una parte delle piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Il nostro protagonista, tuttavia, non è Hamilton (gli furono dedicati ben tre generi, ma nessuno oggi valido), bensì il sovrintendente di Woodlands, il giardiniere scozzese John Lyon, che, dopo qualche anno trascorso a lavorare qui, si trasformò in un infaticabile cacciatore di piante indipendente, al quale Aiton in Hortus Kewensis attribuisce l'introduzione in Europa di oltre trenta specie. Tra le più note oggi, Phlox paniculata e Pieris floribunda. Assai affine a Pieris è Lyonia (Ericaceae), il genere che ne preserva il ricordo.  Dalle aiuole alle montagne del Nord America Al ritorno da un viaggio in Europa, in gran parte dedicato a visitare parchi e giardini britannici, il facoltoso proprietario terriero e collezionista William Hamilton (1749-1813) decise di far ricostruire la casa padronale della tenuta di Woodlands, nei pressi di Filadelfia, secondo lo stile di Adam; anche il parco venne ridisegnato secondo i canoni del giardino paesaggistico d'oltre Oceano. In pochi anni, le collezioni di piante, native o fatte venire dall'Europa, dall'Asia e dal Sud Africa, giunsero a comprendere diecimila specie. Nel 1807 Jefferson, grande ammiratore di Hamilton (Woodlands sarà uno dei modelli di Monticello), chiese a McMahon, cui aveva affidato i semi raccolti durante la spedizione di Lewis e Clark, di dividerli equamente con lui, per aumentare le possibilità di riuscita, vista l'esperienza e i mezzi di Hamilton. Quest'ultimo, del resto, era già in relazione con i due esploratori, che nel 1804 gli avevano inviato da Fort Mandan alcune talee di Maclura pomifera (arancio degli Osagi). Sappiamo che Hamilton ricevette i semi di almeno 19 specie, che includevano diverse varietà di Ribes e il tabacco selvatico Nicotiana quadrivalvis. Un anno dopo, egli informava il presidente che non tutti i semi erano germogliati, mentre le piante di Maclura prosperavano. Dopo la morte di Hamilton, quella magnifica collezione andò rapidamente in rovina; una parte del parco fu venduta dagli eredi e intorno al 1840 molto di ciò che rimaneva venne trasformato in un cimitero rurale; è un luogo affascinante e caro ai cittadini di Filadelfia, ma certo molto diverso rispetto ai suoi anni d'oro. Molte informazioni sulla sua storia in questo sito. Ma il nostro protagonista non è Hamilton; certamente questo patrono dei giardini attirò l'attenzione dei botanici che gli dedicarono ben tre generi Hamiltonia: nel 1806 il conterraneo Muhlenberg, nel 1824 Roxburgh, nel 1838 Harvey; nessuno dei tre oggi è però valido. Dunque la nostra attenzione si sposta su una figura forse più interessante, e sicuramente più simpatica: il sovrintendente, o capo giardiniere, di Woodlands, lo scozzese John Lyon. Nulla sappiamo della sua vita prima che fosse assunto da Hamilton nel 1785; ignoriamo persino se si trovasse già in America, o se abbia incontrato il futuro datore di lavoro in patria. Ci mancano notizie anche sul primo decennio trascorso a lavorare a Woodlands; la nostra principale fonte informativa è infatti il suo diario di campo, che inizia nel 1799. E' probabile che in quei sedici anni egli già affiancasse alla cura del giardino - di cui fu evidentemente il principale realizzatore - escursioni nei dintorni, per incrementare le collezioni di piante native. Il primo viaggio documentato è proprio di quell'anno, quando Hamilton lo inviò sugli Allegheny della Pennsylvania alla ricerca di Pyrularia pubera, una pianta emiparassita con semi oleosi e tossici di potenziale interesse farmacologico, che il collezionista non era riuscito fino ad allora a far germinare. La spedizione si concluse con un nulla di fatto. E' possibile che già allora Lyon mordesse il freno; preparato, intelligente, industrioso e di spirito indipendente, incominciava a sentirsi soffocare al servizio di un uomo arrogante, esigente e imperioso, tanto più che la figura sociale del capo giardiniere in America non godeva della stessa considerazione sociale che forse aveva potuto sperimentare in patria. A partire dal 1802, e per i successivi dodici anni, non avrebbe mai cessato di viaggiare, dapprima per conto di Hamilton, poi in proprio. Erano viaggi faticosi e pieni di insidie, in zone spesso poco conosciute e non segnate sulle carte. Lyon si muoveva a cavallo, alloggiava talvolta all'aperto, ma più spesso in locande o presso case ospitali; portava con sé provviste minime, carta per gli esemplari pressati, mentre le collezioni di radici e semi andavano crescendo. Gli incidenti non mancarono: fu morso da un cane rabbioso e dovette curare da sé la ferita infetta cauterizzandola con un ferro rovente; si intossicò gravemente raccogliendo semi del velenoso Rhus michauxii; affrontò una bufera così forte da abbattere gli alberi; perse più volte il cavallo. Viaggiava per lo più da solo, ma spesso faceva tappa presso altri botanici o appassionati, che talvolta gli facevano da guida o lo accompagnavano per qualche tratto. I suoi viaggi, in tutto dieci, lo portarono ad esplorare buona parte degli Stati centrali e meridionali dell'America atlantica, in particolare, oltre alla Pennsylvania e alla Virginia, le due Caroline, la Georgia e la Florida settentrionale, con una predilezione per le montagne che fanno da confine tra North Carolina e Tennessee; solo un viaggio lo portò a Nord, verso i grandi laghi. Tra i luoghi ricorrenti, dove si fermava presso amici, cui spesso affidava le sue raccolte o preparava i materiali per le spedizioni, Silk Hope, in North Carolina, dove abitava l'amico Stephen Elliott, che fu anche suo compagno di viaggio in diverse occasioni; le città portuali di Savannah in Georgia e Charleston nella Carolina del Sud, da dove spediva per nave a Filadelfia le sue raccolte; Nashville e Asheville, rispettivamente in Tennessee e North Carolina, punto di partenza per l'esplorazione delle amate montagne; Lancaster, tappa obbligata sulla via del ritorno per visitare l'amico Henry Muhlenberg. Le spedizioni più ampie e importanti sono probabilmente quelle del 1803-1804 e del 1807. Durante la prima Lyon percorse 2250 miglia, giungendo fino in Florida e esplorando anche, oltre a diverse aree montane, buona parte della costa e delle isole della Georgia. Proprio durante questo viaggio, nel 1803, fu l'ultima persona a vedere in natura alcuni esemplari di Franklinia alatamaha (e potrebbe avere qualche responsabilità nella sua estinzione). Durante la seconda, percorse 2500 miglia, muovendosi lungo le montagne sui confini tra North Carolina e Tennessee (dove sarebbe tornato altre volte e sarebbe morto); tra i suoi ospiti, la colonia morava della Cherokee Country, e tra gli incontri notevoli, quelli con Moses Fisk, pioniere degli insediamenti nel Tennessee, e con il pastore e botanico Samuel Gottlieb Kramsch. Una narrazione più dettagliata dei suoi viaggi nella vita. 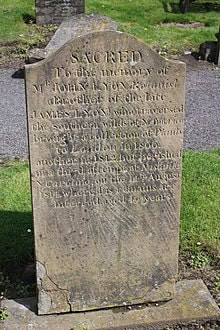 Collezioni di piante e spirito imprenditoriale Lyon è una figura interessante anche perché si distacca dagli altri cacciatori di piante per la sua indipendenza e intraprendenza. Mentre i suoi colleghi erano finanziati da sovrani, istituzioni pubbliche, mecenati oppure, sempre più spesso, lavoravano per qualche ditta commerciale, Lyon era un libero professionista che si assumeva le spese e i rischi e provvedeva da sé alla vendita delle sue raccolte. Probabilmente lasciò Hamilton (per il quale tornò a lavorare occasionalmente anche in seguito, ma solo come giardiniere) nella seconda metà del 1803; nel frattempo era stato sostituito con Frederick Pursh. Da quel momento, Lyon prese a creare una propria collezione, con l'obiettivo di commercializzarla in Inghilterra. In natura raccoglieva piante vive (in quantità che a noi fanno accapponare la pelle, come le 200 radici di Podophyllum di cui fece incetta nel 1804 in Georgia), ma ancora più semi; questi ultimi erano destinati alla vendita, ma anche alla riproduzione. In effetti, alla fine del 1804 il giardiniere avrebbe voluto imbarcarsi per l'Inghilterra, ma non trovando un imbarco si fermò a Filadelfia per quasi un anno, dedicato a seminare e curare le plantule da portare con sé in patria. A tal fine, si appoggiò al vivaista David Landreth (fondatore nel 1784 della più antica ditta sementiera statunitense), da cui affittò una parte del vivaio. Alla fine del 1805 Lyon poté finalmente imbarcarsi per Londra, via Dublino. Nella capitale inglese dimostrò ottime capacità imprenditoriali; per vendere le sue piante, si affidò non solo a una clientela privata, ma a un'asta pubblica, pubblicizzata con annunci su sette giornali e con la stampa di un catalogo, in cui le piante nuove (sp. nova!) sono ben evidenziate. Forte di questo successo, ritornò subito in America, dove investì i guadagni in nuovi viaggi, che si mossero principalmente lungo le predilette montagne tra North Carolina e Tennessee. Dopo cinque anni di fatiche aveva creato una seconda, ancora più ricca, collezione, che portò con sé in Inghilterra nell'inverno 1811-12. La clientela inglese fu impressionata dalla qualità e dalla quantità dell'offerta, anche questa volta venduta con un'asta pubblica (ce n'è rimasto il catalogo). L'infaticabile Lyon tornò quasi immediatamente in America, dove fece ancora due viaggi nei luoghi prediletti; ammalatosi probabilmente di febbre gialla, si spense a Asheville (North Carolina) nel 1814. Non conosciamo il luogo della sua sepoltura, ma i parenti gli eressero una lapide nel cimitero di Dundee, dove è ancora conservata. Nelle testimonianze dei contemporanei, l'importanza del suo contributo all'introduzione delle specie americane in Europa appare imponente. Secondo la seconda edizione di Hortus Kewensis, redatto da William T. Aiton, le specie nuove messe in vendita nel 1806 e nel 1812 sono 31; spesso non si tratta davvero di novità (molte erano già arrivate in Europa, in particolare grazie ai Michaux che avevano raccolto nelle stesse aree), ma piuttosto di reintroduzioni, rese però disponibili da Lyon in modo ben più massiccio. Nell'elenco figurano tra l'altro (uso le denominazioni attuali) Desmanthus illinoensis, Amsonia tabernemontana var. salicifolia, Asclepias pedicellata, Calycanthus floridus var. glaucus, Dicentra eximia, Hamamelis virginiana, Iris fulva, Cliftonia monophylla, Calycocarpum lyonii, Tradescantia subaspera. Ho lasciato volutamente per ultime le introduzioni più importanti e durature: Phlox paniculata, Pieris floribunda e Magnolia macrophylla (ma potrebbe trattarsi di una specie affine che vive nelle stesse aree, Magnolia fraseri var. pyramidata). Entrambe sono oggi considerate relativamente rare in natura, forse anche a causa del contributo di Lyon, che nel suo viaggio del 1809 in North Carolina ne raccolse ben 3600 esemplari. Amabile Lyonia
In questo atteggiamento predatorio verso la natura, Lyon era un figlio del suo tempo, e lo perdoneremo, tanto più che, come abbiamo visto, pagò di persona il suo accanimento di cacciatore di piante indipendente con la fatica, le malattie, la solitudine e infine con la morte precoce. La puntigliosa registrazione delle entrate e delle uscite annotata nel diario ci dice anche che, se la sua impresa non fu in perdita, neppure gli assicurò un largo guadagno. Come al suo datore di lavoro, anche a lui furono dedicati tre omonimi generi Lyonia; nel 1808 da Rafinesque; nel 1817 dall'amico Elliott; nel 1818 da Nuttall. Per una volta ad essere accettato da botanici è il più recente. Questa la dedica: "Per commemorare il nome del fu Mr. John Lyon, un raccoglitore infaticabile del Nord America, che cadde vittima di un'epidemia perniciosa in mezzo a quelle montagne selvagge e romantiche che erano state tanto spesso teatro delle sue fatiche". Numerose sono poi le specie che lo ricordano nel nome specifico, come Chelone lyonii o Rosa carolina var. lyonii. Lyonia Nutt. (famiglia Ericaceae) comprende circa 35 specie di piccoli alberi o arbusti diffusi nelle boscaglie dell'area himalayana, in Asia orientale, nel Nord America e nelle Antille. E' molto affine a Pieris, in cui in passato è anche confluito (oggi studi molecolari ne confermano l'indipendenza). Decidue o sempreverdi, le piante di questo genere hanno foglie alternate, intere, coriacee e lucide e graziosi fiori penduli tubolari o a forma di urna raccolti in racemi terminali, solitamente bianchi. Tra le specie americane vale la pena di ricordare L. ligustrina, nativa degli Stati Uniti orientali dal Maine alla Florida, notevolmente adattabile ad ambienti diversi e capace, grazie ai rizomi, di resistere agli incendi (molto frequenti nelle pinete in cui vive abitualmente); L. mariana, sempre degli Stati Uniti orientali, usata dai Cherokee come pianta medicinale, e oggi minacciata in Pennsylvania e Connecticut; L. lucida, la specie più nota e diffusa, raccolta anche da Lyon, presente nelle pianure costiere degli Stati Uniti orientali dalla Virginia alla Florida e alla Louisiana e nell'isola di Cuba, con graziosi fiori penduli cilindrici portati su rami arcuati, bianchi, ma anche rosa o rossi. Sono tutti arbusti, mentre può diventare un vero albero l'asiatica L. ovalifolia, diffusa nell'India himalayana, in Cina e in Giappone. Una curiosità: un tempo Lyonia viveva anche in Europa. Alcuni frutti fossili di †Lyonia danica, attribuiti al Miocene medio, sono stati infatti trovati nello Jutland centrale (Danimarca). Qualche approfondimento nella scheda. Acquisita l'indipendenza politica, gli Stati Uniti incominciano ad emanciparsi dal passato coloniale anche sul piano culturale e scientifico. Nel campo delle scienze naturali, figura chiave di questo momento di passaggio tra una scienza ancora eurocentrica e una scienza autenticamente americana è Benjamin Smith Barton, titolare della prima cattedra statunitense di botanica e scienze naturali; autore del primo manuale di botanica, Elements of Botany; istruttore di Lewis in preparazione della grande spedizione nel Nord Ovest; finanziatore dei viaggi botanici di Pursh e Nuttall. Dunque un padre fondatore a tutti gli effetti; ma anche una figura controversa, con una biografia segnata da vicende poco chiare, promesse mancate, opere annunciate e mai finite, senza parlare del pessimo carattere. Ambizioso e desideroso di gloria, nei suoi ultimi giorni provò conforto nel pensare che la sua memoria sarebbe stata preservata dal nome di una delle più belle specie delle praterie americane; la regola della priorità l'ha invece legato per sempre a un'altra Bartonia, una pianta minuscola e insignificante, in una sorta di giustizia poetica. 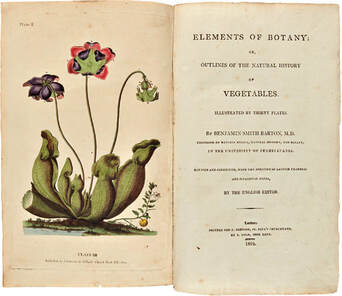 Un padre fondatore delle scienze naturali americane... I primi passi della scoperta della natura dei territori che diverranno gli Stati Uniti d'America si muovono in un'ottica ancora coloniale; europei sono i primi esploratori (come John Tradescant e John Clayton); quando John Bartram inizia i suoi viaggi, lo fa per soddisfare le esigenze di clienti britannici; ancora nei primi anni dell'indipendenza, il massimo protagonista dell'esplorazione botanica dell'America atlantica sarà il francese André Michaux. Europei erano anche i modelli teorici (prima quello di Linneo, poi quello di Jussieu) e i libri di testo, tutti regolarmente importati dal vecchio continente. Ma anche la scienza americana era desiderosa di emanciparsi e di acquistare la sua indipendenza; un processo di cui senza dubbio una delle figure chiave è Benjamin Smith Barton, titolare della prima cattedra universitaria di botanica degli Stati Uniti e autore del primo manuale di botanica, Elements of Botany, consulente di Jefferson che gli chiederà di istruire sulla natura e sui nativi il capitano Lewis, in preparazione della prima autentica spedizione naturalistica americana. Nel 1803, quando incontrò Lewis, Barton aveva appena pubblicato il suo manuale e, a soli trentasette anni, poteva già vantare una brillante carriera accademica. Gli inizi, tuttavia, era stati quanto meno imbarazzanti. Proveniente da una famiglia che vantava altri naturalisti (i più noti sono lo zio materno David Rittenhouse, eminente astronomo, e William P.C. Barton, anch'egli botanico e autore di Flora of North America), dopo aver seguito i corsi di medicina a Filadelfia, nel 1786, quando era appena ventenne, si spostò a Edimburgo con l'intenzione di laurearsi in quella prestigiosa università. Ambizioso e brillante, affascinante parlatore, con le sue conversazioni su popoli e piante native americane fu accolto con entusiasmo in quell'ambiente avido di esotismo; fu presto ammesso alla Royal Medical Society, di cui anzi divenne uno dei presidenti annuali, e ottenne un premio per un articolo sul giusquiamo nero (Hyosciamus niger); tuttavia dopo due anni, senza aver conseguito la laurea, lasciò precipitosamente la città. Secondo la vulgata familiare, era entrato in conflitto con alcuni insegnanti; visto il suo carattere ombroso, è più che possibile, ma a spingerlo alla fuga fu un prestito da parte della Medical Society che non poteva o non voleva onorare. Di lì passò in Germania. Quando nell'autunno del 1789 rientrò in patria senza alcun titolo universitario, si sparse la voce - che Barton non fece nulla per smentire, se non la diffuse egli stesso - che si fosse laureato presso la celebre Università di Gottinga. In ogni caso nei registri della Philosophical Society cui fu ammesso quello stesso anno il suo nome compare seguito dal titolo abusivo di "dottore in medicina". Sempre nel 1789 iniziò a praticare la professione medica e soprattutto gli venne assegnata la cattedra di storia naturale e botanica al Philadelphia College, due materie inedite nel curricolo universitario statunitense; incarico confermato due anni dopo, quando il Philadelphia College si fuse con l'Università di Pennsylvania. Nel 1790 fu ammesso al Collegio medico di Filadelfia; nel 1792 divenne membro dell'American Arts of Science; nel 1796, alla morte del precedente titolare, fu chiamato a reggere anche la cattedra di materia medica. A questo punto, essere privo di un titolo accademico poteva essere assai rischioso, tanto più che contava non pochi nemici; Barton cominciò così a sollecitare i suoi contatti europei per ottenere una laurea honoris causa; alla fine, pochi mesi prima che assumesse l'incarico, il sospirato titolo arrivò da una delle più oscure università tedesche, quella di Kiel. In ogni caso, Barton riuscì ad agire in modo così discreto che questa storia è stata scoperta solo intorno al 1970; fino ad allora, tutti - compresi gli storici - avevano presa per vera la laurea a Gottinga. Nonostante questo esordio fortunoso, Barton divenne presto una figura eminente del naturalismo americano. Come primo insegnante di storia naturale e botanica del suo paese, teneva affollate lezioni cui partecipavano non solo gli studenti di medicina, ma anche un pubblico di curiosi, comprese molte signore, che il professore sapeva affascinare toccando gli aspetti più diversi della natura americana. Divenne la figura centrale di un circolo di naturalisti che comprendeva anche il celebre raccoglitore William Bartram e il botanico Henry Muhlenberg. Anche grazie allo zio, David Rittenhouse, che era succeduto a Franklin come presidente della società, divenne il membro più giovane della American Philosophical Society, di cui poi fu vicepresidente dal 1802 al 1816; della società fu uno dei membri più attivi, pubblicando numerosi articoli che nel 1804 gli guadagnarono il Premio Magellano. Nel 1803 fondò la Philadelphia Linnean Society, di cui fu il primo presidente; dal 1809 alla morte fu anche presidente della Philadelphia Medical Society. Abile gestore della propria fama, seppe anche ingraziarsi i potenti in patria come all'estero. Era in corrispondenza con molti naturalisti europei, tra cui Banks (cui dedicò Elements of Botany); quanto a Jefferson, tra lui e il presidente esisteva un legame speciale da quanto gli aveva dedicato il genere Jeffersonia (come ho raccontato in questo post). Scrisse moltissimo (oltre che di medicina e botanica, di zoologia, mineralogia, geologia, antichità e lingue indiane, di cui fu un grande cultore), soprattutto articoli brevi che pubblicò dapprima nelle Transactions dell'American Philosophical Society, poi in Medical Physical Journal, la rivista medica che fondò e diresse per molti anni. Come ho anticipato all'inizio, nel 1803 uscì la prima edizione della sua opera più nota, Elements of Botany, il primo manuale di botanica scritto negli Stati Uniti, un testo di successo che raggiunse le sei edizioni, tre delle quali durante la vita dell'autore. Importante anche Collections for an Essay towards Materia Medica of the United States, che nella terza edizione (1810) descrive oltre un centinaio di piante officinali native e le loro proprietà mediche. Tra i suoi contributi più interessanti, vale anche la pena di citare A discourse on some of the principal desiderata in natural history: and on the best means of promoting the study of science in United States, letto da Barton nel giugno 1807 alla Linnean Sopciety, in cui tracciò un lucido programma di ricerca per gli scienziati della nuova nazione; per limitarci alla botanica, poneva tra i principali obiettivi lo studio delle crittogame, l'attenzione alla distribuzione geografica delle piante, gli studi comparativi, le acquisizioni dei nativi sulle piante medicinali e alimentari. E' dunque logico che Jefferson abbia inviato proprio a lui Lewis, perché gli aprisse le porte degli studiosi di Filadelfa (cosa che Barton non fece, o fece con riluttanza) e gli impartisse un corso accelerato di botanica e zoologica. Il professore non solo insegnò al capitano come raccogliere, conservare correttamente e etichettare gli esemplari, ma decise che doveva assolutamente partire anche lui, o almeno accompagnare la spedizione per un tratto. A questo punto va detto che egli, come riferisce a denti stretti il nipote e biografo William, soffriva di quello che oggi chiameremmo disturbo bipolare, sempre oscillante tra esaltazione e depressione; a ogni nuova occasione, a ogni nuovo soggetto di ricerca, si entusiasmava e si lanciava in vasti progetti, salvo poi abbandonarli per noia non appena dall'ideazione bisognava passare alla realizzazione concreta. L'idea di partire con Lewis sarà stato dunque un sogno, un fuoco fatuo tipico del suo carattere, che probabilmente egli stesso - un valetudinario cronico che soffriva di tubercolosi e di attacchi invalidanti di gotta - era il primo a non prendere sul serio. Dunque Lewis partì senza Barton, ma portando con sé come sostituito una copia fresca di stampa dei suoi Elements of Botany. Comunque Jefferson contava su di lui per pubblicare i risultati scientifici della spedizione, tanto che egli fu il destinatario del primo invio da Fort Maidan; ma la sospirata Storia naturale della spedizione di Lewis e Clark andò ad allungare la lista delle sue opere "fantasma". 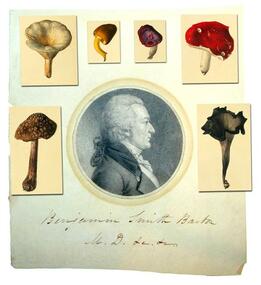 ... con un lato oscuro Dopo aver elencato i successi, il lato luminoso del nostro professore, è infatti venuto il momento di parlare del suo lato oscuro. Quella non fu l'unica opera promessa, ma mai scritta. Egli in effetti fu uno scrittore prolifico, ma farraginoso e prolisso, che dava il meglio di sé in testi brevi; la sua bibliografia è costellata di opere di più ampio respiro annunciate, progettate, a volte iniziate, poi abbandonate. Ma c'è di peggio. Ambizioso e avido di successo, non era sempre corretto verso gli altri ricercatori, tanto da essersi attirato l'accusa di plagio. L'ornitologo Charles Willson Peale lo accusò, probabilmente a torto, di essersi impadronito di alcuni esemplari destinati al suo museo e espresse la convinzione che "non si è mai fatto scrupolo di prendere le penne degli altri per arricchire il suo piumaggio". In effetti, gli studiosi hanno rilevato che non di rado fece passare per proprie idee altrui, senza citare la fonte né aver ottenuto l'autorizzazione dell'autore. A suscitare polemiche fu anche la pubblicazione di Jeffersonia diphylla, che non si basava su ricerche proprie, ma su raccolte di André Michaux e William Bartram. Ancora più criticato fu per la riluttanza a scambiare informazioni e materiali, secondo la secolare consuetudine dei naturalisti; ad esempio Henry Muhlenberg, che pure gli fu amico, lamentava che mentre lui gli aveva mostrato il suo erbario, Barton non aveva mai contraccambiato il favore. D'altra parte, bipolare anche in questo, sappiamo che a volte fu assai generoso con la sua preziosissima biblioteca, la più completa degli Stati Uniti per la storia naturale, prestando ad altri studiosi volumi altrimenti introvabili nel paese. Barton era più un teorico, un botanico da scrivania, che un ricercatore sul campo. Il suo erbario, conservato alla Natural Science Academy di Filadelfia, comprende 1674 esemplari, ma solo circa 200 furono raccolti da lui, per lo più nei pressi della città o della tenuta di famiglia. E' nota una sola spedizione di un certo impegno cui partecipò di persona, da New York fino alle Cascate del Niagara, ma anche in questo caso si dedicò più all'osservazione dei costumi dei nativi che alla raccolta di piante. L'erbario fu dunque messo insieme con acquisti e con il contributo di almeno una trentina di raccoglitori, molti dei quali suoi studenti. L'apporto maggiore (circa 1200 esemplari) tuttavia venne da Federick Pursh che egli assunse nel 1805 perché lo aiutasse a completare il suo maggiore progetto: una flora del Nord America, che avrebbe dovuto includere anche le piante raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark. Probabilmente Barton aveva iniziato a lavorarci subito dopo la pubblicazione di Elements of Botany e nel 1806 ne pubblicò un'anticipazione dal titolo chilometrico: Prodromus of a Flora of the States of New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland and Virginia. Riccamente illustrata dal pittore francese Turpin, fu stampata in 500 copie, ma non se ne è conservata neppure una. Come mai? Fu l'autore stesso a ritirare tutta l'edizione e a farla distruggere. L'ipotesi più probabile è che, lavorando insieme a Pursh, un eccellente tassonomista formatosi in Germania, che catalogò con ammirevole e teutonica precisione il suo erbario, Barton si sia reso conto di aver commesso molti errori e abbia preferito eliminare un'opera che, più che la sua gloria, avrebbe sancito la sua mediocrità di sistematico e tassonomista. L'opera andava riscritta e ampliata. A tal fine finanziò i viaggi di ricerca di Pursh che al suo servizio nel 1805 esplorò le regioni montane della Carolina e della Georgia e nel 1806 le montagne della Pennsylvania e del Vermont. L'anno successivo, di ritorno da una spedizione che lo aveva portato nello stato di New York e ancora nel Vermont, Pursh preferì non rientrare a Filadelfia e accettare l'incarico di curatore dell'orto botanico di New York. In tal modo, recuperava la sua indipendenza scientifica, e si liberava di un "patrono" mai troppo generoso, collerico e probabilmente geloso della sua competenza. Barton, privato del suo principale collaboratore, si trovò impossibilitato a proseguire, finché la dea bendata fece arrivare alla sua porta un giovanotto entusiasta con una pianta da riconoscere. Era il ventiduenne Thomas Nuttall, un apprendista stampatore britannico con la passione per le scienze naturali. Barton, che, colpito dal suo entusiasmo e dalle sue buone maniere, ne fece il suo pupillo, gli insegnò il sistema di Linneo e lo spronò a studiare ed esplorare la natura americana, sull'esempio di William Bartram. Dopo averlo messo alla prova con alcuni brevi viaggi, nel 1810 finanziò la prima grande spedizione di Nuttall fino ai Grandi laghi, con una paga di 8 dollari al mese più le spese; le osservazioni e i quaderni di campo sarebbero stati di esclusiva proprietà di Barton, ma il raccoglitore poteva tenere per sé la propria copia degli esemplari; esattamente il contrario di ciò che avveniva di solito: il finanziatore/collezionista esigeva per sé una o più copia dei materiali, ma il ricercatore manteneva la proprietà intellettuale delle proprie scoperte. Tuttavia anche questa collaborazione finì bruscamente, quando l'imminente scoppio della guerra del 1812 con l'Inghilterra spinse Nuttall a tornare in patria. Del resto, anche le forze di Barton andavano declinando. Morì nel 1815, al rientro da un viaggio in Europa grazie al quale aveva sperato di recuperare la salute. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Termino con una curiosità: la prestigiosa rivista Bartonia, organo del Philadelphia Botanical Club, non è dedicata a lui, ma a suo nipote William Paul Crillon Barton, autore di Compedium Florae Philadelphicae (1818) e A Flora of North America (1821), che dello zio fu allievo, biografo e successore per la cattedra di materia medica.  Bartonia, ovvero botanica e giustizia poetica Tre giorni prima di morire, Barton aveva terminato il suo ultimo articolo, su un argomento che gli era molto caro: una pianta che nel 1812 Sims aveva denominato Bartonia decapetala, sulla base di materiali raccolti da Pursh e da Nuttall. Concordi sulla dedica al loro patrono, il primo, a quanto pare, avrebbe voluto chiamarla B. ornata, il secondo addirittura B. superba. In ogni caso, una pianta magnifica, con spettacolari fiori bianchi che si aprono di notte, che riempiva d'orgoglio il vecchio professore. Ma anche nella botanica c'è una giustizia poetica, che assume le petulanti vesti della legge della priorità. Molti anni prima, Henry Muhlenberg aveva già creato un genere Bartonia, pubblicato nel 1801 con tutti i crismi da Willdenow. Niente di cui andare orgogliosi, ahimè: si tratta di uno dei più insignificanti generi della famiglia Gentinaceae, minuscole annuali erbacee che passano quasi inosservate. Vivono nelle paludi, alcune specie in mezzo allo sfagno, da cui quasi non si distinguono se non durante la fioritura, e, come adattamento a un ambiente così povero di nutrienti, sono emiparassite che si nutrono a spese delle piante vicine, con foglie ridotte a scaglie insufficienti ad assicurare una sufficiente fotosintesi. Muhlenberg ovviamente di questo non poteva sapere nulla (dedicò a Barton B. verna, una specie che avevano raccolto insieme) ma non spiace che a ricordare il troppo vanaglorioso professore, accusato dai detrattori di adornarsi delle penne altrui, sia Bartonia Muhl. ex Willd. e non la più appariscente Bartonia Pursh ex Sims. Il piccolissimo genere comprende tre specie, endemiche degli Stati Uniti orientali. Legate ad ambienti fragili e sempre più ridotti, sono piuttosto rare: B. virginica è inclusa nella lista rossa delle specie a rischio mentre B. paniculata subsp. paniculata in Canada è oggetto di programmi di conservazione. Ancora non del tutto spiegati i meccanismi della sua nutrizione: secondo alcuni studiosi, sono saprofite mentre alcuni studi recenti mostrano evidenze di micorrize che permetterebbero di assorbire i nutrienti dall'apparato radicale delle piante circostanti. Un breve profilo delle tre specie nella scheda. Una trentina di militari, guidati da due capitani, uno schiavo nero, guide e trappers franco-canadesi, un'intrepida ragazza indiana e il suo neonato, un cane labrador sono i protagonisti della più mitica spedizione della storia statunitense: quella di Lewis e Clark e del Discovery Corps, che tra il 1804 e il 1806 per la prima volta attraversò il nord America da est a ovest, aprendo la via per il Pacifico. Imponenti i risultati scientifici: i primi contatti con una sessantina di tribù indiane, grandi progressi nelle conoscenze geografiche, nuove carte e centinaia di animali e piante raccolti e descritti per la prima volta, tra cui diversi nuovi generi; ai due capitani Lewis e Clark toccarono i notevoli Lewisia e Clarkia.  Preparazione Nel 1803, dopo una breve trattativa, Napoleone cedette la Louisiana francese agli Stati Uniti in cambio di 23 milioni di dollari; quel territorio di oltre due milioni di km² raddoppiava d'un solo colpo la superficie del paese. Oltre a parte dell'attuale Louisiana, con la capitale New Orleans, comprendeva infatti Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, parte del Minnesota, gran parte del Dakota del Nord, Dakota del Sud, l'area nordorientale del Nuovo Messico, l'estremità settentrionale del Texas, parte del Montana, Wyoming, il Colorado orientale e anche alcune parti delle attuali province canadesi di Alberta e Saskatchewan. Un territorio immenso, ma anche ben poco conosciuto, che la stessa Francia non aveva mai controllato davvero e neppure esplorato, se non per le piste battute dai cacciatori di pellicce e le poche vie commerciali lungo i bacini del Mississippi e del Missouri. Per il presidente Jefferson, che si era battuto per quell'acquisto nonostante la forte opposizione dei suoi avversari politici, era l'occasione per realizzare il sogno a lungo inseguito di esplorare l'occidente americano e di aprire una strada verso il Pacifico. Nel gennaio 1803 egli indirizzò al congresso una lettera segreta per chiedere un finanziamento di 2500 dollari per esplorare il bacino del Mississippi. Ottenuta l'approvazione, scelse come capo della futura spedizione il proprio segretario privato Meriwether Lewis, seguendo con cura la sua preparazione. Non solo gli mise a disposizione la sua biblioteca di Monticello - la maggiore del paese - ma lo inviò a Filadelfia perché potesse essere istruito da alcuni dei più eminenti scienziati americani in cartografia, astronomia, medicina, zoologia e botanica. In paleontologia lo istruì il medico Caspar Wistar, mentre il suo tutor in botanica fu Benjamin Smith Barton, amico e referente botanico di Jefferson. E' significativo che il presidente abbia affidato la missione a un militare (e soldati, a parte le guide e i battellieri, furono tutti i componenti della spedizione) e non a un naturalista di professione. Può aver influito il fatto che Jefferson stesso fosse un genio poliedrico versato in molte scienze che vedeva in Lewis una proiezione di se stesso; ma soprattutto contarono gli scopi politicamente sensibili della missione. Si trattava in primo luogo di mappare un territorio in gran parte ancora non segnato sulle carte; di valutare la presenza di inglesi e franco-canadesi e la loro intenzioni; di rivendicare il possesso effettivo dei territori prima di altre potenze; di stabilire relazioni commerciali con le popolazioni native; di aprire una strada percorribile fino al Pacifico, premessa di ogni futura espansione. Certo, non mancava l'aspetto scientifico; Lewis ricevette precise istruzioni direttamente da Jefferson che, per quanto riguarda la flora, recitano: "dedicare ogni attenzione al suolo e all'aspetto del paese, alle piante che vi crescono e ai prodotti vegetali, in particolare a quelli non presenti negli Stati Uniti". Lewis convinse William Clark, un vecchio compagno d'armi (erano entrambi capitani dell'esercito), ad unirsi all'impresa. Da quel momento, anche se nominalmente Lewis era il capo, avrebbero condiviso alla pari responsabilità e autorità. Incominciò poi a procurarsi l'equipaggiamento (tra cui figuravano il Dizionario di Miller e le opere di Linneo) e a luglio su recò a Pittsburg ad allestire il battello a chiglia necessario per navigare lungo il Missouri e i suoi affluenti. Ad agosto, insieme alle prime 11 reclute, risalì il fiume Ohio fino a Clarksville, dove incontrò Clark. I due si divisero i compiti: mentre Lewis muovendosi a cavallo completava l'equipaggiamento, Clark con il battello raggiunse Saint Louis, dove si occupò di arruolare ed addestrare nel forte di Camp Dubois sulla riva est del fiume i volontari del “Corps of Volunteers for Northwest Discovery.” I prescelti dovevano essere sani, scapoli, bravi a cacciare e usare le armi, dotati di buone capacità di sopravvivenza in un ambiente selvaggio. In tutto, i partecipanti furono 45, inclusi i due capitani, una trentina di volontari, i battellieri, gli interpreti e le guide ingaggiati durante il viaggio, uno schiavo di Clark di nome York. Completava la compagnia Seaman, il terranova di Lewis. 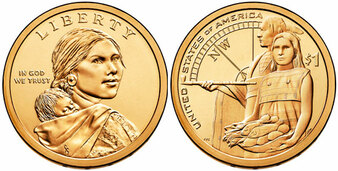 Andata: da Camp Dubois al Pacifico La spedizione esordì ufficialmente il 24 maggio 1804 con la partenza da Camp Dubois del Corpo di scoperta, a bordo del battello a chiglia e di due piroghe; a Saint Charles i volontari incontrarono Lewis e Clark e proseguirono la navigazione sul Missouri, superando La Charette, ultimo insediamento bianco. Da quel momento entravano in territorio indiano; in previsione degli incontri con i nativi, era stato predisposto un protocollo che prevedeva il baratto di beni e il dono ai capi tribù di una medaglia con l'effige di Jefferson su un lato e due mani allacciate sotto un tomahawk e un calumet della pace sormontati della scritta “Peace and Friendship” dall'altro. Il primo contatto avvenne il 15 agosto con un gruppo di Odo, nei pressi dell'attuale Council Bluffs, Iowa; qualche giorno più tardi fu la volta di alcuni Sioux Yankton. Questi gruppi avevano già avuto contatti con cacciatori bianchi e, per quanto un po' delusi dai "doni" degli americani, si dimostrarono abbastanza amichevoli. Il 20 agosto si ebbe l'unica vittima della spedizione, il sergente Floyd, morto probabilmente di appendicite. Alla fine di settembre entrarono nel territorio degli Sioux Teton, detti anche Lakota, che accolsero i doni in modo ostile; il capo Bufalo Nero cercò di bloccare la spedizione, esigendo la consegna di uno dei battelli come pedaggio; si sfiorò la battaglia, ma di fronte alla superiorità militare del Corpo di scoperta, i Lakota si allontanarono. Continuando la navigazione verso ovest, all'inizio di novembre la spedizione toccò i villaggi di altre tribù amichevoli, i Mandan e i Minitari; Lewis e Clark decisero di fermarsi qui per l'inverno. Venne costruito un forte, detto Fort Mandan, dove il Corpo trascorse cinque mesi cacciando, preparando canoe, abiti di cuoio, mocassini, mentre Clark si dedicava a tracciare carte. A Fort Mandan fu ingaggiato come interprete il cacciatore franco-canadese Toussaint Charbonneau e venne permesso alla moglie incinta, un'indiana Shosone di nome Sacagawea, di stabilirsi nel forte; a febbraio proprio qui la ragazza partorì il suo primogenito, Jean Baptiste soprannominato Pompy o Pomp. La giovane donna ebbe un ruolo importante per il successo della spedizione: non solo per la sua abilità di interprete e la profonda conoscenza del territorio, ma grazie alla sua stessa presenza. Poiché gli indiani non usavano portare donne nelle loro spedizioni guerresche, il fatto che i soldati fossero accompagnati da una donna e da un bambino in fasce agiva da salvacondotto, indicandone le intenzioni pacifiche. Il 7 aprile 1805 il battello a chiglia e il suo equipaggio con dodici uomini furono rimandati a Saint Louis, con relazioni, lettere, carte, manufatti indiani e esemplari zoologici e botanici. I "membri permanenti" (Lewis, Clark, 27 soldati, York, con l'aggiunta della famiglia Charbonneau e di almeno un'altra guida franco-indiana, George Drouillard) ripresero il cammino verso ovest per affrontare la parte più difficile del viaggio. Continuando a navigare in canoa lungo il Missouri, a metà giugno ne raggiunsero le grandi cascate, in realtà un sistema di cinque cascate successive, che impiegarono oltre due settimane a superare, spesso in condizioni difficili. Quando raggiunsero il punto in cui tre corsi d'acqua confluiscono per dar vita al Missouri, li battezzarono Galtin, Madison e Jefferson e proseguirono lungo quest'ultimo. Qui divenne importantissimo l'aiuto di Sakagawea; la giovane donna era un'indiana Shoshone, rapita da una tribù nemica quando era bambina e poi passata attraverso diverse mani prima di essere venduta a Charbonneau. Ella riconobbe il punto esatto dove era stata rapita e quindi il Beaverhead Rock, una formazione rocciosa non lontana dalla sede estiva del suo popolo, dove avrebbero potuto procurarsi dei cavalli. Toccava ora lasciare il fiume e proseguire a piedi; il 12 agosto raggiunsero il Lemhi Pass, Montana, che segna lo spartiacque continentale. Qualche giorno dopo, incontrarono guerrieri Shoshone avvertiti della loro presenza; grazie a Sakagawea, che fungeva da interprete, ottennero guide e i desiderati cavalli; la ragazza ritrovò la sua tribù e scoprì che suo fratello Cameahwait ne era divenuto capo. Quindi il gruppo attraversò la Bitterroot Mountain Range percorrendo il Lolo Trail. Fu il tratto più difficile, in cui dovettero affrontare rocce, foreste impenetrabili, fame, deidratazione, cattivo tempo, temperature inclementi, alcuni casi di congelamento. Dopo 11 giorni, il 22 settembre lungo il Clearwater River, Idaho, incontrarono un'amichevole tribù di Nez Percé, che li accolse e li aiutò a recuperare le forze e la salute. Costruite alcune canoe e affidati i cavalli agli amici indiani, affrontarono le rapide del Clearwater River per raggiungere lo Snake River, quindi il Columbia River. Il 7 novembre, Clark annotò nel suo diario: "Oceano in vista! Oh, gioia!". La missione era compiuta.  Ritorno e congedi Prima di affrontare il ritorno, bisognava trovare un ricovero per l'inverno. Accamparsi al di qua o al di là del fiume Oregon, dove si trovavano terreni di caccia più abbondanti? La decisione venne messa ai voti e tutti parteciparono, compresi York e Sakagawea (un episodio celebre perché fu la prima volta, nella storia degli Stati Uniti, in cui venne riconosciuto il diritto di voto a un nero e a una donna, che allo stesso tempo era una nativa). Il mese di dicembre venne impiegato a costruire Fort Clatsop, presso l'odierna Astoria, Oregon, che fu pronto per Natale. Qui il Corps trascorse un inverno difficile, dovendo affrontare il tormento degli insetti, umidità, influenza e infezioni intestinali. Il viaggio di ritorno iniziò il 23 marzo. Risalendo contro corrente il Columbia e molte cascate, ritornarono presso gli amici Nez Percé, dove recuperarono i cavalli e attesero lo scioglimento delle nevi prima di affrontare il cammino attraverso le montagne. Lewis approfittò di questa sosta per raccogliere la maggior parte dei suoi esemplari botanici. Poterono rimettersi in marcia solo a giugno. Dapprima ripercorsero il cammino dell'andata attraverso le Bitterrots e il Lolo Pass, dove Lewis e Clark decisero di dividersi in due gruppi, nella speranza di trovare un collegamento più agevole tra Pacifico e Atlantico. Lewis si diresse a nord lungo il fiume Missouri, mentre Clark a sud lungo il fiume Yellowstone, fissando come punto d'incontro la confluenza dei due corsi d'acqua. Lewis prese con sé i cacciatori migliori e l'interprete e scout franco-indiano George Drouillard. Il gruppo di Clark includeva York, Sacagawea, Pompy e Charbonneau. Lungo il fiume Marias il gruppo di Lewis incontrò alcuni guerrieri Piedi neri che cercarono di rubare loro le armi e i cavalli; ne nacque uno scontro a fuoco (l'unico di tutta la spedizione) in cui morirono due indiani; poco dopo lo stesso Lewis fu ferito da un compagno in un incidente di caccia, con conseguenze spiacevoli ma non fatali. Al gruppo di Clark, toccò invece il furto di alcuni cavalli, sottratti da abilissimi indiani Crow che i nostri non ebbero neppure modo di vedere. I due gruppi riuniti raggiunsero il 12 agosto il villaggio dei Maidan, dove salutarono Sakagawea e la sua famiglia e da qui, con una facile navigazione con corrente a favore lungo il Missouri, il 23 settembre rientrarono a Saint Louis, dove furono accolti come eroi. Avevano percorso più di 8000 miglia, incontrato e stabilito relazioni con almeno una sessantina i popoli indiani, raccolto informazioni geografiche di prima mano e prodotto dozzine di carte. Nel campo delle scienze naturali, il contributo fu notevolissimo. Già mentre risalivano il Missouri, Lewis prese ad annotare sul suo diario di campo la velocità della corrente, la natura delle rocce e, ovviamente, gli animali e le piante via via incontrati. Il primo animale nuovo per la scienza fu Neotoma floridana, un roditore noto come eastern wood rat. Seguirono bufali, grizzly, cani della prateria, castori, coyote, pecore bighorn, per un totale di 120 specie tra mammiferi, uccelli, pesci e rettili. Quanto alle piante, Lewis, che era munito di una piccola pressa manuale, ebbe cura di raccoglierne centinaia di esemplari; furono coinvolti anche altri membri della spedizione, tra cui Clark e Sakagawea. Nelle sue note, Lewis dimostrò notevoli capacità di osservazione sull'habitat e le caratteristiche morfologiche di ciascuna specie, facendo anche tesoro delle conoscenze dei nativi sugli usi alimentari, medicinali e pratici delle piante. Ad esempio, descrisse con precisione il modo in cui le donne Nez Percé raccoglievano e preparavano i bulbi di Camassia quamash, una componente molto importante della loro dieta. In tutto, le specie raccolte furono 174, di cui circa 90 nuove per la scienza. Molte sono belle piante da fiore, raccolte lungo il Lolo trail nel viaggio di ritorno, e alcune sono oggi molto comuni nei nostri giardini, come Mimulus guttatus, Euphorbia marginata, Echinacea angustifolia. Se volete conoscerle tutte, non vi resta che visitare il bellissimo sito The Lewis and Clark Herbarium. Dopo la grande avventura, le sorti dei due capitani furono assai differenti. Lewis, nominato da Jefferson governatore della Louisiana, non si dimostrò all'altezza del compito e finì presto i suoi giorni nell'alcoolismo e forse nel suicidio (qui una sintesi della sua vita); invece Clark divenne governatore del Missouri, giocò un ruolo centrale nelle relazioni con i nativi ed ebbe una vita lunga e operosa. Si dimostrò abbastanza generoso e umano da educare nella sua casa e far studiare il piccolo Pompey, rimasto presto orfano, ma non abbastanza da affrancare York, che pure della spedizione era stato uno dei membri più validi.  Le amare radici della Lewisia Ma torniamo alle piante. Quelle essiccate furono inviate a Philadelphia all'American Philosophical Society perché fossero studiate dal mentore di Lewis, Benjamin Smith Barton. Le poche piante vive e i numerosi semi furono divisi tra due vivaisti, William Hamilton e Bernard McMahon. A questi tre personaggi era legato il botanico tedesco Frederick Pursh, che fu incaricato dapprima di disegnare le illustrazioni che avrebbero dovuto accompagnare la pubblicazione dei diari di Lewis e Clark (che non si realizzò mai); andò poi con McMahon a Londra dove nel 1813 in Flora Americae Septentrionalis descrisse 130 piante raccolte durante la spedizione. Tra di esse anche le specie tipo dei due generi destinati ad immortalare i capitani, Lewisia e Clarkia. Due specie del primo risultano nell'erbario di Lewis e Clark: Lewisia rediviva Pursh, raccolta il 2 luglio 1806 lungo il Betterroot River; L. triphylla (S. Watson) B. L. Rob., raccolta qualche giorno prima lungo il Lolo Trail. Solo la prima fu descritta da Pursh e deve il suo nome a una vicenda curiosa. Giunta a Filadelfia come esemplare essiccato, in realtà era viva grazie alla radice carnosa; fu quindi prelevata e piantata nel vivaio di McMahon, dove spuntò e visse qualche anno prima di morire a causa delle annaffiature eccessive. Nota con il nome franco-canadese radiz amère, in inglese fu chiamata bitterrot, e diede il suo nome sia all'omonimo fiume sia all'adiacente catena delle Montagne rocciose. Nel 1895 è stata scelta come pianta ufficiale del Montana. Il genere Lewisia Pursh appartiene alla famiglia Montiaceae (un tempo Portulacacae) e annovera 16-19 specie endemiche degli Stati Uniti nord-occidentali; sono piante perenni rupicole amanti dell'ombra che crescono abbarbicate alle rocce del versante nord, basse e molto decorative grazie ai grandi fiori. Oggi la più popolare nei nostri giardini è Lewisia cotyledon, disponibile in un'ampia gamma di colori che vanno dal rosa chiaro al porpora passando per il salmone e l'arancio, spesso con i petali sfumati in più colori. Altre informazioni nella scheda. Ricordano Lewis anche molti nomi specifici delle specie da lui segnalate, come Phildelphus lewisii, Linum lewisii, Mimulus lewisii. Purtroppo nessun botanico ha pensato invece di dedicare un genere a Sakagawea, che pure l'avrebbe meritato come tramite tra gli esploratori bianchi e le conoscenze etnobotaniche dei nativi, oltre che come raccoglitrice in prima persona. A ricordarla (ma il personaggio è molto popolare negli Stati Uniti, celebrato da dozzine di statue) c'è però proprio una specie di Lewisia, L. sakajaweana, un endemismo dell'Oregon.  La singolare Clarkia Fu sempre Pursh a stabilire il genere Clarkia, sulla base di C. pulchella, raccolta il 1 giugno 1806 sempre lungo il Bitterroot River da Lewis che la definì "una pianta singolare" per i quattro petali finemente divisi in tre lobi. Nella storia della scienza è nota anche perché Robert Brown si servì del polline di questa specie per le osservazioni che lo portarono alla scoperta del moto browniano. Il genere Clarkia appartiene alla famiglia Onagraceae e comprende una quarantina di specie di annuali, tutte native del Nord America, ad eccezione della sudamericana C. tenella. Diverse specie sono popolari annuali da giardino. La più nota è probabilmente C. amoena, spesso utilizzata anche come fiore reciso, di cui esistono molte serie con fiori a imbuto singoli e doppi in una gamma di colori che include il rosa, il lilla, il salmone, il porpora. il bianco; alcune cultivar hanno margini bianchi o centri in colore contrastante. Per ironia della sorte, proprio alcune delle specie più coltivate sono note con il nome comune godezia, o il nome botanico Godetia, poiché un tempo appartenevano al genere Godetia Spach, che fin dal 1955 è confluito in Clarkia di cui è divenuto una sezione. E' uno dei tanti esempi di quella che definisco "viscosità dei nomi botanici", ovvero della fatica di coltivatori ed appassionati ad adottare i nuovi nomi, anche dopo decenni e decenni come in questo caso. Qualche approfondimento nella scheda. Di Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, è stato detto che potrebbe essere nominato patrono laico dei giardini e dei giardinieri statunitensi. Quella per la natura, le piante e i giardini fu infatti per lui una passione costante in tutte le fasi della vita, fino alla creazione dello splendido giardino di Monticello. Protagonista di una rete di "scambisti" di piante tra le due sponde dell'oceano, botanico dilettante, presidente della American Philosophical Society, ebbe anche il merito di sponsorizzare la grande spedizione di Lewis e Clark. Lo ricorda una pianta del sottobosco delle foreste americane, Jeffersonia diphylla, che coltivava in una delle aiuole del suo giardino, dove spesso gli faceva omaggio della sua candida fioritura come dono di compleanno.  Una dedica all'uomo di scienza, non al politico La sera del 18 maggio 1792 sei uomini si incontrarono presso la Philosophical Hall di Filadelfia, la sede della American Philosophical Society, per la consueta riunione del venerdì; dopo il momento conviviale del pranzo, Benjamin Smith Barton, professore di botanica e storia naturale presso l'Università della Pennsylvania, lesse una lettera che aveva scritto ai colleghi europei circa una pianta nativa della Virginia. Linneo, basandosi solo su esemplari essiccati, l'aveva assegnata al genere Podophyllum, con il nome P. diphyllum. Barton, studiandola dal vivo, era giunto alla conclusione che andasse invece assegnata a un genere nuovo e, aggiunse, "Mi sono preso la libertà di renderlo noto ai botanici sotto il nome di Jeffersonia, in onore di Thomas Jefferson, segretario di Stato degli Stati Uniti". E ciò, aggiunse, non in considerazione dei suoi meriti politici, ma delle sue conoscenze di storia naturale che, soprattutto nei campi della zoologia e della botanica "sono eguagliate da poche persone negli Stati Uniti". In effetti, il multiforme Thomas Jefferson, estensore della Dichiarazione d'Indipendenza, quindi ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, segretario di Stato, presidente per due mandati, oltre che uno dei padri fondatori degli Stati Uniti fu un intellettuale di notevole spessore, con forti interessi scientifici che spaziavano dalla matematica all'archeologia, dalla geografia alla paleontologia: le scienze naturali e la botanica furono una passione che coltivò per tutta la vita. Si racconta che quando era presidente conoscesse tutte le piante dei dintorni della Casa Bianca, e non si facesse sfuggire una specie nuova per il suo erbario. Per quanto riguarda la botanica, notevole fu il suo lascito in tre settori: la promozione dell'agricoltura del suo paese, con migliorie tecniche e l'introduzione di nuove specie; la creazione dello splendido giardino di Monticello; la promozione dell'esplorazione delle risorse naturali del territorio statunitense. Convinto che l'agricoltura fosse la base della prosperità, dell'indipendenza, ma anche della moralità di una nazione, sognava un paese di piccoli agricoltori liberi, anche se lui, da parte sua, era il proprietario schiavista di vaste piantagioni. Il suo contributo in questo campo fu soprattutto nella sperimentazione e nell'introduzione di nuove varietà: ad esempio, portò con sé dall'Europa una pianta di fico acquistata a Marsiglia, che a suo dire produceva i frutti migliori che mai avesse mangiato, e ne distribuì talee a vicini e amici; creò un vigneto sperimentale; incoraggiò la coltivazione del sesamo per la produzione familiare di olio. Ma il suo capolavoro fu Monticello, la sua residenza nei pressi di Charlottesville, Virginia, il cui nome italiano fa riferimento alla posizione della proprietà, sulla cima di un colle delle Southwest Mountains. Nel 1768 iniziò l'edificazione di una casa in stile palladiano, progettata dallo stesso Jefferson, che era quasi completa nel 1784 quando egli dovette lasciare gli Stati Uniti per la Francia, con l'incarico di ambasciatore presso la corte di Parigi. Contemporaneamente, cominciò a realizzare il giardino, sulle cui vicende siamo ben informati grazie al suo Garden Book, ovvero il quaderno dove annotava piantagioni, semine, esperimenti. La prima annotazione risale al 1769, quando Jefferson fece piantare alberi da frutto sul versante sud della collina. Nel 1774, in collaborazione con l'italiano Filippo Mazzei, che procurò vignaioli e vitigni, impiantò la prima vigna della Virginia. Tra il 1778 e il 1782 fu la volta di un vasto frutteto di meli e peschi e del primo orto, lungo la strada principale della piantagione, dove vennero seminari asparagi, piselli e carciofi. Il soggiorno in Europa, che si protrasse dal 1784 al 1789, permise a Jefferson di allargare i suoi orizzonti culturali e di allacciare proficue relazioni. Oltre alla Francia, visitò la Gran Bretagna, l'Italia, il Belgio e i paesi Bassi, dove visitò case e giardini, rimanendo profondamente impressionato dallo stile libero dei nuovi parchi all'inglese. A Parigi incominciò a frequentare il salotto di Madame de Tessé, zia di Lafayette e grande appassionata di giardini, che gli chiese di procurargli piante americane; e così, tra Parigi e Monticello, iniziò un attivo scambio transoceanico di piante: mentre esemplari di Callicarpa americana, Diospyros virginiana, Calycanthus floridus procurati da amici e corrispondenti di Jefferson raggiungevano il parco di Chaville, a Monticello arrivavano semi di elitropio bianco (Helitropium arborescens), ranuncoli, cavolfiori, broccoli e bulbi di tulipani. Un altro contatto importante fu André Thouin, capo giardiniere del Jardin du Roi.  Un giardino per frutti, verdure, fiori Tornato in patria, Jefferson cercò di conciliare l'attività politica (che egli definiva il suo dovere) con gli interessi scientifici (che egli definiva la sua passione). Così, nel 1791 lo troviamo ad erborizzare nel New England con l'amico James Madison. Nel 1797 fu nominato presidente della American Philosophical Society (incarico che mantenne per un ventennio, anche durante i due mandati presidenziali). Nel 1812, quando durante la guerra anglo-americana un incendio distrusse la biblioteca del Congresso, Jefferson offrì di reintegrarla con la sua collezione (che vantava il doppio dei volumi di quella perduta), dietro un compenso che doveva aiutarlo a ripianare i grandi debiti contratti per la ristrutturazione di Monticello; il congresso accettò, creando così il primo nucleo dell'attuale Library of Congress. Egli inoltre si impegnò attivamente nella creazione dell'Università della Virginia a Charlottesville, che fu infine inaugurata nel 1819. A partire dal 1794, lo stesso anno in cui divenne segretario di Stato, Jefferson intraprese la totale ristrutturazione della casa e del parco di Monticello, ispirandosi a quanto aveva visto in Europa. Come Mount Vernon di Washington, anche il giardino concepito da Jefferson unisce le funzioni di parco paesaggistico, frutteto, orto e giardino di piacere. I frutteti e gli orti si trovavano fuori del parco vero e proprio, lungo il viale principale della piantagione. I frutteti, con pianta formale a grata, erano due, uno posto a nord, l'altro a sud. Includevano anche meli per la produzione di sidro; a più riprese, venne impianta una vigna, ma con poco successo. L'orto venne collocato su una lunga terrazza ricavata dal lavoro degli schiavi sul fianco della collina; comprendeva 24 parcelle quadrate destinate alla produzione di "radici" (come rape e carote), "frutti" (pomodori, fagioli), "foglie" (insalate, cavoli). Al centro un piccolo padiglione da cui si poteva godere il panorama. Alla base del muro di sostegno venivano coltivate le primizie e le piante più delicate, come i piselli, una delle grandi passioni di Jefferson. Anche i fichi portati dalla Francia crescevano qui. L'orto era anche uno spazio sperimentale dove provare novità, come i broccoli e i cavolfiori importati dall'Europa o gli stessi pomodori. Si calcola che nel corso degli anni Jefferson vi abbia fatto coltivare 330 varietà di 70 specie. La sommità della collina era occupata da una spianata con un vasto prato dai contorni irregolari, il West Lawn, a nord ovest del quale si trova il Grove, il boschetto, un'area di 18 acri concepita come una foresta ornamentale in cui agli alberi nativi più alti (potati in modo da lasciare luce e spazio agli alberi minori) si affiancavano piante scelte per il contrasto di colori, forme, tessiture. Il sottobosco naturale doveva essere eliminato per lasciare posto a radure a prato, con erbacee perenni e gruppi di arbusti disposti secondo un disegno labirintico a spirale. Il collegamento tra le varie parti del giardino era garantito da quattro viali circolari concentrici, posti a livelli differenti, bordati di gelsi e Gleditsia triacanthos e collegati tra loro da sentieri diagonali. Se, proprio come Mount Vernon, all'inizio anche Monticello era stato concepito soprattutto con funzioni utilitarie, dopo l'esperienza europea l'interesse di Jefferson per i fiori e le piante ornamentali aumentò. Nel 1807, in previsione del suo ritiro dalla vita politica, egli disegnò venti aiuole ovali, poste ai quattro angoli della casa, ciascuna delle quali destinata a una specie diversa, con bulbose, erbacee perenni e piccoli alberi da fiore. Probabilmente nel 1808 fu creata la grande bordura serpeggiante che contorna il prato centrale. In entrambe le aree la figlia e le nipoti di Jefferson coltivavano una grande varietà di piante e bulbi, forniti soprattutto dal vivaista di Filadelfia Bernard McMahon, in modo da assicurare fioriture dalla primavera all'autunno. C'erano i fiori coltivati tradizionalmente che i coloni avevano portato con sé dall'Europa; piante più inusuali o novità fornite dai contatti europei (ogni anno, una cassa giungeva dal Jardin des Plantes di Parigi). Almeno un quarto delle piante da fiore coltivate a Monticello erano tuttavia native; oltre a Jeffersonia diphylla, particolarmente gradita perché oltre a portare il suo nome fioriva proprio intorno al suo compleanno (il 2 aprile), c'erano diverse specie raccolte durante la spedizione di Lewis e Clark, come Fritillaria pudica e Lobelia cardinalis. Siamo così giunti all'ultimo titolo di merito di Jefferson: quella spedizione era stata voluta e sponsorizzata proprio da lui, durante il suo primo mandato presidenziale. Negli anni successivi all'indipendenza, il territorio del nuovo stato era confinato nella stretta striscia tra gli Appalachi e l'Oceano, mentre si avevano scarse conoscenze delle terre poste al di là delle montagne. Jefferson era conscio delle enormi potenzialità di quel territorio inesplorato e sognava di trovare una via di comunicazione con l'Oceano Pacifico. Già quando si trovava a Parigi come ambasciatore sostenne il progetto dell'esploratore anglo-americano John Ledyard che si proponeva di raggiungere lo stretto di Bering attraversando la Russia via terra; da qui pensava di trovare un passaggio per l'Alaska, da dove sarebbe sceso verso sud per poi percorrere il continente americano fino alla Virginia. Ma, dopo essere arrivato in Siberia, nel febbraio del 1788 Ledyard fu arrestato per ordine dell'imperatrice Caterina e deportato in Polonia. Una seconda possibilità si presentò nel 1793, quando l'American Philosophical Society pensò di affidare la missione di "esplorare il paese lungo il Missouri e di lì proseguire verso ovest fino all'Oceano Pacifico" al botanico francese André Michaux, che da qualche anno viveva in Carolina del Sud e aveva una larga esperienza di viaggi di esplorazione e raccolta. Jefferson stesso organizzò la sottoscrizione che doveva finanziare la spedizione e ottenne l'assenso di Washington; tuttavia, quando fu chiaro che Michaux era coinvolto in un piano antispagnolo organizzato dall'ambasciatore francese, per evitare di peggiorare le relazioni diplomatiche con la Spagna il progetto fu annullato. Il sogno di Jefferson poté infine realizzarsi nel 1804 grazie alla spedizione capeggiata da Lewis e Clark, argomento su cui però tornerò in un altro post. Jefferson morì nel 1826, a ottantaquattro anni, ormai sprofondato nei debiti contratti per la sua vita troppo dispendiosa e soprattutto per la creazione di Monticello. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. La figlia fu costretta a vendere la tenuta che, dopo essere passata attraverso vari proprietari, nel 1836 fu acquistata da Uriah Levy, grande ammiratore di Jefferson, il quale nel 1862 la lasciò in eredità al popolo americano perché fosse usata come scuola agraria. Ma si era in piena guerra civile e il congresso rifiutò il lascito. Dopo complesse vicende, a cercare di salvare Monticello, che era ormai in uno stato deprecabile di abbandono, fu il nipote Jefferson Monroe Levy, che ne iniziò il restauro, poi proseguito a cura della Thomas Jefferson Foundation, nata nel 1923. Monticello come lo vediamo oggi è il frutto dei restauri da essa promossi: sono stati ricreati il prato e la sua bordura, le aiuole ovali, il viale circolare inferiore, la terrazza con l'orto, mentre i frutteti non esistono più e il Grove è ben diverso da come doveva presentarsi all'epoca del suo creatore. Dal 1987 la tenuta è inclusa nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO. Moltissime notizie sul giardino e sullo stesso Jefferson nel sito di Monticello.  Una pianta americana Abbiamo già visto che Jeffersonia fu dedicata a Jefferson nel 1792 da Benjamin Smith Barton. Appartenente alla famiglia Berberidaceae, comprende una sola specie, appunto J. diphylla, una rara erbacea perenne a fioritura primaverile del sottobosco delle foreste decidue con suolo calcareo degli Stati Uniti orientali. Alta fino a 25 cm, ha grandi foglie bilobate con lobi da arrotondati ad acuti posti quasi ad ala di farfalla; all'inizio della primavera produce fiori a coppa con otto petali bianchi e stami gialli. Gli si attribuiscono proprietà antireumatiche. Qualche informazione in più nella scheda. Ha anche una bellissima cugina asiatica che oggi, dopo molte incertezze, è stata restituita al genere Plagiorhegma. Dunque dobbiamo rassegnarci a chiamare questa perla dei giardini boschivi con foglie lobate e fiori lilla con l'orrendo nome Plagiorhegma dubium anziché Jeffersonia dubia. Nel 1800 Brickell dedicò a Jefferson un secondo genere Jeffersonia; illegittimo per la regola della priorità, è oggi sinonimo di Gelsemium. Tra gli avventurosi cacciatori di piante di inizio Ottocento c'è anche un botanico piemontese, Carlo Giuseppe Bertero. Formatosi alla scuola di Balbis, di fronte all'onda nera della Restaurazione decise di lasciare l'Europa e di dedicare la sua vita all'esplorazione della flora di paesi lontani, possibilmente poco battuti. Il primo viaggio, tra il 1816 e il 1821, lo portò nelle Antille e in Colombia; dopo un breve rientro in patria, nel 1827 ripartì nuovamente per le Americhe, scegliendo una meta quasi vergine per la scienza: il Cile. Fu poi la volta delle Juan Fernandez, uno straordinario arcipelago oceanico che per qualche aspetto anticipa le darwiniane Galapagos, quindi di Tahiti; ma era l'ultimo viaggio: mentre faceva ritorno in Cile, la nave su cui era imbarcato si inabissò nell'Oceano Pacifico. Privo di sostegno da parte di sovrani o altre istituzioni pubbliche, finanziò le sue ricerche mantenendosi con la sua professione di medico. Anche se non pubblicò quasi nulla, il suo contributo alla conoscenza della flora del Nuovo mondo fu inestimabile. De Candolle, che gli fu amico e mentore, già al suo ritorno dalle Antille aveva voluto dedicargli Berteroa, un piccolo genere di Brassicaceae affine ad Alyssum che non ha nulla di esotico, essendo diffuso soprattutto nel Mediterraneo e nell'Asia occidentale.  Primo viaggio: Antille Fu forse l'indignazione per un gesto politico che calpestava un uomo che considerava un secondo padre e con lui le ragioni della scienza a spingere Carlo Giuseppe Bertero a trasformarsi in un cacciatore di piante. Nato a Santa Vittoria d'Alba nel fatidico 1789, era venuto a studiare medicina a Torino ed era divenuto uno dei più brillanti allievi di Giovanni Battista Balbis, cui lo legava un affetto quasi filiale. Nel 1814, quando il suo maestro fu cacciato dall'università e l'intera facolta di medicina fu epurata degli "infranciosati" (con il licenziamento di otto docenti su nove), Bertero decise di dare le dimissioni da segretario del Grand Jury (l'organismo che faceva le veci del Tribunale di Protomedicato) e di non continuare gli studi nel collegio medico dell'Università. Anche la monotona e soffocante provincia albese non sembrava offrirgli alcuna prospettiva. Tornato a casa, come l'eroe stendhaliano Fabrizio del Dongo, si trovò immerso in atmosfera stagnante, senza alcuna prospettiva. A soddisfare la sua sete di conoscenza non bastavano le escursioni botaniche sulle Alpi e nelle campagne di casa. Era ora di lasciare l'Italia per cercare altrove fama e conoscenza. Unico cordone ombelicale con una patria matrigna, la corrispondenza con gli amici, primi tra tutti il maestro Balbis e il colto botanico dilettante Luigi Colla che, come vedremo, furono poi i principali destinatari anche dei suoi invii di piante e semi. La prima tappa, quasi ovviamente, fu Parigi, dove poté sfruttare le relazioni di Balbis con i maggior botanici francesi per avere accesso al Jardin des Plantes e a erbari ricchi di piante esotiche; importante fu l'incontro con C.H. Persoon, grazie al quale trovò un imbarco per le Antille come medico di bordo. Si era preparato al viaggio con scrupolo, non solo studiando negli erbari la flora di quell'area, ma anche l'inglese e lo spagnolo. Imbarcatosi nell'agosto 1816 a Le Havre, a fine anno giunse in Guadalupa, salutato quasi come un eroe per aver salvato se stesso e molti compagni di viaggio da un'epidemia di febbre gialla scoppiata a bordo. Nell'isola esercitò con successo la professione medica e divenne una figura nota e riconosciuta, tanto che il governatore gli offrì la direzione dell'orto botanico e di un laboratorio di storia naturale. Nonostante la proposta fosse allettante anche sul piano economico, Bertero rifiutò per non legarsi a un singolo luogo e estendere la sua esplorazione ad altre isole dell'arcipelago. Privo di ogni sostegno ufficiale a causa della cecità dei Savoia, egli dovette dunque dividere il suo tempo tra la professione medica, che amava e esercitava con il tipico spirito umanitario della tradizione illuminista-giacobina, e le ricerche sul campo; altra difficoltà, la mancanza di testi di consultazione (all'epoca, non erano ancora state pubblicate i grandi repertori di de Candolle e Sprengel, che per le piante americane in modo diverso tanto dovettero proprio alle ricerche del nostro). Così, la sua avventura americana fu costellata di progetti e ripensamenti: in una lettera a Colla, annuncia che intende visitare sistematicamente tutto l'arco delle Piccole Antille (Marie-Galante, Dominica, Martinica, St. Lucia, St. Vincent, Barbados, Grenada, Tobago, Trinidad), per poi raggiungere il delta dell'Orinoco. Il percorso reale fu tutt'altro: lasciata Guadalupe nel luglio 1818, visitò due isole all'epoca sotto dominio danese, St. Thomas e St. Croix; passò poi a Porto Rico, lussureggiante per la flora, ma deludente per il dispotismo e l'arretratezza civile. Tra 1819 e 1820 visitò le due parti di Hispaniola, quella orientale ancora colonia spagnola, e quella occidentale, divenuta nel 1804 repubblica indipendente con il nome di Haiti. Da qui, tra 1820 e 1821, si spostò verso le coste dell’attuale Colombia. La guerra civile che imperversava nel paese lo spinse a lasciare quell'area di per sé promettente; dopo aver toccato ancora la Giamaica, a ottobre era di nuovo in Europa.  Il viaggio continua: Cile, Juan Fernandez, Tahiti Desiderava soprattutto incontrare Balbis (che ormai si era trasferito stabilmente a Lione) e riordinare le proprie collezioni. Probabilmente, pur non manifestando apertamente la sua delusione per rispetto del maestro, non fu soddisfatto nello scoprire che Balbis, invece di tenere riuniti gli esemplari che egli gli aveva inviato tra tante difficoltà, li aveva distribuiti, generosamente ma altrettanto sconsideratamente, agli studiosi interessati, disperdendo una collezione che solo chi l'aveva raccolta avrebbe potuto ordinare e catalogare in modo completo. Rientrato ad Alba alla fine dell'anno, erborizzò ancora intensamente in Piemonte, ma crescevano la frustrazione e il desiderio di ripartire. Nel 1825 collaborò con Moris che stava esplorando la flora sarda, ma pasticci burocratici trasformarono anche questa opportunità in un fallimento, nonostante gli ottimi rapporti personali con il collega. Quando, all'inizio del 1827, la morte della amata madre sciolse l'ultimo legame con il Piemonte, capì che era ora di mettersi di nuovo in viaggio. Cercava una meta poco battuta dai botanici, e su suggerimento di de Candolle, che incontrò a Parigi, scelse il Cile. In effetti quell'angolo del Sud America, se si escludono il viaggio di Feuillé all'inizio del Settecento e il capitolo sulla vegetazione nel Saggio sulla storia naturale del Cile dell'abate Molina, era quasi sfuggito ai botanici. Ancora una volta, Bertero dovette muoversi in modo individuale; è vero che a Parigi molti colleghi lo avevano blandito e corteggiato, ma egli dovette amaramente constatare che in realtà speravano di sfruttarlo per ottenere l'invio di qualche pianta rara; lo stesso de Candolle gli offrì del denaro per raccogliere piante per lui, proposta che egli respinse con sdegno, nonostante l'amicizia personale che lo legava allo svizzero. Accettò invece che pubblicasse le sue specie e le sue descrizione nel Prodromus, come male minore, prima che lo facesse qualcun altro. Strinse anche un accordo con il barone Delessert: dal Cile avrebbe inviato i suoi esemplari a lui, che avrebbe custodito le collezioni fino al ritorno di Bertero, distribuendo una copia ciascuno a Balbis, Colla, de Candolle e trattenendone una per sé. Tuttavia il pur ricco barone non finanziò il viaggio, che Bertero ancora una volta si pagò con la sua attività di medico. Anche in questo caso si imbarcò come medico di bordo; partito da Le Havre nella seconda metà di ottobre 1827, sbarcò a Valparaiso nel febbraio dell'anno successivo. Anche in Cile alternò all'attività di ricerca la professione medica, in condizioni tuttavia ben più difficili di quelle già complesse che aveva incontrato nelle Antille. Nel paese era difficile spostarsi per l'assenza di strade, il territorio battuto da banditi, la resistenza endemica degli indios mapuche; il livello culturale era basso (da un medico ci si aspettava che ti guarisse subito, altrimenti meglio gli intrugli tradizionali) e la natura ostile, con piogge incessanti e frequenti terremoti. In quegli anni, il territorio del Cile, ancora oggi un lungo petalo stretto tra le Ande e l'Oceano Pacifico, come ebbe a definirlo Neruda, aveva un territorio di circa un terzo di quello attuale, che rispetto alla capotale si estendeva per circa 500 km a Nord (fino a La Serena, ultima città prima del deserto di Atacama) e altrettanti a Sud (fino a Concepción, sulla foce del fiume Bío-Bío). Di fatto, i viaggi di Bertero dovettero limitarsi alla valle centrale; dopo essere vissuto per qualche tempo nei villaggi di Rancagua e San Fernando, si stabilì essenzialmente tra la capitale Santiago e il porto di Valparaiso, da dove partivano i suoi periodici invii di piante essiccate e semi per l'Europa. Per qualche tempo, a quanto pare, insegnò anche disegno naturalistico all'Instituto National e tra il 1828 e il 1829 pubblicò sulla rivista Mercurio cileno la sua unica opera edita, Lista de las plantas que han sido observadas en Chile por el Dr. Bertero en 1828, in cui passa in rassegna le piante da lui osservate nel paese, indicate con il nome latino e quello locale (prive di descrizione, non sono tuttavia valide ai fini dell'attribuzione del nome botanico). Tra le escursioni più ricche di scoperte quella che lo portò a risalire la valle andina del fiume Aconcagua, fino a Quillota. Nel 1829 o nel 1830 Bertero conobbe il viaggiatore inglese Alexander Caldcleugh, appassionato di mineralogia e di botanica. Costui, di ritorno da un viaggio in Brasile e Argentina, aveva visitato brevemente Más a Tierra, l’isola principale dell'arcipelago Juan Fernández, oltre 600 km al largo di fronte a Valparaiso. Nacque così l'idea di recarsi in quel luogo remoto e singolare, che insieme al nuovo amico il piemontese esplorò dal marzo al maggio 1830. Era la prima spedizione di un botanico professionista in una terra ricca di endemismi, dove egli raccolse 330 specie, di fatto quasi l'intero catalogo della flora dell'isola. Ma sulle Juan Fernández, oggi riserva della biosfera, vorrei tornare in un altro post, visto che non mancano le storie da raccontare. Si trattava di un'impresa di grande valore che forse avrebbe potuto aprire a Bertero le porte di un incarico prestigioso, come la direzione del Museo nazionale cileno. Tuttavia, proprio mentre il piemontese era a Más a Tierra, il governo liberale con il quale probabilmente aveva avuto contatti, come dimostrerebbe la sua collaborazione al Mercurio cileno, venne rovesciato e si impose un regime autoritario. Furono forse queste circostanze a spingere Bertero, privo di appoggi e credenziali internazionali, a partire per una meta ancora più remota: Tahiti. A proporglielo fu il belga Jacques Antoine Morenhout, che aveva stabilito un proficuo commercio di madreperla, legname, olio di cocco tra Cile e isole del Pacifico, con centro a Tahiti, dove aveva una casa. Poco sappiamo del soggiorno di Bertero a Tahiti, che dovette durare sei mesi; nell'aprile 1831, essendo venuto a sapere (con dieci mesi di ritardo) della rivoluzione di luglio in Francia, si imbarcò alla volta di Valparaiso, dove aveva lasciato i suoi materiali e da dove intendeva tornare in Europa. Ma la nave su cui si era imbarcato, appartenente a Morenhout, non arrivò mai in porto. Il belga ne concluse che doveva aver fatto naufragio dopo aver lasciato Raiatea, un'isola a 290 km a nord-ovest di Tahiti, da dove Bertero gli aveva inviato la sua ultima lettera il 15 aprile 1831. In ricordo, battezzò Bertero Reef, scogliera di Bertero, un gruppo di isolotti e scogli corallini della Polinesia francese dove verosimilmente potrebbe essere avvenuto il naufragio. Una sintesi della vita avventurosa del botanico piemontese nella sezione biografie. 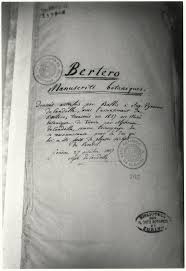 La dispersione delle collezioni Vicende altrettanto sfortunate ebbero le sue collezioni. Come ho già accennato, molti degli invii ricevuti dalle Antille da Balbis, furono da quest'ultimp dispersi tra numerosi colleghi; inoltre Balbis consegnò (prestò?) a de Candolle il diario di campo del viaggio che Bertero gli aveva donato, perché se ne servisse per la stesura del Prodromus (lo svizzero vi attinse a piene mani, talvolta anche riproducendo le descrizioni di Bertero parola per parola). Per fortuna, nel 1857, grazie a suo figlio Alphonse il prezioso manoscritto tornò a Torino; si tratta di 14 quaderni di campo, per un totale di oltre 1000 pagine, dove Bertero annotò 1746 raccolte, con una descrizione minuziosa, habitat, luogo di raccolta, nomi comuni, usi officiali locali, accompagnati talvolta da una discussione sistematica e tassonomica e da precisi disegni di dettagli morfologici. Le piante essiccate raccolte nelle Antille sono in parte confluite negli erbari di Colla e Balbis, ora presso l'Orto botanico di Torino, in parte disperse in dozzine di erbari sparsi per l'Europa. Non possediamo purtroppo i diari di campo relativi a Cile, Juan Fernandez e Tahiti. Dopo la morte del congiunto, gli eredi di Bertero misero all'asta i materiali conservati presso il barone Delessert (circa 15000 esemplari) e, benché i botanici torinesi fossero riusciti a raccogliere la somma necessaria tramite una sottoscrizione, ad aggiudicarseli fu una ditta tedesca che a sua volta li vendette tanto a istituzioni scientifiche quanto a collezionisti privati, disperdendo anche questa collezione. Un piccolo erbario di circa 400 esemplari rimase in Cile, dove costituisce la collezione più antica dell'erbario del Museo Nacional de Historia Natural di Santiago. A questo punto, il più importante depositario della memoria di Bertero rimase Colla, che sulla base degli invii dell'amico ne aveva pubblicato un parziale catalogo già nel 1829 in Plantae rariores ex regionibus chilensibus a clarissimo C. G. Bertero nuper detectae et ab. L. Colla in lucem editae. Ma anche su Colla tornerò in un altro post.  La modesta Berteroa Benché queste sfortunate vicende abbiano privato Bertero della gloria che sognava e ben meritava, il valore del suo lavoro non sfuggì ai botanici contemporanei, come dimostrano le varie dediche che ricevette in vita e dopo la morte. Intanto l'imponente numero di piante contrassegnate dagli specifici bereteroi, berteroanus (oltre 300) sta a dimostrare l'importanza del suo contributo alla conoscenza della flora delle Americhe. Tre sono i nomi specifici che gli sono stati dedicati (cui si aggiunge il fungo Berteromyces Ciferri). Il più antico (e unico oggi valido) è Berteroa, creato da de Candolle nel 1821, separando B. incana dal linneano Alyssum. Seguì nel 1854 E. G. von Steudel che, anagrammando la denominazione, creò Terobera (oggi sinonimo di Machaerina Vahl); infine nel 1919 O.E. Schulz assegnò una Brassicacea affine a Berteroa al nuovo genere Berteroella (oggi sinonimo di Stevenia). Il genere Berteroa, della famiglia Brassicaceae, comprende cinque specie di erbacee annuali, biennali o perenni di breve vita distribuite tra Mediterraneo e Asia occidentale, dall'Italia alla Turchia, con massima concentrazione nella penisola balcanica. La più nota è B. incana, un'erbacea abbastanza invasiva che si è infatti diffusa al di fuori dell'area originaria, per altro difficile da determinare, ed ora è presente dall'Europa occidentale fino alla Siberia; si è anche ampiamente naturalizzata negli Stati Uniti dove è considerata un'infestante. In Italia sono presenti tre specie, appunto B. incana (Italia settentrionale e forse centro-settentrionale, Basilicata), B. mutabilis (solo in Calabria), B. obliqua (Italia centro meridionale, a partire dal Lazio). Tendono a crescere in ambienti disturbati caldi e aridi; i fiori generalmente bianchi, portati su lunghi racemi, hanno quattro petali profondamente divisi e sono seguiti da silique ovoidali. Qualche informazione in più nella scheda. Quando Mociño mostrò a de Candolle i disegni eseguiti durante la Real Expedicion Botanica, che aveva sottratto al saccheggio trasportandoli da Madrd a Montpellier con una carretta a mano, in cui trascorreva le notti facendo loro letteralmente scudo con il suo corpo, il botanico svizzero ne fu stupefatto, tanto da esclamare che superavano per qualità scientifica ed estetica quelli del tanto celebrato Redouté. Eppure erano opera non di illustri pittori accademici, ma di due illustratori botanici messicani, Vicente de la Cerda e Atanasio Echeverría, che per circa quindici anni avevano condiviso tutte le avventure della spedizione, accompagnando i botanici in ogni angolo della Nuova Spagna e disegnando qualcosa come 4000 tavole. Poiché molte delle piante essiccate erano andate perdute per le circostanze della guerra, attraverso le copie eseguite per de Candolle dalle dame ginevrine, quei disegni furono a lungo l'unica testimonianza visibile di molte nuove specie descritte nei manoscritti di Sessé e Mociño e una fonte fondamentale per il Prodromos dello stesso de Candolle. Il quale, riconoscente, volle dedicare due nuovi generi agli artisti messicani: quello che toccò a de la Cerda è piccolo e misconosciuto, mentre Echeverría si è aggiudicato il più noto, amato e coltivato tra quelli che onorano i membri della spedizione.  Due giovanotti vivaci e volenterosi La realizzazione di un corredo di disegni botanici dal vivo della flora messicana fu fin dall'inizio uno degli obiettivi fondamentali della Real Expedición Botánica a Nueva España. Gli artisti cui sarebbe stato affidato questo compito dovevano essere ingaggiati sul posto; Martin de Sessé si rivolse perciò al direttore della Reale Accademia d'Arte di San Carlos, Jéronimo Antonio Gil; sebbene l'illustrazione botanica non fosse prevista nei corsi dell'Accademia, Gil scelse quattro allievi del corso di incisione cui fornire una preparazione specifica, sulla scorta delle puntuali indicazioni di Sessé, che li visitava assiduamente. Alla fine due furono i prescelti: il talentuoso Atanasio Echeverría y Godoy e il volenteroso Juan de Dios Vicente de la Cerda, meno dotato ma capace di significativi progressi. I due, descritti come giovanotti (avevano diciotto o diciannove anni) docili, volenterosi e dediti al lavoro, vennero assunti con una paga di 600 pesos annui per l'attività in bottega, da raddoppiarsi per il lavoro sul campo. Benché questa paga fosse la metà di quella percepita dagli artisti spagnoli che avevano partecipato alla spedizione nel Vicereame del Perù, fu ulteriormente ridotta a 500 pesos dalla Junta Real, l'Organo amministrativo della colonia. Da quel momento, e per circa quindici anni, i due artisti accompagnarono, ora insieme ora separatamente, le "escursioni" della spedizione. Il primo a partire fu de la Cerda, che partecipò alla prima campagna dell'ottobre 1787 nei dintorni della capitale; Echeverría seguì poco dopo. Poiché le loro opere sono rarissimamente firmate e i due pittori, oltre ad essere allievi dello stesso maestro, obbedivano alle identiche convenzioni dell'illustrazione scientifica, è difficile distinguere il lavoro dell'uno da quello dell'altro (tranne per i disegni che si riferiscono a piante di aree visitate da uno solo); nonostante ciò, agli occhi degli esperti almeno in qualche caso la mano di Echeverría è riconoscibile per la sicurezza del tratto, l'abilità nel tratteggio delle ombre, la luminosità dei colori, la precisione dei dettagli. Certa è invece l'enorme mole di lavoro compiuto, in parte sul campo in parte in atelier. Già all'inizio di maggio 1788 i due pittori avevano realizzato 187 tavole. Alla fine ufficiale della spedizione, sedici anni dopo, sarebbero state oltre 4000. I documenti della spedizione ci permettono di ricostruire la loro attività con una certa precisione. I due pittori accompagnarono insieme la prime due escursioni e la prima parte della terza, quando i botanici si divisero in due sottogruppi. I disegni realizzati in questa prima fase obbediscono a criteri formali molto precisi (inclusi in un rettangolo, con la pianta inserita al centro, adattandone per così dire la disposizione a questo rigido spazio), furono probabilmente eseguiti in collaborazione dai due artisti, che ne prepararono almeno due copie (una da inviare a Madrid, l'altra da conservare a Città del Messico a corredo del corso di botanica tenuto da Vicente Cervantes; in alcuni casi, furono eseguite ulteriori copie). Nella seconda fase, ciascuna sotto équipe fu invece formata generalmente da un solo botanico, accompagnato da un naturalista e da un disegnatore. Portando con sé i propri materiali (la carta, necessaria sia per i disegni sia per l'erbario, era il prodotto più ingombrante e indispensabile, poi c'erano i colori, le matite, le penne, i pennelli, le gomme e i raschiatoi), dovevano affrontare lunghi viaggi a piedi, dormire in una tenda, lavorare sul campo spesso in condizioni difficili. Mano a mano che il numero di specie raccolte cresceva, dovevano anche lavorare in fretta, per documentarne il maggior numero nel minor tempo possibile, non trascurando però i particolari anche minuscoli indispensabili per l'identificazione. In questa seconda fase, non vennero più eseguite copie sul campo. Anzi, spesso il pittore realizzava solo un bozzetto, che poi sarebbe stato completato in un secondo tempo. Come si vede dall'immagine che ho scelto, il pittore tracciava il disegno a matita, con una linea molto sottile ma sicura; il disegno veniva quindi ombreggiato con china o inchiostro ferrogallico steso a pennello; soltanto per gli esemplari più interessanti almeno alcuni particolari erano colorati con velature successive ad acquerello. Il bozzetto poteva poi essere completato in atelier, talvolta anche con l'ausilio di altri artisti (come Francisco Lindo, un altro allievo del San Carlos) che erano impegnati anche nella realizzazione di copie. Ma molti disegni sono rimasti allo stadio di bozzetto.  Avventure di uomini e disegni A partire dagli ultimi mesi del 1791, Echeverría e Cerda non lavorarono più insieme sul campo. Quando la spedizione si divise per esplorare le regioni del Messico nordoccidentale, a Echeverría, con Mociño e Castillo, toccò l'area più impervia e settentrionale, fino al deserto di Sonora, mentre Cerda esplorava l'attuale stato di Sinaloa con Sessé e Maldonado. Tra il 1792 e il 1793, ancora Echeverría fu prescelto, insieme a Mociño e Maldonado, per la spedizione di Nootka (ce ne rimane una serie di piante regionali molto riconoscibili, caratteristiche delle regioni costiere umide del Pacifico nordorientale), mentre Cerda, attraversando il Messico centrale, rientrava a Città del Messico con Sessé e l'ormai malatissimo Castillo, avendo qui agio di completare, nei molti mesi che vi trascorse prima del ritorno del collega, molti bozzetti. Tra luglio e dicembre 1793, quando Sessé visitò le aree di Puebla e Veracruz, fu presumibilmente accompagnato prima da Echeverría , poi da Cerda. L'anno successivo, Echeverría accompagnò nuovamente Mociño nelle aree di Veracruz, Oaxaca, Tabasco. Quando poi la spedizione venne allargata ai Caraibi e all'America centrale, nuovo scambio di ruoli: mentre insieme a Mociño Cerda si spingeva in Guatemala, Salvador, Nicaragua e Costa Rica, Echeverría era con Sessé a Cuba e Puerto Rico. Le 140 tavole da lui dipinte nelle Antille sono considerate il suo capolavoro, rimarchevoli per l'attenzione ai dettagli e i colori vividi. Del resto, il dotatissimo Echeverría era ormai un artista riconosciuto, tanto che quando Sessé rientrò a Città del Messico, egli rimase a Cuba, entrando a far parte, come aiuto di José Guío, il pittore ufficiale, della Commissione di Guantanamo, una spedizione a carattere a metà tra scientifico e militare, durante la quale fu raccolta un'eminente collezione di pesci, uccelli e anche piante. Ritornato a Città del Messico intorno al 1802, l'anno successivo seguì Sessé e Mociño in Spagna, che però lasciò quasi immediatamente, per lo stato di guerra del paese, rientrando in Messico, dove fu nominato direttore della Reale accademia di San Carlos, morendo però presumibilmente poco dopo. Altro non sappiamo della sua vita; ancor meno di quella di Vicente de la Cerda. Sappiamo che Sessé avrebbe voluto che anche lui lo accompagnasse in Spagna, ma la Giunta gli impose invece di rimanere in Messico, al servizio dell'Orto botanico. Non conosciamo però né la data della sua morte né altri particolari sulla sua esistenza da questo momento in poi. Ma c'è ancora una storia da raccontare: quella delle meravigliose tavole create dai due artisti messicani. Alcune furono effettivamente consegnate all'Orto botanico di Madrid e lì sono ancora custodite; alcune copie rimasero a Città del Messico, altre furono donate a vario titolo; ma il grosso della collezione rimase nelle mani di Mociño che le portò avventurosamente con sé nel suo esilio in Francia, affidandolo a de Candolle. Ho già raccontato in questo post come il botanico svizzero, dovendo restituire i disegni in tutta fretta all'amico, le avesse fatte copiare da un centinaio di signore di Ginevra (dove queste copie sono tuttora conservate). Gli originali, invece, dopo la morte di Mociño sembrarono perduti per sempre. Stavano invece vivendo una vita sotterranea: passati nelle mani del dottore che aveva assistito Mociño nella sua ultima malattia, fino alla fine dell'Ottocento rimasero, sconosciuti a tutti, tra i beni ereditari dei suoi discendenti. Verso la fine del secolo dovettero essere venduti allo storico e bibliofilo Lorenzo Torner Casas. La biblioteca dell'erudito catalano passò poi al fratello minore e ai due nipoti, Jaime e Luis Torner Pannocchia, che nel 1979 li cedettero all'Hunt Institute di Pittsburg, dove giunsero nel 1981, ritornando ad essere accessibili agli studiosi dopo 160 anni. Se ne volete sapere di più, la storia della Torner Collection of Sessé and Mociño Biological Illustrations è raccontata con maggiori particolari in questa pagina del sito dell'istituzione americana.  La modesta e multiforme Cerdia Grande ammiratore del lavoro di Cerda e Echeverría, che divenne anche il principale punto di riferimento per la stesura della sua Flore du Mexique, de Candolle volle onorare i due artisti dedicando a ciascuno di loro uno dei nuovi generi messicani pubblicati in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis (1828), sulla scorta degli appunti di Sessé e Mociño. Entrambi sono ancora validi, ma ben diversi per ampiezza e notorietà. Per volontà di Sessé e Mociño, rispettata da de Candolle, al modesto e solerte Vicente del la Cerda è toccato il monotipico Cerdia, della famiglia Cariophyllaceae, rappresentato dalla poco appariscente C. virescens, una minuscola erbacea perenne a cuscino con fiori bianco-verdastro privi di petali che poco si distinguono dal fogliame. Endemica delle aree aride del Messico, dal deserto di Chihuahua alle montagne centrali, è una specie piuttosto variabile - per il colore e la disposizione delle foglie, il numero di fiori per infiorescenza, la morfologia dei tepali e delle brattee, la presenza o l'assenza di stipole - tanto che in passato ne furono distinte quattro specie; oggi, sulla base di studi molecolari, tutte sono ricondotte a C. virescens. Qualche approfondimento nella scheda. 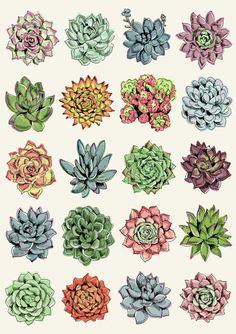 Echeveria, una scelta infinita Se nessuno di noi, a meno di essere un esperto di flora dei deserti messicani, ha mai visto una Cerdia, alzi la mano chi non conosce e coltiva le Echeveriae. Al brillante Atanasio Echeverría è infatti toccato in sorte uno dei generi più noti, amati e coltivati dell'intera famiglia Crassulaceae. A dire il vero, Sessé e Mociño avevano destinato al più dotato dei loro pittori un'altra specie dei deserti messicani, l'ocotillo, un arbusto spinoso simile a un rovo che alla prima pioggia si trasforma in una cascata di fiori rosso fiamma. Ma, prima che de Candolle potesse pubblicarlo, era stato anticipato da Kunth (il collaboratore di Humboldt) che l'aveva battezzato Fouquieria splendens. Dunque l'assegnazione del nostro Echeveria a Atanasio Echeverría fu decisa dal solo de Candolle, sulla base di tre specie che Sessé e Mociño avevano assegnato ai generi Cotyledon e Sedum. Echeveria è un genere vastissimo, con oltre 150 specie di piante succulente sempreverdi, talvolta suffrutici, con foglie per lo più a rosetta, diffuse prevalentemente negli habitat aridi di media e alta quota del Messico (una specie raggiunge il Texas e alcune, attraverso il Centro America, si spingono fino all'America andina). Sono tra le succulente più popolari soprattutto per la bellezza delle foglie, in una vasta gamma di forme e colori (che includono il verde, il grigio, l'azzurro, il porpora, il rosato), generalmente raccolte in una rosetta più o meno globosa o aperta, ma anche per la facilità della coltivazione e della propagazione (è molto facile riprodurle anche da una singola foglia). I fiori campanulati, anch'essi piuttosto carnosi, raccolti in cime o pannocchie su lunghi steli lievemente arcuati, con i loro colori in tecnicolor (aranciati, rossi, rosati, spesso con apice dei petali giallo) aggiungono un'ulteriore attrattiva. Impossibile citare anche solo le specie più abitualmente coltivate; la scelta è ampissima, con centinaia e centinaia di cultivar. Disponibili in un'infinita varietà di forme e colori, attraenti tutto l'anno, a prova di pollice secco, relativamente rustiche, sono apprezzate tanto dai collezionisti a caccia dell'ultima novità quanto dal "coltivatore" più occasionale. Alle numerosissime varietà e agli ibridi interspecifici, si aggiungono anche gli ibridi intergenerici con altri generi di Crassulaceae; i più noti e disponibili sul mercato sono quelli con gli affini Pachyphytum, Graptopetalum, Sedum sezione Pachysedum (x Pachyveria, x Grapteveria, x Sedeveria). Qualche informazione in più nella scheda. Concludiamo con una nota dolente: sembra che, nonostante l'incredibile varietà di forme e di colori resa possibile dal lavoro di selezione e creazione di vivaisti e ibridatori, il mercato sia alla ricerca di qualcosa di diverso, di ancor più strabiliante. Così, da qualche anno, soprattutto nel periodo natalizio, ecco sui bancali di fiorai e garden center fare brutta mostra di sé le grandi rosette di E. agavoides (una specie assai robusta e facile da coltivare, che può raggiungere anche un diametro di 20 cm) verniciate in giallo, blu, rosso, nero, oro. Al di là del giudizio estetico, si tratta di una pratica assassina: la vernice impedisce alle foglie di respirare e di effettuare la fotosintesi; nell'arco di pochi mesi, la pianta è destinata a perire. Per gli olandesi che le producono a migliaia di esemplari, poco importa: gli affari sono affari. Ma per chi ama il verde e rispetta la natura, è un infelice connubio di ignoranza, cattivo gusto e consumismo. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|


 RSS Feed
RSS Feed