|
Diverse specie del genere Galinsoga rientrano indubbiamente nel novero delle piante viaggiatrici, o anche in quello delle piante vagabonde. Originarie delle aree montuose del centro America e dell'America tropicale, nell'arco di pochi secoli sono riuscite a colonizzare tutti i continenti (eccetto l'Antartide), sfuggendo dagli orti botanici dove erano state introdotte come curiosità per intrufolarsi ovunque trasportate dal vento e dall'acqua, infiltrate negli imballaggi e in veicoli di ogni genere, mescolate a terricci, sementi e prodotti agricoli. A donare il suo nome a queste infaticabili viaggiatrici dall'aspetto apparentemente innocente, oggi tra le infestanti più temute, è stato un medico e uomo di potere della Spagna di fine Settecento, Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga, primo medico della regina Maria Luisa e intendente dell'orto botanico di Madrid. Morto piuttosto giovane, si segnala soprattutto per essere stato uno dei primi specialisti di ginecologia; come tale lanciò i suoi strali contro un aggeggio di moda, o meglio di tortura: il corsetto, che donava alle dame un vitino di vespa a prezzo di gravi menomazioni fisiche. Insomma, nel suo nome si incrociano due storie di effetti collaterali. 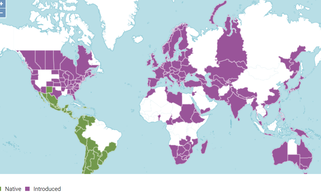 L'inarrestabile viaggio di Galinsoga All'interno della loro numerosissima famiglia (sono Asteraceae, la più vasta tra le fanerogame) le specie del genere Galinsoga non possono certo aspirare al primato per bellezza o vistosità, ma in qualcosa sono indubbiamente delle campionesse: la capacità di viaggiare e diffondersi in ogni dove, con mezzi propri, ma soprattutto con l'aiuto più o meno incauto degli esseri umani. Originarie dell'America tropicale e subtropicale, con centro di diversità nelle aree montuose del centro America, sono annuali con semi privi di dormienza che germinano rapidamente, fioriscono molto presto, completano il ciclo vitale in circa cinquanta giorni, il che permette molteplici generazioni nell'arco di una stagione e, ovviamente, producono semi copiosissimi con una straordinaria vitalità (oltre il 90%). Poco esigenti, possono vivere ovunque, ma danno il meglio (o il peggio) di sé in suoli umidi e dove possono godere di lunghe giornate di luce. Tra i luoghi preferiti, i terreni disturbati, i giardini, gli orti e coltivi di ogni tipo, incluso grano, granoturco, tabacco, cotone, patate, e ogni altra coltivazione da reddito che riuscite ad immaginare. Dalle loro sedi originarie due specie (le altre sono endemismi poco diffusi e se ne stanno tranquille) sono partite alla conquista del mondo verso la fine del XVIII secolo, quando i botanici si sono accorti di loro, hanno dato loro un nome (ne parliamo tra poco) e le hanno tanto entusiasticamente quanto incautamente seminate negli orti botanici. Per prima è arrivata Galinsoga parviflora, approdata all'orto botanico di Madrid nel 1795 e ai Kew Gardens nel 1796; tempo pochi decenni, aveva già conquistato l'Inghilterra meridionale, tanto da guadagnarsi il nome di Kew weed, l'erbaccia di Kew. Nel corso dell'Ottocento, di orto botanico in orto botanico, si è diffusa nel continente europeo; poi ha continuato il suo cammino, trasportata dal vento, dalle acque, da animali, da veicoli di ogni tipo, dai vestiti e dalle suole delle scarpe, nascosta in scatole e imballaggi, mescolata a terriccio, ammendanti, sementi e ortaggi. Oggi è presente in tutti i continenti eccetto l'Antartide e in moltissimi paesi è considerata una infestante tra le peggiori. Qualche dato sulla sua attuale diffusione nel mondo in questa pagina di CABI (Centre of Agricolture and Bioscience international). Un po' più lenta ma non meno trionfale la marcia di Galinsoga quadriradiata (spesso nota con il sinonimo G. ciliata). Nel 1836 la troviamo a Filadelfia nel Bartram Botanical Garden; ne sfugge presto, si naturalizza prima nei dintorni e poi prosegue verso nord; oggi è naturalizzata in gran parte degli Stati Uniti e in Canada ed è arrivata persino in Alaska. Il primo approdo in Europa è forse l'orto botanico di San Pietroburgo, nel 1846; in Germania la prima segnalazione è del 1892, ad Amburgo; nel corso del Novecento si diffonde a macchia d'olio in tutto il continente. Oggi gli unici paesi europei in cui non sembra arrivata sono l'Islanda, le isole Faroe e la Groenlandia. Anche per questa specie, diffusa anche nel resto del mondo, rinvio alla scheda di CABI. Anche nel nostro paese, dove entrambe le specie sono naturalizzate e presenti in tutte le regioni, la prima ad essersi diffusa risulta G. parviflora, segnalata per la prima volta in un orto di Tezze Valsugana nel 1820; da qui si diffuse prima nella Valsugana, quindi nella provincia, e così via. Non abbiamo dati così precisi per G. quadriradiata che potrebbe essere arrivata nella seconda metà dell'Ottocento, anche se per molte regioni le prime segnalazioni risalgono al secolo scorso. Ha fatto però in fretta a recuperare e oggi sembra più diffusa della prima arrivata.  Una carriera di successo e una battaglia igienico-sanitaria Il nome di questa vigorosissima ed inarrestabile erbaccia è un omaggio dei soliti Ruiz e Pavon a un personaggio all'epoca assai influente, Ignacio Mariano Martinez de Galinsoga, primo medico della regina di Spagna e intendente dell'orto botanico di Madrid. Nel 1794, quando i due botanici crearono il genere sulla base delle loro raccolte in Perù, la sua posizione a corte era seconda solo a quella del protomedico Francisco Martinez Sobral. Galinsoga la doveva in parte a una solida preparazione professionale, ma ancor più alla alla protezione della regina Maria Luisa. Aveva iniziato la carriera a 21 anni come chirurgo, o meglio come cirujano latino. il titolo che distingueva gli abilitati in chirurgia con formazione universitaria, inclusa la conoscenza del latino, dagli illetterati cirujanos romancistas con formazione pratica attraverso l'apprendistato. Laureatosi in medicina all'Università di Valladolid, dove serviva come chirurgo militare, era poi passato nella capitale, dove frequentò gli ambienti accademici e incominciò a farsi conoscere come specialista in malattie femminili (noi oggi diremmo in ginecologia). Fu così che fu più volte incaricato di selezionare le balie per i nuovi nati della coppia regale; un incarico che svolse con scrupolo, visitando i villaggi che avevano fama di maggiore salubrità, alla ricerca di gestanti di eccellente salute e sani principi morali. Si dimostrò così abile ed efficiente, che nel 1789 fu nominato medico della famiglia reale, dando inizio a un'ascesa quasi inarrestabile come la marcia della Galinsoga. Nel 1790 era medico di camera e nel 1791 primo medico di camera della regina; come tale, nell'ambito della ristrutturazione del Tribunale del Protomedicato, l'istituzione che regolava tutte le professioni sanitarie e esaminava i futuri medici, ne fu nominato vicepresidente, con salario, prerogative e incarichi equivalenti a quelli del presidente, il medico di camera del re, don Francisco Martinez de Sobral, con il quale avrebbe dovuto alternarsi nella direzione effettiva. Inutile dire che il medico più anziano (all'epoca Sobral era sessantenne, mentre il rampante Galinsoga aveva appena 34 anni) non la prese affatto bene, tanto più che mai in precedenza il medico della regina aveva avuto tali privilegi. Ne seguirono tensioni e conflitti di competenza, che il re cercò di risolvere rafforzando la posizione di Galinsoga, che alla fine del 1791 fu nominato intendente dell'Orto botanico di Madrid e protomedico dell'esercito (incarichi fino ad allora tradizionalmente affidati al medico del re). Una decisione destinata ad aumentare le tensioni, più che a sopirle. Era questa la situazione a corte quando Ruiz e Pavon in Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus (1794) pubblicarono i 149 nuovi generi raccolti nella spedizione in Perù, dedicandoli prevalentemente a glorie della scienza e della medicina iberica, di cui volevano dimostrare l'eccellenza. Per non fare torto a nessuno, uno toccò a Galinsoga, un altro a Sobral. Ma se guardiamo alle piante assegnate rispettivamente ai due protomedici rivali, forse non si tratta di una scelta di equidistanza: Galinsoga, lo abbiamo visto, comprende piccole annuali dalle fioriture insignificanti, Sobralia raffinate orchidee dalle fioriture spettacolari. Poco dopo, fu la morte precoce del più giovane (una sintesi biografica nella sezione biografie) a mettere fine alla rivalità e alla vita di Galinsoga, morto a solo quarant'anni nel 1797. Oltre che medico di successo, fu anche insegnante universitario, membro di innumerevoli società scientifiche, membro fondatore della Real Academia nacional de Medicina; tra i suoi meriti, la creazione presso l'Ospedale generale di Madrid dello Studio reale di medicina pratica (1795) dove i futuri medici avrebbero svolto i due anni di praticantato prescritti, che in precedenza erano costretti a svolgere privatamente sotto la supervisione di un medico. Quanto alla sua gestione del Reale orto botanico, non sembra aver lasciato molte tracce; ma la carica di intendente era amministrativa e politica, mentre la reale direzione era nelle mani del primo professore di botanica, all'epoca Casimiro Gomez Ortega. Prima di congedarci da Galinsoga, vale la pena di dedicare qualche riga alla sua unica opera a stampa, il curioso opuscolo Demostración mecánica de las enfermedades que produce el uso de las cotillas, pubblicato nel 1784. Tra gli accessori indispensabili delle dame dell'epoca c'era il corsetto (il modello spagnolo si chiamava cotilla, letteralmente "piccola corazza") in stoffa e stecche di balena, che aveva lo scopo di modellare la figura assottigliando il punto vita e spingendo verso l'alto il seno; stretto da una serie di lacci, obbligava a una postura rigida e impediva parzialmente i movimenti. Nel corso del Settecento, con l'Illuminismo e il Preromanticismo, cominciò tuttavia a diffondersi anche nella moda l'esigenza di una maggiore naturalezza e praticità e il corsetto finì sotto attacco. Ne è un esempio l'articolo scritto nel 1785 da Jean Jacques Rousseau per The lancet. In questa polemica si inserisce perfettamente l'opuscolo di Galinsoga, che, rispetto ad altri critici, i quali fanno spesso appello a considerazioni moralistiche, si muove su un piano strettamente medico. Nella prefazione, egli afferma di poter provare che molte delle infermità di cui soffrono le madrilene sono causate da questa moda funesta; basta paragonare la costituzione debole e asfittica delle dame della corte con la salute robusta, briosa e costante delle popolane delle campagne; la colpa è tutta del corsetto che "tormenta tutte le viscere del basso ventre, le strangola, ne disloca la posizione, e ne muta la forma, tanto che tutte le operazioni di questi organi ne diventano imperfette". Tra le conseguenze, trombosi a causa della cattiva circolazione venosa; neuriti per compressione; sincopi, svenimenti e letargia per difficoltà cardio-respiratorie; ernie e prolassi genitali; difficoltà digestive, nausee, vomiti e indigestioni. Galinsoga si spinge addirittura a accusare i corsetti di provocare alcune malattie veneree: "La leucorrea e la gonorrea semplice sono cattivi inquilini di Madrid, e non si vedono mai tra i contadini". Non parliamo poi delle conseguenze per la prole, decimata dagli aborti o contraffatta nella figura, nuovamente con gli alti e gagliardi montanari contrapposti ai miserevoli madrileni, rattrappiti nel ventre materno dai malefici corsetti a detrimento della nazione iberica.  Soldati galanti in marcia Per concludere, torniamo brevemente sul genere Galinsoga. cui sono assegnate dodici specie diffuse spontaneamente tra Messico, Antille e Sud America. Sono erbacee annuali dal fusto gracile, con foglie opposte da lanceolate a quasi romboidali, con margini interi o serrati, glabre oppure pelose. Le infiorescenze sono capolini di piccole dimensioni, con fiori del disco solitamente gialli, con corolle tubolari a cinque denti, che formano un bottoncino dorato, tutto sommato più appariscente dei fiori del raggio tridentati, bianchi o gialli, minuti e piuttosto radi. A parte le ormai onnipresenti G. parviflora e G. quadriradiata, le altre specie sono solitamente endemismi diffusi in aree circoscritte: ad esempio, G. caligensis è una specie peruviana presente solo nelle regioni desertiche della regione di Lima; G. durangensis è invece originaria degli stati di Durango e Sinaloa nel Messico nordoccidentale; G. formosa vive solo nello stato messicano di Oaxaca. Quest'ultima specie è la miss del genere: i numerosissimi fiori del disco (circa cento) formano una cupola molto rilevata, circondata da 5-15 fiori del raggio gialli, talvolta soffusi di porpora. Tradizionalmente usate nella medicina popolare fresche o in decotto, le galinsoga sono anche commestibili, anzi proprio l'umile G. parviflora è l'irrinunciabile protagonista di alcuni piatti della cucina sudamericana, cui dona un particolarissimo aroma. Un'ultima curiosità: il nome comune inglese di questa specie è gallant soldier, "soldato galante" o "coraggioso", un'etimologia popolare ovvero una reinterpretazione ad orecchio del nome botanico, incomprensibile per i britannici. Per analogia, l'altra specie naturalizzata, la villosa G. quadriradiata, è diventata shaggy soldier, "soldato capellone". Non sembra esserci molto di militaresco nelle Galinsoga, ma è innegabile che questi soldatini più o meno capelluti e ben poco galanti, ma indubbiamente coraggiosi, si sono inesorabilmente messi in marcia. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
Di origini italiane, ma nato in Francia e naturalizzato belga, Henri Guillaume Galeotti tra il 1835 e il 1840 fu protagonista di una importante spedizione in Messico, in cui unì le sue due competenze: quella di geologo e quella di botanico. Visitando regioni all'epoca in larga parte inesplorate, spesso di difficile accesso, come gli altopiani e le montagne del Messico centrale, fece imponenti raccolte, facendo conoscere alla scienza numerose nuove specie, in particolare orchidee e cactacee, le sue piante preferite. Al suo ritorno in Belgio, aprì un vivaio dedicato proprio a loro, ma non fu molto fortunato. Lo fu invece nella sua gestione dell'Orto botanico di Bruxelles, nota come "era Galeotti". Lo ricordano due generi di orchidee, ovviamente di casa in Messico: Galeottia e Galeottiella. 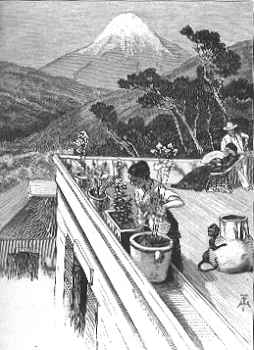 Un grande e instancabile raccoglitore Nato a Parigi da genitori italiani, ma arrivato in Belgio nella prima infanzia, Henri Guillaume Galeotti era un vero figlio d'Europa. Subito dopo l'indipendenza del Belgio, nel 1830, fu uno dei primi allievi dell'Etablissement Géographique, la straordinaria istituzione privata creata dal cartografo Philippe Vandermaelen. Si trattava molto di più di uno stabilimento industriale dove si stampavano carte, atlanti e dizionari geografici; Vandermelen sognava di farne un centro scientifico e didattico dove sarebbero confluite le conoscenze geografiche di tutto il mondo. Lo dotò di una ricchissima biblioteca, di collezioni naturalistiche e etnografiche, di un medagliere e di vari laboratori, compreso un laboratorio di anatomia comparata. In modo più o meno formalizzato, vi si tenevano lezioni gratuite, destinate a ragazzi tra 14 e 18 anni; in tal modo, vi si formò un'intera leva di giovani tecnici e scienziati di modeste origini familiari, che altrimenti non avrebbero avuto accesso agli studi. Grazie alla passione per le piante del fratello Jean-François Vandermaelen, lo stabilimento divenne anche un importante centro di studi botanici, con un erbario, un giardino con piante esotiche, due serre, una scuola di botanica dove due volte alla settimana Michel Scheidweiler insegnava botanica e fisiologia vegetale. Galeotti approfittò fino in fondo di questo ambiente così ricco di stimoli: si appassionò di scienze naturali, divenne un abile disegnatore e si specializzò in geologia; nel 1835, poco più che ventenne, si laureò con una tesi sulla struttura geologica e paleontologica del Brabante, che fu premiata e pubblicata dall'Accademia reale del Belgio. Ma quando venne a sapere del premio, era già in viaggio per il Messico. I fratelli Vandermaelen infatti, per accrescere le collezioni geologiche, naturalistiche e botaniche dell'Etablissement, organizzarono e finanziarono diverse spedizioni di ricerca. Nel 1832, inviarono in Brasile due giovani formatosi alle scuola dello stabilimento: Gédéon Crabbe che. oltre a seguire le lezioni di scienze naturali e disegno, vi prestava servizio come aiuto giardiniere, e Achilles Deyrolle, figlio del tassidermista del Museo di Bruxelles, allievo delle classi di zoologia. I due tra il 1832 e il 1834 esplorarono per sedici mesi la provincia di Rio e ritornarono in patria con notevoli collezioni; c'erano anche piante vive, tra cui un'orchidea che in onore dei loro protettori battezzarono Maelenia paradoxa (oggi sinonimo di Cattleya forbesii). Nel 1837 fu la volta dei fratelli Jean-Baptiste e Honoré Lacourt, inviati in Australia. Ma la più importante spedizione naturalistica sponsorizzata dai fratelli Vandermaelen fu proprio quella di Galeotti in Messico. Imbarcatosi ad Amburgo, egli sbarcò a Veracruz alla fine del 1835, iniziando immediatamente le ricerche geologiche e botaniche. I primi mesi furono dedicati all'esplorazione dello stato di Veracruz, in particolare attorno a Xalapa e alla colonia tedesca di El Mirador. Nei tre anni successivi egli esplorò estesamente gli altopiani interni; nell'estate del 1836 fece raccolte a Real del Monte insieme al tedesco Carl August Ehrenberg. Non gli facevano paura neppure i grandi vulcani: fu il primo botanico a scalare il Cofre del Perote; nel 1837, esplorò le pendici del Popocatepl, raccogliendo esemplari fino al limite delle nevi; nell'agosto 1838 scalò il Pico de Orizaba insieme a Funck, Ghiesbreght e Linden. Dal loro campo base, situato in una caverna a circa 3300 metri d'altezza, raccolse tra 400 e 500 piante di alta quota. L'ultimo anno, si spostò a sud, da Puebla a Oroxaca, dove raccolse le collezioni botaniche più importanti. Lasciò il Messico nel giugno 1840 e ritornò in Belgio via Cuba, dove raccolse ancora qualche pianta. 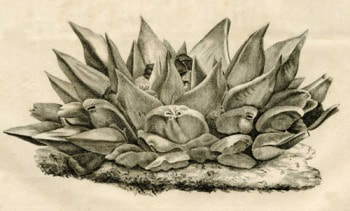 Un vivaio senza fortuna e un orto botanico ben gestito Senza trascurare il lavoro geologico, anch'esso di primaria importanza, Galeotti si rivelò un grande raccoglitore di piante, con all'attivo circa 8000 esemplari di 931 specie diverse. Importanti furono soprattutto le sue collezioni di orchidee e di cactacee. Tra le piante vive che spedì a Bruxelles, la maggioranza appartenevano a quest'ultima famiglia; tra di esse alcune rarità come Ariocactus retusus, raccolto in altura nel deserto di Chihuahua; Astrophytum myriostigma, con l'insolita forma a stella che lo fa assomigliare alla berretta di un vescovo; il variabile e difficile Echinocactus horizontalonius. Anche il suo contributo alla conoscenza delle orchidee messicane è assai rilevante; tra le specie da lui raccolte per la prima volta Barkeria melanocaulon, Bletia adenocarpa, Cyclopogon luteo-albus, C. saccatus, Epidendrum galeottianum, E. longipetalum, E. propinquum, Masdevallia galeottiana, Pleurothallis violacea, Prosthechea chondylobulbon, Schiedeella violacea. Al suo ritorno in Belgio, gli fu offerta una cattedra all'Università di Bruxelles, ma egli rifiutò, preferendo aprire un proprio vivaio presso Lovanio, dove intendeva importare e coltivare piante rare, in particolare le amate cactacee. Contemporaneamente, scrisse diverse memorie di argomento geologico e botanico per l'Accademia delle Scienze; pubblicò alcune specie insieme al suo maestro Scheidweiler, ma per lo più affidò la pubblicazione delle raccolte botaniche ad alcuni importanti specialisti: per le cactacee Charles Antoine Lemaire; per le orchidee Achille Richard (che avvalendosi dei suoi quaderni di campo pubblicò Monographie des orchidées mexicaines (1844); Trunius per le Poaceae; Martens per le felci. Con quest'ultimo nel 1842 pubblicò l'importante Memoire sur les Fougères du Mexique, et considérations sur la géographie botanique de cette contrée e collaborò a lavori sulle Gesneriaceae e le Solanaceae messicane. Intanto aveva preso la cittadinanza belga; intorno al 1850, colpita dalla crisi economica seguita agli eventi del 1848, la sua impresa fallì e fu costretto a cercare altre fonti di reddito. Dal 1852 divenne curatore del Journal d'Horticulture Pratique e nel 1853 accettò l'incarico di direttore dell'Orto botanico di Bruxelles. I cinque anni in cui diresse il giardino sono passati alla storia come "era Galeotti". Egli mise a frutto la sua esperienza di raccoglitore e la sua ampia rete di corrispondenti per incrementare gli scambi con altri orti botanici e acquisire collezioni di essiccata e piante vive; furono anche assunti altri giardinieri e accresciuta la biblioteca. Purtroppo, questa specie di età dell'oro durò poco: da tempo malato, Galeotti morì di tubercolosi a soli 44 anni. L'orto botanico di Bruxelles riuscì ad aggiudicarsi l'erbario, venduto dalla vedova.  La splendida Galeottia e la minuscola Galeottiella Oltre a diversi nomi specifici, come Senecio galeottii o Phyllantus galeottianus, il ricordo di Galeotti è affidato a due generi di orchidee, Galeottia e Galeottiella. Galeottia gli fu dedicato nel 1845 da Richard, sulla base di G. grandiflora, una bella specie raccolta dal dedicatario in Messico. Questo piccolo genere di una dozzina di orchidee epifite o terrestri è diffuso nelle foreste umide di bassa quota tra Messico e Sud America settentrionale. Affini a Zygopetalum, di medie dimensioni, portano fiori molto belli, con labello fimbriato, petali e sepali molti allungati con apici acuti, quasi a stella, rigati o macchiettati, il cui aspetto evoca qualche fantastico insetto tropicale. Per attirare i loro impollinatori, emanano un profumo complesso, greve, quasi intossicante. Si fanno notare molto meno le due specie del genere Galeottiella, creato da Schlechter nel 1920 separando da Spiranthes una specie raccolta da Galeotti in Messico. Con questa dedica, il botanico tedesco volle ricordare il grande contributo di Galeotti alla conoscenza delle orchidee messicane, aggiungendo un secondo genere a quello istituito da Richard. Si tratta di minute orchidee terrestri originarie delle praterie di alta quota del Messico e del Guatemala, con spighe di piccoli fiori tubolari caratterizzati dai sepali laterali con gli apici rivolti indietro, e petali e sepalo superiore quasi fusi a cappuccio. Nella stagione arida vanno in riposo, per spuntare e fiorire in quella delle piogge. Un sottile filo rosso lega la passione ottocentesca per le orchidee e la rivoluzione industriale: i progressi nella navigazione marittima accorciano le distanze, rendendo più accessibili i paesi esotici; le spedizioni dei cacciatori di piante si moltiplicano, finanziate non più solo dagli Stati e dalle istituzioni scientifiche, ma da cordate di affaristi e da grandi aziende vivaistiche, in spietata concorrenza; il collezionismo di piante esotiche diviene uno status symbol che investe nuove figure come banchieri, magnati del commercio e dell'industria, desiderosi di affermazione sociale. Ma soprattutto, l'incremento della produzione di acciaio e ghisa rende possibile la costruzione delle grandi serre ventilate indispensabili per coltivare le orchidee con successo. E non a caso, dopo le rivoluzioni del 1830-31, la mania per le orchidee, nata in Inghilterra intorno al 1818, attraversa la Manica e dilaga prima in Belgio, poi in Francia. Facciamo dunque anche noi tappa in Belgio per incontrare l'uomo che per primo, studiando le orchidee tropicali in natura, ne comprese le esigenze e gettò le basi per la loro coltivazione industriale: Jean Linden. Insieme a lui conosceremo i suoi collaboratori Nicolas Funck e Louis Joseph Schlim, che, a differenza del loro principale, sono onorati da due generi validi; di Orchidacee, ovviamente! 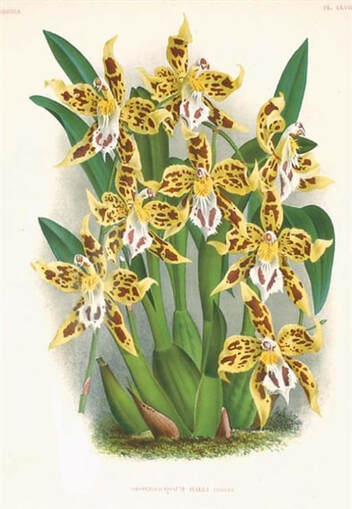 Linden, da cacciatore di piante a creatore di un impero commerciale Ottenuta l'indipendenza dai Paesi Bassi nel 1831, il neonato regno del Belgio affrontò una difficile congiuntura economica: nell'immediato, la perdita del mercato olandese si tradusse in una catastrofe per l'industria tessile e per il traffico marittimo con le colonie. Tra i settori più colpiti, anche quello florvivaistico, che, oltre ad essere danneggiato dal generale clima di crisi, venne escluso dal flusso di piante esotiche provenienti dalle colonie olandesi. Tuttavia, l'ambiente orticolo belga era vivacissimo e pronto a reagire trasformando le difficoltà in opportunità, sostenuto da una legislazione ultra-liberale che favoriva in ogni modo lo spirito imprenditoriale. A ridosso dell'indipendenza, nel 1828, un gruppo di borghesi appassionati di orticoltura aveva fondato la Société royale d'horticulture des Pays-Bas (dal 1837 Société royale d'horticulture de Belgique), una società per azioni privata con l'obiettivo di creare un orto botanico a Bruxelles, inaugurato nel settembre 1829 insieme alla prima esposizione orticola. Fu proprio la Societé royale a chiedere al governo ad aggregare una missione scientifica alla legazione commerciale inviata in Brasile nel 1835. Due gli scopi principali; da una parte, aprire possibili mercati, dall'altra cercare nuove fonti di approvvigionamento di piante esotiche, ora che erano venuti meno quelle garantiti dai Paesi Bassi. Nacque così la prima spedizione scientifica ufficiale della storia del Belgio, cofinanziata dallo stato e dalla Societé royale. Per la missione vennero scelti tre giovanissimi: il diciottenne di origini lussemburghesi Jean Jules Linden (1817-1898) come botanico, il conterraneo Nicolas Funck (1816-1896) come disegnatore e Auguste Ghiesbreght (1810-1893) come zoologo. A Rio de Janiero, i tre furono accolti dal console del Belgio Adolphe Tieberghien e dal pittore Benjamin Mary, che li accompagnarono nell'esplorazione degli stati di Rio, Spirito Santo e Minas Gerais; poi i tre giovani naturalisti proseguirono da soli a cavallo, estendendo le ricerche agli stati di São Paulo e Santa Catarina. I risultati furono eccezionali: casse e casse di materiali naturalistici che furono divisi tra le università di Gand e di Liegi, e ben cinquemila piante vive. Tra di esse, diverse specie di quelle che erano ormai diventate la passione, e l'ossessione, di Linden: le orchidee. Al loro rientro in Belgio, Linden e i suoi compagni furono accolti trionfalmente e ricevuti dal re in persona. La loro missione del resto non era che la punta di diamante di una sorprendente sequela di spedizioni botaniche in America latina made in Belgium: Achilles Deyrolle e Gidéon Crabbe in Brasile tra 1832 e 1834, Henri Galeotti in Messico tra 1835 e 1840, Louis van Houtte in Brasile tra 1834 e 1836. Ma torniamo a Linden e compagni, che appena assaporato il successo erano di nuovo in partenza per una seconda missione ufficiale: via l'Avana, furono inviati in Messico, con il duplice incarico di raccogliere esemplari scientifici per le istituzioni nazionali e informazioni sulle potenzialità economiche del mercato messicano. In Messico i tre incontrarono Galeotti, con il quale nell'agosto 1838 scalarono il maggiore vulcano del paese, il Pico de Orizaba. Le loro ricerche proseguirono poi soprattutto in Tabasco e Chapas. Benché funestata dalla scarsità di fondi, da una grave malattia di Linden, dalla situazione di guerra e dalla perdita di molte piante durante il viaggio in mare, la spedizione in Messico permise al botanico lussemburghese di studiare in natura le condizioni di crescita delle orchidee, comprendendo per primo che molte sono piante di montagna, provenienti da ambienti con grandi escursioni termiche e enormi variazioni stagionali della piovosità. Nel settembre 1840 Linden e Funck tornarono in Europa, mentre Ghiesbreght, che si era ormai trasformato in un raccoglitore professionista, rimase in Messico, dove continuò le sue ricerche da solo. Infine si stabilì a San Cristobal, in Chapas, dove creò un bell'orto botanico e continuò a raccogliere insetti, molluschi, orchidee, cactacee, agavi e bromeliacee. Ha lasciato il suo nome a diverse specie messicane, tra cui Agave ghiesbreghtii, I risultati scientifici della seconda spedizione Linden furono importanti, ma le prospettive economiche delusero il governo belga, che esitava a finanziare una terza spedizione; si decise a contribuire solo dopo che Linden a Parigi ebbe trovato altri finanziatori, in particolare una cordata di vivaisti statunitensi, che lo assunse come cacciatore di piante. Poté così ripartire alla volta di Venezuela e Colombia, accompagnato sempre da Funck e dal fratellastro Joseph Schlim; durante questa spedizione scoprì diverse nuove specie di orchidee, tra cui Anguloa x ruckeri. A. clowesii e Uropedium lindenii (oggi Phragmipedium lindenii). La missione si prolungò fino al 1844, quando gli esploratori tornarono in patria via Giamaica, Cuba, Messico e Stati Uniti. Al suo ritorno in Europa, Linden comunicò le sue scoperte a Lindley, che le pubblicò in Orchidaceae lindenianae. Ma il botanico lussemburghese aveva ormai deciso di abbandonare la vita di cacciatore di piante per trasformarsi in vivaista, anzi in "industriale delle orchidee". Nel 1846, grazie al finanziamento di una cordata di banchieri e industriali, in società con Funck fondò a Limperstsberg, un sobborgo di Lussemburgo, l'Etablissement d'Introduction des Plantes, il suo primo vivaio, specializzato nell'importazione e nella coltivazione di piante esotiche, prime fra tutte le orchidee. La sua idea vincente fu coltivarle in tre tipi diversi di serre (calda, temperata, fredda), rispettando le diverse esigenze di ciascuna specie. Nel 1853 l'azienda fu trasferita a Bruxelles e nell'arco di pochi anni diventò un vero e proprio impero commerciale, con filiali a Gand (1869), Parigi (1879), Costa azzurra (1888), secondo solo a quello di Sander per giro d'affari. Mentre Linden si muoveva tra Belgio e Francia per incrementare il suo successo commerciale, a viaggiare e a cercare nuove orchidee da immettere nel mercato erano ora i cacciatori di piante al suo servizio: tra il 1841 e il 1865, a inviargli piante sono almeno nove raccoglitori: Funck (Colombia e Venezuela), Ghiesbreght (Messico), Schlim (Colombia, Venezuela, Centro America), Libon (Brasile), Warscewicz (America centrale), Porte (Brasile, Filippine), Wagener (Venezuela, Colombia), Triana (Colombia), Braam (Colombia). Sapienza di conoscitore delle orchidee e spirito imprenditoriale si uniscono anche nelle due maggiori iniziative editoriali di Linden, allo stesso tempo monografie scientifiche, opere d'arte e vetrine commerciali, pensate per presentare al mondo le "sue" orchidee: Pescatorea (1854), finanziata da Jean-Pierre Pescatore e interrotta dalla sua morte precoce; e soprattutto la rivista Lindenia. Iconographies des orchidées, pubblicata in due serie, la prima in dieci volumi tra 1885 e 1894, la seconda, curata dal figlio Lucien, in sette volumi tra 1885 e 1901. Sono opere raffinatissime in grande formato, che presentano la descrizione di più di 800 tra specie e ibridi di orchidee, accompagnate da illustrazioni di grande pregio artistico. Linden (che nella sua vita ricevette onori di ogni tipo, dal titolo di commendatore dell'ordine di Leopoldo a quello di console onorario del Lussemburgo e console di Colombia a Bruxelles), per non parlare delle dozzine di medaglie collezionate dalle sue piante nelle esposizioni internazionali, fu invece relativamente sfortunato nella tassonomia botanica. Certo, sono decine le specie esotiche introdotte dai suoi stabilimenti che lo ricordano nel nome specifico, da Caladium lindenii a Dianthera lindeniana; tra le orchidee, citiamo almeno Phalaeonopsis lindenii, Dendrophylax lindenii e Broughtonia lindenii. Tuttavia oggi non è valido nessuno dei ben quattro generi che gli furono dedicati: Lindenia M. Martens & Galotti (sinonimo di Cyphomeris Standl.), Lindenia Benth. (sinonimo di Augusta Pohl), Neolindenia Baill. (sinonimo di Louteridium S. Watson). Lindeniopiper Trel. (sinonimo di Piper L.). Dunque, il nostro Linden è a tutti gli effetti un botanico senza Nobel. Se volete sapere qualcosa di più su questo eccezionale personaggio, non vi resta che navigare in questo sito.  Orchidee e parenti intellettuali: Funck e Funkiella Tuttavia, a tenere alto l'onore della famiglia (e a permettermi di forzare le regole del blog facendone il protagonista di questo post) ci sono le dediche di due generi validi a suoi principali collaboratori, e parenti: il compagno d'avventure, socio e cognato Nicolas Funck e il fratellastro Louis Joseph Schlim. Proviamo a conoscerli meglio. Di un anno più anziano di Linden, anche Funck era lussemburghese e si era spostato a Bruxelles, dove studiava architettura. Fu in qualità di disegnatore che accompagnò Linden nelle tre spedizioni in Centro e Sud America. Tra i due, conterranei e quasi coetanei, nacque una grande amicizia, che si strinse ancora di più quando divennero cognati. Tra 1845 e 1846, egli partecipò a una seconda spedizione in Colombia e Venezuela assieme a Schlim. Per prepararsi al viaggio, andò a Parigi per conoscere Humboldt, con cui da allora rimase in contatto. Le sue raccolte in Sud America sono importanti, ma andarono in buona parte perdute in un naufragio. Al suo ritorno in Europa, Funck intraprese la carriera accademica e fu attivo in molte società scientifiche: dal 1848 fu professore di scienze naturali e geografia all'Università di Lussemburgo; nel 1850 fu tra i fondatori della Société des sciences naturelles del Granducato del Lussemburgo, del cui gabinetto di botanica e zoologia fu nominato conservatore. Nel 1857 tornò in Belgio come direttore aggiunto de Jardin royal zoologique et botaniques di Bruxelles, di cui nel 1861 divenne direttore. Dal 1870 al 1886, diresse lo zoo di Colonia. Dopo il pensionamento, trascorse gli ultimi anni nella città natale. Fu prolifico autore di articoli scientifici soprattutto di botanica, pubblicati in diverse riviste belghe e lussemburghesi, e dal 1858 al 1862, curatore del mensile Journal d'horticulture pratique de la Belgique. Durante il periodo tedesco, pubblicò numerosi articoli divulgativi di zoologia. Comparvero invece postume le sue interessanti memorie di viaggio. Dotato di buone capacità di divulgatore e servito da una prosa limpida, si segnala anche per lo spirito di osservazione e l'apertura mentale. Molti anni dopo la sua morte, nel 1920, F.R.R. Schlechter volle ricordare il suo contributo alla botanica dedicandogli un'orchidea da lui raccolta durante il viaggio messicano, Funkiella hyemalis (precedentemente Spyrantes hyemalis A. Rich. & Galeotti). Oggi al genere Funkiella sono attribuite sette specie, distribuite tra Messico e America centrale. Sono orchidee terrestri, erbacee, di medie dimensioni, con infiorescenze di pochi fiori, in genere bianchi, talvolta con labello rosso. La specie più nota è proprio F. hyemalis, un'orchidea terrestre di alta quota, che si spinge fino 4000 metri sul livello del mare.  Orchidee e parenti poveri: Schlim e Schlimia In confronto a Funck (per non parlare di Linden) ben poche notizie sono reperibili su Louis Joseph Schlim; nato dal secondo matrimonio della madre di Linden, aveva appena due anni meno del fratellastro. Non sappiamo molto della sua formazione né della sua vita prima del 1841; forse era orologiaio. Tra il 1841 e il 1844, come abbiamo già visto, partecipò alla spedizione di Linden in Venezuela e in Colombia, ricevendo dal fratellastro una retribuzione per la sua attività di raccoglitore. Nel 1845 tornò in Venezuela con Funck. Come riconoscimento del suo contributo alla conoscenza del territorio nazionale, il governo del paese latino americano aveva nel frattempo donato a Linden la tenuta El Tocuyo, che divenne le base di Funck e Schlim, incaricati di procurarsi nuove specie per l'Etablissement d'Introduction des Plantes. Dopo il rientro di Funck, non conosciamo con precisione i movimenti di Schlim. Dalle etichette degli esemplari d'erbario, si deduce che rimase in America almeno fino al 1852, visitando America centrale, Venezuela e Colombia. Nel 1851 visitò il municipio di Ocaña con Jeronimo Triana. Non sappiamo praticamente nulla della sua vita negli anni successivi, tranne che assunse la cittadinanza belga, per poi trasferirsi a Parigi dove forse esercitò la professione di orologiaio e morì in ancora giovane età. Nel 1852 Jules Emile Planchon, che stava scrivendo una monografia sulla flora colombiana basata sulle scoperte di Linden e dei suoi raccoglitori, in collaborazione con lo stesso Linden gli dedicò Schlimia, un piccolo genere di orchidee, nativo della Costa Rica e del Sud America settentrionale. Oggi gli sono assegnate sei specie. Sono epifite, occasionalmente terrestri, delle foreste umide fredde andine, con centro di diversità in Ecuador. Vive invece tra Costa Rica e Colombia la specie tipo, S. jasminodora. Sono piante compatte, con graziosi fiori bianchi di consistenza cerosa, raccolti in infiorescenze pendule; i sepali laterali formano una specie di elmetto, da cui protrudono i petali, il sepalo dorsale e la colonna aranciata. Molto rare in natura, sono talvolta coltivate dagli appassionati di orchidee miniatura. Quando l'autore di un nome botanico celebrativo non indica in modo esplicito chi intendesse onorare, può essere difficile ricostruire le sue intenzioni. E' il caso delle bellissime orchidee Laelia, che si riferiscono sicuramente all'antica gens romana omonima, senza che riusciamo tuttavia a sapere con certezza a quale dei suoi membri. L'ipotesi più gettonata identifica la dedicataria in una vestale vissuta all'epoca di Nerone, di cui non conosciamo nulla oltre la data di morte. E' d'altra parte più che probabile che la scelta sia stata dettata soprattutto dal suono: Laelia è un nome armonico, eufonico, evocativo, come piacevano al suo creatore, il padre dell'orchidologia John Lindley. 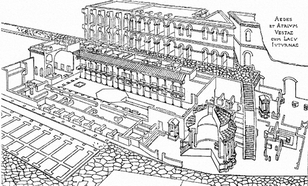 Un'evanescente figura femminile Nella sua lunga e instancabile carriera di studioso di orchidee, John Lindley diede il nome a oltre 120 generi validi di questa famiglia, e a molte centinaia di specie. Ricavò la maggior parte dei nomi generici da caratteristiche morfologiche distintive, ma agli altisonanti (e spesso cacofonici) composti greci prediletti dai suoi colleghi (come Odonthoglossum, creato da Kunth, oppure Phalaenopsis, creato da Blume) preferiva nomi brevi, se possibile dal suono armonioso, simili a epiteti femminili: Eria, "la villosa", Stenia, "la stretta", Coelia "la cava", Sophronitis "la casta". Gli piacevano i nomi di dee e ninfe, come Lycaste o Herycina, o di figure a metà tra storia e leggenda, come Aspasia o Ada. Di questo gruppo fa parte anche l'amatissimo genere Laelia. Sicuramente il botanico inglese aveva in mente un membro della gens romana omonima, ma quale? Impossibile saperlo con certezza, dal momento che egli non ha esplicitato il motivo della sua scelta. In realtà, la denominazione era già stata usata in precedenza da Adanson, che aveva dedicato un genere Laelia (Brassicaceae) al più noto esponente della famiglia, Gaio Lelio Sapiente (188-125 a.C.), celebre soprattutto per la sua amicizia con Scipione Emiliano, nonché protagonista del dialogo ciceroniano De amicitia. Ma proprio per la diffusione della denominazione di Lindley, quella di Adanson, benché precedente, è stata abbandonata. Sebbene questa ipotesi sia accettata da qualche studioso, è improbabile che Lindley avesse anch'egli in mente questo illustre personaggio: per le sue denominazioni "storiche" egli preferiva evocare donne sospese tra mito e storia, come appunto Aspasia e Ada. La dedicataria sarà dunque più probabilmente una donna della gens Laelia. Ne conosciamo essenzialmente tre, vissute rispettivamente tra il II e il I sec. a.C. e nel primo secolo d.C. Le prime due erano le due figlie del Sapiente, Laelia Major, moglie di Quinto Mucio Scevola, e Laelia Minor, moglie di Gaio Fannio Strabone; la maggiore fu elogiata da Cicerone per l'abilità retorica e la purezza del linguaggio, che trasmise alle figlie, una delle quali sposò Lucio Licinio Crasso, il più celebre oratore del suo tempo. Della terza, conosciamo quanto ne dice Tacito in una riga degli annali: "[Nel 64] morì la vergine vestale Laelia, e fu sostituita da Cornelia, della famiglia dei Cossi". Insomma, nacque, visse, morì. E' possibile che fosse figlia di D. Lelio Balbo che fu console nel 46 sotto Claudio. Ed è proprio questa Lelia vestale la più gettonata dedicataria dell'orchidea Laelia, benché a prima vista possa stupire che in mezzo a varie dediche a Afrodite (evocata come Doritis, Erycina e Paphinia) Lindley abbia associato a un'orchidea una casta sacerdotessa di Vesta. Tuttavia in Messico la simbologia legata alle Laelia non ha nulla di erotico: con i nomi di "flor de las almas", "lirio de todos los santos", "flor de muertos", o addirittura "calaverita", sono associate ai defunti, sia per il periodo di fioritura (è il caso di L. autumnalis), sia perché dai loro pseudobulbi è tradizionalmente ricavato un collante utilizzato nella confezione degli alfeniques, le figurine di zucchero della festa dei morti. Inoltre, c'è un parallelo con il genere Promeneia, dedicato da Lindley a un'altra sacerdotessa, la più anziana delle tre che servivano l'oracolo di Dodona. Proviamo dunque a immaginare la nostra vestale massima Lelia (tale sarà stata, se Tacito ne registrò la morte) nella Roma dei tempi di Nerone, magari sulla scorta del romanziere tardo vittoriano Frederick W. Farrar che in Darkness and Dawn (1891) la descrive come "una dama bella e signorile" e la mette in scena nell'atto di salvare dalla morte un condannato, su richiesta del giovane Tito, il futuro imperatore. Le vestali, infatti, l'unico collegio di sacerdotesse dell'antica Roma, godevano di grandi privilegi, tra cui il diritto di chiedere la grazia per un condannato a morte; vivevano a spese dello Stato, potevano testimoniare senza giuramento ed erano le uniche donne romane a poter fare testamento; i magistrati cedevano loro il passo e facevano abbassare i fasci littori in loro presenza. La loro persona era inviolabile e così sacra e pura che avevano il diritto di essere sepolte nel pomerio, mentre nessun altro poteva essere né sepolto né cremato in città. Vivevano nella casa delle vestali, che insieme al tempio della dea costituiva l'Atrium Vestae. Scelte tra fanciulle di ottima famiglia perfette nel corpo, con i genitori entrambi viventi, tra i sei e i dieci anni lasciavano la famiglia e entravano a far parte del collegio come novizie. Dopo dieci anni di noviziato, diventavano effettive e si occupavano dei doveri del culto, ovvero di mantenere acceso il fuoco sacro e di preparare la mola salsa, una focaccia sacra usata nei riti religiosi e nei sacrifici; dopo dieci anni di servizio, diventavano maestre e istruivano le novizie per un altro decennio. Infine, erano libere di tornare nella propria famiglia e di sposarsi. Nei trent'anni di servizio, potevano uscire liberamente, ma dovevano mantenersi in assoluta castità, pena la morte, L'Atrium Vestae si trova a ridosso del Foro. Anticamente, era attiguo a un bosco sacro, Lucus Vestae, che si estendeva fino alle pendici del Palatino, ma fu progressivamente ridotto per fare spazio agli edifici. Al centro della casa c'era però un grande cortile, simile a un peristilio, con tre bacini e presumibilmente aiuole fiorite, magari una pergola e piante in vaso. Forse esisteva anche un giardino sul retro dell'edificio. Tuttavia proprio nell'anno della morte della nostra Lelia, il complesso andò distrutto nell'incendio di Roma e le vestigia che possiamo vedere oggi risalgono a periodi successivi. Dopo un lungo restauro, sono state riaperte al pubblico nel 2010; nelle vasche è tornata a scorrere l'acqua e intorno sono state piantate aiuole di rose "antiche".  Laelia, un'orchidea che non teme l'aridità In definitiva, chiunque fosse la Lelia cui pensava Lindley, il suo intento - perfettamente raggiunto - era dare a queste orchidee un nome evocativo, nobile, dal suono armonioso, perfettamente adatto alla loro bellezza. Egli istituì il genere in The Genera and Species of Orchidaceous Plants (1831), sulla base di due specie messicane: Laelia grandiflora (oggi L. speciosa) e L. autumnalis. Ed è infatti proprio il Messico il centro di diversità di questo bellissimo genere, che oggi conta circa venticinque specie, dopo aver subito una profonda revisione tassonomica. Laelia è molto affine a Cattleya (con la quale infatti forma bellissimi ibridi), da cui venne distinta in base al numero dei pollinii (ne ha otto, anziché quattro). Fino alla fine del secolo scorso, gli era assegnata una cinquantina di specie, divise in due gruppi geograficamente distanti, nonché molto diversi per habitat e caratteristiche ecologiche; da una parte le Laelia del Messico e del Centro America, che vivono in aree aride prevalentemente montane con clima da temperato a freddo; dall'altra quelle brasiliane, diffuse in una varietà di ambienti tropicali o subtropicali dal livello del mare alle montagne. Come hanno dimostrato le ricerche basate sul DNA, si trattava di un raggruppamento artificiale, che è stato risolto dapprima trasferendo in Sophronitis quasi tutte le Laelia brasiliane, passate poi a Cattleya quando Sophronitis è confluito in quest'ultimo. Il risultato è che diverse tra le specie più note hanno cambiato nome, tra le altre Laelia purpurata, il fiore nazionale del Brasile, oggi Cattleya purpurata. Nella nuova circoscrizione più ristretta, le Laelia ci portano in un ambiente che non tendiamo ad associare alle orchidee: le foreste stagionali aride, soprattutto querceti-lecceti, dove per molti mesi all'anno non piove e in inverno le temperature possono scendere anche di vari gradi sotto zero. Per superare i periodi di aridità sono dotate di organi di riserva, gli pseudobulbi, che permettono di superare l'assenza di precipitazioni e il gelo; alcune di esse in inverno vanno in riposo. Inoltre, come adattamento all'aridità, adottano la fotosintesi CAM (metabolismo acido delle crassulacee) che permette di ridurre la traspirazione chiudendo gli stomi durante il giorno e assorbendo di notte l'anidride carbonica che verrà usata il giorno successivo per la fotosintesi. Hanno in genere fiori dai colori molto brillanti che si presume siano impollinati da colibrì. La bellissima Laelia speciosa (che è anche la specie tipo) è un endemismo del Messico centrale; è un'epifita che ama annidarsi sui rami dalla corteccia corrugata di diverse specie di querce delle montagne del centro del paese (Sierra madre occidentale e orientale, settore meridionale dell'altopiano messicano, fascia vulcanica trasversale). Di dimensioni compatte, ma con fiori enormi relativamente alle sue dimensioni, è stata raccolta e associata a riti sacri fin dai tempi degli aztechi. La raccolta indiscriminata dei fiori recisi e soprattutto degli pseudobulbi, usati per la confezione dei dolci dei morti, ne hanno ridotto molto il numero; oggi è protetta. Ne esistono molte varietà che si differenziano per il colore dei fiori, da lilla rosato a magenta. Importante come specie coltivata è anche L. anceps; anch'essa originaria del Messico centrale, di dimensioni molto maggiori della precedente, è tra le più usate nella produzioni di ibridi, soprattutto con generi affini come Cattleya e Brassavola. Come la precedente, L. autumnalis fiorisce dal tardo autunno all'inverno; è la specie abitualmente associata ai morti, con nomi come fiore dei morti, fiore di Ognissanti, fiore dei teschi, fiore delle anime; anch'essa cresce nei querceti e negli arbusteti di alta quota, con temperature notturne molto basse ed estati fredde; oltre alle querce, non disdegna cactacee e yucche. Qualche approfondimento nella scheda. Quando approdarono in Europa a inizio Ottocento, alle orchidee esotiche non mancava nulla per accendere i cuori: erano bellissime, erano rare, si ammantavano di mistero, ed erano pure molto costose, il che alimentava un certo snobismo. Fu così che la fioritura di quella che di lì a poco sarebbe stata battezzata Cattleya labiata segnò l'inizio di una passione collettiva: l'orchidelirium, ovvero il delirio per le orchidee. Nacque persino una nuova professione: quella dei cacciatori di orchidee, inviati a cercarle ai quattro angoli del mondo da ricchi privati o da aziende intraprendenti. Alle aste, le più nuove e le più rare raggiungevano prezzi da capogiro. Per settant'anni la più ambita e ricercata continuò ad essere Cattleya labiata. Fino a fine secolo, molte spedizioni andarono a cercarla a casa sua in Brasile, ma sempre senza esito. Niente di strano che la sua storia sia stata trasformata in leggenda, anzi quasi in una fiaba, con lei, la regina delle orchidee, nelle vesti di Cenerentola e lui, William Cattley, nelle vesti di principe azzurro. Quasi spiace ammettere che la realtà sia molto più prosaica.  Un'imbottitura a sorpresa... o forse no Come tutte le leggende, anche la storia dell'arrivo in Europa e della prima fioritura di Cattleya labiata è stata raccontata in diverse versioni. La più comune vuole che il giovane naturalista John William Swainson (1789-1855) nel 1818 abbia spedito in patria dal Brasile un pacco di piante contenente rari licheni (o felci, secondo un'altra versione); per preservarli nel lungo viaggio, come imbottitura usò una liana o pianta parassita che credeva senza valore. Il destinatario dell'invio era il mercante William Cattley, grande appassionato di piante esotiche che coltivava nella sua serra di Barnet, alla periferia londinese. Aprendo il pacco, in mezzo a quell'ammasso di materiale secco, egli individuò quello che riconobbe come uno pseudobulbo di orchidea; doverosamente coltivato, prosperò e giunse a fioritura, producendo bellissimi fiori lilla, i più belli che mai si fossero visti. Arrivata nelle vesti dimesse di Cenerentola, la sconosciuta si era rivelata una splendida principessa, anzi la regina delle orchidee. Nel 1821, il futuro padre dell'orchidologia John Lindley (1799-1865) la descrisse e la pubblicò con il nome di Cattleya labiata in onore del suo "salvatore". Mi spiace deludervi, ma le cose non sono affatto andate così. Insieme a molte altre piante, tra cui un Oncidium barbatum (oggi Gomesa barbata), la nostra pseudo Cenerentola venne inviata da Swainson non a Cattley, ma a William Jackson Hooker, che all'epoca insegnava botanica all'Università di Glasgow. Swainson l'aveva vista in fioritura e sapeva perfettamente di quale meraviglia si trattasse; appena arrivata, fu trattata con tutte le cure del caso e in quello stesso anno, come riferisce Hooker nel terzo volume di Exotic flora (1827), fiorì nella serra del suo giardino di Halesworth nel Suffolk; Hooker affidò uno o più pseudobulbi all'amico Cattley, noto come infallibile pollice verde, che in effetti riuscì a portarla a fioritura nel novembre 1820; riprodotta per divisione, infine nel 1824 fiorì della serra dell'orto botanico di Glasgow. Benché avessero tutti la stessa origine, la pianta di Cattley emanava un delicato profumo, assente nelle altre. In ogni caso, tanto Lindley quanto Hooker ne erano entusiasti: per il primo era "senza eccezione, la più bella specie del suo ordine che io abbia visto dal vivo", per il secondo "la più splendida, forse, di tutte le orchidacee". Dunque, nella nostra fiaba mancata non c'è né Cenerentola, né principe azzurro: Cattley non salvò la misconosciuta pianta, che non fiorì per la prima volta a casa sua; molto più prosaicamente, era il finanziatore di Collectanea botanica (1821-26), la pubblicazione in cui Lindley la descrisse, dedicandogliela con queste parole: "ho avuto grande piacere a pubblicarla, perché mi ha dato l'opportunità di offrire un omaggio a un gentiluomo il cui ardore nel collezionare e il cui inarrivabile successo nel coltivare la difficile tribù di piante cui appartiene lo rendono da tempo la persona più adatta a questo omaggio". 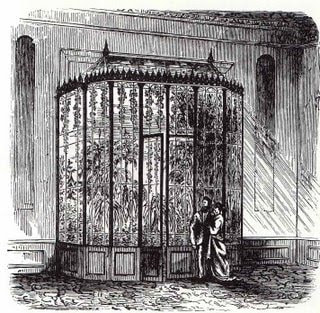 Un collezionista di piante esotiche E' dunque ora di sapere qualcosa di più su di lui. Cattley apparteneva a una grande famiglia di commercianti, con interessi soprattutto in Russia, da dove importava granaglie. Negli anni turbolenti delle guerre napoleoniche, i suoi affari avevano prosperato, permettendogli di dedicare tempo e denaro alla sua grande passione: le piante esotiche. Divenne un collezionista piuttosto noto, il cui nome ricorre in pubblicazioni dell'epoca come Curtis's Botanical Magazine o Edward's Botanical Register, relativamente all'introduzione di nuove specie, che a quanto pare riusciva a far prosperare nella serra della sua casa di Barnet, a nord di Londra. Era membro della Linnean Society e della Horticultural Society, che nel novembre 1820 lo premiò con una medaglia d'argento per la sua abilità nel coltivare le piante esotiche, in particolare per essere riuscito a far fruttificare una nuova specie di guaiava che venne denominata in suo onore Psidium cattleyanum. Anche se le orchidee non erano la sua passione esclusiva, dovettero essere una parte importante della sua collezione: in un'epoca in cui le serre inglesi, secondo le parole dello stesso Hooker, erano la tomba delle orchidee e nulla si sapeva della loro riproduzione e molto poco della loro coltivazione, era uno dei pochi che riusciva a coltivarle con successo. A nostri occhi, il suo merito maggior è di essere stato il mecenate di John Lindley, all'epoca ancora giovanissimo. Poco più che adolescente, il promettente botanico aveva conosciuto Hooker che lo aveva raccomandato a Banks, il quale lo aveva assunto come assistente per il suo erbario. Nel 1820, alla morte di Banks, sempre Hooker - che conosceva bene Cattley perché entrambi erano membri delle stesse società scientifiche nonché accaniti collezionisti che si scambiavano esemplari - gli suggerì di assumere Lindley per riordinare e disegnare le sue collezioni. Per circa un anno, Lindley fu stipendiato da Cattley, che finanziò la pubblicazione di Digitalium Monographia, una monografia sul genere Digitalis illustrata da Bauer, e soprattutto Collectanea Botanica. Contrariamente a quanto si legge in molte fonti anche autorevoli, quest'ultima non è un catalogo delle collezioni di Cattley, ma una rassegna di piante rare coltivate tanto da lui quanto da altri; quelle coltivate a Barnet sono solo 8 su 41. Circa un quarto delle piante trattate sono orchidee (tra di loro la nostra Cattleya labiata); fu proprio grazie a Cattley, alla sua collezione e a questo lavoro che Lindley scoprì il fascino di questa famiglia di piante, cui avrebbe dedicato tutta la vita, divenendo il padre dell'orchidologia. Tuttavia dopo poco più di un anno di collaborazione, la ditta di Cattley ebbe un rovescio di fortuna. Il mercante non poté più finanziare Lindley, e la pubblicazione di Collectanea Botanica venne interrotta; Lindely dovette ridimensionare il progetto e pubblicare gli ultimi fascicoli a sue spese con una notevole dilazione, E' per questa ragione che il fascicolo 7, dove si trova la descrizione di C. labiata, anche se è datato 1821, in realtà fu stampato presumibilmente nel 1824. Quanto a Cattley, sebbene con mezzi ridotti, continuò a curare la sua collezione, visto che il suo nome continua a comparire nei periodici dell'epoca, dove è definito "il più ardente collezionista di piante rare dei nostri giorni". Morì a Londra nel 1835. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Alla ricerca dell'orchidea perduta Nel frattempo, la fioritura di C. labiata aveva destato grande sensazione. Non era certo la prima orchidea esotica a fiorire in Europa (come ho raccontato in questo post, la prima era stata Brasavola nodosa nel 1698), ma non si era mai visto un fiore così appariscente, così raffinato, così esotico, con sepali e petali di un delicatissimo lilla e un grande labello sfrangiato porpora, con la gola giallo profondo. E fu subito orchidelirum, come venne chiamata l'ossessione per le orchidee che travolse l'Inghilterra vittoriana. Vennero organizzate costose e difficili spedizioni nei paesi tropicali (soprattutto in Sud America e nel sudest asiatico) per procurarsi sempre nuove specie. Nacquero ditte specializzate e una nuova professione, quella di cacciatore di orchidee. Alle aste che venivano organizzate a Londra al loro ritorno, quelle più rare raggiungevano prezzi da capogiro, come le 80 ghinee (equivalenti a circa 9000 euro) sborsate da Sigismund Rucker negli anni '40 per una Barkeria spectabilis. Le più ambite erano ovviamente quelle più rare e più difficili da trovare. Ovviamente, in testa alla lista c'era Cattleya labiata, la cui ricerca in natura deluse le aspettative per ben 70 anni. Swainson non aveva rivelato dove l'avesse raccolta e la leggenda fiorita sul suo invio contribuì a confondere i ricercatori. Poiché egli aveva fatto base a Rio, si pensò provenisse da quell'area, dove per anni i cacciatori di orchidee andarono a cercarla senza successo (in realtà, Swainson l'aveva raccolta nel Pernambuco). Nel 1846, destò dunque grande sensazione la pubblicazione di Travels in the Interior of Brazil del chirurgo e naturalista George Gardner (1812-1849) in cui raccontava come l'avesse ritrovata nel 1836 sulle rocce a precipizio sul mare della Pedra de Gavea, a una quindicina di miglia da Rio. Gardener si sbagliava: esaminando i suoi campioni, l'ormai autorevolissimo Lindley decretò che non si trattava di C. labiata, ma di un'altra specie che denominò C. lobata. Nel suo Flower Garden, Joseph Paxton (famoso sopratutto come creatore del Crystal Palace) riprese la notizia, accompagnandola con la versione più nota, potremmo dire ormai ufficiale, del famoso invio di C. labiata come imbottitura. Inutile dire che diverse spedizioni batterono le montagne della foresta di Tujica alla ricerca dell'orchidea perduta, inondando il mercato europeo di centinaia di nuove specie, ma senza mai ritrovarla. Gardner pensò di aver fatto centro durante un secondo viaggio in Brasile, quando credette di averla ritrovata sulle rive del fiume Parabaya, al confine tra gli Stati di Rio e Minas Gerais. Si sbagliava di nuovo: si trattava di C. warneri. Di conseguenza diverse spedizioni setacciarono la regione; inutilmente, tanto che qualche botanico incominciò a pensare che C. labiata fosse ormai estinta in natura. Finalmente, la notizia del ritrovamento, questa volta vero, arrivò nel 1889. E, vero schiaffo all'orgoglio nazionale britannico, il merito andava ai francesi. Monsieur Moreau, un entomologo parigino, aveva finanziato una spedizione entomologica nel Brasile centrale e settentrionale; sapendo che era anche collezionista di orchidee, i raccoglitori gli inviarono anche una cinquantina di piante di un'orchidea dai grandi fiori lavanda raccolte nel Pernambuco. A questo punto, storia e leggenda tornano a mescolarsi: si racconta che, per un'incredibile coincidenza, Frederick Sander (1847-1920), ovvero il re delle orchidee, a capo del vivaio specializzato più importante d'Europa, facesse visita a Moreau proprio mentre le piante iniziavano a fiorire: gli bastò un'occhiata per capire che si trattava della perduta C. labiata. Il francese non ebbe problemi a rivelargli dove era stata raccolta, e Sanders poté inviare i suoi cacciatori a raccoglierla a colpo sicuro. Già nel 1892 fu in grado di immettere sul mercato ben 25.000 esemplari. Ma non manca una versione più romantica, secondo la quale l'orchidea perduta fu ritrovata sempre a Parigi, ma durante una serata mondana, appuntata alla scollatura di una dama.  E infine, Cattleya! Nell'Ottocento, mentre sempre nuovi generi e specie di orchidee si riversavano come un fiume in piena nell'avido mercato europeo, Cattleya mantenne il suo primato di regina delle orchidee. Era il genere più amato, più ricercato, apprezzato soprattutto come fiore reciso per comporre lussuosi bouquet e per ornare scollature. A ostentare una Cattleya non era solo la misteriosa (e presumibilmente inesistente) dama parigina della leggenda, ma anche Odette, la bella demi-mondaine amata da Swann nella Recherche di Proust; il gesto di Swann, che si offre di sistemarle il fiore appuntato sul petto, diventa il preludio al loro primo rapporto sessuale: da quel momento i due amanti lo chiameranno eufemisticamente faire Cattleya, "fare Cattleya". Le circa centoventi specie del genere Cattleya sono orchidee epifite, o più raramente terrestri, originarie delle foreste pluviali dell'America latina, dalla Costa Rica al Brasile. I fiori, raccolti in infiorescenze terminali, hanno sepali e petali liberi; il petalo inferiore è modificato a formare un labello sfrangiato, solitamente di colore contrastante. Sono orchidee simpodiali, con pseudobulbi alla cui estremità si sviluppano una o due foglie. Proprio in base a questa caratteristica, vengono divise in due grandi gruppi: monofoliate e bifoliate. Le prime sono le Cattleyae classiche, piante robuste a forte sviluppo con grandi fiori; le seconde hanno fiori più piccoli, ma spesso forme e colori affascinanti. In coltivazione sono state introdotte almeno una cinquantina di specie, senza contare i numerosissimi ibridi. Il primo si deve a un altro grande collezionista, John Dominy, che nel 1853 incrociò C. loddigesii e C. guttata. Da allora ne sono stati prodotti centinaia e centinaia. Come se non bastasse, Cattleya forma ibridi intergenerici (nothogenera) con altri generi del vasto gruppo di orchidee neotropicali detto Cattleya alliance: i più noti sono Brassavola, Encyclia, Epidendrum, Laelia, Rhyncholaelia, con i quali forma rispettivamente x Brassocattleya, x Catyclia, x Epicattleya, x Laeliocattleya, x Rhyncolaeliocattleya. Tra gli ibridi che coinvolgono tre generi il più noto è senza dubbio Brassolaeliocattleya (Brassavola x Laelia x Cattleya), ma non mancano ibridi ancora più complessi che ne coinvolgono da quattro in su, come Andersonara (Brassavola x Cattleya x Guarianthe x Laelia x Ryncholaelia). Un tempo la coltivazione degli ibridi era rivolta soprattutto al mercato dei fiori recisi, oggi meno importante a favore della vendita come pianta fiorita. Tuttavia Cattleya mantiene un ruolo di una certa importanza anche come fiore reciso grazie alle fioriture indipendenti dalla stagione. Infatti sono piante brevidiurne, che tendono a fiorire quando le giornate si accorciano. Diminuendo artificialmente le ore di luce, possono dunque essere indotte a fiorire in ogni momento dell'anno. Nella scheda notizie sulla classificazione di Cattleya, link selezionati e una selezione di specie notevoli. La Missione geodetica nel Vicereame del Perù è correntemente nota come "Missione La Condamine". Eppure il matematico, geografo, avventuriero Charles Marie de La Condamine non ne era né l'ideatore né il capo designato (ruoli che spettano piuttosto a Godin); anzi, dei tre accademici era probabilmente il meno qualificato: come matematico era inferiore a Bouguer, come astronomo era appena un apprendista se paragonato a Godin. Furono piuttosto la sua abilità di scrittore e il suo fantastico viaggio di ritorno, che lo vide - primo scienziato a farlo - discendere il corso del Rio delle Amazzoni, a trasformarlo nel protagonista assoluto di un'impresa di cui in precedenza era stato solo uno dei tanti attori. Anche per quanto riguarda la botanica, egli strappò a Joseph de Jussieu il primato che gli sarebbe spettato di diritto, offrendo al mondo accademico la prima descrizione della misteriosa e ricercatissima Cinchona, l'albero da cui si ricavava il "cortice peruviano", ovvero la corteccia di china. Durante la discesa del Rio delle Amazzoni, poté inoltre osservare il modo in cui gli indigeni si servivano del curaro e del lattice dell'albero della gomma, Hevea brasiliensis. Grande osservatore, ha lasciato una testimonianza preziosissima (anche se spesso non benevola) della vita delle comunità indie dell'Amazzonia. Se non avesse letto le sue pagine affascinanti forse Humboldt non avrebbe mai deciso di partire per il Sud America. Insomma, ce n'è abbastanza per guadagnargli la dedica di un genere botanico, Condaminea, che de Candolle scelse proprio per la sua affinità con Cinchona, di cui La Condamine fu il primo descrittore.  La "scoperta" dell'albero della china Dei tre accademici inviati in Ecuador a misurare il meridiano, Charles Marie de La Condamine era di sicuro il meno "accademico" e il più avventuroso. Figlio di un facoltoso ricevitore delle imposte, era stato per qualche anno militare; insofferente della disciplina, aveva poi deciso di dedicare la propria vita alla scienza, studiando molte materie diverse, dalla matematica alla chimica, dalla meccanica alla fisica. Aveva anche dimostrato un notevole fiuto per gli affari; nel 1729, a capo di una cordata di cui faceva parte anche Voltaire, applicando il calcolo delle probabilità era riuscito ad arricchire se stesso e l'amico philosophe sfruttando le falle di una lotteria indetta dal ministero delle finanze per incentivare l'acquisto delle obbligazioni municipali parigine. Ma la vita sedentaria non era fatta per La Condamine, che nel 1731 si unì alla squadra dell'ex corsaro Dugay Trouin inviata ad ispezionare gli scali del Mediterraneo. Poté così visitare Algeri, Tripoli, Tunisi, Alessandria d'Egitto, la Terra santa, Cipro, Rodi e le isole del Dodecaneso, per poi fermarsi tre mesi a Costantinopoli. Durante il viaggio, tenne un diario, rimasto inedito, e raccolse osservazioni geografiche, matematiche e fisiche che al suo ritorno, presentate all'Accademia delle scienze, gli guadagnarono l'ammissione alla prestigiosa istituzione. Fu dunque in qualità di accademico e viaggiatore già riconosciuto che poté partecipare alla spedizione geodetica nel Vicereame del Perù. E' stato osservato che, studioso eclettico com'era, era un matematico meno preparato di Bouguer, e un astronomo poco più che dilettante, rispetto allo specialista Godin. Eppure è certo che senza di lui la spedizione sarebbe fallita sul nascere. Furono infatti le sue doti di uomo di mondo e la sua abilità finanzia a salvarla ripetutamente dal disastro, sia sostenendo i suoi compagni con prestiti a fondo perduto (l'affare della lotteria l'aveva reso milionario) sia negoziando prestiti e trovando crediti presso la corona spagnola e finanziatori privati. Divenne così abituale, quando la spedizione si arenava per mancanza di fondi, inviare La Condamine fino a Lima a raggranellare quattrini. Fu proprio durante uno di questi viaggi che egli fece la "scoperta" (come vedremo, il termine è piuttosto improprio) destinata a farlo entrare nella storia della botanica. Tra gli obiettivi secondari della missione c'era anche quello di sapere qualcosa di più sulla misteriosa "corteccia dei gesuiti" (in Italia la chiamavano anche "cortice peruviano"), unico rimedio veramente efficace contro la malaria. In Europa arrivava sotto forma di frammenti di corteccia, importati dal Perù, prima grazie ai Gesuiti poi all'impero spagnolo, che ne difendeva strenuamente il monopolio, mantenendo il segreto sull'origine di quel farmaco miracoloso. Appena giunto in Ecuador, Joseph de Jussieu si era dato da fare per raccogliere tutte le informazioni disponibili ed era riuscito a scoprire che la corteccia proveniva da alberi delle foreste della regione intorno a Loja. Non aveva però ancora potuto andare a verificare di persona; in attesa di farlo, aveva mandato in avanscoperta La Condamine che nel 1737, sulla strada per Lima, fece una deviazione per Loja munito delle sue indicazioni. Sul posto seppe che la migliore "cascarilla" (questo era il nome spagnolo della droga) si raccoglieva a circa due miglia dalla cittadina, sul monte Cajanuma; vi si trasferì immediatamente e trascorse la notte del 3 febbraio ospite di uno dei più abili raccoglitori e commercianti, che il mattino dopo lo condusse nella foresta dove poté infine vedere qualche esemplare del misterioso albero, disegnarne un ramo e raccogliere semi, fiori e foglie. Gli indigeni lo chiamavano quinaquina ("corteccia delle cortecce") e ne distinguevano tre qualità, in base al colore del tronco sotto la corteccia: rossa, la migliore e più potente, gialla e bianca. Al suo rientro a Quito, La Condamine si affrettò a scrivere le sue osservazioni in una memoria per l'Accademia delle scienze, in cui, dopo aver esposto la storia degli usi della corteccia di china, ne descrisse i tre tipi, nonché le modalità di raccolta e di conservazione praticati dagli indios. Spedita in Europa, fu letta in una seduta dell'Accademia parigina nel 1740. Pochi mesi dopo il viaggio di La Condamine, insieme al medico Siniergues e al disegnatore Morainville Jussieu poté infine visitare egli stesso l'area di Loja, studiando le piante di china in modo molto più approfondito e sistematico; ma poiché la sua memoria Description de l'arbre à quinquina rimase inedita, a far conoscere la vera identità dell'albero alla scienza europea fu La Condamine. Fu sulla base della sua descrizione (nonché degli esemplari essiccati che avrebbe portato con sé in Europa) che Linneo creò il genere Cinchona. Come abbiamo già visto in questo post, la spedizione fu funestata da vari incidenti e soprattutto dalla rivalità tra i tre accademici che la dirigevano, Godin, Bouguer e La Condamine. Per qualche tempo gli ultimi due si coalizzarono contro Godin e lavorarono insieme, ma, quando nel 1741 Bouguer scoprì un piccolo errore nei loro calcoli, tra di loro scoppiò una lite così violenta che da quel giorno si tolsero la parola, continuando a lavorare ognuno per conto proprio. Nella primavera del 1743, quando La Condamine venne a sapere che l'ex amico si accingeva a tornare in Europa per la via più breve, decise che la sua strada sarebbe stata un'altra: avrebbe attraversato il continente e raggiunto l'Atlantico discendendo il Rio delle Amazzoni. 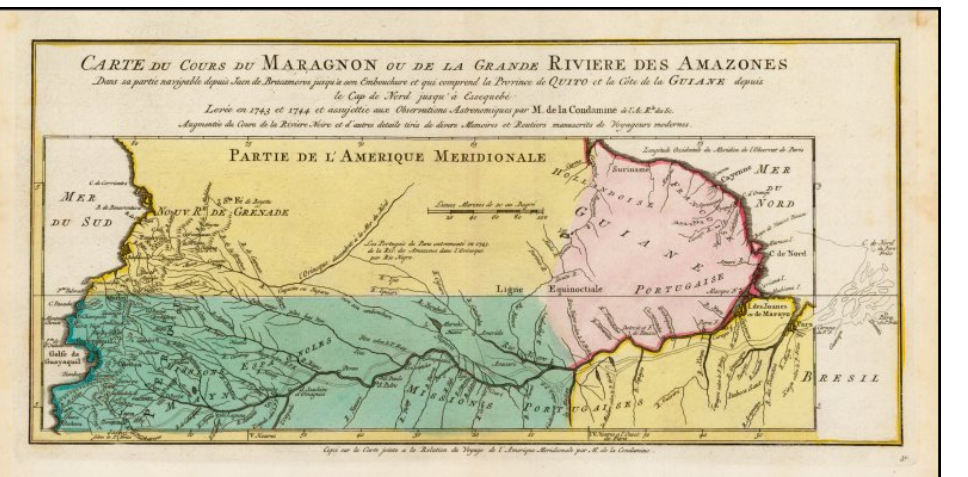 Lungo la corrente del grande fiume A spingerlo a questa decisione furono diversi fattori: la consapevolezza che la Missione, cui pure aveva dedicato otto anni della sua vita, non gli avrebbe assicurato alcuna gloria, visto che la questione della forma della Terra era già stata risolta e liquidata dalla spedizione in Lapponia di Maupertuis; il suo carattere avventuroso e il fascino esercitato anche su questo razionale figlio dei Lumi dalle leggende nate attorno al grande fiume, sulle cui rive si favoleggiava si trovasse il mitico Eldorado e vivessero tribù di amazzoni guerriere; ma l'elemento determinante fu l'amicizia con l'uomo politico e scienziato Pedro Vicente Maldonado (1704-48), che rendeva quell'impresa, se non facile, almeno fattibile. Membro di una delle più illustri famiglie del Vicereame, proprietaria di estesi latifondi nella Sierra centrale dell'Ecuador, Maldonando era un sagace amministratore, un esploratore e uno studioso autodidatta della natura del suo paese. Quando la spedizione geodetica arrivò in Perù, era impegnato nella costruzione di una strada che avrebbe dovuto collegare l'Audienca di Quito con Panama, attraversando le impenetrabili foreste della provincia di Esmeraldas. Fu proprio qui che lo incontrò La Condamine al suo arrivo in Ecuador, mentre dalla costa si spostava a Quito. Tra i due, uniti dall'amore per la scienza e dallo spirito avventuroso, iniziò una grande amicizia. Maldonado, che dal 1742 divenne anche governatore di Esmeraldas, collaborò in molti modi con la Missione geodetica, fornendo appoggio logistico e aiuti finanziari; insieme a La Condamine, redasse una importante Mappa della regione di Quito. Fu forse lui a proporre al geografo francese di raggiungere la costa atlantica scendendo il corso del Rio delle Amazzoni; anni prima aveva già visitato la regione di Maynas, da cui si accedeva al grande fiume, e sapeva che durante il viaggio avrebbero potuto trovare ospitalità nelle missioni gesuite disseminate lungo il suo corso. Da tempo sognava di andare in Europa, dove l'amicizia con La Condamine gli avrebbe aperto le porte delle società scientifiche. Il grande viaggio iniziò nel maggio 1743. Il primo a muoversi fu Maldonado; partito da Baños, scese lungo il Pastaza, un tributario del fiume Marañón che attraversava la regione di Maynas che egli aveva già visitato in passato. A giugno arrivò a La Laguna, il principale centro delle missioni di Maynas, dove, in attesa dell'arrivo di La Condamine, si dedicò a osservazioni naturalistiche, raccogliendo tra l'altro per l'amico esemplari dell'albero di cannella (come abbiamo già visto parlando di Joseph di Jussieu, non si tratta della vera cannella, Cinnamomum verum, ma di un'altra Lauracea utilizzata come succedaneo, Ocotea quixos). Negli stessi giorni, La Condamine lasciò Tarqui, ma prima di unirsi all'amico volle visitare le miniere di Zaruma e soprattutto tornare a Loja, dove si procurò alcune pianticelle e moltissimi semi di Cinchona; la sua intenzione era portarli con sé in Francia, per rompere il monopolio iberico con una vera e propria operazione di contrabbando. Per raggiungere il bacino del Rio delle Amazzoni aveva deciso di scendere lungo il Marañón, ma prima dovette affrontare un cammino difficile, funestato dalla pioggia incessante, tra selve impenetrabili e torrenti troppo impetuosi per consentire la navigazione; mentre ne guadava uno, una delle mule, carica dei suoi strumenti e degli appunti, finì in acqua, rischiando di fargli perdere tutto. Giunto all'altezza di Jaen, poté infine imbarcarsi sul Marañón con le sue guide: lo attendeva il difficile Pongo de Manseriche, una gola lunga circa cinque chilometri, dove l'alveo del fiume si restringe da 450 metri a poco più di 40 e la navigazione è resa insidiosa dalle pareti a strapiombo e dai gorghi. La zattera su cui era imbarcato rischiò di essere sommersa insieme a tutte le raccolte. Ma La Condamine aveva già imparato come difenderle dall'umidità: ancora in Ecuador, era stato colpito dagli oggetti di caucciù fabbricati dagli indigeni e dalle sue guide imparò a creare involucri di stoffa resi impermeabili immergendoli nel lattice. Superata la terribile gola, prese terra a Borja dove fu ospitato dal padre gesuita Maguin che gli diede una carta della regione e si offrì di accompagnarlo fino alla missione di La Laguna, dove era fissato l'appuntamento con Maldonado. Dopo sei settimane di separazione, finalmente i due amici si ricongiunsero, La navigazione lungo la corrente del rio delle Amazzoni iniziò il 23 luglio. Imbarcati con i vogatori che su davano il cambio e remavano giorno e notte in due grandi canoe, ciascuna formata da un unico tronco, poterono ora navigare in relativa sicurezza, dedicando tutto il loro tempo alle osservazioni scientifiche; La Condamine si occupò soprattutto di mappare e misurare il fiume, mentre Maldonado osservava e catalogava piante e animali, stupefatto per la loro abbondanza e varietà. Anche i costumi delle tribù che vivevano lungo il fiume non mancarono di attirare l'attenzione del sempre curioso La Condamine: alla confluenza tra il Marañón e l'Ucayali, dove inizia convenzionalmente il Rio delle Amazzoni, incontrarono la tribù degli Omagua che coltivavano una pianta dai semi allucinogeni e usavano porre le teste dei neonati tra pezzi di legno per arrotondarle. Alla confluenza con il Napo, dove arrivarono l'ultimo giorno di luglio, i due osservarono l'emersione del primo satellite di Giove e determinarono la latitudine esatta della località, mettendo finalmente a frutto il pesante telescopio che il francese aveva trascinato con sé per centinaia di chilometri tra fiumi e montagne. Dopo una sosta nella missione di Pebas, per tre giorni attraversarono un'area quasi disabitata finché arrivarono alla missione carmelitana di Sao Paulo, già in territorio portoghese. Qui furono stupiti dal trovare edifici in pietra e mattoni, e dal notare vestiti di stoffa inglese e oggetti importati come forbici, coltelli, specchi, pettini, che arrivavano dalla foce del fiume in cambio del cacao. Grande osservatore, uomo di ampie letture e di molteplici interessi, La Condamine si informava di tutto, misurava tutto e tutto annotava. La sua testimonianza sui costumi delle tribù indie è particolarmente preziosa, perché presto sarebbero state cancellate o assimilate. Già allora egli notò che le loro lingue erano in regresso di fronte all'avanzare del portoghese, mentre, come abbiamo già visto, nuovi oggetti e nuove abitudini soppiantavano i modi di vita tradizionali. Si informò accuratamente su come gli indios preparavano e usavano il curaro e come ne combattevano gli effetti, nonché sull'impiego del lattice di Hevea brasiliensis per confezionare oggetti di gomma. Egli pensava si trattasse della stessa pianta usata anche in Perù; in realtà gli indios peruviani ricavavano il lattice da Castilla elastica. Mano a mano che i viaggiatori scendevano lungo il fiume e incontravano un tributario dietro l'altro, l'alveo si faceva sempre più ampio. Quando giunsero dove il Rio Negro si getta nel Rio delle Amazzoni, La Condamine poté osservare il flusso di marea che dall'Atlantico risale il fiume, benché alla foce manchino ancora più di 1000 km. Il comandante del forte portoghese li accolse amichevolmente e li accompagnò per un tratto. Qui, dove il fiume è così largo che è impossibile scorgerne le rive, La Condamine notò sprezzantemente che l'abbondanza di pesci dovuta al riflusso della corrente "sembra aver favorito la naturale propensione degli indiani alla pigrizia". Verso i "selvaggi" non aveva certo un atteggiamento rousseauiano: li considerava poco più che bestie, dei gran pelandroni che approfittavano della generosità della natura per darsi da fare il meno possibile, nonché degli imprevidenti ghiottoni che si abbandonavano alle orge quando c'era abbondanza di cibo e facevano la fame quando non ce n'era. Non capiva che, in quel clima e in quelle condizioni, era impossibile fare e conservare scorte. Il 19 settembre Maldonado e La Condamine raggiunsero Gran Parà (oggi Belem): dopo quattro mesi di navigazione il grande viaggio era finito e i due si divisero: Maldonado decise di imbarcarsi immediatamente per la Spagna, dove intendeva far stampare la sua relazione sulla provincia di Esmeraldas. La Condamine si trattenne ancora a Gran Parà, dove fece esperimenti sul curaro e sui suoi antidoti. Era deciso a raggiungere il lembo estremo della foce: fu così che a bordo di un'altra canoa esplorò l'isola Marajó e raggiunse la piana di Macapà; misurandone la latitudine di 3 gradi nord, osservò con una certa ironia che sarebbe stata una sede perfetta per la missione geodetica dell'Accademia delle Scienze, ben più facile da raggiungere degli altopiani dell'Ecuador. Altri due mesi di canoa, dedicati a studiare le numerose bocche del Rio delle Amazzoni, lo portarono infine a Cayenne (Guyana francese), dove dovette aspettare ancora sei mesi una nave diretta in Francia; occupò il tempo facendo esperimenti sul curaro, sul lattice dell'albero della gomma e cercando di moltiplicare la Cinchona di cui distribuì il maggior numero possibile di semi. Quando infine partì per l'Europa, imbarcò anche numerosi virgulti, ma nessuno sopravvisse al viaggio. Era di nuovo a casa nel febbraio 1745, dopo dieci anni di assenza. A Parigi la sua vita sarebbe stata ancora lunga: a parte una sterile e virulenta polemica con Bouguer, occupò il suo tempo a viaggiare (fu in Italia e in Inghilterra), a intrattenere una formidabile corrispondenza, a battersi per l'inoculazione del vaiolo, che in gioventù gli aveva deturpato il volto, a propagandare la creazione di una misura universale (è la prima idea del metro); ma soprattutto a raccontare e divulgare la sua grande avventura di esploratore del Sud America. La sua Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale, letta a un'assemblea dell'Accademia delle Scienze nel 1745, e soprattutto Journal du voyage fait par ordre du roi, à l'Equateur divennero due classici della narrativa di viaggi e influenzarono il modo in cui l'Europa per decenni vide il Sud America, ispirando anche il viaggio di Humboldt. Anche se la sua grande avventura aveva minato seriamente la sua salute, privandolo dell'uso di una gamba e rendendolo sordo, non perse mai la sua curiosità e il suo spirito combattivo: era consueto vederlo nei salotti e alle sedute dell'Accademia, appoggiato a un pesante bastone e con il cornetto acustico all'orecchio; anche quando, nel 1763, fu colpito dalla paralisi, continuò a studiare e a scrivere, collaborando anche all'Encyclopédie. Morì ultrasettantenne nel 1774. Una sintesi della vita nella sezione biografie.  La poco nota Condaminea Anche se La Condamine non riuscì a far arrivare in Francia neppure una pianticella di Cinchona, come abbiamo già visto fu sulla base della sua descrizione che Linneo creò il genere. Bonpland, che seguì le orme del grande viaggiatore francese insieme all'amico Humboldt, ne battezzò addirittura una specie C. condaminea (oggi considerato un semplice sinonimo del linneano C. officinalis). A fare entrare il nostro poliedrico esploratore nella galleria dei dedicatari di generi botanici provvide però de Candolle nel 1830 in Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis, dedicandogli Condaminea. La ragione è semplice: si tratta di una Rubiacea affine a Cinchona, e il botanico svizzero volle ricordarlo come "esploratore del Perù e primo descrittore di Cinchona". A questo piccolo genere distribuito tra Centro America e Brasile sudorientale sono attribuite quattro specie. La più nota è probabilmente C. corymbosa, un alberetto o un arbusto molto ramificato con grandi foglie cerose dalla consistenza coriacea e vistosi corimbi di fiori bianchi a imbuto con petali retroflessi, relativamente frequente nei terreni disturbati delle pendici andine, dove è una pianta antifrana utile per consolidare e trattenere il terreno. La parentela di Condominea con Cinchona è per altro molto meno stretta di quanto pensasse de Candolle: appartengono sì alla stessa famiglia, ma a tribù e sottofamiglie diverse; inoltre le specie di questo genere non risultano avere proprietà officinali. La dedica rimane però azzeccata, visto che il centro di diversità è la foresta pluviale amazzonica del Perù, che il nostro percorse tra mille difficoltà per raggiungere il Marañón. Un elenco delle specie e qualche notizia in più nella scheda. Tra le questioni scientifiche più dibattute dalla scienza del '700 c'era quella della forma e della dimensione della Terra: a Newton che, sulla base della teoria della gravità postulava che fosse schiacciata ai poli e rigonfia all'equatore, si opponeva Cartesio che, basandosi sulla propria teoria dei vortici, pensava piuttosto a una forma simile a un uovo, con un allungamento verso i poli. A sostegno di quest'ultima tesi, l'astronomo Cassini portava le misure da lui effettuate in Francia. Per dirimere la controversia, nel 1735 l'Accademia delle Scienze francese organizzò due spedizioni: una si sarebbe recata in Lapponia, la seconda nel vicereame del Perù. Le misure di un arco di meridiano prese rispettivamente al circolo polare artico e all'equatore avrebbero dovuto fornire la risposta. Per la durata, le personalità coinvolte, i risultati, la più importante fu indubbiamente la seconda, passata alla storia con tanti nomi: Missione geodetica in Perù, Missione geodetica all'equatore, Missione geodetica franco-spagnola o anche Spedizione La Condamine, da uno dei principali protagonisti. Anche se i suoi obiettivi principali erano geografici ed astronomici, coinvolse anche un botanico, Joseph de Jussieu, e portò a rilevanti scoperte su piante medicinali di grande importanza. Fu la prima grande spedizione scientifica internazionale, poiché vi presero parte anche due giovanissimi e perspicaci ufficiali della Marina spagnoli, destinati a un brillante avvenire: Jorge Juan e Antonio de Ulloa, i due dedicatari dello spettacolare genere Juanulloa.  Dramatis personae: francesi e spagnoli L'idea che la Terra non fosse perfettamente sferica fu avanzata nel 1671 dal francese Jean Picard, l'astronomo che inventò il metodo della triangolazione geodetica. Qualche anno dopo Newton affermò che, se la Terra possedesse solo il moto di rivoluzione, sarebbe perfettamente sferica; ma a causa del movimento di rotazione assume la forma di uno sferoide schiacciato ai poli e dilatato all'equatore. A questa tesi si opponeva Cartesio, che, sulla base della teoria dei vortici, riteneva piuttosto che il pianeta avesse una forma simile a un uovo, con un allungamento lungo l'asse dei poli. A partire dal 1683, si passò alla verifica sperimentale; in Francia, gli astronomi Cassini, Maraldi e La Hire misurarono un meridiano dalla Manica ai Pirenei; le loro misure sembrarono confermare l'allungamento della Terra in senso longitudinale, secondo la tesi di Cartesio, ma furono respinte come erronee dai newtoniani . Per risolvere la questione una volta per tutte, l'Accademia delle Scienze decise di organizzare due spedizioni geodetiche (debitamente finanziate dalla Corona), che avrebbero dovuto misurare un arco di meridiano rispettivamente in prossimità del Polo nord e all'Equatore. La spedizione polare (1736-1737) fu guidata dal convinto newtoniano Pierre Louis Moreau de Maupertuis, accompagnato dal matematico Alexis Clairaut e dagli astronomi Charles-Étienne-Louis Camus e Pierre Charles Le Monnier; in Svezia fu inoltre accolta da Anders Celsius, l'inventore del termometro centigrado. La spedizione misurò un arco di meridiano tra Kittis e Tornea, constatando che era più lungo rispetto quello misurato da Cassini tra Amiens e Parigi; era la conferma che la Terra è appiattita ai poli. Maupertuis ritornò trionfante a Parigi e presentò i risultati con grande risonanza mediatica, tanto da guadagnarsi da parte dell'ironico Voltaire il soprannome di "schiacciatore della Terra". Ben più complessa si presentava la spedizione all'Equatore. Il primo problema era politico: la Francia decise di effettuare le misurazioni nell'attuale Ecuador, che all'epoca faceva parte del Vicereame del Perù, territorio sotto la giurisdizione spagnola. Fino ad allora, la Spagna aveva sempre negato l'autorizzazione a spedizioni straniere nelle proprie colonie; in virtù del patto di famiglia (tanto a Parigi quanto a Madrid regnava un Borbone) e del desiderio di partecipare a un'impresa tanto prestigiosa, la Spagna si convinse, ma a condizione che partecipassero anche due militari iberici, ufficialmente come collaboratori, ma in realtà come sorveglianti. Fu così che la Missione geodetica all'Equatore divenne la prima spedizione internazionale dell'età moderna. Per numero di partecipanti era decisamente imponente. L'équipe scientifica francese comprendeva dieci membri: tre accademici, l'astronomo Louis Godin (1704-1760), che era anche colui che aveva avuto l'idea della missione; il matematico, fisico e idrografo Pierre Bouguer (1698-1758); il chimico e geografo Charles de La Condamine (1701-1774); i disegnatori e cartografi Jean-Louis de Morainville e Jean-Joseph Verguin; l'orologiaio e "ingegnere agli strumenti matematici" Théodore Hugot; il chirurgo Jean Siniergue; gli aiutanti Couplet-Viguer e Godin des Odonnais (nipote di Louis Godin); il medico e botanico Joseph de Jussieu (1704-1779), fratello minore degli accademici Antoine e Bernard. Infatti, anche se l'obiettivo principale della missione era geodetico e astronomico, l'Accademia non volle perdere l'occasione di studiare la natura di quella contrada esotica, in particolare le sue reputate piante medicinali. Aggiungendo i servitori e i soldati di scorta, a lasciare La Rochelle il 16 maggio 1735 a bordo del mercantile Portefaix furono in ventitré. Dopo 37 giorni di navigazione, la prima tappa fu la Martinica, quindi Santo Domingo dove dovettero attendere tre mesi il vascello che li avrebbe condotti a Cartagena de las Indias (nell'attuale Colombia); durante il soggiorno forzato, secondo la loro specializzazione, gli scienziati si dedicarono alle osservazioni astronomiche o alla raccolta di piante e animali. Purtroppo ebbero anche il primo assaggio di febbri tropicali: ne soffrirono Jussieu e Godin des Odonnais in modo lieve, La Condamine in modo grave, due servitori e un soldato ne morirono. Per rimpiazzarli, furono acquistati alcuni schiavi neri, intaccando le non molto abbondanti risorse finanziarie, che vennero per altro dissennatamente sperperate da Godin per far colpo su una bellezza creola. I francesi arrivarono a Cartagena solo nel novembre 1735, dove ad attenderli c'erano i loro compagni spagnoli, arrivati da Cadice già a giugno: una squadra di sette uomini capeggiata dai tenenti di vascello Jorge Juan Satacilia (1713-1773) e Antonio de Ulloa de la Torre Giral (1716-1795). Entrambi giovanissimi (avevano rispettivamente 22 e 19 anni), erano i due migliori allievi dell'Accademia dei guardia marina di Cadice, un centro di formazione di élite dove i rampolli dell'aristocrazia venivano preparati a comandare le navi della flotta spagnola. Avevano già partecipato ad azioni militari, possedevano buone basi matematiche e nozioni elementari di astronomia, ma erano dei "ragazzini" (come li definirà sprezzantemente La Condamine), che da guardia marina erano stati promossi dalla sera alla mattina tenenti di vascello per non troppo sfigurare. Erano muniti di istruzioni molto precise, alcune ufficiali, altre segrete: in base alle prime, dovevano determinare le coordinate dei porti visitati, tracciare le carte delle città, ispezionare lo stato delle difese, raccogliere ogni possibile informazione su cantieri, risorse economiche, minerarie e naturali incluse le piante, suggerire riforme; in base alle seconde, dovevano sorvegliare strettamente i francesi che agli occhi di Madrid, più che scienziati, erano potenziali spie. Nell'attesa dei francesi, anche loro non avevano perso tempo, esplorando e cartografando la regione: tra le altre cose, in una miniera abbandonata nella selva del Chocó Ulloa osservò un metallo così duro da resistere alla calcinazione. Era la prima segnalazione del platino, di cui Ulloa è considerato lo scopritore. 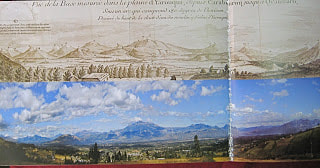 Un'impresa epica... e litigiosa Così riuniti, francesi e spagnoli si imbarcarono per Portobelo, da dove avrebbero raggiunto la costa del Pacifico addentrandosi a piedi nelle foreste dell'istmo di Panama, un cammino reso difficile dalla vegetazione impenetrabile, dalle punture di insetti e scorpioni, dagli incontri con animali selvatici di ogni tipo, ma soprattutto dalle dimensioni stesse della carovana, che comprendeva trenta muli carichi di abiti, tende, attrezzi da cucina, armi, acquavite e ovviamente strumenti astronomici, geodetici, topografici. Trovare un imbarco a prezzo accessibile per tanti bagagli e una quarantina di persone fu dunque tutt'altro che semplice; solo dopo quasi tre mesi gli esploratori poterono imbarcarsi sul San Cristobal, che li condusse a Manta, sulla costa dell'attuale Ecuador (marzo 1736). Bouguer e Godin incominciarono subito ad accapigliarsi: gli accordi tra Francia e Spagna prevedevano che venisse misurato l'arco di meridiano che passa per Quito (sull'altopiano, a circa 2850 metri sul livello del mare), ma Bouguer suggerì di misurarlo sulla costa, dove le operazioni sarebbero state più semplici e non sarebbe stato necessario trasporre i calcoli al livello del mare; Godin rifiutò, ben sapendo che i loro passaporti erano vincolati all'itinerario già stabilito e che le autorità locali li guardavano con sospetto. Concesse però a Bouguer e La Condamine di fermarsi qualche giorno sulla costa per determinare la posizione esatta dell'equatore. Fu così che per arrivare a Quito ognuno dei tre accademici fece gruppo a sé: Godin e gli spagnoli vi arrivarono per primi il 29 maggio 1736, seguiti a qualche giorno di distanza dagli altri. Per nessuna delle tre comitive fu una passeggiata: senza considerare seccature come il cibo troppo piccante o la mancanza di vino, ad accoglierli ci furono nuvole di moscerini, piogge torrenziali, foreste in cui bisognava aprirsi il cammino con le asce e orientarsi con la bussola, ponti di corda sospesi su abissi vertiginosi. Dopo diversi mesi dedicati alla preparazione logistica e alla verifica degli strumenti, le triangolazioni iniziano a ottobre nella pianura di Yaruqui e proseguono fino all'agosto 1738: viene misurato l'arco geodetico che da Quito arriva fino a Cuenca, per una lunghezza di oltre 300 chilometri. Come aveva previsto Bouguer, effettuare misure geodetiche in un territorio accidentato d'altura pone problemi non banali. In una regione in cui le cime superano i 5000 metri, capita che le basi di rilevazione coincidano con un burrone o una scarpata, gli strumenti devono essere spostati, smontati e rimontati rischiando di comprometterne il funzionamento. Per sistemare i punti di riferimento e osservare gli angoli, bisogna scalare montagne, sopportare il mal d'altura, il freddo, le piogge torrenziali, le nebbie, il vento che spazza via i segnali (senza contare quelli smantellati e rubati dagli indigeni), cui si aggiungono occasionali terremoti e eruzioni vulcaniche. Molto spesso le guide si rifiutano di proseguire; gli unici che non demordono, e condividono con scienziati e tecnici il merito del successo finale, sono gli schiavi neri, di cui non conosciamo né il numero né il nome. A tutte queste difficoltà, si aggiunse la situazione finanziaria sempre più drammatica: terminati i fondi inizialmente assegnati e mai giunti quelli richiesti a Parigi, i francesi furono costretti a chiedere prestiti al tesoro spagnolo o a commercianti locali, indebitandosi sempre più pesantemente; ogni tanto, bisognava interrompere i lavori per tornare a Quito per riparare gli strumenti e per cercare soldi, un'operazione solitamente affidata a La Condamine: figlio di un esattore delle imposte, sapeva come condurre le trattative e, soprattutto, godeva di un patrimonio personale da usare come garanzia. Così, ogni tanto partiva e si faceva centinaia e centinaia di chilometri per andare a Lima a battere cassa. Le intemperie, le difficoltà del cammino, le malattie e gli scontri con i locali diradarono le file della spedizione: nel 1736 l'aiutante geografo Couplet-Viguer morì di malaria; nel 1739 Siniergues, in seguito a un intrigo amoroso, venne assassinato durante una corrida a Cuenca. Anche due dei servitori morirono di morte violenta. A tutte queste difficoltà oggettive si aggiunsero i pessimi rapporti tra i tre accademici; Godin rifiutò di mostrare i suoi dati ai colleghi per un confronto. Quando, terminate le misure geodetiche nell'agosto 1738, passarono a quelle astronomiche, un errore di calcolo di Godin rilevato da Bouguer fece scoppiare una violenta lite. Per altro, la parte astronomica delle missione si rivelò anche più penosa e difficile di quella geodetica, con giorni e giorni persi ad attendere condizioni di perfetta visibilità, supporti resi instabili dai terremoti, la necessità di smontare, rimontare e rettificare continuamente gli strumenti, senza contare l'inesperienza di Bouguer e La Condamine che persero quasi due anni in un duro apprendistato. Le misure astronomiche, condotte dagli accademici divisi in tre équipes separate, richiederanno quasi cinque anni, fino al 1743. Terminato il loro compito, anziché rientrare insieme, i tre litigiosi scienziati francesi si divisero, a testimoniare il solco incolmabile che si era scavato tra loro. Pierre Bouguer ripercorse all'inverso la strada dell'andata, imbarcandosi per Panama e da qui per le Antille, quindi per Nantes. Nell'agosto 1744 era a Parigi, dove il suo ritorno quasi non fece notizia: che la Terra fosse appiattita l'aveva già dimostrato Maupertuis otto anni prima. In ogni caso, egli presentò all'Accademia una relazione in cui cercò di attribuirsi tutti i meriti, minimizzando i contributi di Godin e La Condamine. Quest'ultimo arrivò a Parigi solo alla fine del 1745, dopo un viaggio molto avventuroso che merita di essere raccontato in un post a parte, visto che coinvolge la botanica e gli ha guadagnato la dedica di un genere. Quanto a Godin, aveva deciso di ampliare la triangolazione, estendendola fino alla latitudine di Cuenca; continuò il suo lavoro con l'assistenza di Juan e Ulloa fino al maggio 1744. Oppresso da enormi debiti che non aveva modo di saldare, si trasferì poi a Lima dove lavorò come astronomo e professore; poté tornare in Europa solo quando la corona spagnola pagò i suoi debiti a condizione che si trasferisse a Cadice come professore dell'Accademia dei guardia marina (quella dove si erano formati Juan e Ulloa). Non sarebbe più tornato in Francia. 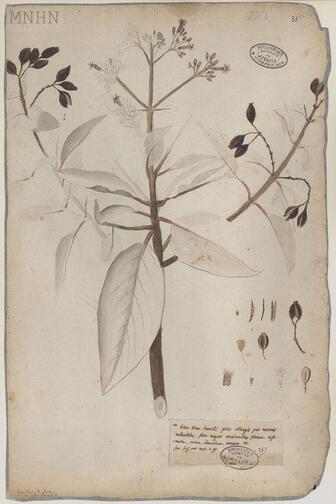 Un botanico inquieto e sfortunato Godin non fu il solo membro della spedizione ad essere trattenuto nel Vicereame del Perù dai debiti o da nuovi affetti. Suo nipote Jean-Baptiste Godin des Odonais si sposò con una ragazza della buona società creola e tornò in Francia con la moglie solo nel 1773 dopo avventure a non finire; in una versione un po' romanzata, le ha raccontate Robert Whitaker in La moglie del cartografo. Il meccanico-orologiaio Théodore Hugot rimase a Quito, si sposò con una peruviana e morì nella selva, mentre era impegnato a sfruttare una miniera. L'ingegnere e disegnatore Jean Louis de Morainville divenne architetto e morì per la caduta di una trave mentre lavorava alla ricostruzione di una chiesa a Riobamba, nel 1764 o nel 1765. Un destino amaro attendeva anche il nostro botanico, Joseph de Jussieu. Prima di studiare medicina e botanica seguendo l'esempio dei fratelli, aveva studiato matematica con l'intenzione di diventare ingegnere. In vista del viaggio in Sudamerica si era preparato alla sua missione studiando l'erbario di Joseph Donat Surian, il compagno di viaggio di Plumier. Le soste in Maritinica, a Santo Domingo, Cartagena e Portobelo furono per lui altrettante occasioni di raccolta di specie esotiche. Una volta a Quito, dovette però limitare le sue escursioni botaniche sulla sierra (dove in genere era accompagnato dal disegnatore de Morainville) perché, grazie alle sue basi matematiche, fu attivamente coinvolto nelle misurazioni geodetiche. Ma soprattutto a sottrarlo alle ricerche botaniche fu la sua condizione di medico in una regione dove la presenza di personale sanitario preparato era inversamente proporzionale alla frequenza di epidemie. Nel 1736 e nel 1737, insieme a Siniergues, fu cooptato dal viceré del Perù per assistere la popolazione colpita da epidemie di vaiolo a Cuenca e a Guayaquil. Fu dunque solo nel 1739, quando terminarono le misurazioni geodetiche, che poté dedicarsi pienamente alle ricerche botaniche. Quell'anno si recò a Loja, dove scoprì diverse specie di Cinchona, di cui studiò le caratteristiche botaniche e farmaceutiche. Quando la spedizione si sciolse, pensò di unirsi a La Condamine, ma ne fu impedito da un attacco di febbre e dalla mancanza di mezzi, che lo costringevano a mantenersi esercitando la medicina. Nel 1745 aveva abbastanza soldi per pensare di partire, ma non poté farlo a causa di un decreto della Real Audiencia di Quito che vietava di lasciare la città. Nel 1747, ricevette l'ordine del ministro degli esteri francese Maurepas di raggiungere Godin a Lima per recuperare gli strumenti. Attraversò a piedi la provincia di Canelos dove studiò gli alberi di cannella (non si tratta della vera cannella, Cinnamomum verum, nativa dell'Asia, ma di una pianta della stessa famiglia oggi denominata Ocotea quixos); esplorò poi la valle del fiume Chambo, le pendici del vulcano Tunguragua e la valle centrale, dove fece importanti raccolte botaniche che inviò ai fratelli a Parigi, raggiungendo Lima nel 1748. Qui si unì a Godin e ad agosto si mosse con lui in direzione di Buenos Aires, visitando tra l'altro le sponde del lago Titicaca, dove raccolse molti esemplari di uccelli. Ma quando raggiunsero La Paz, dopo un viaggio di nove mesi, decise di separarsi del suo compagno per visitare le coltivazioni di coca a Yunga, continuando poi per Santa Cruz de la Sierra. Aveva intenzione di raggiungere Godin più tardi, ma ciò non avvenne mai. Infatti nel luglio 1750 l'inquieto botanico arrivò a Potosì, dove sorgevano le più importanti miniere d'argento dell'epoca, e vi si trattenne per cinque anni, esercitando la professione medica e interessandosi di opere idrauliche. Con la vista indebolita, depresso e debilitato dalle malattie e dall'esposizione ai vapori di mercurio, tornò a Lima nel 1755. La famiglia premeva perché tornasse a casa, ma gli mancarono sempre i mezzi per farlo. Solo nel 1771 poté tornare a Parigi: era ormai un vecchio dal corpo e dalle mente distrutti; lasciò dietro di sé a Lima erbari e manoscritti che Joseph Dombey fu incaricato di recuperare senza esito. Altri materiali erano andati perduti già in precedenza, rubati da un servo. Ammesso all'Accademia delle scienze per volontà degli influenti fratelli, Joseph de Jussieu non poté partecipare neppure a una seduta. Visse ancora otto anni, immemore e immerso nel suo mondo interiore. Tra le piante di cui gli viene attribuita l'introduzione Heliotropium arborescens. I suoi maggiori contributi riguardano la china (Cinchiona spp.), l'albero di cannella (egli la chiamò, in onore del suo re, Borbonia peruviana, oggi come abbiamo visto si chiama Ocotea quixos) e la coca (Erythroxylum coca).  Marinai, scienziati, funzionari, spie... Ad eccezione di La Condamine, sul quale ritornerò, nessuno dei protagonisti francesi di questa spedizione (incluso il botanico Joseph de Jussieu) ha dato il suo nome a un genere botanico valido. Uno più che notevole celebra invece congiuntamente gli spagnoli Jorge Juan e Antonio de Ulloa. E' dunque ora di conoscerli meglio. I due "ragazzini" non solo si dimostrarono compagni di lavoro leali e affidabili, ma sfruttarono l'occasione per un apprendistato che fece di loro due esponenti di punta dell'illuminismo iberico. Come ho già accennato, al loro arrivo nel Vicereame si unirono a Godin, in quanto capo della missione, e solitamente fecero squadra con lui anche negli anni successivi. Condivisero i disagi, i pericoli e le malattie e furono determinanti per il completamento della missione, imparando ad usare strumenti che in Spagna non si erano mai visti, tanto da trasformarsi in provetti geodeti, cartografi ed astronomi. Come i francesi, erano ben accetti dagli ambienti colti e illuminati della colonia, e sospetti alle autorità, che li consideravano delle spie del governo centrale. Ritardi nell'atto di nomina e il rimborso del trasporto di alcuni bauli contenenti strumenti scatenarono una battaglia burocratica con il presidente dell'Audiencia di Quito e il suo tesoriere che si trascinò per anni. In tre occasioni, tra il 1740 e il 1744, in seguito alla ripresa delle ostilità con l'Inghilterra i due furono cooptati dal viceré del Perù per la difesa della costa. Per rispondere alla sua chiamata, nel 1740 essi percorsero in meno due mesi i 1800 km che separano Quito da Lima, guadando fiumi impetuosi, attraversando selve e deserti privi di acqua potabile, sempre accompagnati dai fedeli moscerini. Mentre attraversava un burrone, Ulloa cadde dal mulo, si ferì gravemente, viaggiando fino a Lima in condizioni molto difficili. Appena guarito, con il suo commilitone si occupò di organizzare la difesa dei porti più importanti della costa peruviana, di dirigere le costruzioni navali e disegnare le mappe delle principali città. Nel settembre 1741 erano di nuovo a Quito, ma ben presto furono richiamati dal viceré che, oltre a compiti simili a quelli già visti, affidò loro il comando di due brigantini mercantili trasformati in navi militari per contrastare la minaccia inglese (che, per loro fortuna, non si palesò). Quando tornarono a Quito per la terza volta, la spedizione era già in via di scioglimento. Come abbiamo già visto, affiancarono Godin nella triangolazione dell'area di Cuenca fino al maggio 1744. Poi partirono anch'essi per l'Europa, imbarcandosi su due diverse navi di una flotta francese che seguiva la rotta di Capo Horn. Nell'Atlantico, i vascelli si persero di vista ed ebbero sorte molto diversa: quello su cui viaggiava Juan ebbe una tranquilla navigazione e arrivò a Brest nell'ottobre 1745; l'ufficiale spagnolo proseguì per Parigi, dove espose le sue osservazioni astronomiche all'Accademia delle scienze (di cui divenne membro corrispondente), per poi rientrare a Madrid. Quello su cui era imbarcato Ulloa fu catturato dagli inglesi nei pressi di Terranova; Antonio gettò fuori bordo tutti i documenti, ad eccezione delle misure geodetiche. Imprigionato, fu condotto a Londra; ma appena si conobbe la sua identità, fu liberato e ammesso alla Royal Society per i suoi meriti scientifici. Una nave inglese lo ricondusse in patria, dove arrivò qualche mese dopo l'amico. Nominati capitani di vascello, Juan e Ulloa scrissero a quattro mani Observaciones astronómicas y físicas hechas en los Reinos del Perú e Relación histórica del viaje hecho de orden de su Majestad a la América Meridional, pubblicati nel 1748, debitamente epurati dalla censura, che fece cancellare tutte le beghe con le autorità coloniali, e dall'Inquisizione, che impose di presentare il sistema copernicano come un'ipotesi non provata. Entrambi ebbero poi carriere prestigiose e furono figure importanti della rinascita scientifica della Spagna del secondo Settecento. Ulloa, dopo un viaggio di studio in Europa, fondò lo Studio e Gabinetto di storia naturale, antenato dell'attuale Museo nazionale di scienze naturali e creò il primo laboratorio di metallurgia del paese. Divenne poi un importante funzionario coloniale, occupandosi tra l'altro del miglioramento del servizio postale tra America e madrepatria. Meno fortunato nella carriera militare, fu messo sotto processo quando fallì nel tentativo di riconquistare la Florida, ma terminò la sua carriera con il grado di ammiraglio e direttore generale dell'esercito spagnolo. Quanto a Juan, nel 1748 il ministro della marina lo mandò in Inghilterra a spiare i cantieri navali britannici per carpirne i segreti industriali. Riuscì a svolgere brillantemente l'incarico, convincendo anche ingegneri navali e operai qualificati a trasferirsi in Spagna con le famiglie; la polizia era sulle sue tracce e arrestò alcuni dei suoi contatti, ma egli riuscì a sfuggire di un soffio imbarcandosi clandestinamente su una nave diretta in Francia. Nel 1752, fu nominato direttore della Accademia dei Guardiamarina di Cadice, dove ritrovò il suo compagno di avventure Godin. Provetto matematico, applicò le sue conoscenze alle costruzioni navali, trasformò l'arsenale di Cadice in un laboratorio all'avanguardia. Fu tra i promotori della creazione dell'Accademia delle Scienze di Madrid, città dove fondò anche l'Osservatorio reale. Fu poi coinvolto nella creazione dell'arsenale di Ferreol e nella riorganizzazione della Scuola dei nobili. Fu autore di un importante compendio di navigazione e come astronomo elaborò un metodo di calcolo della parallasse solare.  Liane epifite e grappoli aranciati Nel loro Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus del 1794 Ruiz e Pavon dedicarono molti nuovi generi a scienziati spagnoli, con il preciso intento di dimostrare che la scienza iberica aveva ormai raggiunto la maggiore età e la Spagna poteva competere alla pari con le altre nazioni europee anche in questo campo. In questo contesto, la dedica di un genere a Juan e Ulloa era obbligata: non solo erano due esponenti particolarmente brillanti del rinnovamento scientifico della Spagna, ma come esploratori del Vicereame del Perù e membri di una missione internazionale franco-iberica potevano essere considerati i diretti predecessori degli stessi Ruiz e Pavon. La pianta che scelsero per onorarli era singolare da diversi punti di vista: cresceva sui rami degli alberi della foresta pluviale peruviana e produceva fiori spettacolari di un caldo color arancio; credendo si trattasse di una pianta parassita, la chiamarono Juanulloa parasitica, unendo nel nome generico i nomi dei due dedicatari, in modo da sottolineare la loro stretta collaborazione e l'amicizia che li legò per tutta la vita. In realtà, le specie di questo piccolo genere della famiglia Solanaceae non sono parassite, ma semi epifite: possono crescere sia a terra, sia su alberi e rocce. Le sue nove-dieci specie sono distribuite tra il Messico e il Perù; la maggior parte sono liane, ma possono avere anche portamento arbustivo. Molte sono caratterizzate da vistose infiorescenze di fiori con corolle tubolari avvolte in calici pentagonali persistenti dai colori brillanti (rosso, giallo, arancio, viola). La specie più nota, disponibile anche da noi in vivai specializzati, è J. mexicana (spesso commercializzata con il sinonimo J. aurantiaca). E' una liana o un piccolo arbusto perenne sempreverde con foglie coriacee e racemi di fiori penduli con calice e corolla arancio brillante. In natura può essere epifita; proprio per questo si adatta molto bene alla coltivazione in vaso. Un cenno alle altre specie e alla loro distribuzione nella scheda. In Sud America, tra Perù e Ecuador, c'era un tesoro vero e molto ambito: quello delle piante di quina, ovvero delle diverse specie di Cinchona la cui corteccia era l'unico rimedio conosciuto per la malaria. Ma fin dal tempo dei Conquistadores si favoleggiava di altri, più mitici tesori, come quello che uno degli ultimi capi Inca avrebbe nascosto tra le montagne dell'Ecuador. Partito dalla Spagna per il Sud America per studiarne i tesori naturali, il farmacista sivigliano Anastasio Guzman finì per farsi sedurre dal miraggio del tesoro perduto degli Inca e da solerte indagatore dei tre regni della natura si trasformò in una specie di sfortunato Indiana Jones. Ma prima aveva fatto tempo ad incrociare i protagonisti della seconda fase della Spedizione botanica nel Vicereame del Perù nonché Bompland e Humboldt durante il loro soggiorno in Ecuador. Alla fine, conquistò davvero un tesoro: la dedica del genere Guzmania, noto a tutti grazie alla coltivatissima G. lingulata, una delle più comuni e amate piante d'appartamento.  Un naturalista visionario a caccia dei segreti della natura Probabilmente grazie alla testimonianza di Humboldt, diverse fonti qualificano Anastasio Guzmán come "eminente naturalista" o "famoso studioso"; in realtà sappiamo ben poco di questo farmacista andaluso morto in Ecuador nel 1807 mentre era alla ricerca del misterioso tesoro degli Inca. Non ne conosciamo neppure la data e il luogo di nascita. La prima notizia certa su di lui risale al 26 maggio 1794, giorno in cui, come riferisce la Gaceta de Madrid, "Don Anastasio de Guzman, professore di farmacia" fu onorato con il primo premio ai pubblici esami di botanica, alla conclusione del corso istituto dalla Reale società di Medicina di Siviglia. Poiché all'epoca in Spagna non era previsto l'insegnamento universitario della farmacia, probabilmente il titolo "professore di farmacia" significa semplicemente che era un farmacista provvisto della licenza, avendo superato l'apprendistato e l'esame di fronte al Tribunale del Protomedicato. Guzman ci teneva molto a questo titolo, visto che in Sud America si presenterà come "professore pratico di Farmacia, Galenica e Clinica, ricevuto e convalidato a Siviglia, Puerto de Santa Maria, Guayaquil e Quito, cattedratico, licenziato in botanica nella Reale società medica di Siviglia". Da questo pomposo curriculum (che mi ricorda irresistibilmente quello del dottor Dulcamara) deduciamo anche che per qualche tempo dovette esercitare la professione di farmacista a Puerto de Santa Maria, una piccola località nei pressi di Cadice. Non molto tempo dopo il brillante esame di botanica Guzmán deve essere partito per il Sud America per un viaggio di studio a proprie spese, intenzionato a studiare la chimica e le altre scienze della natura. Qualcuno si è chiesto ironicamente come potesse venire in mente in quei tempi di andare in Perù (dove non esistevano né scuole né laboratori) a studiare la chimica; eppure per un farmacista proprio qui c'era un grande oggetto di richiamo le cui proprietà chimiche e farmaceutiche valeva la pena di studiare sul posto: gli alberi di quina, ovvero di diverse specie di Cinchona, dalla cui corteccia si ricavava l'unico medicamento capace di tenere a bada la malaria. Anche le tappe del viaggio sudamericano di Guzmán sono note solo a grandi linee; la prima meta fu Montevideo, quindi Buenos Aires, da cui proseguì per il Cile a piedi, approfittando del viaggio per raccogliere esemplari dei tre regni della natura e dati su ogni genere di soggetto. Lo troviamo poi in Perù. A Lima i suoi passi si incrociarono con quelli di Juan José Tafalla, il capo della Spedizione botanica nel Vicereame del Perù dopo il ritorno di Ruiz e Pavon in Spagna. Prima di proseguire con le sue avventure, dunque, fermiamoci un attimo anche noi per riannodare i fili della spedizione al punto in cui l'avevamo lasciata in questo post. Come avevamo visto, Madrid si preoccupò di garantire la continuità della spedizione anche quando i botanici spagnoli fossero rientrati in patria; a questo scopo, nel 1785 vi furono aggregati due "apprendisti", scelti su suggerimento del sovrintendente del Perù José Escobiedo tra i militari appena congedati dal reggimento di fanteria Soria, sciolto nel 1784 dopo aver partecipato alla repressione dell'insurrezione di Tupac Amaru. I due erano il navarrino Juan José Tafalla Navascués (1755-1811), appartenente a una famiglia di farmacisti e forse farmacista egli stesso, e Francisco Pulgar, pittore toledano. Nato nel 1755, Tafalla aveva trent'anni, mentre non conosciamo la data di nascita di Pulgar. Dopo essersi fatti le ossa partecipando alle campagne del 1785-1787 con Ruiz e Pavon, nel 1787 i due erano ormai in grado di continuare da soli le ricerche. Congiuntamente alla partenza di Ruiz, un decreto reale nominò Tafalla capo della spedizione e venne istituita per lui una cattedra di botanica presso il Collegio di Chirurgia di San Fernando di Lima. Inizialmente Tafalla e Pulgar lavorarono soprattutto nella zona di Huánuco, approfondendo lo studio degli alberi di quina e delle tecniche della sua estrazione. Nel 1790 accompagnarono in questa regione la spedizione Malaspina. Nel 1793 Tafalla ricevette da Ruiz, divenuto suo superiore come capo dell'Oficina de la Flora peruana y chilensis, precise istruzioni per l'invio di piante vive e essiccate, semi e disegni. Lo stesso anno la spedizione si arricchì di un secondo botanico, Juan Agustín Manzanilla, al momento come volontario senza paga. Tra il 1793 e il 1795 il gruppo erborizzò nelle montagne di Tarma. Tra il 1797 e 1798, si spostò nella provincia di Humalíes e nella valle del Monzón. Fu probabilmente in questo arco di tempo che Guzmán giunse a Lima, dove a quanto sembra visse per un anno; sappiamo che strinse amicizia con Tafalla e che i due erborizzarono insieme; l'interesse comune che li unì, al di là di una generica passione per la botanica, saranno stati proprio gli alberi di Cinchona, il tesoro verde di cui entrambi volevano scoprire i segreti.  Incontri botanici in Ecuador Più ancora del Perù, il vero regno della Cinchona era l'Ecuador. Ed è proprio questa la prossima meta sia di Guzmán sia di Tafalla e compagni. Nel 1799 a Tafalla fu ordinato di organizzare una grande spedizione in Ecuador; a tal fine, il gruppo fu integrato da due nuovi pittori (Pulgar era ormai uscito di scena), Xavier Cortés e il peruviano José Gabriel Rivera. Tra il 1799 e il 1802 i quattro naturalisti esplorarono i dintorni di Guayaquil, studiando soprattutto le piante atte a fornire legname per le costruzioni navali. Probabilmente nello stesso periodo anche Guzmán era Guayaquil, dove lavorava come sovrintendente delle haciendas di Jacinto de Bejarano, un grande proprietario terriero e futuro leader del movimento indipendentista; ma non amava il clima della costa e si trasferì nella sierra e quindi a Quito dove si trovava sicuramente nel 1800 (finalmente una data certa) e, secondo le sue parole, intendeva "esercitare la farmacia e la chimica e proseguire gli studi sui tre regni della natura, animale, vegetale e minerale". Nella città ecuadoregna Guzmán strinse amicizia con un giovane intellettuale, José Mejía Lequerica, che lo ospitò a casa sua in cambio di lezioni di scienze naturali; insieme esplorarono la flora dei dintorni in numerose escursioni botaniche e accumularono osservazioni geografiche, meteorologiche, minerarie, economiche. Guzmán, che era anche un eccellente disegnatore, aveva già messo insieme copiose collezioni, eseguito centinaia di disegni e redatto numerosi manoscritti, tra cui un proprio sistema di classificazione dei tre regni della natura, cui aveva dato il titolo linneano Sistema de la Naturaleza. Nei primi giorni del 1802, provenienti da Bogotà, arrivarono a Quito Bompland e Humboldt; incontrarono Guzmán il quale mostrò i suoi materiali al tedesco, che fu talmente ammirato dalla sua profonda conoscenza della natura da sostenere che nell'altopiano dell'Ecuador aveva trovato un naturalista la cui sapienza superava quella di Linneo. E' alla sua testimonianza che dobbiamo l'elenco delle numerose opere manoscritte redatte da Guzmán. La sua ammirazione è dimostrata anche dalla dedica del bellissimo e raro Ranunculus gusmannii, con queste significative parole: "Lo ha raccolto il nostro grande amico Guzman, farmacista, sul monte Corazon di Quito, proprio al limite delle nevi". Nel 1803 arrivò a Quito anche Francisco de Caldas, inviato da Mutis a studiare la quina; si trattenne nella zona fino al 1805 e divenne amico di Guzmán con il quale fece diverse escursioni; anche lui vide i manoscritti del naturalista andaluso, senza farsene impressionare più di tanto. Quanto a Bompland e Humboldt, dopo sei mesi trascorsi a Quito e nei dintorni, si spostarono a Loja e da qui in Perù; tornati in Ecuador, a Guyaquil incontrarono Tafalla e Manzanilla e erborizzarono con loro tra gennaio e febbraio 1803. Il tedesco confrontò il suo erbario con quello degli spagnoli e nelle sue successive pubblicazioni ne elogiò la padronanza della flora locale. Poi i due visitatori si congedarono dall'Ecuador e dai nuovi amici. Dobbiamo farlo anche noi, raccontando brevemente le loro ulteriori vicende prima di tornare a Guzmán. Tra 1803 e 1804, Tafalla e Manzanilla spostarono le loro ricerche nelle Ande ecuadoregne, in particolare nei dintorni di Cuenca e Loja, il centro riconosciuto del regno della quina. Divisi in due gruppi (Tafalla con Cortés e Manzanilla con Rivera), ne individuarono e descrissero 32 diversi tipi, studiando anche attentamente i metodi di estrazione e sfruttamento. Nel 1808 Tafalla tornò a Lima, incaricato di crearvi un orto botanico. Nel 1809, mentre Manzanilla lo sostituiva come professore supplente, fece una breve spedizione in Cile; morì quindi a Lima nel 1811. Manzanilla, che dal 1804 era diventato secondo botanico, gli succedette come capo della spedizione e professore di botanica al Collegio di chirurgia e fece ancora qualche invio fino al 1815. Poi la sua salute mentale si deteriorò; la spedizione fu dichiarata ufficialmente conclusa e nel 1818 il corso di botanica cessò di esistere. Nell'arco di ventisette anni (dal 1788 al 1815) Tafalla e Manzanilla effettuarono 101 invii di materiali a Madrid, 45 dal Perù e 56 dall'Ecuador, con oltre 750 disegni e migliaia di esemplari. Ruiz e Pavon se ne servirono come propri, e il contributo dei due ricercatori non venne mai riconosciuto. Solo in epoca recente (1989) lo storico Eduardo Estella Aguirre mise in luce l'importanza del lavoro di Tafalla e del suo gruppo, rendendosi conto che avevano più che raddoppiato le specie scoperte da Ruiz e Pavon. Grazie a lui venne anche pubblicato il manoscritto di Tafalla Flora Huayaquilensis (1989-1991); rimasto inedito per quasi duecento anni, costituisce la prima flora dell'Ecuador. 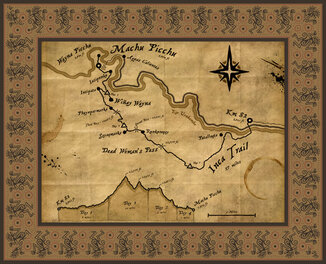 Un tesoro misterioso e maledetto E' ora di tornare a Guzmán, che, inquieto come sempre, aveva lasciato Quito e per breve tempo aveva gestito una farmacia a Latacunga, una città situata sull'altopiano. Qui venne a sapere di un favoloso tesoro nascosto nelle montagne di Llanganates. La storia che gli fu raccontata è, nelle grandi linee, la seguente: nel 1532 l'ultimo imperatore inca, Atahualpa, fu catturato da Pizarro; per riottenere la libertà, promise che come riscatto avrebbe riempito una stanza d'oro. Pizarro finse di accettare il patto, ma poi fece uccidere Atahualpa. Alla notizia della sua esecuzione, il valoroso generale Rumiñahui, che stava portando a Cajamarca ben 750 tonnellate d'oro come riscatto, tornò a Quito e portò il tesoro sui monti Llanganates, dove lo gettò in un lago o lo nascose in una grotta. Una cinquantina di anni dopo, un certo Valverde affermò di essersi arricchito dopo che la famiglia della moglie, una donna inca, lo aveva condotto sul luogo dove era nascosto il tesoro. Prima di morire, lasciò alcune indicazioni per ritrovarlo, il cosiddetto Derrotero de Valverde. Da allora il tesoro non fu mai trovato, e molti di coloro che lo cercarono fecero una brutta fine, compreso il nostro Guzmán. Il farmacista infatti si convinse della fondatezza della leggenda e cercò di ricostruire l'itinerario di Valverde. Durante le ricerche si imbatté in alcune vecchie miniere di rame e argento, e, sempre afflitto da problemi di soldi, pensò che avrebbe potuto arricchirsi in modo immediato e sicuro, riprendendone lo sfruttamento; litigi con i suoi collaboratori e risultati poco redditizi lo convinsero ben presto a desistere. Nel 1806 si spostò nel villaggio di Patate dove visse sotto la protezione del sindaco; qui, basandosi sull'itinerario di Valverde e altre dicerie, disegnò una mappa dei monti Llanganates, totalmente immaginaria visto che non si era mai addentrato nelle profondità di quelle misteriose montagne, sempre avvolte dalla nebbia. Una notte, mentre camminava nella campagna in preda ad un attacco di sonnambulismo, cadde in un burrone perdendo la vita. Nel 1860 la sua mappa fu scoperta dal viaggiatore e cacciatore di piante Richard Spruce che la pubblicò nel Journal of Royal Geographical Society rendendo popolare la leggenda. La maledizione degli Inca colpì anche il lavoro di naturalista di Guzman, perché i suoi manoscritti andarono perduti o dispersi. A ricordare questo naturalista avventuroso e visionario è così rimasto solo un elenco di titoli riportati da Humboldt, la cui portata scientifica non possiamo dunque valutare.  Le coloratissime brattee di Guzmania Messi in secondo piano da Ruiz e Pavon, che li considerarono semplici raccoglitori e si appropriarono senza scrupoli del loro lavoro, Tafalla e Manzanilla sono stati misconosciuti anche dalla terminologia botanica. Non c'è alcun genere a celebrare Manzanilla e i tre pittori della spedizione (di cui uno, Francisco Pulgar, di grandissimo valore); quanto a Tafalla, fu sfortunato anche in questo: nel 1794 Ruiz e Pavon crearono in suo onore il genere Tafalla, che tuttavia non è valido trattandosi di un sinonimo di Hedyosmum. Un secondo Tafalla, creato da Don nel 1831, è invece sinonimo di Loricaria. Il botanico navarrino è ricordato almeno da qualche nome specifico: Condea tafallae, Salvia tafallae, Mikania tafallana. Ad aggiudicarsi, almeno in questo campo, un vero tesoro, alla fine è stato Anastasio Guzman. Su istanza di Tafalla, nel 1802 Ruiz e Pavon gli dedicarono infatti Guzmania, uno dei generi più ampi e importanti della famiglia Bromeliaceae. Anche la loro dedica merita una citazione: "Abbiamo dedicato questo genere al farmacista Anastasio Guzman, industrioso e diligente ricercatore di piante, animali e di ogni altro corpo naturale nelle sue peregrinazioni per l'America". Guzmania comprende circa 120 specie di perenni epifite originarie delle foreste pluviali degli Stati Uniti meridionali, dell'America centrale e delle Antille, del Sudamerica settentrionale e occidentale. Il centro di diversità sono le foreste andine d'altura, con numerose specie anche in Ecuador, così appassionatamente esplorato da Guzman. Proprio nei Llanganates vive ad esempio la rara Guzmania puyeoensis. La specie più nota, una delle più diffuse e vendute piante d'appartamento, è però G. lingulata, originaria di un'area abbastanza vasta che si estende dall'America centrale al Brasile. E' molto apprezzata per la facilità di coltivazione e la prolungata fioritura; i fiori di per sé sono insignificanti, ma sono circondati da vistosissime brattee rosso vivo (ma anche arancio, giallo, rosa in alcune cultivar). Se questa è la Guzmania per eccellenza, non mancano altre specie di grande interesse, come l'enorme G. lindenii con infiorescenze alte più di tre metri, oppure G. sanguinea con le cui foglie si colorano di rosso al momento della fioritura, oppure G. wittmackii con delicate infiorescenze lievemente arcuate . Su queste e altre specie qualche informazione nella scheda. Per la Spagna, il Settecento fu un secolo di grandi spedizioni geografiche e scientifiche: dal 1735 al 1800 se ne susseguirono una sessantina, geografiche, idrografiche, cartografiche, astronomiche e naturalistiche. Questo attivismo toccò il suo vertice con il regno di Carlo III (1759-1788) che promosse tre importanti spedizioni botaniche nei vicereami americani: il vicereame del Perù (che comprendeva Perú e Cile), quello di Nueva Granada (l'attuale Colombia) e quello di Nuova Spagna (Messico e America Centrale). La serie fu inaugurata dalla Expedición botanica al virreinato del Perú (1777-1788), frutto della cooperazione con la Francia, potenza alleata grazie al "patto di famiglia (su entrambi i troni sedevano esponenti dei Borboni) ma anche sospetta rivale per il dominio coloniale e il prestigio scientifico. I protagonisti furono tre giovani botanici: gli spagnoli Hipólito Ruiz e José Antonio Pavón e il francese Joseph Dombey. Tra vicissitudini di ogni genere, tra cui la più vasta rivolta della storia coloniale sudamericana, un naufragio che portò alla perdita di considerevoli raccolte, un incendio devastante, senza contare gli insanabili dissidi tra Dombey e i colleghi spagnoli, la spedizione ottenne risultati straordinari: oltre 3000 esemplari di piante essiccate, 2500 disegni botanici, con la scoperta di almeno 500 nuove specie e 140 generi. Molte furono pubblicate insieme da Ruiz e Pavón, che prima nella ricerca sul campo poi a Madrid costituirono un inossidabile sodalizio scientifico; anche a loro, che avevano dedicate dozzine dei generi da loro scoperti a uomini politici e scienziati, spetta l'ambito riconoscimento di un genere celebrativo: il monotipico Ruizia, endemico dell'isola di Réunion, e il ben più noto Pavonia. Entrambi si devono a Cavanilles, futuro direttore dell'Orto botanico di Madrid, e, per giustizia poetica, appartengono alla stessa famiglia, quella delle Malvaceae, mantenendo almeno in questo un legame tra i due inseparabili compagni. 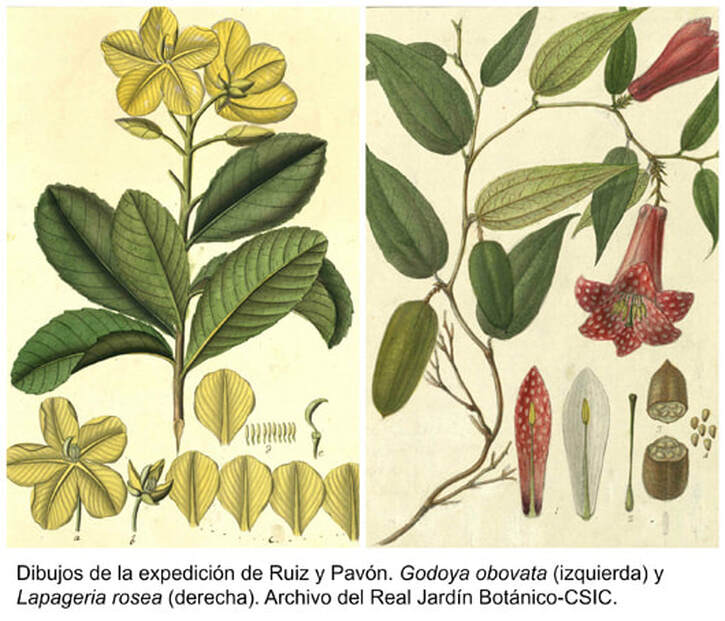 Una spedizione franco-iberica Nel 1774, di recente nominato Controllore generale delle finanze, il ministro francese Turgot chiese alla corona spagnola di autorizzare l'invio di un botanico francese in Sud America, per studiare la flora locale e cercare di recuperare le carte di Joseph de Jussieu che, rimasto in Perù 35 anni, era di recente rientrato in Francia in stato di estrema prostrazione. L'obiettivo principale era la ricerca e l'introduzione di specie alimentari nella Francia mediterranea e in Corsica, nella speranza di far fronte alle ricorrenti carestie. La proposta fu accolta con favore dal re di Spagna Carlo III, ma con due importanti modifiche: si sarebbe trattato di una spedizione congiunta, coordinata e diretta da Madrid, e il botanico francese sarebbe stato affiancato da colleghi spagnoli; alla Spagna inoltre spettavano la metà delle raccolte e la priorità della pubblicazione. In tal modo, la monarchia iberica, pur beneficiando delle conoscenze e della maggiore esperienza di un botanico formato al Jardin des Plantes parigino, avrebbe mantenuto il controllo della spedizione, con obiettivi parzialmente diversi da quelli francesi: la ricerca di piante industriali e medicinali (in particolare quelle da cui si ricavava il chinino), di cui intendeva riservarsi il monopolio. L'impresa fu posta sotto la tutela del Segretariato di Stato e affidata alla direzione scientifica di Casimiro Gomez Ortega, il direttore dell'Orto botanico di Madrid, che come primo farmacista reale era anche direttamente interessato alla scoperta e allo sfruttamento di medicamenti in regime di monopolio. Gli uomini scelti a Parigi e a Madrid era tutti giovani o giovanissimi: da parte francese, il trentacinquenne Joseph Dombey, che si era laureato in medicina a Montpellier, aveva partecipato a spedizioni botaniche in Provenza e sulle Alpi e si era perfezionato al Jardin des Plantes con Bernard de Jussieu e André Thouin; da parte spagnola, due studenti di farmacia allievi di Gomez Ortega, Hipólito Ruiz e José Antonio Pavón, entrambi ventitreenni. Per età, titoli ed esperienza, il più qualificato era certamente Dombey, l'unico laureato e il solo vero botanico; ma, per opportunità politica, a capeggiare la spedizione fu Ruiz, con il titolo di "primo botanico"; Pavón fu nominato "secondo botanico", mentre a Dombey toccò il ruolo collaterale di "botanico naturalista in qualità di accompagnatore dei botanici spagnoli della stessa professione". Non vera collaborazione dunque, ma una specie di convivenza forzata, nutrita di diffidenza reciproca. Dombey, che si era preparato con scrupolo alla missione studiando gli erbari di Joseph de Jussieu e imparando lo spagnolo, arrivò a Madrid all'inizio di novembre 1776, ma tra rinvii, ripensamenti e cambi di programma, la partenza per il Sud America avvenne solo un anno dopo, il 4 novembre 1777, quando i tre botanici si imbarcarono a Cadice alla volta di Callao, accompagnati da due pittori, Joseph Brunete e Isidro Gálvez, allievi della accademia di pittura di San Fernando. 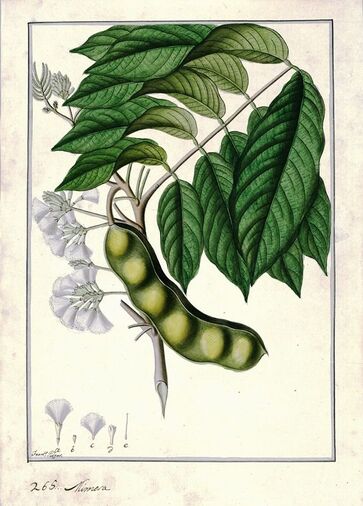 Dal Perù al Cile, con disastri Il gruppo giunse in Perù ad aprile e si mise alacremente al lavoro, stabilendo il proprio quartiere generale a Lima. Dapprima esplorarono i dintorni della capitale e le province costiere del nord, Huaura e Laurín. Sostenuti dall'entusiasmo, fecero importanti raccolte: i contadini, vedendo questi uomini ben vestiti, che percorrevano le campagne con una cartella sotto braccio in cui riponevano le piante, impressionati, li soprannominarono brujos yerbarteros, "stregoni erboristi". Già a settembre poterono spedire in Europa diciassette casse di materiali, dieci in Spagna e sette in Francia; l'invio di Dombey comprendeva anche alcuni reperti archeologici, raccolti presumibilmente a Laurin. Tuttavia non arrivò mai a Parigi: la nave su cui viaggiava fu intercettata dagli inglesi, e solo più tardi le sue preziose casse vennero restituite, ma alla Spagna. Nonostante il proficuo lavoro comune, l'atmosfera continuava ad essere improntata alla diffidenza; a Dombey era vietato muoversi da solo, a meno che gli fossero affidati compiti particolari dalle autorità (per la corona spagnola, era pur sempre uno straniero, dunque una potenziale spia) e la sua corrispondenza era sorvegliata; non poteva usufruire della collaborazione dei pittori, che erano al servizio esclusivo dei suoi colleghi spagnoli; inoltre, mentre le spese degli altri membri erano a carico della corona, lui doveva pagare tutto di tasca propria; e in colonia, dove ogni cosa doveva essere importata dall'Europa, la vita era molto cara. Anche i suoi rapporti personali con Ruiz, un giovane dal carattere vivo e amante della polemica, furono sempre piuttosto tesi; meglio andò con il pacato Pavón, che si assunse il ruolo di paciere, e divenne il suo compagno in molte escursioni. Nel maggio del 1779, il gruppo lasciò la costa per spostarsi tra le selve della Cordigliera, la cui vegetazione era all'epoca quasi sconosciuta alla scienza europea. Seguendo il sentiero inca, si spostò a La Oroya e Tarma, dove fissò la prima base. Poi si divisero: Ruiz e Galvez proseguirono fino al monastero francescano di Santa Rosa de Ocopa, mentre Pavón e Brunete andavano a Palca. Quanto a Dombey, fu inviato dal viceré a studiare le acque minerali di Cheuchin, per riunirsi con Ruiz e Galvez a Tarma, da dove i tre tentarono la scalata al monte Churupullana, dovendo desistere per la pioggia mista a grandine, Alla fine dell'anno tutto il gruppo si ricongiunse a Huasahuasi, rientrando a Lima alla fine del gennaio 1780 con la stagione delle piogge. Ad aprile ripartirono per la montagna, fissando la loro sede a Huanuco, al centro di una zona ricchissima di vegetazione, già alle porte dell'Amazzonia: la parte più difficile del loro viaggio, per l'assenza di sentieri segnati, il soffocante clima caldo-umido, le punture degli insetti, Tutti soffrirono di dissenteria e Ruiz si ammalò di febbri perniciose che furono sul punto di costargli la vita. In queste foreste i botanici trovarono molte piante ignote e importanti specie medicinali: alberi di coca (Erythroxylum coca) e soprattutto diverse specie di Cinchona, dalla cui corteccia si ricavava il chinino, il cui studio era uno degli obiettivi principali della spedizione spagnola. Mentre esploravano questa regione, incominciarono a diffondersi voci di una rivolta: erano le prime avvisaglie del sollevamento di Tupac Amaru, che sarebbe iniziato nel novembre 1780. A settembre, temendo un attacco, Dombey e Pavon rientrarono in fuga da Cuchero a Huanuco. L'avventura (poi rivelatasi un falso allarme) pesò molto negativamente sul morale di Dombey e minò il suo prestigio agli occhi dei compagni. Dopo essersi trattenuto a Huanuco fino a settembre egli rientrò a Lima, dove per mantenersi lavorò qualche mese come medico; solo a fine anno si ricongiunse ai suoi compagni, che nel frattempo avevano attivamente esplorato la provincia di Huamalies. Tutto il gruppo rientrò a Lima alla fine di marzo 1781. Nella seconda metà del 1781 gli spagnoli tornarono ad esplorare la provincia di Chancay, mentre Dombey rimase a Lima, come membro di una commissione incaricata di studiare le maree del porto di Callao. E' probabile che le autorità spagnole avessero preferito trattenerlo sulla costa, non desiderando che uno straniero fosse testimone di una ribellione tanto pericolosa. Il programma iniziale prevedeva che il gruppo proseguisse per Quito, da dove poi avrebbe dovuto raggiungere Cartagena per imbarcarsi alla volta dell'Europa. Fu probabilmente il dilagare della rivolta di Tupac Amaru a indurre Madrid a cambiare programma: nel gennaio 1782 la spedizione venne spostata in Cile. Giunti per mare a Talcahuano, i naturalisti stabilirono la loro base a Concepcion, dove si trattennero per circa un anno con escursioni a Arauco, Culenco e altrove; solo Pavón fece una puntata alla Cordigliera, per studiare il "pino del Cile", ovvero Araucaria araucana. Durante il loro soggiorno a Concepcion scoppiò un'epidemia di colera e Dombey prestò gratuitamente le sue cure agli ammalati come medico capo della città. Nel marzo 1783 la spedizione si spostò a Santiago, dove Ruiz si ammalò di febbre tifoidea, Dombey venne inviato a Coquimbo e Jarilla, per valutare le potenzialità economiche di alcune miniere abbandonate di mercurio. A ottobre si ritrovarono tutti a Santiago, per spostarsi insieme a Valparaiso, da dove si imbarcarono per Callao. Qui le sorti di Dombey e dei suoi compagni si separarono; mentre gli spagnoli rimanevano in Perù per continuare le esplorazioni secondo i nuovi ordini di Madrid, il francese, essendo ormai terminato il tempo fissato da Parigi, nell'aprile 1784 si imbarcò sulla nave El Peruano alla volta di Cadice. Lo attendevano sgradevolissime vicissitudini, su cui tornerò in un prossimo post. Su un'altra nave, la San Pedro de Alcantara, viaggiavano invece le 55 casse con le raccolte di Ruiz e Pavon; tuttavia, al largo del Portogallo, il vascello naufragò e tutto il materiale andò perduto. Nel frattempo, i botanici spagnoli avevano ripreso le ricerche, visitando nuovamente Huánuco e le montagne di Puzuzo. Poiché anche per loro si avvicinava il momento del ritorno, si decise di aggregare alla spedizione due apprendisti, che potessero continuare il lavoro dopo la loro partenza; la scelta cadde sul farmacista militare Juan José Tafalla come botanico e su Francisco Pulgar come pittore. Nel 1785 il gruppo così integrato continuò ad esplorare la ricca area di Huánuco, concentrandosi in particolare nello studio delle diverse specie di Cinchona; grazie all'esperienza accumulata, fu sicuramente il periodo più fruttuoso dell'intera spedizione; tuttavia mentre si trovavano a Macora un violento incendio distrusse la fattoria dove soggiornavano, mandando in fumo tre anni di diari di campo e quattro anni di descrizioni botaniche. La campagna dell'anno successivo li vide a Muña e ancora a Huánuco, Pillao e Chacahuasí. Durante uno degli spostamenti, Brunete si ammalò e morì; così furono solo in tre, Ruiz, Pavón e Galvez a imbarcarsi per Cadice, dove arrivarono il 12 ottobre 1788, a quasi 11 anni esatti dalla partenza. In Perù rimasero Tafalla e Pulgar che, con alcuni collaboratori, continuarono a inviare materiali alla Oficina de la Flora Peruviana y Chilense diretta da Ruiz fino al 1814, estendendo le ricerche anche all'Ecuador. 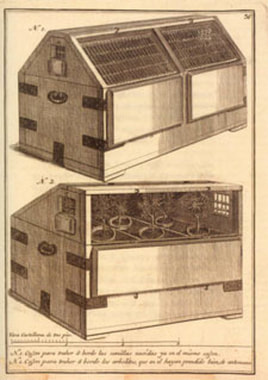 Una nuova flora tutta da scoprire e pubblicare Appena giunti in Spagna, Ruiz, Pavón e Galvez si recarono a Madrid per dedicarsi al'immane lavoro della pubblicazione delle raccolte. Li accolse una situazione di grande tensione, causata dalla pubblicazione, prima in Francia poi in Inghilterra, di alcuni dei materiali raccolti da Dombey, nonché dal conflitto più o meno latente tra Ortega e Cavanilles. I due botanici furono aggregati all'orto botanico di Madrid come "dimostratori" e nel 1792 fu creata per loro l'Oficina de la Flora Peruviana y Chilensis, diretta da Ruiz. Iniziò un intenso e metodico lavoro di studio delle raccolte, per classificare, nominare e descrivere correttamente le piante, in stretta collaborazione con Gomez Ortega come consulente e correttore. Intanto Galvez, assistito da un incisore e più tardi da un altro disegnatore, allestiva le illustrazioni. Il primo frutto di questo lavoro editoriale fu Quinología o tratado del árbol de la quina, pubblicato da Ruiz nel 1792, in cui descrisse sette specie di Cinchona raccolte in Perù; sull'argomento sarebbe tornato, insieme a Pavón, in Suplemento a la Quinologia (1801) in cui descrisse altre sette specie raccolte da Tafalla e polemizzò con una certa violenza con Mutis. Nel 1794, a quattro mani, usciva Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus, in cui - a mo' di anticipazione della più ambiziosa Flora - pubblicarono i caratteri distintivi di 149 nuovi generi, accompagnati da 37 tavole in bianco e nero. Nel 1798 iniziò ad uscire la monumentale Flora peruviana, et chilensis, sive descriptiones, et icones, in cui le specie erano disposte secondo il sistema linneano; tra il 1799 e il 1802, ne uscirono altri due volumi, estendendo la pubblicazione fino alla classe linneana Octandria. Contemporaneamente, nel 1798 diedero alle stampe Systema vegetabilium florae peruvianae chilensis, un versione ampliata del Prodromus, priva di illustrazioni, contenente tutti i nuovi generi e le specie relative. Il nuovo contesto delle guerre con la Francia rivoluzionaria e napoleonica rese impossibile la pubblicazione di altri volumi della costosissima Flora peruviana, anche se i due autori riuscirono a preparare i manoscritti di ulteriori due volumi. Nel 1816 morì Ruiz (una sintesi della sua vita nella sezione biografie) e Pavón cercò di continuare da solo il lavoro comune; mentre il suo compagno non aveva problemi finanziari, avendo ereditato una farmacia da uno zio, egli doveva mantenersi solo con lo stipendio di botanico, che negli anni dell'occupazione francese venne a mancare. Per cercare di salvare il salvabile, fu così costretto a vendere a diversi collezionisti buona parte della sua biblioteca e molti esemplari di erbario (raccolti durante la spedizione o inviati da Tafalla o anche altri botanici); il lotto più cospicuo se lo aggiudicò Aylmer Bourke Lambert, cui tra il 1817 e il 1824 vendette oltre 15.000 campioni d'erbario, oggi custoditi al British Museum di Londra. Uno scempio che i botanici più giovani non perdonarono a Pavón; sempre più isolato, morì nel 1840; anche per la sua vita si rimanda alla sezione biografie. Il contributo della Spedizione botanica nel Vicereame del Perù alla conoscenze della flora sudamericana fu immenso: migliaia di essiccata, senza contare i semi e le piante vive inviati all'orto botanico di Madrid per essere moltiplicati e coltivati, 2000 disegni, circa 3000 specie, di cui non meno di 500 inedite e 140 nuovi generi. Va anche sottolineato che, essendo Ruiz e Pavón molto prudenti nella istituzione di questi ultimi, un'alta percentuale dei generi da loro creati è ancora oggi valida. Tra i più noti, vorrei citare almeno Aechmea, Aloysia, Bletia, Galinsoga, Guzmania, Gilia, Jovellana, Juanulloa, Lapageria, Masdevallia, Nierembergia, Peperomia, Salpiglossis.  Dediche di piante e scherzi del destino Nell'assegnare un nome ai loro nuovi generi, Ruiz e Pavon predilessero i nomi celebrativi, che utilizzarono talvolta per ingraziarsi il politico di turno (inclusi il re Carlo IV e sua moglie Maria Luisa, dedicatari di Carludovica e Aloysia, il ministro Godoy con Godoya, Napoleone con Bonapartea - oggi sinonimo di Agave - e l'imperatrice Giuseppina, con Lapageria), ma soprattutto per ricordare studiosi ed esploratori, prevalentemente ma non esclusivamente spagnoli. Ovviamente si resero omaggio l'un l'altro: Pavon ricordò il suo capo e amico con Ruizia, e Ruiz il fedele collaboratore con Pavonia; per sottolineare la loro amicizia, scelsero due arbusti della flora cilena piuttosto affini; appartenenti alla famiglia delle Monimiaceae, sono oggi entrambi sinonimi, il primo di Peumus, il secondo di Laurelia. Infatti le due dediche, pubblicate in Florae peruvianae et chilensis prodromus, erano state anticipate di qualche anno da Cavanilles, ancora prima del ritorno di Ruiz e Pavón dall'America. Per un caso singolare, i suoi Ruizia e Pavonia oggi appartengono alla stessa famiglia, le Malvaceae, insieme a Dombeya, il genere che, per non fare torto a nessuno, l'illustre botanico volle dedicare a Joseph Dombey. Visti i rapporti piuttosto elettrici di Ruiz con Dombey e con lo stesso Cavanilles (reo di aver pubblicato alcune piante peruviane senza il suo assenso), a posteriori questa dedica ecumenica appare piuttosto ironica, come lo sono la grandezza e l'importanza rispettiva dei tre generi: a Ruiz, il capo della spedizione e dell'Oficina de la Flora Peruviana y Chilensis è toccato il monotipico Ruizia, endemico di una piccola isola; al suo "secondo" Pavón il lussureggiante Pavonia, un grande genere di oltre duecento specie; al terzo incomodo Dombey l'ancora più spettacolare Dombeya (su questo genere, ovviamente, tornerò nel post a lui dedicato). Iniziamo dunque con Ruizia; proprio come Dombeya, fino a qualche anno era assegnata alla famiglia Sterculiaceae, che è confluita in Malvaceae, sottofamiglia Dombeioideae (uno scherzo del destino?). Comprende una sola specie, Ruizia cordata, un alberello endemico dell'isola della Réunion nell'Oceano indiano, dove è nota come bois de senteur blanc, ovvero "legno profumato bianco". Allo stato selvatico, dove è presente in aree collinari aride, è ridotta a pochi individui, mentre è coltivata nei giardini e negli orti botanici. Ha un'elegante chioma arrotondata e due tipi di foglie: più piccole, molto incise e verde chiaro quelle giovanili, più grandi, argentate e grossolanamente triangolari quelle più mature. E' dioica e presenta fiori maschili o femminili in piante separate; rosa salmone, hanno cinque petali e sono riuniti in infiorescenze lungo i rami. E' considerata una pianta magica e porta fortuna, con cui si fabbricavano feticci e amuleti scaccia-malocchio. Qualche approfondimento nella scheda. Molto più di recente, un secondo piccolo genere si è aggiunto a glorificare Ruiz. Durante una delle sue compagne, egli a Pozuzo in Perù aveva raccolto un esemplare che più tardi aveva classificato e pubblicato come Guettardia ovalis. Nel 1937 il botanico svedese Robert Elias Frias studiando questa pianta concluse che doveva essere assegnata a un genere proprio, che in onore del raccoglitore battezzò Ruizodendron (famiglia Annonaceae); R. ovale ne costituisce l'unica specie. E' un albero di grandi dimensioni originario della foresta pluviale del Sud America settentrionale, dove può superare i 40 metri; ha foglie con lamina cartacea da ellittiche a ovali e fiori crema, con petali di consistenza carnosa, seguiti da frutti verdastri. Qualche informazione in più nella scheda.  Pavonia, per prolungare le fioriture Anche Pavonia è una Malvacea, ma appartiene alla sottofamiglia Malvoideae, di cui costituisce uno dei generi più variegati, ricchi di specie e di più ampia diffusione, con circa 200-250 specie delle zone tropicali e temperate calde, 100 delle quali in Sud America, 50 sia in Nord America sia in Africa, cui sia aggiungono poche specie asiatiche e australiane. Sono erbacee annuali o perenni oppure arbusti, spesso con foglie cordate alla base, e grandi fiori a coppa in genere solitari, più raramente raccolti in racemi terminali; i fiori ricordano molto da vicino quelli dell'ibisco. Molto decorative, alcune specie hanno incominciato ad essere coltivate anche da noi per l'insolito periodo di fioritura, autunnale o anche invernale. Probabilmente la più diffusa è Pavonia hastata, di origine sudamericana; è un arbusto sempreverde dal portamento ordinatamente tondeggiante con foglie ovato-cordate e copiosa fioritura; i fiori a coppa, simili a quelli dell'ibisco, sono bianchi o rosati con una vistosa macchia scura al centro e sono prodotti dalla fine dell'estate all'autunno inoltrato. In realtà, un prima fioritura avviene già in primavera, quando il cespuglio si riempie di boccioli, che però non si aprono, sebbene siano seguiti dalla produzione di semi. Si tratta del fenomeno della cleistogamia: la pianta, per superare condizioni avverse, è in grado di autofecondarsi senza subire lo stress dell'apertura dei fiori. Proviene invece dal Texas e dal Messico P. lasiopetala, un'erbacea suffruticosa che forma bassi cespugli con foglie dentate o lobate persistenti e grandi fiori a coppa rosa vivo da giugno fino alla fine dell'autunno. Entrambe le specie sono abbastanza rustiche. E' invece adatta solo ai climi caldi o alla coltivazione in interno la brasiliana P. multiflora, nota come "candela brasiliana", caratterizzata da curiosi fiori con brattee lineari rosse o rosa fucsia che circondano i petali arrotolati su se stessi e gli stami prominenti blu scuro; è un grande arbusto con foglie lanceolate lucide verde scuro, la cui fioritura si prolunga dalla primavera all'autunno; in casa e nelle giuste condizioni, può invece fiorire per tutto l'inverno. Affine è P. x gledhillii, un ibrido di origine orticola tra P. makoyana e P. multiflora, con brattee rosse. Qualche approfondimento nella scheda. Il Rancho Santa Ana Botanical Garden (RSABG) è una delle più importanti e benemerite istituzioni botaniche della California (anzi, degli interi Stati Uniti). Situato a Claremont, a est di Los Angeles, è il più ricco giardino botanico dello stato integralmente dedicato alla flora locale, con 22.000 piante native appartenenti a 2000 tra specie, ibridi e cultivar. Svolge anche una rilevante attività di ricerca e formazione, con un dipartimento di ricerca specializzato in tassonomia e botanica evolutiva; offre corsi di laurea di secondo livello e stage post laurea, in collaborazione con l'università Pomona di Claremont. Pubblica una rivista e altre pubblicazioni scientifiche. Custodisce una biblioteca specializzata, un archivio di 23.000 documenti (incluse fotografie e illustrazioni botaniche originali), un erbario di 1.200.000 esemplari che comprende tutte le specie della area floristica californiana; promuove la conservazione della flora della California meridionale attraverso una banca dei semi, la salvaguardia, la riproduzione e la diffusione delle sue specie; in campo orticolo, è attivamente impegnato nel produrre e testare nuove cultivar. Organizza innumerevoli attività per le scuole e le comunità locali. Tutto questo è nato dal sogno di una donna tenace e volitiva, Susanna Bixby Bryant, circa 90 anni fa quando solo pochi pionieri si rendevano conto di quanto fosse importante la conservazione delle flore locali. Grazie a uno dei ricercatori che lavorano nel RSABG, da qualche anno a ricordarla contribuisce anche il genere Bryantiella (Polemoniaceae).  Il sogno di una donna di carattere Con circa 6000 specie, un terzo delle quali endemiche, la California è lo stato con la flora più ricca degli Stati Uniti. Ma già all'inizio del '900, dopo che la Febbre dell'oro vi ebbe riversato migliaia di uomini in cerca di fortuna, quel tesoro naturale incominciava ad apparire in preoccupante e veloce declino per la pressione delle coltivazioni e dell'urbanizzazione e l'invasione di piante aliene. Tra i primi a rendersene conto, Theodore Payne (1872-1963), giardiniere e vivaista inglese trapiantato in California, dove si era innamorato della peculiare e variegata flora della patria d'adozione. Cominciò così a raccogliere bulbi e semi in natura e a moltiplicarli nel suo vivaio di Los Angeles, specializzandosi nella coltivazione di piante locali. Nel 1915 la città di Los Angeles gli affidò la sistemazione di un'area di 20.000 metri quadri nell'Exibition Park, nel quartiere centrale della città; Payne usò esclusivamente piante native, piantandone 262 diverse specie. Fu probabilmente questa realizzazione di Payne ad ispirare a Susanna Bixby Bryant, una dama dell'alta società californiana, il progetto che avrebbe portato alla nascita di Rancho Santa Ana Botanical Garden. La giovane donna era nata in una famiglia di ricchissimi latifondisti, proprietari di immensi ranch gestiti con modalità industriale, ed aveva trascorso la prima infanzia in una delle proprietà dei Bixby, Rancho Los Alamitos, dove grazie al padre, un imprenditore dalle idee innovative, aveva sviluppato un forte legame con la natura di quei luoghi così particolari, tra mare, colline e deserto. Rimasta presto orfana, fu inviata in un ottimo collegio di Boston dove ricette un'educazione formale insolita per le ragazze dell'epoca, quindi viaggiò a lungo con la madre in Europa e altrove. Al suo ritorno in California, nel 1904, si sposò con Ernest Albert Bryant, il medico personale del magnate delle ferrovie Henry Hungtington (che proprio in quegli anni stava facendo costruire un giardino botanico ricco di essenze esotiche a San Marino, oggi una delle maggiori attrazione dell'area di Los Angeles). Nel 1906, quando la madre morì, Susanna si trovò comproprietaria, con il fratello, di due vaste proprietà, Rancho Los Alamitos e Rancho Santa Ana; decise che ne aveva abbastanza di dividere le sue giornate tra tè, ricevimenti e riunioni di comitati di beneficenza, e, prima donna a farlo, incominciò a gestire di persona l'azienda, dove piantò aranci, noci, peri, melograni e sperimentò nuove introduzioni come pompelmi e litchi. Da tempo desiderava fare qualcosa per onorare la memoria del padre, che aveva perso quando aveva solo sette anni ma non aveva mai dimenticato. Il giardino californiano creato da Payne all'Exibition Park le diede l'idea che cercava: avrebbe trasformato una parte del Rancho Santa Ana (di cui nel frattempo aveva acquisito l'intera proprietà) in un orto botanico interamente dedicato alla flora californiana e l'avrebbe intitolato alla memoria del padre John William Bixby. Non si sarebbe trattato di un giardino privato di piacere; Susanna lo concepì fin da subito come un'istituzione pubblica, con compiti di conservazione, ricerca ed educazione. Per definire il progetto, si avvalse della consulenza di vari esperti, in particolare lo stesso Payne e il professor Willis Linn Jepson dell'Università di California, autore di una flora californiana di riferimento. Il progetto incominciò a prendere corpo nel 1926. All'interno del Rancho Santa Ana, la signora Bryant scelse un terreno singolarmente adatto per riprodurre, sebbene in miniatura, i diversi habitat della California: esteso su circa 160 acri sulle colline lungo il fiume Santa Ana tra 130 e 340 m. sul livello del mare, presentava una grande varietà di suoli e esposizioni, dal pieno sole all'ombra profonda; al momento, era uno spazio nudo, quasi privo di alberi. Prima di iniziare i lavori, ella volle comunque ancora sentire il parere del patriarca della botanica americana, Charles Sprague Sargent, il direttore dell'Arnold Arboretum di Boston. La risposta del burbero botanico fu deludente: a suo parere, riprodurre i vari ambienti della regione e piantare ogni tipo di pianta era assolutamente sconsigliabile; sarebbe stato meglio limitare lo spazio destinato all'arboreto e accontentarsi di una selezione di specie capaci di vivere senza irrigazione, che una volta cresciute avrebbero potuto fare da sé. La signora Bryant non si lasciò scoraggiare e replicò con un pizzico di ironia: "In maniera squisitamente femminile, ho deciso di correre il rischio e intendo procedere con il mio progetto iniziale". Accettò tuttavia il secondo consiglio di Sargent: affidare la progettazione a Ernest Braunton, architetto del paesaggio dell'Università della California meridionale. I lavori iniziarono nel 1927; i primi sette anni vanno considerati sperimentali: furono occupati nella costruzione di una serra, della direzione e degli altri edifici necessari, nella messa a dimora delle piante, inizialmente procurate da Payne, ma poi raccolte dal piccolo staff del giardino (di cui fin dall'inizio fece parte un botanico) in spedizioni in natura, e soprattutto nella verifica della fattibilità del progetto. Nel 1934 Susanna e i suoi collaboratori decisero che la prova era superata ed era ora di trasformare il giardino in un'istituzione formale. Con la stesura dello statuto, la creazione di una fondazione, la nomina di un consiglio d'amministrazione (Trustee), il conferimento di un capitale sociale (grazie a una donazione della signora Bryant) nacque così ufficialmente il Rancho Santa Ana Botanical Garden (RSABG). Negli anni successivi l'orto botanico continuò a crescere, con la creazione di alcuni "giardini speciali": quello dei cactus, quello delle succulente (dedicato in particolare ai generi Sedum e Dudleya), la collezione dei Penstemon, il giardino dei bulbi, quello delle piante acquatiche e di palude, il felceto, il prato naturale di fiori selvatici (con piante della prateria come Clarkia, Gilia, Phacelia). Parallelamente si sviluppò l'attività di ricerca e formazione, in collaborazione sempre più stretta con Pomona University di Claremont, grazie all'arrivo a Santa Ana in qualità di botanico di Philip Munz, grande esperto di flora dei deserti, che insegnava botanica in quella Università. Furono creati un erbario e una biblioteca; vennero organizzate mostre, conferenze, visite guidate; nel 1948 incominciò anche la pubblicazione di una rivista semestrale, Aliso (dal nome locale del platano della California o sicomoro, Platanus racemosa), che poi si sarebbe specializzata in tassonomia e botanica evolutiva. In quel momento, già da due anni la signora Bryant non c'era più: era infatti morta all'improvviso nel 1946; una sintesi della sua vita nella sezione biografie. 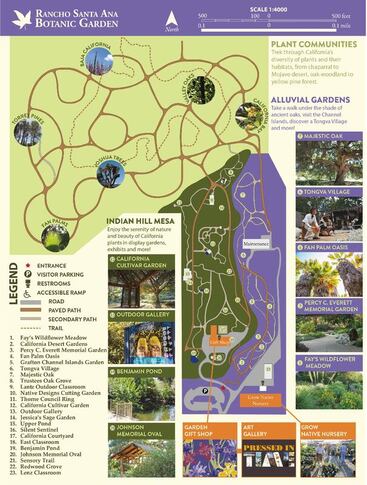 Una grande istituzione botanica Al momento della scomparsa di Susanna Bixby Bryant, l'istituzione nata dal suo sogno e dalla sua determinazione era ormai in grado di reggersi sulle sue gambe. Da tempo la signora Bryant e i suoi collaboratori pensavano che la collocazione del giardino, pur eccellente sotto molti punti di vista e così colma di significato simbolico e affettivo, fosse però troppo periferica per permettere la frequentazione continuativa degli studenti e dei dottorandi di Claremont. Fu così che, senza tradire la volontà della fondatrice, nel 1950 il giardino venne trasferito nell'attuale sede, ai piedi della collina San Gabriel a Claremont; invariati rimanevano gli obiettivi: in primo luogo, la conservazione della flora della California attraverso lo sviluppo delle collezioni vive del giardino botanico; il suo studio attraverso la ricerca sul campo, i laboratori, la collaborazione con l'Università; la divulgazione della conoscenza delle piante native e la loro diffusione in giardini pubblici e privati. Oggi il RSABG è una grande istituzione scientifica, retta da un nutrito staff professionale ma anche dall'entusiasmo di centinaia di volontari; è aperta alle scuole e al territorio, ospita stages di formazione e i corsi di dottorato in botanica dell'Università di Claremont; ha un dipartimento di ricerca specializzato in sistematica e botanica evolutiva; si è dotato di una banca dei semi e partecipa attivamente ai progetti di reintroduzione con semenzali prodotti e testati nei propri vivai. Per altre informazioni sulle collezioni, i progetti scientifici, i progetti di ricerca, le attività divulgative e didattiche si rimanda al sito del RSABG. Su un'estensione di 86 acri (35 ha), il giardino ospita oltre 20.000 piante native, appartenenti a circa 2000 tra specie, ibridi e cultivar. Si incontrano le prime già a far ombra al parcheggio; tra di loro due esemplari di Juglans californica, il noce della California. Subito dopo l'ingresso, si trova il negozio del vivaio, dove il visitatore può trovare in vendita le piante native e le cultivar sviluppate nel giardino: sono oltre 75, e tra di esse si annoverano numerosi Arctostaphylos, Ceanothus, Fremontodendron, Heuchera. Subito dopo, si passa in mezzo a un prato naturale, Fay's Wildflower Meadows, un tappeto fiorito ricchissimo di specie sempre mutevole nel corso delle stagioni, con il massimo di fulgore tra metà inverno e inizio dell'estate; tra gli altri, ad attirare visitatori, farfalle e colibrì, Eschscholzia californica, Lupinus albifrons e Calochortus clavitus. La visita può proseguire lungo il sentiero facilitato che conduce alla parte bassa o arrampicarsi immediatamente sulla Indian Hill Mesa. Il giardino è infatti diviso in tre settori principali: in basso, l'East Alluvional Garden e le Plant Communities, in alto, con un dislivello di una dozzina di metri, appunto la Indian Hill Mesa, una tipica formazione rocciosa con fianchi scoscesi e cima pianeggiante. L'East Alluvional Garden ospita le piante di vari habitat: le succulente del non lontano deserto di Mojave nel California Desert Garden, le specie costiere nel Costal Dune Garden, la peculiare flora delle isole nel Grafton Channel Island Garden. Di grande impatto la Palm oasis, che riproduce una oasi del Colorado Desert, dominata dall'unica palma nativa, Washingtonia filifera, di cui si possono ammirare esemplari che superano i 20 metri, con le foglie secche lasciate al loro posto, come in natura, a fare da gonnellino e a proteggere dall'arsura. Al limitare di questo settore, si incontra il patriarca del giardino, il Majestic Oak, un esemplare di Quercus agrifolia la cui età stimata è di 250 anni. Su un'area di circa 55 acri si estende il settore più selvaggio del giardino, le Plant Communities, in cui le piante sono lasciate il più possibile allo stato di natura. Qui il momento migliore è l'inverno, dopo che le piogge autunnali hanno risvegliato le piante assopite dai calori estivi. Tra le varie comunità rappresentate, i chaparral della California meridionale e settentrionale, il bosco pedemontano umido, i boschetti di ginepri della California settentrionale nonché comunità specifiche dominate rispettivamente dai pini di Torrey (Pinus torreyana), dai Joshua Trees (Yucca brevifolia), dai ginepri (Juniperus occidentalis). E' un'area ricca di esemplari notevoli, come un altissimo Boojum tree (Fouquieria columnaris), un enorme Big Berry Manzanita (Arctostaphylos glauca), gli spinosi Crucifixion Thorn (Canotia holacantha), le dorate fioriture di Parkinsonia florida e Fremontodendron californicum, le macchie rosa di Chilopsis linearis. La Indian Hill Mesa è il cuore del giardino, di cui ospita anche la direzione, le strutture didattiche e i vivai; vi si trovano un padiglione delle farfalle, il Giardino delle cultivar, un piccolo stagno ombroso dove nuotano le tartarughe, e naturalmente una distesa di arbusti e alberi, tra cui non possono mancare i giganti della California, Sequoia sempervirens e Sequoiadendron giganteum. Possiamo concludere che il sogno di Susanna Bixby Bryant ha dato buoni frutti.  Bryantiella, un fiore per il più arido dei deserti Tra i numerosi botanici che lavorano al RSABG come ricercatori, c'è anche J. Mark Porter, attualmente professore associato di botanica all'Università di Claremont, uno specialista di sistematica e botanica evolutiva. I suoi studi più noti riguardano due famiglie ben rappresentate nella flora californiana, le Cactaceae e le Polemoniaceae. Nel 2000, insieme a L.A. Johnson della Brigham University, ha pubblicato un importante studio su quest'ultima famiglia, in cui ha proposto di staccare cinque piccoli generi da Gilia Ruiz. & Pav., uno dei generi più variegati dei deserti americani. Uno ha voluto dedicarlo alla nostra Susanna, denominandolo Bryantiella. Al momento della sua creazione, gli furono assegnate due specie, con un areale disgiunto: Bryantiella palmeri, un endemismo della Baja California, e B. glutinosa, che vive in diversi ambienti aridi del Cile. Poiché più recentemente (2015) quest'ultima è stata trasferita nel genere Dayia, oggi Bryantiella è un genere monotipico, rappresentata dalla sola B. palmeri. E' un'erbacea che può comportarsi come annuale o perenne, in base al regime delle piogge; ha foglie lineari intere o pennatosette, fusticini sottili, fiori solitari a coppa con cinque lobi bianchi o rosa-violaceo. All'apparenza fragile, si è adattata a uno deserti più aridi del Nord America, il San Felipe Desert in Baja California. Un breve profilo nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed