|
Tra le piante più venerabili del Jardin des plantes di Parigi, c'è un albero di pistacchio famoso non solo per la sua età (un po' più tre secoli) ma per aver permesso a Sébastien Vaillant di comprendere i meccanismi della riproduzione sessuale delle piante. Quando egli presentò i risultati in pubblico, le sue parole destarono scandalo, forse anche perché non risparmiò le metafore antropomorfe. Linneo ne aveva invece grande stima e considerava il suo Botanicon parisiense il vero inizio della botanica moderna. Riprendendo una denominazione di Tournefort, lo celebrò con Valantia, un piccolo genere che annovera anche due rari endemismi siciliani.  Scandalose nozze delle piante Il 10 giugno 1717, tra gli studenti che affollavano l'anfiteatro del Jardin royal c'era una certa attesa per la prolusione con la quale Sébastien Vaillant (1669-1722) avrebbe inaugurato il corso di botanica. Vaillant, che lavorava nel giardino già da una quindicina di anni e da una decina era sotto dimostratore (l'insegnante "pratico" che mostrava come riconoscere le piante) non era certo una faccia nuova. Ma quell'anno avrebbe tenuto anche il corso teorico, come supplente del professore titolare, il dimostratore Antoine de Jussieu, in missione botanica nella penisola iberica. Forse in quel che successe quel giorno c'entrò anche un pizzico di spirito di rivalsa. Al contrario di Jussieu, medico e accademico di Francia, Vaillant aveva fatto la gavetta e non aveva titoli accademici. Nato in una famiglia contadina, inizialmente aveva ricevuto una formazione come musicista; poi era divenuto chirurgo (ricordo che all'epoca i chirurghi non erano laureati, ma artigiani che imparavano il mestiere con l'apprendistato), lavorando prima nell'esercito poi all'Hôtel-Dieu di Parigi. Incominciò così a seguire i corsi di botanica, chimica, anatomia del Jardin royal. Appassionato raccoglitore, fu d'aiuto a Tournefort per la sua flora dei dintorni di Parigi Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris. Fu notato da Fagon che ne fece il suo segretario. Nel 1702 gli fece ottenere il brevetto di «inserviente del laboratorio del Giardino reale», un titolo modesto che ne faceva il responsabile delle coltivazioni. Nel 1708, gli cedette il suo posto di sotto dimostratore di botanica, mentre a Tournefort, morto quell’anno, succedeva come professore il medico Antoine-Tristan Danty d’Isnard. Dopo appena un anno, quest’ultimo diede le dimissioni; Vaillant, che dal 1709 era stato nominato anche direttore del Gabinetto reale delle droghe, sarebbe stato il più qualificato ad assumere la cattedra, ma non era né medico né laureato. Così il posto andò a un outsider, il medico lionese Antoine de Jussieu che aveva solo ventiquattro anni, diciassette meno di lui. Tra i due c'era anche una certa rivalità scientifica: Jussieu era uno stretto seguace di Tournefort, mentre Vaillant aveva espresso da tempo riserve su Institutiones rei herbriae e conduceva ricerche sperimentali che lo stavano portando su strade nuove. E qui entra in scena il famoso pistacchio (Pistacia vera). Era nato nei primi anni del secolo dai semi portati dal Levante da Tournefort, prosperava, fioriva, ma non portava frutti. Vaillant venne a sapere che anche nel Giardino dei farmacisti ce n'era uno, con fiori diversi, che ugualmente fioriva senza fruttificare. Nel 1716 tagliò una fronda fiorita del pistacchio del Jardin e la scosse presso l’altro albero e viceversa. Poco tempo dopo l'albero del Giardino dei farmacisti (un esemplare femminile), così fecondato, diede i primi frutti, cosa che non fece quello del Jardin des plantes, maschio. Era la prova che serviva a Vaillant per spiegare la funzione del polline. Così decise di inaugurare il corso di botanica del 1717 con una prolusione dedicata alla funzione sessuale dei fiori. Che le piante avessero organi sessuali e che una pianta potesse portare solo fiori maschili, solo fiori femminili, oppure fiori sia femminili sia maschili non era un’idea nuova. All'inizio del Seicento, era stata suggerita da Prospero Alpini; nel 1681 Nehemiah Grew ipotizzò che gli stami fossero gli organi maschili e in Historia plantarum (1686) Ray portò numerosi esempi di piante dioiche; nel 1694 il tedesco Rudolph Camerarius in De sexu plantarum epistola diede la dimostrazione sperimentale della funzione del polline. Tuttavia, oltre ad essere ancora inaccettabile per l’opinione pubblica, la sessualità delle piante era stata respinta proprio dal maestro di Vaillant, Joseph Pitton de Tournefort, che riteneva il polline un «escremento» delle piante. Vaillant, oltre tutto, entrò in campo a gamba tesa, usando metafore antropomorfe e sessualmente esplicite, con espressioni come «letto nuziale», «consumare il matrimonio», «questi focosi non sembrano che cercare altro che soddisfare i loro violenti trasporti». Gli studenti furono elettrizzati, i professori dell’Accademia delle scienze un po’ meno. A indignare era anche il fatto che Vaillant avesse osato criticare un mostro sacro come Tournefort, mostrando quella che veniva considerata vera e propria ingratitudine. L'Accademia, alla quale Vaillant era stata ammesso nel 1716 (prima del fattaccio) arrivò addirittura ad ammonirlo ufficialmente di non attaccare più il suo maestro. Nei salotti non si parlava d'altro e quando Jussieu tornò dalla Spagna, le acque erano ancora agitate. Fino a quel momento, egli aveva seguito le idee di Tournefort ma, non essendo un dogmatico, volle capire meglio. Scrisse al farmacista Joan Salvador i Riera, che lo aveva accompagnato in Spagna, di raccogliere esemplari di fiori di piante fruttifere e non fruttifere di palme da dattero, e capì che Vaillant aveva ragione. L'anno successivo, nella prolusione del 1718, abbracciò le sue tesi, anche se le espresse con un prudente linguaggio neutro e distaccato. Vaillant applicò le sue scoperte alla sua opera maggiore Botanicon parisiense, frutto di trent’anni di ricerche, in cui descrisse sistematicamente la flora di Parigi e dintorni delineando un nuovo sistema di classificazione basato sugli organi sessuali, criticò anche con asprezza il sistema di Tournefort e usò per la prima volta nel significato moderno i termini stame, ovario, ovolo. In vista della pubblicazione, fece eseguire accuratissimi disegni a Claude Aubriet, ma si trovò impossibilitato a pagarlo; tanto meno aveva i soldi per la stampa, che certo l'Accademia non avrebbe finanziato. Nel maggio 1721, si risolse a scrivere a Boerhaave, il direttore dell'orto botanico di Leida, che liquidò il debito con Aubriet e insieme a William Sherard, amico comune, curò la pubblicazione. Una prima edizione senza figure uscì nel 1723 e Vaillant, morto nel 1722, non fece in tempo a vederla. Nel 1727, sempre a Leida, seguì una seconda edizione, con trecento tavole di Aubret incise da Jan Wandelaar, che qualche anno dopo avrebbe collaborato con Linneo per Hortus Cliffortianus. Per l'Académie, Vaillant rimase un paria: contrariamente all'uso, alla sua morte non venne commissionato il consueto elogio a Fontenelle. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Endemismi siciliani Non molto tempo prima di morire, Tournefort in una Memoria letta all'Accademia delle scienze aveva dedicato all'allievo il genere Valantia: uno di quelli che lo stesso Vaillant contestava, visto che lo considerava identico a Cruciata; del resto esprimeva le sue riserve anche sull'abitudine di denominazioni ricavate dai nomi dei botanici. Linneo lo recuperò in Species plantarum. Non solo aveva grande stima di Vaillant, in cui vedeva un proprio precursore considerando Botanicon parisiense il vero inizio della botanica moderna, ma riteneva il genere particolarmente adatto. Non certo per la sua bellezza: si tratta di pianticelle minime, che passano inosservate, ma per le singolari caratteristiche dei fiori perfette per celebrare lo studioso della differenziazione sessuale. Questo piccolo genere della famiglia Rubiaceae raggruppa sette specie di minute erbe rupicole diffuse attorno al bacino del Mediterraneo, dalla Macaronesia al Vicino oriente. Hanno minuscole foglie carnose verticillate in gruppi di quattro, da cui il nome comune di «erba croce»; i fiori sono raggruppati in verticilli di tre: quello centrale è bisessuale, i due laterali maschili. Quattro specie (V. calva, V. deltoidea, V. hispida, V. muralis) fanno parte della flora italiana; V. calva è endemica dell’isola di Linosa dove cresce sulle pendici laviche del Monte Vulcano e di Montagna rossa. V. deltoidea è invece un endemismo della Rocca Busambra, il rilievo maggiore dei monti Sicani, dove vive nei pascoli aridi intorno a 1600 metri. Qualche approfondimento nella scheda.
0 Comments
Ultimo esponente di un'illustre famiglia di astronomi, Henri Cassini (ovvero Cassini V) fu costretto a rompere la tradizione, e invece che di astri si occupò di... Aster, o meglio di Asteraceae. Di questa immensa famiglia, la più estesa tra le piante da fiore, elaborò la prima classificazione, così puntuale e innovativa da gettare le basi di tutte le sistematizzazioni successive. Fu il primo a raggruppare i generi in tribù e a intuire relazioni ed affinità evolutive tra i diversi gruppi. La sua impronta è tuttora largamente presente nelle denominazioni della famiglia, con circa 130 dei generi da lui stabili tuttora validi. Tra le specie che ha descritto e denominato, molto opportunamente per un discendente di astronomi, non poteva mancare la stella alpina, Leontopodium alpinum Cass.; e non stupisce che Cassinia, il genere con cui Robert Brown volle onorarlo, appartenga alla famiglia Asteraceae. 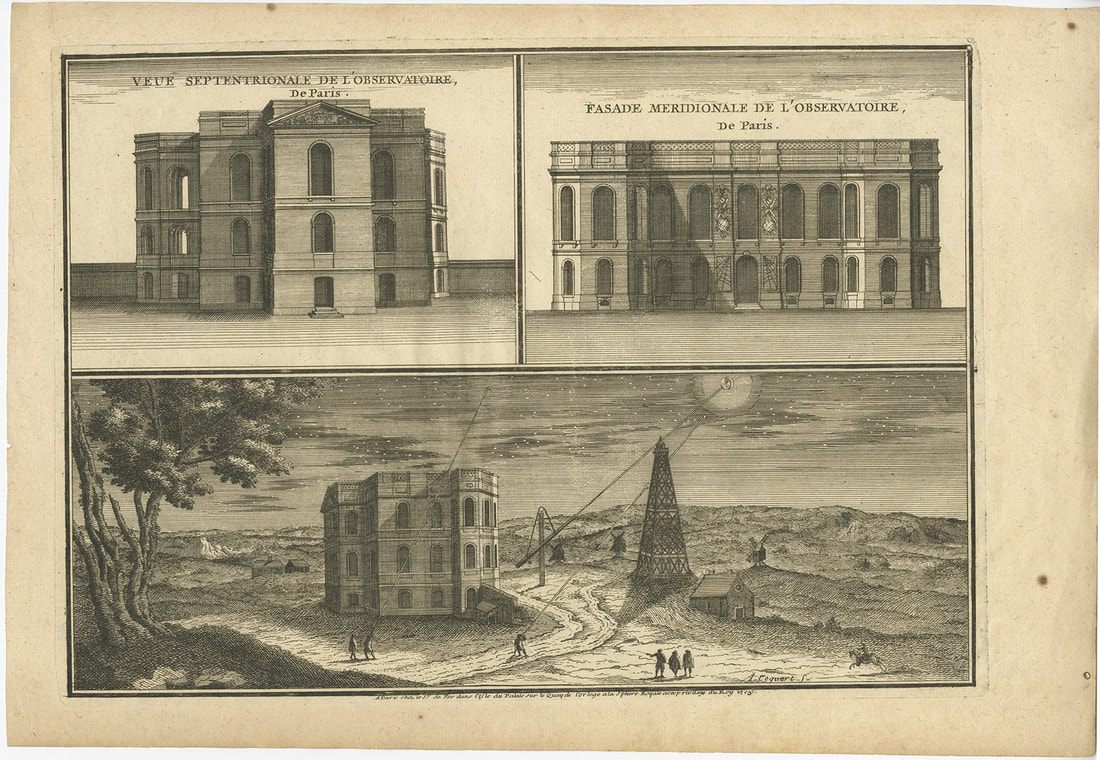 Una nascita all'Osservatorio Il 9 maggio 1781, nell'appartamento di famiglia situato al primo piano dell'Osservatorio di Parigi, viene alla luce Alexandre Gabriel Henri Cassini (d'ora in avanti, lo chiameremo semplicemente Henri, come spesso si firmava). Il suo destino sembra già tracciato: come il trisnonno Giovanni Domenico, detto Cassini I (1625-1712), il bisnonno Jacques, detto Cassini II (1677-1756) e il nonno César-François, detto Cassini III (1714-1784), studierà astronomia e a suo tempo dirigerà l'Osservatorio. Da più di un secolo i Cassini si tramandano quell'incarico di padre in figlio, e dal 1771 con Cassini III il titolo di "Direttore generale" dell'Osservatorio è diventato anche formalmente ereditario, così come il diritto di abitare in quell'appartamento. Nel 1784, Jean-Dominique, detto Cassini IV, che già da tempo affianca l'anziano padre, ne prende puntualmente il posto. Cerca di convincere il re a finanziare un rinnovamento dell'edificio e delle attrezzature ormai obsoleti e intanto completa la carta generale di Francia (la "carta di Cassini") iniziata da suo padre. Nel 1787 partecipa alle rilevazioni per stabilire la distanza esatta tra gli osservatori di Greenewich e Parigi. Al piccolo Henri incominciano ad essere impartite le prime nozioni di astronomia. Ma la storia si incarica di rimescolare le carte. Il 16 luglio 1789, due giorni dopo la presa della Bastiglia, trecento rivoluzionari irrompono nell'Osservatorio alla ricerca di viveri, armi, munizioni; non trovano nulla, ma in mancanza di meglio strappano il piombo della cupola per farne pallottole. Cassini IV è fedele alla monarchia: la sua famiglia è stata grandemente beneficiata dai Borboni, si è imparentata con la nobiltà, ed egli stesso si fregia del titolo di conte. Nel 1791 l'Accademia delle Scienze, al fine di stabilire la lunghezza corretta del metro, decide di effettuare una nuova misurazione del meridiano di Francia (la prima era stata portata a termine nel 1718 da Cassini I e Cassini II ed era stata rettificata da Cassini III nel 1740) e istituisce una commissione apposita, formata da Cassini IV, Legendre, Méchain e Borda. I quattro il 19 giugno vengono ricevuti da Luigi XVI. Il re è perplesso e chiede a Cassini: "Davvero volete misurare di nuovo il meridiano che vostro padre e vostro nonno hanno misurato prima di voi? Pensate di saperlo fare meglio?". Cassini replica: "Sire, non mi lusingo di essere migliore di loro. Ma i miei strumenti sono quindici volte meglio". Il giorno dopo il re prende la fuga, ma viene intercettato a Varennes e arrestato. La situazione precipita anche dalle parti dell'Osservatorio. Cassini IV si scontra con i suoi assistenti che lo accusano di pubblicare a suo nome i loro lavori. Nelle sue memorie, l'astronomo ne traccia un ritratto patibolare: il più vecchio, Nicolas-Antoine Nouet, è l'ex cappellano dell'osservatorio con il quale ha rotto ogni rapporto quando ha saputo che si è spretato e intende sposarsi con la sua serva; il secondo, Jean Perny, avrebbe anche talento, ma una notte è rientrato ubriaco dal suo club giacobino e ha incominciato a tempestare la sua porta con l'elsa della spada gridando "Cassini l'aristocratico a morte!"; il terzo, Alexandre Ruelle, è un disertore che egli ha accolto generosamente e adesso gli si rivolta contro. L'Assemblea nazionale vede le cose diversamente. E' ora che anche all'Osservatorio il monarca Cassini ceda il posto alla repubblica: dovrà dividere le responsabilità alla pari con i suoi tre assistenti, e ciascuno di loro sarà direttore a turno, per un anno; la sua paga sarà dimezzata. Cassini IV dà immediatamente le dimissioni; l'Assemblea nazionale gli dà 24 ore di tempo per sgomberare l'appartamento dove la sua famiglia vive da 122 anni. I Cassini si trasferiscono nel loro castello di Thury. Durante il Terrore, Jean-Dominque è arrestato e rimane in carcere per otto mesi e mezzo. Il Termidoro gli salva la vita. D'ora in avanti dedicherà tutta la vita (lunghissima, visto che morirà nel 1845, a 97 anni) alla stesura di testi polemici in difesa della reputazione scientifica propria e dei suoi antenati. 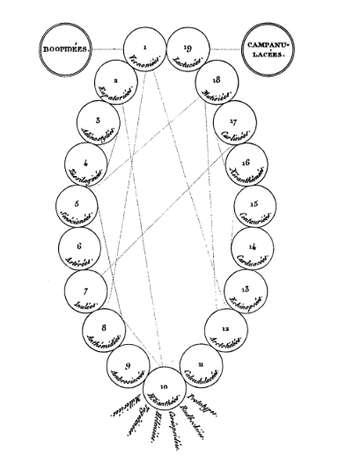 a.C. e d.C (prima e dopo Cassini) Quando viene cacciato dall'Eden dell'Osservatorio, Henri ha dodici anni. E' evidente che non sarà mai astronomo. Anzi, neppure scienziato, almeno non ufficialmente. Dopo aver completato gli studi, entra in magistratura e percorre una carriera di successo: negli anni napoleonici, è giudice del tribunale di prima istanza della Senna, di cui nel 1811 diventa vice-presidente. Con la restaurazione, diventa consigliere quindi presidente della Corte Reale di Parigi (l'equivalente della corte d'appello) e consigliere della corte di Cassazione. Nel 1831 Luigi Filippo lo nomina pari di Francia. L'anno dopo, a soli cinquant'anni, Cassini V muore di colera, ultimo membro della famiglia. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Eppure anche il nostro Henri Cassini raccoglie, in altro modo, l'eredità scientifica dei suoi avi. Non misura meridiani, non disegna carte, non osserva gli astri con il telescopio; ma nel suo tempo libero studia appassionatamente, disseziona, osserva al microscopio le sue piante preferite: le Asteraceae (il nome prevalente ai suoi tempi era Compositae, ma lui amava chiamarle Synantherées, ovvero "piante con stami caratterizzati da antere fuse in unico corpo"). A chi gli chiedeva perché le avesse scelte, rispondeva che la dissezione di una margherita richiede poca empatia. Oltre a studiarle, le coltivava nel giardino di Thury, facendo anche esperimenti di introduzione soprattutto di specie americane . I suoi studi su questa famiglia (la più vasta delle Fanerogame, con forse 32.000 specie e 1900 generi) sono così importanti che qualcuno ne ha diviso la storia in due ere: prima e dopo Cassini. Anzi è considerato il vero fondatore di questo ramo della botanica, che grazie a lui si chiama sinanterologia. Tra il 1812 e il 1831, Cassini V pubblicò circa 65 articoli, in cui propose la prima divisione delle Asteraceae in tribù, sezioni e sottosezioni. Il suo sistema, pur con aggiustamenti dei tassonomisti successivi, ha gettato le base della classificazione della famiglia fino a tempi molto recenti; anzi si può dire che perdura in altra forma anche oggi, quando le relazioni tra le tribù (molte delle quali coincidono con quelle riconosciute da Cassini) sono studiate sulla base di dati molecolari. Henri Cassini non scriveva in latino, ma in francese e pubblicò buona parte dei suoi articoli nel Dictionnaire des Sciences Naturelles di Cuvier tra il 1816 e il 1830; contemporaneamente articoli sugli stessi taxa uscivano in riviste come il Bulletin des Sciences della Société Philomatique de Paris, il Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts et Métiers, Annales des Sciences naturelles, a volte con sovrapposizioni che creano qualche confusione. Il suo intento era stabilire una classificazione naturale delle Asteraceae, secondo la tradizione della scuola tassonomica francese; si basò dunque sull'osservazione minuziosa, sull'analisi sistematica e sul confronto tra il maggior numero possibile di caratteristiche morfologiche, che includono l'ovario, lo stilo, gli stami, la corolla staminata, il capolino, il ricettacolo, le brattee, il portamento, lo scapo, le foglie, il colore delle corolle, senza lasciarsi sfuggire neppure gli elementi più minuti. Il suo sistema, esposto nel 1816 e poi via via perfezionato, suddivide la famiglia in 19 tribù. Originale e suggestivo è anche il metodo di cui si servì per presentare quelle che chiama le "affinità" tra di esse: un diagramma in cui ciascuna tribù, posta in un cerchio, si sistema lungo un'ellisse, accanto alle tribù più vicine. Le Heliantheae, le Asteraceae più tipiche con capolini completi di flosculi ligulati e flosculi del raggio, stanno in basso al centro, le Eupatorieae e le Veronieae con capolini solo discoidi occupano il vertice sinistro, in contrapposizione a Mutisieae e Lactucaceae (= Cichorieae) con capolini solo ligulati posti al vertice destro. Linee continue e tratteggiate suggeriscono altri legami possibili E' stato ipotizzato che il concetto di "affinità" sia stato influenzato dalle teorie evoluzioniste di Lamarck (Philosophie zoologique uscì nel 1809); ma forse per Cassini sarebbe stato poco diplomatico parlare apertamente di evoluzione, dato che, come abbiamo visto, i suoi lavori furono pubblicati per lo più sull'Enciclopedia di Cuvier, che di quelle posizioni fu acerrimo avversario. Cassini fu anche un prolifico creatore di generi: ne descrisse e stabilì 391; molti sono oggi ridotti a sinonimi, ma è significativo della alta qualità del suo lavoro che circa 130 siano ancora accettati, ovvero circa l'8% delle denominazioni della famiglia. Tra di essi, per citare solo alcuni dei più noti, Brachyscome, Callistephus, Eurybia, Euryops, Felicia, Glebionis, Gynura, Kalimeris, Leontopodium, Ligularia, Pallenis. Ed è simpatico pensare che la stella alpina debba il suo nome botanico Leontopodium alpinum a questo discendente di astronomi.  Omaggi coniugali Nel 1812 Henri Cassini si sposò con Catherine Elisabeth Agathe de Riencourt, che era anche sua cugina, essendo figlia di Louis Henri de Riencourt e Françoise Elisabeth Cassini, sorella di suo padre. La coppia non ebbe figli. Non sappiamo quasi nulla di Mme la contesse Cassini. Intorno al 1839, il suo nome appare tra i sottoscrittori di una raccolta fondi a favore dell'Abbaye du Gard. Probabilmente viveva a Parigi, dove morì nel 1861, quasi trent'anni dopo il marito. Grazie all'affetto di Henri, anche lei è entrata a fare parte dei dedicatari di generi celebrativi, ben due volte. Nel 1816 il marito le dedicò Agathaea, sulla base di A. coelestis, una bellissima margherita sudafricana dalle corolle azzurre. Oggi non si chiama più così perché il genere è confluito in Felicia, un'altra creatura di Cassini, ma il nome persiste non solo in vecchie pubblicazioni e abbastanza spesso come nome commerciale, ma anche nel nome comune agatea (spesso scritto così) di quella che ora si chiama Felicia amelloides. Nel 1818 Cassini replicò con Riencourtia, ricavato dal cognome della moglie. Questo piccolo genere sudamericano, con cinque specie diffuse nelle savane da Panama al Brasile settentrionale, non ha i pregi estetici di Agathaea-Felicia. Si tratta infatti di modeste erbacee annuali o perenni con esili fusticini alquanto ramificati, foglie più o meno da ovate a lanceolate, e minuscoli capolini bianchi o lilla con pochi fiori tubolosi e un unico fiore fertile. Una sintesi delle poche informazioni disponibili in rete e un elenco delle specie nella scheda.  Cassinia, arbusti australiani E' invece un grande genere di notevole impatto estetico quello che onora lo stesso Henri Cassini: Cassinia, omaggio di Robert Brown. Inutile dire che anche queste piante sono Asteraceae, diffuse prevalentemente nell'Australia sud-orientale, ma anche nelle isole Norfolk e in Nuova Zelanda. Il genere comprende più di quaranta specie. Sono grandi arbusti legnosi o piccoli alberi, di portamento prostrato o eretto, con foglie dai margini ricurvi o arrotolati e vistose infiorescenze corimbose, piramidali o raccolte in grappoli compatti. Visti da vicino, i piccoli fiori ricordano un po' quelli dei nostri Gnaphalium (e infatti Cassinia appartiene alla tribù Gnaphalieae), per l'involucro con numerose brattee cartacee. Il colore va dal bianco al cinerino al giallo oro. Una delle specie più diffuse è C. aculeata, nota infatti come "common Cassinia", un grande e folto arbusto con foglie lunghe e strette quasi arrotolate su se stesse e fitte infiorescenze terminali bianco crema. C. arcuata, caratterizzata da rami sottili e arcuati, ha dimensioni minori, foglie aromatiche molto minute e ciuffi di piccoli fiori biancastri che durano mesi, per poi essere sostituiti dai frutti, di aspetto non dissimile. Poiché ciascuna pianta produce migliaia di semi, è invasiva, ma è anche una specie pioniera che è stata utilizzata per il recupero di aree disturbate. Ha invece fiori dorati C. cunninghamii, un piccolo arbusto con fusti e foglie tomentose. E' stata invece recentemente trasferita a Ozothamnus C. leptophylla, oggi Ozothamnus leptophyllus. Qualche approfondimento nella scheda. La pubblicazione di The Cactaceae dei botanici statunitensi Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose segna una pietra miliare nella classificazione dei cactus e ne rivoluziona la tassonomia. I quattro volumi, editi tra il 1919 e il 1923 dalla Carnegie Institution for Science, sono anche una sontuosa opera d'arte, grazie ai disegni in bianco e nero e alle tavole a colori, di impressionante precisione, della pittrice britannica Mary Emily Eaton e delle sue collaboratrici; centinaia di fotografie in bianco e nero ne arricchiscono l'apparato iconografico. Anche se da allora le Cactaceae hanno subito numerose revisioni, almeno 50 dei 79 generi stabiliti da Britton e Rose rimangono validi, e i volumi di The Cactaceae sono ricercati da ogni cactofilo. L'opera nasce dalla stretta collaborazione tra Nathaniel Britton, all'epoca direttore del New York Botanical Garden, e Joseph Nelson Rose, un grande e metodico tassonomista al cui il destino ha riservato il ruolo dell'eterno secondo. A ricordarlo i generi Rhodosciadium (Apiaceae) e Roseodendron (Bignoniaceae). 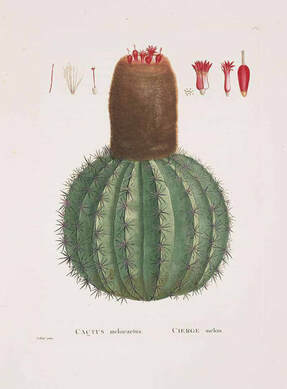 Una classificazione spinosa Come ben sanno gli appassionati di cactus, abituati a fare i conti con continue revisioni e cambi di nome, la classificazione delle Cactaceae è una faccenda spinosa; a ciò contribuiscono diversi fattori: citiamo soltanto la grande variabilità morfologica che spesso rende difficile distinguere specie da specie, specie da sottospecie, specie da varietà; l'alto grado di convergenza evolutiva di queste piante di habitat estremi che fa sì che piante lontane dal punto di vista genetico tendano ad assomigliarsi perché devono affrontare le stesse condizioni ambientali; la difficoltà di raccogliere, seccare e preservare esemplari d'erbario di queste piante spinose, con forme arrotondate e tessuti succulenti. Con la sola eccezione di Rhipsalis baccifera, si tratta di una famiglia esclusivamente americana, in cui gli europei si sono imbattuti con le scoperte geografiche. Probabilmente la prima specie ad arrivare in Europa, forse già con i viaggi di Colombo, fu il fico d'India (qui le Indie sono quelle occidentali) Opuntia ficus-indiae, ma la prima ad essere attestata è un Melocactus "cactus a melone" noto a Londra intorno al 1570. Qualche anno dopo nell'erbario di Tabaernemontanus vengono descritti sia cactus globosi, sia cactus colonnari, che il botanico tedesco chiama Cereus, ovvero "cero, candela". A cavallo tra Cinquecento e Seicento diverse specie sono descritte da altri botanici, come Clusius, L'Obel e Gerard. Pitton de Tournefort pubblica Melocactus e Opuntia, mentre Plumier riporta dai suoi viaggi nelle Antille Pereskia. Questa è la situazione prima di Linneo che nel 1753, in Species Plantarum, descrive 22 specie ma sorprendentemente le raggruppa nell'unico genere Cactus, nome che ricava dal gr. kaktos, una pianta spinosa di Teofrasto non meglio identificata. Più analitico di lui Philip Miller che nella quarta edizione di The Gardener's Dictionary (1754) descrive quattro generi: Cactus, Cereus, Opuntia e Pereskia. Tuttavia, nella nona edizione (1787) farà marcia indietro e si adeguerà alla posizione di Linneo. Poco dopo, nel 1789, Antoine Laurent de Jussieu crea la famiglia Cactaceae. A rimescolare le carte è Haworth che nel 1812 dichiara il genere linneano Cactus inutilizzabile, riservandolo al solo Cactus melocactus L., e lo smembra in Cactus, Cereus, Epiphyllum, Mammillaria, Opuntia, Pereskia e Rhipsalis (creato da Gaertner nel 1788). Nel terzo volume del Prodromus (1828) de Candolle opta per la prudenza, descrivendo sette generi e 174 specie, suddivisi nei grandi gruppi di cactus epifiti e cactus non epifiti. Il grande collezionista principe di Salm-Dyck, che nel suo castello nei pressi di Düsseldorf possedeva la più importante collezione di Cactaceae dell'epoca, in Cacteae in Horto Dyckensi Cultae (1850) pubblica 20 generi, dividendo la famiglia in due gruppi: Cacteae Rotatae, con fiori a disco, e Cacteae Tubulosae, con fiori tubolari. Nel corso del secolo, mano a mano che gli ambienti aridi del Nuovo mondo vengono esplorati e sempre nuove specie vengono scoperte e inviate ai giardini botanici ma anche ai vivai europei, si aggiunge una grande quantità di specie che i botanici tendono a riunire in pochi grandi generi. Nel 1891 nella sua revisione di Genera Plantarum, Otto Kuntze torna addirittura all'antico, ovvero a Linneo, riconoscendo solo tre generi: i piccoli Pereskia e Pterocactus e un super genere Cactus con oltre 1000 specie. La sistematizzazione più influente a cavallo tra i due secoli è tuttavia la monumentale Gesamtbeschreibung der Kakteen, "Descrizione generale dei cactus", di Karl Moritz Schumann, in tredici volumi pubblicati tra il 1897 e il 1898, con un appendice nel 1903. Rifacendosi soprattutto a Salm-Dick, egli accetta 21 generi e 640 specie. Divide poi la famiglia in tre tribù: Rhipsaloideae, Mammillarieae, Echinocactaceae. Una posizione in parte più aperta è quella di Alwin Berger, curatore dei giardini Hambury, che accetta 41 generi e propone di dividere il vasto genere Cereus in 5 1sottogeneri. E' questa la situazione quando entrano in scena i nostri protagonisti, Nathaniel Lord Britton e Joseph Nelson Rose. 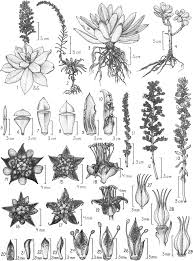 Un botanico taciturno, eterno secondo Britton e Rose incominciarono a studiare le Cactaceae nel 1904; entrambi conoscevano bene le flore degli Stati Uniti, dei Caraibi e del Messico e inizialmente il loro intento era pubblicare una revisione complessiva delle specie nordamericane. Solo più tardi, nel gennaio 1911, Daniel MacDougal, il direttore del Desert Laboratory di Tucson, suggerì loro di allargare le ricerche all'intera famiglia e di chiedere il sostegno finanziario della Carnegie Institution for Science. Di Britton ho già parlato in questo post; è ora di conoscere meglio Rose. Aaron M. Socha, un esperto di cactus che ha lavorato per il Giardino botanico di New York, lo ha definito "un individuo così spiccato che neppure Shakespeare avrebbe potuto renderlo universale". Era un uomo taciturno, riservato, modesto e disinteressato agli onori, ma allo stesso tempo determinato; come botanico, un ricercatore instancabile (qualcuno lo ha definito un "cavallo da tiro"), un descrittore minuzioso e un tassonomista di estremo rigore. Ripercorrendo la sua carriera, a me è sembrato un eterno secondo, un Bartali della botanica. E a Bartali assomiglia anche per la forza di volontà, la bontà d'animo, la generosità, la profonda religiosità. Nato nell'Indiana e rimasto presto orfano durante la guerra di Secessione, studiò nel piccolo college di Wabash; mentre seguiva i corsi post laurea di biologia, divenne assistente del suo professore di botanica, John Merle Coulter, che lo volle al suo fianco per studiare un'altra famiglia difficile, le Apiaceae (a quei tempi, si chiamavano ancora Umbellifere); la collaborazione tra professore e allievo iniziò con Revision of the North American Umbelliferae (1888) e, dopo una serie di articoli su vari generi, culminò con Monograph of the Umbelliferae (1900). Secondo i biografi, a fare il lavoro duro fu Rose, mentre Coulter ebbe piuttosto un ruolo di revisore. Nel frattempo, Rose si era sposato e si era trasferito a Washington per iniziare la sua carriera professionale nel Dipartimento di Agricoltura (USDA) come assistente di George Vasey, botanico capo dell'USDA e curatore dell'erbario nazionale. Rose lo affiancò nella pubblicazione delle raccolte di Edward Palmer in Messico e Centro America, con grande apprezzamento di quest'ultimo che nel 1897 lo invitò ad accompagnarlo in Messico; grazie a questa spedizione, Rose si familiarizzò con il lavoro sul campo e imparò le tecniche di raccolta e conservazione anche di piante difficili come le succulente messicane. Nel 1896 l'Erbario nazionale era passato sotto la giurisdizione dello Smithsonian, e Rose fu promosso assistente curatore di botanica, poi dal 1905 curatore associato. Fu questo il vertice della sua carriera, come notiamo anche dal ruolo di vice presidente - in armonia con il suo carattere e il suo destino - di associazioni attive nella capitale come Botanical Society, Washington Botanical Society, Washington Society, Washington Biological Society (di cui, a dire la verità, dopo essere stato il vicepresidente dal 1909 al 1917, divenne presidente nel 1918). Come assistente curatore dell'USDA, organizzò nove spedizioni in Messico e in Centro America, di cui pubblicò i risultati in Studies of Mexican and Central American Plants, 1897-1911. Intorno all'inizio del secolo, incominciò a corrispondere con Britton, cui inviò molti esemplari per il New York Botanical Garden; entrambi erano particolarmente interessati alle Crassulaecae e a partire dal 1903 incominciarono a scrivere vari articoli a quattro mani su questa famiglia, pubblicati per lo più sul Bollettino del New York Botanical Garden. I loro primi lavori comuni sulle Cacataceae risalgono al 1905. Il progetto suggerito da MacDougall fu presentato da Britton e Rose alla Carnegie all'inizio del 1911 e fu immediatamente approvato. Nel 1912 Rose prese un congedo non pagato dallo Smithsonian e fu nominato ricercatore associato della Carnegie, affiancato da due assistenti, W.R. Fitch e P.G. Russel. Britton, che continuava a dirigere l'orto botanico di New York, fu nominato ricercatore associato onorario (ovvero senza paga), mentre il suo collaboratore R.S. Williams fu incaricato di selezionare e preservare gli esemplari per le illustrazioni. 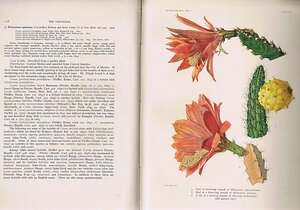 Una rivoluzione tassonomica Quando Britton e Rose incominciano il loro lavoro, la situazione è confusa al massimo grado. Nel corso di un secolo, le specie di cactus, spesso introdotte direttamente non da botanici, ma da raccoglitori di piante al servizio di collezionisti e vivai, si sono moltiplicate a dismisura; e insieme si sono moltiplicati gli errori. Un caos perfettamente descritto dai due botanici nella prefazione del I Volume di The Cactaceae: "descrizioni interpretate scorrettamente, piante identificate in modo sbagliato, errori perpetuati; così la distribuzione geografica di molte specie è stata pubblicata in modo erroneo e le conclusioni basate su dati di questo tipo risultano inaffidabili. Non solo ci sono nomi specifici attribuiti a piante cui non spettano, ma i nomi generici sono diventati interscambiabili e le leggi della priorità sono state ignorate". Quella che Britton e Rose decidono di operare è una rivoluzione; il botanico Lyman Benson ha osservato che, se gli stessi criteri fossero stati applicati a tutte le piante "almeno un milione di piante avrebbero dovuto cambiare nome". Nei quattro volumi di The Cactaceae, i 21 generi accettati da Schumann esplodono e diventano 124, mentre le specie classificate sono 1325. Insomma, per la tassonomia delle Cactaceae, dopo un secolo di prudenza e di enormi super generi, è arrivata l'ora dell'audacia e della suddivisione in molti generi più piccoli, basati sia sulle evidenze morfologiche, sia sulla distribuzione geografica. Anche se i due botanici ottimizzano il tempo, dividendosi il lavoro sia di ricerca sia di scrittura e sono affiancati da una dozzina di collaboratori, il compito è immenso e i cinque anni previsti inizialmente si dilatano a dieci. Bisogna reperire e leggere tutte le descrizioni originali e verificarle quanto più possibile sugli esemplari tipo custoditi negli erbari, quindi confrontarle con le piante vive in coltivazione e/o in natura. Senza dimenticare che il lavoro (1912-1923) verrà a cadere a cavallo della Prima Guerra Mondiale e anche il Messico si chiuderà alle ricerche a causa della rivoluzione messicana. Le Cactaceae vivono nei deserti delle Americhe, ma nell'Ottocento sono state prevalentemente studiate e classificate da studiosi europei, commercializzate da vivai europei e collezionate da collezionisti europei. Ecco perché le ricerche di Rose, già nei primi mesi del 1912, si spostano in Europa. A Londra visita gli erbari di Kew, del Natural History Museum e della Linnean Society e a Parigi l'Hérbier National. Passa poi in Italia dove visita piccole collezioni pubbliche e private di Roma, Napoli, Firenze e Venezia. La tappa principale è però la Riviera, dove Rose va a trovare Alwin Berger; i due botanici corrispondono fin dal 1905, quando Rose aveva scritto a Berger per complimentarsi per il suo studio sulle Cactaceae. E' poi la volta della Germania con gli erbari e gli orti botanici di Monaco e Berlino, la collezione privata di Leopold Quehl ad Halle, il vivaio Haage & Schmidt a Erfurt e l'orto botanico di Darmstadt. Prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, Rose fa ancora un salto ad Anversa per esaminare la collezione privata di Frans de Laet. Le spedizioni sul campo iniziano l'anno successivo. Insieme a sua moglie Elizabeth Knight Britton, all'amica Delia West Marble, membro del Botanical Club, pittrice e fotografa, e al raccoglitore dell'orto botanico di New York John Adolph Shafer, Nathaniel Britton visita le Isole vergini americane, Porto Rico e Curaçao; Rose e i suoi assistenti percorrono Saint Croix, St. Kitts, Antigua e Hispaniola. Nel 1914, mentre in Europa si accendono i fuochi di guerra, Britton torna a Porto Rico per esplorare le isole dell'arcipelago, mentre Rose, accompagnato dalla moglie Lou Beatrice Sims, parte per il suo lungo giro in Sud America. Dopo due brevi tappe in Giamaica e Panama, nel 1915 esplora le zone ricche di cactus di Perù, Bolivia centrale, Cile settentrionale e centrale; come aveva fatto in Europa, a Santiago del Cile esamina le specie tipo raccolte il secolo precedente da Rodolfo Amando Philippi e le specie rare dell'orto botanico. Passa in Brasile, dove studia soprattutto le aree di Bahia e Rio de Janeiro, quindi in Argentina, dove si concentrata sulle province di Mendoza e Cordoba. Come in Europa e in Cile, visita botanici e collezionisti da cui ottiene esemplari e informazioni di prima mano. Nel 1916 Britton è a Cuba insieme a Percy Wilson, mentre Rose e sua moglie concludono il viaggio sudamericano con Curaçao e Venezuela. Per i due botanici è arrivata l'ora del lavoro da scrivania, tanto più che la guerra ora rende difficile gli spostamenti anche in America. Nel 1918, per Rose c'è ancora un viaggio (ad accompagnarlo questa volta è suo figlio Thomas) in Ecuador. Inoltre sono stati coinvolti altri raccoglitori, come J.K. Small inviato nel 1916 in Florida alla ricerca di rare specie di Opuntia o Shafer che nell'inverno 1916-17 fa importanti raccolte in Bolivia, Argentina, Paraguay e Uruguay. Altri esemplari furono inviati da collezionisti, curatori di orti botanici e erbari, studiosi e appassionati. Il primo volume, dedicato alle tribù Pereskieae e Opuntieae, uscì infine nel 1919; il secondo, dedicato alle sottotribù Cereanae e Hylocereanae della tribù Cereae, nel 1920; il terzo, dedicato alle sottotrbù Echinocereanae, Echinocactanae e Cactanae, seguì nel 1922; il quarto, dedicato alle sottotribù Coryphanthanae, Epipyllanae y Rhipsalidanae, completò l'opera nel 1923. Nel 1922 Rose era tornato una seconda volta in Europa, per consultare nuovamente Berger, con il quale aveva continuato a corrispondere, almeno finché la guerra non lo aveva reso impossibile. Ma appena il conflitto era finito, si era affrettato a inviare dall'opulenta America un ricco pacco di cibo all'amico e alla sua famiglia, alle prese con la fame nella Germania postbellica. Pubblicati dalla Carnegie Institution of Science senza badare a spese, oltre ad essere una pietra miliare della botanica, i quattro volumi di The Cactaceae sono una raffinata opera d'arte grazie al ricchissimo apparato iconografico con tavole a colori, disegni e fotografie in bianco e nero nel corpo del testo. A dipingere tre quarti delle 800 tavole fu la pittrice inglese Mary Emily Eaton, che all'epoca lavorava per l'orto botanico di New York; per la precisione del tratto e la vivezza dei colori questa eccellente artista fu definita dai contemporanei "la più grande pittrice di piante dal vivo". A coadiuvarla, un team tutto al femminile: Deborah Griscom Passmore, Helen Adelaide Wood, Kako Morita. Britton e Rose partirono dalle revisioni di Schumann e di Berger, ma si spinsero molto più in là, creando molti generi più piccoli; oltre a correggere le denominazioni di molte specie, ne pubblicarono numerose per la prima volta. Anche se nel secolo che è intercorso da allora la storia tassonomica della Cactaceae ha continuato ad essere travagliata e molte sono state le revisioni, è significativo della qualità del loro lavoro il fatto che ben 50 dei 79 generi da loro creati continuato ad essere accettati, anche se spesso ne sono stati ridefiniti i confini. Inoltre, anche grazie alla splendida veste editoriale, The Cactaceae ebbe anche il merito di destare l'interesse del grande pubblico per una famiglia di piante che all'epoca era ancora poco di moda.  Modeste piante aromatiche e alberi d'oro Terminata l'impresa, Rose riprese il suo lavoro allo Smithsonian. Non cessò però la sua collaborazione con Britton; negli anni '20 i due botanici scrissero insieme la trattazione delle Mimosaceae e delle Caesalpinaceae per la North American Flora. Rose diede ancora prova delle sue grandi capacità di tassonomista ridefinendo il super genere Cassia, il cui status all'epoca era estremamente confuso. Egli morì nel 1928, sei anni prima dell'amico e compagno di avventura. Nella sezione biografie, una sintesi della vita di questo grande botanico, che il destino e l'ordine alfabetico collocano in seconda posizione anche come autore di The Cactaceae. Vorrei salutarlo con le parole di Alwin Berger che lo definì "uno degli uomini meno egoisti e di animo più gentile che io abbia mai incontrato". Come a Britton, anche a Rose furono dedicati numerosi generi (c'è anche una dedica comune, Brittonrosea Speg., oggi sinonimo di Echinocactus); a essere attualmente validi sono due: Rhodosciadium e Roseodendron. Come abbiamo visto, nella sua lunga carriera di tassonomista specializzato nel riportare ordine nella sistematica di famiglie complicate, i primi lavori di Rose furono dedicati alle Apiaceae. E proprio a questa famiglia appartiene Rhodosciadium, che nel 1889 gli fu dedicato dall'illustre botanico Sereno Watson. Il nome, un composto di rhodon, "rosa" e sciadeion "ombrello", si basa su un gioco di parole tra rose, "rosa" in inglese, e Rose, il cognome del nostro botanico e significa "ombrellifera dedicata a Rose". Il genere è distribuito tra Stati Uniti meridionali e Guatemala e gli sono attribuite da cinque a quindici specie. Sono erbacee perenni degli ambienti montani, con ombrelle rade con pochi fiori viola o giallo-verdastro. E' curioso che proprio Rose nel 1895 abbia separato dal genere dedicato a lui stesso alcune specie messicane, assegnandole al nuovo genere Deanea (oggi non accettato). In rete sono disponibili davvero poche informazioni su questo genere discusso; Rhodosciadium longipes (una specie pubblicata per la prima volta da Rose con il nome Deanea longipes) in Messico, dove è chiamata espico, è considerata una pianta medicinale. Una sintetica presentazione del genere nella scheda. Le ricerche di Rose prima in Messico e poi in Sud America ne hanno fatto una figura quasi leggendaria per i botanici dell'America latina. Non stupisce che Faustino Miranda, forse il più noto botanico messicano, nel separare da Tabebuia due specie abbia voluto dedicare a Rose il nuovo genere Roseodendron (1965), ovvero "albero di Rose". La denominazione di Miranda tuttavia fu presto respinta, e le piante furono assegnate a Cybistax, per poi ritornare a Tabebuia. Ricerche molecolari pubblicate nel 2007 hanno però dato ragione a Miranda, raccomandando di resuscitare Roseodendron. Appartenente alla famiglia Bignoniaceae, comprende due sole specie: R. donnell-smithii, e R. chryseum. R. donnell-smithii è la specie più diffusa; raccolta in Messico da Palmer, fu pubblicata proprio da Rose nel 1892 come Tabebuia donell-smithii. E' un albero magnifico che al momento della fioritura si ricopre di grandi fiori dorati; è nota con il nome colloquiale "primavera"; ha un areale abbastanza ampio (dal Messico meridionale al Guatemala) ma è anche frequentemente coltivata. R. chryseum è invece un endemismo delle foreste aride del Venezuela nordoccidentale e della Colombia settentrionale. Rispetto all'altra specie è di dimensioni minori e presenta infiorescenze meno compatte. Qualche approfondimento nella scheda. C'è chi lo chiama il Plinio tedesco (anche se non era tedesco, ma svizzero, era erudito quanto Plinio, ma molto più dotato di senso critico), oppure il Leonardo svizzero (dato che, oltre a essere un genio poliedrico, era anche un disegnatore di talento, il paragone calza di più). In ogni caso, anche per gli standard del Rinascimento, epoca che coltivò più d'ogni altra l'aspirazione all'uomo universale, lo svizzero Conrad Gessner fu certamente una personalità d'eccezione. Fu teologo, medico, insegnante, linguista, filologo, bibliografo, naturalista, un poligrafo che scrisse degli argomenti più diversi. Per i posteri è il padre di due discipline tanto lontane come la bibliografia e la zoologia, con le enciclopediche Bibliotheca universalis e Historia animalium. Ma per i contemporanei, e forse per lui stesso, era soprattutto un botanico; la morte precoce e improvvisa gli impedì di completare e pubblicare quella che riteneva la vera grande opera della sua vita, l'altrettanto enciclopedica Historia plantarum. Rimasta manoscritta e pubblicata parzialmente solo duecento anni dopo la morte dell'autore, è la grande opera mancata della botanica rinascimentale. A rivelarci il metodo innovativo di Gessner, basato sull'osservazione minuziosa delle piante e sul confronto tra il maggior numero possibile di specie alla ricerca di una chiave di classificazione, sono soprattutto le lettere ai numerosissimi corrispondenti e ancor più i disegni allestiti per il suo magnum opus, sorprendenti per la precisione e per la scelta dei particolari, del tutto inconsueti per l'epoca. Il poligrafo svizzero era anche un alpinista entusiasta, oltre che il primo in età moderna a rimarcare il legame tra la distribuzione delle piante, il terreno e l'altitudine. Inoltre fu uno degli animatori della grande rete di scambio di informazioni, semi, piante, esemplari che caratterizzò l'ambiente naturalistico del Cinquecento; in relazione con molti dei maggiori botanici del suo tempo, influenzò direttamente l'opera di Jean Bauhin, che fu suo allievo. Stimato dai botanici delle generazioni successive, fu ricordato da Plumier (e da Linneo) con la dedica del genere Gesneria, che dà il nome alla famiglia Gesneriaceae.  Una memorabile ascensione Nel 1541, Conrad Gessner (all'epoca aveva ventisei anni) in una lettera all'amico Jakob Vogel, poi pubblicata come dedicatoria dell'opuscolo Libellus de lacte ac operibus lactariis, espresse tutto il suo entusiasmo per le montagne e promise: "Mi propongo per il futuro, finché Dio mi concede di vivere, di scalare le montagne, o almeno di scalare una montagna all'anno". Sappiamo che tenne fede alla promessa, ma di queste escursioni annuali purtroppo ci rimane un solo resoconto: quella della scalata del Grepfstein (1926 m. sul livello del mare), una delle cime del gruppo del Pilatus, alle spalle di Lucerna, nell'agosto 1555. Insieme ad alcuni amici, da Zurigo, dove abitava, Gessner raggiunse Lucerna, dove assunse una guida, dal momento che le autorità cittadine vietavano di accedere al Pilatus da soli. Si credeva infatti che la montagna fosse infestata dal fantasma di Ponzio Pilato, che qui sarebbe stato esiliato e qui sarebbe morto suicida; meglio non sfidare quell'anima in pena, che alla minima provocazione scatenava terribili tempeste! Gessner non ci crede più di tanto e si gode la gita con tutti i sensi: la vista ammaliata dallo spettacolo delle cime e dal magnifico panorama; il tatto piacevolmente solleticato dalle fresche e pure brezze alpine, tanto in contrasto con l'inquinata aria cittadina; l'olfatto deliziato dal profumo dei fiori e delle erbe; persino il gusto è appagato da uno rustico spuntino a base di pane e acqua di fonte: "Dubito che i sensi umani possano assaporare un piacere più grande e più epicureo". Prima di affrontare l'ultimo tratto, nell'ultima malga Gessner vede e ascolta un corno delle Alpi e, quasi per sfida, prova a suonarlo. Quindi la guida li conduce alla cima, attraverso un cammino abbastanza arduo e non segnato da sentieri. Sulla cima, gli amici incidono il loro nome sulle rocce, come hanno fatto molti altri viandanti prima di loro; di Pilato nessun segno, da nessuna parte. Gessner conclude: "Da parte mia, sono inclinato a pensare che non sia mai stato qui". All'andata e al ritorno, il naturalista osserva gli animali (le trote del torrente Rumling, camosci, stambecchi, marmotte) e erborizza, raccogliendo una quarantina di specie diverse. E' affascinato dalla maestosità delle montagne, che per un uomo profondamente religioso come lui è segno e prova della grandezza di Dio, e dalla varietà della natura alpina: "In nessun altro luogo come in montagna è possibile incontrare tanta varietà; a parte ogni altra considerazione, solo in montagna è possibile contemplare e sperimentare le quattro stagioni, estate, autunno, inverno e primavera, riuniti in una sola giornata". Al ritorno a Zurigo, racconterà l'escursione in Descriptio Montis fracti sive Montis Pilati ut vulgo nominant, la prima monografia dedicata alla descrizione di un ambiente alpino, tanto precisa da essere in gran parte valida ancora oggi. In quel laboratorio all'aria aperta che è per lui la montagna, Gessener osserva le piante nel loro ambiente naturale e, secoli prima di Humboldt, è il primo naturalista a intuire l'influenza della temperatura e dell'altitudine sulla distribuzione della flora alpina. Per le sue precise notazioni sull'ecologia delle piante osservate, Descriptio Montis fracti è considerata la prima opera di geografia botanica. 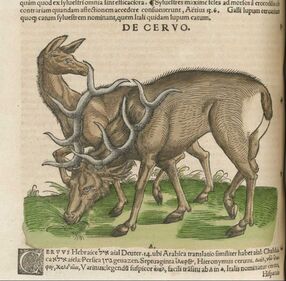 L'opera poliedrica di un genio universale Quando organizza la memorabile escursione, Gessner ha già dato alle stampe Bibliotheca universalis (1545-1549) ed è impegnato nella stesura e nella pubblicazione di Historia animalium (1551-1587). Sono le due grandi opere enciclopediche che hanno consegnato la sua fama ai posteri. Gessner era nato a Zurigo in una famiglia con troppi figli e troppi pochi soldi. Il padre, che secondo alcune fonti era un pellicciaio, era un seguace di Zwingli e morì insieme a lui nella battaglia di Kappel. Il quindicenne Conrad fu affidato a uno zio materno, un canonico che coltivava un piccolo giardino ed era esperto di erbe medicinali; fu lui, a quanto pare, a trasmettergli l'amore per la natura. Per il dotatissimo adolescente iniziava una vita errabonda: sempre a corto di soldi e dipendente dal sostegno finanziario di diversi mecenati, lo troviamo a studiare ebraico a Strasburgo, lingue classiche e medicina a Brouges, teologia e medicina a Parigi. Nel 1535 tornò in patria e a soli 19 anni si sposò con una ragazza povera quanto lui nonché malaticcia. Una scelta che egli stesso anni dopo giudicherà avventata e che lo privò momentaneamente dell'aiuto dei suoi protettori. Per vivere, fu costretto a insegnare per qualche tempo in una scuola elementare. Presto fu perdonato e poté riprendere gli studi di medicina a Basilea, quindi si spostò a Losanna, dove per tre anni (1537-1540) insegnò latino e greco all'Accademia cittadina, appena fondata; fu un periodo relativamente tranquillo, durante il quale godette di una certa tranquillità economica e iniziò a pubblicare i primi scritti di medicina, filologia e filosofia. Risalgono a questi anni anche le prime escursioni nel Giura, nel Vallese e sulle Alpi della Savoia e i primi testi di botanica, in cui l'interesse per le piante si coniuga con quelle per le lingue: Historia plantarum ordine alphabetico ex Dioscoride sumtis descriptionibus, et multis ex Theophrasto, Plinio et recentioribus Graecis (1541), una lista in ordine alfabetico dei nomi di piante che compaiono negli autori dell'età classica e del primo Medioevo; Catalogus Plantarum Latine, Graece, Germanice, et Gallice, un catalogo quadrilingue (1542) in ordine alfabetico dei nomi delle piante in latino, greco, tedesco e francese. Nel 1540, sollecitato dalla città di Zurigo che gli offrì una borsa di studio, Gessner riprese gli studi di medicina a Montpellier; un soggiorno breve, ma decisamente importante, che consolidò le sue conoscenze in botanica e anatomia e gli permise di stringere legami personali con altri studiosi, primo fra tutti Rondelet. L'anno successivo si laureò in medicina a Basilea e tornò a Zurigo; qui, a parte le consuete escursioni in montagna e qualche viaggio occasionale, sarebbe rimasto fino alla morte, mantenendosi con vari incarichi: lettore di Aristotele al Carolinum; medico capo della città dal 1554; docente di fisica, scienze naturali ed etica al Carolinum dal 1557 alla morte, avvenuta nel 1565 in seguita a un'epidemia di peste. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Negli anni zurighesi Gessner pubblicò numerose traduzioni e edizioni di testi classici, soprattutto di argomento medico, e scrisse copiosamente di teologia, medicina, linguistica, zoologia, botanica. Soffermiamoci solo sulle opere maggiori. Subito dopo il ritorno a Zurigo, egli fu impegnato nella stesura della monumentale Bibliotheca universalis: impressionato dalla distruzione della biblioteca di Buda, data alle fiamme dai Turchi, che aveva causato la perdita di numerosi inestimabili manoscritti, egli decise di pubblicare un catalogo completo di tutte le opere "esistenti o no, antiche o più recenti fino ai giorni nostri, dotte o no, pubblicate o conservate manoscritte nelle biblioteche". Dopo tre anni di ricerche, che egli stesso definì "un labirinto", il grandioso catalogo uscì infine a Zurigo nel 1545. E' la prima bibliografia dell'età moderna. Nel 1548, l'erudito svizzero la completò con le Pandectae, un indice tematico in cui i testi sono catalogati in 19 materie e 3000 voci; potremmo definirlo il primo motore di ricerca della storia. Subito dopo, egli iniziò a lavorare alla enciclopedia zoologica Historia animalium, una grandiosa opera in cinque volumi: il primo uscì nel 1551, l'ultimo nel 1587, ventidue anni dopo la morte dell'autore. L'intento di Gessner era presentare tutti gli animali conosciuti, nonché una bibliografia di tutte le opere di storia naturale a partire dall'antichità. In mancanza di un criterio di classificazione globale soddisfacente, gli animali, divisi in quadrupedi (I volume), ovipari (II volume), uccelli (III volume), pesci e animali acquatici (IV volume), serpenti e scorpioni (V volume), compaiono in ordine alfabetico; tuttavia alcune grandi categorie sono raggruppate insieme: ad esempio, tutti i bovini sono trattati sotto la voce Bos e tutte le scimmie sotto la voce Simia. Historia animalium è indubbiamente un'opera contraddittoria, con un piede nel passato e uno nel futuro. Da una parte è una compilazione erudita, in cui si riversa il patrimonio di conoscenze zoologiche ereditato dall'antichità o anche dal folklore, tanto che, accanto agli animali reali, non mancano quelli fantastici. Dall'altra parte, Gessner cerca di distinguere i fatti dai miti, e spesso si basa sull'osservazione diretta degli animali e delle loro abitudini; inoltre introduce informazioni sugli animali esotici recentemente conosciuti nelle Americhe o nelle Indie orientali. Di grande rilevanza è poi l'apparato iconografico, con oltre 1500 tavole spesso di grande precisione e realismo. Tra gli autori delle xilografie, va ricordato Albrecht Dürer. Nel 1555, Gessner pubblicò una terza opera notevole, Mithridates sive de differentiis linguarum, che possiamo considerare il testo fondante della linguistica comparata. Il breve opuscolo contiene un elenco in ordine alfabetico di 130 lingue e dialetti, corredato da osservazioni linguistiche, da informazioni sui popoli che li parlano, da esempi testuali e dal testo del Padre nostro in ventisei lingue.  Alla ricerca di una chiave per classificare le piante Nonostante questa mole di lavori in altri campi, il principale interesse di Gessner fin dagli anni di Losanna, quando si era innamorato delle piante alpine del Vallese, era la botanica. Negli anni in cui scriveva le grandi opere erudite, continuava a raccogliere e studiare le piante: nei suoi viaggi ne scoprì almeno 200 specie. Corrispondeva con molti colleghi, con cui scambiava esemplari e osservazioni e talvolta polemizzava, nonostante il carattere mite e conciliante (celebre è la controversia con Mattioli sull'identificazione dell'Aconitum primum di Dioscoride). Negli anni cinquanta, diede alle stampe una serie di brevi opere botaniche, talvolta in forma di lettera, tra cui De raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias ob causas, Lunariae nominantur (1556) in cui si occupa del fenomeno della luminescenza e espone le sue osservazioni sulle differenze tra alcune piante con nomi simili. All'inizio del decennio successivo risale De hortis Germaniae (1561), che contiene la descrizione di varie giardini botanici tedeschi, svizzeri, polacchi, francesi e italiani, incluso quello dello stesso Gessner a Zurigo, piccolo ma ricco di piante particolari; seguono indicazioni per la scelta e la coltivazione delle piante e una lista di piante coltivate in ordine alfabetico. E' interessante sottolineare che non si tratta solo di specie officinali o utilitarie, ma anche ornamentali. Terminata la stesura di Historia animalium (anche se la pubblicazione, come abbiamo già visto, si protrasse per decenni oltre la sua morte), Gessner decise che era venuto il tempo di dedicarsi interamente alle piante. Gli ultimi dieci anni della sua vita furono così consacrati alle ricerche e alla scrittura di un'altrettanto enciclopedica Historia plantarum. Fu un lavoro febbrile, una lotta contro il tempo: da sempre di salute cagionevole, miope e con la vista compromessa dallo studio e dall'uso delle lenti di ingrandimento, il grande naturalista temeva che la sua vita non sarebbe durata abbastanza per consentirgli di portare a termine l'impresa. E, come abbiamo visto, purtroppo non si sbagliava. Nella sua casa, che già da tempo era un piccolo museo naturalistico, incominciarono ad ammassarsi fogli di erbario inviati da amici (come Daléchamps e l'allievo Jean Bauhin, piuttosto nervoso quando il maestro li trattenne molto oltre le promesse), testi di altri botanici con le pagine fitte di annotazioni di mano di Gessner, e soprattutto disegni su disegni. Le oltre 1500 illustrazioni, in gran parte disegnate da lui stesso (era un disegnatore di grande talento) o affidate a collaboratori sotto la sua supervisione, erano diventate il suo principale strumento di lavoro, un modo per fissare sulla carta e rendere evidenti i particolari anatomici di ciascuna specie: ogni pianta era "fotografata" in tutti gli stadi di sviluppo, con tutti gli organi disegnati con la massima precisione e gli ingrandimenti di particolari significativi come i petali, gli organi riproduttivi, il sacco pollinico, i frutti e i semi. Attorno ai disegni, una ragnatela di annotazioni in una scrittura minutissima, con osservazioni sulla località di crescita, le forme di sviluppo, i particolari morfologici, le caratteristiche distintive. Attraverso queste osservazioni e questi disegni, Gessner stava cercando di scoprire una chiave di classificazione del vasto mondo vegetale, i cui confini non facevano che allargarsi con l'afflusso di sempre nuove specie da altri continenti. Una fatica di Sisifo e un fallimento annunciato. Anche se da nessuna parte Gessner ha esposto le sue conclusioni e in Historia plantarum le piante sono effettivamente raggruppate in modo incoerente ed empirico, dai particolari su cui insiste nei disegni e da alcune lettere possiamo ricavare chiaramente che aveva capito l'importanza dei fiori, dei frutti e dei semi per classificare le piante. Non a caso, la sua opera fu particolarmente apprezzata da Tournefort che possedeva una copia di De raris et admirandis herbis fittamente annotata. Inoltre fu tra i primi a distinguere con una certa chiarezza i concetti di genere e specie, scrivendo tra l'altro: "Non esiste quasi pianta che costituisca un genere che non possa essere diviso in due o tre specie. Gli antichi descrissero una specie di genziana. Io ne conosco dieci o più". Abbiamo già anticipato che Historia plantarum rimase incompleta ed inedita. Alla morte dell'autore i disegni furono acquistati da Camerario il Giovane che ne utilizzò una quarantina per il suo Hortus medicus (1588); il manoscritto passò per varie mani e fu parzialmente riscoperto da Trew, che lo pubblicò sotto il titolo Opera botanica tra il 1753 e il 1759, quando ormai era troppo datato per influire sugli sviluppi della scienza botanica. Circa 150 disegni furono scoperti nel 1927 nella Biblioteca di Erlangen; il terzo volume dell'opera, che si credeva perduto, è stato ritrovato solo nel 2013 nella biblioteca dell'Università di Tartu.  Gesneria, tropicali per intenditori L'ammirazione di Tournefort per Gessner era condivisa dal suo amico Plumier, che volle celebrare il botanico svizzero dedicandogli uno dei suoi nuovi generi americani. La dedica di Gesneria fu poi confermata da Linneo, che riteneva Gessner uno dei botanici più importanti delle generazioni precedenti e gli riconosceva il merito di essere stato il primo ad usare la struttura dei fiori come criterio di classificazione delle piante. Grazie a Plumier e Linneo, Gessner è diventato così il patrono non solo del genere Gesneria, ma delle Gesneriacae, una grande famiglia di più di 150 generi e 3500 specie, per lo più tropicali, caratterizzate da fiori vistosi e di grande bellezza. Molto meno nota delle cugine Achimenes, Gloxinia, Sinningia, Streptocarpus o Saintpaulia, anche Gesneria non manca di farsi notare per le fioriture smaglianti. Con circa cinquanta specie di piccoli arbusti, suffrutici ed erbacee perenni, è un genere quasi esclusivamente caraibico, ad eccezione di due o tre specie dell'America meridionale. Le Gesneriae sono vere tropicali, abitanti delle foreste d'altura, dove vivono sulle rocce e sulle pareti rocciose, godendo di ombra luminosa, suolo ricco e sciolto e umidità costante. Condizioni difficili da riprodurre in coltivazione, tanto più che basta che il terreno secchi troppo anche per un breve periodo per ucciderle; ecco perché sono piante da collezione, da coltivare in un terrario o in una serra protetta. Tra le poche specie relativamente diffuse, G. cuneifolia, nativa dei Caraibi orientali; è una erbacea in miniatura con foglie alternate lucide e fiori tubolari arancio vivo. Ne sono stati introdotti anche alcuni ibridi. G. ventricosa, nativa della Giamaica e delle piccole Antille, è invece un arbusto relativamente grande che vive in spazi semi-aperti sulla sommità delle colline nelle foreste pluviali di mezza montagna; ha corolle a imbuto rosso aranciato lievemente ricurve e rigonfie. Qualche approfondimento nella scheda. Quando arrivò in Brasile come giardiniere della spedizione austriaca, Heinrich Wilhemn Schott era un giovanotto di ventitré anni. Quell'avventura che sognava fin da bambino, quando, malato, aveva ricevuto la visita del grande Humboldt, cambiò per sempre la sua vita, facendogli incontrare le piante a cui avrebbe dedicato quasi mezzo secolo di studio meticoloso ed appassionato: le Araceae. Prima di lui, erano ancora poco conosciute e mal classificate; basandosi tanto su esemplari d'erbario, quanto sulle piante vive che coltivava nel giardino di Schönbrunn, di cui era capo giardiniere, fu il primo ad analizzarne in modo comparativo infiorescenze, fiori e frutti, stabilendo molti generi validi anche oggi e gettando le basi della tassonomia della famiglia. A ricordarlo non potevano che essere due generi di Araceae, originarie di Sarawak, nel Borneo settentrionale: Schottarum e Schottariella.  Una passione iniziata nel segno di Humboldt Sull'infanzia di Heinrich Wilhelm Schott, brillante giardiniere imperiale e grande tassonomista, si racconta un aneddoto dal sapore di fiaba. Nato a Brno in Moravia, a sette anni aveva raggiunto a Vienna il padre, capo giardiniere dell'Orto botanico universitario; poco dopo cadde malato e sembrò in punto di morte. Quando seppe che l'uomo che più ammirava al mondo, il grande Alexander von Humboldt, si trovava in città, espresse il desiderio di conoscerlo. Suo padre scongiurò il direttore dell'orto botanico, Nicholas Joseph von Jacquin, di intercedere presso lo scienziato perché visitasse il piccolo malato. Humboldt acconsentì prontamente; rivolse al bimbo parole così giuste e incoraggianti da risvegliare la sua forza vitale. Heinrich Wilhem guarì e giurò che avrebbe dedicato la sua vita a studiare la natura e le sue intime relazioni, sull'esempio del suo idolo. Negli anni successivi segui le lezioni di botanica, agricoltura e chimica all'Università, senza però conseguire alcun titolo, visto che adolescente incominciò a lavorare come aiuto giardiniere agli ordini del padre. Nel 1815 (all'epoca aveva ventun anni) divenne giardiniere del Palazzo Belvedere, dove gli fu assegnata la cura delle piante native. Due anni dopo, Joseph Franz von Jacquin lo raccomandò come giardiniere della spedizione austriaca in Brasile: era la persona ideale, unendo solide basi teoriche e abilità pratica. In Brasile il compito principale di Schott fu l'allestimento di un giardino di acclimatazione annesso all'ambasciata austriaca a Rio de Janeiro, dove coltivava le piante raccolte dai membri della spedizione e le preparava per il lungo e difficile viaggio verso l'Europa. Egli stesso si procurava semi e piantine in brevi spedizioni nei dintorni, ma, affascinato dall'esuberante natura tropicale, avrebbe desiderato spingersi più lontano. Solo dopo circa un anno, quando arrivò da Vienna l'aiuto giardiniere Schücht, poté soddisfare questo desiderio, con qualche missione a più largo raggio in compagnia del pittore Frick. Il suo diario di campo, notevole per la precisione delle descrizioni e arricchito da informazioni sulla geografia, l'economia e l'etnografia delle aree visitate, fu pubblicato a Brno nel 1822, dopo il rientro in Austria. Schott era infatti tornato a casa nell'estate del 1821. A Vienna, riprese il suo lavoro al Belvedere; nel 1828 fu promosso Hofgärtner, ovvero capo giardiniere. Ma intanto in Brasile aveva incontrato le piante del suo destino: le Araceae. Da quel momento avrebbe alternato al lavoro di giardiniere lo studio delle sue piante preferite; oltre al metodo rigoroso e a una brillante capacità di mettere a confronto una grande quantità di piante, a facilitargli il compito fu proprio la sua doppia veste di tassonomista e giardiniere; come capo dei giardini imperiali (nel 1845 venne nominati direttore del Giardino Imperiale di Schönbrunn, di cui diresse anche la trasformazione in giardino all'inglese) aveva accesso a una vasta collezione di piante esotiche, che egli stesso ebbe cura di incrementare grazie agli invii dei suoi numerosi corrispondenti. Così, poteva studiare le piante non solo su esemplari d'erbario o conservati sott'alcool, ma anche dal vivo, sperimentando diverse condizioni di coltivazione e osservando tutti gli stadi di sviluppo. Inoltre, come giardiniere, diede un importante contributo all'introduzione nei nostri giardini e nelle nostre case di piante oggi molto popolari, come Dieffenbachia, Anthurium scherzerianum, Schindapsus aureus. Grande esperto di piante tropicali, era anche appassionato di piante alpine e a palazzo Belvedere creò uno dei primi giardini ad esse dedicato. Una sintesi della sua vita operosa nella sezione biografie.  Araceae, fortissimamente Araceae Schott iniziò a studiare le Araceae fin dal suo ritorno dal Brasile, a partire dalle sue raccolte brasiliane e dalle collezioni di N.J. von Jacquin nelle Indie occidentali. All'epoca, questo gruppo di piante era ancora poco conosciuto. La famiglia è diffusa in tutto il mondo, ma il 90% delle specie proviene dai tropici. Alcune specie europee erano note fin dall'antichità e i botanici prelinneani, come Dodoens, tendevano a unirle tutte insieme sotto l'etichetta Arum, un nome di etimologia incerta, dal gr. aron, che indicava qualche pianta di questo gruppo, forse Dracunculus vulgaris. All'inizio del Settecento, Tournefort circoscrisse i tre generi europei Arum, Dracunculus, Arisaema e li raggruppò in una "classe" caratterizzata da un unico petalo; la struttura fiorale delle Araceae non era infatti ancora stata compresa e la brattea che avvolge lo spadice, l'infiorescenza tipica della famiglia, fu scambiata per un petalo sia da lui sia da Linneo. Quest'ultimo, in Species Plantarum (1753) ne descrisse 26 specie (oggi ne conosciamo circa 3750 distribuite in oltre 120 generi) distribuite nei quattro generi Arum, Dracontium, Calla, Pothos, cui l'anno successivo aggiunse Pistia; descrisse anche Orontium e Acorus, di cui però, come per Pistia, non riconobbe un'affinità con Arum. Intanto, con il moltiplicarsi delle spedizioni botaniche nei paesi tropicali molte nuove specie affluivano in Europa. Nel 1789 Antoine Laurent Jussieu fu il primo a riconoscere che il cosiddetto fiore è in realtà un'infiorescenza composta da uno spadice con numerosissimi minuscoli fiorellini avvolto in una brattea, o spata. A lui si deve anche la creazione della famiglia Araceae. Nel frattempo erano stati riconosciuti diversi nuovi generi, ma il primo a studiare sistematicamente questo gruppo di piante fu appunto Heinrich Wilhelm Schott, che può fregiarsi a ragione del titolo di "papà delle Araceae". Esordì con una serie di brevi articoli pubblicati in una rubrica intitolata Für Liebhaber der Botanik, "Per gli amanti della botanica", sulla rivista culturale Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode; benché solitamente molto brevi e rivolti a un pubblico generalista, sono molto importanti perché Schott vi venne via via pubblicando molti nuovi generi. Nel 1832 pubblicò la prima monografia sulle Araceae, Meletemata botanica (in collaborazione con Stephan Ladislaus Endlicher, all'epoca direttore dell'orto botanico di Vienna), uscito in sole sessanta copie; in questo lavoro, dedicato a una miscellanea di piante tropicali di recente raccolta, Schott riconobbe 40 generi e incominciò a delineare l'organizzazione della famiglia in sottofamiglie e sezioni. Seguì uno iato di vent'anni, nel corso del quale il botanico pubblicò solo due lavori estranei alla famiglia, uno sulle Rutaceae e l'altro sulle felci. In realtà, era tutt'altro che inattivo ma stava perfezionando con cura meticolosa il suo sistema di classificazione; era in contatto con molti colleghi che operavano in zone tropicali e gli inviavano nuove Araceae che studiava e spesso coltivava nelle serre di Schönbrunn; supervisionava il lavoro dei disegnatori e degli illustratori che, a sue spese, lo assistevano preparando i disegni e gli acquarelli per le future pubblicazioni. Così, a partire dal 1853, incominciarono a susseguirsi a breve intervallo diverse importanti monografie illustrate; la serie fu aperta tra il 1853 e il 1857 da Aroideae, con sessanta tavole; continuò con Synopsis Aroidearum (1856) e Genera Aroidearum Exposita (1858) e culminò con Prodromus Systematis Aroidearum (1860), in cui Schott portò a conclusione il sistema di classificazione perfezionato nell'arco di uno studio quarantennale. Contemporaneamente, diede alle stampe una magnifica raccolta di litografie in 4 volumi, Icones Aroidearum (1857-58). In questo periodo di iperattività, pubblicò anche dozzine di brevi articoli, usciti prevalentemente su Oersterichisches Botanisches Wochenblatt. Nel 1878, 14 anni dopo la sua morte, venne infine pubblicato, a cura di J.J. Peyritsch, un magnifico in folio illustrato con testi di Schott, dedicato alle Araceae raccolte nel Brasile orientale durante la spedizione finanziata nel 1859-60 dall'arciduca Ferdinando Massimiliano, più tardi imperatore del Messico come Massimiliano I. Il contributo di Schott alla conoscenza delle Araceae è incalcolabile; nel suo capolavoro, Prodromus Systematis Aroidearum, pubblicato a proprie spese all'età di 66 anni, trattò 110 generi, la maggioranza dei quali è tuttora valido o come genere o come sottogenere; si calcola che circa una terzo dei generi di questa famiglia debbano il loro nome a Schott, a testimonianza della vastità e della serietà del suo lavoro scientifico. I suoi lavori hanno gettato le basi della tassonomia delle Araceae e sono rimasti imprescindibili per tutti i botanici che sono venuti dopo di lui.  Resistere alle correnti Stranamente, questo grandissimo botanico ha rischiato di non ricevere il "solo onore che spetta a un botanico", come lo definiva Linneo, ovvero la dedica di un genere celebrativo. Certo, sono decine le piante che si fregiano degli eponimi schottii o schottianus come Philodendron schottii o Aphelandra schottiana; ma fino a tempi recenti un genere mancava. A rimediare a tanta ingiustizia hanno provveduto tra il 2008 e il 2009 i botanici P.C. Boyce e S.Y. Wong che in due studi dedicati alle Araceae del Borneo hanno voluto ricordalo con altrettanti generi: Schottarum e Schottariella. Appartenenti alla tribù Schismatoglottideae, sono molto simili tra loro e condividono l'habitat e le caratteristiche ecologiche. Sono piccole erbacee che crescono sulle ripide sponde argillose di corsi d'acqua dalle correnti impetuose, tributari di fiumi maggiori; le piante di questi habitat sono dette reofite, dal greco rèos "corrente" + phytòn "pianta". Riescono a sopravvivere in un ambiente così difficile grazie all'apparato radicale, molto profondo ed esteso, e alle foglie strette, allungate, flessibili e talvolta sfrangiate; nel descriverle, Beccari, che fu tra i primi a studiare la flora di Sarawak, nella parte nord occidentale dell'isola, ha definito questo carattere "stenofillia". Le foreste del Borneo sono insolitamente ricche di specie di Araceae (ne sono state recensite circa 130), tra cui numerose reofite. Sono ancora poco note perché spesso limitate a poche località, ma anche difficili da studiare perché le rive dei fiumi dove vivono possono essere totalmente sommerse per molti mesi all'anno, senza contare che le loro acque sono infestate dai coccodrilli. I due nuovi generi dedicati a Schott sono entrambi endemici di Sarawak, rari e presenti in poche stazioni. Schottarum comprende due specie, S. josefii e S. sarikense; Schottariella una sola, S. mirifica. Tutte sono piccole erbacee acquatiche con profondo ed esteso apparato radicale strisciante che consente di abbarbicarsi al substrato argilloso, con una rosetta di molte foglie strette e allungate, infiorescenze solitarie ma spesso numerose con spata a conchiglia e spadice subcilindrico. I due generi differiscono tra loro per alcuni particolari dei fiori apprezzabili solo al microscopio. Nei periodi di piena le piante possono trovarsi completamente sommerse, e quando emergono trattengono residui di fango sulle foglie; nei periodi di siccità, quando le acque scendono di molto e i corsi d'acqua si riducono a rigagnoli, possono trovarsi completamente all'asciutto. Anzi, coltivata in laboratorio, Schottariella mirifica ha dimostrato di essere in grado di rivivere anche dopo essere rimasta totalmente senza foglie e con l'apparato radicale inaridito per la siccità prolungata. Qualche approfondimento su Schottarum e Schottariella nelle rispettive schede. Citato per diritto e per traverso, noto anche a chi non ha letto il romanzo, l'incipit di Anna Karenina è uno dei più celebri della letteratura mondiale: "Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo". Eppure sfido il grande Leo a trovare un amore felice simile a quello di Kate e Townshend Brandegee, che si innamorarono a quarant'anni sotto l'egida della botanica e per quasi altrettanti formarono una famiglia felice a modo loro. E a modo suo vive anche Brandegea bigelovii, tenace Curcurbitacea a suo agio nei deserti tra Stati Uniti e Messico.  Townshend prima di Kate, Kate prima di Townshend Fu la botanica a far incontrare Mary Katharine Layne Curran (1844-1920) e Townshend Stith Brandegee (1843-1925), e fu la botanica a farli innamorare. Entrambi erano sulla quarantina, nel pieno di una carriera che ne faceva personalità riconosciute nel loro campo. Ma i veri traguardi li avrebbero raggiunti insieme. Townshend era un ingegnere, ma, figlio di un medico che era anche un agricoltore, fin da bambino si era appassionato di storia naturale e aveva incominciato a creare un erbario. Dopo aver combattuto giovanissimo nella guerra civile, studiò ingegneria, ma anche botanica, alla Yale University’s Sheffield Scientific School; durante gli anni universitari, raccolse piante nella zona di New Haven, incluse alcune specie rare. Dopo la laurea, nel 1871 si trasferì a Cañon City in Colorado, come agrimensore della contea e ingegnere della città; anche qui continuò ad erborizzare, inviando piante a vari corrispondenti, incluso Asa Grey. Anche grazie alla raccomandazione di quest'ultimo, fu assunto come assistente topografo nella spedizione geografica nota come Hayden Survey, che tra il 1871 e il 1873 esplorò l'area che sarebbe diventata il parco di Yellowstone. Poté così lavorare fianco a fianco con il botanico della spedizione, John Coulter. Fu l'inizio di una carriera di ingegnere e topografo, al servizio delle compagnie ferroviarie e del servizio forestale; viaggiando in molte regioni ancora poco note degli Stati Uniti occidentali, ebbe anche occasione di esplorarne la flora. Fu anche incaricato di disegnare le mappe forestali di diverse regioni; nell'inverno 1886-87 fu inviato in California a rilevare le risorse forestali e cercare alcune essenze; visitò le isole di Santa Cruz e Santa Rosa, dove raccolse campioni per Charles Sprague Sargent. La scoperta della particolarissima flora delle isole lo convinse a stabilirsi a San Francisco e ad abbandonare la carriera di ingegnere civile per diventare un botanico a tempo pieno. Per saperne qualcosa di più, visitò l'erbario dell'Accademia delle scienze californiane. E lì avvenne l'incontro fatidico con Kate. Dopo aver raccontato di "Townshend prima di Kate", è dunque ora di parlare di "Kate prima di Townshend". Mary Katharine Layne aveva avuto un'infanzia errabonda. La famiglia Layne era approdata in California all'epoca della corsa all'oro, quando Kate aveva cinque anni, ma aveva continuato a cambiare sede al seguito di un padre inquieto. Nonostante l'educazione discontinua, la ragazza era diventata insegnante e nel 1866, a 22 anni, si era sposata con il poliziotto Hugh Curran, che purtroppo amava alzare il gomito e dopo sei anni la lasciò vedova. Kate, che adesso si chiamava ufficialmente Mary Katharine Curran, decise di trasferirsi a San Francisco e di iscriversi alla scuola di medicina, che aveva appena aperto le porte alle donne; lei fu la terza ad approfittarne. Nel 1878 si laureò. All'epoca, l'insegnamento della tradizionale "materia medica", ovvero della botanica applicata alla farmacia, faceva ancora parte del curriculum di medicina. Grazie a un professore eccezionale, Hans Hermann Behr, un convinto evoluzionista, la giovane donna incominciò ad interessarsi di piante e apprese il metodo rigoroso che poi sempre l'avrebbe contraddistinta. Behr la introdusse all'Accademia delle Scienze e al suo erbario, dove Katharine incominciò a prestare la sua opera come volontaria. Quando scoprì che per una donna era difficile esercitare la professione medica, questo divenne il suo lavoro. Nel 1879 divenne assistente del curatore dell'erbario, Albert Kellogg, e dal 1883, quando egli andò in pensione, gli succedette come curatrice e responsabile del dipartimento di botanica dell'Accademia; era una posizione eccezionale per una donna. All'epoca, nell'intera California, le botaniche professioniste erano solo due. Oltre a lavorare intensamente al riordino e all'accrescimento delle collezioni con escursioni sul campo, per presentare le nuove scoperte la dottoressa Curran ebbe l'idea di creare una rivista che scriveva di fatto da sola, Bulletin of the California Academy of Sciences; ufficialmente era solo la curatrice, e non il direttore responsabile, perché l'Accademia era riluttante a riconoscere che la sua principale pubblicazione era diretta da una donna. Fin a quel momento, l'autorità di Asa Gray e di Harvard era tale che all'Ovest nessuno osava pubblicare una nuova specie senza consultare quell'oracolo. La rivista fornì un veicolo per pubblicare più rapidamente le nuove specie e diede un grande contributo alla coscienza di sé e all'indipendenza della botanica californiana. Determinata, dotata di leadership e grinta, quando incontrò Towshend, la dottoressa Curran era una delle poche donne a dirigere una importante istituzione scientifica, senza tirarsi indietro anche quando si trattava di dare battaglia per conquistare un finanziamento. Vedova, senza figli, divideva il suo tempo tra il lavoro quotidiano all'erbario, la redazione di articoli scientifici e del Bollettino, le spedizioni sul campo.  Un'unione di cuore e di mente Il fatidico incontro tra Towshend e Kate dovette avvenire nell'inverno 1886. Non conosciamo i particolari del loro innamoramento, che dovette essere profondo e fulminante, nonché piuttosto inconsueto per l'epoca, tanto da destare battutine e pettegolezzi. Katharine confessò a una sorella di essere "innamorata in modo folle" e i sentimenti di Townshend, benché fosse un uomo discreto e taciturno, non dovettero essere diversi. Presto decisero di sposarsi, ma lontano dal pettegolo ambiente dell'Accademia; dunque non a San Francisco, ma a San Diego, dove nel maggio 1889 Kate raggiunse Towshend di ritorno dalla sua prima spedizione botanica in Baja California per conto dell'Accademia delle Scienze. Dopo la cerimonia, officiata da un pastore, iniziarono la loro vita di coppia con un inconsueto viaggio di nozze: da San Diego a San Francisco, raccogliendo piante lungo la strada; una bella camminata, se si pensa che le due città sono separate da oltre 800 km! Oltre che innamorati e devoti l'uno all'altro, anche come botanici i Brandegee erano perfettamente complementari. Il punto forte di Towshend era il lavoro sul campo, la vasta conoscenza della flora degli Stati Uniti occidentali acquisita in quasi vent'anni di viaggi e raccolte; quello di Kate, che aveva erborizzato solo nella California centrale, era l'eccezionale competenza di tassonomista. Inizialmente la coppia rimase a San Francisco; Kate, che adesso si firmava Katharine Layne Brandegee, continuò a lavorare all'erbario; Townshend entrò a far parte dell'Accademia delle Scienze. Nel 1890 ricevette una piccola eredità; grazie a questa somma, Kate poté fondare una propria rivista scientifica, Zoe; tuttavia, ufficialmente come direttore responsabile figurava il marito, perché la comunità scientifica non era ancora pronta ad accettare una rivista diretta da una donna. Nel 1891 Katharine fondò il California Botanical Club, aperto anche agli amatori, la prima associazione di questo tipo della West Coast. Entrambi i coniugi intensificarono le attività di raccolta, lui soprattutto in Baja California, lei prevalentemente nella California centrale. Durante un'escursione, Townshend incontrò una giovane botanica canadese, Alice Eastwood, e la presentò alla moglie, che esaminando il piccolo erbario raccolto dalla ragazza a Denver, rimase colpita dalla sua qualità. Rinunciando a una parte dello stipendio, la assunse come assistente, finché nel 1892 l'Accademia l'assunse ufficialmente come curatrice aggiunta. Potendo affidare molto del lavoro di routine ad Alice, ora Katharine poteva concentrarsi su ciò che più la interessava: la descrizione, l'identificazione e la classificazione delle piante. Profondamente consapevole che le specie possono presentare un altro grado di variabilità, secondo l'esposizione, il suolo, le condizioni climatiche, era convinta che, prima di denominare una nuova specie, bisognasse studiarne le crescita in situazioni differenti, raccogliendo e confrontando il maggior numero possibile di esemplari cresciuti in diverse condizioni ambientali. Di conseguenza, non sopportava i botanici egocentrici che moltiplicavano le denominazioni al puro scopo di aggiudicarsi l'effimera gloria di una nuova scoperta. Contro di loro, lanciò i suoi strali su Zoe, divenendo celebre - potremmo dire famigerata - per la ferocia delle sue critiche. Nel suo rigore, arrivò a lamentarsi persino del marito che "ha descritto come nuova una specie contro la mia volontà". Townshend si specializzò nella flora del Messico, in particolare della Baja California, che percorse in numerose spedizioni, divenendone il massimo esperto. Tra aprile e maggio 1893 insieme a altri cinque botanici esplorò la Sierra San Pedro Mártir nella Baja California settentrionale; lo stesso anno, tra settembre e ottobre, fece due viaggi da San Jose del Cabo nelle montagne della regione del Capo; al primo partecipò anche Katharine, che fotografie del tempo ritraggono a cavallo di una mula vestita in abiti maschili. Mentre rientrava da sola da questo viaggio, la sua imbarcazione naufragò. Fu forse considerano questi rischi e la distanza di San Francisco dal Messico che i Brandegee decisero di trasferirsi a San Diego; Katharine diede le dimissioni dall'erbario (come curatrice le succedette Alice Eastwood) e nel marzo 1894 acquistarono un vasto terreno non edificato sull'altopiano alle spalle della città, la mesa, con vista sulla baia di San Diego. Il loro primo pensiero, prima ancora di costruire la casa, fu per l'erbario, per ospitare il quale fecero costruire un padiglione di mattoni, mentre loro vivevano in una tenda. Fu poi la volta della casa e di una serra. Tutto attorno uno straordinario orto botanico, con piante raccolte in natura e portate qui dalle spedizioni della coppia in Messico e nella California meridionale. Era in primo luogo un laboratorio all'aria aperta, dove le piante raccolte durante le spedizioni venivano coltivate riproducendo le diverse condizioni naturali di crescita, in modo da osservarne le variazioni e giungere a una classificazione corretta. Ma era anche un giardino bellissimo, che così è stato descritto da un ospite: "Un paradiso botanico, con fiori rari da tutte le parti, e i canti di tordi beffeggiatori, quaglie e altri uccelli canori nativi a rendere l'aria musicale". Nel 1896, l'appassionato raccoglitore di piante di origine tedesca Carl A. Purpus scrisse a Katharine per chiedere l'identificazione di diverse specie; la cortese ed esperta risposta della botanica fu l'inizio di una collaborazione e di un'amicizia. Da quel memento la casa di San Diego divenne la base delle spedizioni di Purpus in Messico; in cambio, egli arricchì il giardino e l'erbario dei Brandegee con continui invii di piante dei deserti messicani, che i due botanici studiavano, coltivavano, classificavano. Townshend rinunciò alle faticose spedizioni in Messico, ma continuò ad esplorare assiduamente i dintorni di San Diego. Unica eccezione, una spedizione del 1902 in compagnia di Kate Sessions, una intraprendente e creativa vivaista dalla quale i Brandegee al loro arrivo a San Diego avevano acquistato alcune piante. Insieme a lei, Townshend ritornò nella regione del Capo per visitare alcune località trascurate nelle spedizioni precedenti; dopo aver raggiunto San Jose del Capo in battello, si addentrarono sulle montagne a dorso d'asino; fu così che scoprirono una palma ancora ignota, Brahea brandegeei. Lo stesso anno, Sessions fu incaricata dalla Città di San Diego di piantare un nuovo parco (Balboa Park) e convinse il botanico a prestare la sua consulenza per la scelta delle piante. Avvicinandosi la sessantina, i Brandegee cominciarono a pensare al futuro del loro amatissimo erbario, a cui dedicavano molte ore della giornata e che adesso comprendeva circa 76.000 esemplari. Decisero di farne dono, insieme alla biblioteca, all'Università della California a Berkeley, a condizione di poter continuare a lavorarvi fino alla fine dei loro giorni. Nonostante la munificenza del dono, le trattative si trascinarono per quattro anni. I Brandegee dovettero farsi carico anche delle spese di trasporto e non vennero aiutati neppure a trovare una casa. Poco prima della data fissata per il trasloco, nell'aprile 1906, avvenne il disastroso terremoto di San Francisco. Fortunatamente Berkeley e il campus subirono danni limitati e entro la fine dell'anno il trasferimento era completato. Fino a tarda età marito e moglie continuarono a lavorare gratuitamente ogni giorno all'erbario, di cui Townshend era stato nominato curatore onorario, e finché fu possibile continuarono anche le spedizioni botaniche; nel 1913, anche se soffriva di diabete in una forma sempre più grave, Katharine fece ancora una lunga spedizione in California alla ricerca di esemplari-tipo, per sostituire quelli andati perduti nell'incendio di San Francisco. Per molti anni, a occupare le giornate di lui fu anche la pubblicazione delle piante raccolte da Purpus in Messico, nella imponente Plantae Mexicanae Purpusianae, in 12 volumi (1909-1924). Quando completò l'opera, era già rimasto solo. Kate se ne era andata per prima, nel 1920, a 76 anni. Townshend la raggiunse nel 1925. Chi li conobbe durante gli anni di Berkeley, notò che anche da vecchi continuavano a mostrare "lo stesso indomabile amore per il pensiero critico e difficile che li aveva caratterizzati già da giovani". A rimanere invariato fino alla fine era stato anche l'amore reciproco, che li aveva sorprendentemente uniti quasi quarant'anni prima. Una sintesi delle loro vite tutte dedite alla scienza nella sezione biografie.  Brandegea, una deserticola variabile Il lascito di Townshend Brandegee sta soprattutto nelle piante che scoprì nelle sue spedizioni: gli è accreditata la scoperta di circa 225 piante della Baja California. Parecchie lo ricordano nel nome specifico. Abbiamo già incontrato Brahea brandegeei; tra le californiane, aggiungiamo Salvia brandegeei, una notevole Salvia dell'isola di Santa Rosa che è stata anche introdotta nei giardini per il grande valore ornamentale; tra le messicane, Echinocactus brandegei, una specie molto variabile che sembra fatta apposta per confermare le teorie di Katharine Layne Brandegee. Anche Katharine scoprì diverse piante notevoli, come Eriastrum brandegeeae, una rara Polemoniacea della catena costiera californiana. Ma questa grandissima botanica è ancora più importante come ricercatrice, tassonomista, teorica; giocò un ruolo enorme nell'emancipare la botanica californiana e diede un contributo altrettanto incisivo agli studi tassonomici, soprattutto sul piano metodologico. Di valore incalcolabile è poi il lascito comune di entrambi: il grande erbario ora custodito a Berkeley. Quanto al giardino di San Diego, purtroppo passò in altre mani che lo lasciarono morire, e non ne rimane nulla. Né Townshend né Katharine cercavano fama e onori; a loro interessava unicamente il progresso della scienza. Così la piccola pianta del deserto che li celebra appare straordinariamente adatta a ricordarli. A rigori, fu dedicata solo a lui, ma poiché vive sia in California sia nel Messico settentrionale, le aree di cui i due botanici erano specialisti, possiamo considerarlo un omaggio a entrambi. Durante la sua prima spedizione in Baja California, Townshend raccolse una cucurbitacea dai fiori molto minuti che pubblicò come Cyclanthera monosperma Brandegee; poco dopo, l'importante tassonomista belga Célestin Alfred Cogniaux, esperto di Cucurbitaceae, la unì a una specie già nota come Elaterium bigelovii S. Watson, creando il genere Brandegea con due specie, B. bigelovii (S.Watson) Cogn. e B. monosperma (Brandegee) Cogn. Oggi al genere Brandegea, una liana della famiglia Cucurbitaceae, con profondissime radici a fittone, sottili fusti volubili, piccole foglie verde scuro profondamente palmate, ma molto variabili nella forma e nelle dimensioni, piccolissimi fiori bianchi con cinque petali appuntiti, minuscoli frutti secchi spinosi, è assegnata una sola specie, B. bigelovii. Come molte piante del deserto, che devono affrontare condizioni estreme e molto differenziate nel corso delle stagioni e da un anno all'altro, anch'essa è estremamente variabile, tanto che in passato i botanici, meno prudenti di Katharine Layne Brandegee, le avevano assegnato almeno quattro specie, con una foresta di sinonimi. E' dunque anch'essa una conferma vivente della correttezza del metodo di questa grande botanica, che ne diventa così la co-dedicataria onoraria. Qualche approfondimento nella scheda. Talvolta, la giustizia poetica è concessa anche ai nomi botanici. Che a ricordare il grande Michel Adanson, autore di un'opera impossibile per il suo stesso gigantismo, per perseguire la quale egli rinunciò a fama, riconoscimenti materiali e alle stesse elementari necessità della vita per chiudersi nel suo lavoro solitario, sia proprio il baobab, albero gigante che si erge sulla arida savana, vive per migliaia di anni e supera le peggiori siccità accumulando acqua nel fusto e rinunciando alle foglie, ne è la dimostrazione. A guidare la mano dell'inconsapevole Linneo e a ispirargli la creazione del genere Adansonia, molto prima che il destino di Adanson si palesasse, è uno scherzo della sorte o, appunto, un atto di giustizia poetica. 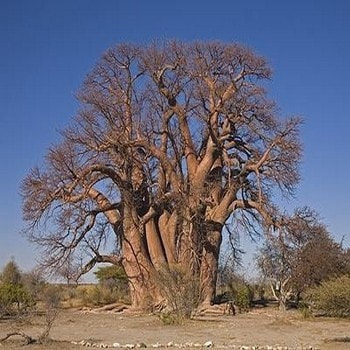 Primo atto: un viaggio in Senegal L'incontro tra i due protagonisti della nostra storia avviene nell'agosto del 1749, nel villaggio senegalese di Sor. Michel Adanson è arrivato in Senegal da circa sei mesi ed è ancora pieno di entusiasmo e di stupore per la ricchezza della natura tropicale. Ha già imparato abbastanza la lingua wolof (tra i suoi tanti talenti c'è anche quello linguistico) da muoversi da solo; chiede indicazioni su un buon terreno da caccia e viene indirizzato sulle tracce di un branco di gazzelle. Ma una visione stupefacente spegne ogni interesse venatorio: è un albero immenso, il più grande che abbia mai visto. Non per l'altezza (forse una ventina di metri), ma per la circonferenza straordinaria; incredulo, Adanson gli gira intorno tredici volte. Cerca di misurarla allargando le braccia, poi con una corda. Calcola una circonferenza di 20 metri, e un diametro di quasi 7. Ciascuno dei rami che forma la chioma, alcuni dei quali toccano terra, è più lungo e spesso del tronco di uno dei maggiori alberi monumentali d'Europa. L'albero in sé non è raro, aggiunge Adanson, appartiene anzi a una delle specie più comuni nel paese, che i francesi chiamano calebassier, o anche pain-de-singe ("pane delle scimmie") e i locali goui. Noi lo conosciamo con il nome di origine araba baobab, ma anche - grazie a Bernard de Jussieu e a Linneo - come Adansonia digitata. Nel momento in cui incontrò l'albero destinato a preservare il suo nome, Adanson aveva 22 anni, ma era già un naturalista ambizioso e singolare. La famiglia lo aveva destinato alla chiesa e durante gli anni di collegio si era distinto come allievo solerte e brillante; quattordicenne, aveva attirato l'attenzione del biologo inglese John Needham che gli donò un microscopio con queste parole: "Dato che avete imparato così bene a conoscere le opere degli uomini, è ora che studiate quelle della natura". Fu una folgorazione. Il ragazzo incominciò a frequentare il Jardin du Roy e le lezioni di Réaumur e Bernard de Jussieu. A diciotto anni conosceva migliaia di specie vegetali e sapeva classificare tutte le piante del giardino. Gli era anche chiaro che il suo destino non era nella Chiesa, ma nello studio della natura. Rinunciò al beneficio ecclesiastico che aveva coperto i costi degli studi e insisté con il padre - scudiero del vescovo di Parigi - perché trovasse il modo di farlo partire per un paese tropicale, se possibile inesplorato. Grazie a Pierre-Barthélemy David, direttore della Compagnia delle Indie, ottenne infine un modesto posto di commesso a Saint-Louis, l'emporio della compagnia sulla costa del Senegal. Malfamato per il suo clima insalubre, era praticamente sconosciuto ai naturalisti. Senza alcun incarico ufficiale, senza alcun titolo di studio formale, fu dunque come "impiegato incaricato di tenere i registri" che Adanson il 3 marzo 1749 si imbarcò a Lorient sul Chevalier marin. Si era preparato con scrupolo al viaggio, raccogliendo tutte le informazioni possibili sul clima, gli animali, le piante, le lingue, i costumi locali. Aveva imparato i metodi più all'avanguardia per conservare piante e animali. Nel suo bagaglio, telescopi, barometri, termometri e altri strumenti scientifici. Il soggiorno di Adanson in Senegal si prolungò per cinque anni (fino al febbraio 1754), fu ricchissimo di risultati scientifici, ma difficile da ogni punto di vista. Si ammalò ripetutamente e la Compagnia si dimostrò ostile; anche se lui cercava di convincere i suoi capi dell'utilità anche economica delle sue ricerche, per loro questo impiegato che si dava troppo da fare e faceva di tutto tranne quello per cui era pagato, era davvero meno che inutile. Solo grazie alle insistenze dei suoi protettori parigini (in particolare Jussieu e Réaumur) riuscì ad ottenere il permesso di coltivare un piccolo giardino, dove sperimentava incroci e coltivava piante rare da introdurre in Francia. Eppure, era attivissimo: oltre a St. Louis e ai suoi dintorni, visitò l'isola di Gorée, Podor, e il bacino del Gambia; annotò dati meteorologici e astronomici, disegnò mappe, imparò lingue e compilò dizionari, raccolse ogni sorta di dati etnografici, geografici, economici. E, ovviamente, campioni di minerali, animali, piante. Spedì centinaia di esemplari ai corrispondenti parigini, e molte migliaia lo avrebbero accompagnato nelle casse che portò con sé nel viaggio di ritorno, insieme a 300 piante vive da acclimatare al Jardin du Roy. 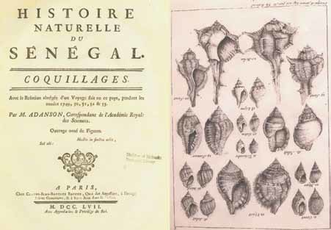 Secondo atto: un'opera pionieristica Provato dal clima tropicale, privo di mezzi e di relazioni, l'uomo che sbarca infine in Francia nel 1754 è molto diverso dal ventunenne di quasi sei anni prima. Da quell'esperienza, oltre all'enorme mole di materiali, ha portato indietro una convinzione profonda: per comprendere la natura, la scienza deve cambiare paradigma. Tutti i sistemi che si è finora data per classificarla, di fronte alla sterminata esuberanza dei tropici, dimostrano la loro inconsistenza: "Appena lasciamo i nostri paesi temperati per entrare nella zona torrida, la botanica sembra mutare totalmente volto: sono sempre piante, ma sono così particolari nelle loro loro forme, hanno caratteristiche così nuove che eludono la maggior parte dei nostri sistemi, i cui limiti non vanno al di là delle piante dei nostri climi". Ma il primo compito è studiare e pubblicare le raccolte senegalesi. Ospitato generosamente dai Jussieu, Adanson elabora il primo dei suoi grandiosi progetti: una storia naturale del Senegal in otto volumi. In realtà, ne scriverà solo il primo: Histoire naturelle du Sénegal (1757) comprende il vivace racconto del suo viaggio e le descrizione delle conchiglie senegalesi, che egli classifica in modo del tutto originale, non più basandosi sulle conchiglie stesse, come si faceva all'epoca, ma sui molluschi che vivono all'interno e le loro strutture. E' il primo saggio di quel metodo globale che tra poco vedremo in azione con le piante. Benché parziale, l'opera gli assicura fama immediata. Adanson è ammesso all'Accademia delle Scienze parigina, seguita qualche anno dopo dalla Royal Society. Ottiene una pensione con il titolo (praticamente una sinecura) di censore reale. Ma ormai sta perseguendo un nuovo progetto. Dal 1759, collabora con il maestro Bernard de Jussieu alla creazione del giardino botanico del Trianon, con le piante disposte in famiglie naturali e incomincia a lavorare a un proprio metodo di classificazione, che esporrà nella sua opera maggiore, Familles naturelles des Plantes (1763). Quando essa uscì, Adanson viveva ancora a casa dei Jussieu ed è impossibile che la frequentazione quotidiana e il lavoro comune non abbiano influito sul suo pensiero; eppure, Adanson cercò di minimizzare il debito con il suo maestro. A suo dire, aveva concepito il progetto di una classificazione naturale fin da ragazzo al Jardin du Roy e la spinta decisiva era venuta dal viaggio in Senegal, con la sua natura tanto diversa da quella europea; quanto a Bernard, lo descriveva come un linneano ortodosso, incapace di allontanarsi dal fallace sistema di Linneo. Di parere opposto sarà Antoine-Laurent de Jussieu, secondo il quale il metodo di Adanson era un plagio delle elaborazioni di suo zio, il solo vero inventore della classificazione naturale. Come avviene quasi sempre, anche in questo caso la verità starà nel mezzo: Bernard aveva cominciato a lavorare a una classificazione naturale e a insegnarla ai suoi allievi quando il giovanissimo Michel seguiva le sue lezioni al Jardin du Roy e sicuramente alla fine degli anni cinquanta era giunto a definire un proprio sistema (non sappiamo quanto coincidente con quello esposto da Antoine-Laurent in Genera Plantarum); d'altra parte, la ricerca di Adanson, se fu stimolata da quella di Bernard de Jussieu, dovette poi seguire un proprio percorso e un proprio metodo.  Terzo atto: manie classificatorie Il primo volume di Familles naturelles des Plantes si apre con un'ampissima disamina di tutti i sistemi di classificazione proposti in precedenza, tutti quanti considerati incapaci di rendere conto del vero ordine della natura. Per giungere a individuarlo, lo studioso non deve concentrasi su uno o pochi elementi, scelti in modo più o meno arbitrario, ma deve analizzare tutte le caratteristiche possibili, senza stabilire una gerarchia: "Non c'è dubbio che in botanica c'è un solo metodo naturale, ed è quello che considera tutte le parti, qualità, proprietà e facoltà delle piante". Adanson individua quindi 595 categorie di caratteri che raggruppa in 66 sistemi "artificiali", fondati ciascuno su un gruppo di caratteri omogenei (ad esempio, caratteristiche delle foglie, delle radici, delle corolle, ecc.); inserendo tutte le piante note in ciascun sistema, è possibile individuare la loro maggiore o minore affinità. Le piante che, in tutti i sistemi, ricadono nella stessa classe, hanno un alto grado di affinità; quelle che si ritrovano insieme solo in alcune classi sono meno prossime; quelle poi che in tutti i sistemi stanno in classi diverse non hanno alcuna affinità. Come si vede, è un metodo altamente complesso che implica un enorme numero di comparazioni, che difficilmente Adanson avrà utilizzato davvero per classificare nel secondo volume ben 1615 generi, assegnati a 58 famiglie naturali (52 delle quali sono piante da fiore), in un'epoca in cui i computer e il calcolo combinatorio erano al di là da venire. Anche lui, non diversamente da Bernard de Jussieu, avrà condotto le sue comparazioni "par tatonnement", per usare le parole di Augustin de Candolle. In ogni caso, il risultato è imponente; il concetto di "famiglia" entra ormai nella storia della botanica e molte delle sue famiglie sono riconosciute ancora oggi, spesso proprio con i nomi che lui stesso diede loro. Fu infatti Adanson a introdurre la convenzione di nominare le famiglie sulla base di un genere tipico, anche se non usava ancora il suffisso che oggi le contraddistingue: ad esempio, Papavera (oggi Papaveraceae), Ranunculi (oggi Ranunculaceae), Cisti (oggi Cistaceae), Solana (oggi Solanaceae). Nel Congresso internazionale di botanica del 1987, Familles naturelle des plantes fu addirittura scelto come punto di partenza per i nomi delle famiglie (attualmente, tuttavia, non lo è più: dal 2003 è sostituito da Genera plantarum di Jusseu). Di Linneo, Adanson rifiutò anche la nomenclatura binomiale, vista a sua volta come un'imposizione. A suo parere i nomi delle piante dovrebbero cambiare il meno possibile e non dovrebbero essere motivati: bisognerebbe evitare sia i nomi figurati sia i termini che rimandano a una qualche etimologia. I nomi migliori sono quelli che esistono già, quindi in primo luogo quelli indigeni. Coerentemente, gli spiacque persino che Linneo avesse dato il suo nome al baobab. Insieme alla personalissima grafia fonetica che Adanson volle adottare per la sua opera (ad esempio scrive Botanik anziché Botanique), anche questa scelta contribuì all'insuccesso dell'opera che la comunità scientifica apprezzò per l'erudizione, ma non per il metodo; fu ovviamente avversata dai linneani; quanto a Linneo, il suo commento fu che non aveva mai visto un simile ammasso di sciocchezze. Da parte sua, Adanson stava già pensando a un nuovo progetto, ancora più ambizioso. Il metodo induttivo e combinatorio da lui scoperto non era forse universale, applicabile all'intero mondo naturale, anzi ad ogni sapere umano? Ci lavorò almeno una dozzina di anni, e nel 1774 (l'anno prima aveva finalmente ottenuto il sospirato titolo accademico, come botanico aggiunto dell'Accademia delle scienze) presentò all'Accademia stessa lo schema del suo L'Ordre universel de la Nature. La commissione incaricata di analizzare la proposta, sgomenta, si trovò di fronte 27 volumi manoscritti dedicati alle relazioni tra tutte le entità; 150 volumi manoscritti con la descrizione di 40.000 specie in ordine alfabetico; un vocabolario di 200.000 parole; 40.000 illustrazione; 24.168 esemplari; in più, note e osservazioni. I commissari gli consigliarono di espungere tutta la parte compilatoria, limitandosi ai suoi contributi originali, da presentare in una serie di memorie separate. Adanson rifiutò, ostinandosi fino alla fine della vita nel suo folle progetto. Il rifiuto lo amareggiò, e lo spinse a chiudersi in se stesso, a sacrificare tutto alla sua "enciclopedia". Non aveva più né amici né allievi, e neppure una famiglia. Nel 1784 lasciò addirittura la moglie, da cui aveva avuto una bambina (Aglaé Adanson, a sua volta botanica), perché la sua presenza lo distraeva dal lavoro. Divenne un eremita; si ritirò in periferia, in una casa sempre più ingombra di collezioni e manoscritti, dove lavorava accanitamente sedici, diciotto ore al giorno; unica pausa dallo studio e dalla scrittura, il piccolo giardino dove sperimentava incroci e coltivava alberi di gelso. Già in condizioni economiche precarie, fu totalmente rovinato dalla Rivoluzione, che soppresse le pensioni reali di cui godeva. Perse anche l'amatissimo giardino e fu ridotto a vivere in condizioni di miseria estrema. Nel 1798, invitato a prendere parte alle sedute dell'Institut national (la nuova denominazione "rivoluzionaria" dell'Accademia delle scienze), rifiutò, dicendo che gli era impossibile andarci perché non aveva neppure un paio di scarpe. Se non altro, il ministro dell'interno provò vergogna e gli assegnò una pensione, poi raddoppiata da Napoleone. Nel testamento, espresse un solo desiderio: che la sua bara fosse ornata da una ghirlanda formata dai fiori delle sue 58 famiglie. Una sintesi di questa vita tutta occupata dallo studio e da progetti sempre più giganteschi e più impossibili nella sezione biografia. 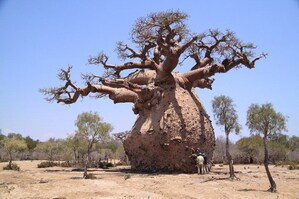 Boabab, giganti minacciati Tra le scoperte di Adanson in Senegal, sicuramente quella che destò maggiore interesse fu proprio l'albero gigante che tanto aveva ammirato. Poco dopo il suo ritorno, nel 1757, egli lesse all'Accademia delle scienze una memoria in cui lo descriveva e ne ricostruiva la storia. Prima di allora, nessun europeo l'aveva mai visto, anche se se ne conoscevano i frutti, che venivano venduti nei mercati egiziani, dove li vide Alpini. Jussieu ritenne che sarebbe stato un doveroso omaggio dedicare allo scopritore il nuovo genere e si affrettò a scrivere in proposito a Linneo. Il tempo dell'inimicizia e delle polemiche era ancora lontano, e lo svedese lo accontentò volentieri, ufficializzando la denominazione nella decima edizione di Systema naturae (1759). Così, con dispetto del dedicatario, il baobab (parola di origine araba che significa "padre di molti semi"), divenne Adansonia digitata. E' la più nota delle otto-nove specie del genere Adansonia, della famiglia Malvaceae (precedentemente Bombacaceae). Uno dei suoi esemplari, il baobab di Glencoe, un albero monumentale della provincia di Limpopo in Sud Africa, era considerato l'essere vivente più grande del mondo, con una circonferenza di 47 metri e un diametro di 15,9. Purtroppo nel novembre del 2009 si è spaccato in due parti e il primato è passato al baobab di Sunland, sempre in Sud Africa, con una circonferenza di 34 metri. Nativi di aree stagionalmente aride, i baobab africani sono in grado di immagazzinare nel tronco enormi quantità di acqua (fino a 120.000 litri); inoltre nella stagione secca, riducono la dispersione lasciando cadere le foglie. Tuttavia, oggi in varie zone dell'Africa sono in grande pericolo: a partire dall'inizio del secolo, proprio gli esemplari maggiori, che vantano un'età tra 1000 e 2500 anni, hanno incominciato a collassare e a morire uno dopo l'altro. Secondo gli studiosi, è una conseguenza del cambiamento climatico, in particolare della combinazione tra siccità e innalzamento della temperatura: gli alberi si disidratano e non riescono più alimentare i loro enormi tronchi. E non possiamo neanche sperare in un Napoleone che sollevi questi giganti dalla loro miseria. Ma non c'è solo A. digitata. Il Madagascar ospita ben sei specie endemiche, tra cui A. grosdidieri, considerata la più bella per il tronco slanciato. Vive invece in Australia A. gregorii, non meno affascinate delle cugine africane. Qualche approfondimento nella scheda. Per circa centocinquanta anni, l'orto botanico parigino, prima Jardin du Roy poi Jardin des Plantes, fu dominato da esponenti della famiglia Jussieu, nelle vesti di professori di botanica e dimostratori. Abbiamo già incontrato uno dei membri della prima generazione, Joseph de Jussieu, nel ruolo di botanico della spedizione geodetica nel Vicereame del Perù. E' ora di conoscere più da vicino i suoi celebri fratelli, gli accademici Antoine e Bernard, soprattutto quest'ultimo, cui si deve un decisivo passo avanti nell'elaborazione di un metodo di classificazione naturale delle piante, poi perfezionato da un altro Jussieu, suo nipote Antoine-Laurent. L'ultima generazione è poi rappresentato dal figlio di questi, Adrien. Non più validi i generi che furono dedicati all'intera famiglia, a celebrare almeno Bernard e Adrien rimangono due generi di Euphorbiaceae, Bernardia e Adriana. 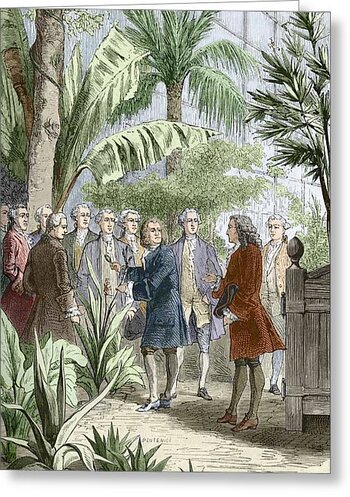 I Jussieu, linneani riluttanti Nel maggio del 1738, prima di tornare definitivamente in Svezia, Linneo passò da Parigi per visitare il Jardin du roy e le sue collezioni. Per preparare il soggiorno, aveva scritto ai padroni di casa, i due Jussieu: Antoine, il titolare della cattedra di botanica, e Bernard, il dimostratore delle piante. Si racconta che arrivasse al Jardin senza annunciarsi, unendosi a un gruppo di studenti che seguiva una dimostrazione di Bernard. A un certo punto, questi chiese di identificare una pianta sconosciuta. Dal gruppo si levò una voce dall'accento straniero: "Haec planta facem americanam habet" (Questa pianta ha le caratteristiche di una pianta americana). Bastò perché Bernard capisse con chi aveva a che fare, replicando "Tu es diabolus aut Linnaeus" (O sei il diavolo o sei Linneo"). Fu l'inizio di una duratura amicizia. Bernard condusse Linneo a visitare il giardino, gli aprì le porte dell'erbario e della biblioteca, erborizzò con lui nelle campagne parigine, lo introdusse nei circoli scientifici della capitale. Più tardi, ne fece il suo corrispondente all'Accademia delle Scienze e fu determinante per la sua ammissione all'istituzione come membro estero. Linneo ricambiava con una profonda stima per Bernard, con cui continuò a scambiare lettere per quasi un trentennio; nel 1747 così scrisse a un corrispondente: "E' l'astro del nostro secolo; lo metto al di sopra di tutti, perché è ricchissimo di osservazioni solide e ben fondate". Nella sua famosa lista degli "ufficiali del Regno di Flora", assegnò a Bernard il ruolo di generale maggiore, secondo solo a lui, il generale in capo. Candolle riferisce che lo ammirava tanto da dire ai suoi allievi: "Non c'è nessuno in grado di spiegare così bene le piante. Aut Deus aut magister noster Jussiaeus, o Dio o il nostro maestro Jussieu". Al contrario di Buffon, il sovrintendente del Jardin, che espresse critiche feroci al sistema linneano, i Jussieu ne vedevano con equilibrio pregi e limiti. Nel 1744 Bernard curò la pubblicazione francese della quarta edizione di Systema naturae, integrando le denominazioni linneane con quelle di Tournefort e i nomi volgari francesi. Nel 1774, per volontà di Bernard e suo nipote Antoine-Laurent, la denominazione binomiale fu adottata nel Jardin des Plantes. I Jussieu riconoscevano anche i vantaggi pratici del sistema sessuale linneano, tanto che Antoine-Laurent scrisse: "La botanica gli deve una parte dei suoi progressi. Il suo sistema occuperà sempre uno dei primi ranghi tra i metodi artificiali, e faciliterà lo studio delle piante". Tuttavia, si trattava appunto di un metodo artificiale, comodo e facile da usare per identificare e nominare le piante, ma incapace di dare conto delle affinità reali e di cogliere l'ordine naturale del mondo. Naturalmente, Linneo stesso ne era perfettamente consapevole e, a parole, ammetteva la superiorità del metodo naturale, che definì "il compito ultimo della botanica", un compito, però, a suo parere non ancora accessibile ai botanici della sua generazione. 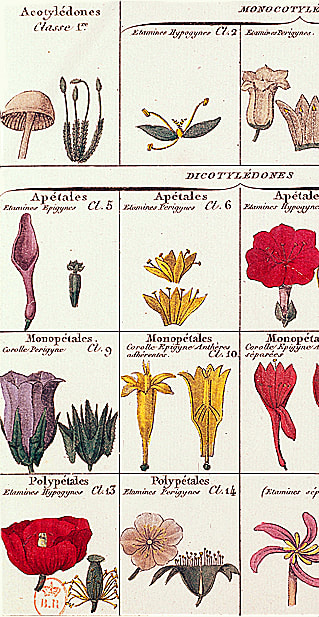 Alla ricerca di un metodo naturale Pur nella sua infinita modestia, Bernard la pensava diversamente. Probabilmente poco dopo il fatidico incontro con Linneo, intorno al 1740, incominciò a elaborare un proprio metodo, basato non su un singolo criterio, ma sul maggior numero di criteri possibili, riprendendo la strada percorsa da Ray, Tournefort e Magnol. Gli erano di stimolo le acquisizioni dei suoi colleghi zoologi del Jardin du Roi, primo fra tutti Buffon, che molto prima dei botanici stavano individuando con successo validi criteri di classificazione degli animali. Nella sua ricerca Bernard si basò sull'osservazione continua e diretta delle piante, acquisendone una conoscenza profonda, direi intima. Era un osservatore, non un teorico, con un approccio olistico in cui molto contava l'istinto; il sistema dovette emergere poco a poco, per tentativi, "par tatonnement", con scriverà Candolle. Purtroppo egli era un grande studioso e un grande didatta che trasmetteva generosamente le sue acquisizioni agli allievi, ma non ha lasciato nulla di scritto sul suo lavoro. Come per ricostruire il pensiero di Socrate dobbiamo affidarci a (e fidarci di) Platone, per ricostruire il metodo di questo Socrate della botanica dobbiamo basarci su quanto ce ne racconta il nipote e allievo, Antoine-Laurent (un testimone tutt'altro che disinteressato). Nel 1759, il re chiese a Bernard di creare un orto botanico nel giardino del Trianon; il botanico accettò, e sistemò le piante nelle parcelle suddivise sulla base di ordini naturali (equivalenti grosso modo alle nostre famiglie). Non scrisse una riga per spiegare i criteri seguiti nei raggruppamenti, che però possiamo almeno in parte dedurre dalla lista manoscritta dei generi suddivisi in ordini, che fu pubblicata trent'anni dopo da Antoine-Laurent, nel 1789. Nel raggruppare le piante, Bernard prese in considerazione elementi come le caratteristiche dell'embrione, la posizione dell'ovario, la presenza o l'assenza di petali, la fusione o la libertà dei petali. La classificazione venne strutturata gerarchicamente in tre gruppi principali, 14 classi e 65 ordini. Cominciando dalle crittogame, proseguiva con le monocotiledoni, quindi le dicotiledoni, per finire con le conifere. Dal 1763, Bernard fu affiancato dal nipote Antoine-Laurent, che l'avrebbe poi sostituito come dimostratore e avrebbe concluso la carriera come direttore post rivoluzionario del Museo nazionale di scienze naturali. Nel fatidico 1789, oltre al manoscritto sulla disposizione del giardino del Trianon, egli diede alle stampe Genera Plantarum, secundum ordines naturales disposita. In questo testo importantissimo, oggi considerato il vero inizio della classificazione naturale come noi la concepiamo, egli presenta il proprio metodo come la continuazione, o meglio l'attualizzazione e il perfezionamento, delle acquisizioni dello zio. Non sappiamo se dobbiamo credergli fino in fondo; in questa affermazione c'è infatti l'intento polemico di assicurare la primogenitura alla propria famiglia, sminuendo il contributo di Adanson, che di Bernard era stato allievo, e aveva pubblicato la sua Familles de plantes a partire dal 1763. Non sappiamo dunque se davvero risalisse già a Bernard, o si debba interamente a Antoine-Laurent, l'introduzione di quella che Cuvier (che fu profondamente influenzato da quest'ultimo) avrebbe chiamato "legge di subordinazione degli organi". Per ritrovare l'ordine che presiede alla natura è necessario, è vero, osservare ogni parte delle piante, tenere conto dell'insieme delle caratteristiche, ma non tutte hanno la stessa importanza gerarchia. Per prime vengono le caratteristiche costanti, comuni a tutte le piante dell'ordine, ricavate dagli organi essenziali (prime fra tutte il numero dei cotiledoni o la loro mancanza); quindi le caratteristiche quasi costanti, ricavate da organi non essenziali, in particolare la corolla e gli stami, che nel loro insieme contribuiscono a individuare le caratteristiche di una famiglia, ma singolarmente servono unicamente a determinare un genere; infine le caratteristiche variabili, ricavate da qualsiasi organo, distintive di ciascuna specie. E' questa la maggiore novità del sistema di Jussieu, che lo distingue dai precedenti metodi naturali e apre la strada ai rapidi progressi della classificazione naturale, portata avanti nell'Ottocento tra gli altri dal maggiore discepolo di Antoine-Laurent, Augustin Pyrame de Candolle.  Una famiglia di botanici per le famiglie di piante Prima di lasciare questa importantissima famiglia di botanici, che dominò il Jardin du Roy, poi Jardin des plantes per tre generazioni e quasi un secolo e mezzo, dal 1709, quando vi approdò Antoine, al 1853, quando morì Adrien, il suo ultimo esponente, è ora di conoscerne meglio i membri. I Jussieu erano originari di Lione, dove esercitavano da generazioni la professione di farmacista. Antoine (1686-1758) andò a studiare medicina a Montpellier, dove si appassionò di botanica; le sue spedizioni botaniche in Normandia e Bretagna attirarono l'attenzione di Fagon, che nel 1709, alla morte di Tournefort, lo chiamò al Jardin du Roy a insegnare botanica. Già due anni dopo fu ammesso all'Accademia delle Scienze. Nel 1716 fu inviato in missione in Spagna e prese con sé il fratello minore Bernard (1699-1777), all'epoca ancora adolescente. Nel 1722 anche Bernard arrivò al Jardin du Roy, come sottodimostratore, e nel 1725 anch'egli fu ammesso all'Accademia delle Scienze. Tra i due fratelli, legatissimi, ci fu subito una netta divisione di ruoli: Antoine era il professore titolare, ricopriva ruoli ufficiali anche amministrativi e inoltre era un medico reputato, con una vasta clientela. Bernard, sempre modesto, poco propenso ad apparire, era l'appartato studioso e il prestigioso didatta che svelava i segreti delle piante a uno stuolo di allievi riverenti. Si occupava anche dell'erbario e delle collezioni del Jardin, che incrementò (sembra di tasca propria) anche con due viaggi in Inghilterra, da uno dei quali riportò due plantule di Cedrus, che secondo un aneddoto forse apocrifo fecero il viaggio nel suo cappello. Da questa posizione defilata non volle discostarsi neppure dopo la morte di Antoine, rifiutando di succedergli nella cattedra di botanica per rimanere sottodimostatore come era sempre stato. Ai vecchi, diceva, non piacciono i cambiamenti. Ma ci sono ancora due fratelli; Christophe, rimasto a Lione a gestire la farmacia di famiglia, e Joseph (1704-1779) che abbiamo già incontrato parlando della Spedizione geodetica nel Vicereame del Perù. Rimasto in America 35 anni a raccogliere piante e ad assistere i poveri, ritornò in Francia solo nel 1771, ormai privo di senno, e fu amorevolmente assistito da Bernard, ormai divenuto capo famiglia dopo la scomparsa di Antoine. Come ho già anticipato, dal 1763 era arrivato a Parigi anche Antoine-Laurent (1748-1836), figlio di Christophe. Divenuto l'assistente e il migliore allievo di Bernard, nel 1770 succedette a Le Monnier come professore al Jardin du Roy. Per almeno un quindicennio fu impegnato nella stesura di Genera Plantarum, che, come ho anticipato, uscì proprio nell'anno d'inizio della rivoluzione francese. Con la quale il nostro riuscì a destreggiarsi a sufficienza da essere nominato nel 1804 direttore del Museo Nazionale di Scienze naturali, sorto dalle ceneri del Jardin du Roy, ormai Jardin des Plantes. Fu una delle principali figure della botanica europea della prima metà dell'Ottocento. Nel 1826, divenuto quasi cieco (un destino che toccò a molti botanici, affaticati dall'eccessivo uso del microscopio, compreso suo zio Bernard), lasciò la cattedra al figlio Adrien. Siamo così arrivati all'ultima generazione: Adrien (1797-1853) fu a sua volta professore sia al Jardin des Plantes sia alla facoltà di scienze. Il suo contributo più importante è Cours élémentaire de botanique, un'opera didattica di grande diffusione. Gli si devono anche alcuni saggi su varie famiglie di piante, che andavano ad aggiungere un mattoncino all'edifico della botanica sistematica di cui Bernard aveva gettato le fondamenta.  Due Euphorbiaceae esotiche per due Jussieu A questa famiglia così illustre non potevano mancare le dediche di generi botanici. Nel 1753 Linneo cercò di pagare il suo debito di riconoscenza verso i fratelli Jussieu dedicando loro Jussaea, oggi confluito in Ludwigia insieme a Isnardia. Nel 1781, in Reliquiae Houstonianae, lo scritto di Houstoun edito postumo da Banks, seguì Jussieuia, oggi sinonimo di Cnidoscolus. E così anche Antoine, Joseph e Antoine-Laurent si aggiungono alla lunga lista di grandi botanici non ricordati da alcun genere valido. Non è così né per Bernard né per Adrien. Si dove ancora a Houstoun (in questo caso la proposta fu accolta e fatta propria da Philip Miller, che il botanico lionese aveva conosciuto durante il viaggio a Londra) la dedica a Bernard de Jussieu del genere Bernardia della famiglia Euphorbiaceae. Bernardia è un vasto genere che comprende almeno una settantina di specie di arbusti ed erbacee perenni originari dell'America tropicale e subtropicale, tipiche soprattutto degli ambienti semiaridi, dalla California al Brasile. Morfologicamente molto vario, nonostante il grande numero di specie, è relativamente poco studiato. Sono piante monoiche o dioiche, con foglie per lo più dentate, usualmente con ghiandole basali e piccole stipole solitamente persistenti. I fiori unisessuali, privi di petali, sono raccolti in infiorescenze in forma di spiga o di racemo all'ascella dei rami. Quelli staminati (maschili) presentano solitamente tre brattee simili a foglie, mentre quelli pistillati sono globosi e ricoperti di peli. I frutti sono delle capsule con tre lobi o tre angoli. Tra le specie più note, B. incana, originaria dei deserti tra California e Messico settentrionale, con stipole persistenti che essudano una resina scura e foglie biancastre per la presenza di una densa peluria; B. myricifolia, che fa parte delle comunità di macchie di arbusti su roccia calcarea di Texas e Messico, è simile alla precedente, ma con stipole caduche e prive di essudato. Un riconoscimento, infine, è toccato anche all'epigono Adrien, che nel 1825 ricevette da Gaudichaud-Beaupré la dedica di un altro genere di Euphorbiaceae, il piccolissimo Adriana, con solo due specie originarie dell'Australia, A. quadripartita e A. urticoides, il primo endemico dell'Australia meridionale, il secondo presente in tutta l'isola, ad eccezione della Tasmania. Sono fitti arbusti eretti, dioici, anch'essi adattati ad habitat aridi. Di A. quadripartita, nota come bitter-bush, esistono due forme: una con foglie glabre, l'altra con foglie pubescenti. Quest'ultima viene anche utilizzata per formare siepi costiere antivento. Se i suoi colleghi l'avessero pensata come Karl August von Bergen, medico e botanico nonché professore dell'Alma Mater Viadrina di Francoforte sull'Oder, questo blog non esiterebbe. Nel ragionare sul sistema migliore per denominare un nuovo genere, la sua preferenza andava infatti ai nomi descrittivi basati sulle caratteristiche distintive o l'aspetto generale. A suo giudizio l'abitudine di usare i nomi delle piante per "onorare persone bene merite della botanica" era da condannare, perché l'utile va preferito alla vanità. Eppure è proprio grazie alle bergenie, tra i primi fiori a rallegrare i nostri giardini tra inverno e primavera, che è stato preservato anche il suo nome, che altrimenti sarebbe conosciuto forse da qualche studioso della storia della medicina o della botanica prelinneana, come autore di un piccolo libro che è insieme una flora regionale e un trattatello di botanica sistematica. E dunque, a suo dispetto, sia gloria al professor Bergen e al genere Bergenia. 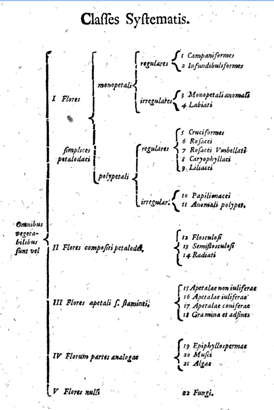 Una botanica metodica Nel Settecento, il dibattito sui sistemi di classificazione delle piante fu assai vivace. A prevalere, anche fuori dei confini francesi, fu probabilmente quello creato da Tournefort, ma molti botanici ne elaborarono dei propri, più o meno diffusi. Dunque, quando Linneo pubblicò Systema naturae (la prima edizione è del 1735), il suo era solo uno dei tanti sistemi in concorrenza, che faticò assai ad imporsi. Forse l'accoglienza più contrastata si ebbe nell'area tedesca, con posizioni fortemente ostili come quelle di Ludwig e Siegesbeck, o più aperte e favorevoli come quella di Gleditsch. E' in questo contesto che si inserisce una figura indubbiamente minore, ma significativa del mondo accademico tedesco, Karl August von Bergen (1704-1759). Egli era figlio d'arte e arrivava da uno degli angoli più remoti della Germania, Francoforte sull'Oder. Suo padre era Johann Georg von Bergen, professore di anatomia presso l'Università Viadrina, la più antica e più prestigiosa del Brandeburgo. La formazione del giovane Bergen tuttavia non fu affatto provinciale: venne mandato a completare gli studi a Leida, dove fu allievo di Boerhaave e si laureò in medicina; fu poi a Parigi e a Strasburgo. Rientrato in patria, prima insegnò presso l'università della città natale come professore straordinario, quindi succedette al padre nelle cattedre di anatomia e botanica, incarico che comprendeva anche la direzione dell'orto botanico (fondato nel 1679). Come anatomista, si segnalò per le sue ricerche sul sistema nervoso, ma si interessò anche di zoologia (con un'operina sul rinoceronte e un saggio sulla classificazione dei molluschi con conchiglia). Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Bergen intervenne nel dibattito sul sistema linneano nel 1742 con Programma: utri systematum Tournefortiano an Linneano potiores partes deferendae sint, in cui mise a confronto i sistemi di Tournefort e Linneo, sostenendo la superiorità del secondo. Ma pochi anni dopo sembrò cambiare idea. Nel 1750, infatti, in Flora fracofortana adottò come punto di riferimento il sistema del francese. Senza essere uno dei testi sacri della botanica, è senza dubbio un'opera significativa che vale la pena di analizzare più da vicino. Si tratta di una delle numerose flore regionali prodotte dai botanici tedeschi tra Seicento e Settecento; in questo caso, l'ambiente indagato è la marca di Brandeburgo, di cui si passano in rassegna alcune centinaia di piante sia native sia coltivate in orti e giardini. Da questo punto di vista, l'autore stesso lo presenta modestamente come un aggiornamento e un completamento di un'opera precedente, Hodoegus botanicus, un vademecum per gli studenti di medicina e botanica di Francoforte pubblicato da Martin Daniel Johren nel 1715. Le sue ambizioni si espressero piuttosto al saggio introduttivo, in cui Bergen espone le sue riflessioni (cogitata) sullo studio metodico della botanica; il suo proposito è individuare un metodo facile, praticabile anche dagli autodidatti, un filo d'Arianna che li condurrà per mano nei labirinti del regno di Flora; e questo metodo deve essere naturale, o per dirla con le sue parole Botanices... proprio Marte addiscendae, "una botanica da studiare in base alle sue stesse forze". Il metodo è esposto in 52 brevi o brevissimi paragrafi di tono aforistico; dopo aver definito i concetti stessi di metodo e di scienza, Bergen elenca le parti distintive delle piante, distinguendole in primarie (fiori, frutti e semi) e secondarie (radici, tronco, caule, foglie). Afferma quindi che a fornire le note caratteristiche in base alle quali si distinguono e classificano le piante sono le parti coinvolte nella fruttificazione. Passa quindi a definire le categorie tassonomiche: classi, ordini, generi, specie, varietà. Il concetto fondamentale, sulla scorta di Tournefort, è quello di genere, che raggruppa specie simili e va individuato sulla base delle parti primarie. Tanto meno si dovranno considerare le parti secondarie per definire le classi. D'altra parte, Bergen è consapevole che botanici diversi nelle loro classificazioni hanno considerato differenti parti connesse con la fruttificazione: Cesalpino il frutto, Ray, Tournefort, Magnol e altri il calice, von Haller corolla, stami e frutto , Linneo stami e pistillo. Tutti questi metodi sono artificiali, mentre quello che si desidera è un metodo naturale. Linneo ne ha fornito solo dei frammenti. Per altro, a suo parere, il medesimo criterio non funziona per tutti i generi, molti dei quali presentano caratteristiche singolari. Bergen passa poi a occuparsi delle denominazioni. I nomi dei generi ottimi sono quelli basati sull'aspetto e le caratteristiche delle piante che ne fanno parte, mentre le denominazioni celebrative devono essere evitate, perché l'utilità deve avere la meglio sulla vanità. Analogamente, sono eccellenti i nomi delle classi e degli ordini che sintetizzano le caratteristiche dei generi che raggruppano, anche se quelli assegnati finora, per esempio da Tournefort, sono prevalentemente artificiali e arbitrari. I nomi specifici dovrebbero invece essere desunti dalle parti secondarie, in particolare quelle che differenziano una specie dall'altra. Non per questo Bergen anticipa la denominazione binomia di Linneo: se ridicolizza i prolissi nomi polinomi definendoli septempedales (insomma, peggio che sesquipedali), nel suo catalogo egli stesso usa nomi-descrizione spesso di cinque o sei parole. Dopo aver concluso con un appello appassionato allo studio delle piante, osservate là dove vivono nei diversi momenti dell'anno e esaminate in tutte le loro parti, Bergen fornisce ai lettori un utile glossario dei termini botanici (utile anche per noi per capire lo stato dell'arte verso metà Settecento). Ed ecco infine il suo sistema di classificazione che si basa in parte su quello di Tournefort, in parte se ne discosta. Anche qui il criterio di classificazione è la corolla, gli ordini sono cinque e le classi ventidue, ma scompare la bipartizione, ancora presente nel francese, tra piante erbacee o arbustive e alberi, che lo aveva costretto a raddoppiare alcune classi. Se dunque i primi due ordini (fiori petalati semplici e fiori petalati composti) e le prime 14 classi sono identici a quelli di Tournefort, in realtà si sono allargati a comprendere anche le specie arboree. Del tutto originali sono invece i raggruppamenti successivi: il terzo ordine (apetali staminati), con le quattro classi apetale senza amenti, apetale con amenti, apetale conifere, graminacee ed affini; il quarto ordine (con parti analoghe ai fiori), che comprende le tre classe epifillosperme - cioè le felci -, muschi e alghe; il quinto ordine, privo di fiori, è costituito dai funghi. Rispetto al sistema di Tournefort, il progresso è chiaro soprattutto per quanto riguarda le crittogame, precedentemente raggruppate in due classi, apetale senza fiori (le felci) e apetale senza né fiori né frutti (tutte le altre).  Bergenia, una pianta demodé? A questo nemico dei nomi celebrativi è toccato in sorte di essere ricordato, più che per i suoi studi, apprezzati dai contemporanei ma presto dimenticati, per la dedica di un genere botanico molto popolare: Bergenia, creato nel 1794 da Conrad Moench in un'opera che ha qualche analogia con Flora francofortana, ovvero Methodus plantas horti Botanici et agro Marburgensis: anche in questo caso una flora regionale, con un forte tensione metodologica. La denominazione Bergenia venne usata illegittimamente anche da Necker per il genere Lythrum e da Rafinesque (1838) per il genere Cuphea. Ma molto prima si era ricordato di Bergen anche Michel Adanson, che nel 1763 aveva creato in suo onore Bergena. La denominazione non è valida, trattandosi di un doppione di un genere linneano, ma è significativa: se Bergen pensava che un sistema naturale fosse desiderabile, Adanson vi dedicò ossessivamente tutta la vita. Bergenia, della famiglia Saxifragaceae, è un piccolo genere di rusticissime erbacee perenni originarie dell'Asia centrale, della Siberia, dell'Afghanistan, della Cina e dell'area himalayana. La prima ad arrivare in Europa fu la siberiana B. cordifolia, che Linneo attribuì al genere Saxifraga (nome che, per la solita viscosità dei nomi delle piante, le è spesso rimasto appiccicato). La denominazione di Moench non fu accettata nel mondo anglosassone, dove le fu preferito il nome Megasea, coniato da Haworth nel 1821. Altre specie arrivarono dalla Cina e dell'area Himalayana nel corso dell'Ottocento; risale al periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento il periodo della grande fortuna delle bergenie, soprattutto grazie alle precocissime fioriture che le rende interessanti anche come fiori invernali, stimolando un'intensa attività di ibridazione. Poco esigente, generosa nelle fioriture molto precoci, la più comune nei giardini è B. crassifolia (anche nota con il sinonimo B. cordifolia), con grandi foglie persistenti e grappoli di fiori rosa intenso che sbocciano tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, nel nord Italia tipicamente intorno al 19 marzo (da qui il nome popolare "giuseppina"). Forse proprio perché facili e indistruttibili, talvolta sono sentite come piante banali, vecchiotte, fuori moda. Non la penso così, ma chi volesse qualcosa di nuovo non ha che l'imbarazzo della scelta: può rivolgersi ad altre specie, come B. purpurascens, con fiori rosa carminio e foglie a cucchiaio che in autunno si tengono di rosso, oppure B. stracheyi, un'alpina dalle dimensioni più contenute con fiori rosa chiaro gradevolmente profumati; ma soprattutto ai numerosi ibridi che hanno allargato la gamma dei colori dei fiori al bianco, al porpora e a tutte le sfumature del rosa, inclusa l'albicocca, e sono spesso molto interessanti anche per la tessitura e/o il colore del fogliame. Quale approfondimento nella scheda. Quanti personaggi diversi è stato Joseph Pitton de Tournefort, il più importante botanico francese del Seicento! Seminarista scavezzacollo che scala muri per "rubare" piante; viaggiatore intrepido che sfida gli elementi, i briganti, fatiche di ogni genere, percorrendo le strade della Francia, della penisola iberica e le rotte del Levante; a soli 27 anni, professore carismatico di botanica al Jardin des plantes, forse il primo botanico professionista della storia; teorico e creatore del più diffuso sistema tassonomico prelinneano; autore rinomato per la chiarezza delle sue descrizioni, che impose definitivamente il concetto di genere; vittima di un incidente tragico che anticipa la sorte di Pierre Curie. E, ovviamente, dedicatario del linneano genere Tournefortia. 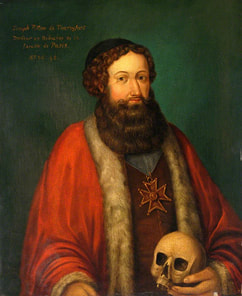 Le trasformazioni del Giamburrasca della botanica Basta osservare i ritratti di Joseph Pitton de Tournefort per capire che ci troviamo di fronte a uno spirito anticonformista. In un'epoca in cui Luigi XIV aveva imposto a cortigiani e funzionari pompose parrucche e abolito barba e baffi, ostenta corti capelli ricciuti, baffi e una barba che, in alcune versioni che lo ritraggono al ritorno del viaggio in Levante, si allunga a ventaglio fino a metà petto. Non aveva paura di sfidare le convenzioni, come non aveva esitato a affrontare la verga paterna, i banditi dei Pirenei o i disagi di un viaggio dal porto di Marsiglia alle pendici dell'Ararat. Come cadetto di una famiglia della nobiltà di toga di scarse fortune, il padre lo destina al sacerdozio. Tuttavia, alle lezioni di latino e teologia impartite nel seminario dei gesuiti di Aix, sua città natale, Joseph preferisce di gran lunga la botanica, cui è stato iniziato dal farmacista Jacques Daumas. Grazie a quest'ultimo, trova un compagno di avventure in un altro allievo del collegio, di poco più giovane, Pierre Garidel. Da solo o con l'amico, sfidando le punizioni paterne marina le lezioni per battere la campagna alla ricerca di nuove piante, senza farsi intimorire da recinzioni, staccionate e muri. Un bel giorno il nostro Giamburrasca della botanica, scambiato per un ladro mentre scavalca il muro di un frutteto, viene preso a sassate dai contadini. Altrettanto proibita è la sua passione per Cartesio, un autore considerato poco ortodosso, che studia di straforo nella biblioteca paterna. Nel 1676, la morte del padre lo libera da una carriera ecclesiastica senza vocazione. Ma prima di iniziare studi seri, per festeggiare la liberazione, parte con Garidel per la prima delle sue lunghe scorribande botaniche. Sul loro cammino incontrano un altro appassionato, il frate minimo Charles Plumier, che diverrà ben presto il loro mentore e li accompagnerà nelle montagne del Delfinato e in Savoia. Nel 1679 Pitton va a studiare medicina, anatomia e botanica a Montpellier, dove rimane due anni e si lega con Pierre Magnol. Ma allo studio libresco preferisce l'esplorazione sul campo: percorre la Linguadoca, poi i Pirenei e la Spagna, che visiterà a più riprese tra il 1681 e il 1689. Nel corso di questi viaggi, compiuti ora da solo, ora con altri studiosi spagnoli e francesi, affronta disagi e pericoli di ogni tipo: rimane sepolto dal crollo del tetto di una baita, prima di essere tratto in salvo dai paesani; più volte, incontra i banditi che infestano la regione. Per non farsi derubare, nasconde il poco denaro che porta con sé in una pagnotta di pane nero, rustico e ben poco appetibile (in seguito dirà che il cibo pessimo era stato una prova peggiore dei briganti di strada). Ma intanto la sua fama di botanico ha raggiunto Parigi, e Guy Fagon, all'epoca medico della regina, lo chiama nella capitale ad assumere la cattedra di botanica al Jardin des Plantes. E' un insegnante carismatico, che richiama allievi non solo dalla Francia, ma dall'intera Europa; tra di essi, i britannici Hans Sloane e William Sherard. Non per questo cessa di viaggiare: nei mesi estivi torna in Spagna, va in Portogallo, poi in Olanda (qui gli viene offerta una cattedra alla prestigiosa università di Leida, che rifiuta) e in Inghilterra. Viaggia per studio, ma anche per incarico del re, che, impressionato dalla sua sapienza botanica, gli chiede di raccogliere esemplari per arricchire il Jardin des plantes. Intanto Tournefort progetta la stesura di una Histoire naturelles des plantes, catalogo monumentale di tutte le specie conosciute. Per incoraggiarlo in questo intento, il cancelliere Pontchartrain e suo nipote, l'abate Bignon, ne favoriscono la nomina all'Accademia delle scienze (1690); è la prima volta che questo onore tocca a un botanico, per altro privo della prescritta laurea in medicina. Per evitare di creare un precedente, Tournefort ritorna sui banchi e in due anni consegue la laurea. 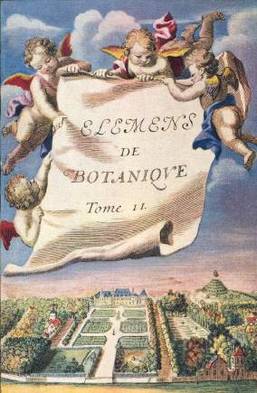 Il sistema di Tournefort Nel 1694 l'Accademia abbandona il costoso progetto dell'Histoire naturelle; Tournefort ripiega su un'opera più breve, destinata ai suoi studenti: Elemens de botanique ou méthode pour connaitre les plantes; proprio come l'ammirato Discours de la méthode di Cartesio, è scritto in francese, con una scelta rivoluzionaria che allarga il pubblico anche ai semplici appassionati. Corredata da 451 ottime tavole disegnate da Claude Aubriet e caratterizzata da uno stile limpido, veramente cartesiano, l'opera ottiene un enorme successo, che spinge Tournefort a tradurlo egli stesso in latino per metterlo disposizione degli studiosi europei; con il titolo Institutiones rei herbariae l'edizione latina esce a partire dal 1700. In queste opere Tournefort espone il suo sistema di classificazione delle piante, il più diffuso prima di quello di Linneo. Proprio come quest'ultimo, si tratta di un sistema artificiale, che non pretende di ricostruire l'ordine naturale del mondo vegetale (cui mirava il contemporaneo John Ray, che del sistema di Tournefort fu uno dei maggiori critici) ma di offrire un metodo "chiaro e distinto" per riconoscere e classificare le piante. Assumendo come criterio di classificazione principalmente la struttura della corolla e del frutto, il botanico provenzale descrive più di 10000 piante, raggruppandole in 22 "classi" e in 698 generi. Proprio la precisa definizione di genere (un concetto non nuovo, ma fino ad allora mai utilizzato in modo così chiaro e sistematico) è il maggiore merito di un sistema che, comunque, per la sua chiarezza e semplicità ottenne grande successo, imponendosi anche in altri paesi. Nello stesso 1694, Tournefort che ormai è il vero direttore scientifico del Jardin des plantes (Fagon, ormai divenuto primo medico del re e intendente, gli lascia mano libera), fa ripiantare le parcelle didattiche dell'orto in base al proprio sistema (che continuerà ad essere usato al Jardin des plantes fino al 1773, ovvero ancora vent'anni dopo l'uscita di Species plantarum di Linneo). Ormai il destino dell'irrequieto botanico viaggiatore sembrerebbe quello di un tranquillo accademico: ma nel 1700, su proposta di Pontchartrain, riceve l'ordine del re di partire per il Levante. Ha 44 anni, una solida posizione accademica, ma come potrebbe rifiutare un ordine del re, tanto più che risponde ai suoi più profondi desideri? E così si rimette in viaggio. Ma questa è una storia così bella che merita un post tutto per sé. Dopo due anni avventurosi, Tournefort è di nuovo a casa, con un immenso bottino. Pubblica un supplemento agli Elements aggiungendo le specie raccolte in Levante (una conferma del suo sistema, perché le nuove specie vanno tutte a inserirsi nei generi già determinati). Nel 1706 ottiene la cattedra di medicina e botanica al Collège royal; intanto attende alla revisione del resoconto del viaggio in Levante (uno dei libri di viaggio più belli e tuttora appassionanti del secolo). Ma dopo tanti viaggi, tante avventure, il destino lo attende a pochi passi dal Jardin des plantes: mentre vi si reca, viene urtato violentemente da un carretto che lo schiaccia contro un muro; perde moltissimo sangue e, dopo qualche mese di sofferenza, si spegne a 52 anni. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  La sfuggente Tournefortia Nel 1700, in Institutiones rei herbariae, Tournefort aveva reso omaggio all'amico e maestro Plumier dedicandogli il genere Plumeria. Nel 1703, il frate ricambiò il favore, battezzando Pittonia uno dei nuovi generi scoperti nei suoi viaggi nelle Antille. La dedica fu accolta da Linneo in Species plantarum (1753) che tuttavia mutò il nome in Tournefortia, facendo notare che se in Francia il botanico provenzale era noto anche con il cognome, all'estero tutti lo conoscevano con il titolo nobiliare. Tournefortia è un grande genere della famiglia Boraginaceae (o Heliotropiaceae, secondo proposte recenti), affine ad Heliotropium; a quest'ultimo tradizionalmente vengono assegnate le specie erbacee, mentre a Tournefortia le specie arbustive e i rampicanti legnosi. Una distinzione semplice, di evidenza cartesiana, ma purtroppo semplicistica, che negli ultimi anni è stata messa in discussione dalle ricerche basate sul DNA. Allo stato attuale (molto rimane da chiarire) a Tournefortia sono assegnate 100-150 specie di arbusti, alberelli e rampicanti legnosi per lo più neotropicali (dagli Stati Uniti meridionali fino al Perù); a distinguerlo da Heliotropium, più ancora che il portamento, sono l'habitat (le foreste aride per Tournefortia, le zone aride aperte e per lo più sabbiose per Heliotropium), alcune particolarità dei fiori, le infiorescenze sparse e non allargate, e soprattutto i frutti, drupe che non si dividono in mericarpi. Come non di rado avviene, le specie più note sono ora transitate in altri generi: la più diffusa, T. argentea, è ora Helitropium fortherianum. Nonostante qualche incertezza, la maggior parte delle fonti continua ad assegnargli T. gnaphalodes, un arbusto dal portamento espanso delle aree costiere della Florida e delle Antille, noto come lavanda di mare. Tra le specie più comuni T. hirsutissima, una liana ricoperta di una densa peluria che si arrampica sugli alberi delle foreste aride, diffusa in Florida, Messico, America centrale, Venezuela, Perù e Bolivia. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed